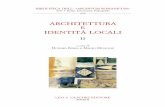Azioni collettive e mobilitazioni locali: dentro il quartiere Sant'Eusebio
Le elezioni regionali e locali del 2013
-
Upload
univ-catholille -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le elezioni regionali e locali del 2013
2. Né di primo né di secondo livello: le elezioni regionali e locali del 2013
di Emanuele Massetti e Giulia Sandri
Il 2013 è stato prima di tutto un anno elettorale. Molti elet-tori italiani sono stati chiamati alle urne non solo per rinnovare il Parlamento, ma anche per eleggere diverse nuove amministrazioni regionali e locali. Quattro regioni a statuto ordinario sono andate ai seggi due anni (Lombardia, Lazio, Basilicata) o tre (Molise) prima del previsto a causa di scandali che avevano portato alle dimissioni dei governi regionali. Per tre di queste regioni – Lombardia, Lazio e Molise – le elezioni si sono svolte insieme alle elezioni politiche, il 23 e il 24 febbraio, mentre il 17 e il 18 novembre la consultazio-ne della Basilicata ha chiuso il calendario elettorale del 2013. Nel frattempo, si è votato anche in quattro regioni a statuto speciale1 in base al loro calendario elettorale naturale: in Friuli-Venezia Giulia (Fvg) il 21 e il 22 aprile, in Valle d’Aosta (VdA) il 26 maggio, nelle province di Trento e Bolzano il 26 e il 27 ottobre. Inoltre, il 26 e il 27 maggio sono stati rinnovati quasi 600 consigli comunali, 92 dei quali appartenenti a comuni con più di 15.000 abitanti, i cui sindaci sono stati eletti al secondo turno (9 e 10 giugno) nei casi in cui nessuno dei candidati aveva ottenuto la metà più uno dei voti al primo turno. Tra queste elezioni locali, quelle dei sedici capoluoghi provinciali, tra cui Roma, erano particolarmente importanti. Nel loro complesso, le elezioni amministrative hanno dato al centro-sinistra quella netta vittoria che non ha ottenuto alle politiche.
In questo capitolo focalizziamo la nostra attenzione secondo due criteri principali. In primo luogo, il peso demografico delle unità territoriali coinvolte ci porta a dedicare più attenzione alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, e alle elezioni comu-nali della capitale. Ciò si riflette non soltanto in un resoconto più dettagliato dei risultati, ma anche in un’analisi del contesto politico pre-elettorale (alleanze, selezione dei candidati a presidente e a sin-daco e campagne elettorali). In secondo luogo, ci siamo concentrati sui risultati di quelle elezioni che appaiono più direttamente colle-gate alla politica nazionale. Il collegamento con la politica nazionale
2 Le elezioni regionali e locali del 2013
si può determinare in due modi. Uno consiste nel tener conto delle implicazioni centro-periferia di un risultato elettorale. Qui facciamo riferimento alla possibilità che i risultati di un’elezione regionale at-tivino dinamiche specifiche della politica territoriale in grado di as-sumere una rilevanza nazionale. Da questo punto di vista, accennia-mo brevemente alla misura in cui il successo conseguito dalla Lega Nord (LN) in Lombardia potrebbe avviare una nuova ondata di riforme regionali, specie in materia fiscale, tramite il progetto della «macroregione del nord». E analizziamo rapidamente le possibili conseguenze della crescita dei partiti secessionisti nella provincia di Bolzano. Ma il collegamento più diretto è l’interpretazione delle elezioni regionali/locali alla luce della politica nazionale. In questa prospettiva, ci concentriamo su quelle consultazioni che sono più comparabili con le elezioni nazionali, dedicando perciò una par-ticolare attenzione alle unità territoriali caratterizzate da sistemi partitici simili a quello nazionale, e preoccupandoci meno delle regioni che hanno sistemi partitici altamente regionalizzati (VdA, province di Trento e Bolzano). Tra le prime, dobbiamo distinguere (e comparare) le elezioni che si sono svolte in contemporanea con le politiche (Lombardia, Lazio e Molise) da quelle che si sono svol-te in tempi diversi (Fvg e Basilicata). Confrontiamo, in particolare, i risultati del Fvg con quelli della Lombardia e del Lazio. Quest’a-nalisi mette in luce un fenomeno molto interessante: da una parte, le elezioni regionali (e locali) appaiono certamente di «secondo livello» se guardiamo all’affluenza alle urne; dall’altra, appaiono di «primo livello» se guardiamo alle preferenze per i partiti e per le coalizioni (i partiti e le coalizioni principali hanno fatto meglio alle elezioni regionali e locali che alle elezioni nazionali). Esaminiamo per sommi capi questo fenomeno emergente valutando il possibile impatto di leader, candidati e sistemi di voto.
1. Offerta politica e campagna elettorale in Lombardia, nel Lazio e a Roma
Data la contemporaneità con le elezioni nazionali, non c’è ov-viamente da sorprendersi se il rinnovo delle assemblee regionali del Lazio e della Lombardia è stato influenzato dalle elezioni nazionali. Sia i problemi su cui si incentrava la campagna elettorale sia la con-figurazione dell’offerta politica replicavano in larga misura quelli che caratterizzavano la consultazione nazionale.
In entrambe le regioni, la campagna elettorale è stata molto breve e focalizzata principalmente sulla legalità e su problemi di
3Le elezioni regionali e locali del 2013
ordine pubblico. In Lombardia, la campagna elettorale guidata dal Partito democratico (Pd) si imperniava sulla condanna del presun-to sistema di corruzione attribuito allo storico governatore Rober-to Formigoni negli ultimi due decenni, un sistema che era stato denunciato con sempre maggiore insistenza dai media regionali e nazionali nel periodo pre-elettorale. Il Popolo della libertà (Pdl), per contro, ha costruito la sua campagna sui risultati ottenuti dalla precedente amministrazione di centro-destra: una riduzione signi-ficativa del personale (comparativamente meno numeroso rispetto a quello di altre regioni italiane), la riduzione della spesa pubblica regionale e lo sviluppo di un ottimo sistema locale di welfare. La campagna è stata dominata anche dall’impegno formale della LN a creare una macroregione del Nord che dovrebbe integrare Lom-bardia, Piemonte e Veneto. Avendo abbandonato le antiche idee secessioniste e sostanzialmente accantonato il progetto del federa-lismo fiscale, la LN, che guidava la coalizione di centro-destra con il suo nuovo segretario Roberto Maroni, prometteva di creare una nuova unità di governance territoriale integrata ricalcata sul modello di strutture cooperative fra regioni come le «euro regioni». L’obiet-tivo principale di questo nuovo livello di governo del territorio, che integrerebbe le amministrazioni regionali della Lombardia (la regione più importante d’Italia in termini demografici ed economi-ci), il Piemonte, il Veneto e potenzialmente anche il Fvg, sarebbe trattenere sul territorio almeno il 75% del gettito fiscale.
Nel Lazio, la campagna elettorale è stata più complessa e più vivace, specie per quanto riguarda la coalizione di centro-destra. Il candidato del centro-destra alla presidenza della regione, Fran-cesco Storace, l’ha praticamente dedicata a confutare le accuse di corruzione mossegli dalla coalizione opposta, la cui strategia prin-cipale era ricordare agli elettori gli scandali politici che avevano portato alle dimissioni della giunta regionale in carica. Grazie alla politica di comunicazione messa in atto dal Pd durante la campa-gna, Storace si era guadagnato l’appellativo di «Mr. Debito» per la cattiva gestione della spesa sociale nel suo mandato precedente (2000-2005). Perciò, ad eccezione dei temi specifici della legalità e dei fenomeni di corruzione che avevano turbato l’opinione pubbli-ca in Lombardia e nel Lazio, nelle tre regioni testé menzionate la campagna elettorale per le elezioni regionali era indistinguibile da quella per le elezioni nazionali in programma nelle stesse giornate.
Quanto all’offerta politica, essa era significativamente influen-zata dalla elevata «nazionalizzazione» della campagna regionale e dal forte impatto delle strategie di coalizione sviluppate a livello nazionale per le competizioni politiche regionali. Gli assetti del-
4 Le elezioni regionali e locali del 2013
le coalizioni elettorali nelle tre regioni erano il frutto di faticosi compromessi tra le strategie delle segreterie nazionali dei partiti e i bisogni specifici delle loro segreterie locali. Il Pdl, alquanto indebolito dagli scandali politici della regione Lazio, ha dovuto ri-solvere non pochi problemi per comporre le proprie liste regionali. In realtà, il conflitto continuativo tra i due partiti che si sono fusi nel 2009 dando vita al Pdl (per poi ridividersi), Alleanza nazionale (An), e Forza Italia (FI), è stato particolarmente dannoso nel Lazio e ha reso quanto mai difficile la scelta di un candidato comune per la presidenza della regione. Una soluzione è venuta fuori dalla candidatura spontanea di Storace, che ha poi avuto l’appoggio di Silvio Berlusconi (sulla base di sondaggi d’opinione leggermente più favorevoli ma senza effettive speranze di vittoria). Nello stesso tempo, gli scandali hanno offerto alla coalizione di centro-sinistra l’opportunità di riconquistare una regione chiave. L’identificazione del candidato più rappresentativo per la coalizione non era facile, anche per il dissenso interno al Pd sulle procedure di selezione da adottare (e in particolare sul possibile ricorso alle primarie). Nicola Zingaretti, il presidente uscente della provincia di Roma, sembrava in linea con il profilo ideale, ma il Pd ha dovuto superare due grandi difficoltà per poterlo candidare: Zingaretti intendeva candidarsi per la carica di sindaco di Roma (contro la volontà della maggioranza del partito), e si parlava di indire le primarie per la scelta del candidato alla presidenza della regione. In precedenti occasioni, le primarie organizzate dalla coalizione di centro-sinistra avevano portato alla scelta di outsider che hanno prevalso sui candi-dati sostenuti dagli organi direttivi del partito. Grazie all’intervento del segretario regionale del Pd, Enrico Gasbarra, Zingaretti ha poi abbandonato la competizione interna al partito per la candidatura al municipio di Roma e, nello stesso tempo, la direzione centrale del partito ha deciso di non indire le primarie e di nominarlo can-didato della coalizione di centro-sinistra.
In Lombardia, gli scandali che hanno portato l’amministra-zione Formigoni a dimettersi hanno creato un’opportunità senza precedenti per il centro-sinistra. La coalizione di destra guidata da Berlusconi non poteva permettersi di perdere l’appoggio della LN né a livello nazionale né a livello regionale. Ciò dava alla LN un potere negoziale relativamente forte, che alla fine ha fatto accettare a Berlusconi (dopo qualche esitazione) il suo leader Maroni come candidato presidenziale della coalizione di destra. Il Pd ha invece deciso di organizzare le primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Lombardia. Ma anziché proporre candidati inter-ni, ha preferito sponsorizzare l’indipendente Umberto Ambrosoli,
5Le elezioni regionali e locali del 2013
che appariva fin dall’inizio in grado di sfidare vittoriosamente sia Maroni sia il leader della coalizione di centro-destra, Gabriele Al-bertini (appoggiato da Scelta Civica (Sc) e da diverse altre liste civiche e locali). La storia personale di Ambrosoli (stimato avvo-cato e figlio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, ucciso da un killer di Cosa nostra ingaggiato da Michele Sindona nel 1979) e il suo profilo politico e morale facevano di lui il candidato più idoneo a sfruttare il deficit di credibilità, specie in termini di onestà, della destra. Legalità ed etica nella politica erano perciò i punti focali della sua campagna. Inoltre, il suo profilo moderato attraeva l’e-lettore medio lombardo, tradizionalmente avverso ai candidati di sinistra.
Le primarie per il candidato della coalizione di centro-sinistra (Patto civico per la Lombardia) si sono svolte il 15 dicembre 2012 ed erano aperte a tutti gli elettori ultrasedicenni residenti nella re-gione (anche di nazionalità diversa da quella italiana). I candidati in lizza erano tre: Ambrosoli, il giornalista Andrea Di Stefano e la ginecologa Alessandra Kustermann. Ambrosoli ha vinto le primarie con il 57% dei voti e la coalizione di centro-sinistra ha iniziato la campagna elettorale con un grandissimo slancio.
Ben 19 candidati si sono presentati alle elezioni comunali di Roma, mentre le liste che li appoggiavano erano più di 40: 6 per il centro-sinistra, 6 per la destra e le restanti per altri partiti e liste civiche e locali. I quattro candidati principali erano: Gianni Ale-manno (Pdl, Fratelli d’Italia, FdI, La Destra); Ignazio Marino (Pd, Sinistra ecologia e libertà, Sel, Centro democratico, Cd, e Verdi); l’indipendente Alfio Marchini e il candidato del Movimento 5 stelle (M5s) Marcello De Vito. Ma fin dall’inizio della campagna la gara si è ristretta ai rappresentanti dei due partiti maggiori: l’uscente Alemanno, la cui candidatura era peraltro indebolita da una serie di scandali e casi di corruzione che avevano affossato la sua ammi-nistrazione, e il candidato del centro-sinistra Marino. Il processo di selezione dei due candidati principali è stato molto complesso. Nel caso della coalizione di destra, che era asimmetrica rispetto a quella messa in campo per le elezioni nazionali, il partner minorita-rio, FdI, ha tentato inizialmente di imporre la sua giovane dirigente (Giorgia Meloni) per mitigare le conseguenze degli scandali che avevano azzoppato l’amministrazione di Alemanno. La coalizione di centro-sinistra, per contro, era costruita sullo stesso cartello elet-torale presentato alle elezioni nazionali (Pd, Sel, Cd) e ha deciso fin da subito di organizzare come al solito le primarie per la scelta del candidato alla poltrona di sindaco. Il 7 aprile 2013, il candidato del Pd, Marino, che nel 2009 aveva gareggiato per la leadership
6 Le elezioni regionali e locali del 2013
del partito, ha ottenuto il 51% dei voti alle primarie, mentre i suoi competitor principali, il giornalista David Sassoli e l’ex ministro Paolo Gentiloni hanno ottenuto, rispettivamente, il 28% e il 14% dei consensi.
2. Offerta politica e campagna elettorale nelle province e nelle regioni autonome
Le regioni a statuto speciale e le province di Bolzano, Trento e della Valle d’Aosta sono caratterizzate dalla presenza di minoranze etniche o linguistiche, da una netta divisione tra centro e periferia, e da un sistema partitico dominato da attori regionali e/o regiona-listi. In base a queste caratteristiche e alle ampie competenze di cui sono investite le regioni, la struttura dell’offerta politica nelle elezioni regionali viene determinata principalmente da dinamiche locali, anziché nazionali2.
In Valle d’Aosta, due coalizioni principali sono scese in cam-po per il rinnovo del parlamento regionale: una coalizione regio-nalista di centro-destra formata da Union valdôtaine (Uv), Stella alpina-Lega Nord (Sa) e Fédération autonomiste (Fa); e una coa-lizione regionalista di centro-sinistra (chiamata Autonomie, liberté dèmocratie) formata dall’ala regionalista locale del Pd e altri partiti regionalisti (Autonomie liberté participation ecologie e Union val-dôtaine progressiste, una formazione di sinistra staccatasi recente-mente dall’Uv). Il candidato della coalizione di centro-destra alla presidenza della regione era l’uscente Auguste Rollandin, vittorioso alle primarie del 24 marzo 2013; mentre il candidato della coalizio-ne regionalista di centro-sinistra era Laurent Viérin, ex assessore all’educazione nell’amministrazione Rollandin.
Nella provincia di Bolzano, il sistema elettorale è ancora pro-porzionale, il che consente ai partiti di competere individualmente senza formare coalizioni preelettorali. La competizione elettorale si svolge in prevalenza all’interno dei confini etnici, anziché tra-sversalmente a essi. L’elettorato di lingua italiana si è frammentato sempre di più lungo il continuum delle ideologie, mentre l’elet-torato di lingua tedesca è rimasto più concentrato. A livello del personale politico, la novità più importante era il rinnovamento in corso nel partito da sempre più votato, la Südtiroler volkspartei (Svp). Sotto l’attacco dei concorrenti populisti (Die Freiheitlichen, Df) e secessionisti (Südtiroler Freiheit, Stf), Luis Durnwalder, pre-sidente della provincia di Bolzano dal 1989, ha annunciato il suo ritiro nell’autunno del 2012. Alle primarie del 21 aprile, la Svp ha
7Le elezioni regionali e locali del 2013
scelto Arno Kompatscher (che ha ottenuto l’82% dei voti) come candidato alla presidenza.
Nella provincia di Trento, i candidati principali erano Ugo Rossi, membro del partito regionalista Patt (Partito autonomista trentino tirolese) e appoggiato dal Pd, e l’autonomista Diego Mo-sna (Progetto Trentino). Guidavano due coalizioni autonomiste di centro, che presentavano differenze minime a livello ideologico-programmatico.
Nel Friuli-Venezia Giulia, quattro candidati principali si con-tendevano la presidenza della regione: il presidente uscente Ren-zo Tondo, leader della coalizione di destra (Pdl, LN, La Destra e Unione di centro, Udc); Debora Serracchiani per il centro-sinistra (Pd, Sel, Slovenska Skupnost e Italia dei Valori, Idv); Saverio Gal-luccio (M5s) e un indipendente, Franco Bandelli (sostenuto dalla lista civica Un’altra regione).
3. Risultati elettorali in Lombardia e nel Lazio
Prima delle elezioni, entrambe le regioni erano governate da una coalizione di destra, e ambedue i presidenti provenivano dal partito principale della destra: il Pdl. Il responso delle urne ha fatto perdere alla destra il Lazio (oltre al Molise), mentre in Lombardia ha prodotto un passaggio di consegne all’interno della destra, da Formigoni (Pdl) a Maroni (LN). Da questo punto di vista, non ci sono state grosse sorprese, perché i risultati elettorali apparivano sostanzialmente in linea con le traiettorie di lungo e medio termine delle rispettive regioni. Nella Seconda Repubblica, la Lombardia è sempre stata una roccaforte elettorale delle coalizioni nazionali guidate da Berlusconi. Qui, per il centro-sinistra, non si tratta di vincere o di perdere, ma solo di perdere bene o male. La vittoria di Ambrosoli sarebbe stata una sorta di «miracolo», anche se la coalizione di destra era indebolita da scandali politici e messa in difficoltà da una coalizione di centro-destra dichiaratamente anta-gonista. Quanto al Lazio, è sempre stata una regione aspramente contesa, in cui a partire dalle elezioni del 1995 centro-sinistra e centro-destra si sono alternati in continuazione.
Nonostante l’assenza di sorprese in termini di risultati comples-sivi, l’analisi dei dati elettorali rimane molto interessante per diverse ragioni: primo, si possono usare per valutare le strategie messe in atto dai diversi partiti e dalle diverse coalizioni; secondo, mettono in luce le traiettorie elettorali dei singoli partiti e permettono un confronto tra le loro performance e quelle delle liste personali;
8 Le elezioni regionali e locali del 2013
terzo, soprattutto nel caso della Lombardia, essi rappresentano il punto di partenza per l’analisi di possibili sviluppi nella politica multilivello e territoriale; infine, poiché si sono svolte in contem-poranea con le elezioni generali, possono costituire una sorta di benchmark per la valutazione dei risultati di elezioni subnaziona-li successive (specie in Fvg e in Basilicata). La tabella 1 riporta i risultati elettorali della Lombardia aggregate per candidati alla presidenza, per coalizioni e per partiti principali.
Ci sono vari punti da approfondire. Primo, pur essendo riuscita a vincere le elezioni, la destra ha subito una fortissima emorragia di voti. La lista Maroni è stata decisiva per la vittoria elettorale, mentre le principali liste partitiche, sia quella del Pdl sia quella della LN, hanno perso migliaia di consensi. Presumibilmente, la lista personale ha permesso a molti elettori di destra di continuare a sostenere la propria coalizione senza dover scegliere quei partiti che, ai loro occhi, avevano perso credibilità. Secondo, le perdite subite dalla destra non sembrano causate dalla concorrenza subita dalle forze politiche di centro-destra. Fare per fermare il declino (Fpfd) è stato un flop e l’alleanza Sc-Udc-Fli (Futuro e libertà), pur avendo presentato un candidato potenzialmente vincente (l’ex sin-daco di Milano Albertini) non è andata oltre i voti raccolti dall’Udc nel 2010 (con Savino Pezzotta candidato alla presidenza). Terzo, la coalizione di centro-sinistra ha fatto meglio (molto meglio se non si tiene conto dei voti conseguiti dall’Idv) che nel 2010, grazie soprattutto alla lista Ambrosoli. Anche il Pd ha migliorato rispetto ai risultati del 2010, ma la strategia di presentare uno stimato espo-nente della società civile, anziché un politico, sembra aver prodotto risultati positivi per l’intera coalizione. Infine, il M5s ha guadagnato ben 12 punti percentuali rispetto al risultato della consultazione precedente, «rubando», in questo caso, voti prevalentemente alla destra. Curiosamente, i voti ottenuti dal suo candidato Silvana Car-cano hanno superato sia in numeri assoluti sia in percentuale quelli ottenuti dalla lista del partito.
Poiché la richiesta di riforme in senso federalista era sospinta principalmente dal «vento del nord»3, i risultati elettorali del 2013 sono i più interessanti in termini di possibili implicazioni per la po-litica territoriale e multilivello. Con la vittoria di Maroni tutte e tre le grandi regioni del nord – Lombardia, Veneto e Piemonte – sono ora guidate dalla LN (anche se in coalizione con il Pdl e altri partiti minori di destra). Lo si può considerare un primo passo importante verso la realizzazione della «macroregione del nord». La domanda è: quali sono le probabilità che il controllo simultaneo delle tre regioni del nord nei prossimi due anni rafforzi la pressione per
Tab. 1
. R
isul
tati
ele
zion
i re
gion
ali
del
24 e
25
febb
raio
201
3 in
Lom
bard
iaa
Can
dida
tiC
arca
noA
mbr
osol
iA
lber
tini
Pina
rdi
Mar
oni
Vot
i78
2.00
72.
194.
169
236.
597
68.1
332.
456.
921
% v
oti
13,6
38,3
4,1
1,2
42,8
Coa
lizio
neM
5sC
entr
o-si
nist
raC
entr
o-de
stra
Fpfd
Des
tra
Vot
i77
5.21
12.
015.
110
219.
156
68.4
692.
328.
809
% v
oti
14,3
37,2
4,1
1,3
43,1
Dif
fere
nza
2010
-201
3 +
12,0
+3,
9b+
0,2
––1
5,1
Segg
i9
21–
–48
Lis
teM
5sPd
Lis
ta
Am
bros
oli
Alt
re l
iste
Lom
bard
ia
civi
caU
dcFp
fdPd
lL
NL
ista
M
aron
iA
ltre
lis
te
Vot
i77
5.21
11.
369.
440
380.
241
265.
429
133.
435
219.
156
68.4
6990
4.74
270
0.90
755
2.86
317
0.29
7%
vot
i14
,325
,37,
04,
92,
51,
61,
316
,713
,010
,23,
1D
iffe
nza
2010
-201
3+
12,0
+2,
4–
–4,3
–+
0.2
––1
5,0
–13,
2–
+3,
0Se
ggi
917
4–
––
–19
1511
3
a A
fflu
enza
: 76,
7%, l
a di
ffer
enza
con
le p
rece
dent
i ele
zion
i del
201
0 è
di 1
2,1
punt
i per
cent
uali.
b N
el 2
010
la c
oaliz
ione
di c
entr
o si
nist
ra in
clud
eva
l’Idv
, che
nel
201
3 no
n fa
ceva
par
te d
ella
ste
ssa
coal
izio
ne. S
e si
sco
rpor
a la
per
cent
uale
di
vot
i del
l’Idv
, il v
anta
ggio
net
to d
ella
coa
lizio
ne s
ale
a 10
,19
punt
i per
cent
uali.
Font
e: N
ostr
a el
abor
azio
ne s
u da
ti p
rovv
isor
i del
min
iste
ro d
ell’I
nter
no -
Dir
ezio
ne c
entr
ale
per
i ser
vizi
ele
ttor
ali.
10 Le elezioni regionali e locali del 2013
un’ulteriore federalizzazione, specie in termini di poteri tributari?4 La Costituzione italiana, riformata nel 2001, lascia aperta la possi-bilità che le singole regioni ottengano competenze speciali, e per la prima volta nella sua storia, la LN sarebbe in grado di combattere la sua battaglia sfruttando, oltre al peso politico di cui dispone a Roma, anche accordi intergovernativi multilivello5. Ma questa forza istituzionale senza precedenti a livello regionale (e macroregionale) si viene a determinare proprio nel periodo più sfavorevole per la LN. Che oltre a perdere metà del suo peso elettorale e un gran numero di attivisti, è tuttora lacerata da lotte intestine. Inoltre, non fa più parte della compagine governativa da novembre del 2011 ed è stata relegata ai margini della politica nazionale (parlamentare). Per giunta, questa marginalizzazione politica e istituzionale ha con-tribuito, insieme al fallimento del «federalismo fiscale»6, all’improv-viso abbandono del discorso federalista predominante. Le politiche economiche finalizzate al contenimento della spesa pubblica hanno vanificato de facto il progetto federalista, specie per quanto riguarda le competenze finanziarie/fiscali, innescando addirittura un proces-so di ricentralizzazione. Perciò, in assenza di cambiamenti radicali nella politica economica, e più in generale nel contesto politico di Roma, la possibilità di sfruttare la vittoria ottenuta in Lombardia e di avviare una nuova stagione di riforme in senso federalista appare piuttosto improbabile.
Quanto al Lazio, i risultati visualizzati nella tabella 2 mostrano un quadro parzialmente diverso. Qui le performance dei partiti principali, Pd e Pdl, sono state positive rispetto alla consultazione precedente, mentre il contributo fornito dai candidati alla presiden-za è stato più modesto che in Lombardia.
Sembra, in particolare, che la scelta di Storace abbia danneg-giato la coalizione di destra. In effetti, la lista Storace ha ottenuto un misero 1,6% dei voti e si è piazzata al quarto posto, dopo le liste partitiche di Pdl, FdI e La Destra. Il candidato del centro-sinistra Zingaretti ha fatto molto meglio, ma la performance mi-gliore all’interno del centro-sinistra è stata quella del Pd, che è cresciuto notevolmente rispetto ai risultati del 2010. L’insuccesso del centro-destra è stato ancora più evidente che in Lombardia, e la lista Bongiorno (appoggiata da Sc-Udc-Fli) ha preso meno voti dell’Udc nel 2010 (ma il confronto è più problematico perché nel 2010 l’Udc faceva parte della coalizione di destra). La scelta di Giulia Bongiorno come candidata non ha danneggiato la coalizione di centro-destra, ma non sembra neppure averle dato una spinta significativa. Infine, il M5s ha ottenuto un risultato oltremodo po-sitivo alla sua prima consultazione nel Lazio, e come è accaduto
Tab. 2
. R
isul
tati
ele
zion
i re
gion
ali
del
24 e
25
febb
raio
201
3 ne
l L
azio
a
Can
dida
tiB
arill
ari
Zing
aret
tiB
ongi
orno
Stor
ace
Altr
i
Vot
i66
1.86
51.
330.
398
154.
986
959.
685
165.
812
% v
oti
20,2
40,7
4,7
29,2
5,1
Coa
lizio
neM
5sC
entr
o-si
nist
raC
entr
o-de
stra
Des
tra
Alt
ri
Vot
i46
7.21
51.
168.
909
124.
238
920.
951
126.
100
% v
oti
16,6
41,6
4,4
32,8
4,6
Dif
fere
nza
2010
-201
3–
–6,4
b–
–18,
6c–
Segg
i7
282
13–
Lis
teM
5sPd
Lis
ta
Zing
aret
tiA
ltri
cen
tro-
sini
stra
Sc-U
dc-F
liPd
lFd
IL
a de
stra
Alt
ri d
estr
aA
ltri
Vot
i46
7.21
583
4.23
712
6.64
620
8.02
612
4.23
859
5.21
210
7.73
094
.113
123.
896
126.
100
% v
oti
16,6
29,7
4,5
7,4
4,4
21,2
3,8
3,4
4,4
4,6
Dif
fere
nza
2010
-201
3–
+3,
4–
––
+9,
3d–
–0,6
––
Segg
i7
232
32
101
11
–
a A
fflu
enza
: 72,
08%
, la
diff
eren
za c
on le
pre
cede
nti e
lezi
oni d
el 2
010
è di
+11
,19
punt
i per
cent
uali.
b N
el 2
010
la c
oaliz
ione
di c
entr
o si
nist
ra in
clud
eva
dive
rsi p
arti
ti c
he n
on n
e fa
ceva
no p
arte
nel
201
3 (c
ome
l’Idv
, i R
adic
ali e
i C
omun
i-st
i). S
e si
sco
rpor
ano
i vot
i di q
uest
i par
titi
, la
scon
fitt
a el
etto
rale
del
la c
oaliz
ione
si t
rasf
orm
a in
una
net
ta v
itto
ria
(+8,
29 p
unti
per
cent
uali)
.c
Nel
201
0 la
coa
lizio
ne d
i des
tra
incl
udev
a l’U
dc e
l’U
deur
. Se
si s
corp
oran
o i l
oro
voti
, le
perd
ite
elet
tora
li de
lla c
oaliz
ione
si r
iduc
ono
a 11
,62
punt
i per
cent
uali.
d N
ella
con
sulta
zion
e pr
eced
ente
(20
08),
il P
dl n
on h
a pr
esen
tato
ent
ro i
term
ini l
a lis
ta d
ei c
andi
dati
per
la p
rovi
ncia
di R
oma.
Di c
onse
-gu
enza
la li
sta
del P
dl è
sta
ta e
sclu
sa d
alla
cir
cosc
rizi
one
elet
tora
le p
iù im
port
ante
del
la r
egio
ne. P
erci
ò i d
ati r
elat
ivi a
lla d
iffer
enza
per
cent
uale
co
n la
con
sult
azio
ne p
rece
dent
e no
n so
no in
dica
tivi
del
la p
erfo
rman
ce r
eale
del
par
tito
.
Font
e: N
ostr
a el
abor
azio
ne s
u da
ti p
rovv
isor
i del
min
iste
ro d
ell’I
nter
no -
Dir
ezio
ne c
entr
ale
per
i ser
vizi
ele
ttor
ali.
12 Le elezioni regionali e locali del 2013
in Lombardia, il suo candidato Brillari ha ottenuto più voti della lista presentata dal partito, sia in numeri assoluti sia in percentuale.
Occorre infine evidenziare le differenze registrate nel compor-tamento elettorale tra le elezioni generali e queste due consultazio-ni regionali. La figura 1 dimostra come, sia in Lombardia sia nel Lazio, le due coalizioni principali, di centro-sinistra e di destra, abbiano fatto meglio a livello regionale che a livello nazionale. Per contro, tutti i «partiti terzi» – M5s, Sc-Udc-Fli e Fpfd – sono andati molto meglio nelle elezioni nazionali che nelle elezioni regionali. Nel Molise, il centro-destra e la destra erano alleati, ma i risultati del M5s e del centro-sinistra confermano lo stesso trend (quest’ul-timo è andato molto meglio alle elezioni regionali, mentre il primo è andato molto meglio alle elezioni nazionali). In altre parole, le elezioni regionali rimangono più influenzate da una logica bipolare rispetto alle elezioni nazionali.
Questo andamento emergente è esattamente all’opposto di quanto suggerirebbe la teoria delle «elezioni di secondo livello», cioè che i due competitor più importanti dovrebbero fare meglio alle elezioni nazionali, mentre i partiti terzi e minori dovrebbero fare meglio alle elezioni amministrative7. Gli ultimi studi sulle ele-zioni regionali hanno messo sempre più in dubbio l’applicabilità di questa teoria8. Inoltre, la simultaneità verticale delle elezioni potrebbe spiegare, di per sé, la modestia degli «effetti di secondo livello» attesi. L’inversione dell’andamento previsto per le elezioni amministrative rimane tuttavia un risultato a sorpresa.
Una spiegazione potrebbe essere l’effetto-leadership: i leader nazionali dei partiti terzi e delle coalizioni (Beppe Grillo, Mario Monti e Oscar Giannino) erano particolarmente attrattivi rispetto a quelli delle due coalizioni principali (Pierluigi Bersani e Berlu-sconi), e creavano perciò un forte differenziale positivo tra le due arene politiche; oppure, simmetricamente, i candidati regionali dei partiti terzi erano particolarmente poco attraenti rispetto a quelli delle due coalizioni principali, e creavano perciò un forte differen-ziale negativo. I risultati ci permettono solo di rifiutare la seconda parte dell’ipotesi, perché i candidati del M5s e del centro-destra hanno fatto meglio del rispettivo partito e della rispettiva coalizio-ne sia alle regionali della Lombardia sia alle regionali del Lazio. Ipotesi analoghe si potrebbero applicare alla diversa attrattività di tutti i candidati a entrambi i livelli elettorali, anziché unicamente ai leader. In altre parole, l’intera classe politica regionale apparirebbe più impreparata e/o più affidabile della classe politica nazionale per i partiti principali/consolidati, mentre sarebbe l’opposto per i par-titi terzi. Questa ipotesi non appare del tutto convincente perché,
13Le elezioni regionali e locali del 2013
Fig. 1. Differenza nelle percentuali di voti delle coalizioni tra le elezioni regionali e le elezioni nazionali in Lombardia e nel Lazio.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Nazionali
Regionali
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Nazionali
Regionali
Sinistra M5s CS CD Fpfd Destra Altri
Sinistra M5s CS CD Fpfd Destra Altri
a) Lombardia
b) Lazio
14 Le elezioni regionali e locali del 2013
da una parte, gli scandali politici scoppiati recentemente a livello regionale hanno coinvolto dei partiti consolidati (specie il Pdl), e dall’altra, i candidati nazionali del M5s erano «scarti» delle prece-denti elezioni locali e regionali.
Un’altra spiegazione potrebbe essere legata alle differenze istituzionali tra i due livelli. Ambedue i sistemi elettorali (per le amministrazioni regionali e per la Camera) creano forti incenti-vi, e forti vincoli, a favore della competizione bipolare, in quanto garantiscono una maggioranza a uno dei contendenti. Ma ci sono significative differenze nelle regole istituzionali/elettorali tra i due livelli. In particolare, il sistema nazionale è ancora ispirato da una «logica parlamentare» (il premio di maggioranza viene assegnato in base al voto per le elezioni parlamentari), mentre i sistemi regionali sono informati da una chiara logica «presidenziale» (è il voto per il leader della giunta regionale, il presidente, che stabilisce a quale coalizione andrà il premio di maggioranza nel parlamento regiona-le). L’elezione diretta del presidente della regione potrebbe rappre-sentare un incentivo più forte ad appoggiare le coalizioni principali. E cosa forse più importante, il Parlamento nazionale è bicamerale e il sistema elettorale in vigore per il Senato non garantisce una mag-gioranza a nessuna partito o a nessuna coalizione. Ciò potrebbe aver indotto un «travaso» psicologico, indebolendo la logica bipolare su tutte le elezioni generali, incluse quelle per la Camera.
4. Risultati elettorali in Friuli-Venezia Giulia e in Basilicata
In Fvg, dove le elezioni si sono svolte circa due mesi dopo le elezioni generali e alla fine del processo che ha portato alla rie-lezione di Giorgio Napolitano alla presidenza delle Repubblica, la contesa elettorale è stata più soggetta all’influenza del quadro politico nazionale. La tabella 3 mostra gli interessanti risultati di questa consultazione elettorale.
Qui, la candidata del centro-sinistra Serracchiani (Pd) ha vinto per un’incollatura sul presidente uscente e candidato della destra Tondo (Pdl) e ha conquistato la presidenza, insieme a un’ampia maggioranza per la sua coalizione all’assemblea regionale. Ma le preferenze espresse dai lettori sulle liste di partito mostrano una chiara vittoria della destra (45% contro 39%). Ci sarebbe ovvia-mente abbastanza materia per mettere in discussione il sistema elet-torale che viene usato in quasi tutte le regioni d’Italia, ma questo argomento esula dalle finalità del presente capitolo. In termini di differenze con le elezioni precedenti, si possono mettere in luce due
Tab. 3
. R
isul
tati
ele
zion
i re
gion
ali
del
21 e
22
apri
le 2
013
in F
riul
i-Ven
ezia
Giu
liaa
Can
dida
tiG
allu
cci
Serr
acch
iani
Ban
delli
Tond
o
Vot
i10
3.13
521
1.50
812
.908
209.
457
% v
oti
19,2
39,4
2,4
39,0
Coa
lizio
neM
5sC
entr
o-si
nist
raR
egio
nale
Cen
tro-
dest
ra
Vot
i54
.908
155.
547
8.23
118
0.62
6%
vot
i13
,839
,02,
145
,2D
iffe
renz
a 20
08-2
013
––7
,4–
–8,4
–Se
ggi
526
–16
–
Lis
teM
5sPd
Lis
ta
Serr
acch
iani
Sel
Alt
ri
cent
ro-
sini
stra
Un’
altr
a re
gion
ePd
lA
uton
omia
re
spon
sa-
bile
LN
Udc
Alt
ri d
estr
a
Vot
i54
.908
107.
180
21.1
7017
.757
9.65
78.
231
80.0
6342
.851
33.0
4714
.759
9.99
0%
vot
i13
,826
,85,
34,
52,
42,
120
,010
,78,
33,
72,
5D
iffe
renz
a 20
08-2
013
––3
,1–
––
––1
3,0
––4
,6–2
,4–
Segg
i5
193
31
08
43
1–
a A
fflu
enza
: 50,
51%
, la
diff
eren
za c
on le
pre
cede
nti e
lezi
oni d
el 2
008
è di
–21
,82
punt
i per
cent
uali.
Font
e: N
ostr
a el
abor
azio
ne s
u da
ti p
rovv
isor
i del
min
iste
ro d
ell’I
nter
no -
Dir
ezio
ne c
entr
ale
per
i ser
vizi
ele
ttor
ali.
16 Le elezioni regionali e locali del 2013
aspetti principali. Primo, l’affluenza alle urne è calata drasticamente (–21,82 punti percentuali); secondo, le due coalizioni principali e i due maggiori partiti (soprattutto il Pdl) hanno perso parecchio, la consultazione precedente era stata pienamente bipolare (le due co-alizioni principali avevano raccolto praticamente il 100% dei voti). Eppure, i risultati davano percentuali più basse per i partiti terzi rispetto alle elezioni politiche. In particolare, una parte della stam-pa nazionale ha sottolineato la performance deludente del M5s9, ipotizzando una perdita di attrattiva elettorale legata alla rigidità con cui aveva affrontato sia il problema della formazione del go-verno sia l’elezione del presidente della Repubblica. Mentre il gap tra le performance del M5s nelle due elezioni era particolarmente ampio in Fvg (ha quasi dimezzato la sua percentuale), il risultato appare in linea con l’effetto inverso di secondo livello già emerso in Lombardia e nel Lazio all’epoca delle elezioni generali.
Le elezioni regionali della Basilicata, tenutesi circa sette mesi dopo quelle del Fvg, hanno riprodotto sostanzialmente gli stessi risultati: vittoria del centro-sinistra, guidato da Marcello Pittella; fortissimo calo dell’affluenza alle urne; affluenza molto più bassa ri-spetto alle elezioni politiche, ma effetto inverso di secondo livello in termini di performance dei partiti e delle coalizioni. La differenza più significativa rispetto al Fvg è che, in Basilicata, il centro-sinistra ha ottenuto una netta maggioranza di voti sia nelle elezioni per la presidenza sia nelle elezioni per l’assemblea regionale.
5. Risultati elettorali in Valle d’Aosta e nelle province diTrento e Bolzano
I risultati delle elezioni che si sono svolte nelle regioni e nel-le provincie autonome della VdA, di Trento e Bolzano non sono comparabili con quelli delle elezioni nazionali per la radicale in-congruenza tra il sistema nazionale e i rispettivi sistemi partitici regionali. Eppure, queste competizioni elettorali sono molto im-portanti, specie in VdA e in provincia di Bolzano, per le possibili conseguenze della coabitazione tra i vari gruppi etnico-linguistici e per la relazione tra lo Stato centrale e il territorio. In entrambi i casi, l’affluenza ai seggi è stata relativamente alta (73,02% in VdA e 77,7% nella provincia di Bolzano), e in entrambi i casi i partiti etnico-regionalisti hanno confermato il loro predominio elettorale e politico. In VdA, la coalizione regionalista di centro-destra (Uv-Sa-Fa) ha vinto, ancora una volta, con un ampio margine, ottenendo il 47,9% dei consensi. La coalizione regionale di centro-sinistra, che
17Le elezioni regionali e locali del 2013
raccoglie partiti regionalisti e la branca regionale del Pd, è arrivata seconda con il 40,42%; mentre il M5s si è fermato al 6,62%. La destra regionale è pressoché scomparsa, insieme al Pdl, restando al di sotto del 5%. Nella provincia di Bolzano, i tre partiti che rappresentano la popolazione di lingua tedesca hanno ottenuto il 70,8% dei voti (il 72,9 inclusa la lista ladina), riflettendo più o meno l’incidenza numerica del gruppo etnico tedesco. La rappre-sentanza politica della popolazione di lingua italiana ha raggiunto un livello massimo di frammentazione, con nove partiti che si divi-devano meno del 20% dei voti e il più grande (il Pd) che arrivava appena al 6,7%. Il partito interetnico Verde ha ottenuto un buon risultato (l’8,7%), crescendo di circa tre punti percentuali rispetto alle elezioni del 2008.
Ma il risultato più importante di questa consultazione è stato un decisivo spostamento di voti all’interno del gruppo etnico tede-sco, dalla moderata Svp (–2,4) alle radicali-secessioniste Df (+3,6) e S-Tf (+2,3). Gli errori della precedente amministrazione Svp (spe-cie gli enormi costi sostenuti per costruire l’inutile aeroporto di Bolzano) e le strategie estremiste dei partiti radicali filo-tedeschi hanno avuto chiaramente un impatto considerevole. Anche se pos-sono apparire limitate, le perdite subite dalla Svp hanno avuto un effetto cruciale: per la prima volta dal 1948, il partito più rappre-sentativo (e quasi sempre moderato) del gruppo etnico tedesco non avrà la maggioranza dei seggi all’assemblea provinciale. Analizzare in dettaglio tutte le implicazioni di questo evento storico esula dalle finalità del presente contributo. Non è difficile dimostrare, tuttavia, che questi cambiamenti potrebbero portare a una ripolarizzazione delle relazioni interetniche nella provincia di Bolzano e/o riaprire il dibattito sulla posizione istituzionale di quella provincia all’interno dell’Italia.
Quanto al Trentino, in passato questa regione presentava no-tevoli affinità con il livello nazionale sia in termini di offerta po-litica sia in termini di comportamento elettorale. Ma questa volta i risultati hanno messo in mostra un sistema partitico altamente regionalizzato. Un 38% dei voti è andato a partiti e liste regionalisti che non hanno la benché minima relazione con i partiti nazionali (Patt, Ual, Progetto Trentino), mentre più del 13% dei voti è an-dato all’Upt, che rimane un partito regionale anche se il suo leader Lorenzo Dellai è membro di Sc. Rossi, leader di una coalizione centrista-regionalista (Pd, Patt, Upt, Ual, ecc.), ha vinto con un am-pissimo margine. La sorpresa principale è che la destra nazionale si è presentata divisa e non è arrivata seconda nella competizione elet-torale (la LN con il 6,2% e Forza Trentino, un’emanazione del Pdl,
18 Le elezioni regionali e locali del 2013
con il 4,4). Il principale avversario di Rossi era invece Mosna, il lea-der di un’altra coalizione centrista-regionalista (Progetto Trentino e altre liste minori). I risultati evidenziavano anche la performance insoddisfacente del M5s (5,8%), a conferma del trend già osservato nei contesti fortemente regionalizzati della VdA e dell’Alto Adige.
6. Risultati delle elezioni comunali di Roma e di altre ele-zioni locali
L’esito complessivo delle elezioni locali è stato una netta vittoria del centro-sinistra, e in primis del suo partito principale, il Pd. Il centro-sinistra ha assunto il controllo del 57,6% dei Comuni oltre 15.000 abitanti. La coalizione di destra ne ha conquistati appena il 15,2%, mentre nel 26,2% dei casi la vittoria è andata a liste civiche locali non legate ai partiti nazionali. I partiti terzi hanno assunto il controllo di sei consigli comunali: due sono andati al M5s, due alla sinistra, uno al centro-destra e uno all’estrema de-stra. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, i loro risultati confermano sia la schiacciante vittoria del centro-sinistra, che ha vinto dappertutto (portando via cinque capoluoghi di provincia alla destra e uno alla sinistra) sia il predominio elettorale delle due coalizioni principali: solo in due casi (Avellino e Massa) il centro ha superato la destra come avversario principale del centro-sinistra. Particolarmente bassi, rispetto sia alle elezioni nazionali sia alle elezioni regionali, sono stati i consensi ottenuti dal M5s. In quasi tutti i capoluoghi di provincia, specie al di fuori dell’Italia centrale, il nuovo partito è rimasto sotto il 10%, il minimo e il massimo li ha toccati, rispettivamente, ad Avellino (3,1%) e ad Ancona (14,0%). Può sembrare un paradosso, ma il movimento/partito che era nato con una elevata focalizzazione programmatica sui problemi locali (acqua, termovalorizzatori, case, ecc.) e con l’obiettivo di fare da cane da guardia per i cittadini all’interno dei consigli comunali, si è trasformato rapidamente in una forza politica prevalentemente nazionale. L’affluenza alle urne è stata molto bassa praticamente dappertutto, in linea con i trend emersi nelle elezioni nazionali, e ancor di più in quelle regionali.
Per ragioni di spazio riportiamo solo i risultati del comune di Roma. Al secondo turno (a cui possono partecipare solo i due candidati più votati), Marino (Pd) ha sconfitto il sindaco uscente Alemanno con un’ampia maggioranza: il 64% contro il 36%. La tabella 4 riporta i risultati elettorali del primo turno, a cui hanno partecipato tutte le forze politiche e i relativi candidati a sindaco.
Tab. 4
. R
isul
tati
ele
zion
i co
mun
ali
del
26 e
27
mag
gio
di R
omaa
Can
dida
tiD
e V
itoM
arin
oM
arch
ini
Ale
man
noA
ltri
Vot
i14
9.66
551
2.27
011
4.16
936
4.33
762
.444
% v
oti
12,4
42,6
9,4
30,3
5,3
Coa
lizio
neM
5sC
entr
o-si
nist
raM
arch
ini
Des
tra
Alt
ri
Vot
i13
0.63
543
3.71
479
.607
323.
272
51.6
83%
vot
i12
,842
,57,
831
,75,
2D
iffe
renz
a 20
08-2
013
+10
,2–4
,7+
4,5
–7,9
–Se
ggi
329
211
–
Lis
teM
5sPd
Lis
ta
Mar
ino
Sel
Alt
ri c
entr
o-si
nist
raM
arch
ini
Pdl
FdI
Cit
tadi
ni
per
Rom
aA
ltri
de
stra
Alt
ri
Vot
i13
0.63
526
7.60
575
.494
63.7
2826
.887
79.6
0719
5.74
960
.375
50.2
3916
.909
51.6
83%
vot
i12
,826
,57,
46,
32,
67,
819
,25,
94,
91,
65,
2D
iffe
renz
a 20
08-2
013
+10
,2–7
,7–
––
––1
7,3b
––
––
Segg
i3
195
41
27
22
––
a A
fflu
enza
: 52,
81%
, la
diff
eren
za c
on le
pre
cede
nti e
lezi
oni d
el 2
008
è di
–22
,85
punt
i per
cent
uali.
b Se
la p
erce
ntua
le d
i vot
i di F
dI s
i som
ma
a qu
ella
del
Pdl
, la
perd
ita
di c
onse
nsi r
ispe
tto
al 2
008
scen
de a
13,
29 p
unti
per
cent
uali.
Font
e: N
ostr
a el
abor
azio
ne s
u da
ti p
rovv
isor
i del
min
iste
ro d
ell’I
nter
no –
Dir
ezio
ne c
entr
ale
per
i ser
vizi
ele
ttor
ali.
20 Le elezioni regionali e locali del 2013
Com’era prevedibile, la ripartizione percentuale dei voti tra le due coalizioni principali ha riflettuto molto da vicino quella delle elezioni regionali del Lazio. Per contro, i risultati del M5s eviden-ziavano differenze significative, perché il nuovo partito ha fatto decisamente meglio alle regionali che alle comunali. Un confronto con le ultime comunali mette in luce un fortissimo calo dell’af-fluenza e perdite considerevoli per i due partiti principali: il Pd, e in misura molto maggiore, il Pdl. Le perdite subite dalle due mag-giori coalizioni sono state limitate dalla presenza di liste personali o civiche (soprattutto la lista Marino) a supporto dei loro candidati alla presidenza, ma restano consistenti e dimostrano un progressivo indebolimento della logica bipolare al primo turno delle elezioni. Ma come si è visto alle elezioni regionali della Lombardia e del La-zio, la competizione bipolare rimane forte rispetto ai risultati delle elezioni nazionali, nonostante la presenza di un candidato locale indipendente (Marchini). I partiti terzi, in particolare il M5s, hanno fatto molto peggio che alle elezioni per il Parlamento, confermando il già accennato effetto inverso di secondo livello.
7. Considerazioni conclusive
La nostra analisi delle elezioni subnazionali del 2013 ci ha por-tato a mettere in luce diversi punti, alcuni del tutto in linea con i trend delle elezioni nazionali, altri in netta controtendenza rispet-to ai risultati delle elezioni nazionali, e altri ancora peculiari delle dinamiche politiche che caratterizzano le singole unità territoriali. Primo, tutte le elezioni subnazionali che non si sono svolte in con-comitanza con le elezioni generali (Lombardia, Lazio e Molise) o in contesti di competizione etnica (VdA e provincia di Bolzano) hanno fatto registrare un sensibile calo nell’affluenza alle urne rispetto alle ultime elezioni dello stesso tipo. Questo risultato è perfettamente in linea con il calo dell’affluenza registrato alle elezioni nazionali, e più in generale con i bassi livelli di fiducia accordati a tutte le istituzioni politiche nazionali nei due anni precedenti. Inoltre, i livelli di affluenza sono stati molto più bassi alle elezioni subnazio-nali che alle elezioni generali (sempre con le eccezioni della VdA, della provincia di Bolzano e delle tre regioni dove si è votato in contemporanea con le elezioni nazionali), a conferma dello status «secondario» di quasi tutte le competizioni elettorali subnazionali.
In termini di coalizioni/partiti vincenti, si può osservare una certa sovrapponibilità tra i risultati delle elezioni nazionali per la Camera e i risultati delle elezioni subnazionali, che hanno visto la
21Le elezioni regionali e locali del 2013
vittoria del centro-sinistra. Nelle consultazioni subnazionali, questa vittoria era molto accentuata, perché il Pd rimaneva, di gran lunga, il maggior partito nazionale nei sistemi partitici regionalizzati (VdA, province di Trento e Bolzano); mentre in quasi tutte le elezioni re-gionali e locali il centro-sinistra ha vinto la contesa per il presidente o per il sindaco, con l’importante eccezione della Lombardia. Par-ticolarmente significativa è stata la riconquista del Lazio, di Roma, del Fvg, del Molise e di sei capoluoghi provinciali sparsi in tutta Italia. Vale altresì la pena di notare che (diversamente da quanto è accaduto alle elezioni comunali di Milano del 2011), il centro-sinistra ha vinto la maggior parte di questi confronti con candidati provenienti dai ranghi del partito, benché non strettamente associa-ti alla leadership storica del Pd. Per la destra, l’unica consolazione è stata la conferma della roccaforte lombarda.
Guardando più in generale alle preferenze per i partiti o per le coalizioni, sembrava emergere un andamento a sorpresa, una sorta di «effetto inverso di secondo livello». La dinamica bipolare della competizione elettorale che caratterizzava sia la politica nazionale sia la politica subnazionale nella Seconda Repubblica, pur indebo-lita a tutti i livelli, sembra rimanere notevolmente più pronunciata a livello subnazionale (specialmente regionale) che a livello nazio-nale. In altre parole, le coalizioni e i partiti terzi e minori – come il M5s, la coalizione di centro-destra, Fpfd e la coalizione di sinistra – hanno fatto molto meglio alle elezioni nazionali che alle elezio-ni subnazionali, sia in presenza sia in assenza della simultaneità verticale. Specie per il M5s, questo andamento potrebbe apparire paradossale, perché il Movimento si è preoccupato principalmente, fino a pochissimo tempo fa, di problemi locali. Abbiamo passato brevemente in rassegna alcune possibili spiegazioni di questo nuovo trend, ma nessuna di esse appare del tutto convincente. In parti-colare, il differenziale degli effetti di leadership tra i diversi livelli elettorali non convince pienamente perché, da una parte, Grillo ha fatto campagna elettorale anche in alcune elezioni regionali mentre, dall’altra, i candidati alla presidenza regionale dei «partiti terzi» (specie quelli del M5s) hanno ottenuto più voti delle rispettive liste di partito. Il differenziale di reputazione della classe politica tra i due livelli non appare convincente a causa dei recenti scandali che hanno coinvolto soprattutto i partiti principali. Infine, le differenze tra i sistemi istituzionali/elettorali potrebbero spiegare un effetto psicologico più marcato a livello regionale, in favore del bipola-rismo. Più in dettaglio, l’elezione diretta del presidente regionale potrebbe promuovere il voto strategico anche nella scelta delle liste di partito. Ma anche il sistema di voto in uso per la Camera offre,
22 Le elezioni regionali e locali del 2013
in teoria, grossi incentivi al voto strategico e alla competizione po-polare. Forse, questi incentivi diventano meno stringenti perché gli elettori sanno che i risultati della Camera bassa non bastano a determinare la formazione del governo (che dipende anche dal Senato).
In alcuni casi, come quelli della provincia di Bolzano e della Lombardia, i risultati delle elezioni innescheranno probabilmente conflitti politici multilivello e territoriali. Nella provincia di Bol-zano, la crescita dei partiti radicali-secessionisti di lingua tedesca può portare a una nuova polarizzazione delle relazioni interetniche all’interno della regione e alla riapertura della questione sudtirole-se a livello nazionale. Sotto la crescente pressione di questi nuovi sfidanti, la tradizionalmente moderata Svp potrebbe essere indotta a radicalizzare la propria linea, sia in provincia di Bolzano sia nei confronti di Roma. Analogamente, la vittoria di Maroni in Lombar-dia e il controllo contestuale delle tre regioni principali del nord da parte della LN potrebbero rinvigorire, tramite una pressione inter-governativa multilivello, il «vento del nord» che ha sostenuto due decenni di programmi neofederalisti e, in qualche misura, di rifor-me. Bisogna osservare peraltro che le condizioni straordinariamente favorevoli determinatesi a livello regionale possono essere pregiudi-cate dalla debolezza della LN sia sul piano organizzativo (perdita di membri/attivisti e continue lotte intestine) sia sul piano elettorale. Inoltre, la marginalizzazione della LN a Roma, quantomeno in ter-mini di partecipazione alla compagine di governo, e l’imposizione di una «disciplina di bilancio», sembrano aver determinato, insieme al fallimento della riforma fiscale in senso federalista (2009-2011), un frettoloso accantonamento del discorso neofederalista.
Note1 Le province autonome di Trento (o Trentino) e di Bolzano (o Alto Adige)
si possono considerare regioni de facto sia per gli ampi poteri di cui dispongono sia perché la regione Trentino-Alto Adige è ormai diventata un’entità pressoché formale (a partire dal 1988 l’assemblea regionale non è altro che la riunione delle due assemblee regionali).
2 F. Tronconi e C. Roux, The Political Systems of Italian Regions between State-wide Logics and Increasing Differentiation, in «Modern Italy», vol. 14, n. 4, 2009, pp. 151-166; E. Massetti e G. Sandri, Italy: Between Growing Incongruence and Region-Specific Dynamics, in R. Dandoy e A.H. Schakel (a cura di), Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Coun-tries, Basingstoke, Palgrave, 2013, pp. 142-162.
3 E. Massetti e S. Toubeau, Sailing with Northern Winds: Party Politics and Fed-eral Reforms in Italy, in «West European Politics», vol. 36, n. 2, 2013, pp. 359-381.
23Le elezioni regionali e locali del 2013
4 Nel 2015 Veneto e Piemonte torneranno alle urne, insieme alla maggior parte delle altre regioni, perciò è possibile che risultati diversi vengano a modificare le priorità politiche.
5 N. Bolleyer, Intergovernmental Cooperation. Rational Choices in Federal Sys-tems and Beyond, Oxford, Oxford University Press, 2009.
6 E. Massetti, Federal Reform: The End of the Beginning or the Beginning of the End?, in A. Bosco e D. McDonnell (a cura di), Italian Politics. From Berlusconi to Monti. Ed. 2011, Oxford, Berghahn, 2012, pp. 137-154.
7 K. Reif, Second-order Elections, in «European Journal of Political Research», vol. 31, n. 1, 1997, pp. 115-121.
8 A.H. Schakel e C. Jeffery, Are Regional Elections Really Second-order?, in «Regional Studies», vol. 47, n. 3, 2013, pp. 323-341.
9 Elezioni Friuli, vince Serracchiani. Pd e Pdl tengono, crolla M5s, «la Repubbli-ca», 22 aprile 2013; A. Punzo, Elezioni in Friuli: Il M5s perde 90mila voti. Il grillino friulano Battista: «Colpa dell’astensionismo e della linea intransigente sul governo», «Huffington Post», 23 aprile 2013.