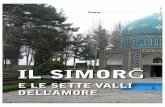Sviluppo economico e istituzioni locali del Lodigiano nel secondo Novecento, in Ambizioni e...
Transcript of Sviluppo economico e istituzioni locali del Lodigiano nel secondo Novecento, in Ambizioni e...
5
Indice
Ambizioni e reputazioni, di Pietro Cafaro
Parte prima Età moderna e passaggio al contemporaneo
1. Godere di credito. Finanza e istituzioni nella costruzione dell’élite lodigiana tra Seicento e Ottocento, di Marco Dotti
2.BeneficiecostruzionidiéliteaLodi(XVIII-XIXsecolo),diEmanuele C. Colombo
3. Appendice
Parte seconda Età contemporanea
4.Élite ed istituzioni nel Lodigiano tra Otto e Novecento, di Enrico Berbenni
5.SviluppoeconomicoeistituzionilocalidelLodigianonelse-condoNovecento,diAndrea Salini
Indice dei nomi
pag. 7
» 13
» 47» 77
» 143
» 183
» 217
7
Ambizioni e reputazioni
di Pietro Cafaro
Generalmente,lastoriadeicetielitariinItaliaèstataricostruitainmo-dostatico,focalizzandosiiricercatoriinparticolaresultemadell’iscrizioneallanobiltàoppure,perquelcheriguarda l’etàcontemporanea,sul rappor-totraborghesiaericchezza.Piùraramente,lastoriaeconomicaesocialesièinvecemisurataconanalisiditipopiùdinamico,inteseachiarirelepra-ticheconcreteadottatedaigruppisocialiperemergere1.Questoè invecel’obiettivodelvolume,comedichiaratofindalsuotito-
lo,Ambizioniereputazioni.AttraversoquestachiavediletturalastoriadialcunedellefamigliepiùrilevantidiunaLodiormaiscomparsa,appareinunanuova luceepermettedipoter formularealcuneconclusionigenerali.Laprincipaleèchesedauncertopuntodivistarisultaconfermatalatra-dizionalediscontinuitàtraanticoregimeedetàindustriale,dall’altroalcunistrumenticomeibeneficiecclesiasticitendonoamantenereunacertaforzafinoalNovecento2.Èquesto inparticolare il temadella primaparte del volume, scritta da
Marco Dotti e da Emanuele Camillo Colombo, che si concentra sull’etàmodernafinoallaprimametàdell’Ottocento.Inparticolare,ilsaggiodiDottidescriveunasocietàlocaletutt’altroche
immobileedimmutabilemacontinuamenteridisegnatadallepratichecari-tativeefinanziarie(lequaliinbuonapartecoincidono,omegliovedonoinazionegli stessi soggetti).L’analisi si soffermasui legatigestitidall’Ospe-
1.Cfr.peresempioP.Macry,Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Tori-no, 1988; A. Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento,Venezia,1989;E. Grendi, I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero, Torino, 1997.
2.Nella leggediconversionedel7 luglio1866,art.11, ibeneficiparrocchiali furonol’unica categoria di beni ecclesiastici non contemplati, sfuggendo dunque all’eversione,cfr. G. Forchielli, Beneficio ecclesiastico, in Novissimo digesto italiano II,Totino,1958,pp.357-445.
8
daleMaggiore,cherealizzanounaduplicefunzioneperformativa:“ricorda-reilsingolo”e“trasmettere”uncapitalesimbolico–oltrecheeconomico–alla famiglia. Inquestocontestosievidenziaanche ilvalorecomunicativoe simbolicodeibeniutilizzati inquestogeneredi trasferimenti. Imembridell’élite, tra Seicento e Settecento, cominciano ad utilizzare le entrate fi-scalialienatedellacittàeicreditineiconfrontidellecomunitàlocalietal-voltadeiprivati,siaperlacostituzionedeilegatiedeibeneficicheperbe-neficare i luoghipii.Perquestaviaglienti localidivengonodigranlungaiprincipalidetentorideldebitopubblicolocale,lecuirenditefinisconocolfinanziarequelleche,conunlinguaggiooggipernoiusuale,potremmofa-cilmentedefinireesternalitàpositive,spendibilisoprattuttonelsostegnodelwelfare. Questo sistema di legittimazione e di costruzione di reputazionitendeadincanalarelevelleitàfamiliarientromodelliistituzionalicollegia-li3,comel’Incoronatael’OspedaleMaggiore.Iltemadicomeagisconolefamiglielodigianeperraggiungereemante-
nere uno status economicoesocialeelevatoèaffrontatoanchedaColom-bo, attraverso un’indagine rivolta in specifico ai benefici ecclesiastici.Co-meènoto,ibeneficifuronoinanticoregimeunodeglistrumentipiùusatidalle famiglie, nobili e non, per garantire una carriera ai propri cadetti eallo stesso tempo per proteggere parte del loro patrimonio familiare.Manonsolo.Ibeneficirappresentanopiùingeneralelabaseperrealizzarepiùampie promozioni sociali, consentendo in diversi casi alle famiglie di en-trarea farpartedelleélite.LapromozionedellaparrocchialediCodognoacollegiatanel1678neèuncalzanteesempio:unluogo(Codogno)èrico-nosciuto come“comunitàmaggiore”,mentre al tempo stesso alcune fami-glie(quellechehannofornitoicapitalinecessariall’erezionedellacollegia-ta) ottengono in cambio un canonicato. I dodici canonicati corrispondonodunqueallefamigliepiùimportantiinquelmomento,chesisonoauto-pro-mosse ehannopromosso al tempo stesso la comunità4. Il saggio analizzaquindi uno dei benefici più importanti della Lodimedioevale emoderna,quello della famiglia Tresseni (oggi estinta), per concludersi con l’anali-sidelconcettodiélitenelcorsodellaRestaurazione.Inparticolare,emergecome lanobiltàufficialmente riconosciuta sia ridottaormaiapoche fami-glie, i cuimembri non sonoormai più coincidenti con le personepiù ric-chediLodi(inappendiceèstatotrascrittounimportantedocumentofinorainedito,cheriportaiprimi100estimatialladatadel1847).
3. Si veda per una definizione di questomodelloN.Terpstra,Abandoned Children of the Italian Renaissance. Orphan Care in Florence and Bologna,Baltimore,2005.
4. Sui benefici milanesi cfr. G. Dell’Oro, Il regio economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei domini sabaudi,Milano,2007,cheanalizzainpar-ticolareisistemidicontrollointrodottidalpoteresovrano.
9
I saggi di EnricoBerbenni edAndrea Salini rappresentano invece unprimoabbozzosultemaperquantoriguardal’etàcontemporanea.Atalfi-ne, i due autori hanno compiuto una ricostruzione generale delle vicen-deeconomichediLodieterritorionelNovecento,cercandodi illuminarespecialmente l’azionedelle istituzionipubbliche.Per risponderealle sfidepostedaimutamenti economici e socialidel secolo si sono infatti rivela-tefondamentalilevisionielepropostedegliamministratorilocalinonchédelle numerose associazioni di categoria presenti sul territorio. In questosenso, il protagonismo della classe dirigente lodigiana può essere intesacomeesempioparadigmaticodicomesièrealizzatoalivellolocaleilmo-dello di rappresentanza pluralista che ha caratterizzato la società italiana nelcorsodelXXsecolo.AncheLodieilLodigiano,comemoltissimiter-ritoridipiccolaemediadimensione, sicaratterizzano, infatti,per lapre-senzadi élite che circolavanomoltofluidamente tra l’associazionismo, lapolitica, ilmondodelcredito, secondounasortadiprincipiodeivasico-municanti.Salini si è soffermato in particolare su alcune esperienze virtuose, og-
gi definite best practices, da cui è possibile cogliere i nodi problemati-ciaffrontatielesoluzionipiùsignificativechehannoguidatoingeneralele azioni orientate allo sviluppo.A questo proposito, un ruolo di aggre-gazione degli interessi e di incubatori di idee venne svolto soprattuttodall’ATSIL (Associazione per la Tutela e lo Sviluppo degli Interessi delLodigiano) e dalConsorzio provincialeper ilmiglioramentodelle condi-zionieconomicheesocialidelLodigiano.Essifacilitaronolamaturazionediunacoscienzacomprensorialetragliamministratoripubblicielepopo-lazionidel territorio, ingradodisuperaregliangusticonfinidegli interes-si locali e campanilistici, gettando lebasi per la creazione alcunidecennipiù tardi dell’istituzioni provinciale di Lodi. Furono gli amministratori dimoltissimi comuni del territorio, sostenuti anchedai dirigenti politici, chesimosseroperdarenuovoslancioeconomicoesocialealLodigianonellaprofondaconsapevolezzadiunamarcatadiversitàediunaspecificapecu-liaritàneiconfrontidelcapoluogomilanese.Paradossalmente, però, proprio negli anni successivi all’istituzione del-
la Provincia di Lodi, che in teoria ha segnato il riconoscimento istituzio-nalediunacoesionesocialeeterritorialedifatto,ilLodigianosiètrovatoadoveraffrontarenuovieprofondimutamenti,riconducibilientroicanonidella grande transizionedel capitalismodi territorio italiano.Reti di rela-zione semprepiù larghe, crescente terziarizzazionedell’attività economicaegrandeinstabilitàdelcontestocompetitivocomplessivohannoresoestre-mamentemutevoleunoscenariocheperdecennierastatostabileecoeso,facendo venirmeno anche l’equilibrio che contraddistingueva il patto so-ciale su cui si fondava la comunità territoriale.Unequilibrio cheva rico-
10
struitoapartiredainuoviparadigmi incui si articolanoeconomia,politi-caecomposizionesociale,inparticolarefraipossessorideicosiddettibenicompetitividiterritorio5,cioèquellerealtàchecontribuisconoaformareogiàcostituisconolenuoveélite localichiamatearicostruire ilnuovopattosocialeattornoaun’identitàcomune,crucialeper lefuturestrategiedigo-vernoedisviluppodituttoilLodigiano.
5.SucuisivedalasintesidiA.Pichierri,Lo sviluppo locale in Europa. Stato dell’arte e prospettive,SoveriaMannelli,2005.
13
1. Godere di credito. Finanza e istituzioni nella costruzione dell’élite lodigiana tra Seicento e Ottocento
di Marco Dotti
La questione delle élite – come disseMaurice Aymard già diversi an-niorsono–haincontratonuovamentel’interessedeglistoricidopounalun-ga emarginazione. In particolare, negli ultimi decenni, la storia sociale equellaeconomicache,aduncertopunto,avevanoprivilegiatodegli“ogget-ti” quantitativi, sono tornate a dedicarsi a tale tematica1. Questo rinnova-tointeressehapermessodiorientarediversamentelosguardo,focalizzandole strategie ed i comportamenti anziché inseguire un’inafferrabile identi-tàdell’élite,oppureun’altrettantosfuggenteculturacomplessiva.Del resto,anche inantico regime,quando la“nobiltà” inqualchemodosegnavaunasoglia, molto labile e confusa nella pratica, ma quantomeno vistosa nellaforma,l’identitànobiliaresiriducevaaduneserciziotautologico2.Pareinquestosensopiùstimolanteunaletturacheprivilegiladimensio-
nedellepratichesociali,volgendolosguardoalcomplessodelleazioniat-traverso lequalisigeneraesi legittimail“verticesostanziale”(aprescin-dere dunque dai titoli nobiliari) della società locale. Si tenterà dunque diguardare alle dinamiche sociali entro le quali erano coinvolte le famiglieegemonidiLodi, interpretando iprocessidiascesasocialesiaattraverso idispositividiaffermazionechemediantequellidilegittimazione.Emerge in questi termini un tratto caratteristico della società barocca,
ovverolasovrapposizionedi“pubblico”e“privato”,mavieneallalucean-
1.Cfr.M.Aymard,Pour une historie des élites dans l’Italie moderne, in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal Quattrocento al Seicento. Fonti e problemi,AttidelCon-vegno,(Milano1-4dicembre1983),Roma,1986,pp.207-19,inparticolare207-9.
2.La stessaossessionedeinobili settecenteschiper ladefinizionediunapropria con-sistenzacetuale, siperdeva inunarassicurantequantodeprimente«[…]ridda tautologica,per cui è nobile chi, nato nobile, vive nobilmente,muore nobilmente e viene nobilmentesepolto[…]».G.Benzoni,A proposito di cultura nobiliare (e non dirigenziale), in M. Pe-grari(acuradi),La società bresciana e l’opera di Giacomo Ceruti,Brescia,1988,pp.183-225.
14
cheunaconfigurazionelocalepeculiare,chetendeadincanalarelevelleitàfamiliari entromodelli istituzionalipercosìdire“collegiali” (li sipotreb-beanchedefinire“comunitari”,tenendoperòpresentelanaturapursempreelitariadelleistituzioniciviche).
1. Ambizioni e celebrazioni
Cercandounapossibilemappaturadeicomportamentidell’élitelodigianainetàmoderna–senzadistingueretranobiliepossidentinontitolati–nonsipuòprescinderedallemodalitàditrasmissioneedimpiegodellaricchez-zaalmomentodellamorte.Ilascitiailuoghipiiedilegatiperlacelebra-zionedimesse,daquestopuntodivista,costituisconounpassaggioquasiirrinunciabileperimembrideicetimedio-alti.
Si tratta, del resto, di una pratica diffusa in gran parte dell’Europa d’an-cien régime, cheè stata invariomodo interpretatadai contemporanei an-corprimachedaglistorici.Adunadiffusaepocoarticolatavisionebene-vola di tale comportamento si alternano letture più complesse e critiche.Nonèdifficiletrovaretraccediunacondanna,ancheaspra,benprimadelcelebreattacco settecentescodiMandeville. Inun raccoltacinquecentescadisentenzemoralisilegge:
Grandeerrorequand’il riccos’indugiafinallamortesuaa far l’elemosina,Etal-loraè liberalediquellochenonpuòportar seco.A lamorte le ricchezze lascia-no i ricchi: et non i ricchi le ricchezze.Noi altri huomini nonmangiamo uccel-li,neanimali,senonquandosonomorti,arrostoòlessi:Cosiavvienea’poveretti,chenonpossonomangiaredellarobbadiquestitaliricchi,finchelamortenongliammazza,lessa,òarrostisce3.
Adun’interpretazionechevede inquestepratiche la ricercadi salvezzain extremis, seneaffiancheràpoiunapiùcomplessa,chevi leggeunavo-lontàdialimentareunafamacheoltrepassi i limitidellapropriaesistenza.AllafinedelSettecentoMandevillescrisse:
L’uomo che finanzia a proprie spese ciò cui si dovrebbe provvedere col denaropubblico apre un credito con ognimembro della società e perciò tutti sono pron-tiadesprimerglilalororiconoscenzaesisentonoobbligatiagiudicarevirtuosetaliazioni,senzaesaminarenéscrutareafondoimotivichehannospintoacompierle4.
3. Effetti mirabili della limosina et sentenze degne di memoria, appartenenti ad essa. Raccolti da Giulio Folco,Verona,1591,p.248.
4.B.DeMandeville,La favola delle api, ovvero vizi privati, pubblici benefici. Con un saggio sulla carità e le scuole di carità e un’indagine sulla natura della società,Roma,1994,p.63.
15
Ciòvaleva,secondol’Autore,soprattuttonelcasodeilascitiadenticari-tativi,«[…]questisonoinfattiimigliorimercatiperacquistarel’immortali-tàconpocomerito»5.Aldilàdellavalutazionemorale,quest’ultimoragionamentometteinlu-
ceduequestioni centrali nell’interpretazionedi tali comportamenti: daunlato c’è il temadel “merito” o, in altri termini, della reputazione di colo-rochelascianopartedellepropriericchezzeadunluogopio;dall’altroc’èl’argomento dellamemoria imperitura. Tuttavia, in questa prospettiva, percertiversiattualizzante,vienealmeno inparte frainteso il sensopramma-tico di questi lasciti; si guarda infatti alla remunerazione in termini indi-viduali, come soddisfacimento della vanità del benefattore, addirittura ascapitodeilegittimieredi.Alcontrario,moltospessoilascitiob piam cau-samedirelativilegati,inetàmoderna,annuncianooproseguonoundialo-gocondottoproprioinnomedeipropriaviedafavoredelpropriolignag-gio,perseguendodunqueunastrategiaeconomicafamiliare.Mancainoltreilnessorituale tra idueaspettichevengonocolti (lacostruzionedellare-putazioneediunamemoria imperitura), ovveroquellodella celebrazione:laripetizionedellemessequotidiane,ebdomadarieedeglianniversaridel-lamorte,neicuicicliprobabilmenterisiedeinbunamisurailsensoultimodella pratica6.Queste riflessioni di carattere generale, tuttavia, ci servono solo, da un
lato, per apprendere la percezione esterna di pratiche ben poco generaliz-zabili;dall’altroperdelineare l’orizzonte“universale”diundiscorso i cuiterminidevonoesserelettinellaloroarticolazionelocale.Percuiciadden-treremo nelle pratiche successorie dell’élite lodigiana, concentrandoci so-prattutto su di una serie particolarmente densa e completa, ovvero quel-ladelleereditàricevuteinetàmodernadall’OspedaleMaggiorediLodi.Ilquadropuò tuttavia essere arricchito e completato con l’analisi, non siste-matica,deilegatigestitidaaltreistituzioniurbane.
5. Ibidem.6.Sullastruttura intimadiqueste“ripetizioni”continuanoadessere illuminanti leos-
servazionidiGillesDeleuze:«Laripetizionecomecondottaecomepuntodivistaconcer-ne una singolarità impermutabile, insostituibile. […] Se lo scambio è il criterio della ge-neralità, il furtoe ildonosonoicriteridellaripetizione.C’èdunquedifferenzaeconomi-catraidueordini.Ripetereècomportarsi,mainrapportoaqualchecosadiunicoodisin-golare, chenonha simileo equivalente.E forse codesta ripetizione comecondotta estre-mariecheggiaperpropriocontounavibrazionepiùsegreta,unaripetizioneinterioreepiùprofondanelsingolarechelaanima.Lafestanonhaaltroparadossoapparente:ripetereun“irricominciabile”.Nonaggiungereunasecondaeunaterzavoltaallaprima,maportarelaprimavoltaall’ennesimapotenza.Sottotalerapportodellapotenza, laripetizionesirove-scia interiorizzandosi;comedicePéguy,nonè la festadellaFederazioneacommemorareorappresentare lapresadellaBastiglia,maè lapresadellaBastigliachefesteggiaeripe-teperprefigurazionetutteleFederazioni[…]».G.Deleuze,Differenza e ripetizione, Mila-no,1997,pp.7-8.
16
Analizzando i legati di giuspatronato dell’Ospedale Maggiore, di cui èpossibileosservare lasequenzanel lungoperiodo,sipuònotarechedal re-moto testamentodiCarloMandelli, risalenteal lontano1325,finoversogliultimidecennidelSeicento,tuttiilegativennerofondatimedianteiltrasferi-mentoditerreniedimmobili(sivedal’appendice).Cerchiamodicomprende-reconcretamente ilmeccanismo:GiulioCodecasa,con il testamentostilatoil14ottobredel1688,stabilìtrelegati,lasciandoneilgiuspatronatoperpetuoall’OspedaleMaggiore.Periprimiduelegati,cheriguardano«lacelebrazio-nediunanniversario»7nellechiesediS.Domenicoenellacattedraledellacittà,venneromesseadisposizione200lireequamentesuddivise.Aquestisiaggiunseunimpegnopiùconsistente:500lirepersovvenzionarelacelebra-zionedi365messeall’annonell’oratoriodiS.SalvatoreaLodivecchio.Spe-secosìconsistentieripetitiverichiedonounsistemadifinanziamentoperma-nente;inquestocasol’ospedaleaffittòunaproprietàdell’ereditànelterritoriodiLodivecchio, il cuivalorevennestimato in12.457 lire. Il testatorestabi-lì inoltreisacerdoti incaricatidellecelebrazioni(rispettivamenteipadrido-menicani, imembri del capitolo della cattedrale ed un cappellano vitaliziodinomina familiare,cheverso lametàdelSettecentoeraGirolamoRanca-ti)el’usodiquantosarebbe«avanzato»dellerenditeannuali,impiegato«permantenereincurabili,poverivecchiimpotentiedementati»8.Lemodalità di questo esempio non si possono certo estendere al “cor-
po” del legati controllati dall’ospedale, dunque per un quadro analitico si rinviaall’appendice.Nondimenolaseriepresenta,quantomenosottoilpro-filodeibeniutilizzatipercostituireilegati,dellecontinuitàedellefratturebenvisibili.Dopounalungafaseincuilemessevengonopagatemediantel’affittodi terreniecase,apartiredallafinedelSeicentosonogli interes-sisuicreditifornitiallacittàarendereoperativiibenefici.Inalcunicasiirettoridell’ospedale,aprescinderedallaformadelcapitalechehannorice-vuto,utilizzanounadeterminatatipologiadirenditepergarantirelaconti-nuitàdellecelebrazioni,ovvero,ancheseil testatorehaversatodeldenarocontante,poggianolostrumentosuunimmobiledell’ente(sullarelativalo-cazione)oppuresuunarenditadellacittà.Ma,anche inquestosenso,per-manelamedesimadiscontinuitàchecomunqueparesuggeritapiùdalcom-portamentodaitestatorineiconfrontidell’entechenonviceversa.A partire dal testamento del ricco causidico Giambattista Gorla, roga-
tonel1658,divenneabitualeoptareperdellerenditesuldebitomunicipale:quasi tutti i successivi legati furono costituitimediante capitali «impiega-tinelpubblicodiLodi»9o,moltopiùraramente,permezzodialtricrediti.
7.ArchiviodiStatodiMilano(ASM),Amministrazione del Fondo di religione,504.8. Ibidem.9. Ibidem.
17
Questimeccanismi sonobenvisibili nelle stessedisposizioni testamen-tariediGiambattistaGorla,sullequalièopportunosoffermarci.Eglieleg-ge come erede universale la moglie Veronica Rho, vincolandone però lasuccessione:«Finalmenteintuttiglialtrisuoibenigeneralmente,salvoco-mesopra instituisceheredeuniversale lad.aSig.raVeronicaRhòsuamo-glie, e quella morendo ò passando alle II nozze, ò premorendo a dettosig.Gorla instituisce overo sostituisce IlVen.doHospitaleGrande di Lo-di[…]»10.All’eredeGiambattistaimposenumerosilegatiperlacelebrazio-ne dimesse, a partire dalle 24 commissionate agli altari «privileggiati»11 siaperilgiornodellamortecheperilseguente.Acuifeceseguitoillega-todi500liredapagareentroquattroanniallaScuoladelSS.Rosarionel-la chiesadiS.Domenico,per celebrareunproporzionatonumerodimes-se. Un altro legato speculare, sia nelle modalità che nell’importo, è statoindirizzato alla Scuola dellaB.V. delCarmine nella chiesa dell’Annuncia-ta.Singolarmenteiltestatoresiaddentranellestessemodalitàdaadoperar-siperilpagamentodeilegati:
[…] con che fosse lecito all’infrascritta sig.ra Veronica Rò sua herede assignaretanti capitali alled.eScuole rispettivamentedaquali si cavassero i frutti equiva-lenticomesopra,efattidettiassegninonpossilaSig.raVeronicaperlipagamentineevittionitantodecapitalicomedelleannueprestazioniessermolestata,màfattiliassegnis’intendis’intendi[sic.] liberadalcaricodidetti legati;epossanodetteScuolelidettipagamentiecapitaliriscuotereefareliconfessieliberationi[…]12.
Emergono da questi passaggi alcuni elementi rilevanti: oltre allemesseprescrittedirettamenteall’ospedale(sivedasemprel’appendice) il testatoretenneadisegnareunabenprecisatopografiadellecelebrazioni;insecondoluogo indicò l’investimentofinanziariocomelostrumento idoneoall’istitu-zione dei legati; infine distrasse dall’erede ogni responsabilità sull’affida-bilitàdeldebitorepubblicooprivato che fosse.La logicadeldiscorso, sinqui cristallina, s’intorbidisce un poco nel seguito. Probabilmente per evi-tareognigenerediliteilGorlasuggerisce«[…]chenell’attodipagamentodi detti capitali s’habbinod’impiegare in qualcheproprietà idoneanelLo-diggiano di qua dell’Adda, e redimendosi, sempre s’habbino ad impiegare,e convertirsi perpetuamente la rendita d’essi nella celebrazione sodd.a»13. Sembrerebbe indicare una ulteriore destinazione dei capitali (la cui natu-rafinanziariaèevidentevistochenederivano«frutti»,«rendite»e«annue
10.Archivio storico-civicodiLodi (d’ora inpoiASCL),Archivio dell’Ospedale Mag-giore p.a., 19. Eredità, Libro Heredità Gorla, p. 3.
11.Ivi,p.1.12.Ivi,p.3.13. Ibidem.
18
prestazioni»)nell’acquistodiunaterraopiùprobabilmentenellacostituzio-ne di un censo consegnativo14 (come suggerirebbe il termine «redimendo-si»).Ma,probabilmente,daquestodiscorsotraspare il timorecheil lascitodivengaoggettodellemalversazionideiconfratelli,percuisi indicaun’op-zioneaidestinataridellegatoinmodoche,daunlatononpossanorivendi-care alcunché per l’eventuale inadempienza dei debitori, dall’altro – comediviene esplicito nella conclusione – non possano per così dire “prestarsi”agevolmenteildenaro.Infattiiltestatoreconcluseilragionamentoproiben-do«[…]l’impiegoinalcunodescolaridelled.eScuole,overalcunloropa-renteòinteressatoinqualsivogliamanieraperdegnecause,caricandoinciòlaconscienzadidettiscolari,econtravenendoàciòprivad.aScuoladid.oLegato,evuolechepervenghineld.oHospitaleMaggiorediLodi[…]»15.Questo discorso, al di là della prolissità e della complessità, ha come
obiettivoprincipalequelloditutelareillegato,chesignificasoprattuttoga-rantirneladuratao–sulpianoideale–l’eternità.GiambattistaGorlasape-vabenechemoltospessolecelebrazionipost mortemvenivanoalimentatepermezzodirenditefinanziarie.Sapevaaltrettantobenechelariscossioneditalicreditieranondiradoonerosaodifficile,anchenelcasodeidebito-ri“pubblici”,percuilefamiglietendevanoaindirizzarliversoleistituzio-ni (che sicuramenteerano ingradodiproteggerlimeglio)equesteultime,più omeno pretestuosamente, usavano l’inadempienza dei debitori per ri-durre le prestazioni di loro competenza. Lo si evince anche da un’ultimaaggiunta,postaimmediatamentedopolaminacciadisottrarre il legatoal-leconfraternitenelcasononrispettinoiltestamento:«[…]ecasochecircal’accettazionenaschiqualchecontroversiaevisianocapitalichepotesseroassegnarsipiùfacilmente,quellilasciapertitolodilegato[…]»16.Lafinalitàèribaditacosìcomel’intenzionediperseguirlaconognimez-
zo.Ma è chiaro che l’impiego di crediti nei confronti della città presen-
14.Suquestistrumentidicreditosiveda:L.Faccini,La Lombardia fra Seicento e Set-tecento. Riconversione economica e mutamenti sociali, Milano, 1988, p. 44. Per un quadro generaledellepratichefinanziarielocalimipermettodirimandarea:Cfr.E.ColomboeM.Dotti, Oikonomia urbana. Uno spaccato di Lodi in età moderna,Milano,2011,pp.17-29
15. ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., 19, Eredità, Libro Heredità Gorla, pp.3-4.Questoatteggiamento,peraltro,esprimeun’ampiadivaricazionetralafiduciaripo-stadaltestatorenell’OspedaleMaggioreequella,benmenosolida,ripostanelleconfrater-niteincaricatedipresiederelemesse.Indicazionidiquestogeneredigenerenonsonodeltutto insolite,nella fondazionedell’OspedaleFissiraga–altrograndecasodi“discenden-za”istituzionale–sispecificache«[…]nonsipossaammettereindeputatooministrodelPioLuogochisiaCreditore,oDebitore,oabbiaqualunqueInteressesiattivochepassivocolmedesimo[…]».ASM,Amministrazione del Fondo di religione,504,Ospitale Fissira-ga,p.2v.
16.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., 19, Eredità, Libro Heredità Gorla, p. 4.
19
tanotevolivantaggi:perenticomel’OspedaleMaggiore,icuiamministra-torisonoampiamenteintrodottinelconsigliodellacittà,èmoltopiùfacilegarantire la continuità delle contribuzioni annuali. Inoltre (come vedremopiù diffusamente nel paragrafo successivo) questi titoli esprimonomegliodialtriuncreditosocialeancorprimacheunarenditafinanziaria,diconse-guenzanonc’èmodomiglioreperevidenziarne ilprestigio intrinsecochericordarlo continuamente. Infatti, quantomenoperquanto concerne i prin-cipali legatiperpetuidell’ereditàGorla,chevengonoancoraadempiutipiùdiunsecolodopo,lerenditesonogarantitedaunacasaaLodi,daunlivel-lopagatosu60pertichedi terrasituatenel territoriodiCastioneesoprat-tuttodauncapitaledi7.000investitonellacittàcherendeil3,5%17.Se allarghiamo lo sguardo al di là dell’ospedale, abbracciando le pra-
tiche religiose e devozionali della società locale nel loro complesso, pos-siamo notare che non si tratta assolutamente di una novità: fin dall’iniziodell’etàmodernal’élitelodigianausòipropricreditineiconfrontidellacit-tàperfinanziaremessepro salute animae.GiànelCinquecentogranpar-tedellecelebrazioniespletatenellachiesadelmonasterodiS.Chiarasonofinanziatemediante rendite della città.MargheritaCagnola, nel suo testa-mentodel1557,disposeunlegatoafavoredellemonacheconilqualetra-sferì loro la titolaritàdi un«redditodi cameradapagarsidai daziari del-lacittàdiLodi»18di66liree4soldiall’annoche,nelcorsodelSeicento,siridusseroa44liree8soldiperviadelledisposizionigovernative.Lemo-nache si obbligarono a far celebrare 18 messe ogni anno per la salvezzadell’animadella testatrice.MargheritaFasoliutilizzòasuavoltauncredi-toversolacittàquando,conilsuotestamentodel19luglio1593,elesseco-mesuoeredeuniversalel’OspedaleMaggiorediLodi,prescrivendoperòaisuoideputatidiversare60lirel’annoallemonachediS.Chiaraperlace-lebrazionediduemesseebdomadarie19.Tuttavia,ancheguardandoalqua-dro complessivo, si evidenzia un trend piuttosto chiaro: nel corso dell’an-tico regime divenne sempre più frequente l’uso dei debiti locali per ilfinanziamentodellecelebrazionireligiose.
Del resto, anche al di là dell’esperienza lodigiana, le entrate alienate del-lecittàed iprestiti allecomunità furonogli strumentiprediletti inquestepratiche, ma talvolta si utilizzarono anche dei censi stipulati tra privati eaddiritturadeidebiticommerciali.Se,anchedaquestopuntodivista,espe-rienzediversenonpossanoesseredeltuttoassimilate(edunqueconsidera-
17. ASM, Amministrazione del fondo di religione,504.18. ASM, Archivio generale del fondo di religione, 5.152, Legati S. Chiara nuova.19. Ibidem. Il dato è confermato anche da un’altra fonte: ASM, Amministrazione del
fondo di religione,504.
20
te echi di un’unicamatrice), emerge comunque una certa “iteratività”.VenesonovistosiesempiancheinaltrecittàdelloStato20. Laddovenonvisiagiàamonteundispositivocapaceditradurrediretta-
menteiproventidelcreditoincelebrazioniefunzioniistituzionali,chiam-ministra gli enti religiosi vede nella rendita finanziaria ilmiglior sistemaperalimentarelespesechesiripetonoconmaggiorcostanza.Unaltrocasoeclatanteèquellodell’ereditàdiAlessandroCarminati,in-
dirizzata all’ospedale con il testamento del 10 luglio 1697. Si tratta di unlascitomoltoconsistente,di conseguenzaanche lamatassadei legati è al-quantodensa;oltre aquello«permesse»21 di3.553 lire a favoredeipadriagostiniani di S.Agnese, ci sono diverse altre obbligazioni.Le più consi-stentiriguardanoimembridellafamigliachehannointrapresodellecarrie-reecclesiastiche:leduesuoreCamillaedEugeniaMargheritaCarminatiedonRemigioCarminari.Significativamentevennebeneficataanchelacon-fraternita dell’Incoronata che, insieme all’ospedale, rappresenta per l’élitelocaleilprincipalepuntodiriferimento.Dall’altro lato le «sostanze» di cui si compone l’eredità sono alquan-
to eterogenee: un gran numero di proprietà immobiliari, tra cui case, ter-reni,sedumi,bottegheedunaltrettantoriccoassortimentodicrediti.Tantoper fare un esempio concreto,MarcantonioScrozzolani deve alCarmina-ti10.000 lire con l’interessedel4%22. Ma, anche in questo caso, le rendi-tedella cittàdivennerobenpresto laprincipalevoced’entratafinanziaria.Unagrandeproprietà appartenente adAlessandroCarminati venneacqui-stata dal conteGio. BattaModegnani che, per il pagamento, versò diver-
20.Nel1657,seguendoilmedesimoiter,ilcomascoBenedettoManticaistituìunacap-pellania nella chiesa di S.Giovanni Battista Pedimonte: assegnò 9 redditi sul dazio del-lamercanziadiComo,stabilendoinoltreunacomplessaturnazionedifamiglietitolarideldirittodinominadelcappellano.Nellastessacittàecon imedesimistrumenti sonostatefondatedallefamiglieGallioeCortilebenpiùcelebri“mansionarie”delduomo.Edanco-ra,nelsoloattodifondazionedell’OperapiaGallio,lafamigliafondatricedisponeafavo-redell’enteunarenditadel5%(ridottapoinel1693al3%)suuncapitaledi125.000lire,suidazialienatidicarne,farinaepanedellacittàdiComo.Perquantoriguardalacappel-laniaMantica:ASM,Finanze Reddituari,49,CappellaniadiS.BenedettoinS.Gio.BattaeS.Gio.EvangelistaalPiededelMonteinComo,testamentodel7/5/1657.Perl’OperapiaGallio:ASM,Luoghi pii, 125.
L’usodicreditineiconfrontidellecomunitàperistituirecappellanieebeneficareiluo-ghipiiurbanièstato,nelcasodiTorinoedellecampagnepiemontesi,oggettodistudise-minali. Cfr. S. Cerutti, Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino, seco-li XVII-XVIII, Torino, 1992, in particolare per il controllo e l’indebitamento delle comu-nitàpp.112-157;A.Torre,Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime, Venezia, 1995, sull’uso devozionale, politico e strategico dei creditineiconfrontidellecomunitàp.XXI,pp.172-225.
21. ASM, Amministrazione del fondo di religione,504.22.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., 6, Eredità,Terzo Libro Mastro de’
debitori e creditori della Eredità del fu sig. Alessandro Carminati, p. 9.
21
sicapitalisuiqualilacittàpagavail4%.Sitrattarispettivamentedicreditiper16.000,3.000,1.400,2.100e4.542liree10soldiperuncapitalecom-plessivodi27.042liree10soldi23.Al di là della natura delle risorse impiegate – su cui ci soffermeremo
maggiormente più avanti – quella dellemesse non era certo l’unica formadi ripetizione rituale in uso. Molti legati, soprattutto quando il testatore non avevafiglimaschiel’eredeuniversaleeraunentereligioso,disponevanodeivitalizi a favore dei propri propinqui, prevedendo la costituzione della do-tedifiglieenipoti,ilfinanziamentodellacarrieradiunparentereligiosoedaltreprestazionicherientravanonei«giochidisquadra»24dellefamiglieal-tolocate.Maaltrettantospessoprescrivevanoaltri legatichepotremmode-finire“comunicativi”,quali ladistribuzionedipaneodialtreelemosineaipoveridideterminateparrocchiee l’assistenzadotalealdi làdellapropriacerchiaparentale.Quest’ultimafunzioneassumeva,inparticolareperlare-altàurbana,unsignificatonotevole,ancheperchéspessoiltestatorelasciavaaiprimogenitidella suadiscendenza il compitodi selezionare lecandidateal beneficio. In assenza di una discendenza diretta si stabilivano comples-seturnazionidiparentieaffini,oppurealtrettantomacchinosisistemiistitu-zionalidiselezione.Inognicasolasceltacadevaquasisempresucandidate
23.Ivi,p.23.24.Lametaforadei«giochidisquadra»,introdottadaRenataAgo,rendeperfettamen-
telestrategieattraversolequalilefamigliecontribuivanonellatotalitàdeiloromembrial-laconquistadiposizionipreminentiinambitoamministrativooecclesiastico.Cfr.R.Ago,Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo, inM.A.Visce-glia(acuradi),Signori, Patrizi, Cavalieri nell’Età moderna,Bari,1992,pp.256-264.
Tab. 1 - Legati dell’Eredità di Alessandro Carminati
Destinatari del legato Rendita annua (lire)
Confraternitadell’Incoronata 25CapitolodellaCattedrale 16RettoredellachiesadiS.Giacomo 6Rettore della chiesa di S. Mauro 5Rettore della chiesa di S. Bassano 12ConventodiS.Agnese 12Rettore di S. Biagio 2CamillaCarminatimonaca 30DonRemigioCarminati 100EugeniaMaddalenaCarminatimonaca 150
Fonte:ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., 6, Eredità, Terzo Libro Mastro de’ debitori e creditori della Eredità del fu sig. Alessandro Carminati,p.20.
22
appartenenti ai cetimedio-alti se non a famiglie dell’élite cittadina,maga-ricadute inrovinaosegnateeconomicamentedaunacongiunturadifficile,mapursempresunubilidestinateamatrimonisenon“dimassima”quanto-menoonorevoli,oppureastallitutt’altrochedisprezzabiliinsenoaicapitolisecolaridellacittà.Nonèdifficileimmaginarequalivantaggiclientelaripo-tesseroderivaredaunsimile“debito”,masitrattavaanchediundispositivochepermettevadiricordaresiacoluiche istituì ilbeneficiochecoloroche,divoltainvolta,intervenivanonellaselezionedellebeneficiarie.Questi comportamenti si collocano senz’altro su un certo sfondo cultu-
raleespirituale,nonchésulvelochecopreun’irrimediabileincertezzaesi-stenziale, ma non si può certo trascurare il loro aspetto comunicativo estrategico.Con questi dispositivi si sfidava in qualchemodo lamorte permezzodella ripetizione ritualedellecelebrazioni, allo stesso temposi raf-forzavalapropriadiscendenzagraziealleclienteleintessute,siafinanzian-do le carriere ecclesiastiche dei cadetti dell’élite locale che le doti nuziali e spirituali delle nubili lodigiane25.
Tab. 2 - Doti derivanti da legati dispensate dall’Ospedale Maggiore nel 1752
Famiglia del testatore N. doti annue Somma pro capite (lire/soldi/denari)
Leccami 5 50Baroncini 4 50Ceresoli 10 100Pozzi 8 58 2 6Cavenago 4 50
Fonte:ASDL,Ordini religiosi e congregazioni,c.225,OspedaleMaggioreII,Conto generale.
Tab. 3 - Doti dispensate dal Monte di Pietà gestito dall’Incoronata nel 1785
Famiglia del testatore N. doti all’anno Somma pro capite (lire/soldi/denari)
Cinquanta 4 50Bononi 2 122 8Bononi 1 50Piperno 2 252 3
Fonte: ASCL, Incoronata, s. 8.1, c. 3, Allegati del bilancio 1783 per la Tesoreria del Venerando Monte di Pietà amministrato dalla Veneranda Scuola della B.V.M. Incoronata di questa città di Lodi.
25.Sull’usodellacappellaniacomestrumentodiappropriazionedei luoghisacriede-glispazipubblici: J.M.DeSilva,Appropriating Sacred Space: Private Chapel Patronage and Institutional Identity in Sixteenth-century Rome,inThe«CatholicHistoricalReview»,4(2011),653-678.
23
2. Debiti locali, crediti sociali e bene comune
Se,comesièvisto,ilconsumodevozionaleeritualedeicreditidicuisidisponerappresentòuntrattodistintivodell’élitelodigiana,c’eranotuttaviaaltri impieghi altrettanto significativi di queste risorse finanziarie. Inoltre,l’asimmetriaapropriofavorerappresentatadauntitolodicreditocostituivadiperséunfattorediprestigioche,sfruttatocorrettamente,potevadiveni-reancheunsignificativoelementoreputazionale.Il coinvolgimento in rapporti finanziari “attivi” o “passivi” – compreso
dunquel’indebitamento–testimoniainognicasolapienaappartenenzaadunacomunità,ovverodimostrachesidisponediunpatrimonio relaziona-le26.Maèchiaroche,quantomenosulpianodelpotere,ladistribuzionetraledueestremitàdiunrapportodebito/creditoèsemprepiuttostosbilancia-ta. Se la natura di questo potere dipende in gran parte da quella del debito-re, lapossibilitàdi trasformarlo inprestigiodipendeinvecedall’usochesifa del credito di cui si dispone.
è il casodimetterenuovamente allaprova la specificitàdei crediti neiconfronti dei corpi locali (comunità, contadi ecc.) ed in particolare dellacittà.Chi erano i principali creditori della città?Come lo erano divenuti?Quali meccanismi governavano il mercato secondario del debito munici-pale?Nel volumeOikonomia urbana si erano accennate alcuneprovviso-rierisposteataliquestioni,tuttavianoncisierachepotutilimitareados-servare alcuni dati generali ed alcune tendenze, dovendo necessariamenteattendere che un ulteriore approfondimento illuminassemeglio la proble-matica. Si era in quell’occasionemessa in luce la preminenza delle istitu-zioni civiche tra i capitalisti della città, senza tuttavia addentrarsi a fondonénellemotivazionidiquestostatodicose,nénellerelativeconseguenze27.
26.L’indebitamento,senonsiguardaallatestimonianzadiprestigiomasemplicementeaquelladiappartenenza,èanchepiùsignificativodelcreditoapropriofavore:«Sil’endet-tementestunmesuredelapauvreté, ilestaussisigned’appartenanceàdescommunautéssociales […]». L. Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Eu-rope préindustrielle,Paris,2009,p.34.Sivedaanche:Id., La dette comme signe d’appar-tenance dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, in«Finance&BienCommun»,37-38(2010),pp.28-44.InPhilosophie des GeldesGeorgSimmelsuggerisce,medianteunaned-dotolondinese,cheanchel’indebitamentocostituiscaunelementodidistinzione:unviag-giatore di passaggio chiese a unmercante inglese comedistinguere un uomo comunedaun gentlemanedilcommerciante,pernullairretitodalladomanda,rispose:«Unuomoco-muneèchicompradellemercipagandoincontanti,ungentlemanèunapersonaacuifac-ciocreditoechemipagaogniseimesiconunocheque».G.Simmel,Filosofia del denaro, Torino,1984,p.675.
27.Milimitoinquestasedearicordareinsintesiladistribuzionedeldebitomunicipalepercategoriedicapitalisti:28,62%privati,39,89%confraterniteeluoghipii,26,66%cleroregolare,4,62%clerosecolaree0,21%corpiterritoriali.Mentreinappendicesipuòvederel’elencocompleto(ancorainedito)dellepartitedeldebito.
24
ènecessarioperciòarticolarel’ipotesidiun“travaso”sistematicodicreditiavvenutodalle famigliedell’élite urbanaadifferenti tipologiedienti (con-fraternite, ospedali, monasteri ecc.), o meglio, comprenderne il significa-toinuncontestoperilqualelaseparazionetra“pubblico”e“privato”–trafamiglieeistituzionilocali–risultapermoltiversiartificiosa.
Se si cercano i principali creditori settecenteschi della città, del resto, noncisiallontanamaidalcerchioprivilegiatodiun’élitebenradicata.Trai privati il primo posto spetta senza dubbio all’oratore Emilio Sommari-va. Costoi non solo era uno dei grandi protagonisti della scena economi-caepoliticalodigiana,manel1769possedevadasolopiùdel6%deldebi-tomunicipale28.Allo stesso tempo,comeprocuratoredellaCongregazionedel patrimonio era uno dei principali intermediari del debito locale pres-solefamiglieeleistituzioniambrosianeenonsolo.Sitrattaevidentemen-tediunsoggettocheriscuotevaunconsistentecredito,tantointerminipo-liticichefinanziari.Lafunzionesocialeestrategicadeicreditineiconfrontidellacittà,tutta-
via,piùchedauncasocomequellodeiSommarivache–insiemeaiBarni–dominarono la scenasette-ottocentescadellacittà, emergeprobabilmen-teconmaggiorenitidezzasesiosservanofamigliepercosìdireindeclino.UnosquarcioèstatoapertoinquestepaginedaEmanueleColomborispet-toallafamigliaTresseni,ilcuiancoraggioall’éliteurbana,costituitoprinci-palmentedalbeneficiodiS.Martino,harettoaisecoliedalparzialeimpo-verimentoche,anchegrazieaquesto,nonèmaidivenutounveroepropriodeclassamento.Latesidifondoèchelacapacitadipermanerenell’élitelo-cale dipenda in buonamisura da quella di utilizzare le risorse, soprattut-to creando delle istituzioni e occupando degli spazi pubblici. A questa più checondivisibileanalisisipuòaggiungereunulterioreelemento:ilcredito. Il«[…]dott.Vincenzo[Tresseni]defonto il3novembre1780inpoverissi-mostato[…]»29nel1769possedevaancorauncreditodi5.300lireneicon-fronti della città.Possiamo ipotizzarechequesti crediti avesserounvalore strategicoche
potevaessereconservato,comedelrestoèavvenutoneisuddetticasi,man-tenendoli in proprio possesso, oppure potevano essere ulteriormente valo-rizzatimedianteleistituzioni.Perquestaviaunaparteconsistentedeicre-diti che i privati vantavanonei confronti del “pubblico”vennerousati per
28. ASM, Censo p.a., 1.385.Per il ruolodelmarcheseEmilioSommariva siveda:M.Sangalli, Lodi nel Settecento: ceti, stato, società in una periferia della monarchia asburgi-ca,inM.Schianchi(acuradi), Tra due secoli. L’amministrazione della città di Lodi 1706-1859,Bergamo,2008,pp.15-117,inparticolare66-69.
29. ASM, Culto p.a.,376,fasc.8,Supplica di Antonia e Marianna Tresseni,12/9/1783,corsivomio.
25
costituire dei «simboli devozionali»30 o, più in generale, vennero istituzio-nalizzati,nonsoloconsumandolinellafondazionedicappellanieenellace-lebrazione,maanchenellabeneficienzadotale,nell’istituzionediluoghipiieneilascitiindirizzatiaimedesimienti.Solo di recente la storiografia ha cominciato ad illuminare il plesso di
funzioni economiche, sociali ed antropologiche svolte dai titoli del debi-topubblico(localeomeno),chefuronotantounserbatoiodiaccumulazio-neeredistribuzionedelreddito,mettendoalriparodall’inflazionepatrimo-ni destinati alle carriere, alle doti ed ai lasciti ob piam causam(chespessocome si è vistomantenevano un involucro finanziario), quanto un’ulterio-rematricedicredito,andandoacostituire lagaranziaperaltricontrattidicenso31.Inquestosensosistadispiegandonellasuacomplessitàilnodo–osarebbemegliodirelapiega–costituitodalcredito,lacuiplurivocitàpareconfigurarsiinetàbarocca32inmodotantoampio(perquantoconcernegliambititoccati)quantocompresso,sesiguardainveceallaviscositàconcuiavviene loslittamentodaunsignificatoall’altro.Delrestoun’articolazionenondissimilepuòessereosservatanellasovrapposizionedirelazionifinan-ziarie, rapporti sociali e legami affettivi33. Il creditofinanziario, inquestocontesto,celastrutturalmenteunapolisemiachecomprendecreditomorale,creditopoliticoecreditosociale, icuisignificatibenchédistinguibili sonoripiegati l’uno sull’altro34.Inmolte città dello Stato diMilano si rileva che, tra i percettori delle
renditemunicipali,c’èunafortepresenzadiinvestitoriistituzionali,inpar-ticolaredientireligiosi, ilcuipesostatrovandosemprepiùampiriscontristoriograficianche inaltre realtàdellapenisola35.Taledistribuzionenonè
30.A.Torre,Il consumo di devozioni,cit.,p.204.31.Cfr.G.DeLucaeA.Moioli, Il potere del credito. Reti e istituzioni in Italia setten-
trionale fra età moderna e decenni preunitari, in Storia d’Italia, Annali 23, La banca, To-rino,2008,pp.212-255,p.218.
32.Inquestaprospettivailtermine“barocco”designapiùunalogicaeconomicao–se-guendoGillesDeleuze–una«funzioneoperativa»attraversolaqualepianidiversicomu-nicanoinmodoobliquo,rifratto,ripiegato.G.Deleuze,La piega. Leibniz e il Barocco, To-rino, 2004, p. 5. Su tale aspetto delle relazioni finanziariemi permetto di rinviare a:M.Dotti, Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca. Il network finanziario della Congrega della Carità Apostolica, Milano,2010,pp.25-27e138-140.
33. Anche per questo è così difficile separare generosità ed interesse. Cfr. A. Arru, «Donare non è perdere». I vantaggi della reciprocità a Roma tra Settecento e Ottocento, in«Quadernistorici»,2(1998),pp.361-382.
34.Sugli idiomiconnaturatialcreditosiveda:R.Ago,Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento,Roma,1998,inparticolarepp.XVIIIe201-203.
35.Sull’importanzadelleistituzionireligiosenellafinanzalocaledellecittàitaliane:M.Carboni,Public Debt, Guarantees and Local Elites in the Papal States (XVI-XVIII Centu-ries),in«TheJournalofEuropeanEconomicHistory»,38/1(2009),pp.149-174;Id.,Il de-bito della città,Bologna,1995,pp.120-127;F.Colzi, Il debito pubblico del Campidoglio.
26
cheinparteilrisultatodelleopzionid’investimentopraticatedaquestoge-nerediistituzioni,cheprivilegianolaproprietàterrieraedilcredito;hannoinfluitocertamenteleformedicoercizioneadottatedalleautoritàcittadineperottenerefinanziamenti,masonodecisiveanchelestrategieelepratichesocialidellefamigliedelleéliteurbane.Nel 1636, per quanto riguarda i solicensi concessi alle amministrazio-
nilocali,leistituzioniecclesiastichefornisconomenodell’1%delcapitale36. Unsecolodopo,nel1726,daquestientidipendepiùdellametàdelcredi-to fornitoallecittàeallecomunitàdi tutto loStatomediante icensi37. Inunaprima fase,quandoquestogeneredi investimentoeraparticolarmenteremunerativo,com’èavvenuto inaltre realtàcittadineeper lostessodebi-to degli Stati, furono soprattutto le éliteurbaneefinanziarieadapprofittar-ne38.Mentre a partire dal Seicento (anche in questo caso ci sono natural-mentedelle significativeeccezionianchemoltoprecedenti),con ladiscesadei tassid’interesse,queste renditepassanogradualmentedimano,soprat-tutto in direzione degli enti religiosi. Ciò dipese anche dall’arretramentosecentescodeiciclieconomiciurbaniedallatemperiecatastroficache,co-mehaosservatoLuigiFaccini,non fececheaccrescere i lasciti indirizza-
Finanza comunale e circolazione dei titoli a Roma fra Cinque e Seicento,Napoli, 1999,pp. 151-169; J.C.Waquet,Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens États italiens, Roma,1990,pp.319-340.Sull’integrazionedegli enti assistenzialinel sistemadigestionedellefinanzesiveda ilmodellonapoletano:G.Sabatini,Nel sistema imperiale spagnolo: il debito pubblico napoletano nella prima età moderna,inG.DeLucaeA.Moioli(acuradi), Debito pubblico e mercati finanziari in Italia, Milano,2007,pp. 287-303.
36.L.Faccini,La Lombardia fra Seicento e Settecento, cit., p. 113. Proprio in quell’an-noloStatointervennefissandountettomassimopericensistipulatidalleamministrazionilocali, incambioaicomuniindebitativenneapplicataun’impostapariallo0,5%delcapi-tale, detta mezza per cento.Nelconteggiolaquotadeicreditiprovenientidaglientidelcle-rovenivaseparata,permettendodunquedirisalirealrelativocapitale.ASM,Finanze p.a., 811, Consulta del Magistrato coll’importanza della mezza per cento de’ censi delle comu-nità e particolari, 8marzo1673.
37. ASM, Finanze p.a., 812, Relazione dell’ammontare della mezza per cento che di presente trovasi in cassa di dett’effetto, 7maggio 1727.La fonte è del tutto omogenea aquelladel1636:suuncapitaleinvestitoincensiversolecomunitàdiquasi28milioni,ben15milioni provengonoda creditori dichiarati ecclesiastici.Diper sé il datohaunvaloreindicativo,vistocheriguardaisolicensi, dunque una quota piuttosto ridotta del debito del-le città; peraltro, anche a causa della tassazione, questi strumenti vennero utilizzati sem-premeno.
38.Isottoscrittoriche,tralametàdelXVIel’iniziodelXVIIsecolo,hannoacquistatoleentratedelloStatodiMilanoprovengonoprincipalmentedalpatriziatolocaleedall’élitefinanziariagenovese:G.DeLuca, Debito pubblico, mercato finanziario ed economia rea-le nel Ducato di Milano e nella Repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo, inId.eA.Moioli(acuradi), Debito pubblico e mercati finanziari in Italia, cit.,pp.119-146,sivedaa p. 133.
27
tiaquesti«mediatoridell’esistenzaultraterrena»39. Di conseguenza, furono proprio questioperatorinonspecializzatia riempire ilvuoto intervenendolargamentesulmercatodeldenaro40.Nellarealtàlodigianatuttaviasimanifestaunapolarizzazionepressoché
inedita, quantomeno stando agli studi disponibili sulle città italiane41. Leproporzioni settecentesche della ripartizione del debito civico, benché sia-nodipersésignificative,devonoesserecompreseinterminipiùdinamici.Lefontirivelanononsoloilruolodei“mercatisecondari”deititolidelde-bitomunicipale,masoprattuttoilfattochealcunidiquestinonadottanounidioma“mercantile”.Ciònonsignificachesitrattidiunarealtàdetermina-tadaunamorale totalizzanteodaun linguaggio idealisticamentecaritati-vo,mapiuttostocheinquestocontestoititolideldebitolocalenonrappre-sentano solo una risorsa finanziaria.Questi crediti costituiscono i terminideldiscorsostessosullacostruzionedell’élitelocale.Lavenditainizialedelcreditononcostituiscealtrocheilmomentoacquisitivodiundirittoesperi-toinmodopiùcomplesso,chenonèdunqueesclusivamentemonetariomaanchedivoltainvoltasimbolico,rituale,strategicoepolitico.Sièpotutoricostruirelosviluppodialcunerenditecheisingolitrasferi-
ronoaglienti, talvoltagratuitamente, talaltradietrouncompensopecunia-rioodialtrogenere.NelSettecento,ilsecondopercettoredellerenditemu-nicipali era l’Ospedale Maggiore che aveva un capitale di quasi 135.000lire, per la maggior parte alimentato nel corso dei secoli precedenti dal-le eredità che, come si è visto, numerosimembri della comunità dispose-roafavoredell’ente.Piùdiunterzodiquestocapitalevenneamministratopermezzo di “tesorerie” separate da quella centrale: si trattava delle ere-ditàpiùconsistenti,costituitedabenimobili, immobiliedatitolidicredi-toneiconfrontidialtriprivatiesoprattuttocreditineiconfrontidellacittà.Maancheititolidicreditoamministratidirettamentedallatesoreriagene-ralederivavanodirettamenteoindirettamentedalleeredità.
39.Cfr.L.Faccini, La Lombardia fra Seicento e Settecento, cit., p. 144.40.G.DeLucaeA.Moioli, Il potere del credito,cit.,pp.212-255,sivedainparticolare
ap.223;M.Carboni,Il debito della città,cit.,p.120.41. Risulta più vicina a queste proporzioni la recente analisi delle finanzemunicipali
delRegnod’Aragona,chehamostratodettagliatamentecome,traSeieSettecento,perviadirettaeindirettaglientireligiosisianodivenutiimaggioricreditoridicittàecomunitàedabbianocosì assunto il controllodeidebitimunicipali: J.A.M.Royo,Municipal Finances in the Kingdom of Aragon in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in«TheJournalofEuropeanEconomicHistory»,3(2009),pp.449-492;Id.,Propios, arbitrios y comunales: la hacienda municipal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII, in«RevistadeHistoriaEconómica»,1(2003),pp.51-78.Lacrescitadelpoterefinanziariodelleistitu-zionireligioseèpiuttostoevidenteancheperlarealtàcastigliana,ove,traSeieSettecento,quotesemprepiùconsistentideldebitopubblicovennerodirettamenteoindirettamentein-canalateinquestadirezione.Cfr.C.A.Nogal, Oferta y demanda de deuda pública en Cas-tilla: los juros de Alcabalas 1540-1740,Madrid,2009,pp.79-121.
28
Tab. 4 - Rendite della città percepite dall’Ospedale Maggiore all’epoca delle riforme asburgiche
Tesoreria generale dell’Ospedale Maggiore 84.211EreditàVillanuova 2.775TesoreriaCarminati 27.042Tesoreria Gorla 7.000Tesoreria Bonetti 1.500CapitalediS.Stefano 11.562
Unmodellomoltosimilecaratterizzavadel resto laconfraternitadell’In-coronata, ovvero il principale creditore locale, che gestiva titoli della cittàperunammontarediquasi150.000lire,risultatoancheinquestocasodellaconsuetudine–significativaediffusa–dibeneficarel’enteconrenditedellacittà42.UnaterzodiquestopatrimonioerarelativoalMontediPietàdiLo-di,amministratodallastessaconfraternita;mentreun’altrapartemenocon-sistentericonduceva,ancheinquestocaso,allecontabilitàseparatedelleere-ditàpiùcospicue.Le“tesorerie”portanoilnomedialcunibenefattoridellaconfraternitache,vista laconsistenzadelle relativeeredità,disposeromolteobbligazionirituali,qualimesseobeneficenzeperiodiche,indirizzateseletti-vamenteversoungrupposocialeounquartiere.Idispositividicontrollofa-miliare sulle nomine dei cappellani e dei beneficati non solo permettevanoallaparenteladicostruireunaclientela,magarantivanoanchedellevied’u-scitastrategicheper imembrimenofortunatidella famiglia (quellichenonerano destinati ad ereditare l’asse principale del patrimonio familiare).Matuttociòpotevaavvenireall’internodiunacorniceistituzionalemoltostrut-turata,cheimpedivaaibeneficididivenireunostrumentototalmenteprivato.Colorochedisposero ilproprio testamentoafavoredell’OspedaleMag-
gioreodellaconfraternitapoteronocertamentedirigerepartedellerisorse,masempredentrounacorniceistituzionale“comunitaria”.Allostessotem-po, istituzioni di questa entità, attorno alle quali si raccoglieva gran par-tedell’éliteurbanaeche,difatto,controllavanolestessefinanzemunicipa-li, garantivano i testatoridipoterproteggere l’ereditàdaqualsiasi attacco,dunquepermettevanolorodiraggiungereunodeiprincipaliobiettivideile-gati:ladurata,opiùprecisamenteladistinzione nella ripetizione (rituale)43.
42.Nonsi trattaperaltrodiunacircostanzaisolataper ilcontestourbanodianticore-gime:aTorino,trailascitiindirizzatialleprincipaliconfraternite,prevalgonoicreditineiconfrontidellecomunitàedellastessacittà.Siveda:S.Cerutti,Identità individuale, iden-tità collettiva: i mercanti torinesi e le loro istituzioni nel Settecento, inD.Zardin(acuradi),Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea,in«QuadernidiChei-ron»,7(1998),pp.213-226.
43.Comesièvistoinquestocasodobbiamointenderelaripetizionecomeiterazione.
29
L’Incoronata, che eradi gran lunga la confraternitapiù importantedel-lacittà,presentavalatipicaconcentrazionedipoteriefunzionisocialidel-le così dette “confraternitemaggiori”.Mentre, dal punto di vista organiz-zativo, rispondevaaquellocheNicholasTerpstrahadefinito il«collegiatemodel»44: la confraternita aveva un numero dimembri estremamente am-pio ed ambiva a rappresentare la comunità urbananel suo complesso.Ri-spondeva dunque ad unmodello “partecipativo”, a differenza dei sodalizidiffusiinmoltealtrerealtàche,soprattuttoconlacontroriforma,sviluppa-ronounrapportogerarchicoepaternalisticoconlasocietàurbana.Ciòna-turalmente non significa che non si trattasse di un’istituzione in qualchemodoelitaria.Tuttavia,l’accessoallaconfraternitanoncostituivalariaffer-mazionedell’appartenenzadellafamigliaalnucleoristrettodiunélite tra-dizionale.Alcontrarioilsodaliziocostruisceedincorporaunidealeampioedinamicodiélite:accostarvisicomeconfratelliecomebenefattoriespri-me certamente l’appartenenza alla società urbana più della stessa cittadi-nanza“formale”.Inquestocontestourbanosonopresentianchedeglientiche rappresen-
tanobene il tentativo–nonmediato–diappropriarsideglispazipubblicidapartedialcunedinastie locali;neèunesempio l’OspedalediS.Stefa-no,riservatoall’accoglienzadeipellegriniecontrollato,perquasitreseco-li, dalla famigliaModegnani.La casata patrona, anche in questo caso, hadotato l’Hospitalecondeicreditineiconfrontidellacittàedellecomunitàrurali;tuttavia,anzichéottenereunrafforzamentodelpropriocontrollosul-lerisorsedell’ente,nevedemessaindiscussionel’autonomiadalleautoritàcittadine a più riprese45.Questapermeabilità tragli spazipubblici equel-liprivativienesfruttataanchepertrasferirerisorsedaunsoggettoall’altro:GiulioModegnaniricevedall’OspedaleMaggioregli interessidiuncredi-to che tuttavia è stato fondato, il 30 aprile del 1759,mediante un capitaledioltre3.000liredell’OspedalediSantoStefano,dicuiiModegnanisonopatroni46.Ma, complessivamente, nella realtà lodigiananonvenneroprivi-
44.N.Terpstra,Abandoned Children of the Italian Renaissance: Orphan Care in Flo-rence and Bologna, Baltimore, 2005, pp. 183-244; Id., In loco parentis: Confraternities, Conservatories, and Orphanages in Early Modern Florence and Bologna, in Id. (a cu-radi),The Politics of Ritual Kinship: Confraternities and Social Order in Early Modern Italy, Cambridge, 2000, pp. 114-131 e pp. 126-28. Per quanto riguarda le confraternitemaggiori:Id.,Kinship Translated: “Confraternite maggiori” and Political Apprenticeship in Early Modern Italy, inD.Zardin (a curadi),Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea,cit.,pp.103-115.
45.Sitrattadi11.562lireversolacittàLodie2.000lireversolacomunitàdiLivraga.ASM, Luoghi Pii, 222, Stato attivo del 1758.
46.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore, 10,Mastri diversi, p. 95.Nella registra-zione dell’ospedale Giulio Modegnani risulta succedere allo xenodochio di Santo Stefano, chetuttaviatermineràlasuavicendadiversiannidopotrasformandosiinun’operapia,nel-
30
legiati gli enti che esprimevano inmodo piuttosto autoreferenziale questevelleitàfamiliari,adifferenzadelleistituzionipartecipativeche,comel’O-spedaleMaggioree l’Incoronata,daun latocatalizzaronoepromossero leambizioniedall’altrogeneraronolereputazionidellefamiglieurbane.Il debito pubblico in questo contesto è uno strumento che le istituzio-
nicomeiprivatiutilizzano,anche invirtùdellasuanatura“comunitaria”,nella legittimazione di spazi e poteri propri. La simmetria di origineme-dievaleindividuatadaKantorowicznelbinomioChristus-fiscus, nella qua-lesivannospecchiandoverticalmentel’immortalitàel’impersonalitàdellaChiesaequelladelfisco,nonsembrapoteresaurireil“commercio”simbo-licoemateriale traquestiambiti47.Quelloche,nelcorsodell’etàmoderna,avvenne–conmodalitàcompletamentedifferenti–aLodi,purnonessen-do un fenomeno universalizzabile, allude ad una forma di legittimazionecompletamentediversainquantoconcretizzataprincipalmente“dalbasso”:lacittadinanzasilegittimaistituzionalizzando(nellacaritàenelledevozio-ni) il credito di cui gode.Sembradunque che, portando a contatto la sfe-radellefinanzemunicipaliequelladelleistituzionireligioselocali,ipriva-ti abbiano trovatounproprioambitodiazionee rivendicazione. Inquestosenso i debiti civici divennero strumenti strategici per ilmantenimento diunequilibrioinstabiletraipoteridelloStato,leautonomiedellecomunità,l’influenzadelleéliteelosviluppodelleistituzionilocali48.
lecuicassetral’altrosarebberodovuticonvergerelesostanzedelprecedenteenteassisten-ziale.
47.Cfr.E.H.Kantorowicz,The King’s Two Bodies, Princeton, 1957. Inquestoeinaltripassaggihousatol’aggettivo“simbolico”inriferimentoasituazionieoggettibendifferen-titraloro.Ineffettiintendoattribuireai“simboli”un’accezionedaunlatopiuttostoampiaedall’altroprivadell’opacitàchespessovisiattribuisce.L’interpretazionesemanticageert-zianarimaneinquestosensounriferimento,benchédalmiopuntodivistaallontanitrop-poiconcettiche isimboliveicolanodalle intenzioniedalleazionidicoloroche liespri-mono,demandandoliadun“orizzonteculturale”piuttostoastratto.Preziosamiparelari-letturadelsimbolismooperatadaRicoeurallalucedellateoriadellametafora,soprattuttoin quanto “corregge” l’opaca «eccedenza di significato» su cui l’ermeneutica tradizionalehafocalizzatol’attenzione,ostacolandolapienacomprensionedellarappresentazionesim-bolicanell’azionesociale.Sipotrebbedirechequellichehodefinitosimboli(adesempioicreditiversolacittà)sonodelleporte“metaforiche”chemettonoincomunicazioneilpia-nomateriale(ildatoeconomico:lacomunitàèindebitocondeterminatosuomembro)conaltripianideterminatidalle intenzioniedalleazionidelsoggetto(adesempioistituireunbeneficioecclesiasticotramitequelcredito)edèsoloallalucediquesteazionicheemerge(omegliochesigenera)ilcontenutoconcettualedelsimbolo.PerdirlaconRicoeursitrat-ta di «metaforevive» egenerativedi concetti, in rapportodinamico con l’azione sociale.Cfr.P.Ricoeur,La Métaphore vive, Paris, 1975. Per quanto riguarda la succitata analisi ge-ertziana:C.Geertz, The Interpretation of Cultures,London,1975,pp.89-100.
48.Peralcunispuntisullacircolazioneesull’usodellefinanzelocalinelloStatodiMi-lanomi permetto di rinviare a:M.Dotti,Fenomenologie di indebitamento. Sotto la su-perficie dei cumuli debitori di città e comunità dello Stato di Milano (secc. XVII-XVIII, in «RivistadiStoriaFinanziaria»,27(giugno-dicembe2011),pp.39-70.
31
Dallasistematicitàdiquesteprassiemergel’importanzadell’impiegodeldenaro, la cui stessa accezione, come hamesso in evidenzaGiacomoTo-deschini, è determinata dall’uso corretto. Il denaro non ha un valore po-sitivo in sé ed assume una connotazione negativa quando viene tesauriz-zato, mentre ha una valenza positiva nelmomento in cui vienemesso incircolazione,allora«sitrasformainun’entitàchefluttuatralepersonesen-za appartenere definitivamente a nessuna di esse»49. L’orizzonte concet-tuale dell’economia è stato edificato assegnando «alla categoria dell’usoun’altissimavalenzadi ricodificazioneeticadelle relazionieconomiche tracristiani»50. Resta ancora damappare almeno in parte il piano nonmenoimportantedellepratiche,nell’alveodellequalileintenzioni,leideologieelestrategiedegliattorisiaddensanoinmodopiùarticolato51.
Sul piano degli effetti concreti, bisogna considerare che, con l’alternarsi di fasidimaggioredelegadapartedelloStatoedaltredi“centralizzazio-ne”,finonel pienodell’Ottocento, quasi tutte le formedi assistenza eranodemandate ai luoghi pii (e dunque sostanzialmente alla carità) posti sot-tounegidareligiosa.Percui,dal legametradebitomunicipaleeistituzio-niurbanederivavanoquelleche,conocchiocontemporaneo,potremmofa-cilmente chiamare “esternalità positive”, anche nel sostegno del “welfare”(orfanotrofi,ospedali,elemosine,istruzione)acui,ancheseconunalogicavistosamenteasimmetrica, sidedicavano iprincipalipercettori istituziona-lidelle renditemunicipali.Allostesso tempo,glientipresso iquali sieraandatoconcentrandoildebitolocaledipendevanoinbuonamisuradallere-lativerendite,ancheperquestodivenneropercertiaspettideigarantidellefinanzemunicipali,dispostiquandonecessarioadinvestirvidirettamente.
3. Immagini dell’élite lodigiana tra Settecento e Ottocento
Laconsapevolezzadelproprioruoloall’internodellacittào, inaltri ter-mini,lacuradellapropriareputazionehasemprericopertounagrandeim-
49. G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato,Bologna,2004,p.97.
50.G.Todeschini,I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso del-la ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna,Bologna,2002,p.128.
51.«Occorrericonoscerechequantomenosiconsideral’azionecomeunamossamassi-mizzante,tantopiùsirendenecessariaun’analisi«situazionale»dell’azionestessa.Unpas-soinquestadirezionesembraesserecostituitodall’adozionediunaprospettiva«comunica-tiva», che inserisca l’azione inun intreccioermeneutico.Comeha sostenuto J.Habermas,ciòchenoiabbiamolapossibilitàconcretadiosservarenonè l’inveramentodiuncodice,maun«linguaggioal lavoro» […] Inultimaanalisi, lavaliditàdellepratiche risiedenellaloroqualitàdiazionifattericonoscerecomeammissibiliinvirtùdiunaloroparticolarere-lazioneconidispositividilegittimazioneesistentiinundeterminatocontesto(situazione)».A. Torre, Percorsi della pratica 1966-1995,in«QuaderniStorici»,3(1995),pp.799-829.
32
portanza nell’Europa cristiana52. La legittimazione del proprio status so-cialeequelladelleproprieambizioni richiedenumerosiadempimenti,chepossonovariareasecondadeiperiodiedei“linguaggi”locali.Lostessosipuòdireperquantoriguardalevelleitàdiascesasocialedeicetiemergenti.Se si dovesse adogni costo– ed inmodocertamentegrezzo e sempli-
cistico – definire una gerarchia dei fattori che, tra Seicento ed Ottocen-to, determinavano l’appartenenza all’élite lodigiana, subito dopo il pos-sessodiun titolo,dovremmoposizionare l’appartenenzaattivaaisodalizidell’Incoronata e dell’Ospedale Maggiore, le “testimonianze” di credito,soprattuttoseriguardanoil“pubblico”evengonoistituzionalizzate, infinel’inclusionenelmicrocosmodeglientiurbani(lealtreconfraternite,leisti-tuzioniassistenziali).Attorno a questi enti ruotavanogli interessi di un’élite urbanapiuttosto
compatta, principalmentema non esclusivamente nobiliare, che includevaancheesponentidellelibereprofessioniealcunifloridimercanti.Finodallaprimaetàmoderna,l’inclusioneinseno,senonaivertici,deiprincipalientiassistenzialidivenne,oltrechel’occasioneperriceverevantaggi immediati(tracuimaggioripossibilitàdi intessererelazioniclientelariconl’élite tra-dizionaleedoccasionidiriceverecreditoacondizionifavorevoli),partediun cursus honorum con il quale si ambiva all’ingressonel consiglio dellacittàoppureadunasuccessivanobilitazionee–quandolafamigliaeragiàsaldamenteinsediataaiverticidellasocietàurbana–alrafforzamentodelleproprieposizioni.Questopercorsoassunseancoramaggior rilievo traSei-centoeSettecentoe,nonostanteiradicalimutamentiistituzionali,continuòadesseredecisivoperbuonapartedell’Ottocento.Delresto,comehadimostratoSimonaCerutti, lafamiliaritàconle isti-
tuzioni urbane – in particolare con le confraternite e con gli enti di assi-stenza – è stata a lungo uno degli elementi costitutivi della cittadinanzastessa53. Inoltre, inmoltecittà labenemerenza, insiemeallaricchezza(allacondizionedi“possidente”),andavaacostituireunbinomiosulqualesipo-teva appoggiare l’ammissione di famiglie “emergenti” all’ordine della no-biltà.Idocumentipresentati inappendicerappresentanounpuntodipartenza
per una ricostruzione dinamica dell’élite lodigiana tra Sette edOttocento.
52.Lanoncuranzadella propria reputazione, al contrario, appare sin dai tempi diAl-bertanodaBresciacomeuntrattodisumanosenoncriminale.Sivedainproposito:G.To-deschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medio-evo all’età moderna,Bologna,2007.
53.Cfr.S.Cerutti,La cittadinanza in età moderna: istituzioni e costruzione della fidu-cia, inP.Prodi (acuradi),La fiducia secondo i linguaggi del potere,Bologna,2007,pp.255-274.
33
Si trattaprincipalmentedi“classificazioni”e“valutazioni”esplicite,ovve-rodisituazionidifatto,comequellerappresentatedalQuadro della nobil-tà lombarda54edaglielenchidegliamministratoridelleistituzionilocali55, oppure di valutazioni ipostatizzate, come quelle relative alla scelta degliamministratorideiluoghipii56.Tuttaviaquestefonti,dipersépiuttostoari-de,non solo ci fornisconodelle immaginidelverticedella societàurbanaall’iniziodell’Ottocento,mapossonorisultareparticolarmenteutilinellari-costruzionedelcontestodispecifichedinamicheevicendecheriguardanoiprotagonistidispiccodellarealtà lodigiana(sviluppi,questiultimi, ilcuistudio,inquestitermini,èancoradilàdavenire).La situazione messa in evidenza da queste fonti suggerisce di evitare,
ancheperquantoriguardalaprimametàdell’Ottocento,unaletturachese-pari in diversi piani l’élite lodigiana, inseguendo deduttivamente l’idea diunacircostanziata“svoltaborghese”.Nel1806,lamaggiorpartedegliam-ministratoridegli istitutidicaritàappartengonoafamiglienobilidellacit-tà, come iMajneri, iBarni, iVistarini ed iProvasi; cheperaltro, comesipuòvederedalsuddettoQuadro della nobiltà lombarda, andranno confer-mandoerafforzandoquestostatusnegliannidellaRestaurazione.Lestes-se istituzioni, tuttavia, rappresentavanoancora laportad’accessoper i ce-tiemergenti.La scollatura tra il piano dei maggiori estimati (si veda l’appendice) e
quello dell’élite tradizionale (e dei luoghi dalla medesima presidiati) noneraprobabilmentecosìnettacomesipotrebbe immaginare.Daun lato, lefamiglie della nobiltà mantennero, almeno parzialmente, il controllo del-leistituzionilocali,purvedendoindebolitalapropriaegemoniaeconomica;dall’altroinuovi“possidenti”continuaronoadambireadintegrarsiseguen-do, del resto, percorsi non dissimili da quelli che caratterizzarono la “co-struzione”dell’élitelocaleneiduesecoliprecedenti.Sottoquestoprofilo,leistituzionilocali,insiemeallestrategiematrimoniali,continuaronoadoffri-recontinueoccasionidifusione,integrazioneericonoscimento.
54. Si veda l’appendiceQuadro nominale della Nobiltà Lombarda confermata nella Provincia di Lodi e Crema.ASCL, Sotto-prefettura, 194.
55.Sivedal’appendiceAmministratori degli Istituti di Carità di Lodi nel 1806. ASCL, Sotto-prefettura, 87.
56.Sivedal’appendiceTerne per la nomina dei Direttori ed Amministratori degli Isti-tuti Elemosinieri, Monti di Pietà e Case d’Industria. ASCL, Sotto-prefettura,6.
34
4. Governare l’incertezza
Ilpodere,sel’erafattostimare,primadifareilcontratto:duesalmeemezzoditerra,tuttabeneficata, permeno di dodicimila lire nonavrebbe potuto averle:Maràbito, settantacin-que anni, non doveva compirli più: per beneche stesse, quant’anni avrebbe potuto vivereancora? tre, quattro; abbondiamo, Uno a ot-tanta;dunque,datreaquattromilalire:Unoa dodicimila, ci correva. […]Ogni quindicigiorni, intanto,Maràbitosi recavadalnotaioNocioZàgara per riscuotere le rate del vita-lizio.[…]Perannieanni, laprimaariaprir-si, all’alba, nella piazzetta fu sempre quel-la porta.Era, senza dubbio, una beffa dellamorte, alMalteseprima,oraalnotaioZàgara.Esenefaceva un gran ridere in tutto il paese. Nonc’era giorno che tre o quattro curiosi non si recasseroalRàbatopervedereilvecchioche«percastigononmoriva».
(LuigiPirandello,Il vitalizio)
QuellanarratadaPirandello èunavicendadidenaro, tempoe fortuna,nellaquale lasortesovvertepercosìdire ilcalcolodelleprobabilità57.Unvecchiocontadinostipulaunvitalizioconilriccoepinguemercanteloca-le,sopravvivendononsoloadessomaanchealnotaiochevisubentra.Percertiversisi trattadiunasortadi ironicoriscattodeicetisubalterni:nellanovellaledonneedilavoratoridelpaesesiprendonocuradelvecchioten-tando con successo di prolungare il più possibile la sua vita, proprio alloscopodi“rendere lapariglia”alpossidenteche,semprecon ilmetododelvitalizio, si eragià appropriatodi altre terredei contadini più anzianidelluogo.Al tavolo ci sono da un lato il sopruso e dall’altro il sarcasmo; da una
parte siedono inotabili edall’altragliultimi,mentredisputanounaparti-taadadiilcuiprevedibilerisultatovienecapovolto.Ivitalizi tuttavia,svi-luppatisinelcuoredell’etàmoderna,esprimevanounasituazionecertamen-temenounilaterale.Bastipensareche,nelcaso lodigiano,moltospesso lefamigliedeicetimedio-altisiritrovanosull’altroversantecontrattuale,ov-
57.Ilvitaliziohaincomunecontutteleformedicreditoiprincipaliparametridirife-rimento:sitrattapursempredi«giocareconiltempoeildenaro»,mainquestocaso,co-me per il meccanismo della tontina, il tempo rappresenta una variabile soggetta ad unaprevedibilità più omeno corroborata dalla conoscenza delle condizioni di partenza e dadati seriali. Cfr. L. Fontaine, Il posto delle donne nella piccola economia finanziaria in Europa, in età moderna,in«QuaderniStorici»,2(2011),pp.513-532,sivedap.514.
35
vero investono dei propri capitali per ottenere delle prestazioni vitalizie.Proprio ladensitàdifattorichevisonocoinvoltisuggeriscecheunalettu-raapprofonditadiquestepratiche–edeisistemidi“contabilità”cheviso-noconnessi–possaforniredellechiaviperlacomprensionedellaculturaedeicomportamenti“economici”(nelsensopiùampioeradicaledel termi-ne)dell’élitelocale.Sono tutt’oranumerose,del resto, le formulecontrattuali egli impieghi
del denaro che lasciano un certo spazio alla sorte e dunque alla probabili-tà.Oggi questi calcoli possono appoggiarsi aduna struttura epistemologi-ca,chesièformalizzatanelSettecentoesièandatacorroborandoneiduesecolisuccessivi,perpoiessereparzialmentemessaindiscussionenelNo-vecento58. Tuttavia se da un lato appare chiaro che, anche ai tempi di Pi-randello,si facevaricorsoancoraadunasortadi“statistica intuitiva”(ela-borando la stima in parte mediante logiche proto-probabilistiche, fondatesull’osservazione delle inferenze di seriazioni incomplete e disomogenee,masoprattuttofacendoricorsoallaprobabilitàsotto-simbolica,fondatasul-la percezione soggettiva59) piuttosto che agli strumenti formali disponibi-li;dall’altrosembrache,finoall’Ottocento,inmolticasinoncisiservisse,quantomenoinmodoesclusivoedaentrambeleparti,dellamedesimalogi-ca,aprescinderedaimezziteoriciadisposizione.Lastoriografia,concentratasisinorapiùsuglistrumentiritenuti“innova-
tivi”(comeicontrattidisocietàeleassicurazioni),hafornitorispostemol-to diverse a domande piuttosto ripetitive: quale ruolo aveva la matemati-canellaformulazionediquestestime?Qual’eralaloroattendibilità?Qualeruoloavevanogliespertidelsettore60?Naturalmentealtristrumentipotreb-beroedovrebberoporrequestionidifferenti.Sinora,tuttavia,ivitalizisonolegittimamente stati accostati agli altrimeccanismi in cui si rende neces-sario praticare una stima, senza addentrarsi più di tanto nel concreto de-gli strumenti e dei contesti entro i quali venivanoutilizzati.Ciò, peraltro,haimpeditoallarappresentazionediquestistrumentididiscostarsidauna
58.Sullaquestionesiveda:G.Ceccarelli,Stime senza probabilità. Assicurazione a ri-schio nella Firenze rinascimentale,in«QuaderniStorici»,3(2010),pp.651-702.
59. Cfr. P.L. Bernstein,Against the Gods: the Remarkable Story of Risk, NewYork,1996,pp.324-5.
60.Sitrattaevidentementedellequestionisuggeritepropriodallefonticonsultate.Sullerisposteinveceipercorsisidivaricano.Acoloroche–comeNorth–vedononell’assicura-zioneun’innovazione istituzionaledecisiva,attraverso laquale il rischiodei trafficidivie-ne ponderabile in terminimatematici, si alternano tesi diametralmente opposte, che assi-milanoquesticontrattialgiocod’azzardo.Traimoltiriferimenti:D.C.North,Institutions, Institutional Change, and Economic Performance,CambridgeMass.,1990,p.126;R.DeRoover,Il banco Medici dalle origini al declino (1397-1494),Firenze,1970.Perunasinte-sideldibattitorimandoancoraa:G.Ceccarelli,Stime senza probabilità,cit.,pp.653-654.
36
matrice tardiva (il genere di contratti stipulati soprattutto tra Otto e No-vecento, similiaquellidescrittidaPirandello61), lacuifisionomiaèmoltolontanadaquelladeivitalizisecenteschiesettecenteschi,pernondiredel-la radicale discontinuità ravvisabile tra le tipologie di contraenti che vi siaccostano.Il problema più trascurato riguarda certamente i termini non pecunia-
ri della stima. E allora sorgono altre domande: quali problemi voleva-no risolvere coloro che stipulavanounvitalizio?è chiaro chegeneralmen-tequest’ultimo,adifferenzadeglialtricontrattimenzionati,nonderivavadauna necessità immediata, come per esempio rendere accettabili i rischi diunaspedizione,odallaricercadelprofittoinsensostretto.Nonparechelacontabilitàoperatadapartediambedueicontraentifosseunasemplicesti-madeiprofittiattesi,interminiesclusivamentepecuniari.Edun’ultimaque-stione:qualetipologiadicontraentiricercavaquestogenerediinvestimento?Traimolticontratticherichiedevanounastima,comeletontineeleas-
sicurazionimarittime, ilvitalizioapparentementenonavrebbedovutopre-sentare imaggioriproblemi. Icosìdetti«censivitalizi»,chiamatianche,asecondadei luoghi, «pensioni vitalizie»62 o ancora «livelli vitalizi»63, ave-vano una struttura di base piuttosto semplice: il sottoscrittore versava undeterminato capitale, costituito da liquidi, beni immobili o crediti, rispet-toalcuivalorericevevauncertotassod’interesseper tutta laduratadellasuavitaoperquelladiunaltrosoggettonominato.Questoscheletroperòpotevaesserecomplicatoall’infinitodallarichiestadellepiùdisparatepre-stazioniaccessorieedallanominadialtribeneficiari.Undatocomequelloche riguarda l’aspettativa di vita era, in termini grezzi, piuttosto intuitivo,cosìcomeneeranoinqualchemodoipotizzabililevariabili.Rispettoaquesticontrattimolti testi,giànelSettecento,offrivanodelle
indicazioni piuttosto precise64.Comehaevidenziatoilgiureconsultoveneto
61.Questa formapiù recente ha rappresentato per i grandi proprietari soprattutto unostrumentodiappropriazionedegliimmobili:capitavaspessochevedoveovedovi,general-mentepiuttostoanzianiedormaiprividellaliquiditànecessariaalpropriosostentamento,scambiasserolaproprietà(disolitodiunterreno)conunamiserapensionevitalizia.Comevedremo, i vitalizi usati nelle città di antico regime–oltre ad essere agli antipodi anchesulpianoformale–sigeneravanoincondizioniprofondamentediverse.
62. Si tratta della terminologia adottata nei documenti della Compagnia di S. Paolo.Cfr.E.Colombo,La Compagnia di San Paolo e le dinamiche del credito in età moderna, incorsodistampa.
63.QuestaadesempioèladefinizioneadottatadaicancellieridellaCongregadellaCa-ritàApostolicadiBresciache,tralafinedelSeicentoequelladelSettecento,fuparticolar-menteattivanellostipularequestogeneredicontratti.Mipermettodirinviarea:M.Dotti,Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca,cit.,pp.129-34.
64.L’argomento attraeva soprattutto l’attenzione deimoralisti che si occupavanodellaliceitàdeicontrattidicredito.TraimoltitestichepresentanodelletavoleperlastimadeivitalizisivedanoivolumicuratidaigesuitiPierreFrançoisXavierdeCharlevoixeGuil-
37
Marco Ferro,lestessenormeinteriorizzaronounrapportorelativamenteri-gidotral’etàdelcontraenteeilsaggiod’interessecorrisposto,fissandounastratificazioneanagrafica,aicui livellicorrispondevanodeirelativiplafon-dsdeltassod’interesse:«Èproibitodiesigeremaggiorsommadeldiecipercentosinoall’etàdiannitrenta,deldodicisinoaquelladisessanta,efinal-mentedelquattordicidagliannisessantainsu»65.Peranalizzare il funzionamentodiquesti rapportieconomici (nel senso
più ampio emeno formalista del termine) è necessario comprenderne piùlaprasseologiachel’eventualestrutturateorica.Cerchiamodicapire,daunlato,chi investivadeicapitalinellacostituzionedivitaliziequaliobiettiviperseguiva,dall’altroilprofiloegliscopidichiricevevatalicapitali.Infi-ne,sitenteràdicomprendereilruoloditalipratichenelcontestospecificodella realtà lodigiana.Diversi studi ed un campione significativo di contratti raccolti per dif-
ferenti città settentrionali stanno ad indicare che, tra la metà del Seicen-to e i primi decenni dell’Ottocento, i vitalizi venivano stipulati principal-menteconluoghipii,inparticolareconospedaliegrandiconfraternite,matalvolta anche con capitoli regolari e secolari. Enti come la compagnia diSanPaolodiTorino, l’OspedaleMaggioreedilpioistitutodiSantaCoro-nadiMilano,laCongregaApostolicadiBresciaeglistessiOspedaleMag-gioreeIncoronatadiLodirappresentavanoipuntidiriferimentoidealiperchiintraprendevaquestogeneredioperazioni.Icontrattitraprivati–salvoeccezioni–sonopiuttostotardiviedisolitoriguardanoil trasferimentoditerrenieimmobiliincambiodiunapensionevitalizia.Cosasiaspettavanoquestegrandiistituzioniurbanedaicontrattichesti-
pulavano?Certamenteintendevanoaccrescereilpropriopatrimonioediffi-cilmenteincappavanoinostacolicapacidiimpedirequestoscopo.Glientiponderavanomoltoattentamentelevariabiliingiocoe,daquestopuntodivista, si comportavano inmodo piuttosto prevedibile, praticando delle ac-curatestimecon o senza probabilità.Disolito,quandolecondizionidava-noaditoaqualcheincertezza,leistituzioniricorrevanoadelleclausolechelimitavanol’erogazionedilivelliannuialtettomassimodelcapitaleversatooppureaduncertonumerodianni.Stipulavanodunqueun«vitaliziotem-poraneo»eliminandoognirischio66.Cisonotuttaviadeicasichevedonole
laumeFrançoisBerthier:Memorie per la storia delle scienze e belle arti, cominciate ad imprimersi l’anno 1701 a Trevoux…,vol.I,1747,pp.201eseguenti.
65.M.Ferro,Dizionario del diritto comune e veneto,IIedizione,Venezia,1847,p.203.66.Inunvitalizio,stipulatoil12giugnodel1714,sileggecheunapersonapiahaver-
sato700scudipergarantireunapensionedi42scudiall’annoaitrefratelliBiasi(unpreteeduesuore),corrispondential5%delcapitale.IlcontrattoprevedechelaCongregaeroghiilvitaliziofinoallamortedeibeneficatio,sequestiultimidovesseroviveremoltoalungo,pertrentatreanni.Cfr.M.Dotti,Relazioni e istituzioni nella Brescia Barocca, cit., p. 131.
38
istituzioni erogare pensioni inmisura addirittura superiore al capitale cheglieraoriginariamentestatoversato,masicollocanonell’alveodirapportidireciprocitàmoltoarticolati.Nonerainfrequentechecolorocheavevanostipulato uno o più vitalizi finissero poi con il lasciare allo stesso istitutoanche la propria eredità, oppure che costituissero il vitalizio in concomi-tanzaconlastesuradelpropriotestamento,lasciandotuttoopartedelpro-priopatrimonioob piam causam.AgostinoBignami,versolafinedelSei-cento, elesse quale sua erede universale l’Incoronata di Lodi, disponendochel’enteerogasseunvitalizioafavoredellesorelle67.Lafisionomiadel contrattovitalizio, del resto, èpiuttostopermeabile: i
suoimarginiincerti lascianocheilrelativospaziotendasoventeaconfon-dersiconquellodialtridispositivi,quali i legatiepiù ingenerale ilcom-positoplessodelleeredità.Sottotaledefinizione,nellaclassificazionecon-trattualeadottatadairettoridell’OspedaleMaggiorediLodi,cadonoinfattidelle obbligazioni eterogenee. Nel testamento di Lattanzio Bianchi, tra ivari legati, ce ne sonodue che impongono all’ospedale di versare due vi-talizidi200e50 lireall’annorispettivamenteaGeltrudeBellavitaeGio-vannaCipolla68. Inalcunicasi, l’entitàdelledotazioni impiegatee lacom-plessità delle prestazioni richieste rende estremamente sottile il confinecheseparaquestiattidalleeredità: ilconteGio.MartinengodaVillagana,nell’apriledel1749,costituìunvitalizioconlaCongregaApostolicadiBre-scia,assegnandoall’ente2/3diunacasaincittà,5fondinelterritorioe14consistentititolidicreditopervalorecomplessivochesuperavale100.000lire venete69. Un patrimonio enorme, assimilabile ad una ricca eredità, afrontedelqualeilnobilerichieseunannuodel3%nelcorsodellasuavita,disponendo inoltre che1/4delle renditevenissero impiegatenella celebra-zionedimesseper100annidopo la suamorte.Se si esclude lapensionepercepita in vita (peraltro il 3% èmeno di quanto avrebbe potuto ricava-redauncomuneprestito:inqueglianniconuncensoounlivellomore ve-neto sipotevaottenereagevolmente il3,5%70), il comportamentodelMar-
67.Cfr.E.ColomboeM.Dotti,Oikonomia urbana,cit.,p.109.68.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore,10,Mastridiversi,p.78,vitalizioafavo-
rediGeltrudeBellavita.MentreildatoriguardanteGiovannaCipollasidesumedaArchi-vio storico-diocesanodiLodi (d’ora inpoiASDL),Ordini religiosi e congregazioni, 225, OspedaleMaggioreII,Conto generale.
69.ArchivioStoricodellaCongregadellaCaritàApostolicadiBrescia, Libro nono dei testamenti e degli strumenti della Veneranda Congrega della Carità Apostolica (1748-1763),p.17r.Peraltronel1753ilMartinengo,insiemecolfratelloFranco,ripetél’operazio-neversandocreditiper4.200 lireveneteecirca5.000 lire incontanti.Laprestazione ri-chiestaeralamedesima,Ivi,p.105v.
70.Sivedano:M.Pegrari, Le metamorfosi di un’economia urbana tra Medioevo ed Età Moderna. Il caso di Brescia,Brescia,2001,pp.200-205;G.Belotti,F.Spinelli eC.Tre-croci, Norme antiusura, prestiti e tassi d’interesse a Brescia, 1425-1789,inF.SpinellieC.
39
tinengo non differisce da quello dei molti patrizi che lasciano la propriaeredità alla confraternita, disponendo legati per la costituzione di doti, la celebrazionedimesseoaltreprestazioni.Infatti,ancheinquestocaso,allaconfraternitevennerichiestodifarcelebraremesseperben100anni.Dall’altro lato, è ancora più complesso leggere le aspettative dei sotto-
scrittori. Tuttavia pare evidente che queste ultime non possono essere at-tualizzate e ricondotte ad un puro calcolo economicistico, ma non si de-vono neppure attribuire in toto alle curvature di un orizzonte culturalestatico, come pure alcune tracce potrebbero suggerire71. A metà del Sei-centoun sessantenne, a frontediuncospicuocapitaleversato all’Ospeda-leMaggiorediMilano,chiesesolamentediesseremantenutoperladuratadella suavita,offrendosi inoltredi lavorareper l’ente senza riceverealcu-na remunerazione, salvo quella di «partecipare dei tesori delle indulgen-zeconcesseachi servegratis»72.La spesso insoddisfacente rimunerativitàmonetaria, la frequente sovrapposizioneai legatied il fattoche ipartners fosseroentireligiosipossonosuggerireunachiavediletturadiquesticom-portamenti.Certamentenonèscorrettoricondurreivitaliziall’idiomadel-lacarità, tuttaviapotrebbeessereparziale,soprattuttosesi intende inmo-dotropposemplificatoriolostessofenomenodellacarità.Percomprenderelavitalitàsocialedellevarieformedibeneficienzaedicarità,comesièvi-
Trecroci(acuradi),Saggi di storia monetaria,Milano,2008,pp.12-73;M.Dotti,Relazio-ni e istituzioni nella Brescia barocca,cit.,pp.96-106.
71.La rappresentazione di un’economia integralmente subordinata alla sfera dei valo-rimorali,culturaliedariferimentieteronomi–comequellarestituitadaalcunistudiosidicredo polanyiano – appare come una seconda caricatura (rispetto alla più diffusa letturadell’economiadiognitempoeluogointerminidimercato),dentrolaqualeleazionidegliindividuiedeigruppivengono incasellate inuna rappresentazionegiàdata,destituendo isoggettidaognipossibilitàd’interazioneconlarealtàsociale.Sitrattainvecedicompren-derecomeleistituzioniegliequilibridelleconfigurazionilocalivincolinoalmenoinpartegli individuiedicorpi,suggerendoobiettivididiversanatura.Suilimitidelleanalisisto-richecondotteapartiredalla“nostramentalitàdimercato”sivedailclassico:K.Polanyi,Our Obsolete Market Mentality, in «Commentary», 3 (1947), pp. 109-117.Per una circo-stanziata analisi critica del retaggio storiografico dell’antropologia polanyiana, di cui lagiàmenzionataoperadiBartoloméClaverocostituisceuncaposaldo,siveda:Z.Moutou-kias,Peut-on faire l’économie d’une économie politique?,in«AnnalesHSS»,6(novembre-décembre 2001), pp. 1111-1128.Sulla questione si veda anche:D.C.North,Markets and Other Allocation Systems in History: the challenge of Karl Polanyi, in«JournalofEuro-peanEconomicHistory»,4(1977),pp.803-816.
72. F. Saba, L’assistenza ai malati come servizio: l’Ospedale Maggiore di Milano, in L’emergenza storica delle attività terziarie (sec. XII-XVIII), Ospitalità, ospedali e medici, XIVsettimanadistudidell’IstitutodiStoriaEconomica«FrancescoDatini»(Prato,23-28aprile1982),pp.19-20.Sivedaanche:A.Pastore,Usi e abusi nella gestione delle risorse (secoli XVI-XVII),inId.eM.Garbellotti(acuradi),L’uso del denaro. Patrimoni e ammi-nistrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII),cit.,pp.17-40,pp.18-20.
40
sto,ènecessarionondemandarne la letturaaduncodiceculturalestatico.Non è affatto scontato che coloro che versavano un capitale per costitui-reunvitalizioagisseroesclusivamenteinbaseadeivaloridiordinecultu-raleemorale.Allostessomodo,nonsipuòaffermarechenonoperasserodelleaccuratevalutazioni.Restanoperòdacomprendereiterminidellasti-mapraticatadaquestiultimi,visto che sembradifficilmente riconducibileaimodellipiùfamiliari.Il profilo dei contraenti e le modalità della transazione forse possono
aiutarciacomprenderemeglioilfenomeno.Tracolorochepropongonodeicapitali all’Ospedale Maggiore di Lodi ci sono alcuni grandi nomi. UnopertuttièAlessandroCorradiche,oltreadappartenereadunadellefami-gliedellanobiltà lodigiana, èben inserito sianelmondodellepratichefi-nanziarieche inquellodelledaicapitoli regolari femminili: fuproprio luiadeffettuareunaricognizionedeicapitalifinanziaridellebenedettinediS.Vincenzonel175473.Nello stessoannoversacontemporaneamente18.000e14.800 lire all’OspedaleMaggioreper costituire duevitalizi a favore diAngelaSciorni,rispettivamenteal5%edal4%74. A queste non trascurabi-li renditevitalizie, il18giugnodel1765, siaggiungeun’ulterioreannuali-tàvitaliziadi140lire,chepermetteallabeneficiariadirealizzareunacom-plessivapensionedi1.633 lire75.Quest’ultimaprestazioneèstatacostituitacon l’ereditàdiAlessandroCorradi,ovverocon ilfittodiunacasa lascia-ta all’ospedale.Un’altraprotagonistadi spiccodiqueste transazioniè lanobilemonaca
SerafinaInzaghiche,inpartecedendodegliimmobiliedinpartepermez-zodella sua ricca eredità, assegnòdiverse rendite vitalizie aDionigiBor-sa76. Da questi casi emergono alcuni elementi interessanti: in primo luo-go, sia dal profilo dei contraenti che dagli importi impiegati, pare chiarocheivitalizivengonostipulatiprincipalmentedaicetimedio-alti;insecon-doluogoèfrequente–sianelcasodell’ospedalelodigianocheinaltricasidistudio–cheglistessisoggettiripetanopiùvoltelamedesimaoperazio-ne,dunquevadanoaccumulandoprogressivamenteuna rendita semprepiùcospicua.Si può inoltre osservare che, nellametà dei casi di cui si ha unquadrocompleto,icapitaliversatiall’ospedalevannoabeneficiodiunsog-gettodiversodalsottoscrittore:inparticolarequestoavvienequandoilsot-toscrittore appartiene all’élite locale in senso stretto.
73. ASM, Archivio generale del fondo di religione, 4.945.74.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., Mastri diversi, 10, p. 74. Purtroppo
sappiamopocodellabeneficiariadiquestivitalizi,lostessocognomedelrestononècertotraquellipiùdiffusialivellolocale(anchesedaldocumentoparechiaro).
75.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a.,106,p.7.76.ASDL,Ordini religiosi e congregazioni,c.225,OspedaleMaggiore II,225,Conto
generale.Perl’eredità:ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a.,109.
41
Unparticolareinteressanteèchealcunitra iprincipalisottoscrittoridivitalizi–comeSerafinaInzaghieLattanzioBianchi–hannoelettocomeeredeuniversalelostessoOspedaleMaggiore77.Nonostantesiastatarara-menteindicatainmodoesplicitol’etàdeibeneficiari,nonèdifficilenota-reche i terminidel contratto sonomoltovariabili epaionocostruitime-diante delle logiche soggettive ed intersoggettive sviluppate, di volta involta,daicontraenti.èchiaroche,seilvitaliziovienecostituitopermez-zodiun’eredità,nonvièalcunapossibilitàdicontrattazione:lastimavie-necostruitaunilateralmenteeall’entenon restacheaccettareo ripudiarel’eredità.Inaltricasi inveceisottoscrittorisirivolgonoall’ospedalepergarantire
unapensioneasestessiedailorofamiliari:èilcasoadesempiodeifratel-liZambelli,diFabrizioPalma,deiMura.è il genere di situazione che do-vrebbegenerare una stimapiùponderata.Spesso si tratta di famiglie nonsaldamente radicatenellasocietàurbanaesovente,comenelcasodiMar-cantonioCornettidiGeraPizzighettone,neppureabitantiincittà.Laconsi-stenzadellecifreinvestiteeleproprietàconfortanol’ipotesichesitrattidibenestanti, soprattuttoproprietari di poderinel territorio emercanti, pocorelazionati con l’élite tradizionale.Addentriamocitralepieghediqualchecasoconcreto.Nel1766Fabrizio
Palmaversò inunasolasoluzione10.000 lireaGiacomoCasati, tesorieredell’OspedaleMaggiore.Aquantopareilversamentoavvenneincontanti.Incambiorichieseedottenneunvitaliziodi600lireall’annoperséeperlamoglie,parial6%delcapitale.Certamentepiùdiquantoottenneroaltricontraenti, soprattutto se si prendono in esame le condizioni poste daFa-brizio:dalmomentodellamortedientrambiiconiugil’enteavrebbedovu-tocorrispondereunapensionedi150lireincontantiallafigliaMariaGel-trude,chehapresoivotipressoilmonasterodiS.LeonardodiLodi78.Nelcasoquest’ultimafossemortaprimadeigenitori,«[…]ononavendoluogoilpagamento insuofavoredisposto[…]»79, l’ospedaleavrebbedovutocor-rispondere «[…] alla signoraAnnaM.raLaCrois loro nipote doppo la diloromorte lireSeicento Imperialialcorsocomunementecorrenteperunasolvolta,equaloradettaloronipoteLaCroisfosseanch’essamortaresteràproprio,ealiberadisposizionedelPioLuogotutto»80.In questo caso non pare si possa vedere all’opera alcun dispositivo so-
cialeoculturaleeteronomo(magari,manipolato,re-interpretatoostrumen-
77. Dell’eredità Inzaghi si è detto poco sopra, per quanto concerne l’eredità Bianchi.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., 111, 3.
78.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a., Mastridiversi,10,p.7.79. Ibidem.80.Ibidem.
42
talizzatoasecondadellecircostanzeedegliobiettivicomplessividegliat-tori,comesuggerisconoalcunideicasivistiinprecedenza).Sidirebbechelafamigliainvestaunacifrapiuttostoconsistenteperrisolvereunproblemachehamoltesfaccettature,lequali,peraltro,nonvengononecessariamentedistribuiteinmodounivocodatuttigliattori.Aquestoproblemapossiamodare dei nomi tutto sommato piuttosto attuali: incertezza, insicurezza op-pure precarietà esistenziale. Adifferenzadeinobili localiche,entrounrapportodi intimitàconl’o-
spedale,visirivolgonoperfornirecertezzeadaltri(ancoraunavoltainunrapporto di reciprocità), questi contraentimirano a risolvere un problemache, anche se benestanti, sentono in qualchemodo più incombente e che,sidirebbe,noncredanopossaessererisoltodaaltri.Imembridell’élite,delresto, compiono queste operazioni all’ombra di una relazione privilegiataconleistituzioni,cherimaneilloroobiettivoprincipale.Costoro,oltrechesulle loro ricchezze, possono contare su una rete di relazioni con la loro pa-rentela e con le loro clientele (anche istituzionali), nonché sumeccanismidedicatialledifficoltàdei“privilegiati”81.Passiamoaibeniutilizzatipercostituireivitalizi.ComesièvistoiPal-
mausanodenarocontante,mailventagliodelleopzionièpiuttostoampio.Adesempio,il29maggiodel1763,BernardinoMuraesuasorellaAntoniacostituironounvitaliziodi90 lire l’annofornendoal luogopio«[…]noveored’acquadaestraersidallaRoggiaVillanadisottodelMolinodiBoffa-lora Gera d’Adda Ducato di Milano di quelle ore 24 che detti sig.ri tengono indettaRoggia[…]»82.Insostanza,anzichévenderesemplicementeidirittisull’acqua, li usano per garantirsi una piccola pensione.MoltospessoaLodi–ecomeabbiamovistoancheinaltrerealtà–ivi-
talizisonocostituitiutilizzandodeititolidicredito.Questodelrestoavvie-ne ancheper altri trasferimenti che le famiglie indirizzano alle istituzioniurbaneedinparticolareaglientireligiosi.Sipossonodunquemettereipo-teticamente in campo lemedesime spiegazioni addotteper i legati: la tra-sformazionedirisorsefinanziarieinrisorsesimbolicheepolitiche,lemag-giori capacità delle istituzioni di gestire e tutelare dei titoli di difficile
81. Per un quadro generale sui sistemi di assistenza dedicati ai declassati si veda:G.Ricci, «Nel paese di Anomalia» (vergognosi/declassati),inV.Zamagni(acuradi),Pover-tà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi,Bologna,2000,pp.175-182;Id.,Povertà, vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo e età moderna,Bologna,1996.Traimoltistudisucasispecifici:M.Taccolini,Attività assistenziale e iniziativa econom-ica della Congrega della Carità Apostolica di Brescia tra Settecento ed Ottocento, in «Cheiron»,27-28(1997),pp.229-402;S.Musella,Il Pio Monte della Misericordia e l’as-sistenza ai «poveri vergognosi»,inG.GalassoeC.Russo(acuradi),Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d’Italia,vol.I,Napoli,1982,pp.107-337.
82.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore p.a.,Mastridiversi,10,p.83.
43
riscossionee, infine, lanecessitàdi rammentareed istituzionalizzaredellevecchieobbligazioniinmodochelafamiglianepossafruireindirettamen-te (come avviene spesso con le cappellanie).Anche in questo caso si po-trebbeipotizzarechetalepraticasiaintrisadiunvaloresimbolicoecomu-nicativo.L’uso di crediti per costituire le doti spirituali e soprattutto i «legati di
messe»esprimeilcreditodicuisigodepersonalmente,omeglioancorailcredito socialedellapropria famiglia; la sceltache inquesti casicadeco-sìspessosuititolideldebitolocale(renditedellacittàecensineiconfron-tidellecomunità)rendepiùevidentetalevolontà.Inquestosensononpareinvececonfigurarsiperivitaliziunidiomaspecifico.Nei vitalizi che, nella seconda metà del Settecento, vennero stipulati
dall’OspedaleMaggiorespessononvenivaprecisata lanaturadelcapitale,masarebbe ingenuopensareche si trattasse sempredicontante,delqualepuretalvoltasispecificaval’utilizzo.Neicontrattiperiqualivennechiaritalanaturadelversamento, i sottoscrittori, nellamaggiorpartedei casi,uti-lizzarono dei titoli di credito o dei terreni83.Masitrattavasempredipresti-titraprivati.IsacerdotiAntonioeGiuseppeZambellicostituirono,insiemeallorofratelloGiovanni,unodeivitalizipiùconsistentidelperiodo:trasfe-rirono all’ospedale 5 censi che, insieme agli interessi giàmaturati almo-mento della transazione, valevano 15.000 lire84. In cambio ricevettero unvitaliziodi750lire(5%)perladuratadellavitadituttietre85.
Tab. 5 - Capitali usati dai fratelli Zambelli per costituire un vitalizio con l’Ospedale Mag-giore di Lodi
Debitori Provenienza Capitale
PaoloLuglio Lodi 4.000PadreefiglioIsotta Lodi 1.350GaudenzioPallavera Secugnago 150Andrea Sebastiani Mairago 450Pietro Frasi Castione 8.000Francesco Tentore Crespatica 800
Fonte:ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore,10.
83. Lo stesso del resto avviene anche per altre istituzioni locali: Giuseppe Arrigoniper esempiousaun terreno situatoaBagnoloper costituireunvitaliziocon l’Incoronata.ASCL,Notarile,not.MichelangeloBonelli,cart.30.
84.ASCL,Archivio dell’Ospedale Maggiore,10,Mastri diversi, p. 85.85.Sulvitaliziosiinnestaunulterioresistemadidistribuzione“probabilistica”traitre
beneficiari,conunmeccanismopertaluniversisimileaquellodellatontina.Diversamen-te,inmolticasi,sistabilisceunaprogressivariduzionedellivelloannuoviaviacheicon-traenti decedono.
44
Queste ultime situazioni possono aiutarci ulteriormente a comprenderelafisiologia (oltreche lafisionomia)diquesteoperazioni.Liberarsidell’o-neredellariscossionediunaseriedicreditièmoltoprobabilmenteilsinto-modelpassaggioadun’altrafasedellavita,come,del resto, lastessapre-occupazione per il proprio sostentamento e soprattutto per quello di figlie congiunti lasciano indovinare. Lo stesso si dica per l’uso di terreni chenon si possono più gestire. Per capire quali logiche operassero nei vitali-ziènecessariocomprendereilprincipalescopodellostrumento,nonchéleaspettativedicolorochenepromuovevanolastesura.Nonsitrattatantodistimareirischidiuncontrattodallanaturaincerta,mapiuttostoditrasfor-mareleincertezzequotidianeinsicurezze.Nonc’èdubbio che, sottoogniprofilo, laprecarietà e l’insicurezza fos-
seroonnipresentinell’esistenzadianticoregime.è altrettantoevidentecheilcostonecessarioperridurrequestaprecarietàpotevaesseresostenutoso-lodaimembriagiatidellasocietà:l’élitelocalepotevapermettersimaggiorisicurezzeepotevaanchecomprarleperaltri.Lestimepraticateinquestoparticolaremercatosonotesecomesièvi-
stoa scambiaredei capitalipiù impegnativi (crediti e terreni)pergaranti-re alla famiglia unamodesta entrata priva di rischi,ma in qualchemodo“mettonoinconto”ancheilprezzodialtreprestazioni,qualilacelebrazio-ne dimesse. Infine, comprendono il lascito di un surplus al luogo pio, la cuiconsistenzavariainmisurainversamenteproporzionalealladuratadel-lavitaterrenadeipercettorideivitalizi.Nonsipraticaunazzardomacisiaffida(espessosiaffidalapropriadiscendenza)aglientireligiosiedaciòcherappresentanosulpianomateriale(lastessaéliteurbana)edimmateria-le. In questi scambi non c’è – per parafrasareChiffoleau – una contabili-tàdell’aldilàcontrappostaadunadell’aldiquà,mapiuttostouna«contabilitàtotale»86lecuiproporzionipossonovariareasecondadeisoggetticoinvol-tiedelleloroaspettative,maimplica,consapevolmenteomeno,entrambiipiani.Sul versante opposto, istituzioni come l’Incoronata e l’Ospedale Mag-
gioredivennerodeglispecialistidellagestionedelrischioesoprattuttodeltempo:accumularonograndipatrimonifinanziariesi specializzarononel-lariscossionedelcredito.Allostessotemposvilupparonoalorovoltalaca-pacità di praticare stime articolate, tenendo conto delle aspettative com-plessivedicolorochevisirivolgevano,maanchedelleopportunitàofferte
86.Cfr.J.Chiffoleau,La Comptabilité de l’Au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans région d’Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-vers 1480),Rome,1980.PeraltreviePierreBourdieugiungeaformularelasuadefinizionedi«comptabilité totale des pro-fitssymboliques»,amontedellaqualecomponentimaterialiesimbolicherimangonoindif-ferenziate. P. Bourdieu, Le Sens pratique,Paris,1980,p.204.
45
daqueste relazioni (come,peresempio,ottenerechecoloroavevanostipu-lato un vitalizio o chiesto un prestito alla fine lasciassero la propria ere-dità all’ente). Divennero in definitiva dei venditori di certezze, capaci dicommutare le ricchezze onerose dell’élite locale in rendite e prospettiverassicuranti.
47
2. Benefici e costruzioni di élite a Lodi (XVIII-XIX secolo)
di Emanuele C. Colombo
1. Il mondo dei benefici. Élite e comunità
Cisipotrebbeingeneralechiederecosasiaunacattedrale,o,nelnostrocaso,unacollegiata.Esistenaturalmenteunarispostapiùomenofissa:unacollegiataèuninsiemedidiritti,espressiinunaseriedicanonicati.Madietroquestarisposta,senzadubbiocorretta,possiamovedereall’o-
peraunaseriediforze,omegliodiinvestimenti.PrendiamocomeesempioilcasodellacollegiatadiCodogno,S.Biaggio,lettoattraversolabrevesto-riadiunadiqueste forzeeconomiche,unacappellania.Èquiall’operaunprocesso:rendere collegiataciòcheèunasempliceparrocchiale.Inparticolare,questoesempiopermettediilluminarel’ideadibeneficio
ecclesiasticocomeunaattivitàal tempostessopolitica,economicaereli-giosa;e,d’altronde,consentedi introdurreunproblemacheabbiamopo-stoadoggetto inquestovolume: inchemododelleélitepromuovonounluogo?Il beneficio in questione vede alle sue origini (come spesso accade) un
testamento,quellodiBartoloMartinenghi1.Nel1618,Bartolodisponechealla suamortevenganoassegnate196pertichedi terrenoaideputatidellaMagnificaComunitàdiCodogno,con l’obbligodi farcelebrareduemessequotidiane nella chiesa parrocchiale di San Biagio ad un altare da eriger-
1.Diverselefontisullacappellania.Cfr.inparticolareArchiviostorico-civicodiCodo-gno(d’orainpoiASCC),Sez. antica,b.8,fasc.1,doveèconservatoiltestamentodel4di-cembre1618,rogatodalnotaioFrancescoZani.Unasezioneappositadedicataallacappel-laniaeaciascunsingolocanonicatoesisteinArchiviostorico-diocesanodiLodi(d’orainpoiASDL),Serie parrocchie, Codogno, S. Biagio,checiteremodivoltainvolta.Cfr.inol-trelaricostruzioneoperatanelcorsodiunacausatraduechierici, inArchiviodiStatodiMilano(d’orainpoiASM),Culto p.a.,cart.321(Codogno),Il sacerdote Gio. Batta Alberi-co di Casalpusterlengo nella causa contro il cherico Gio. Batta Belloni di Codogno, Pro-memoriadel1/2/1774.
48
sinellastessachiesa.Lanominadelcappellanosarebbestatadidirittodeisuoieredi inperpetuo.Siamoquinell’alveodiunacappellaniache sipuòritenereabbastanzatipica:vengonolegatideibenipercostituireunufficioecclesiastico,previstedellemesse,estabilitoungiuspatronato.Gliobblighiconsistonoinduemessequotidiane.Esiste tuttavia una clausola importante, che fa riferimento al vero sco-
podellacappellania.Iltestamentoprescriveinfatticheselachiesaparroc-chiale fossediventataunacollegiatadotatadicapitolo, il legatosisarebbepotuto trasformare in un canonicato, ed in questo caso si sarebbe cele-brata una solamessa quotidiana.Al tempo stesso, il dispositivo chiariscel’importantissima posizione goduta dalla comunità nel lascito. Infatti, es-soprescrivecheinmancanzadieredilametàdeibenisarebbespettatoal-lacomunità, laqualeavrebbedovutodevolverlaaicanonici.Unquartosa-rebbe toccatoadalcuniparentidel testatore, i fratelliRubbiati,mentreunulteriorequartoavrebbedovutofinanziareun’operadicarità,ecioèistitui-reunadoteannuadilire100afavorediseipoverefanciulledelluogo.Leprescrizioni relative ai diritti di nominadiquesteultimemostranoancoraunavoltalaparticolareattenzionedeltestatoreversolacomunitàeilfutu-rocapitolocollegiale.Altempostesso,però,rivelanol’inestricabilelegamechesisarebbedovutoinstauraretracomunitàefamiglia.Lasceltadellefanciulleacuiassegnareladoteerainfattiriservata(co-
piamodal testamento)«perriguardoanumeroseidaduesenioridella fa-miglia, per riguardo a n. quattro dal prevosto e capitolo e per riguardo aduedalConsigliodella terradiCodogno,obligandoedichiarandocheglistessideputaticoniloroduevotisianotenutianominareedeleggerepove-refigliedellafamiglia».Non bisogna perdersi nell’apparente complicazione del dispositivo: lo
scopodel testamentoè in realtà chiaro, ancorché strettonellanecessitàdifissare con precisione una serie di clausole. Una necessità assolutamen-tenoncasuale: ibeneficieranotipicamenteall’originedifittissimecontro-versie,aventiperoggettoperlopiùildirittodigiuspatronato,cioèdinominadelcappellanoofficiante2. L’elementopiùevidenteèilparallelismotrapromozionesocialedellefa-
miglieedellacomunità,chesiesprimerànellacreazionediottocanonica-tidiprimaerezionedilìapochianni,quandonel1633laparrocchiaverràtrasformata in collegiata da papaUrbanoVIII3. La creazione della colle-
2.Cfr. per esempio il caso studiato daA.Ciuffreda, I benefici di giuspatronato nella diocesi di Oria tra XVI e XVII secolo,in«Quadernistorici»,67(1988),pp.37-72,chenonacasousacomeprincipalefonteunriccofondodicontroversierelativeabenefici.
3. ASDL, Serie parrocchie, Codogno, S. Biagio, b. 5: Instromento di erezione della Prepositura, o Collegiata di Codogno, 7/7/1635;Ivi, Statuti ed ordini del molto Rev. Capi-
49
giata, resa possibile anzitutto dalla ricchezza incorporata nei canonicati, mette in azione il dispositivo previsto daBartolo. Come un’inchiesta del-lagiuntaeconomaleavrebbeaccertatosecolidopo:«Fucommutatoilpre-dettolegatoinuncanonicato,efudatointitoloadunodellafamiglial’an-no 1636, qual era il Rev.DonGioBattistaMartinenghi». L’élite di turnodunquepartecipa allapromozionediun luogoattraverso la formazionediuncapitoloe incambioottienedipoternecontrollare i relatividirittieco-nomici.Ilcheapreancheadunpossibilepercorsodiascesasocialedapar-tedellafamigliaoadunasuaconferma,attraversol’utilizzodelbeneficioedeilegamidiparentelazio-nipote4.Sitrattatuttaviadiunlegametrafamigliaecomunitàentrocertitermi-
niinestricabile,comeemergeinparticolareinunadisputachesiverifiche-rà nel 17745.Lacontroversiatoccaunargomentoricorrentenellastoriadel-le cappellanie: un sacerdote, Gio. Batta Alberico di Casalpusterlengo, facausacontro il chiericoGio.BattaBellonidiCodogno in relazioneal ca-nonicato.Alberico si presenta come discendente diBartoloMartinenghi,allegando la suagenealogia. IlBelloni, che risultanominato invecedallacomunità,riesceperòadimostrarelesueragionidifronteallagiuntaeco-nomalemostrandocheCodognoeraentrata inpossessodei trequartideldirittodinominadelcappellano.Ilriferimentoèancoraunavoltaall’ere-zionedellacollegiata,poiché«l’eredeuniversalediVincenzodi luifiglioadottivoacuiquandomorissesenzafiglisostituìnellametàdellasuaere-ditàlaMagnificaComunitàdiCodognocoll’obbligodifareriggereincol-legiata la suaccennata chiesa diS.Biaggio»,mentre le altre dueparti so-notoccateunaaiparentiRubbiatiel’altranuovamenteallacomunitàperladote alle fanciulle.Codogno,pertanto,inquestocaso“vince”,ereditandoleragionidellafa-
miglia e trasformando il giuspatronato familiare in comunitario. Un pro-cessoèdunqueinatto:icanonicatisicomunitarizzano,dopoesserestatilaforzapropulsivaallabasedellapromozionesocialedelterritorio.Vedremo
tolo della Chiesa collegiata insigne di San Biagio della terra di Codogno Diocesi di Lodi, s.d.;Ivi,Altre memorie intorno all’origine di Codogno ed alla Chiesa parrocchiale, 1814; ivi,Narrativa di fatto intorno alla Comunità del borgo di Codogno e suoi primi otto ca-nonicati, s.d.
4.EmblematicoinquestosensoilcasodeiProsperistudiatodaM.Moroni,Reti di re-lazioni, rapporti di patronage, enfiteusi e benefici ecclesiastici: l’ascesa dei Prosperi nella Marca pontificia del Settecento,in«Societàestoria»,82(1998),pp.745-766.Lacostruzio-nedella fortuna familiareavvienequiapartiredallacarrieraecclesiasticadiNicolaPro-speri,titolarediunacappellaniaaRecanatiepoiamministratorediunariccacausapia,laMassucci.Ladefinizionedellignaggioèinseguitorealizzataattraversolafiguradelfratel-loprete,chetrasmetteràdivoltainvoltalacappellaniaaiproprinipoti.
5. ASM, Culto p.a., cart. 321(Codogno),Promemoriadel1/2/1774,Il sacerdote Gio. Bat-ta Alberico di Casalpusterlengo nella causa contro il cherico Gio. Batta Belloni di Codogno.
50
tuttaviaabrevecheinunperiodocompletamentediversolefamiglie,inte-secomeélite,forzeattivesulterritorio,ritornerannodinuovoinaugenellastoria della collegiata.Percapireappienoilfenomenobisognafarriferimentoinmanieraalme-
no sporadica a cosa siaCodogno nel Seicento: una realtà commerciale ingrandeespansione,chenegliannisuccessiviall’erezioneincollegiatadellaparrocchialeriusciràafarsiconcedereungrandemercatosettimanale,no-nostante tutta l’area ne fosse già punteggiata6.Unadellelineeargomentati-veportateavantinelladomandapresentatadal feudatarioèovviamente lagrandequantitàditrafficichevisisvolgevano7;maèbenesottolinearean-che il carattere trans-nazionalediquesticommerci.Codognovienecomu-nementedescrittacomeunaportaapertaverso ilPiacentino8. Inoltre, sap-piamochenellacomunitàoperavanomercantigenovesi,probabilmenteperrifornirsi di grani9.Laricchezzaincorporataneicanonicatirappresental’altrafacciadique-
stodinamismocommerciale10,esitrattadiunelementoconnessoaunapiùgeneralestrategiapersvincolarelacomunitàdalcontrollodiLodi,nelcuicontado e nella cui diocesiCodogno si trova inserita.Non è un caso chelacollegiatavengainaugurataallapresenzadelvescovodiPiacenzaAles-sandroScappi,quasiasancirel’esistenzadiunlegamepiùforteconilPia-centino rispettoalLodigiano.Altroelemento importantedasottolineareèla proprietà della terra, che a inizioCinquecento risulta essere inmano amembridifamiglielocali(rurali),conunascarsa/nessunaincidenzadiLo-digiani o Milanesi11.Iltrattoeradelrestocomuneamoltedellegrandico-munitàruralidellaBassatraLodieCremona.
6.Horicostruitolaretedimercatidell’area(moltideiqualiaprirononelSeicento)inE.Colombo,Alla ricerca del mercato. Mercati rurali del Lodigiano e del Cremonese nel Sei-cento,in«StudiStoriciLuigiSimeoni»,57(2007),pp.149-185.
7.Vieneinfattidescrittacome«terramercantile,chevisifannomoltitrafficiperchéinessavi sonodellimercanti ricchissimi,etvi sonoquasidi tutte le sortideartisti»,ASM,Commercio p.a.,cart.159,Processod’istruzionedelmercatodel14/3/1659.
8.SecondoilpodestàdiCodogno,nelcart.1591:«LaterradiCodognosiedetantovici-naaluoghidelPiacentinocheèquasiunaportaaquellichedilàvengono»,cit.inG.Cairo,F. Giarelli, Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia,Codogno,1898,p.451.
9. ASM, Commercio p.a., 159, interrogationes del 14/3/1659.Tutta l’area traCodognoePiacenzaerapercorsadasfrosatori,piùomenoprotettidaifeudatari,cfr.varietestimo-nianzecit.inColombo,Alla ricerca del mercato, cit.
10.Perunaltrocaso,quellodiPievedelCairo,cfr.A.Torre,Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea,Roma,2011,p.152,incuilaricchezzaincorpo-rata inunelevatonumerodibeneficiecclesiasticiecanonicatisembraesserestrettamentelegataaldinamismocommercialedell’area.
11.Nel1521laterrapossedutadaruralieraparial79%aCasalpusterlengo,all’89%aMaleo,al75%aCornoGiovine,all’80%aCastiglioneeaben il97%aCodogno,cfr.E.Roveda,La popolazione delle campagne lodigiane in età moderna, in «ArchivioStoricoLodigiano»,104(1985),p.7.
51
Nellememoriedellacomunitàdel1814,teseadunarapidaricostruzionediquestevicende, il legame inscindibile traparrocchia/collegiata, insedia-mentoe fondazionedeicanonicati tornerà inmanieramoltonetta12. Ildo-cumento è ovviamente di origine ecclesiastica,ma colpisce il fatto che lememoriesianoprecedutedallastoriadiciascunsingolocanonicatodipri-maerezione,edellalorocomposizionepatrimoniale(incuiicreditigioca-noun’importanza fondamentale13).Le installazioni religiosedichiaratedaldocumentosonobenquindicichieseentrolacomunità,settealsuoesterno(Codognoèterracircondatada“cassine”,epresentaunelevatissimofrazio-namento14),quattromonasterifemminili,duemaschili,unseminario,quat-troospedali e sei confraternite. Il capitolo rappresenta nell’estensore dellememoriel’epicentrodiquestosistema.Bisognaperaltroricordarechel’isti-tuzionepiùimportantenellastoriamodernadiCodogno,ilcollegioOgnis-santi,nonacasounseminarioperl’educazionedeichierici,dovettelasuarifondazione nel 1666 proprio grazie al cospicuo lascito di un canonico,LucaTrimerio15.L’abolizionedelcapitolonel1810rappresentòdunqueunseriomotivodi
scontrogiurisdizionaleconLodieal tempostessounmotivodi “diminu-zione” per le famiglie patrone dei canonicati. Una tardissima idea (1935)di riproporre la collegiata lodichiarerà espressamente, facendonotare co-me«Per le leggieversive,nel1810ilcapitolofusoppresso;maavendoal-cune famiglie rivendicato il lorodirittoa favorediqualchecanonicato,nesopravvisseroquattroconredditoassaimeschino»16.Icanonicati intesico-
12.ASDL,serie Parrocchie, Codogno, S. Biagio, b. 5: Trascrizione di queste memorie, Codogno,3/10/1814.
13.Ilcanonicatosottol’invocazionediS.Bonaventura(dipatronatodellafamigliaBel-loni) è composto ad esempiodaquattro capitali di 4.900 lire complessive, tra cui unodi2.100neiconfrontidellacomunità,ivi,f.30.
14.Ilnumerodelle installazionireligiosesarebbenaturalmentedaverificareattraversouna precisa indagine sugli insediamenti. Sul fenomenodelle “cassine” nelLodigiano cfr.l’indaginediA.Zambarbieri,Terra, uomini, religione nella pianura lombarda. Il Lodigia-no nell’età delle riforme asburgiche,Roma,1983, pp. 62-64.SecondoZambarbieri la di-spersione della popolazione in insediamenti staccati dal corpodella comunità raggiunge-vavalorimoltoelevati,superioriancheal60%.Un’altrafonteinteressantepermisurareladispersioneinsediativaèquellarelativaalletentateaggregazionicomunalidietànapoleo-nicaedelperiodopost-unitario. Inparticolare, laSotto-prefettura lodigianaavevachiestoaciascuncomunedifornireunelencodeicomuni,frazioniecassinaliubicatientrolacir-conferenzaditrechilometri,cfr.Archiviostorico-civicodiLodi(d’orainpoiASCL),Sot-to-prefettura,cart.123,Concentrazionedeicomuni,1867.Irisultatidelleinchiestemostra-no l’esistenza di alcuni casi limite: il comune diMontanasoLombardo, per esempio, di-chiara44cassinali e comunivicini,mentre iChiosidiPorta cremoneseaddirittura86, asintomodellanotevoleframmentazionedellostessocircondariocittadino.
15.Cfr.ASCC,Sez. antica,b.5,fasc.1,testamentodel7/12/1666.16.ASDL, Serie parrocchie, Codogno, S. Biagio,b.5:LetteradelvescovodiLodiCal-
chiNovatialPapaindata22/5/1935.
52
mefondazionidimesseeranoresistitifinoal1907,apartiredaquandononnefuronopiùcelebrate.Laspiegazionefornitaèdiordinefinanziario:l’in-teressedeiproventi sarebbe statounito al capitale, senzapiù impiegare larenditanelculto.Ècuriosonotarecome tuttaquestacomplessacostruzio-neeconomicaeritualesisiaaquantoparepersacompletamentenell’incer-tezza;secondoilsuddettodocumentoscrittodalvescovonel1935,«Nessu-noèingradodidarenotizieprecise»e«Precisareglionerideisuddescritticanonicatiècosadifficilissima,pernondire impossibile»17, limitandosiadesprimereungenericoobbligodimesseperillegatoMartinenghi.In realtà, l’ordine logico dell’argomentazione può essere comodamente
rovesciato.L’abolizionenapoleonica,e lasuccessivadistruzionedegliono-riritualidiCodognosembranopiuttostodescrivereun’incapacitàdelleéli-tediproseguirenellalorooffertadevozionale.AinizioOttocento,ineffet-ti,lecapacitàfinanziariedellefamiglieedeglistessicanonicatisembranoaquantopareessersidisseccati.LostessocollegioOgnissantiavevaaquan-topareesauritolericchezzetestateinparticolaredalTrimerio.Questafineingloriosaevocavadel restoanche lospettrodiunnuovomodellodicari-tàealtempostessodinuoviidealieconomicidelleélite.Loschemacano-nicale,elefortunedelrapportofamiliarenepotisticovengonocosìribaltatiinonoredinuoveeconomie18.
2. Fondazione di messe e carriere. La prospettiva lodigiana
Cambiamo prospettiva e cerchiamo di considerare il problema dellemessefondatenelsuocomplesso,inrelazionealtemaquiproposto:ladefi-nizionedelleéliteeleloroambizioni.Comeèstatosottolineato,ladiocesidiLodirappresentaadunlivelloepidermicodianalisiun’altissimapercen-tuale di patronati laici sui benefici esistenti. Secondo questi calcoli, i lai-cisonopresentiallafinedelSettecentoin213chiesesu240,esoprattuttocontrollano130beneficisu200.Il36%diquestiultimirisulterebbedivisofracomunità,confraterniteefamiglieprivatementrebenil46%èdipatro-nato nobile19.
17. Ibidem.18.Conalcuneapparentireminescenze.Sipensiallatardivafondazionediunmontedi
pietàaCodogno,avvenutanel1847grazieallegatodiAntonioFerrari«doveilpegnosiarestituito senza interesse dopoun anno», cfr.ASCL,Sotto-prefettura, cart. 87,CarteggiomontedipietàdiCodogno,3/10/1847.
19. G. Greco, I giuspatronati laicali nell’età moderna, in Storia d’Italia,Annali9:La Chiesa e il potere politico dal Medio Evo all’Età Contemporanea, Torino, 1988, p. 547. Sulclerolombardo,conuncapitolodedicatoinspecificoaLodi,sivedaX.Toscani,Il cle-ro lombardo dall’Ancien régime alla Restaurazione, Bologna, 1979.
53
Come vedremo a breve, tuttavia, altri documenti relativi alle fondazio-nidimessedifineSettecentodescrivonounarealtàdiversa.Ipatronatiap-paiono in realtàormai largamente inmanoaquelle checon il linguaggioodierno potremmo tranquillamente chiamare “istituzioni” (confraterni-te,scuole,laCassadireligione,ecc.).Adesempio,neldocumentodel1788danoistudiato,moltoanaliticoeriportatoinappendice,incattedrale(l’ar-cadevozionalepiù importantedellacittà),soltanto12beneficisu99risul-tanocontrollatidapatroninobiliocomunqueprivati20.Moltosimileèlasi-tuazionenelleparrocchiali,contrebeneficisuundicidipatronatonobileoprivatoaS.MariadellaPace, tresu14aS.Lorenzo,diecisu31aS.Mi-cheleArcangelo,unosu17aS.Biagio,tresu26aS.Salvatore,unosu13aS.Nicolò,quattrosu14aS.Naborre,addiritturaunosu41aS.Geminiano,seisu55aS.Maddalena,duesu23aS.Giacomo.Intuttequesterealtà,ifondatori originari dei benefici erano privati, quasi sicuramente cittadini,mentreèdifficilestabiliresefosseromembrideldecurionatoomeno(mol-toprobabilmenteno,oalmenocertonontutti,consideratoilgrandenume-rodifondatori).Ilrisultatoèdunquechiaro:lagranpartedeibenefici,checonognipro-
babilitàinorigineeranodipatronatoprivatodiventanodinominaistituzio-nale nel corso dei secoli. Resta naturalmente da capire quanto queste istituzioni siano interpreta-
bili come enti riconducibili a precise famiglie alla fine del Settecento. Siapre qui la necessità di unamicro-analisi dei benefici, che potrebbe esse-reunutile grimaldello per tentaredi scardinareunodeimaggiori proble-midistoriaeconomicaesocialedell’anticoregime,valeadireiconfinitrapubblicoeprivatonellaproprietàe seuna taledistinzione,quellacioè trapubblico e privato, può essere ancora analiticamente utile. In altri termi-ni, l’analisideibeneficidovrebbe invitareastudiareunaparticolareformadiproprietàchedalnostropuntodivistacontemporaneosipuòa ragionedefiniremista, piuttosto che portarci a pericolose avventure definitorie dicosaèprivatoe cosapubblico (oppure laicoe religioso) in antico regime.Detto in altri termini, la dinamica che stiamo osservando pare alludere aungigantescofenomenodimetamorfosidellaproprietà,chesi istituziona-lizza nel corso dei secoli.Le fondazioni secolari della diocesi, dunque parrocchie e chiese, sem-
brano letteralmente dominate da questo fenomeno di trasformazione, cheinvitaaleggerelastessaideadireligioneinmanierapiùproblematica21.
20.ASM,Culto p.a., cart. 373, Stato attuale delle messe fondate nella Città e ne’ sob-borghi di Lodi, 1788.
21.Giàdatempolastoriografiasottolinealacattivatendenzadiseparareeconomiaspi-ritualeemateriale,cfr.peresempioilseminalelavorodiJ.Chiffoleau,Pour une économie
54
Cisipuòdunquedomandareinchemodosipotrebbeimpostareunari-cercadelgenereperquantoriguardaladiocesinelsuocomplesso.Ilnostrofocus èvalutareilbeneficiocomeveicolodelleambizioni,inteseinunsen-somoltoconcreto:attivitàchesonoall’originedipromozioneeconomicaesociale di famiglie, costruzione o rafforzamento di comunità. Dunque unlatosocialeeunaltroinsediativo.Le indagini centralizzate promosse in epoca riformistica hanno confe-
rito grande importanza ai benefici, cercando di capirne le condizioni (lemesseacuidannovita,ipatronati,ipagamenti,iparrociofficianti)etalo-ra tentandodi ricostruirne lastoria.Suquestidati,che impongonounno-tevolelavorodicaratterequantitativo,hagiàcondottodelleindaginiAnni-baleZambarbieri,chehafornitounospecchiogeneraledellemessefondateindiocesi,proponendo in sostanzauna letturadi carattere territoriale (ca-pirequantemesseeranostatefondateincittà,neichiosienelcontado)eti-pologica(divisioneinregolari/secolari)22.In questa ricerca si è presa in considerazione una fonte quasi coeva a
quella utilizzata da Zambarbierima più analitica, trascritta qui in appen-diceerelativaatuttelemessefondateindiocesi23.Diognibeneficiosiri-
de l’institution ecclésiale à la fin du Moyen Âge,in«Mélangesdel’EcolefrançaisedeRo-me.Moyen-Age,Tempsmodernes»,96(1984),pp.247-279eilprecedenteId., La compta-bilité de l’Au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-vers 1480), Rome, 1980. Sul sistema beneficiale cfr. P. Preto,Be-nefici parrocchiali e altari dotati dopo il Tridentino a Padova, in «Quaderni storici», 5(1970),pp.795-813;L.Chatellier,Elementi di una sociologia del beneficio,inC.Russo(acuradi),Società, Chiesa e vita religiosa nell’Ancien Régime,Napoli,1976,pp.83-114;R.Bizzocchi, Patronato politico e giuspatronati ecclesiastici: il caso fiorentino,in«Ricerchestoriche», 15 (1985), pp. 95-106;D. Julia, Système bénéficial et carrières ecclésiastiques dans la France d’Ancien Régime, in Historiens et sociologues aujourd’hui. Journées d’étu-des annuelles de la Société Française de Sociologie,UniversitédeLilleI,14-15juin1984,Paris, 1986, pp. 79-107; Ciuffreda, I benefici di giuspatronato nella diocesi di Oria tra XVI e XVII secolo, cit.; Greco, I giuspatronati laicali nell’età moderna, cit.; A. Montan, Ecclesiastici e benefici ecclesiastici nello stato veneto durante il pontificato di Benedet-to XIV (1740-1758), in «StudiVeneziani», 24 (1992), pp. 87-145;Moroni,Reti di relazio-ni, rapporti di patronage, enfiteusi e benefici ecclesiastici, cit.; P.Hurtebise, Idéal réfor-miste et contraintes sociales. Le problème des bénéfices ecclésiastique au XVIe siècle, in D.Letocha(acuradi),Aequitas, Aequalitas, Auctoritas. Raison théorique et légitimation de l’autorité dans le XVIè siècle européen, Paris,1992,pp.127-139.Cfr.infineperlaSpa-gnaM.BarrioGózalo,El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-1834),SanVicentedelRaspeig,2010.
22.Zambarbieri,Terra, uomini, religione nella pianura lombarda, cit., pp.155-180.23. ASM, Culto p.a., cart. 373, Stato attuale delle messe fondate nella Città e ne’ sob-
borghi di Lodi, 1788, già citata.Molte dellemesse risultano a questa data vacanti, comeavverte il documento: «S’avverta che messe n. 12.056 delle incombenti ai sovradescrit-ti vacanti si trovano attualmente descritte ancora sotto varie chiese della città per aver-leiparrochiespressenelleloronotificazioni,qualimesse12.056rispettoan.10.069sonovincolateintitoloelerestanti1.387sonolibere».PerlerenditeparrocchialisivedaASM,
55
porta ilnomedel fondatore(manon l’annodellafondazionepurtroppo), ilsoggettotitolaredeldirittodinomina,chifinanzia(nonsemprecoincidenteconilpatrono),ilnomedelsacerdotetitolare,eilnumerodimesse.Lafon-teèstraordinaria,esiponeamiomododivedereallabasediunaqualsiasiindaginecheintendainvestigaretuttoilprocessodicostruzionesocialedapartedigruppichechiamiamoélite inanticoregime,esuunperiodoinso-spettabilmentelungo.Vedremo poi un caso specifico, quello del beneficio Tresseni, che per-
mette di verticalizzare e rendere diacronico, di spessore, questo ragiona-mento per ora sincronico. Non c’è dubbio infatti che la massa beneficia-lecostituisca/costruiscaunalargafettadisocietà,contribuendoarendernepiù dinamica e comprensibile la sua definizione, altrimenti spesso assaisfuggente e generica. Ciòdetto,miparechelafontepongaproblemidianalisinonindifferen-
ti.Anzitutto, il consistente numero dimesse (che, a livello epidermico, ciavvisa dell’ampia dimensione della questione) parrebbe invitare quasi adunaletturastrettamentequantitativa.Eventualigrigliesonoperòdifficolto-se.Inprimoluogo,visonoistituzionichepropongonoambizionimoltodi-verse, la qual cosa sfugge del tutto ad uno sguardo superficiale e classifi-catorio. La chiesa di S.Martino deiTresseni, tanto per dire, poco c’entracon le fondazioni in cattedrale, senza parlare poi di casi particolari comegli ospedali o l’Incoronata. Casi talmente diversi pongono la necessità diletture altrettanto diverse, rendendo una possibile classificazione unifican-tesimilealfamosoelencoborgesianoincuirientravaognisortadielemen-todifforme24,conl’unicadifferenzachenelnostrocasounasimileeteroge-neitàverrebbeoccultataenondisvelatacomeinBorges.Infine, un elemento cruciale con cui incrociare la fonte, e che necessi-
taperforzedicosediunaricercadicaratteremicro-analitico,èlacompo-sizionedeibenefici:quali tipologie dibenivenivano legatepercostituirli?Ineffetti,qualsiasigeneredirenditapuòessereconsideratautilepercosti-tuire unbeneficio: dagli affitti di terra, ai censi consegnativi, agli interes-sisuicrediti,finoaraggiungereformeancheassaisofisticatedidotazione.Altempostesso,laquestionevavistaanchesottoun’altraprospettiva:nonsolo entro il cono di osservazione della fondazione in titoloma anche in
Culto p.m., cart. 1.322, La municipalità di Lodi inoltra lo stato nominativo delle parroc-chie colla verosimile rendita e popolazione compresa nel di lei distretto,5/6/1805eperleproprietà(maperunperiodoprecedente)Zambarbieri,Terra, uomini, religione nella pia-nura lombarda, cit.,pp.139-143.
24. Il catalogo degli animali borgesiano, finto ritrovamento all’interno di un emporioceleste,haattiratodatempoleattenzionidisemiologi,filosofi,storici.Perunarivisitazio-ne inchiavedistoriadellascienza,cheriprende lesuggestionielaboratedaFoucault,cfr.M.Vegetti, Il coltello e lo stilo, Milano, 1987.
56
quellodellaprotezionepossibiledicertibeni(maggiorfacilitàdiesenzionefiscale25, ingeneralemigliorequalitàdeidirittidiproprietà26)odell’inten-sificazionedialtri,alludoinparticolareallamigliorecapacitàdiriscuoterecreditiointeressisuicreditirispettoagliindividui27.Un’analisi in profondità quantomeno delle carriere ecclesiastiche relati-
veaciascunafondazione,e inpartedeipatronati, sembraesseresuggeritadallapresenzadiunfondoarchivisticodiestremointeressepresenteinAr-chivioStorico-DiocesanoaLodi,danoiscandagliatopergliannifinalidelSettecento e iniziali dell’Ottocento: il fondo cosiddetto deiTituli sacri. Ilfondo,attualmenteprivodi inventario,èorganizzato insensocronologico,e comprende tutte le costituzioni in titolodei legati di culto lodigiani, ur-banieforensi.Ciòvuoldirecheècompostodafascicolichetrattanodellafondazioneopiùcomunementedellatrasmissionediunbeneficioallamor-te del precedente sacerdote titolare. Dunque, le inchieste riguardano gene-ralmentetreaspetti:daunlatoilpatronatoattivoepassivo,icuititolaride-vonofrequentementefornirel’alberogenealogico;dall’altro,unprogettodicarriera per l’assegnatario, e attestazioni sulla sua probità; infine, lo statodeibeniallabasedelbeneficioovvero«Seessoesaminatosappiachedet-tibenisianoliberi,oppureaffettiaqualchesortadilegato,dote,fedecom-messo,oaltraipoteca»28. Entroquestequestioni,chesonoevidentementetrasversaliaduncertoti-
po di società, ne possono naturalmente rimanere impigliate diverse altre.Ilragionamentomiparevalidosoprattuttoinrelazioneadueelementi,co-me inparte richiamato: il valorepotenzialmente “pubblico”delbeneficio;edilsuousopercambiarelanaturagiuridicadeipatrimonilegati.Ilprimopuntoèdavalutarsiinparticolareperquantoconcerneiltemadell’insedia-mento:ibeneficiservonoperpromuovereinsediamentiseparati29.Ilsecon-do riguarda il privilegio: i beni legati sono trasformati giuridicamente in
25. Bizzocchi, Patronato politico e giuspatronati ecclesiastici, cit.; Greco, I giuspatro-nati laicali nell’età moderna, cit., p. 549.
26.Greco, I giuspatronati laicali nell’età moderna, cit., p. 544, che sottolinea l’uso in funzione anti-dissipatoria del beneficio (in questo equiparabile ad altri dispositivi come ifedecommessi).
27.Tutta la storia ritualedell’Incoronata è segnatadaquesto leitmotiv, che la rende il grandeintermediariocreditiziotraprivatidellaLodidietàmoderna,cfr.E.Colombo,M.Dotti, Oikonomia urbana. Uno spaccato di Lodi in età moderna (secoli XVII-XVIII), Mi-lano,2011.Pertanto,isuoibeneficiappaionolargamentefondatisullerenditederivantidaldebito pubblico.
28.La domanda,molto comune, è tratta da un’indagine sul patrimonio per la costitu-zionediunbeneficioparrocchialeaTrebbiano,cfr.ASDL,Tituli sacri,1782-b,12/8/1782.
29.SivedaancheilcasofiorentinostudiatodaRobertoBizzocchi,Patronato politico e giuspatronati ecclesiastici,cit.,p.98,conlaconstatazioneche«c’èdinormaunacorrela-zionefragiuspatronato,insediamentoeproprietàfondiaria».
57
ecclesiastici,ponendosicosìinunasituazionefavorevoleperottenereesen-zionifiscaliepiùingeneraleneiconfrontidicreditoridisvariatanatura.Considerandolaquestionedaunpuntodivistaistituzionale,èchiaroco-
me i benefici portino ad un notevole accumulo rituale all’interno dei va-ri enti. Nel volume “Oikonomia” avevo passato in rassegna la situazionedell’Incoronata,laprincipaleistituzionecivilelodigiana,chetraSetteeOt-tocentopresentaunrilevanteaccumulodiculti,moltideiqualipongonose-riproblemidifinanziamento30.Lamaggiorearcaritualecittadina,studian-dolasituazionesecondolafotografiadel1788,è tuttavia lacattedralecheconta99fondazioni,peruntotalediben11.515messe.Comedetto,quasi tutte lemesserisultanofondatedafamiglie,canonici
odaprecedentivescovichehannopoilasciatoilpatronatoaistituzioniin-terneallacattedrale,inparticolareilcapitolooleconfraternite.Ipatronatiprivatirimastiaquestadatasonoinvecepochi.Invece,sul frontedelladomanda l’accumulazioneèormai la regola,co-
mesipuòfacilmentenotaredallaricorrenzadeinomideisacerdotibenefi-ciati, e spesso si spalma supiù istituzioni.Cosapensare adesempiodelladichiarazionedel1798 resadauncanonicopatrizio,FabrizioCarpani, al-lorché «espone possedere esso un canonicato residenziale nella Collegia-ta di S.Lorenzo di detta città del netto ricavo di lire 400, altro beneficiosemplicedeSS.GervasoeProtasoorainS.MariadelSoledellastessacit-tà fruttantedinetto lire253,altrobeneficiosemplicedeSS.Giacomo,In-tercisoedIlarioneerettonellachiesadelSS.moSalvatoredel ricavonettodi lire 20»31? Il tutto comepreludio alla possibilità di ottenereunulterio-re beneficio offertogli da suo cugino Filippo Pontiroli. La giustificazioneper l’unionedeidiversibeneficivenivafornitacostruendoquellocheeraeancorapiùdiventeràun topos neglianniseguenti,valeadire il riferimen-toaélitedivenuteormai indigenti,quasisulmodellodeipoverivergogno-sichetantosuccessostavanoriscuotendonelleistituzionicaritativeitalianedel Settecento32.Ilsupplicanteadducevainfatti«lascarsezzadeproprired-diti patrimoniali» oltre alle «abituali indisposizioni di salute oltre il pesodella famiglia, che gli cagionano più dispendioso il vitto»33. Come vedre-mo,lapovertàsaràunfenomenaleargomentoperrivendicareibenipatro-nalineiconfrontidi istituzionisempremenoacontrollofamiliarenell’Ot-
30.Colombo,Dotti,Oikonomia urbana, cit.31. ASM, Amministrazione del fondo di religione,cart.779,Lodi,13/9/1792.32. Cfr. S. Cavallo,Charity and power in early modern Italy. Benefactors and their
motives in Turin, 1541-1789, Cambridge, 1995;G. Ricci, «Nel paese di Anomalia» (ver-gognosi/declassati),inV.Zamagni(acuradi),Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi,Bologna,2000,pp.175-182.
33. ASM, Amministrazione del fondo di religione,cart.779,Lodi,13/9/1792.
58
tocento,unprocessocheerastatoinunaqualchemisuragiàfavoritodalleriformesettecentesche.Più in generale, questo fenomeno di istituzionalizzazione dei patrimoni
sembraesseremoltopiù trasversale enon toccare soltanto il temadelpa-tronato, come altrove abbiamo cercato di indicare34. Il versante dei dirittidinominarestacomunqueassaisignificativo,eaprenaturalmenteadun’ul-teriore importante direzione di ricerca: quella appunto all’interno dei fon-diistituzionali.Daquestopuntodivista,siailfondodireligioneoilfondoCulto inASM,come il fondoparrocchie inASDL (frantumatoa suavol-tainunaseriedicorpieinparticolareconfraterniteebenefici)fornisconomateriali di notevole interesse, chemi pare siano stati finora scarsamenteindagati. Ilmio tentativo di ricostruire la storia del beneficioTresseni se-gue in effetti proprio queste coordinate.
3. Il beneficio Tresseni: dalla fondazione della città alla dissoluzione del patronato
La ricostruzione della storia del beneficioTresseni è di particolare dif-ficoltà anzitutto per un fatto di durata: il beneficio si snoda sul lunghissi-moperiodo,dapocodopolafondazionedellanuovaLodifinoall’Ottocen-toavanzato.Anche ilpatronatovanta in realtàuna storiaquasi altrettantolunga: l’ultimadiscendentedella famigliaTresseni,Antonia, scomparene-glianninovantadelSettecento,passandopertestamentoloius attivo al co-gnato Filippo Pontiroli35. In particolare, iomi focalizzerò qui sulla docu-mentazionetardosettecentescaedottocentesca,corrispondentealmomentodi passaggio del patronato ed al confronto con le riforme prima e con laquestione dei beni nazionali e del controllo dello Stato poi. Naturalmen-te,taledocumentazioneèinteressanteancheperchéricostruisce(purbreve-mente)lastoriadelbeneficio.Come detto, esso vanta un’origine antichissima. Il beneficio era infatti
stato fondatodaMartinoCapitanodeiTresseninel1183,pochiannidopolaricostruzionediLodicompiutanel1158dapartediFedericoI36. Marti-no (riportoquidauna supplicadiAntonia eMariannaTressenidel1783)
34.E.Colombo,M.Dotti,Social configurations of municipal debt (Lombardy, XVII-XVIIIth centuries), in corso di pubblicazione sullo «European Journal of EconomicHi-story».
35. ASM, Culto p.m.,cart.1.340,fasc.743,dovesifariferimentoalpassaggiodelleso-stanzecontestamentodiAntoniadel19/5/1790.
36.L.Samarati,Dalla fondazione di Lodi nuovo alla riforma tridentina,inA.Caprio-li,A.Rimoldi,L.Vaccaro(acuradi),Diocesi di Lodi,Brescia,1989,pp.47-65.
59
«sotto l’invocazione del Santo di cui ne portava il nome, fundò due cap-pellanie, che volle chiamarsi rettorie con obbligo di una messa quotidia-nacadaunadiesse,dotandoledimoltiriguardevolisuoibenipatrimoniali,riservatoinperpetuoallasuafamigliailjuspatronatodellachiesaedell’e-lezione dei rettori»37. Nel 1203 si ha un’importante aggiunta patrimonialedapartediZanonecapitanodeTresseni,che«dotòlachiesaanzidettad’al-tri suoibeni, le cui rendite, col titolodi comunanzadiS.Martino, s’aves-sero da convertire da un amministratore da eleggersi da compadroni nel-le contingibili perpetue riparazioni della chiesa e delle case ivi annesse,non che per lamanutenzione de sacri arredi, ed altro inserviente al divinculto»38. La comunanza di S.Martino era uno dei quattro quartieri dellacittà,sortiattornoadaltrettanteparrocchie.Ilriferimentoallacapacitàdelbeneficiodipromuoverel’insediamentocittadino,omegliounasuaparte,èdunqueevidente.Nel1522,leduecappellanievengonodefalcatediunapartedeibeniper
costituirealtriduechiericati,«riconosciutosipoidacompadroniessereas-sai pingue la rendita».Un’ulteriore aggiunta alla sostanza del beneficio si ha infine nel 1584,
quando ne furono accorpati altri tre precedentemente fondati dalla fami-glia inalcunechiesedeisobborghi,cioèS.Maria inborgo,S.Giorgioex-tra muroseS.Martino inSolarolo,che«indiversi tempi inunco’sobor-ghi venivano demolite». Quest’ultimo beneficio sarebbe stato chiamato“delletrerettorie”39.La fondazioneoriginaria e le successive aggiunte formanounbeneficio
non solomolto ricco,maanchecapacedimantenersi economicamenteat-traversoil tempo.ÈcosìcheloritroviamoneglianniottantadelSettecen-to,allorchéseneparlacomediunarealtàeconomicaassaipingue.Nelcomplesso,lamassabeneficialesicomponediduerettorieporziona-
rie,duechiericati,unacomunanza,etrerettorieunite.Nel1785,lostatoat-tivoepassivoèilseguente40:
37. ASM, Culto p.a., cart. 376, fasc. 8, supplica di Antonia eMarianna Tresseni del12/9/1783.
38.Ivi,Antefatti della giunta economale, 1784.39.Cfr. Ivi, foglio segnatoF,Tre rettorie unite de SS. Mattia in Borgo, Giorgio fuori
delle mura e Martino in Solarolo trasportate l’anno 1584 nella chiesa di S. Martino no-minata de Tresseni, 19/2/1785.
40. Ivi, Conto dimostrante la totale rendita de benefici esistenti nella Chiesa di S. Martino de Tresseni di giuspadronato della famiglia Tresseni.
60
Tab. 1- Stato attivo e passivo benefici Tresseni (1785, lire imperiali)
Beneficio Rendita Pesi Rendita nettaComunanzaS.Martino 122.18Rettoriaporzionaria(Boccadoro) 515.7.9 397.2 118.5.9Altra porzionaria 584.18.9 483.2.6 101.16.3Letrerettorieunite 605.9.10 63.9.3 542.0.7ChiericatopossedutodaAscanioMarzani 150.16.6 15 135.16.6Altro chiericato 150.16.6 15 135.16.6
Consideriamo inmaniera piuttosto rapida e impressionistica la compo-sizione di queste rendite, come si può vederemolto premianti per gli of-ficianti,poiché ipesi (fracui icostiper lemesse)sembranoessereridotti.Bisognacomunquetenerecontochelostatoèpresentatodaunasupplican-te,AntoniaTresseni,chemiravaproprioadimostrarelapresenzadiunari-levanterenditalibera.Inognicaso,amiomododivedereèlacomposizio-nedelleentratearisultaredavverosignificativa.Riportoquisottoatitolodiesempioleentratedellacomunanza:
Tab. 2 - Rendite della communanza della Chiesa di S. Martino de Tresseni (1785)
Autore del pagamento Natura del pagamento LireDomenicoBalzari Affittodipertiche2aiChiosidiPorta
Cremonese23.16
CasaAndreani Livellonellecalendedinovembre 2.10NobileAlfonsoBarni LivelloaS.Michele 15.10NobileAlfonsoBarni LivelloaS.Michele 2.10Bellavita LivelloaS.Michele 2Rev.Gio.Bonomi Precario a S. Martino 4Rev.GiuseppeBrocchieri LivelloaS.Michele 3GiulioComizzoli LivelloaS.Martino 8BassianoCeresoli LivelloaS.Martino 3.10MarcheseMarcoCornaggia LivelloaS.Martino 2Giuseppe Fenino LivelloaS.Martino 5FlaminioGhisalberti LivelloaS.Michele 9GiuseppeGulielmino LivelloaS.Martino 3.10Antonio Magnani LivelloaS.Michele 4.10MonasterodiS.Giovanni LivelloaS.Martino 1.10PadriSomaschi LivelloaS.Michele 2.2CollegioorsolinediBorghetto LivelloaS.Martino 5OspedalMaggiorediLodi Livelloallecalendedigiugno 12Franco Piazza LivelloaS.Martino 4NobileGioBattaSilva LivelloaS.Martino 3NobileGuidoVisconti Livelloallecalendedinovembre 2MauroVitali LivelloaS.Michele 2Rev.BassianoZambellini LivelloaS.Martino 1.10Rev.BassianoZambellini LivellonellafestadiS.Giacomo 0.10Totale 122.18
61
Anche gli altri cespiti del beneficio Tresseni presentano composizionimoltosimili.Comesipuònotare,laformaeconomicapiùutilizzataèquel-ladellivello.Per“livello”sideveintendereinsostanzauncontrattoperpetuo,dipura
ricognizione, ormai indistinguibile dall’enfiteusi. Suquestogeneredi con-tratti, quasi tuttimolto risalenti emai affrancati, è costituita l’entrata del-lacomunanza.Tra i livellaricompaionoalcuninomidipatrizi lodigianiedi istituzioni tra le più antiche della città, in particolare l’ospedale. Vistodal cono di osservazione del Settecento, i diritti economici del beneficiosembranoavvalorare l’ideadiun rovesciamentodei rapporti.Normalmen-te,neitardisecolidell’etàmodernasonoinfattiistituzionidianticaorigine,cheavevanoallivellato i lorobeninelMedioevo,adessere titolaridique-sto tipo di diritti41.Lo stessoospedale è ancoraun riccopossessoredi li-velli.NelcasodeiTresseni,invece,èl’ospedalelodigianochesitrovaado-vercorrisponderelaricognizionelivellariaalbeneficio42.Lareciprocitàtraéliteeistituzioniapparedunqueparadossale:dirittiaccordatinelDuecentosonoancora riscossi,econtribuisconoa formare il redditodiunbeneficiocontesodaisuoistessipatroni.Ilbeneficiohamantenutoinsommalaforzadicontinuareadesigerediritticheainostriocchiappaionoquantomaide-sueti.Essoapparedunqueassaivitaledalpuntodivistasiaeconomicosiagiurisdizionale.Lapretesaideadi“secolarizzazione”portataavanti inpri-mo luogo dalle riforme e poi daNapoleone non intaccheràminimamentequestastrutturadellarendita,almenonelcasodeiTresseni.Vedremoinseguitomeglioiltemadellapovertà.ITresseniobbediscono
comunqueinpienoallostereotipodelnobilepovero.Unaprimasupplicainmateriaviene avanzatadalledueultimediscendenti,Antonia eMarianna,nel1783.Lasciamolorolaparola:
Iljuspatronatorelativoatuttiisuddettibeneficisièsempreconservatonediscen-dentidellafamigliaTresseni,sinoaldott.Vincenzodefontoil3novembre1780inpoverissimo stato, lasciate superstiti due orfane sue figlieMarianna edAntonia,qualibilanciatoadundipressol’enteereditariopaternocollepassività,hannocre-dutodelcasod’adirnel’ereditàcolbenefiziolegale(1782)soloriservandosiilcon-
41.Appare significativo cheRobertoBizzocchi, parlando di questo rovesciamento deirapporti,segnalicomestraordinarioilfattochegliArrigucciricevanoancoranelQuattro-centouncensoricognitivodalvescovodiFiesole,cfr.Bizzocchi,Patronato politico e giu-spatronati ecclesiastici,cit.,p.96.
42.Frugandotralecartedell’ospedale,sitrovanotiziadiduelivellilacuirenditaècor-rispostaregolarmentealbeneficiofinoal1865,unofondatosuunpodereaCàdeZecchiel’altrosualcunipezziditerradettiS.Calistodicircapertiche55postinelcomunediCor-negliano,cfr,ASCL,Ospedal Maggiore,b.224,fasc.7e21.L’affrancazioneinentrambiicasivieneeffettuatail18luglio1865,dapartedelRegioSub-economoaibeneficivacantidiLodiSettimoCrocciolani.
62
seguimentodelletenueragionimaterne,inpartecontrastatedacreditoriscoperti,adognimodoinsufficientiatrarnefruttochebastiaqualunquesiensiscarsissimialimentiavutidallamortedelpadresinoalpresente,colsacrificiodiqualcheca-pitalematerno nel collegio di S.Orsola, ove sonosi rifugiate, come che prive diparenti,pressocuifissarealmenounadecenteabitazione43.
Leragionimaterneeranopariacirca8.500lire,dicui1.800contrastatedai creditori.La richiestadelledue sorelle eradunquequelladipoteruti-lizzareiproventideibenefici, lacuirenditasuperavaa lorodiregliobbli-ghi da soddisfare.Mac’èdipiù.Nellorotesto,AntoniaeMariannatoccanoalcunitemidi
particolarerilevanza“sociale”.Esseinvocano
undecorosomantenimento,convenienteedanalogoallanascitadellesupplicanti,discendenti da una illustre in passato, ed ora depauperata famiglia,massime chegiàdagran temposono indetta chiesa tralasciate leoffiziatureedaltre fonzioniecclesiasticheprescrittedafondatori,siccomegiudicatesuperfluedopochelacittàèstataprovvedutad’altremoltechiese[…]emassimepuranchechetutti ibene-fizisuddetti,eccettol’unodechiericati,daldefuntopadreconferitoalgiàdagrantempo absente chierico AntonioMarzani, sono eglino posseduti da due canoni-cidellacattedrale,donFeliceBoccadoroedonCesareBonifazio,dettodeTresse-ni,altrondeco’lorocanonicatigiàcongruamenteprovveduti,poichés’eglièdove-redesacerdotiilprestaresoccorsoagliindigenti,l’obbligodivienemaggioreversoque’poveri icuimaggiorihannoconsecrate le lorosostanzeallachiesa,eperciòlipossonorichiedereperuntitolodiscambievolecorrispondenza.
Lapovertàdiunamoltonobilefamiglia;lanecessitàdiunnuovogeneredicaritàrivoltaaipatroni;lacrescitadevozionaledellacittà,cherendesu-perfluaunachiesaapertaormaisecoliprima;l’assenzadeichiericieilcu-mulo dei benefici da parte dei canonici sono insomma le principali argo-mentazionisollevatedallesorelle.Vedremoabrevecomequestousoquasicaritativo dei benefici sarà perseguito in unmodo del tutto differente dalpatronosuccessivo,FilippoPontiroli.Tuttequestetematichesiaddensanoconancoramaggioreforzadopoche
Mariannamuoreprecocementenell’ottobredel1784esipone ilproblemadicostituireladoteperl’unicasuperstite,Antonia.Pressochécontempora-neamente, buona parte dei benefici diventano vacanti per lamorte di donCesare Bonifacio de Tresseni avvenuta il 22 ottobre dello stesso 178444. Comesi intuisce facilmentedalcognome,si trattadell’ultimodiscendente
43. ASM, Culto p.a., cart. 376, fasc. 8, Supplica di Antonia e Marianna Tresseni,12/9/1783.
44. I benefici in oggetto sono una rettoria porzionaria; quello delle tre rettorie; ed ilchiericato di S. Martino.
63
deiTresseniadesserestatofornitodiunbeneficio.Aquestopunto,lasup-plicadiAntoniaassumeuntonoimperativo.Antonia,diciannovenne,èdescrittanellasuasupplicacome«bendispo-
sta di corpo e fornita di doti d’animo, facilissima a trovare collocamen-totuttavoltaavesseunadoteproporzionataallaassaicivilenascita,qualenon le può somministrare il tenue suo patrimonio procedente dalla me-tàdelladotematernanoneccedenteadundipressodilire3.350»45.Lari-chiesta, poi accordata, è dunque quella di graziareAntonia dalla nominadel titolaredelbeneficioalfinediusare la renditadelpatrimonioperco-stituire la sua dote.Nonèinquestasedepossibileripercorrereivaripassaggiche,attraver-
so le riformeecclesiastiche,hannoportatoad impostareunanuovastrate-gianeiconfrontidelbeneficio,nelperiodocompresotraMariaTeresae ilnapoleonico. Considerando la questione in seno alle famiglie dei patroni,una linea di tendenza pare comunque ovvia: ovvero, una crescente atten-zionestataleversoleesigenzedeipatronipoveri,chesiaccompagnavaallanecessitàdiuniformarefiscalmente ipatrimonideibenefici. Il tentativodiridurre l’eccezioneparedunqueaccompagnarsiadunanuova ideadicari-tàversoinobilidecaduti,compiutadirettamenteopermezzodeiSub-eco-nomati.Nel nostro caso, la dote viene concessama come “sussidio interinale”:
ciòvuoldireche,secondoilfisco,essaconsistevain«unsemplicesussidiodialimentiodidoteinluogodeglialimenti.Questosussidiorilevadaldi-rittoaccordatodalleleggicanonicheallipatronid’esserealimentatiincasod’indigenza sulli fondi del patronato»46.Antonia,peraltro, trovamaritomaresteràvedovadilìapochissimotempo.La precisazione da parte del Sub-economato era fornita per risponde-
readunapiùgeneralepetizioneper la secolarizzazionedeibeniavanzatadaAntonia,cheavrebbeapertoalloroliberoimpiego.Pocoprima,lastes-saAntoniaavevainfattiricevutounarichiestadi«mutuaricognizioneme-diante il pagamentodel dovuto laudemio»daparte diDonAntonioAgo-stinoMuzzani, acquirente di un fondo affetto al perpetuo livellodi lire 9e 10 soldi verso una delle rettorie beneficiate ora vacante. In sostanza, ilMuzzani chiedeva adAntonia e non all’amministrazionedi poter redime-reillivello47.Afrontediquestaminaccia,sihaunachiarareazionedapar-tedell’amministrazionedelculto,laqualefanotarecomeibeninonsianoin realtà secolarizzati, e pertanto Antonia non debba esserne considera-
45. ASM, Culto p.a., cart.376, supplicadiAntoniadel19/2/1785,cui segue ildecretodellaRealeGiuntadelSubeconomatodeibeneficivacantiindata17/3/1785.
46.Ivi,Milano,5/6/1789,afirmaDraghi.47.Ivi,24/9/1788.
64
ta la piena proprietaria. La definizione del concetto di “secolarizzazione”è in questo caso tecnica; secondo l’amministrazione, avrebbe voluto direchedeibeniinoggetto«siastatacambiatalaloronaturadibeneficiinme-rilegatidimessegiacchésiordinachenondebbanoconferirsiintitolo,malemesseda se stesse si debbano far soddisfareda sacerdotimercenari»48. Dunque:Antoniaavrebbepretesounainaccettabilelibertàdinon concede-reilbeneficioenonunsempliceusodellerenditeinavanzo.Ladecisionedell’amministrazione era pertanto quella di «passare all’instromento di li-vellaria ricognizione conD.AntonioAgostinoMuzzani, e di introitare illaudemionellacassadireligione»49.Letta fra le righe, tale decisione pare tuttavia essere dettata non tan-
to da un ragionamento relativo all’impraticabilità giuridica della secola-rizzazione, quanto vertente sui diritti economici. Questa impressione co-mevedremosaràriconfermataanchepiùavanti.Pochigiornidopo,infatti,lamedesimaamministrazioneapreinmanieramoltochiaraallasecolariz-zazione, interpretata ora come profanazione delle installazioni religiose.VisidiceperaltrocheAntoniapuòpagaresacerdotimercenariperlemes-se,senzachesianocostituiteintitolo,eche«invistadell’inutilitàdell’ora-torio,ossiachiesadiS.MartinodeTresseni,sidebbaqualoravisiailcon-senso della ricorrente profanare dalla curia ecclesiastica servatis servandis il dettooratorio e trasferire l’obbligodimessenellevicineparrocchiepiùbisognose»50. Tuttavia, la situazione sembracambiareancorapiù repentinamentedi lì
apoco, inconseguenzadiunaltroevento traumatico:Antoniamuoregio-vanissima e ad ereditare le sue sostanze è il cognato Filippo Pontiroli,anch’eglimembrodiunaanticacasapatriziadiLodi(anchesemenoanti-caesoprattuttomenorovinataeconomicamentedeiTresseni),chedatem-poaveva legato le sue fortuneaquelledell’Incoronata, il tempiocivicodiLodi51.L’atteggiamentodelpatronosicalaanzituttoinunasituazionediffe-renteemoltopiùfluida,ecioènelprimoperiodonapoleonico.Filippoèaquantopareunapersonaspregiudicata,enonesitaaservirsideisuoilega-mipoliticiedel ruolooccupatonel sistema, tantodapresentarsinelle sueinsistentisupplichecomemembrodellaGuardianazionaledelDipartimen-to dell’Adda.
48. Ibidem.49.Ivi,17/6/1790.50. Ivi,2/7/1790,Istromento nel quale si rileva che la famiglia Tresseni ha di suo pa-
dronato alcuni benefici semplici di detta famiglia esistenti nella chiesa di S. Martino dei Tresseni nella città di Lodi.
51.Colombo,Dotti,Oikonomia urbana, cit.
65
4. Micro-analisi di un beneficio. Età napoleonica e Restaurazione
Ilperiodonapoleonicoapreadunaseriedimicro-transazioni tra inuo-vi patroni e l’Agenzia dei beni nazionali, deputata a gestire i benefici va-canti.Anzitutto, lastessa trasmissionedelpatronatononsembraesentedadifficoltà.Inizialmente,ibeneficinoneranostatitrasmessiaFilippomain-camerati dall’agenzia in quanto considerati vacanti. Filippo riesce però aimpossessarsi dello ius attivo dopomolte insistenze grazie alla reintegra-zionedelladoteversatadaAntoniaalfratello;ilragionamentoèche«Ilti-tolo di dote dando alla dotata anche il pieno dominio degli effetti in do-tecostituitisembrafuordidubbiosimiledominiotrasferibilenelmarito,efatta vidua, nei suoi eredi» testamentari, vale a dire appuntoFilippoPon-tiroli52.L’immaginechel’agenziadiLodidàdiFilippononèpropriamen-te lusinghiera;unanotadel30novembre1793afirmaDraghi stigmatizzailsuocomportamentocomemoltoaggressivo,definendolo“impudenteeri-provevole”, poiché Filippo stava riscuotendo i diritti economici derivantidailivellisenzanemmenointerpellarel’agenzia53.Parimenti,vienevistodimalocchioilsuotentativodiimpedirelaven-
ditadell’oratorioTresseni, eliminatodalpianoparrocchialeedormaipro-fanato.Unanotadell’AgenziadeibeninazionalidelDipartimentodell’Ad-dadescriveFilippocome«benprovvedutodisostanze»,ilqualenonostantedue sentenze contrarie«cerca ancoradi frusciare le autorità costituitepermigliorare il conveniente suo stato a danno della nazione»54. Una pre-cedente supplica di Filippo aveva chiesto «di beneficare senza pregiudi-zio altruiuna famiglianumerosa, che si prestagratuitamenteper la causapubblica»55.Nonostantegli impedimenti, la strategiadiFilippoha successo:non ri-
esce a impedire la vendita dell’oratorio,madiventa e poi resta saldamen-tegiuspatronodelbeneficio.Comesièpotutovedere,Filippopiegaa suofavore l’argomento della povertà patronale; egli di fatto non è povero,ma
52. ASM, Amministrazione del fondo di religione,cart.779,comunicazionedell’Agen-ziadeibeninazionalidelDipartimentodell’Adda,afirmaBrocchieri,25ventosoannoVIdella Repubblica.
53. «Non può essere più impudente e riprovevole il contegno di don Filippo Pontirolinelladiramazionedell’avviso[…]collaqualetentad’impedirlel’esazionedeirispettivifit-tidalliaffittuarielivellarideibenideivacantibenefiziTresseni.LaRegiaamministrazio-neperònonavutoalcunriguardoaldettoarbitrarioecervelloticoavvisoepertantoproce-deràanchecogliattigiudizialicontroquellichenonpagassero;ecosìpureconverràch’el-la proceda indilatamente contro lo stesso Pontiroli per tutti gli altri relativi oggetti», Ivi,30/11/1793,afirmaDraghi.
54. Ivi, 8 fiorile, anno VI, risposta dell’Agenzia dei beni nazionali del Dipartimentodell’Adda a quella centrale.
55.Ivi,16ventosoannoVI.
66
suggerisce l’ipotesi che le rendite dei benefici debbano servire a integra-reunredditofamiliarealtrimentiinsufficiente.Aldilàdelchiaropretesto,unadinamicasièormairovesciata:nonrisultapiùconvenientecostituireibenifamiliariintitolo,creandocosìun’istituzione,masemmaioccorrecer-caredisvincolarli.Anchedaquestopiccolocasomiparechetuttoildibat-tito sulla secolarizzazione avvenuto in età napoleonica possa essere vistononsolocomeuntentativodicambiarecondizionegiuridicaadeibeni,mapiùprofondamentedipensareadun’economiadiversa,chepresentacioèundifferente regimedi scambio tra individui e stato e che su un altro pianoproponeunregimedeiprezzimoltopiùaggressivo.Qualche anno più tardi, la questione della povertà del Pontiroli sarà in
effettiripresa,poichél’agenziafacevanotarecomelasecolarizzazionefos-se impedita proprio dal fatto che «non vi concorre egli è vero l’estremodellapovertà»56.Oltreal temadella famigliaedunquedell’equitàemerge-vainfatticonprepotenzainqueglianniquellodellanazione(nonacasoilPontirolisierapresentatocomeunattivocittadino).Il temadell’equità è unpalese riferimento alla dinamicadei prezzi, di-
venutaferoceinperiodonapoleonico,conunchiaroaumentodell’inflazio-ne. Inquestecircostanze, l’avanzoannuodeibenefici tolte lespesedicul-tosarebbedovutoservireasoddisfarei«bisognidisuanumerosafamigliachenelleattualicircostanzedetempiquantunquenonsienodellamassimaurgenza,sonoperòassaicalcolabilipercuisembrachepossanointeressarel’equitàdelgoverno»57. L’altraideadieconomicitàderivavadalfattochelanazioneavrebbepo-
tuto sfruttare i pagamenti ai sacerdotimercenari fatti dal Pontiroli, defal-candoli da quelli dovuti dalla cassa. Se infatti «nell’accordare la secola-rizzazione dei nominati benefici s’ingiungerà l’obbligo al patrono di farcelebrare le messe dai detti coadiutori e cappellani sussidiari ne seguiràchequest’agenzia verrà scaricata dal far corrispondere ai surriferiti sacer-dotil’elemosinadellamessaquotidianachepresentementepercepisconodaquestacassa,eperconseguenzalanazioneavràunannualepesodimeno».Alcontrario,«seinvecenell’investireunnuovobeneficiatoquestinonèco-adiutorenécappellano,lanazionenonnerisentealcunvantaggio»58.Ilbe-neficio veniva dunque letto attraverso una visione strettamente produttivi-stica;ilsuoscopoeracosìstrettamenteconfinatoallaproduzionedimesse.In tal senso, dal punto di vista della nazione l’obbligo rituale non dovevaessere legato al finanziamento di una carriera possibile, quella del cadet-to;maesserepiuttostodirettoalmerosoddisfacimentodiunonere.Sitrat-
56.ASM,Culto p.m.,cart.1.340,annoX,18piovoso,afirmaTerzi.57. Ibidem.58. Ibidem.
67
tavanaturalmente,nelcasospecifico,diun’interpretazioneestrema,cheperlaveritàbisognerebbeverificarequantosiastatadavveroapplicatainepocanapoleonica.Effettivamente, il fondoTituli sacri diventa nel corso di taleperiodomoltomenocorposochenon inprecedenza, facendoritenere(purperviemoltoempiriche)cheilfinanziamentoallecarriereecclesiasticheinbuonamisurasiinterrompa.Inrealtà,lafamigliaPontirolinegliannisuccessividaràvitaadunase-
rie di nomine che possiamo tranquillamente definire di vecchio stampo,privilegiandoinparticolare(dopolatragicaeprematuramortedelfigliodiFilippo)l’alleanzaconlacasatapatriziadeiBarni,lapiùimportantefami-glia nobile di Lodi nell’Ottocento.Del beneficio si troveranno così titola-ri Ippolito Barni, ancoraminorenne59, figlio di Cecilia Pontiroli60 e di un altroBarni,Luigi; alla suamorte, il titolarediventeràCristoforo.Si segueperaltro lo stilema tipicodella nobiltà beneficiata, quello di nominaremi-norenniinattesadiprenderegliordinimaggiori.Ippolito,peresempio,ve-nivanominatoalbeneficionel1834dasuozioFilippoPontiroli,enel1841risultaancoraminorenne.Inrealtà,contrariamenteadaltresituazionivirtuosediscalataeconomi-
ca,situabiliperòinlineadimassimaneiduesecoliprecedenti61, in questo casol’assezio-nipotenonsembraprodurreparticolarivantaggi.Sesivuo-le,èpiuttostounassepersancire/tenereassiemeun’alleanza traduefami-gliepatriziecittadineimparentatefraloro,inunmomentodicollassoodiri-utilizzodelconcettodinobiltà.La discussione sul beneficio Tresseni copre così nel periodo della Re-
staurazione temi perlopiùmicro-economici. In particolare, il ragionamen-toerarelativoalleduevecchissimecaseincorporatenelbeneficio,edilcuiaffittocostituivapartedellarendita62. Ilproblema,chevedesolidalipatro-
59.ASDL,Serie parrocchie, Lodi, S. Salvatore, Beneficio di S. Martino dei Tresseni, cart. 5, attodi nominadel 12/11/1834. Ippolito succedeva alfigliodelPontiroli,Antonio,nominatonel1803,eaFilippoCarpani.Laconcessionedeibeneficiaminorennierapro-babilmentepiùdiffusanelSudd’Italia,doveeranoattribuiti ancheadonne, cfr.Greco: I giuspatronati laicali nell’età moderna,cit.,p.536.
60.Cecilia è la figlia di secondo letto di Filippo Pontiroli, avuta dalmatrimonio conMariaVisconti(altranobiletitolatasecondoleregoleasburgiche),cfr.ASCL,Sotto-prefet-tura, cart. 194, Elenco nominativo della nobiltà lombarda della regia città di Lodi compi-lati li quadri ritirati dalle famiglie nobili giusta quanto è stato ordinato col Superiore de-creto dell’I.R. Delegazione provinciale n. 11784, 416.
61.Moroni,Reti di relazioni, rapporti di patronage, enfiteusi e benefici ecclesiastici, cit.
62.Le casenoneranonemmenocompresenei catasti immobiliari iniziati daCarloVpoiché «fu[rono] fino da quel tempo (1555) considerate fondo ecclesiastico antico, ed im-munedaqualunquecaricospettanteall’estimosuddetto»,ASM,Esenzioni p.a., cart. 193bis, fededelragionatoBassanoCapellotidel3/11/1758.Lecarteeranoprodottealfinedipre-servareleimmunitànelnuovocenso.LasupplicadiVincenzode’Tressenidiqualchean-
68
no,beneficiarioegoverno,riguardalavetustàdelleabitazioni,chenel1829«trovasiinistatopiuttostod’esserericostrutt[e]cheriparat[e]»63.Inentram-biicasi,lasoluzionesceltaèquelladell’enfiteusi,cheprevedeilpagamen-to di un adeale e di un canone perpetuo, oltre all’obbligo di riparare le abi-tazioni.Unacasavienecompratadaunmaestroelementare,talFerrari,chela tenevagià in affittoper200 lire annue (di cuiperò98erano spesedalbeneficioperriparazioni).Lamotivazionefornitaperl’acquistoèdi«esse-relaripetutacasainvicinanzaaquellocalescolastico,desiderosod’altron-dediaggiungervialcunimaggioricomodi»64.L’enfiteusi,conun’enfasisulcontrattodimiglioria,sembradunqueilcontrattogiustopersgravareilbe-neficiodallecontinuespeseperlamanutenzionee,altempostesso,perga-rantirgli una rendita costante e accontentare il maestro. Naturalmente cisono anche dei “contro”: l’enfiteusi è probabilmente in questo periodo undiritto debole di proprietà, anche se indubbiamente flessibile. D’altronde,sappiamoche contemporanei tentativi di aggiudicazione all’asta erano an-dati deserti.L’altracasa,postanellacontradadiS.Pietroalcivico655, incontranel
1834unasortesimile.Sitentadivenderla,masenzasuccesso;allafine,sifronteggianodueproposte:quelladiGiovanniGhisi,chesioffredipagare170liredicanoneannuomanonl’adeale,equelladiGiovanniPremolicheoffre155lireannueedunadealepariadunanno.Premoliproponeinoltrecheilcanonenonvengacostituitosopralacasadelbeneficiomasu«un’al-tradisuaproprietà liberaedallodiale,echenell’acchiusastimadell’inge-gnerGiuseppeRubiatifuvalutatalire3917,cosicchélacasa,oradelbenefi-cio,verrebbeapassareinproprietàassolutadeldettosig.Premoli»65.SegueunlungoragionamentoeconomicosulvaloredellacasadelPre-
moli proposta come garanzia, da parte dell’efficientissimo Dipartimen-to fabbriche, secondo il quale sarebbe stata più conveniente l’ipotesi delGhisi66,chevienedunquepreferitoacondizionecheleriparazionineces-
noprimasottolineavanaturalmentel’antichitàdelleabitazioni:«Nelprincipiodell’edifica-zione della nova città di Lodi,Martino deCapitani deTresseno fece fabricare una chie-sa indettanovacittà sotto il titolodiS.Martinoconduecaseallamedemacontigue,al-laqualchiesapoi,cioènell’anno1183,daldettoMartinodeCapitanicomesoprafucon-stituitacongruadote,mediante ladonazioneedassegnod’altribenistabili», Ivi, Supplica di Vincenzo de Tresseni per il Reverendo don Vincenzo Boselli rettore porzionario suppli-cante del13/3/1752.
63.ASM,Culto p.m,cart.1.340,12/12/1829.64.Ibidem.65.Ivi,28/6/1834.66.«Calcolando l’eccessodi lire663delvaloreestimatoriodellacasaPremoli incon-
frontodiquellodellacasadelbeneficio,gliufficipreopinantihannogiudicatopiùvantag-giosoalbeneficio stessoche il canonevenisseassentato sullaprimaanziché sulla secon-dadidettecase,nonostantechequestasiadiassaimaggiorestensione,ecostituitadaun
69
sarieallacasadelbeneficiovenganoeffettuateentroseimesidall’aggiu-dicazione.Ugualmente, lo stesso beneficio pare ormai perlopiù attivo soltanto
all’internodi questa dimensione “micro”.Lamaggiore operazione che es-sodecidedi intraprendere riguarda l’acquistodiun«ritagliodi terrenori-mastoisolatonellasistemazionedelpubblicopasseggioincodestacittàdaPorta Castello a Porta Cremona»67, posto di fronte ad una casa allivella-tagiàdisuaproprietà.Ilprezzod’acquistoèconvenutoinlire952,perre-cuperare le quali si usano avanzi progressivi del bilancio e porzioni del-leadealidellecasegiàallivellate.L’investimentohaloscopodicreareunaproprietà più compatta, tanto che la condizione necessaria per ottenere ilpermesso governativo cita esplicitamente come condizione l’accorpamen-to del fondo. Comesipuòfacilmentenotare,inrelazioneallostudioquipropostodel-
le élite lodigiane il temadelbeneficioèdiuna ricchezza straordinaria. Ineffetti,analizzandounbeneficioattivosullunghissimoperiodocomequel-loTresseni,emergecomeilconcettostessodiélitesistrutturidiversamen-teneltempo.Ilragionamentononvuoleessererelativoadunasemplicedi-scontinuità da leggersi entro la storia di una supposta classe dominantecittadina,discontinuitàdelrestoovvia,mainvitainvecearifletteresuidif-ferenti veicoli utilizzati dai gruppi urbani per promuoversi e dirsi élite. Ilbeneficioservedirettamenteaquestoscopoperlargapartedellasuastoria.Inunprimomomento,essoèchiaramenteunmezzopercrearespaziurba-ni in un periodo di ricostruzione; in seguito, l’accento insediativo sembradiventare minoritario (ma la questione andrebbe studiata), in onore al fi-nanziamentodicarriereecclesiasticheedunqueallealleanze.Laripetizio-neneltempodelleélite,comelachiamerebbeforseinquestocasoDeleuze,siconfiguradunqueinmanieradiversaasecondadellecircostanze68. Tra Sette eOttocento, si assiste ad unmomentomolto forte di ristrut-
turazione di ciò che abbiamodeciso di chiamare élite; il patronato, tipica
maggiornumerodiambienti.Matalegiudizioèerroneo,conciòsiachelacasadiragionedelbeneficio intantovennestimatasole lire3.254 inquantochedalvalore […]fudedot-talasommadilire1.712importodiristauriistantaneidicuilacasastessaabbisogna[…]Ora,siccomeil livellarioèobbligatoadeseguiredelproprio idetti ristauri,cosìnevienecheilvaloredellacasadelbeneficiodaconfrontarsiconquellodellacasachesiverrebbesostituiredalPremoli,nonsilimitaallesolelire3.254maèrappresentatadaquestasom-maaccresciutadilire1.712»perirestauri,superandocosìdi1.048lireilvaloredellaca-sadelPremoli.Ibidem.
67.Ivi,28/3/1841.68.G.Deleuze,Differenza e ripetizione, Milano,1997(ed.or.1968).PerDeleuzecome
ènoto la ripetizioneèunacostantesfidaontologica,chenonripetemai l’originemacreacontenutinuoviadognimanifestazione.
70
espressione di queste élite nei secoli precedenti, viene contestato in favo-rediunnuovoconcettodipovertàoraprofessatodagliantichinobili,pro-babilmente in consonanza con il tema della sovvenzione ai poveri vergo-gnosi inrealtàgiàdimodadatempo.Laquestioneèdirompente:apre,adesempio,adunapiùchiaraeconomiadimercato,inparticolareinetànapo-leonica.“Esserepoveri”significainfatti inunqualchemodopiegarsiadi-namichefortementeevolutivedell’economia,sivedailtemadell’inflazione.Naturalmente, la povertà è un’arma a doppio taglio: dalle élite più furbe,come iPontiroli, essapuòessereutilizzatacomeunostrumentoperaccu-mulare ricchezza (inconsonanzaanchecon lanascitadiunanuovaclassepoliticaedell’ideadinazione)69.
5. Carità, nuove ricchezze ed esperimenti di sociabilità nella Lodi otto-centesca
Il rapporto tra povertà ed élite è solitamente letto, come sappiamo, inmaniera inversa: secondo questa visione tradizionale le élite promuovonoistituzioniperalleviare ilproblemadellapovertà70.Asuavolta,questo in-tervento sarebbe funzionaleaduna sortadi auto-affermazionedi tali ceti,diprocessodicostruzionedell’identitànobiliare,infinedicontrollodelpo-tere. Visonotuttaviasvariaticasi incuisonoleélitenobiliariedecclesiasti-
cheadiventarepovere,ragionpercuinonsoloistituzionispecifichemaan-chel’economiaritualeservonoinbuonamisuraasorreggerle71.Gliesempipossonoesserenaturalmentemoltissimi,comela letturadelfondoarchivi-stico Tituli sacri (manonsolo)suggerisce.Tipicamente,lachiaveperacce-derenuovamenteaibeniconcessiinbeneficioèquelladellarichiestadido-teperunafiglia,comeabbiamogiàvistoperiTresseni72.
69.Laquestionefupoinormataanchedalpuntodivistalegale,cfr.D.Schiappoli,Sul diritto del patronato povero d’avere gli alimenti sulle rendite della chiesa o del beneficio di patronato, in«Rivistadidirittoecclesiastico»,16(1906),pp.129-142.
70. PerLodi cfr.D. Fusari,Pauperismo e assistenza nella Lodi dell’Ottocento, in «IlRisorgimento»,39(1987),n.1,pp.1-30;n.2,pp.83-120.
71.Sulproblemadeiparrocipoveri inetànapoleonica,cfr. I.Pederzani,Un ministero per il culto. Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età napoleonica,Milano,2002,pp.177-188. Inognicaso, lacapacitàdi intervento statale sulverocuoredelproblema, ilpatronato,restaaquantoparelimitata,comelastessaautricenotaapropositodella«strut-turabeneficialedelpaeseeinparticolareallapresenzadimoltibeneficidipatronatopriva-to,settore incuineppuregliStatiriformatoripiùavanzatiavevanoavutol’ardiredi inter-venire»,p.179.
72.Oanche inaltricasi. Ilmodellodellasupplica,che ricavodallastoria familiarediunBelloni diCodogno fondatore dimesse in unoratorio di “sfrosatori” vicinoCodogno
71
Il discorso sulla povertà delle élite nobiliari s’intreccia comunque nelcorso della Restaurazione con nuove stringenti regole che tendono a nor-mare l’appartenenza a un cetonobiliare rigidamentedefinito73. In partico-lare,adettareleggesonoleregoleformalidiammissioneaglionoridicor-te,cheimpongonoallefamigliedifornireunaseriemoltocircostanziatadiprove74.LefamiglienobilidomiciliateinLodinel1825sonoappenasedici:Az-
zati,Barni,Bonelli,Carpani,Casati,Codazzi,Ghisalberti,Majneri,Modi-gnani,Pontiroli,Provasi,Rho,Sommariva,Visconti,Vistarini,eZumalli75.Da un rapido confronto con un interessante documento da noi ritrova-
tonelfondoarchivisticodellaSotto-prefettura,cheriportai100principaliestimatidellacittàinordinediricchezza,ilrilievoeconomicodiquestino-bilipareormaipiuttostoridotto.Nell’elencodegliestimati,danoiriportatoinappendice,siritrovanosoltanto:imarchesiGiulioeAnnibaleSommari-va (al settimoposto); ilnobileFlaminioGhisalberti (dodicesimo); il conteAntonioBarni(tredicesimo);GiovanniBarni(trentaseiesimo);GiorgioBar-ni(59°)76;CristoforoBarni(69°);FerdinandoeCarloVistarini(99°);e in-
(come lo chiama lui), segue più omeno questa falsariga: «Trovasi in oggi il supplicanteconladiluipoverafamigliainundeplorabilissimostatoconduefigliedunafiglianubiledinomeMadalenadicircaanni30conprossimaoccasionedelcollocamento,mapernonavereladote,néessereinstatoilsupplicantefargliverunoassegnohaperdutemoltealtrebuone occasioni, e sta in procinto di perdere ancora la presente, per essere il supplicante impossibilitatoadarglidotealcuna»,ASDL,Serie parrocchie, Codogno, S. Biagio, b. 34 (legatiA-G),supplicadiFrancescoBellonidel7/4/1778.
73.Occorre sottolinearecomunqueche la retoricadellapovertà in relazionealbenefi-cioèabbracciataanchedanonnobili.Per lasupplica inmateriadapartediunmercante,GiuseppeBrambilla,cfr.ASDL,Cattedrale,II/6,cart.21,10/10/1786.Larichiesta,relativaalla sospensionedellemessepreviste dal beneficio, èmotivata dalla presenzadi una leg-ge«chenessunopuossaessereiniziatoasagriordiniseprimanonabbiafattolostudiote-ologicosulaRegiauniversitàdiPaviainqualitàdialunnodiquelseminariogenerale».In-fatti,«riesceimpossibilealsupplicantedisostenerelespesedidettoseminarioattesalari-strettezza delle sostanze paterne obbligate al mantenimento della madre, di quattro figlimaschiediduefiglienubilicomedacertificatodelproprioparroco».Èdunquepresentatocomepaleseillegametrapatronatoepatrimoniofamiliare:nell’impossibilitàdifinanziarelacarrieradiunfiglio,sichiedeilrecuperodeiproventidelbeneficio.
74. Inparticolare, si raccomandavadiascrivereaglionori«Gli individuidientrambi isessi,lecuifamigliedaduecentoanniinaddietrofuronoelevatealrangodinobiltàoperesserestataaggregateadunConsiglionobiledicittà,opersovranaconcessione,purchélaloromadrenonfossedibassaestrazionemadifamiglia civile».Siescludevanoovviamen-tegli individuinobili«iqualiesercitanoqualcheartemeccanica»,masoloper ilperiododella loro attività,ASCL,Sotto-prefettura, cart. 194, Norme per l’ammissione agli onori dell’I.R. Corte nel Regno Lombardo-Veneto.
75.Ivi,Elenco dei nobili ammissibili agli onori di corte domiciliati nella città e nella provincia di Lodi, 22/3/1825.
76. Il quale fu a quanto pare piuttosto attivonel corsodelle alienazioni napoleoniche.Cfr. in particolare un’operazione finanziaria con cui Giorgio Barni compra un capitale
72
fineCesareRho (106°).Non vi è invece traccia degliAzzati, deiBonelli,dei Carpani, Casati, Codazzi,Majneri,Modignani, Pontiroli, Provasi, Vi-scontieZumalli.LafamigliapiùpresentesonoiBarni,chenelcorsodellaRestaurazioneappaionodigran lungacome inobili economicamenteme-glio posizionati. Ilraffrontotraelencodeimaggioriestimatiedaccessoallanobiltàapre
naturalmenteadiverse,possibilidomandeeaconseguentiopzionidiricer-ca. La principalemi pare relativa alla questione della non presenza neglielenchi nobiliari e nemmeno in quello degli estimati di unmassiccio nu-merodifamiglieaquantopareormaiex-patrizie.Abbiamoanalizzatopo-cofailcasoestremodeiTresseni.Leragionidiquestasparizioneinvitanoanzituttoadunostudiodeicasi individuali:sottoquali formecambia l’ac-cessoallerisorseurbane?Unapossibile,primarispostamiparesiadacer-carsi nei processi di istituzionalizzazione77. Ciò vuol dire che l’uso dellericchezzedapartedelleantichefamiglienobili inbuonissimapartesiisti-tuzionalizza; e viene dunque travasato nel tempo dentro queste istituzio-ni, cheprevedonodeterminate formedi controllo tendenzialmente semprepiù lassemanmanochecisiaddentranell’Ottocento. In tal senso, ilcasodell’ospedaleModegnani(maingeneraleeprobabilmentedituttigliospe-dali di patronato familiare), mi sembra paradigmatico. Attraverso l’ospe-dale, iModegnani in un certomodo spariscono come famiglia (e dunquecome individui censiti nell’estimo) e rinascono come istituzione. Uno deipresuppostidelnostro ragionamentoèchenelcorsodellaRestaurazioneeinseguitoquestoprocessodi istituzionalizzazionesi sclerotizzi,dandovi-ta a istituzionimagarinemmenopiùcontrollatedaimembrioriginaridel-lafamiglia. IlcasoTresseni(lafamigliasiestingue,mailbeneficioconti-nua)puòforseesserepropostocomeunpossibileparallelo,purcontutteledistinzionidelcaso,ivicompresalaseminaledistinzionetracultoecarità.Un’altradomandadiricercachedovrebbepartiredaquiriguardaappun-
toilrapportoconlacarità,cioèanzituttoconunsistemaistituzionalepre-ciso, che si trova immerso in un parziale processo di controllo da partedelloStatoodelcomunema in realtàancora incentrato largamentesu lo-gichefamiliari.Inqualmodoleélitepartecipanoaquestosistemapatrona-lemasemprepiùgarantitodalpubblico?Una fontechepotrebbe risultare
di15.532 lireal5%dovutodallacittadinaBarbaraZoncadavedovaRancatial soppressoconventodiS.AntoniodaPadova.PerregolareilsuoacquistoilBarniversa8.556lireindenarocontante,267perinteressidecorsie6.666incartedicreditoversolanazione,con-sistentiindueazionida3.333lirerilasciatedalcassiereRadaelli.Ilriferimentolegislativodell’operazioneè la leggedel14settembre1802sull’acquistodeicapitali.Cfr.ASM,Am-ministrazione fondo di religione,cart.115(Alienazioni),16/3/1803.
77.Cfr.inparticolareOikonomia urbana, cit.
73
interessanteèrappresentatadalleternedicandidatichevenivanopresenta-tiallaprefetturaperla«nominadeidirettoriedamministratoridegliistitu-ti elemosinieri,montedipietàecased’industrianellaprovinciadiLodieCrema»78.Aldilàdell’affermazionerelativaaduna«scarsezzadiindividuineiqualiconcorrano laqualitànecessariea sostenere lodevolmenteegra-tuitamente l’incarico»79, probabilmente di sostegno a una ripetizione dellenomine,èinteressanteil tipodigiudiziochesiproponedegliamministra-tori.Di fatto, aprevalereèungiudiziomorale sull’individuo: concetti co-mequellidiprobità, saviezza,naturafilantropicaed il loro riflessonell’o-pinionepubblica,sonodifattodominantinellapresentazionedeicandidati.Aprimavista,l’enfasisulgiudiziomoraleparrebbealludereallacostruzio-nediunasocietànonpiùdivisainnobilienonnobili,almenodalpuntodivistaamministrativo.Difatto,però,èforsesbagliatoragionare inmanieracosìgenerica: in realtà, inobiliufficialmente riconosciutinel1825 riman-gonodeipoli fondamentalidiaggregazioneall’internodideterminate isti-tuzioni.Abbiamo accennato prima agli ospedali: nel 1834, su cinque am-ministratori dell’Ospedale Fissiraga ben quattro fanno parte di famigliericonosciutecomenobili(GiorgioBarni,GuidoProvasi,GoffredoMajneri,MaurizioGhisalberti)80. Insomma, soltantoattraversounaparallela ricercaincentratasullebiografiediistituzioniediindividuisipotràsaperequalco-sadipiùsuprocessisocialichesonostatialungooscuratidaverieproprimitiideologici(riassumibiliforsenelconcettodiborghesia,sortadisuper-enfasidellaleggendadiunasuddivisioneurbanainpreciseclassesociali).Almomento,aifinidiquestofuturolavorosull’“Oikonomia”(comeab-
biamo intitolato uno dei volumi di questa collana) sono perlopiù disponi-bili un’analisi dell’Incoronata, di alcuni percorsi individuali, nonché quel-lachedefinireiunaveraepropriabiografiacreditiziadialcuneistituzioni,in particolare confraternite emonasteri, condotta in gran parte daMarcoDotti.Unlavoropossibiledovrebbeconsistereinunaricostruzionedelrap-portofrafamiglieeistituzioni,eperquantoriguardal’elencodeiprincipa-liestimatidanoiritrovato,inun’analisiinprofonditàdeimodidiproduzio-ne delle ricchezze.Ovviamente anche in quest’ultimo caso c’è un legamemoltoforteconleistituzioni,cheperònonsonostrettamentepatronalico-me nei casi di alcune famiglie “di antico regime”,ma che definirei in unsensomoltolargocome“pubbliche”.Ilprocessodicontrollodeicontiedi
78.ASCL,Sotto-prefettura, cart. 87, Terne per la nomina dei direttori ed amministra-tori degli istituti elemosinieri, monte di pietà e case d’industria nella provincia di Lodi e Crema. Gliannidiriferimentosono1816-1832.
79. Ibidem.80.Almanacco imperiale reale per le provincie del regno Lombardo-Veneto soggette
al governo di Milano, 1834, p. 289.
74
ridefinizionedelle funzioni a cui è sottoposto l’Ospedalemaggiorenel cor-sodell’Ottocentoneèunchiaroesempio.L’ospedalevedeinfattiunapreci-sazionedellecompetenze,versoipazziegliesposti,chelotrascinanoinse-rie difficoltà finanziarie81, mentre contemporaneamente si allentano alcunesuevocazioni(peresempioladotazionedifanciulle,maconogniprobabilitàancheilegatidiculto).Èsuquestasciachelenuovefamiglieegemonisonochiamateafornireamministratoridotatidiprobità,onestà,capacitànellage-stionedelpubblico:insommamoralitàedexpertise amministrativa.Pertanto,èabbastanzanaturalechealcunideigrandi ricchifiniscano inevitabilmenteperesserechiamatiall’internodellemagliediquestaamministrazione.PrendiamoadesempioilcasodellafamigliaGanzinelli,dicuiunmem-
bro figura come terzo estimato della città di Lodi. I Ganzinelli sononell’Ottocento imaggiori rappresentanti di una grande tradizione lodigia-na,l’artedellamaiolica,chespecialmentenelSeicentoavevavistoLodias-surgere a fama supra-nazionale, al pari di Faenza82. Appena dopo la finedell’età napoleonica, i Ganzinelli si contraddistinguono per alcuni corposi acquistiditerra,fracuifiguranolapossessioneLaColomberanelcomunediRoncadelloGhiaiad’Addadipertichecensuarie364,compratanel1816per 23.000 lire italiane; e la possessioneVailetta sita nei Chiosi di portacremonese,dipertiche405,acquistatanel1820per112.000 lire83. Ma an-che il legame con le nuove istituzioni pubbliche è evidente. Il capo-fami-glia,Gio.BattistaGanzinelli,risultavice-presidentedellaCameradiCom-mercionegliannicinquanta,einseguitoanchesuopresidenteconGaetanoPirovano come vice84, nonché assessoremercantile del tribunale di primaistanzaassiemeaCamilloPiccoli.Nel1902,infine,AngeloGanzinellisarànominatoamembrodelConsigliodegliOspitalidiLodi85.LostessoGaetanoPirovano,nonoestimatodellacittà,èunesempioan-
cora più evidente. Presidente anch’egli della camera di commercio, ap-
81.ASCL, Sotto-prefettura, cart. 106, Dimostrazione della deficienza annuale di ren-dita dell’Ospitale Maggiore in Lodi e luoghi pii uniti comprovata dai conti consuntivi la quale è causata dalle gravose spese pel mantenimento dei pazzi e degli esposti, aggiorna-taal21/12/1825.L’inchiestagovernativaèditreannisuccessivi,esi trascineràalmenofi-no al 1833.
82. G. Baroni, Storia delle ceramiche nel Lodigiano, in«ArchivioStoricoLodigiano»,24-26 (1915-1917), alle pp. 137-172; 1-36; 19-26; Id.,La maiolica antica di Lodi, in«Ar-chivioStoricoLombardo»,58(1931),pp.443-461;L.DeMauri, L’amatore di maioliche e porcellane. Notizie storiche ed artistiche su tutte le fabbriche di maioliche e porcellane, Milano, 1951, p. 125.
83. «Gazzetta di Milano», Foglio d’annunzi, Milano, 23/8/1816, p. 187; «Gazzetta diMilano»,editton.301del13/1/1821,p.279.
84.«GazzettadellaprovinciadiPavia»,annuncidiLodi,29/7/1833,p.62.85.ASCL,Ospedal maggiore, b. 247, fasc. 3, Nomine di Angelo Ganzinelli a membro
del Consiglio degli Ospitali di Lodi, (1902-1905).
75
passionato di enologia, sarà primo presidente pure della società dimutuosoccorso lodigiana, l’embrione della futura banca popolare86. Ma tutte le prime posizioni dell’elenco degli estimati rimandano a cariche importantiall’internodelsistemapubblico.Come è ampiamente noto, questo sistema di vertice apre anche a nuo-
vicanaliinformaliperlaformazionedelleélite:èciòchevasottoilnomedi sociabilità,unconcetto (eancheunmetododianalisi) chedaAgulhoninpoièdiventatounpolodiattrazioneperlastoriografia87.Lasopracitatasocietà dimutuo soccorso, per esempio, rappresenta unodi questi classicicanali,essendocostruitaaltempostessocomeunostrumentodielevazionemoraleedeconomicaperglioperai,ecomesocietàpartecipatadaélitede-siderosedi trasmettere tali insegnamenti88. Il sottinteso è che l’associazio-nismodiavitaaun’ampiafasciadisocietàinformale,appuntoformatadal-le élite (o da certe élite), capace di determinare le scelte di governodellacomunitàediaprireallenuove istituzionifinanziarie. IlcasodiLodiè intalsensochiaramenterivelatore,essendolaprimasedediunabancapopo-lareinItalia,nataappuntodaun’iniziativaassociativaqualelamutuosoc-corso89. In questa ottica possono essere letti anche altri tipi di associazione, tra
cui quelle sportive90. A quanto si sapeva finora, la prima società sportivaregolarmentecostituitainLodisarebbestatalaSocietàlodigianadiginna-sticaescherma,chesioccupavadivarisporteorganizzavaanchegiteso-
86.Sivedasullacameraesuisuoipresidenti,F.Samorè,Storia della Camera di com-mercio di Lodi, 1786-2009,Lodi,2009.
87.Cfr. inparticolareM.Agulhon,La repubblica nel villaggio. Una comunità france-se tra Rivoluzione e Seconda Repubblica,Bologna, 1991 (ed. or.La république au villa-ge, 1970); e Id.,Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Etude d’une mutation de sociabilité,Paris,1977.Vaperaltrorimarcatocomeilprimomodellodisociabilitàstu-diatodaAgulhonfosselegatoalleassociazionidiinsediamento,comelaconfraria,cfr.Id.,La sociabilité meridionale. Confréries et associations en Provence Orientale dans la deu-xième moitié du XVIIIe siècle,Aix-en-Provence,1966.
88. Per una sintesi cfr. P.Massa,A.Moioli (a cura di),Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo,Milano,2004.Lostes-sopercorsoèrintracciabileperquantoriguardaCodogno,lacuimutuosoccorsoalparidiquellalodigianatraghettòversolacostruzionediunabancapopolarepermezzodiunisti-tuto per i prestiti sull’onore rivolto ai membri della mutuo, cfr. ASCL, Sotto-prefettura, cart. 49, Società operaia di Codogno. Proposta di uno statuto per l’istituzione d’una ban-ca di prestiti d’onore per i membri effettivi dell’Associazione operaia di Codogno, da pre-sentarsi alla sanzione dell’Assemblea Generale che si terrà la domenica 9 aprile 1865, 10/3/1865.LostatutodellaBancapopolarediCodognoèdipocosuccessivo,del12/3/1866.
89. P. Cafaro, E. Colombo,Un’antica nobiltà. L’altro credito cooperativo a Lodi nel Novecento,Milano,2009.
90. Cfr. per esempio G. Vigarello, Sports, corps et loisir fin de siécle, in «Storia inLombardia»,6(1995),pp.301-401.Comeènotolaprospettivad’indaginesulclubsportivoera stata aperta dallo stesso Agulhon.
76
ciali91. In realtà, esisteva in precedenza unaSocietà pel nuovo giuoco del pallone nelle ortaglie di S. Chiara e Tagliabue presso la contrada di Ser-ravalle in Lodidiepocaaddiritturapre-unitaria,essendostata fondatanelmaggiodel185792. La società si proponevadi comprare le ortaglie di cui sopra, attraverso
unmeccanismodisottoscrizionidiquoteda60lireperognisocio,peruninvestimentocomplessivotraacquistoelavoridicirca15.000lire.Lanuo-vaassociazionerappresentòunnotevolesuccesso, tantodaraggiungereunnumerodipocosuperioreai170sottoscrittori,danoiriportatoinappendi-ce,incuisonocompresiovviamentenominotiegiàincontratidellasocie-tà lodigiana93.Sitrattainquestocasodiunelencoampio,taledacompren-dereancheuncertonumerodi impiegatimasoprattuttodiamministratoridiimportantiistituzionicittadine(ospedali,scuole,l’orfanotrofio,ecc.),cheprevedevano di incontrarsi frequentemente in un’assemblea annuale e inun’altra di carattere più ristretto94.
91. A. Bassi, Lo sport, in Lodi. La storia, dalle origini al 1945,vol.III,Lodi,1989,pp.381-402.
92. ASCL, Sotto-prefettura, cart. 75, fasc. Progetto per il nuovo manicomio in Lo-di, carteggio dal 1857 al 1860, cfr. in particolare il Progetto di statuto della Società per l’attivazione del gioco del pallone in Lodi. Ladocumentazione sulla societàgiococalciosi trova all’internodi un fascicolo sulmanicomionon casualmente, poiché l’associazioneavrebbecompratounfondoattiguoall’erigendomanicomio,cfr.Stralcio del tipo planime-trico della Regia Città di Lodi. In linee rosse viene indicato tanto il confine da assegnar-si all’erigendo manicomio che l’accesso rustico occorrente ad esso ed al gioco del pallo-ne. La risposta positivadellaCameradi commercio e industria dellaprovinciadiLodi eCremaèdel25/2/1857,ecitalapatenteimperialedel26novembre1852sulleassociazioni.
93.Ivi, Elenco dei contribuenti. L’elencofornisceancheleprofessionideisoci.94.ASCL,Sotto-prefettura, cart. 75, Progetto di statuto della Società per l’attivazione
del gioco del pallone in Lodi, art. 2, Dell’adunanza generale; e art. 3, Della rappresentan-za sociale.
77
Appendice
1. Capitalisti della città di Lodi nel 17691
BigoniPrevostodonPietroefratello 8.575Brochieri Paolo Antonio ed eredi 9.994Bonelli don Antonio 13.415Berinzaghi Dottore don Antonio 6.000ConfraternitadellaSS.Trinità 1.300ConfraternitadiS.taMariadelSole 29.233ConfraternitadiS.taMarta 1.350CattaneoCarlo 6.400ConventodiS.Francesco 13.565CalderaramarcheseAntonio 9.951Congregazionede’Pretidell’OratoriodiS.Filippo 16.836ConsorziodelClerodiLodi 6.897ConsorziodelClerodiLodi 8.000CollegiodiS.OrsoladiLodi 22.170CollegiodiS.OrsoladiS.Colombano 11.875CappellanodiMarzano 6.000CappellanodiS.Rocco 2.000CastellimarcheseCamillo 6.010CarminatiDottoreAntonio 800CaritàLuogoPiodiMilano 5.450CapitoloMaggiorediLodi 13.000CesareoR.Gio.Batta 1.300CratediS.Bassano 4.000ComottiR.Gio.Batta 2.000
1.Distribuzionedeldebitomunicipale.ASM,Censo p.a., 1.385.
78
ContadodiLodi 2.260ComunanzadiS.Biagio 200ConventodiS.Domenico 3.800ConventodiS.AntoniodiPadova 3.125ConventodiS.Agnese 9.700CongregazionedeiP.P.Somaschi 10.158CanonicadiS.Romano 1.000DaRhoDonnaGiovanna 5.655DamianiEredità 26.000Fissiraga Eredità 1.610Fossati don Giuseppe 4.400GusmeriCanonicoPrimiciere 3.009GusmeriBassano 9.075GesuitiRR.PP.diS.GirolamodiMilano 3.000Inzaghidottorfisico(cuisucc.l’OspedaleMaggiorediLodi) 2.250MensaVescovilediLodi 1.000MonasteroVecchiodiS.Chiara 6.540MonaciOlivetanidiLodi 4.000Monastero di S. Benedetto 54.400MonasteronuovodiS.Chiara 53.762Monastero di S. Gio. Batta 24.500Monasterode’SS.CosmaeDamiano 19.100MonasterodiS.Vincenzo 71.712Monte di Pietà 27.954Monte di Pietà 15.748M.diS.taSavina 4.415MarchiGavazziAnna 3.000Muzzanidott.Coll.todonAgostino 1.625ModegnaniContedonGio.Batta 28.331Marchi Bassano 8.000OspedaleMaggiorediLodi-tesoreriagenerale 84.211OspedaleMaggiorediLodi-EreditàVillanuova 2.775OspedaleMaggiorediLodi-TesoreriaCarminati 27.042OspedaleMaggiorediLodi-TesoreriaGorla 7.000OspedaleMaggiorediLodi-TesoreriaBonetti 1.500OspedaleMaggiorediLodi-CapitalediS.Stefano 11.562PergamoMarcantonio 1.000Prati don Alessandro 3.690Perla R.D. Francesco 1.200Pontiroli don Antonio 5.000ProvasiFrancesco 21.928
79
Riccio Ricci 7.419ScuoladelSacrarioinDuomo 7.000Scuola di S. Bassano 20.377ScuoladiS.taMariadelCarmine 1.400ScuoladellaPietàinDuomo 500ScuoladellaConcezioneinS.Geminiano 10.812Scuola del Rosario 10.030Scuola del Rosario 5.000ScuoladellaB.V.MariaCoronata-TesoreriaGenerale 71.997ScuoladellaB.V.MariaCoronata-TesoreriaCrotta 14.205ScuoladellaB.V.MariaCoronata-TesoreriaVirtuana 2.623ScuoladellaB.V.MariaCoronata-TesoreriaBignana 10.000ScuoladellaB.V.MariaSottolaScala 7.500ScuoladellaConcezionediS.taMariaMaddalena 1.500ScuoladellaConcezionediS.Lorenzo 23.350ScuoladellaConcezionediS.Lorenzo 7.850ScuoladelSS.inS.Lorenzo 1.200Scuola di S. Paolo 9.000ScuoladiS.Bovo 11.150ScuoladellaConcezioneinS.Francesco 5.233ScuoladellaConcezioneinS.Francesco 5.000SommarivamarcheseOratoredonEmilio 22.652SommarivamarcheseOratoredonEmilio 50.000ScalaContedonBaldassarre 13.077SanLorenzoCollegiataInsigne 8.000Tedeschi Alfonso 1.100Tressenidott.Vincenzo 5.300VillanimarchesedonAlessandro 28.627VillanimarchesedonFrancesco 24.000VignatiCanonicatoSanBassano 6.500Zane Bassano 1.500
2
2.
80
Fond
ator
i de
i leg
ati
Cap
pella
ni
vita
lizi e
m
erce
nari
Fond
i, liv
elli
e ca
pita
li ob
blig
ati p
er
Dot
e de
i Leg
ati
Valo
reN
umer
o e
luog
o de
lle
mes
se a
nnua
li
Rend
ita
annu
a (li
re,
sold
i, de
nari)
Obb
lighi
de
ll’O
sped
ale
oltr
e le
mes
se
Doc
umen
ti de
lla
dona
zion
e
Carlo
Man
delli
Fortu
nato
M
arig
oni
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re d
etto
“Pezzolo”a
Tavazzano
(affittato)
22.000
292
nell’
Ora
torio
di
S. G
io. B
atta
a
Tavazzano
210
4Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento4
maggio1325
Orin
o Ti
zzon
iPi
etro
D
epre
ti ca
ppel
lano
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
12.200
18 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
2415
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
17maggio
1350
Fran
cesc
o M
elet
iBa
ssia
no
Mor
oni
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
292
della
CollegiatadiS.
Lorenzo
401
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
6novembre
1466
Bern
ardi
no
Bore
llaPrevostodi
S. G
iaco
poPo
dere
det
to
“Mariago
Gra
nde”
(affittato)
anniversario
conmessa
cant
ata
dal
prevosto
9pagarelivelli
Paga
re d
el fo
ndo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
13 a
prile
1566
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi2
2. A
SM, A
mm
inis
traz
ione
del
Fon
do d
i rel
igio
ne,504.
81
Tedo
ldin
a D
enti
Teod
oro
Dos
sena
ca
ppel
lano
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
32 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
44Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
24 lu
glio
1685
Ang
ela
Mod
egna
niR
R P
P M
inor
i Osservanti
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
A d
iscr
ezio
ne
dei R
R P
P de
lla
chie
sa d
i S.
Fran
cesc
o
200
pagarelivelli
Paga
re d
el fo
ndo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
19 o
ttobr
e 1607
Chiesadi
S. P
ietro
in
Pirolo(ex
Ospedale)
Ilparroco
della
chi
esa
di S
. Pie
tro
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
216nellachiesa
di S
. Pie
tro in
Pi
rolo
300
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
18 g
enna
io
1624
Fran
cesc
o Pelloja
Ann
ibal
e M
artin
i ca
ppel
lano
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
73 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
100
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
20settembre
1631
Fran
cesc
o Pelloja
Filip
po
Boudray
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
73 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
100
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
20settembre
1631
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
82
Luigia
Vistarini
RR
PP
Dom
enicani
Pode
re d
etto
“M
ariago
Gra
nde”
(affittato)
7 ne
lla c
hies
a diS.D
omenico
912
6Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Codicilli8
gennaio1641
Fran
cesc
o Danova
Prevostodi
S.Salvatore
Pode
re d
etto
“Calca”
(affittato)
3.24
810nella
Parr
ochi
ale
di
S.Salvatore
15Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
25maggio
1556
Fran
cesc
o Danova
Gio
. G
iano
tti
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re d
etto
“Calca”
(affittato)
124
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e17
117
6Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
25maggio
1556
Fran
cesc
o Danova
Sace
rdot
i mercenari
Pode
re d
etto
“Calca”
(affittato)
Unanniversario
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e
6Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
25maggio
1556
Fran
cesc
o Danova
RR
PP
Min
ori
Osservanti
Pode
re d
etto
“Calca”
(affittato)
Unanniversario
nella
chi
esa
di
S. F
ranc
esco
6Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
25maggio
1556
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
83
Ale
ssan
dro
Leccam
iR
R P
P Dom
enicani
Pode
re
“Antegnatica”
(affittato)
9.500
2 ne
lla c
hies
a diS.D
omenico
16Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
26aprile
1534
Barto
lomeo
Gan
dini
RR
PP
Cappuccini
assis
tent
i
Pode
re
“Antegnatica”
(affittato)
292
all’a
ltare
dellaCrocera
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e
401
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento5
giugno1656
Barto
lomeo
Gan
dini
Fortu
nato
Be
sozz
i ca
ppel
lano
vitalizio
Pode
re
“Antegnatica”
(affittato)
292
nell’
Ora
torio
di
S.Salvatoredi
LodiVecchio
401
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento5
giugno1656
Barto
lomeo
Gan
dini
RR
PP
Dom
enicani
Livelloattivo
su u
n po
dere
a
Mon
ticel
li
130
Anniversaricon
messe
60pagarelivelli
Paga
re d
el fo
ndo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento5
giugno1656
Gia
copo
Fi
lippo
Po
rtalu
pi
Giu
sepp
e A
rade
lli
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re
“Antegnatica”
(affittato)
9.500
292
all’a
ltare
ne
lla c
hies
a de
ll’O
sped
ale
Mag
gior
e
401
pagarelivelli
Paga
re d
el fo
ndo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento6
marzo1680
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
84
Giambatta
Baro
ncin
iPrevostodi
S. G
iaco
poPo
dere
“Baroncina”
(affittato)
3.100
Anniversario
ealtremesse
nella
chi
esa
di
S. G
iaco
po d
i Lo
di
112
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
3dicembre
1566
Rev.
Seba
stia
no
Minoja
Paol
o Crevani
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re
“Baroncina”
(affittato)
Unamessa
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
2Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
1°luglio
1678
Elen
a M
uzza
niPa
olo
Crevani
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re
“Santomà”
(affittato)
3.52
542
nel
la c
hies
a de
ll’O
sped
ale
Mag
gior
e
5715
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
26marzo
1565
Elen
a M
uzza
niSa
cerd
oti
mercenari
Pode
re
“Santomà”
(affittato)
Anniversario
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
6Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
26marzo
1565
Ago
stin
o Bo
noni
RR
PP
Fran
cesc
ani
Pode
re
“Santomà”
(affittato)
Anniversario
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
15Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
21 g
iugn
o 15
71
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
85
Ago
stin
o Bo
noni
Arc
ipre
te
della
Cattedrale
diLodi
Pode
re
“Santomà”
(affittato)
Anniversario
nella
chi
esa
Cattedraledi
Lodi
10Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
21 g
iugn
o 15
71
Ora
zio
Sommariva
Piet
ro
Mor
andi
ca
ppel
lano
i vitalizio
Pode
re
“Santomà”
(affittato)
42 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
5715
Pagarelivelli
passividelfondo,
ciòcheresta
afavoredegli
inferm
i
Testam
ento
12 fe
bbra
io
1698
Ale
ssan
dro
Ceresoli
RR
PP
Fran
cesc
ani
Pode
re
“Sanzenone”
(affittato)
5.060
Anniversari
ealtremesse
nella
chi
esa
di
S. F
ranc
esco
50Unlegatodi1.000
lireper10doti
e il
resto
per
gli
ammalati
Testam
ento
1°luglio
1591
Giampietro
Veggi
RR
PP
Ago
stin
iani
Pode
re d
etto
“IlC
omune”di
LodiVecchio
5.32
4Anniversario
nella
chi
esa
di
S. A
gnes
e di
Lo
di
216
Per i
l mantenimento
degliammalati
Testam
ento
22dicem
bre
1665
Giampietro
Veggi
Parr
oco
della
Cattedrale
diLodi
Pode
re d
etto
“IlC
omune”di
LodiVecchio
Anniversario
nellaCattedrale
diLodi
10Pe
r il
mantenimento
degliammalati
Testam
ento
22dicem
bre
1665
Giu
lio
Codecasa
Girolamo
Ran
cati
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re n
el
terr
itorio
di
LodiVecchio
(affittato)
12.4
57365
nell’
Ora
torio
di
S.Salvatorea
LodiVecchio
501
176
Perm
antenere
incurabili,poveri
vecchiim
potentie
dementati
14 o
ttobr
e 1688
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
86
Giu
lio
Codecasa
RR
PP
Dom
enicani
Pode
re n
el
terr
itorio
di
LodiVecchio
(affittato)
Anniversario
nella
chi
esa
di
S.Dom
enico
100
Perm
antenere
incurabili,poveri
vecchiim
potentie
dementati
14 o
ttobr
e 1688
Giu
lio
Codecasa
Capitolo
della
Cattedrale
diLodi
Pode
re n
el
terr
itorio
di
LodiVecchio
(affittato)
Anniversario
nellaCattedrale
diLodi
100
Perm
antenere
incurabili,poveri
vecchiim
potentie
dementati
14 o
ttobr
e 1688
Ale
ssan
dro
Carminati
RR
PP
Ago
stin
iani
Pode
re d
etto
“LaSacchella”
3.55
3N.variabile
dimessenella
chie
sa d
i S.
Agn
ese
12L’avanzoper
mantenerei
convalescenti
Testam
ento
10luglio
1697
Fond
ator
e ig
noto
Parr
oco
diLodi
Vecchio
Pode
re
“Cazum
ani”
vendutoma
gravatodal
lega
to
Anniversario
e ol
io p
er la
lampadanella
chiesadiL
odi
Vecchio
30Instr.odel
4dicembre
1703
Ann
a M
aria
Villanova
RR
PP
Minimi
Pode
re
“Portadore”
oltre
Add
a (affittato)
4.700
37 n
ella
chi
esa
di S
. Fra
nces
co
di P
aola
51L’avanzoper
mantenereimalati
Testam
ento
12 g
iugn
o 1693
Ann
a M
aria
Villanova
Sace
rdot
i mercenari
Obb
ligo
dell’affittuale
del
pod.
”Por
tado
re”
5messe
all’a
nno
710
L’avanzoper
mantenereimalati
Testam
ento
12 g
iugn
o 1693
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
87
Piet
ro
Cam
illo
Villanova
RR
PP
Carmelitani
Scal
zi
Pode
re
“Portadore”
oltre
Add
a (affittato)
Anniversario
conmessa
cant
ata
nella
ch
iesa
di S
. M
arco
200
L’avanzoper
mantenereimalati
Testam
ento
3dicembre
1707
Giu
lia
Serafina
Inzaghi
Sace
rdot
i mercenari
Pode
re
“Cornegliano”
(Ospedale)
7.030
12 n
ella
chi
esa
delle
MM
O
rsol
ine
di
Lodi
1610
L’avanzoper
mantenereimalati
Testam
ento
1°luglio
1715
Giu
lia
Serafina
Inzaghi
Parr
oco
della
ch
iesa
di
S.M
. del
la
Clemenza
Pode
re
“Cornegliano”
(Ospedale)
N.variabile
dimessenella
chie
sa d
i S.M
. dellaClemenza
100
L’avanzoper
mantenereimalati
Testam
ento
1°luglio
1715
Giu
lia
Serafina
Inzaghi
RR
PP
Fran
cesc
ani
Pode
re
“Cornegliano”
(Ospedale)
N.variabile
dimessenella
chie
sa d
i S.
Fran
cesc
o
1210
L’avanzoper
mantenereimalati
Testam
ento
1°luglio
1715
Cont.a
Cam
illa
Cavazzidella
Somaglia
Bass
iano
Zambelli
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
airago
Picc
iolo
” (affittato)
5.045
292
nella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
401
10
L’avanzoperil
mantenimento
degliinfermi
Don
azio
ne 4
lu
glio
172
4
Cont.a
Cam
illa
Cavazzidella
Somaglia
Prevostodi
S. M
iche
lePo
dere
det
to
“Mairago
Picc
iolo
”
10nella
Parr
ochi
ale
di
S. M
iche
le
1315
L’avanzoperil
mantenimento
degliinfermi
Don
azio
ne 4
lu
glio
172
4
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
88
Cont.a
Cam
illa
Cavazzi
della
Somaglia
Gio
. D
agra
da
capp
ella
no
vitalizio
Pode
re d
etto
“M
airago
Picc
iolo
”
32 n
ella
chi
esa
diS.L
eonardo
44
L’avanzoperil
mantenimento
degliinfermi
Don
azio
ne 4
lu
glio
172
4
Carlantonio
Bone
ttiR
R P
P Cappuccini
assis
tent
i
Pode
re d
etto
“M
airago
Picc
olo”
(affittato)
365all’altare
dellaCrocera
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
501
176
L’avanzoperil
mantenimento
degliinfermi
Testam
ento
16settembre
1718
Barto
lomeo
Mar
coli
Sace
rdot
i mercenari
Pode
re
detto“Ca’
de’ Z
ecch
i”
(affittato)
1.54
8120
nell’
Ora
torio
di
S. B
erna
rdin
o nelluogodiC
a’
de’ Z
ecch
i
165
L’avanzoperil
mantenimento
degliinfermi
Testam
ento
17 fe
bbra
io
1712
Cristofano
Castelli
RR
PP
Min
ori
Osservanti
Terr
a a
Castelnovo
Bocc
adad
da
(alivellataa
77L)
A
nnua
le c
on
messacantata
nella
chi
esa
di
S. F
ranc
esco
16
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento
19 fe
bbra
io
1492
Cristofano
Castelli
Prevosto
della
Cattedrale
diLodi
Terr
a a
Castelnovo
Bocc
adad
da
A
nnua
le n
ella
Cattedraledi
Lodi
10
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento
19 fe
bbra
io
1492
Barto
lomeo
Brac
coSa
cerd
oti
mercenari
Casa
dell’
ered
ità
Codecasasu
cui s
i fon
da il
le
gato
225
Ann
uale
nel
la
chie
sa d
i S.
Tommasonel
Seminario
3
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento
26gennaio
1631
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
89
Piet
ro P
aolo
G
andi
ni
Paol
o Crevani
capp
ella
no
vitalizio
Sedumea
Barg
ano
(allivellatoa50
Lannue)
36nellachiesa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
4910
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento
10aprile
1672
Giambattista
Gor
laM
auro
M
oiol
i ca
ppel
lano
vitalizio
Immobilieun
capitaledi7.000
LnelP
ubblico
diLodial3,5%
7.000
52 n
ella
chi
esa
Prep
ositu
rale
di
S. M
iche
le
7110
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento2
luglio1658
Giambattista
Gor
laPa
olo
Crevani
capp
ella
no
vitalizio
Immobilieun
capitaledi7.000
LnelP
ubblicodi
Lodial3,5%
62Oratoriodi
S.Tom
masonel
luog
o di
Pez
zolo
Tavazzano
855
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento2
luglio1658
Giambattista
Gor
laPietroLuca
capp
ella
no
vitalizio
Immobilie
un c
apita
le d
i 7.000Lnel
Pubb
lico
di
Lodial3,5%
62nell’O
ratorio
diS.D
omenico
di A
nteg
natic
a
855
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento2
luglio1658
Giambattista
Gor
laPi
etro
D
epre
ti ca
ppel
lano
vitalizio
Immobilie
un c
apita
le d
i 7.000Lnel
Pubb
lico
di
Lodial3,5%
32 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
44
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento2
luglio1658
Giambattista
Gor
laSa
cerd
oti
Mer
cena
riIm
mobilieun
capitaledi7.000
LnelP
ubblico
diLodial3,5%
N.variabiledi
messeingiorni
festivi
88
L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Testam
ento2
luglio1658
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
90
Mar
gher
ita
Faso
liPi
etro
D
epre
ti ca
ppel
lano
vitalizio
Capitale
di1.200L
impiegatonel
Pubb
lico
di
Lodi
1.200
43 n
ella
chi
esa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
592
6L’avanzoa
beneficiodegli
ammalati
Inst.o20
lugl
io 1
593
Fran
cesc
o DeLemene
Sace
rdot
i benevisi
allaNob.
Famiglia
DeLemene
Capitale
di3.350L
impiegatonel
Pubb
lico
di
Lodi
3.350
N.variabile
dimessenelle
chiesebenevise
dalla
nob
. Famiglia
100
L’avanzoasollievo
degliinfermi
Convenzioni
31 o
ttobr
e 1698
don
Piermaria
Bignam
i
Paol
o Crevani
capp
ella
no
vitalizio
Capitaledi700
Limpiegato
nel P
ubbl
ico
di
Lodi
700
8 ne
lla c
hies
a de
ll’O
sped
ale
Mag
gior
e
11
L’avanzoasollievo
degliinfermi
Testam
ento5
aprile1710
Fran
cesc
o G
erol
aBa
ssia
no
Zane
ca
ppel
lano
vitalizio
Capitale
di2.500L
impiegatonel
Pubb
lico
di
Lodi
2.500
56nellachiesa
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
77
L’avanzoasollievo
degliinfermi
Testam
ento
1°settembre
1738
Beat
rice
Redo
glio
Sace
rdot
i mercenari
Capitale
di1.250L
impiegatonel
Pubb
lico
di
Lodi
1.250
Mes
sa n
el
gior
no d
ei
defu
nti e
altr
e ce
lebr
azio
ni
50
L’avanzoasollievo
degliinfermi
Testam
ento
27 a
prile
1740
2. N
otifi
cazi
one
di tu
tti i
Lega
ti di
Mes
se, e
d A
nniv
ersa
ri c
he so
no a
car
ico
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi
91
3. Quadro nominale della Nobiltà Lombarda confermata nella Provin-cia di Lodi e Crema3
Città di LodiCognome Titolo Nome
Azzati Don Giuseppe Beatrice Eugenia Giulia Scipione Adelaide
Barni Conte Giovanni Teodora Antonio Caterina Candida Giorgio
Barni Don Giorgio Cecilia Tommaso Filippo Antonio Ippolito Angela Maria Giuseppa Anna Maria
Barni Don Giorgio Carla Vittoria Cristoforo Maria Aurelia Gio.Carlo Teresa
Bonelli Donna Luigia Antonio Bassano Camillo
3.ASCL, Sotto-prefettura, 194.
92
Giuseppa Colbina
Codazzi Don Pietro Filippo
Carpani Don Luigi Teresa Ignazio Giovanni Luigia Marianna
Cernuscoli Don Tommaso Cesare Emilia
Della Piazza Conte Annibale Caterina Maria Carolina Giuseppa Teodora Amalia
Ghisalberti Don Francesco Caterina
Ghisalberti Don Maurizio Flaminio Maria Bianca Maurizio
Masneri Don Gottifredo Carolina Annibale
Masneri Don Luigi Caterina Rosa Carlo CamillaMancini Don Carlo
Modegnani Conte Gerolamo GiulioCesare
93
Giorgio Galeazzo
Ponteroli Don Filippo Maria Antonio Cecilia
Provasi Don Francesco Teresa Maria Rachele Maddalena Giuditta Guido Antonio Aurelio Giuseppa Annibale Barbara
Rhò Don Antonio Paola MariaAmalia Giuseppa Enrichetta
Rhò Don Giuseppa Giuseppa Carolina Luigi Cesare
Sommariva Marchese Emilio Giulio Annibale Giuseppa Camilla Luigia Giuseppa Carlo Vincenza Giuseppa Annibale Annibale
94
Giuseppe Marianna Teresa
Della Scala Don Francesco Teresa Barbara Gio.Claudio Baldassare Giulia
Silva Don Donato Luigi Gherardo Paola
LuigiaCamillaFrancesca
Vistarini Don Lodovico
Vistarini Don Ermerico Camilla Ferdinando Carlo Giovanni Reidania Luigia Enrichetta
Vistarini Don Ferdinando Maria Emilia Giuseppe
Visconti Don Giuseppe Emilia Guido Carlo Ugo Ernestina Galeazzo Ersilia Adelaide Clementina Giovanni
95
Camilla Carlotta
Zumalli Don Maria Giusi Teresa Città di Crema
Cognome Titolo NomeBenvenuti Conte Agostino
Benvenuti Conte Ottavio
Benvenuti Conte Alfonso Carlina Angelo Ercole
Benvenuti Conte Carlo Giulia Scipione
Benvenuti Conte Luigi Marianna Matteo Francesco CarolaCassandra IsabellaGirolama
Benvenuti Conte Cesare Giuseppa Clorinda Giulia Maria
Benvenuti Conte Livio
Bernardi Don Nicolò Laura Teresa Camillo Alberto Giambatta Coriolano Faustino Antonio Gaetano Cassandra
96
Bernardi Don Eugenio Laurea Luigi ValeriaIsabella
Carioni Vincenzo Irene
De Arlons Giambatta
Fadini Girolamo Francesco Antonia Orazio Angela Margherita GiacomoAntonio AnnaMariaIsabella Marianna Anna Maria MariaTeresaIsabella GirolamoAntonioEdoardo
Francavalli Don Maria Bradamante Ermia
Francavalli Don,CavalierediMalta Prospero
Griffoni S. Angelo Don Angela Angelo Ernesto
Guarini Giacomo Laurea LuigiGiorgio
Marazzi Don Vincenzo Vittoria Paolo Caterina
Martini Luigi Maria Pisana Giovanna Foscarina Giovanni
97
Oldi Fernanda Giuseppa FernandoRomualdo Casimiro Adamo Timoteo Angela Andrea Stefano
Oldi Giuseppa Elisabetta Antonia Lodovico
Perugini Caterina Francesca Giuseppa
Petrosani Teresa Giuseppe Armelina Paola Maria GiovannaAntonia
Giuseppa
Premoli Don Paolo Marianna CarloLuigi CarlottaMaria Giulia Maria Giuseppa IsabellaGiuseppa Alessandra Maria
Giuseppa
Rovaglio Emilia Caterina Marianna Orazio Caterina Maria AngelaChiara Maria Bianca Ortensina
98
VimercatiSanseverino Don Marcantonio Pisana
Leandra Faustino
VimercatiSanseverino Don Simone Costanza
VimercatiSanseverino Don Girolamo Ginevra
VimercatiSanseverino Don CarloGiuseppe Giambatta
Zurla Marchese Gio. Alessandro Achille Anna Maria Armelina Attilio LuigiAlessandro Emilia
Zurla Marchese Teresa Angelo Giulia
Zurla Don Camillo Angela Agostino Elena
Zurla Giambatta Elena
Zurla Giuseppe Giuditta Carolina Enrico Pietro Rachele Marianna
99
4. T
erne
per
la n
omin
a de
i Dir
etto
ri e
d A
mm
inist
rato
ri d
egli
Istit
uti E
lem
osin
ieri
, Mon
ti di
Pie
tà e
Cas
e d’
In-
dust
ria
(Lod
i e L
odiv
ecch
io 1
816-
1832
)4
Citt
à di
Lod
i
Den
omin
azio
ne
dei L
uogh
i Pii
Te
rne
dei D
iretto
ri e
d Am
min
istr
ator
iIn
form
azio
ni P
erso
nali
(sin
tesi)
Casad’Industria,
IstitutoElem
osiniere
e M
onte
di P
ietà
Dire
ttore
BocconiSettim
oattualmentedirettore
dellaCasad’Industria
Uom
osuperioreadognieccezioneperonestà
efilantro
pia[…
]
Gra
ssi A
b.eattualmente
mem
brodella
CongregazionediC
arità
Dietàavanzata.[…
]som
maillibatezzaedintegrità
dicostumi
RhòGiuseppe
Probo,onesto,cessatoassessoremunicipale
Amm
inis
trat
ore
FornariC
arlo
PrestògiàutiliservigiagliIstitutidiPiaBeneficienza.
Uom
odiesemplareonestà,m
oltaattività
edintelligenza,padredinum
erosafamiglia
CerianiGiuseppeCesare
DiM
ilano,segretarioquiescentediGoverno[…
]abile
amministratore[…
]CassinelliLuigi
Uom
odestro,assaicaritatevole,attualmentecassiere
dell’erariodellaCasad’Industria
4.ASC
L, S
otto
-pre
fettu
ra,6.
100
Com
une
di L
odiv
ecch
ioD
enom
inaz
ione
de
i Luo
ghi P
ii
Tern
e de
i Dire
ttori
ed A
mm
inis
trat
ori
Info
rmaz
ioni
Per
sona
li
IstitutoElem
osiniere
Dire
ttore
Ripam
ontiSacerdote
Piet
ro M
aria
ParrocoeVicarioforaneodinotoriaprobità
PavesiAngeloSacerdote
Probo:dim
oltacapacità
Bers
ani F
elic
iano
Idem
Amm
inis
trat
ore
Bignam
iGiuseppe
Poss
iden
te e
Pro
boG
allin
a G
aeta
noIdem
Ferr
ari A
ngel
o M
aria
Idem
4. T
erne
per
la n
omin
a de
i Dir
etto
ri e
d A
mm
inist
rato
ri d
egli
Istit
uti E
lem
osin
ieri
, Mon
ti di
Pie
tà e
Cas
e d’
In-
dust
ria
(Lod
i e L
odiv
ecch
io 1
816-
1832
)
101
5. Amministratori degli Istituti di Carità di Lodi nel 18064
Ospitale Maggiore e Luoghi Pii UnitiAmministratore M.A. DossenaDirettore A. Alberti
Ospitale FissiragaDeputazioneAmministrativa P. Beonio Brocchieri Decano
M. GhisalbertiG. BarniG.Majneri
OrfanotrofiAmministratore SettimoBocconiDirettore E.Casanova
Istituto Limosiniero, Casa d’Industria, e Monte di PietàAmministratore G. BarniDirezione E.Vistarini
Sacerdote PolenghiG.ProvasiS. StellaIng.C.Moroni
5
4.ASCL, Sotto-prefettura, 87.5.
102
6. V
italiz
i stip
ulat
i dal
l’Osp
edal
e M
aggi
ore
di L
odi6
Dat
a de
lla
sotto
scri
zion
eSo
ttosc
ritto
reC
apita
le (l
ire, s
oldi
, de
nari)
%An
nuo
vita
lizio
(lire
, so
ldi,
dena
ri)
Bene
ficia
rio/
a
1738marzo8
LattanzioBianchi
200
Geltru
deBellavita
1754
apr
ile 1
9AlessandroCorradi
18.000
5%900
Ang
ela
Scio
rni
1754
apr
ile 1
9AlessandroCorradi
14.8
2511
44%
593
5A
ngel
a Sc
iorn
i1765giugno18
AlessandroCorradi
140
Ang
ela
Scio
rni
1763maggio29
Bern
ardi
no e
d A
nton
ia
Mur
a9
ore
di a
cqua
90B
erna
rdin
o ed
Ant
onia
M
ura
1765novem
bre21
MarcantonioCornetti
14.000
5%700
Mar
ia G
iuse
ppa
eCaterinaCornetti
1766dicem
bre3
FabrizioPalma
10.000
6%600
F.Palma,moglieefigli
1767agosto
11
Uncreditoeunacasa
252
GiovannaCeresa
1771
ago
sto 1
8MarcantonioCornetti
3.000
5%150
Mar
ia G
iuse
ppa
eCaterinaCornetti
1771dicem
bre31
Giu
sepp
e, A
nton
io e
GiovanniZ
ambelli
Varicap.per15.000
5%750
Giu
sepp
e, A
nton
io
eGiovanniZ
ambelli
SerafinaInzaghi
3.500
3,50%
122
10D
ioni
gi B
orsa
1.200
7%84
Dio
nigi
Bor
saSerafinaInzaghi
Unacasa
28D
ioni
gi B
orsa
Unsedume
50D
ioni
gi B
orsa
385
3,90%
15Rev.GirolamoRo
ssi
LattanzioBianchi
50GiovannaCipolla
6.ASC
L,A
rchi
vio
dell’
Osp
edal
e M
aggi
ore,10.
103
7. Stato attuale delle messe fondate nella città e sobborghi di Lodi (1788)6
Cattedrale
Fondatore Nomina Paga-mento
Titolo N.
Boccona Eleonora ScuoladelSsmoSacramento
Scuola PeraldiCarlo 365
Boccona Eleonora ScuoladelSsmoSacramento
Scuola Maturlo Antonio 365
Boccona Eleonora ScuoladelSsmoSacramento
Scuola Abbiati Pietro 365
Boccona Eleonora ScuoladelSsmoSacramento
Scuola Roda Stefano 365
Boccona Eleonora ScuoladelSsmoSacramento
Scuola BrambillaGio 365
CassinaElisabetta ScuoladelSsmoSacramento
Scuola Rancati Bernardo 365
CassinaElisabetta ScuoladelSsmoSacramento
Scuola LuiniBassano 90
Brugazza Margarita
ScuoladelSsmoSacramento
Scuola LuiniBassano 101
Brugazza Margarita
ScuoladelSsmoSacramento
Scuola MinojaAngelo 144
Brugazza Margarita
ScuoladelSsmoSacramento
Scuola BesozziCarlo 59
Maineri Gio ScuoladelSsmoSacramento
Scuola Pater Gaetano 55
Fondatoridiversi ScuoladelSsmoSacramento
Scuola BottiGiacomo 138
Galleani Cristoforo
ScuoladelSsmoSacramento
Scuola 6
LavagnaPlacido Scuola S. Bassano(vacante)
Cassarelig. VignatiGio 160
LavagnaPlacido Scuola S. Bassano(vacante)
Cassarelig. Mussida Gio 160
Fondatoridiversi Scuola S. Bassano(vacante)
Cassarelig. CesariBassano 300
6.Fonte:ASM,Culto p.a., cart. 373.
104
CadamostiFlavia Scuola S. Bassano(vacante)
Cassarelig. AloneVincenzo 292
Ricci de, Riccio Scuola S. Bassano(vacante)
Cassarelig. 231
Fondatoridiversi Scuola S. Bassano(vacante)
Cassarelig. Depretti Pietro 177
CerasoliAlessandro
Scuola Pietà (vacante)
Cassarelig. CavezzaliGio 130
Fondatoridiversi Scuola Pietà (vacante)
Cassarelig. 80
Fondatoridiversi ScuolaB.Verginescale(vac.)
Cassarelig. ServidaGiamb. 180
Fondatoridiversi ScuolaB.Verginescale(vac.)
Cassarelig. Ferrabini Antonio 23
Zuccone Giambattista
ScuolaB.Verginescale(vac.)
Cassarelig. Martini Annibale 90
VitaliCamilla ScuolaB.Verginescale(vac.)
Cassarelig. Martini Annibale 19
Maranesi Gio ScuolaB.Verginescale(vac.)
Cassarelig. Maranesi Giuseppe 30
VitaliCamilla ScuolaB.Verginescale(vac.)
Cassarelig. Maranesi Giuseppe 14
Maranesi Gio Capitolodellacattedrale
Capitolo Maranesi Giuseppe 172
VitaliCamilla Capitolodellacattedrale
Capitolo Pater Gaetano 44
Elli Stefano CasaMerlini CasaMerlini 215Rebalia Fausto (monsign.)
Capitolodellacattedrale
Capitolo BesozziCarlo 217
BovioGerolamo(arciprete)
Capitolodellacattedrale
Capitolo 365
CacciatoreC.(canonico)
Capitolodellacattedrale
Capitolo 25
ScanniGiamb.(canonico)
Capitolodellacattedrale
Capitolo Bandirali Bassano 25
Bizzone Pietro (canonico)
Capitolodellacattedrale
Capitolo Bandirali Bassano 20
Bonelli Antonio Capitolodellacattedrale
Capitolo Bandirali Bassano 16
CristiniGiacobino Capitolodellacattedrale
Capitolo 15
105
MajaniBassano(canonico)
Capitolodellacattedrale
Capitolo 5
VidoniPietro(vescovo)
Capitolodellacattedrale
Capitolo 315
Sarri Franco (reverendo)
Capitolodellacattedrale
Capitolo GazzolaGiamb.(105)
365
CorradoBaldassarre(can.)
Capitolodellacattedrale
Capitolo 66
MediciDomenico Capitolodellacattedrale
Capitolo 200
Morone Eraclito Crescenzio(nobile)
Capitolo 365
Fondatoridiversi Sagrestia capitolare
Sagrestia 114
Bonanomi(giugali)
Sagrestia capitolare
Sagrestia 13
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. 7
BellavitaDomenico(rev.)
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Bandirali Bassano 65
CornelianiCleronimo(rev.)
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Bandirali Bassano 27
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. ZambelliniAnto 77
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. CabriniFranco 43
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. VenturelliFelice 146
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Mussida Gio. 66
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. LuiniBassano 30
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Espressi Filippo 31
Forti Gioannina Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. MojoliMauro 92
CortonaAngela Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. 16
LavagnaFranco Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. ZambelliniAnto 4
GrecoPaolo(rev.) Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Mussida Gio 42
106
Maldotti Marco (rev.)
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. MojoliMauro 43
Ferrari Stefano Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. MojoliMauro 96
AndennaCesare(rev.)
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. LatiniBassano 365
VailatiBertolino Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. 16
Bertola Franco (rev.)
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. ZambelliniAnto 25
Bertola Franco (rev.)
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Mussida Gio 41
Zurla Marco Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. 40
TavernaLudovico(vescovo)
Taverna(famiglia)
Taverna GomezGaetano 365
TavernaLudovico(vescovo)
Taverna(famiglia)
Taverna OlcelliVincenzo 365
TavernaLudovico(vescovo)
Taverna(famiglia)
Taverna Bonelli Giambattista
365
BeneficiodellaNiatta
Bigura Giulio (nobile)
Beni beneficio
BesozziCarlo 365
Benef. S. GalloeColombano
Contarica(famiglia)
Cornaggia SemenzaClemente 310
Benef. S. Trinità VescovodiLodi Beni propri Villa(chierico) 30Benef. S. Bernardo VescovodiLodi Beni propri Rossi(arciprete) 14Benef.S.Tomaso VescovodiLodi Beni propri StroppaLuigi 24Benef. S. Rocco VescovodiLodi Beni propri StroppaLuigi 7Benef.S.Caterina VescovodiLodi Beni propri StroppaLuigi 7Benef. S. Marta VescovodiLodi Beni propri StroppaLuigi 6Benef. S.Bassano primo
VescovodiLodi Beni propri StroppaLuigi 20
Benef. S. Stefano VescovodiLodi Beni propri RipamontiPietro 26Benef.S.Nicolò VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 43Benef. S. Bassano secondo
VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 24
Benef. S. Maria Maggiore
VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 12
Benef. S. Secondo VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 8Benef. S. Antonio abate
VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 8
107
Benef.B.V.sottole scale
VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 3
Benef. S. Giorgio VescovodiLodi Beni propri ZambelliniAnto 50CanonicatoS.GiovanniEv.
VescovodiLodi Beni propri CanziGio.Batta 60
Can.diS.GiacomoeFilippo
VescovodiLodi Beni propri CanziGio.Batta 5
Can.DiS.Ambrogio
VescovodiLodi Beni propri 29
CarminatiAmbrogio
Beonio(famiglia) Cassarelig. Manzi Alessandro 245
Tacchi(consorti) Tacchi(famiglia) Arisi Altrocchi Giuseppe 108Tacchi(consorti) Confrat.S.
Trinità(vac.)Cassarelig. Altrocchi Giuseppe 32
Zuccone Bernardo Scuola S. Antonio (vac.)
Cassarelig. ValsazziAnto 48
Mazzola Pietro Prevostocattedrale
Prevosto Barberini Sigismondo
137
Marchi Antonia Prevostocattedrale
Prevosto 32
MarubianiCesare Prevostocattedrale
Prevosto 70
Paraticofalegnami(soppr.)
Moroni(eredi) Moroni Ferrabini Antonio 52
LegatoBignami Pissacani(eredi) Prevosto RancatiIgnazio 78BovioCamillo(arciprete)
Arciprete Prevosto 32
MigliavaccaAless.(canonico)
Promotoredeilegati
Promotore 37
Chiesa S. Maria della Pace
Botta Maria Scuola della pace (vac.)
Scuola BottiGiacomo 64
Birago Bassano Scuola della pace (vac.)
Scuola Botti(34)eBiraghiBass.(32)
108
CinquantaBianca Scuola della pace (vac.)
Scuola RozzoniPrimo 80
Dossena Ermogene
Tela Gian Franco Tela CapraraPietro 172
CernuscoliFlavia Tela Gian Franco Tela RozzoniPrimo 8
108
SalmoiraghiGiambatta
Tela Gian Franco Tela Moretti Filippo 20
Bianchi,Bellavita,deLemene
Consorziodelclero(vacante)
Consorzio 65
Bianchi,Bellavita,deLemene
Consorziodelclero(vacante)
Consorzio DeprettiP.(37)PaterG.(30)
82
DeLemeneAurelio
Consorziodelclero(vacante)
Consorzio SalmoiraghiAnto 70
DeLemeneAurelio
Consorziodelclero(vacante)
Consorzio Moretti Filippo 16
DeLemeneAurelio
Consorziodelclero(vacante)
Consorzio VenturelliFelice 34
Oratorio S. Giuliano
Benef. Porzionario S.Giuliano
Diversipatroniprivati
Beni propri Berinzaghi Manfredo
365
Benef. Porzionario S.Giuliano
Diversipatroniprivati
Beni propri Scala Faustino (conte)
365
Chiesa parrocchiale n. 2, Collegiata di S. Lorenzo
LodiBettino Capitolodellacollegiata
Capitolo 19
CadamostiGio.Batta(rev.)
Capitolodellacollegiata
Capitolo 33
LiviGiulio(canonico)
Capitolodellacollegiata
Capitolo 45
CalucciVincenzo Capitolodellacollegiata
Capitolo 80
Vistarino Capitolodellacollegiata
Capitolo 36
ScaccoGirolamo Capitolodellacollegiata
Capitolo 140
VaccariaVittoria Capitolodellacollegiata
Capitolo 58
PolatriCaterina Capitolodellacollegiata
Capitolo 20
Orietti Gio. e Girolamo
Capitolodellacollegiata
Capitolo 10
BovioGirolamo(canonico)
Capitolodellacollegiata
Capitolo 365
109
Modegnani Modegnani Modegnani Grassi Franco 80
Codazzi Codazzi Codazzi Perla Franco 54Meleti Ospedal
MaggiorediLodiOspedale Moroni Bassano 288
Morandi MigliavaccaBassano
Migliavacca 277
Chiesa S. Giovanni Battista, Commenda della religione di Malta
Obbligo antico commenda
Obbligo Obbligo LonghiPietro 156
Chiesa parrocchiale n. 3, S. Michele Arcangelo
Commotti(preposito)
ScuolaSsmoSacramento
Scuola Besozzi Fortunato 12
MaineriOlimpio Maineri(disc.Maschi)
Scuola Bandirali Giuseppe 83
Toselli Michelangelo
ScuolaSsmoSacramento
Scuola Ferrario Bassano 30
VistariniGiulio ScuolaSsmoSacramento
Scuola CaprottiGiuseooe 35
BravaLaudelia Comunanza Comunanza Grassi Francesco 30CortiLucia Comunanza Comunanza Ferrario Bassano 3Denti Attilio Comunanza Comunanza Grassi Francesco 118MaldottiLucia Comunanza Comunanza Grassi Francesco 3Porchera Francesco
Comunanza Comunanza Grassi Francesco 101
PorcheriaIsabella Comunanza Comunanza Grassi Francesco 25Maineri Melchiorre
Scuola nascita Vergine(vac.)
RegiaAmm. MarzaniCarlo 127
Biraga Prassede Scuola nascita Vergine(vac.)
RegiaAmm. Besozzi Fortunato 29
Commotti(preposito)
Scuola nascita Vergine(vac.)
RegiaAmm. Martini Annibale 89
VeschiGio.Batta(prepos.)
Scuola nascita Vergine(vac.)
RegiaAmm. Besozzi Fortunato 51
Boccadori Girolamo(nobile)
Parroco Parroco Bandirali Giuseppe 17
BignamiPietro SalamancaLudovico(eredi)
Salamanca SalamancaGio.Anto
365
110
BignamiPietro SalamancaLudovico(eredi)
Salamanca Ferrario, Bandirali, Caprotti
98
BonomiRomolo Parroco Parroco Bandirali Giuseppe 130CamolaMarc’Antonio (rev.)
Ferrari Antonio (eredi)
Parroco Locatelli 365
Ferrandi Ferrando Ferrandi(eredi) Parroco 60Ferrandi Giustina Bossi Giustina Parroco 313LodiBassano(rev.)
Conti(fratelli)eparroco
Parroco ComizzoliBartolomeo
202
Maldotti Maurizio Conti-Bertoli Conti-Bertoli
VigorelliFranco 231
Moroni Anna Maria
Parroco Parroco MaseraCarlo 40
MaineriLudovico(rev.)
Parroco Parroco Bandirali Giuseppe 18
Paloschi Domenico
Parroco Eredi Ferrario Bassano 3
PaschermoniMaddalena
Parroco Parroco MaseraCarlo 6
Rossi Antonio Parroco Parroco CaprottiGiuseooe 16Scalfa Francesca Parroco Parroco Motta F.,
Bandirali G.125
Tresti Andrea (rev.)
Robba Gio. (eredi)
Parroco Besozzi Fortunato 29
VeschiSilvia ScuolaIncoronata Incoronata VenturelliFelice 14Gorla Gio. Batta Ospedal
MaggioreLodiOspedale MojoliMauro 52
Fondatoridiversi ConventoS.Antonio(vac.)
Cassarelig. 102
PianesiGiacomo Scuola S. Defendente(vac.)
Cassarelig. Bononi Pietro 168
Morlacco Ferdinando
Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. Marchi Prospero 365
Mozzanica d’Adda (contessa)
Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. OppizioCarlo 126
Bracco Bartolomeo
Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. 80
Gandini Gio. Paolo
Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. BodrèFilippo(40) 110
111
PiazzaChiaraLucia
Bellavita(casata) Cassarelig. 168
BononaCompianaCamilla
Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. 25
Marcellini Nicolina
Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. 10
Piùmonache Mon.CosmoeDamiano(vac)
Cassarelig. 6
Chiesa di S. Tommaso, casa degli ordinandi
BeneficioS.Gottardo
Diversipatroni Beni propri CernuscoliTommaso
365
Fondatoridiversi Vescovo Cessatosem. Diversisacerdoti 531
Chiesa parrocchiale n. 4, S. Biagio
Baselini Giulio (rettore)
Comunanza Comunanza 365
Bosisi Antonio (prep.)
Comunanza Comunanza ErbaLeopoldo 292
DamianiFranco(prep.)
Comunanza Comunanza Ferrabini Antonio (90)
292
Bononi Euterpia Comunanza Comunanza ValzasioAntonio 200CompianiCamilla Comunanza Comunanza BonomiBassano 208QuaitamachiCecilia
Parroco Comunanza Ferrabini Antonio 13
Montanari Angela Galbiati(eredi) Parroco Ferrabini Antonio 24Bruzzi Parroco Parroco Oppizzi Andrea 7CerfedinoAntonio Parroco Parroco 5CaserariaCamilla Parroco Parroco 3DordenaViolante Parroco Parroco Oppizzi Andrea 3PelatiGiovanni Parroco Parroco 5Panighetti Angela Parroco Parroco 20Broggi Giuseppe Parroco Parroco 12Alloni Francesco Parroco Parroco 3CadamostiBaldassarre
Consorziodelclero(vacante)
Cassarelig. Anselmi(153),Tacco(55)
208
BeneficioS.Paoloeremita
Vescovo Beni propri RipamontiPietro 24
112
Chiesa di S. Chiara nuova delle Orfane
RestocchiCarloFranco
Orfanotrofio Orfanotrofio LunghiPietro 39
GuffiCamillo Orfanotrofio Orfanotrofio Maranesi Gio. 298GuffiCamillo Orfanotrofio Orfanotrofio Calderini
Genebardo34
Morlacchi Ferdinando
Orfanotrofio Orfanotrofio Altrocchi Giuseppe 91
SuardiCarlo(rev.) Orfanotrofio Orfanotrofio 110Rizzi Gian Paolo Orfanotrofio Orfanotrofio Calderini
Genebardo28
GusmeriOldonaClara(suor)
Orfanotrofio Orfanotrofio 365
Maranesi Gio. Angelo
Orfanotrofio Orfanotrofio Moretti Filippo 26
LandrianiDaria Orfanotrofio Orfanotrofio Altrocchi Giuseppe 22Bizzoni Rosa Serafina
Orfanotrofio Orfanotrofio Altrocchi Giuseppe 22
MinojaSebastiano(prevosto)
Orfanotrofio Orfanotrofio 5
Fondatore ignoto Orfanotrofio Orfanotrofio 12BacchinoVittorio Orfanotrofio Orfanotrofio Altrocchi Giuseppe 1Guffi,Martinenghi, Borzio
Orfanotrofio Orfanotrofio 37
Chiesa di S. Leonardo, collegio delle vergini
CinquantaAmbrogio
Monte di pietà Monte Aradelli Franco 292
Quartieri Elisabetta
Belgiojoso(famiglia)
Collegio Ricci Gaspare 161
Martinona Cattarina
Collegiodellevergini
Collegio 46
Belloni(sorelle) Collegiodellevergini
Collegio 15
Morlacchi (consorti)
Collegiodellevergini
Collegio 8
BonomaLudovica Collegiodellevergini
Collegio ZambelliniCarlo 236
113
TavazziCamilla Ospedal MaggiorediLodi
Ospedale Dagrada Gio. 40
FaravelliBartolomeo(rev.)
Collegiodellevergini
Collegio 63
Orietti Paola Gerolama
Collegiodellevergini
Collegio 16
NegroliCattarina Collegiodellevergini
Collegio 7
Fondatoridiversiperanniv.
Collegiodellevergini
Collegio 57
Chiesa parrocchiale n. 5, S. Salvadore e B.V. Annunciata
Rett.SS.CosmoeDamiano
Batteri, Carminati,Fasoli
Beni propri Barattieri Antonio 104
Rett.S.IlarioneeGiacomo
Bigura Giulio (nobile)
Beni propri Carpani(canonico) 52
NavaraAmbrogio Navara(canonico) Navara 288CodazzaCattarina Parroco Diversi BriochiDomenico 128Fondatoridiversi Parroco PavesiPietro Calderini
Genebardo88
Fondatoridiversi Parroco MonteS. Teresa
137
ZefirinoBernardo ScuolaSsmaTrinità(vac.)
Cassarelig. Gianotti Gio. 41
RicardiClaudio Consorziodelclero(vac.)
Cassarelig. Moretti Filippo (arcipr.)
52
Puricelli Franca Scuola del Carmine(vac.)
Cassarelig. 41
Quattri Antonia Parroco Diversi CalderiniGenebardo
52
RicardiCandido Parroco Pozzoli(rev.) 17RèAndrea Parroco Brocchieri
G.16
DeNovaFrancesco
Parroco Ospedale 11
Morone Bartolomeo
Parroco Sangallo A. 11
Pelatti(fratelli) Parroco MerliniC. 5BellatestaCesare Parroco Chiesa 5CaldanaClaudia Parroco Ribone G. 3
114
Scrocca Margarita Scuola del Carmine(vac.)
Cassarelig. 3
Franzina di Salerano
Scuola del Carmine(vac.)
Cassarelig. 4
Galeazzi Brinzago Parroco Rossi Rotta Francesco 41CadamostoVittorio
Parroco Ribone G. 6
MediciGiacomo(rev.)
Parroco Seghizzi A. 29
Barni Gio. Batta Parroco MerliniC. 14Fondatoridiversi Parroco Diversi 67BizzoniSerafina(suor)
Parroco Cassarelig. 77
Diversianniversari Regia,ediversiparticolari
Privatiecassa 67
Chiesa parrocchiale n. 6, S. Nicolò
Tosi Bassano Parroco Bonelli ComizzoliPietro 292BeneficioTresseni(secolariz)
Tressena Pontiroli Tressena Pont. 365
ZefirinoBernardo ScuolaSsmaTrinità(vac.)
Cassadi relig.
Graziadelli Antonio 265
Fondatoridiversi ConventoS.Antonio(vac.)
Cassadi relig.
365
CortesiLaura Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
UbertiGiacomo 112
Fondatoridiversi Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
UbertiGiacomo 129
MicoliGiovanna Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
Tronconi Felice 42
BoldoniLudovica Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
Tronconi Felice 5
RossiVirginia Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
Schenino Giuseppe 71
Meriliani Angela Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
Schenino Giuseppe 67
CarnesellaBenedetta
Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
Schenino Giuseppe 8
PontiOttavia Benedettini (vacante)
Cassadi relig.
MojoliMauro 13
115
MuzianiLucrezia Confrat.S.Defendente(vac.)
Cassadi relig.
CalderiniGiuseppe 114
Chiesa dello Spirito Santo per l’Ospedal Maggiore
Tizzoni Orino Ospedale Ospedale De Preti Pietro 18Denti Teodolina Ospedale Ospedale Dossena Teodoro 32PellojaFrancesco Ospedale Ospedale Martini A.,
BodrèF.146
DeNovaFranco Ospedale Ospedale Gianotti Gio. 124PortalupiGiacomo(rev.)
Ospedale Ospedale Aradelli Giuseppe 292
MinojaSebastiano Ospedale Ospedale CrevaniPaolo 1Muzzani Elena Ospedale Ospedale CrevaniPaolo 42SommarivaOrazio Ospedale Ospedale Cappuccini 42Gandini Bartolomeo
Ospedale Ospedale Cappuccini 292
TavazziSomagliaCamilla
Ospedale Ospedale ZambelliBassano 292
BonettiCarloAntonio
Ospedale Ospedale Cappuccini 365
Gandini Pietro Ospedale Ospedale CrevaniPaolo 36GorlaGiambattista Ospedale Ospedale De Preti Pietro 94Fasoli Margarita Ospedale Ospedale De Preti Pietro 43BignamiPietro(rev.)
Ospedale Ospedale CrevaniPaolo 8
Gerola Franco Ospedale Ospedale ZambelliBassano 56Rebaglia Beatrice (mon.)
Ospedale Ospedale 35
Chiesa Parrocchiale S. Naborre
ChiesaBartolomeo,Brigida
Chiesa(famiglia) Alloni B. RozzonePrimo 108
Robba Antonio (prep.)
Parroco Parroco Beonio Gio. 365
QuartieriLaura(nobile)
Congregazionemunicipale
Città MarzaniCarlo 290
116
BovioGiovambattista(prep.)
Scala e Pissacani (famiglie)
Parroco RancatiIgnazio 208
Bertella Marta Parroco Parroco RancatiIgnazio 16Zurla Marco (prep.)
Consorziodelclero(vac.)
Cassarelig. Quinteri Giulio 150
CavannaOliverio Parroco Parroco 48VignatiTeresa(nobile)
Parroco Parroco 52
Pappi Bettino (nobile)
Parroco Parroco 60
Marzia Dorotea Bigoni Gio. Bigoni Gio. TaccoTommaso 36Suardi Giuliano Rezzaghi
(famiglia)Rezzaghi 46
MajneriGiulio(nobile)
Parroco Parroco Pater Gaetano 110
Fondatore ignoto Parroco Parroco 32RaffaglioCarlo(rev.)
Parroco Parroco 365
Oratorio S. Gervaso
Rettoria Brocchieri (consorti)
Beni propri Brocchieri Bassano 104
Regoreri Bassano Brocchieri (consorti)
Beni propri Brocchieri Bassano 36
TravajolliPietro Brocchieri (consorti)
Beni propri Brocchieri Bassano 12
MeratiCesare(rev.)
Barni(famiglia) Barni 149
Chiesa della Beata Vergine dell’Incoronata
Pontirolli Andronico
Incoronata Incoronata MorandiniCarlo 271
Pontirolli Andronico
Incoronata Incoronata Dancaidi Paolo 271
InzoliOttavio Incoronata Incoronata 217Fondatoridiversi Incoronata Incoronata VenturelliGio. 358Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Moro Giuseppe 225Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Dagrada Gio. 329
117
DellaVallePaolo(rev.)
Incoronata Incoronata CernuscoliTommaso
142
MicolliLucia Incoronata Incoronata CernuscoliTommaso
58
Della Scala Anto Incoronata Incoronata Facini Bassani 226Della Scala Anto Incoronata Incoronata MonticelliIgnazio 226CodognolaLuigi,Carlo
Incoronata Incoronata 309
Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Torregiani Gio. 99Fondatoridiversi Incoronata Incoronata TimolariGiuseppe 232Della Torre Marc’Antonio
Incoronata Incoronata MojoliMauro 27
Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Roda Giuseppe 174Micolli Paolo (rev.)
Incoronata Incoronata Ranza Giuseppe 220
Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Ranza Giuseppe 51Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Dagrada Giuseppe 148Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Fraschino Bassano 151Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Sabbia Franco 73Fondatoridiversi Incoronata Incoronata CeresoliAntonio 233Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Rossi Gio. Battista 46Fondatoridiversi Incoronata Incoronata Bruschino Franco 97Fondatoridiversi Incoronata Incoronata 204Malinpensa Giulio Incoronata Incoronata CanobbioPaolo 136BrevedoniGaspare Incoronata Incoronata ValzasioAntonio 126BignamiAgostino Incoronata Incoronata CaprottiPietro 25OrsiBartolomeo Incoronata Incoronata Maranesi Giuseppe 59PozzoliCristoforo Incoronata Incoronata De Preti Pietro 49Pontirolli Andronico
Incoronata Incoronata 52
Martani Alessandro(rev.)
Incoronata Incoronata 40
Paveripietro Incoronata Incoronata ZambelliGiulio 162Savetta(rev.) Incoronata Cong.
S. Filippo300
Maitelli(fratelli,sacerdoti)
Marrani Bassano Incoronata 230
LegatooratorioS.Paolo
Rettoria pio luogo S. Paolo
Rettoria 365
118
LegatooratorioS.Paolo
Rettoria pio luogo S. Paolo
Rettoria 80
LegatooratorioS.Paolo
Rettoria pio luogo S. Paolo
Rettoria 22
LegatooratorioS.Paolo
Rettoria pio luogo S. Paolo
Rettoria Mussida Gio. 48
CadamostoStefano
Consorziodelclero(vac.)
Cassarelig. Pozzoli Bassano 37
Chiesa parrocchiale n. 8. S. Geminiano
Beneficioantico Bonelli(famiglianob.)
Molti livellari
AjersamiLudovico 12
RotaCristoforo Parroco Parroco AjersamiLudovico 50VirtuaniPecchi(giugali)
Parroco Parroco Ongari Pietro 34
ContiLucia Parroco Parroco 8Galiardi Matteo Parroco Parroco 24DeGrassiCometa Comunanza
(vacante)Comunanza 4
CachianiPietro Comunanza(vacante)
Comunanza 8
Sartorio Antonio Scuola Concezione(vac.)
Scuola LatiniMichele 240
Beonio(prevosto) Scuola Concezione(vac.)
Scuola Manzi Alessandro 100
Pozzo Bernardo Scuola Concezione(vac.)
Scuola NivianiGiovanni 150
Merelli Ferrante Scuola Concezione(vac.)
Scuola 200
Sponzetta Arcangela
Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 2
ZambinellaCattarina
Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 2
Prestorella Camilla
Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 2
RizziAngelo(rev.) Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 26
Felici Barbara Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 24
CornalbaErsilia Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 2
119
CamiaMatteo Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 12
Modegnani Angela Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 5
Osio Bassano Scuola Concezione(vac.)
Scuola Ongari Pietro 3
Robba Giambattista
Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita AjersamiLudovico 177
BassiCarlo Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita AjersamiLudovico 35
BattainiLaura Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita AjersamiLudovico 5
BellasioOttaviano Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita AjersamiLudovico 14
Rota Margarita Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita AjersamiLudovico 24
CavenagoFranco(canonico)
Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita EspressiCarlo 110
Quaini Giuseppe Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Moretti Filippo 125
Quaini Giuseppe Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita RozzonePrimo 33
Quaini Giuseppe Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita MorettiCarlo 16
Quaini Giuseppe Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita BodrèFilippo 51
MigliavaccaAntonio
Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita TimolatiGiuseppe 151
Agnati Franco Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita TimolatiGiuseppe 9
Borgognoni Baldassarre
Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Moretti Filippo 13
Ponte Paolo Emilio
Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Moretti Filippo 21
Zucconi Francesco Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Moretti Filippo 9
NegriAnna Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita BodrèFilippo 14
SanaGiovanni Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita SalmoiraghiAntonio
120
CadamostoVittorio
Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Folla Filippo 114
120
Rasio Alessandro Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Folla Filippo 117
MorcarioNicolò Confr.S.MariadelSole(vac.)
Confraternita Pozzoli Bassano 160
Beneficioantico Monastero S. Govanni(vac.)
Fitti, crediti Pozzoli Gio 280
Chiesa parrocchiale n. 9, SS. Vito e Modesto
Denti Marcello Parroco Parroco LattuadaC.,ZambelliniG.
91
BossiCamillo Parroco Parroco 7Orlandi Francesco Parroco Parroco 12CavalleriGiuseppe(rettore)
Parroco Parroco 1
BonanomiGio. Parroco Parroco Albertini Gio. 22RedamigliaRosa Parroco Parroco LattuadaCarlo 122GarottaGio.(rev.) Parroco Parroco Comizzoli 52Martinenghi Giulio(rev.)
Finetti(famiglia) Finetti MilaniBartolomeo 234
AmuelliGaspare Parroco, deputati delSsmo
Parrocoe dep.
Milani B.,e Trezzi B.
132
Recalcati Cattarina
Parroco, deputati delSsmo
Parrocoe dep.
Perla Franco 6
MusaCattarina Parroco, deputati delSsmo
Parrocoe dep.
Perla Franco 12
Zanebone Tommaso
Parroco, deputati delSsmo
Parrocoe dep.
Pozzoli Antonio 135
Chiesa della Ssma Trinità delle Orsole
Ricardi Francesco Orsoline Orsoline Ongari Pietro 240BallioniLucrezia Stella
Bartolomeo,Beonio
Orsoline BonanomiCarlo 158
Turati Giuseppe (rev.)
Ardizzoni (famiglia)
Orfanotrofio 292
Serrati Alcenia Serrati Deogratias
Serrati 229
Moriglia Ortensia Orsoline Orsoline 30
121
Oratorio S. Mauro
Rettoria S. Mauro Diversipatroniprivati
Beni propri BarniCristoforo(abate)
65
S. Filippo, chiesa de preti secolari filippini
BellatestaCesare(rev.)
Congregazione Congreg. 5
DragoneGio.(rev.) Congregazione Congreg. GrazioliCarlo 58SavettaAnto(rev.) Congregazione Congreg. 600ScanniGio.Natta(canonic.)
Congregazione Congreg. GalmozziGiulio 162
ScanniGio.Natta(canonic.)
Congregazione Congreg. BottiGiacomo 68
ScanniGio.Natta(canonic.)
Congregazione Congreg. 126
ArbustiGio.(rev.) Congregazione Congreg. 10DragoneGio.(rev.) Congregazione Congreg. Bricchi Gio. 58DragoneGio.(rev.) Congregazione Congreg. GrazioliCarlo 44DragoneGio.(rev.) Congregazione Congreg. 6Biancardi Bernardo(rev.)
Congregazione Congreg. CeresaGiuseppe 217
CarenziPietroMaria(rev.)
Congregazione Congreg. Bricchi Gio. 207
Arbusti Bartolomeo
Congregazione Congreg. BricchiGio.(100) 109
Portalupi Anto (rev.)
Congregazione Congreg. ColombiniGiuseppe(39)
56
GavardiPietroGiorgio(rev.)
Congregazione Congreg. Fugazza Bernardo 365
Finetti Giulio Cesare(rev.)
Congregazione Congreg. 26
BignamiClara Congregazione Congreg. Galmozzi,Cavezzali,Molossi
250
PrevedoniBassano(nob.)
Congregazione Congreg. TrovatiRaimondo 217
Magni Giuseppe (rev.)
Congregazione Congreg. SilvettiCarlo 365
Magni Giuseppe (rev.)
Congregazione Congreg. 149
122
Magni Giuseppe (rev.)
Congregazione Congreg. NescioGiuseppe 118
Marchese Giacomo
Congregazione Congreg. 316
FerreroVincenzo(nob.)
Congregazione Congreg. GrazioliCarlo(33) 58
CodazziTommaso(canonic.)
Congregazione Congreg. 51
BignamiGinevra Congregazione Congreg. Molossi Giambattista
365
Mauri Antonio Congregazione Congreg. GrazioliCarlo(32) 345LivragaAntonia Congregazione Congreg. GrazioliCarlo 43Molossi Giacinto (rev.)
Congregazione Congreg. 84
Merlini Angelo (rev.)
Congregazione Congreg. 291
VistariniCamillo(rev.)
Congregazione Congreg. CavezzaliR. 187
Ferrarelli Bartolomeo(rev.)
Congregazione C.S.Leonardo
SilvettiCarlo 216
Finali Giuseppe Pozzoli Antonio Pozzoli 365Diversianniversari Congregazione Congreg. 270
Chiesa parrocchiale n. 10, S. Maria Maddalena
BeneficiodelFanzago
Parroco Silva ZambelliniGio. 7
BeneficiodelFanzago
Vescovo Benia Dresano
CanziGio.(canonico)
30
VillanovaPompeo Parroco Parroco LattuadaCarlo 150Mondini Angela Parroco Parroco BignamiApollonio 20PallaviciniGiuseppe
Parroco Parroco Pozzoli Antonio 65
Pollinari Andrea Parroco Parroco SandriniCarlo 10CaravaggiTosiCattarina
TosiCaravaggi(eredi)
Tosi Caravaggi
CapraraValerio 48
FormentiA.,CarminatiC.
ScuoladelSsmoSacramento
ScuolaSsmo CapraraValerio 9
Pozzoli ScuoladelSsmoSacramento
ScuolaSsmo 4
FiamenghiCarlo Fiamenghi(eredi) Fiamenghi BodrèFilippo 12
123
DaLodiGiambattista
Cernuscoli(famiglia,nob.)
Cernuscoli Dossena Teodoro 42
MaitelliLucrezia ComunanzadiS.Giacomo
Comunanza Maitelli Fabrizio 50
Berlenda(consorti) Chiesa Chiesa LandriniCarlo 12MarinoLudovico(rev.)
Consorziodelclero(vac.)
Consorzio TrezziBartolomeo 44
CavrottiGiacinto DeCesarij DeCesarij CavrottiCarlo 330BergomiV.,DurelliC.
Consorziodelclero(vac.)
Consorzio Bussola D.,Molossi A.
751
NazariScariono Merlini, Polli Merlini, Polli
365
BergamoGio.(rev.)
Scuola Concezione(vac.)
Scuola DellaCarlinaVincenzo
250
Bosone Anto Scuola Concezione(vac.)
Scuola Fornari Paolo 224
De Angeli Gio. Scuola Concezione(vac.)
Scuola CavrottiCarlo 66
Besagna Antonia Scuola Concezione(vac.)
Scuola CavrottiCarlo 9
ColdanaCattarina Scuola Concezione(vac.)
Scuola CavrottiCarlo 3
Maggiona Cattarina
Scuola Concezione(vac.)
Scuola CavrottiCarlo 9
Bernoni Anto Scuola Concezione(vac.)
Scuola CavrottiCarlo 11
FormentiAnto Scuola Concezione(vac.)
Scuola CavrottiCarlo 13
ViolaschiPaolo Scuola Concezione(vac.)
Scuola BriocchiDomenico 21
MoralesVeronica Scuola Concezione(vac.)
Scuola BriocchiDomenico 17
Dente Torquato Scuola Concezione(vac.)
Scuola BriocchiDomenico 11
RemitaleCristoforo
Scuola Concezione(vac.)
Scuola BriocchiDomenico 19
PiazzaGiovanna Scuola Concezione(vac.)
Scuola BriocchiDomenico 5
MalvicinaDomenica
Scuola Concezione(vac.)
Scuola BriocchiDomenico 31
LampergoloG.e M., Morales
Scuola Concezione(vac.)
Scuola 20
124
PergomoGiampaolo
Scuola Concezione(vac.)
Scuola 5
Dunieri Paolo Scuola Concezione(vac.)
Scuola 110
Rasi Francesco Scuola Concezione(vac.)
Scuola 44
Pissacani Polissena Pietro
Scuola Concezione(vac.)
Scuola 18
Donzelli,Pergamo,Cesareo
Scuola della Passione(vac.)
Scuola VenostaB.,PolliC.S.
730
Galleana Zucca Laura
Scuola della Passione(vac.)
Scuola BodrèFilippo 38
Bologna Prudenza Scuola della Passione(vac.)
Scuola BodrèFilippo 40
Rossi Peregrino Scuola della Passione(vac.)
Scuola BodrèFilippo 12
DeganoGerolamo Scuola Concezione(vac.)
Scuola 4
VignatiPietro Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. BarbaviniSigismondo
242
CornalbaGiambattista
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. 20
GandinoCarlo Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Altrocchi Giuseppe (5)
ZefirinoBernardo Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Altrocchi (5),Graziadelli(265)
BignamiCristoforo,Sebast.
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Gianotti Gio. 37
Boldoni Franco Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Gianotti Gio. 52
Modegnani Francesco
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Gianotti Gio. 6
ZuccaBartolomeo Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Gianotti Gio. 8
Gandini Pietro Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Gianotti Gio. 1
Biancardi Bartolomeo
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Fraschini Bassano 24
AmanoAlessandro
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Altrocchi Giuseppe 16
MuzzaniClaudio Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Altrocchi Giuseppe 15
125
Denti Torquato, Ippolito
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Altrocchi Giuseppe 9
Zeneri Giambattista
Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. Altrocchi Giuseppe 10
ZambelliBassano Confr.SS.Trinità(vac.)
Confrat. ZambelliGiulio 38
Oratorio Pesalupo (sobborghi d’Adda)
RemitaliCarloAntonio
Salamanca(eredi) Salamanca Dancardi Giuseppe 260
Chiesa parrocchiale n. 11, S. Giacomo
CaravaggiBaldassarre
Caravaggi(eredi) Caravaggi Morandi Franco 265
Garofoli Giulio Scuola S. Anna (vacante)
Scuola Miglio Giuseppe 270
GarofoliLeonardo,Camillo
Scuola S. Anna (vacante)
Scuola Espressi Filippo 100
Moroni G.A., Sommariva
Scuola S. Anna (vacante)
Scuola Espressi Filippo 130
MaitelliLucrezia Comunanza Comunanza Maitelli Fabrizio 50Porro Giac. Ant. (rev.)
Parroco Parroco 45
Garofoli Giulio Scuola S. Anna (vacante)
Scuola Miglio Giuseppe 40
Baroncini Giambattista
Parroco Ospedale Miglio Giuseppe 29
Gandino Alberto Parroco Parroco Oppizzi Giuseppe Andrea
13
Fasolo Marc’Antonio
Parroco Parroco Oppizzi Giuseppe Andrea
14
MajocchiFrancesco
Parroco Parroco Miglio Giuseppe 14
PergamoGimabttista
ConcezioneMaddalena(vac.)
Concezione Miglio Giuseppe 14
DordoniCamillo Consorziodelclero(vac.)
Consorzio 13
Maraschi Francesco
Parroco Parroco 12
126
LamerioCristoforo
Parroco Parroco Oppizzi Giuseppe Andrea
9
ComoGiovanni Parroco Comi(eredi) CasoratiGio.Batta 12MoroneGiacomoAntonio
Scuola S. Anna (vacante)
Scuola Espressi Filippo 25
Garofoli Giulio Scuola S. Anna (vacante)
Scuola 10
PozzoloAmuellaMargarita
Espressi Filippo (rev.)
Espressi ZambelliBassano 17
Pinchiroli Diana Parroco Parroco CasoratiGio.Batta 2Bordona Dorotea Parroco Ceresoli 3MarziLudovico Consorzio
delclero(vac.)Consorzio MojoliMauro 42
CipellettiAntonio Consorziodelclero(vac.)
Consorzio MojoliMauro 42
Chiesa di S. Maria della Fontana (sobborghi d’Adda)
Fondatoridiversi Consorziodelclero(vac.)
Consorzio 116
Oratorio di S. Rocco
PrevedoneBassano(nobile)
SommarivaPietro,Luigi
Consorzio Dossena Teodoro 220
Oratorio di S. Riolo
LodiAntonio(nob.)
Rossoni Prospero Rossoni 52
Fondatoridiversi Sommariva(eredi)
Sommariva 65
Oratorio del Contarico
Tedeschi Alfonso MarchiCarlo,Prospero
Oratorio delle cassine de Travaini
Giuseppe Carminati(prev.)
Carminati(eredi) Carminati Espressi Filippo 33
127
Oratorio di Vigadore
VitaloniAgostino Capitolodellacattedrale
Capitolo Ferrabini Antonio 45
Sobborghi
Chiesa parrocchiale di S. Maria della Clemenza
BelloneC.,Zanoncelli D.
Parroco Parroco 2
NegriGianPaolo ScuolaSsmoSacramento
Scuola ArdemagniBassano 100
InzaghiGiulia(suora)
Ospedal MaggiorediLodi
Ospedale 57
UggeriGiuliana Parroco Parroco ArdemagniBassano 24NuterinaElisabetta
Parroco Parroco ArdemagniBassano 8
ChiesaGiacomo Parroco Parroco ArdemagniBassano 6PiccoliCesare Parroco Parroco ArdemagniBassano 15
Oratorio della Majerana
ErbaFranco(rev.) Erba(famiglia) Erba MoroneCarlo 72
Oratorio della Gatta
LandreaniDaria Mola Antonio Mola GilardiCarlo 262
Oratorio dell’Inseppina
Azzati Fabrizio (nobile)
Azzati(famiglia) Azzati 12
Oratorio delle Quaresmine
CarminatiVincenzo
Carminati(famiglia)
Carminati 8
Oratorio della Maldotta
Berinzaghi Antonio(nob.)
Berinzaghi (eredi)
Berinzaghi 3
128
Oratorio dell’Olmo
Obbligo della comunità
Parroco Parroco 8
Chiesa parrocchiale de SS. Bassano e Fereolo
Sari Francesco (rev.)
Capitolodellacattedrale
Capitolo 68
Pandini Giulio (rev.)
Chiesa Chiesa 68
Oratorio della Muzza
ViscontiIsidoro(nobile)
Orleri(famiglia) Orleri PremoliPaolo 52
Fagioli Giambattista
Deputati oratorio Deputati CeresaGiuseppe 52
CareraAnna Deputati oratorio Deputati PremoliPaolo 52
Oratorio si S. Eugenia
Grassi Giangiacomo
Astori Alessandro Astori 6
Oratorio di S. Barnaba
Brocchieri Pietro (rev.)
Brocchieri (famiglia)
Brocchieri VenturelliFelice 68
Oratorio alla Torre de’ Dardanoni
Pedracini Pietro (senatore)
Pedracini (famiglia)
Pedracini Dordoni 240
Oratorio del Castello de’ Roldi
Terzaghi Pietro e Sebastiano
Terzaghi (famiglia)
Terzaghi 36
Oratorio della Baroncina
Bonelli Antonio Canzi(famiglia) Canzi 40
129
Oratorio di Campo Longo
ViscontiIsidoro(nobile)
Muzzani Agostino
Muzzani Scotti Filippo 45
Chiesa parrocchiale di S. Gualtero
PellizzolaCarloFranco(rev.)
ScuolaSsmoSacramento
Scuola 66
Biancardi Margarita
Parroco Sc. Trin. Livraga
102
RossiniTommaso(rev.)
ScuolaSsmoSacramento
Scuola 52
Roberti Ferdinando
Eredità Roberti Roberti Brunetti Alessandro 292
Roberti Giuseppe Eredità Roberti Roberti Brunetti Alessandro 42CiseriAnto,Canovali
ScuolaSsmoSacramento
Scuola 8
Oratorio di S. Grato
CinquantaAmbrogio
Monte di pietà Monte Dagrada Giuseppe 261
Maraschi Monte di pietà Monte 4
Oratorio delle Zelasche
Fondatore ignoto Riboni Giambattista
Riboni Mazzasogni Antonio
68
Oratorio di Paderno
Marzi Giacinto Perla(famiglia) Medaglia PavesiAntonio 328
Oratorio di Bottezzo
BeneficioTajetti Tajetti(eredi) Beni propri Barone Andrea 300
130
8. Messe fondate della cattedrale di Codogno (1774)7
Collegiata di S. Biaggio
Fondatore Nomina Fondazione Titolare N.
NovarinaGioannina Vescovo Bianchi Pietro 260Beneficioantico Vescovo Beni propri MilaniCarlo 250Legatiantichi(4) Vescovo Beni propri Bandirali,
Sardella780
Greco Giuseppe Comunità Beni propri MazzoletiLuigi 312Martinenghi Bartolomeo
Comunità Beni propri Belloni Giambattista
362
PescarmonaBernardo Garilli(famiglia) Beni propri 186
TrimerioBartolomeo Tugoni, Greci, Siboni
Beni propri Fontana Gio. Anto
200
Folli Giuseppe Eredi del fondatore
Beni propri Rossi Giuseppe 360
Fondatore ignoto Finetti(famiglia) Beni propri Pancera Giuseppe
309
Fondatore ignoto Belloni(fratelli) Beni propri 330Gibeli Manfredino Parroco Ferrario
Bartolomeo40
Molla Giuseppe Parroco 36DomenicanaAntonia Parroco 70Albina Giulia Parroco 2Morzenchio Giuseppe Parroco 37Fondatoridiversi Fabbricieri Beni propri VareseSaverio 230VaresiVincenzo Fabbricieri Beni propri ScotiCarlo 52Salici Antonio Fabbricieri Beni propri ViganoneLuigi 199Dragoni Francesco S.M.dellaNeve
(vac.)Cassarelig. Bignami
Apollonio292
TrimerioOrtensia Mon.S.Chiara(vac.)
Cassarelig. BignamiAntonio
320
Variemonache Mon.S.Chiara(vac.)
Cassarelig. 30
Bassi Giuseppe Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. VareseGiuseppe 226
7.Fonte:ASDL,VicariatodiCodogno,cart.1.
131
BigottiCristoforo Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. VareseGiuseppe 68
Ferrari Franco (canonico)
Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. VareseGiuseppe 13
Albina Giulia Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. VareseGiuseppe 14
Bassi Angela Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. VareseGiuseppe 36
Motta(sorelle) Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. Morosini, Bignami,Ferri
112
Goldaniga Filippo Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. BignamiGaetano
36
Bianchi Giannantonio Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. BignamiGaetano
48
QuattriniCesare Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. Morosini Pietro 14
GoldanigaLucia Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. Morosini Pietro 9
GrossiGiovanni Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. Peroni Bernardo 21
CremonesiGiuseppe Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. CremonesiGiuseppe
208
Tansini Gioanni Scuola del Rosario(vac.)
Cassarelig. TonaniLuigi(canonico)
362
Magnani Giuseppe Molinari(fratelli) Molinari Angelo 10PallaviciniDomenico Garini
(protofisico)292
CremonesiPietro Eredi del fondatore
CremonesiGiuseppe
120
ParmesanoGiac.Antonio
Parmesano(famiglia)
Andreoli Giuseppe
36
Mariani Francesco Dansi(famiglia) Dansi Bartolomeo
362
Gazza Pietro 35Bianchi, Bernardino eLatt.
Bianchi(famiglia) 320
CipolaGiambatta Cipola(famiglia) 7Fondatore ignoto Trivulzio
(albergo)362
132
9. Principali estimati della città di Lodi (1847)8
Nome Cifra d’estimo
FerrariVincenzo,GaetanoeLuigi 3.374PicolliCristoforo 3.191Ganzinelli Gio. Battista ed Angelo 3.057SilvettiGiacomo 2.919Garzia Filippo 2.833Terzaghidott.Carlo 2.545SommarivamarcheseGiulioedAnnibale 2.516BosiaLodovico 2.303PirovanoGaetano 2.281VescoviGiuseppe 2.280OlivaLuigi,Rosa,Giuseppe,Orsola,Angela 1.819GhisalbertinobileFlaminio 1.798Barni conte Antonio 1.675TondiniCarlo 1.670CarnitisacerdotePaolo 1.605TrovatiGiusepe,PietroeGiovanni 1.594Sirtori Giulio 1.538BonomiLorenzo 1.416GrassiLorenzo 1.416ChiappaLuigi 1.408FugazzaCarloefamiglia 1.380ZanoncelliGiacomoeGiovanni 1.364Gazzini Francesco 1.347Mulazzi Antonio 1.347ZalliGiovanni 1.305Mulazzidott.Giuseppeefamiglia 1.288ProvasicavalierGuido 1.263Terzaghi dott. Antonio 1.245De Stefani ing. Paolo 1.242Dossenadott.Lorenzo 1.229OmatiGiuseppe 1.219FornariGiuseppeefamiglia 1.187Pastori Enrico 1.179
8.ASCL,Sotto-prefettura,cart.262.
133
CavezzaliFrancesco 1.152De Righetti Giuseppe 1.127BarninobileGiovanni 1.111BianchiFrancescoefamiglia 1.081Pigna dott. Giuseppe e Michele 1.076Pigna dott. Giuseppe e Gabaglio Maria 1.051RèLuigi 1.027TrovatiGerolamo 1.017GhisiLuigi 1.011Banderali Onorato 1.007StefenoniGiovanniePietro 999MigliavaccaGiuseppeedott.Saverio 971Beluschi Pietro 971MamoliFrancesco 969Zucchinetti Giuseppe 958CeresaBassano 951LondiniAngelo 951MontaniCarloeGiovanni 950Rota Gaetano 946MottaCarlo 930CaravaggioPietro 917RodaVincenzo 886Barni nobile Giorgio 884SalvalaglioAntonio 879Oldrini Gaetano 850Parigi Gaetano 848Alberti Giuseppe 845AjardiGiovanni 841BelloniDomenico 840Marchi Giuseppe e Ganzinelli Gio. Batta 840PomaTomaso 833Narcisiing.Giovanni 831DedèGiovanni 814FerrariGiacomo 803PoggiGiacomo 801BarninobileCristoforo 799Villaavv.Paolo 798Bocconidott.Luigi 796PellizzariCarloefamiglia 785
134
Bizzoni Francesco 777MancininobileCarlo 777MinojaLuigi 776CremonesiPaolo 773Boggiali Filippo 768Zacheodott.Domenico 763Ferrari Bassano 763TaliniPietroefamiglia 763GonzalesLodovico 763TerzaghiPietro,BartolomeoeGiuseppe 756MazzucotelliLuigiefamiglia 750Asti Angelo Maria 740Magnani Paolo 737Pavesidott.Carlo 737CerasoliGiuseppe 736Beretta Gioachino 736Meazza Giuseppe 728MeratiFillippoefamiglia 719NegriLuigi 719CorviBernardo 715Albertini Annibale 712GhisiLuigieDomenico 700TorchianaPasqualeefamiglia 697ComaschiGio.Battista 697CingiaPietro 694ComizzoliGiulio 694VistarininobileFerdinandoeCarlo 694TavajeraBassanoefamiglia 691PremoliGiuseppe 688Merlini ing. Antonio e sacedote Giuseppe 687Bissi Gio. Battista 686CastellazziPietro 684Mola ing. Giuseppe 680RhònobileCesare 680De Righetti Francesco 677Crociolaniavv.Alessandro 666MoroniLuigi 664Vitaliing.Luigi 663Abiati Antonio 659
135
CasanovaBassano 656BocconiSettimo 652MarinoniLuigi 648Dossena Michel Angelo 645Groppi Gabriele 645LavezGiovanni 641Martaniavv.Antonio 638GianelliDomenico 636
10. Sottoscrittori della società del gioco del pallone di Lodi (1857)9
Nome Condizione Domicilio Quote
ParigiLuigi Dottore in legge Lodi 6CattaneoGiuseppe Commerciante 5ParigiLuigi Commerciante 5CagnolaFrancesco Dottore in legge 1GhisalbertinobileFlaminio Possidente 10CiambellanodiSuaMaestà 2Ghisalberti nobile Maurizio Possidente 1Riboni Giuseppe Possidente 2RaimondiCominesiAntonio Notaio 1LentaLuigi Dottore in legge 1LentaGiuseppe Ingegnere 1Biancardi Eugenio Dottore in legge 1WilmantEnrico Commerciante 1DelfrateGiovanni AmministratoreOsp.Magg. 1BonomiEttore Dottore in legge 1NegroniCarlo Possidente 2CodeleonciniGiuseppe Commerciante 1PirovanoGaetano Possidente 1FèRodolfo Possidente 1BalloniCristoforo Possidente 1Bizzoni Augusto Commerciante 1CesariPietro Possidente 1CagnolaGiuditta Possidente 1
9. ASCL, Sottoprefettura, cart. 75, fasc. Progetto per il nuovo manicomio in Lodi, carteggio dal 1857 al 1860.
136
Roda Alberto Possidente 1GibelliErmenegildo Ragioniereorfanotrofio 1BosoniAmos SegretarioIst.elemosiniere 1Mattia Antonio Ragioniere 1ScolaEmilio Ingegnere 1Alberti Giuseppe Possidente 1CarpaniGiacomo ImpiegatoRagionieria
provinciale1
MajocchiAnnibale Commerciante 1Picolli Francesco Ingegnere 1Fornari Paolo Impiegato 1CrociolaniSettimo Notaio 1BassiLuigi Commerciante 1LombardoAntonio Commerciante 1SoffientiniAlessandro Commerciante 1Roda Michele Medico-chirurgo 1BignamiAchille Notaiodegliorfanotrofi 1Bossi Pietro, sacerdote Professore del ginnasio
liceale1
DellaViaMariano Rettore del collegio dei barnabiti
1
SuardiGiacomo Commissariodistrettuale 1RancatiBartolomeo Commerciante 1Mentegalli Antonio Possidente 1AgnelliGiovanni Commerciante 1MojolisGiuseppe Possidente 1Sirtori Antonio Ingegnere 1Terzaghi Paolo Notaio 1ScottiLuigi Avvocato 1BozziMassimo Possidente 1GalmozziAntonio Avvocato 1Ghisi Stefano Impiegatomunicipale 1Barni nobile Filippo Possidente; deput. Fissiraga 1CremonesiCarlo Farmacista 1Dossena Antonio Possidente,vice-pres.
Cameradicommercio1
CottaAntonio Commerciante 1PremoliSalvatore Commerciante 1Mola Pietro Possidente 1
137
Ferla Fortunato Commerciante Cavenago 1Bruschini Pietro Ricevitoredellotto 1Federici Pietro Commerciante 1Monico Pietro Possidente 1VaresiDomenico Dottoreinmatematica 1CaravaggioGiuseppe Commerciante 1Sperati Antonio Farmacista 1Magnani Francesco Impiegatomunicipale 1ColomboGiovanni Commerciante 1Sardi Alessandro Commerciante 1Bignamirag.Ernesto Commerciante 1Dabbene Stefano Commerciante 1ChiappaLuigi Commerciante 1LazzariStefano Possidente 1TirelliVincenzo Medico-chirurgo 1Farina Giuseppe Commerciante 1SalvalaglioFrancesco Sacerdote 1Acerbi Gaspare Possidente 2RiboniCesare Possidente 1BignamiGiuseppe Appaltatore 1DonatelliCarlo Possidente 1Acerbi Gaspare Possidente 1SilvettiGiovanni Dottore in legge 2ParigliettiCarlo Avvocato 1CremaschiLuigi Possidente 2Ferrari Alessandro Possidente 1Pigna Michele Ingegnere 1Zalli Angelo Avvocato 1PontiUrbano Scrittoreprivato 1VignatiBassano Agentedicambio 1TondiniCarlo Possidente 1Mascheroni Stefano Farmacista 1RognoniVincenzo Farmacista 2BellèPaolo Sacerdote 1Mascheroni Giuseppe Medico-chirurgo 1Oleari Battista Impiegatogiudiziario 1CapraraEmanuele Impiegatoorfanotrofi 2Robiati Alberto Ingegnere 1RodaVincenzo Possidente 1
138
PozziCarlo Appaltatorefinanze 2DrobertiCostante Sacerdote 1CantùPaolo Sacerdote 1BarninobileCristoforo Possidente 3Giulini Pietro CappellanoOsped.Maggiore 1Gugelloni Martino Sacerdote 1BarbettaLuigi Possidente 1MalacarneGiovanni Possidente 1CastellettiGaetano Direttorescuolecomunali 1MazzucchiSamuele Commerciante 1PesatoriLuigi Medico-chirurgo 1AcerbiNapoleone Farmacista 1BaroniGiovanni Impiegatoginnasio 1BarinettiCarlo Possidente 1Terzi Angelo Capo-farmacista 1Olcelli Giuseppe Scrittoreprivato 1RhònobileLuigi ImpiegatoOspedalmaggiore 1Bossia Giuseppe Medico-chirurgo 1SangalliCostantino Possidente Chiosi
d’Adda1
GentiliGiovanni Ricevitoredifinanze 1ZamaraFedele Impiegatodifinanze 1Casorati Veterinario 1BergaminiCarlo Possidente 1Rossi Giulio Professore del ginnasio liceale 1Magnani Giuseppe Possidente 1CeruttiPompeo Scrittoreprivato 1CreppiFrancesco Commerciante 1BamatiStefano Vice-conservatorearch.
Notarile1
Bizzoni Francesco Possidente 1Gandini Francesco Negoziante 1Passerini Ettore Impiegatogiudiziario 1AiroldiGiacomo Commerciante 2MulazziLuigi Commerciante 1NibboniCarlo Possidente 1BruschiniGiovanni Dottore in legge 1BarniGiovanni,conte 1CattaneoPaolo Commerciante 1
139
BeonioCarlo Possidente 1Barni Antonio Possidente 1Oldrini Giuseppe Possidente 1Zanaboni Giuseppe Possidente 1BellinettiLazzaro ImpiegatodiFinanze 1SormaniGiovanni Impiegatocomunale 1FarinettiLuigi ImpiegatoOspedalMaggiore 1RovidaValerio Impiegatofinanze 1CasoratiValeriano ImpiegatodiFinanze 1Parigi Ernesto Commerciante 1VeronesiPaolo Commissionario 1ZambonettiBassano Commissionario 1Ghisi Commerciante 1FumagalliFederico Commerciante 1Sentali Angelo Dottore in legge 1Andronio Gioachino Commissionario 1Zalli Pietro Ingegnere 2BergamaschiVincenzo Commissionario 1VignatiLuigi Impiegato 1Moroni Giuseppe DirettoreOrfanotrofio 1VarisioAchille ImpiegatoOspedalMaggiore 1FèAlessandro Possidente 1Bassi Redentore Ingegnere 1Ferrari Gaetano Commerciante 1FerrariLuigi Commerciante 1CroceStefano Commerciante 1Fugazza Michele ImpiegatodiFinanze 1RavasioGaspare Commissionario 1TrovatiPaolo Possidente 1CingiaLuigi Possidente 1Rossi Pietro Commissariocomunale 1BellavitaClaudio Impiegatogiudiziario 1SilvettiBassano Dottore in legge 1CeresaZeffirino Notaio 1CombiCesare Negoziante 1BossiClemente Possidente 1Magnani Bassano Sacerdote 1
143
4. Élite ed istituzioni nel Lodigiano tra Otto e Novecento1
di Enrico Berbenni
1. Le basi agricole dell’economia lodigiana
All’atto dell’unificazione nazionale, poteva ritenersi ormai acquisita larappresentazionedelLodigiano comedi un territorio le cui strutture eco-nomicheeranosaldamenteincardinateinun’agricolturaprogreditache,nelcorsodeisecoli,avevasaputoraggiungereelevatilivellidiproduttivitàcon-giuntiadunaspiccatavocazioneallacommercializzazionedeipropripro-dotti2.Un’agricoltura, quella caratteristica dellaBassa irrigua, in grado disostenerelosviluppodiunterritoriopolicentrico,imperniatononsolosullacittàdiLodimaanchesualtregrosseborgatecheavrebberomantenutoneidecennisuccessivipropriespecificheconnotazioni.Basti,perconvincerse-ne, gettare uno sguardo alla distribuzione della popolazione, distinta per di-stretto, al 1857, da cui risalta la compresenza di aggregati demografici didimensionitraloroconfrontabili3.Comedaaltribensottolineato,sièdunquedifronteaunterritorio“plu-
rale”, a partire proprio dalla conformazione del sistema agricolo4. Il Bel-linzona, nella suamonografia sul circondario diLodi pubblicata nel 1882
1.UnringraziamentodoverosovaaGuidoAlfanieaBarbaraCostaperilorospuntiesuggerimenti.GrazieancheaDomenica,ilcuiaiutoèstato,comesempre,insostituibile.
2. A. De Maddalena, Appunti sull’economia lodigiana nel suo profilo storico, in L’eco-nomia lodigiana. Profilo storico e struttura attuale,RaccoltadistudidellaRivista“Studie statistiche”dellaCameradi commercio, industriaeagricolturadiMilano,n.3-4,1958,p. 11.
3. Lodi (46.479 abitanti), Codogno (41.008), Casalpusterlengo (29.970), Borghetto Lo-digiano(20.770)eS.AngeloLodigiano(18.839).G.Bellinzona,Il circondario di Lodi, in Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola,vol.VI,fasc.III,Roma,1882,p.198.
4.E.C.Colombo,Agli albori del credito cooperativo nel Lodigiano,inP.CafaroeE.C.Colombo(acuradi),Un’antica nobiltà. L’altro credito cooperativo a Lodi nel Novecento, Milano,2009.
144
all’interno dell’inchiesta agraria nazionale, individuava quattro zone prin-cipali,perunasuperficiecomplessivadi81.400ettari:l’agrolodigianopro-priamentedetto,digranlungalapiùestesaconisuoi63.000ettari;lazonavitiferadiS.Colombano(2.500ettari),lazona“Ghiaiad’AddaLodigiana”(4.900ettari)elazona“RegonadiPoed’Adda”(11.000ettari).LedifferenzeesistentitralediverseareeimpedivanodiguardarealLo-
digiano come ad una realtà uniforme e, tuttavia, la netta prevalenza dellaprimapermettevadiriscontrareunmodellodominante,basatosuunsiste-ma irriguocheavevapochiparagoni inEuropa5. Ineffetti, laproporzionedella parte asciutta sull’irrigato eraminima nella zona principale,mentreerapiùsignificativanellapiccolaareadiS.ColombanoenellazonaregonadelPo.Daciòdiscendevanodifferentisistemicolturaliedesigenzediversedicapitalidainvestirenell’attivitàagricola:
Pertrarredaquestiterreni[dellaprimaedellaterzazona]ilmigliorpossibilepro-fitto,bisognanecessariamentededicarsiallaproduzionedellatteperlafabbricazio-nedelformaggiodigrana;quindigrandiosestalle,fienili,emoltimezzipecuniari,perpoterfarl’acquistoelarimontadelbestiameeresistereallesinistreeventualità.Ciònonsipuòdireinvecedellealtreduezone,perchéesse,piùcheiforticapitali,esigono abbondanza di braccia e diligenza di conduzione, essendo le scorte pochis-simeediunvaloredigranlungainferioreaquellodelledueprimesuaccennate6.
Irrigazione ed allevamento del bestiame appaiono dunque come fattoridecisivinelsuccessodibuonapartedell’agricolturalodigiana.Adesseoc-correaggiungereun’altracaratteristica, complementarealleprecedenti, in-dividuabilenelleestesecoltivazioniaprato.Giànel1859,ilprospettodellasuperficiecoltivataperdistretto lasciavachiaramente intendere lacentrali-tà assunta da queste ultime (tab. 1). Infatti, nella bassa pianura, grazie al-larealizzazionediun’imponenteinfrastrutturairrigua,lecoltureforaggereavevano ricevuto un impulso notevolissimo, sia nella formadel prato per-manentesiaavvicendateconaltrecolture7. Ancora nel 1924, una relazione
5.Aa.Vv.,Il grande canale Muzza. La rete delle rogge derivate e il territorio irrigato, Milano, 1939.
6.G.Bellinzona,Il circondario di Lodi,cit.,p.208.7.R.K.Greenfield,Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il movimento nazionale in
Lombardia dal 1814 al 1848,Bari,1964,p.23.Sullosviluppoinsensocapitalisticodell’agri-colturalombardasivedaM.Romani,L’agricoltura in Lombardia dal periodo delle riforme al 1859. Struttura, organizzazione sociale e tecnica,Milano,1957;L.Cafagna,La “rivolu-zione agraria” in Lombardia, in«Annalidell’IstitutoFeltrinelli»,II,Milano,1959,pp.367-428;P.Villani,Feudalità, riforme, capitalismo agrario,Bari,1968;S.Zaninelli,I patti agra-ri in Lombardia intorno alla metà dell’Ottocento. Un tentativo di intervento pubblico diret-to a limitare la libertà contrattuale, in Contributi dell’Istituto di storia economica e sociale, I,Milano,1973,pp.287-307;A.Moioli,L’agricoltura lombarda nell’età della Restaurazione (1815-1848),in«Annalidistoriamodernaecontemporanea»,n.2,1996,pp.147-190.
145
dellaCameradicommerciodiLodicosìsintetizzavailineamentiessenzia-lidell’economiaagricolalocale:
Laproverbialefertilitàdeicampièdovutaingranparteallavoropazienteecon-tinuodell’uomochehacreatounsistemadiirrigazioneammirabileedapplicaunaconcimazionerazionaleedaccurata.[…]L’agricolturalodigianahaunafisionomiapropriaessendofondamentalmenteprativa.Ilnumerosobestiameaddettoall’agri-coltura equellodestinato alla produzione lattifera causanoun forte consumo fo-raggero, che porta di conseguenza a tenere almeno i due terzi dei fondi a coltu-raprativa8.
Tab. 1 - Prospetto della superficie coltivata nel Lodigiano – 1859 (in ettari)9
Distretti Aratorio Risaie Vigne Pratied orti
Pascoli Boschi Totale
Lodicittà 13 – 4 25 5 – 47Lodidistretto 6.908 1.262 43 8.456 514 1.858 19.041Borghetto 2.604 231 1.238 4.357 308 115 8.853S. Angelo 3.328 629 327 4.017 27 67 8.395Codogno 8.184 1.382 4.656 4.156 446 1.060 19.884Casalpusterlengo 6.317 919 47 6.682 66 454 14.485Complemento – – – – – – 3.418Totale 27.354 4.423 6.315 27.693 3.366 3.554 74.123
Comenoto,taleorganizzazionecolturaleconvergevaversolaproduzionelattiferaelasuasuccessivavalorizzazionemediantelavorazioneneicaseifi-ci,un’attivitàcaratteristicadiquestoterritorioechepotevavantareunatra-dizioneormaisecolare,soprattuttoaCodogno10.All’indomanidell’unifica-zionenazionale,ilfulcrodell’economialodigianaeraindividuabileproprio
8.Camera di commercio e industria di Lodi,Caratteristiche economiche del Distret-to camerale,Lodi,1924,pp.6-7, cit. inE.Ongaro, Istituzioni economiche nel Lodigiano negli anni venti, inB.Bezza (acuradi),Movimento contadino e fascismo nel Lodigiano (1915-1930),Milano,1983,p.110.
9. G. Bellinzona, Il circondario di Lodi,cit.,p.204.10.Notizie sull’industriadel formaggionelLodigiano si hannogiànelXIII secolo.P.
Ferrari, L’industria del latte in Italia, Piacenza, 1970, pp. 9-28. Un’idea approssimativadell’importanzadelsettorelattiero-casearionellediversepartidelterritoriolasipuòrica-vareanalizzandoiquantitatividimerci,suddivisepercategorie,speditedallestazionidelcircondario nel 1878: Codogno risulta essere il principale centro di spedizione di burro,latte, latticinie formaggi (13.269q);alsecondoposto,agrandedistanza(2.561q),vieraLodi, laquale tuttaviaeraancheun importantecentrodi spedizionedibozzoli (3.416q);seguivanoCasalpusterlengo,SecugnagoeTavazzano.G.Bellinzona,Il circondario di Lo-di, cit., p. 284.
146
nei circa 400 “casoni” in cui si lavorava il latte11. La possibilità offertadaiformaggidi“allungare”ilciclodivitadellattepermettevadiinvesti-renell’ampliamentodellacapacitàproduttivadiquellocherisultavaesse-reilbenefondamentaledell’economialocale,acuicisiètalvoltasignifi-cativamenteriferiticome“orobianco”12.Ilchedovevariflettersiinmisuranonmarginale nell’inserimento della regione nei traffici commerciali an-che a lunga distanza: come è stato opportunamente osservato, «la gran-dissima produzione di latte di questa regione, che crebbe parallelamenteall’estensionedelsistemad’irrigazione,comportòlaparallelacrescitadel-la produzionedel formaggio che avveniva, diversamentedaquanto acca-devaper lazonadellamontagna,per indirizzarsialcommercio,anchedilungo raggio»13. La produzione di burro e formaggi – in particolare il grana – si inne-
stava a doppiofilo nella realtà agricola locale, tanto da svolgersi all’inter-nodellastessacascina,specialmenteadoperadiunpersonaledipendente,icasari,lacuicentralitàeconomicaeraattestatadaglialtilivellidiretribu-zione rispetto agli altri lavoratori impiegati nell’azienda agricola14. A que-stafiguradiprototecnicisiaffiancava,perquantoattienelacommercializ-zazione del prodotto, quella dei negozianti, i quali non si limitavano allasola attività di intermediazionema, raccogliendo il formaggio ancora allasuaprimafasedimaturazione,curavanoneiloromagazziniancheilcom-pletamentodeldelicatoprocessodistagionatura.Il modello produttivo ruotava pertanto attorno allo spazio fisico del-
la cascina, la quale realizzava in tal modo una complementarità di fon-do tra attività agricole, zootecniche e casearie. Questo sistema raggiunsela sua massima affermazione nella bassa Lombardia nella seconda me-tàdelXIXsecolo,maproprioallora si iniziòaguardare semprepiùallo
11.A.Cova,L’economia dell’Ottocento e del Novecento,inAa.Vv.,Lodi. La storia dal-le origini al 1945,vol.III,Lodi,1990,p.134.
12.P.Battilani eG.Bigatti (a curadi),Oro bianco. Il settore lattiero-caseario in Val Padana tra Otto e Novecento,Lodi,2002.
13. F. Mandressi, La nascita del caseificio industriale in Lombardia,in«Annalidisto-ria dell’impresa», n. 10, 1999, p. 567. L’autore, citando ilVerri, ricorda l’importanza del-leesportazionideilatticiniperlabilanciacommercialedelloStatodiMilanonel1762(p.569).
14.Altrefigureimpegnatenellaproduzionediformaggioeranoilattai–peralcuniver-si, iprecursoridell’industriadel latte–e ibergamini.G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento. Percorsi e protagonisti,Milano,2009,pp.64-79.Peruninquadra-mentodi lungoperiodosivedaG.Bigatti,Dalla “coltura a caci” al caseificio: le aporie di una modernità incompiuta, inP.BattilanieG.Bigatti (acuradi),Oro bianco, cit., pp. 13-35;nellostessovolume,N.AriolieF.Cattaneo,La nascita dell’industria lattiero-case-aria nel Lodigiano,pp.271-346.Perunastimadellaretribuzionemedia,indenaroeinna-tura, del casaro cfr. G. Bellinzona, Il circondario di Lodi,cit.,p.360.
147
strettocollegamentoconl’agricolturacomealprincipalepuntodidebolez-zadelsettorecaseario,ancorpiùgravequandosiconsideriilpesantepas-sivo commerciale italiano verso l’estero in questo ramo, allora particolar-menteevidente.Nei primidecenni post-unitari, dapartedei contemporanei più sensibi-
lialle trasformazionidelmercatoinchiavesempremenolocale,sidenun-ciavaunadiffusatendenzaaconsiderareilformaggiocomeunalavorazio-nefinalizzatapiùadincrementareladuratadiconservazionedellatte,chead attribuire allo stesso un valore aggiunto15. In breve, gli interessi degliimprenditoriagricolieranoconcentrati ingranpartesulla«produzionedellatteveroeproprioesullagestionedelbestiame,escludendodifattoilca-seificio dai loro interessi»16. Di qui le conseguenze deleterie sulla qualità delprodottofinito,derivantidalfattodidelegarelaproduzionedelformag-gioall’esclusivaattivitàdelcasaro:alsuoempirismoeallasuaavversioneall’innovazione si attribuivano le cause prime dell’arretratezza del settore.La posizione inmerito assunta dalBellinzona nella già citatamonografiasulLodigianopareparticolarmenteinteressante,ancheperchémetteanudolemaggioricriticitàdelcaseificioche lacrisiagrarianon facevaaltrocheaccentuare e che avrebbero in seguito sospinto il comparto ad una evolu-zioneinchiavepiùspiccatamenteindustriale:
Che si direbbe d’un industriale che, eretto dalle fondamenta uno stabilimentomodello, fornitolo dimacchine perfezionate e costosissime, disposta lamateriaprima abbondante e perfetta, non si curasse poi di crearsi un’ottimamanualan-zae lasciassechegranpartedeisuoimanufattivenisseroper imperfetta lavora-zionerespintidalcommercio,coniscreditodituttalafabbricazione?Purtroppoèquesto ilcasodellecascine lombarde ingenere,equindipuredelle lodigiane.Danoil’organizzazionedelpoderepuòdirsiveramenteottima,ilcapitaleel’in-telligenza vi si danno lamano, la scienza stessa approva lamassima parte del-lenostreconsuetudiniagrarie.Solo inquestavitalequestionedelcaseificiononsiriesceacomprendereperchédamezzosecoloaquestapartenessunrealepro-gressosiasipotutoottenere.Senonavessimodovutoconvincercide visu che re-almente una parte importante della produzione caseifera va a male, se la crisirecente e l’arrenamento commerciale non fossero, avremmo persino potuto du-bitarecheil lamentofosseesagerato,echeinmancanzad’unbisognoimpellen-te,nonfossesufficientementesollecitatol’interesseelabuonavolontàdeinostrifittabili.Mapurtroppolecondizionisonoeffettivamentegravi,ilprezzodellat-teèinunaragionesoverchiamentebassa[…];purtroppoèunagrossapartedel-laricchezzadelcircondariocheogniannovaperdutaperlefallanzedellaindu-
15.Particolarmentesignificativi,aquestoriguardo,furonoglisforzidimodernizzazio-ne del caseificio sostenuti da un chimico qualeCarloBesana, autore di svariati studi nelsettoreealungodirettoredellaRegiaStazionesperimentaledicaseificiodiLodi.Suque-stafigurasiavràmododiritornarepiùavantineltesto.
16.F.Mandressi,La nascita del caseificio industriale in Lombardia, cit., p. 573.
148
stria caseifera. E tutto, a nostro avviso, proviene assolutamente dal fatto che apresiederequestaindustrianonstagiàilfittabilenostro,istruttoedotatodimol-to buon senso,ma un empirico [il casaro, nda] generalmente per nulla interes-sato, che applica l’arte comepuò, senza ispirarsi ad alcun criterio economicooscientifico17.
Ciononostante,grazieallaminoreflessionesubitadaiprezzidelburroedelformaggionelmercatointernazionalerispettoadaltrematerieprime,larisposta alla grande crisi agraria del penultimo decennio dell’Ottocento –cheavevacolpitoperlaprimavoltal’interocomplessoproduttivolombardo–dovevapassare,nellezonedell’irriguo,proprioattraversol’intensificazio-nedell’indirizzolattiero-caseario(sivedràpiùavanticonqualiconseguen-zesull’organizzazionedelsettore).TrovavaquindisemprepiùconsensiunapoliticadiestensionedelpratochenelLodigianositradusse,trail1884al1906,inunaumentodellecoltureforaggeredaventimilaatrentamilaetta-ricirca,suunasuperficieinrotazionecomplessivadicinquantacinquemilaettari.Quelladelleforaggerediventavacosìlaprincipalecolturalombarda,favorendo di riflesso l’intensificazione della produzione di latte e l’indu-striadelcaseificio,conricadutepositiveanchesull’andamentodelleespor-tazioni.Intalsenso,nellaLombardiairriguaadifferenzadialtrepartidelpaese, la politica protezionistica di quegli anni accompagnò se non persi-noagevolòunprogressoproduttivoeunadattamentodell’agricolturaloca-leversoformedisfruttamentopiùrazionaledelsuolo,cosìdapotervaluta-renelcomplessopositivamentelarispostadell’ambienteregionale(almenodella bassa pianura) alle fratture imposte nell’equilibrio tradizionale dallaperdurante situazione di crisi18.
2. Proprietari ed affittuari: i caratteri di un’imprenditoria agricola
NellasecondametàdelXIXsecolo,ladivisionedellaproprietàfondiarianel Lodigiano era chiaramente influenzata dalmodello di agricoltura do-minante.Ancora una volta, l’inchiesta agraria si rivela una fonte preziosadidatiperunaricostruzionecomplessivadelterritorio19. Se si guarda all’e-stensione della proprietà, la differenza tra la zona principale irrigua e le al-trepartidelcircondarioeraevidente:mentreinfattinellaprimaprevaleva-no terreni di estensionemedia, intorno ai cento ettari, nelle altre (dove si
17. G. Bellinzona, Il circondario di Lodi,cit.,pp.239-240.18.Al contrariodiquanto avvennenellaparte asciuttadella regione,doveci si orien-
tòsemprepiùversoun incremento localedelleattività industriali.M.Romani,Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961),Milano,1963,pp.81-84,90-91,105-110;A.M.Banti, Storia della borghesia italiana. L’età liberale,Roma,1996,pp.94-95.
19. G. Bellinzona, Il circondario di Lodi,cit.,pp.300-305,318-325.
149
concentravano i terreni non irrigatori coltivati a gelso o a vite) essi eranomoltopiùfrazionati,riducendosilagrandezzamediaasolidueettari.Tale differenziazione trovava un immediato riscontro nelle caratteristi-
che dei proprietari, i quali potevano acquisire tratti più omeno spiccata-menteimprenditoriali.Così,nellazonaprincipaleeraravvisabileunaclassediproprietaricoltivatori«chehailvantodipossederelemiglioritenutedellodigianoe,riccageneralmentedicapitali,saepuòcondurlialmassimodiproduttività».Affattodiversadovevaesserelasituazionenellazonaasciut-ta, caratterizzata da appezzamenti diminore estensione, dove avevamag-giordiffusioneunaclassedipiccoliproprietariche«lavoranoilterrenodasé, o coll’aiuto di qualche giornaliero, ed appartengono piuttosto alla cate-goriadeiproprietari-contadini»20.Adognimodo,quest’ultimacategoriadiproprietari–criticatadalBellinzonaperlasuamancanzadiistruzioneedicapitalichelicondannavaadun’agricolturadisussistenza–avevaunpesotutto sommato relativo, proprio per il fatto di concentrarsi essenzialmentenellaparteasciutta,cheoccupavamenodidueottavidell’interoterritorio.Un’altra tipologia di proprietari era data dai comuni, opere pie ed altri
corpimorali.Mentreiprimiavevanodisponibilitàfondiarietrascurabili,leoperepieassommavanounpatrimonioditerrecheraggiungevaundecimo(circa8.000ettari)dituttalaproprietàfondiariadelLodigiano.Danotare,a tal proposito, il peso assunto da enti della vicinaMilano, come l’Ospe-daleMaggiore,chedasolapossedevanelcircondario terreniperoltre tre-milaettari (controuna stimadi2.510ettari controllatidalleoperepiedelcircondario)21.I rapporti di proprietà così descritti non spiegano però del tutto le ba-
sisucuipoggiaval’agricolturalocale.Perfarciò,ènecessarioinfattiintro-durrelafiguradell’affittuario,chepuòessereconsideratosottocertiaspet-tiilmaggioreelementopropulsivodell’economialodigiana.Atalpropositosideveconsiderareche,versolametàdell’Ottocento,soloduequintidellasuperficie fondiariadelcircondarioeranodiproprietàdi lodigiani,mentrequasi tutti lodigianieranoiconduttoriequindiproprioaquestiultimioc-correguardaredipreferenzaquandosivogliafareemergerelacomponen-te sociale più dinamica su base locale22. Il resto dei possedimenti terrieri
20.Ivi,p.303.21. Il censimento del 1861 sugli enti di beneficenzametteva in luce come la proprie-
tàdeglientimoralifosseparticolarmentediffusainLombardia:oltrealcasodiLodicita-toneltesto,illoropossessofondiarioeramoltoestesoanchenelCremoneseederapreva-lentenellaprovinciadiPavia.P.Castiglioni,Opere pie, in L’Italia economica,Roma,1873,cit. in M. Malatesta, I signori della terra. L’organizzazione degli interessi agrari padani (1860-1914),Milano,1989,p.107.
22.C.Vignati,Lodi e il suo territorio,Milano,1860,pp.101-102.G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento,cit.,pp.15-16.
150
era,secondoilVignati,nellemanidifamigliemilanesi,ilcheappared’al-traparte coerente con il carattere sostanzialmente locale checaratterizza-vaalloraicircuitidelmercatofondiario:«Sicompravaesivendevalaterracheeravicinaalluogodiresidenza,chesipotevaraggiungereconunviag-giorelativamentebreveenontroppodisagevole,cheeraaportatadimanoepotevaessere facilmentecontrollata»23.Nonsorprende,quindi,che tra il1871eil1881leterrediproprietàdeimilanesitrasmesseinereditàfosserosituateperil90%inLombardia,dicuiil25%nellabassapianurairriguaeil75%nellazonadellagelsibachicoltura24.Maanche considerando chi, tra i proprietari, era effettivamente lodi-
giano,ilVignatichiamavaincausagliaffittuari,senonaltropermette-reinrisaltounlegamediorigine:«Piùdi20famiglie,chemezzosecolofa,eranoumilifittaiuoli,orahannoestesipossedimenti;anzifra ifittai-uoli sidevonocercare ipiù ricchidelLodigiano»25. Spesso tali acquisti erano avvenuti all’epoca delle guerre napoleoniche e in seguito nel pe-riodo risorgimentale.Molte di queste famiglie, una volta divenute pos-sidenti, si trasferirono in città e i loro discendenti passarono non di ra-do all’esercizio delle libere professioni, portando così a compimento iltipicociclodi“innalzamentosociale”dellefamiglielodigianetraOttoeNovecento26. La rilevanza dell’affittuario scaturiva dal fatto che, nel Lodigiano, la
conduzione in economiadi poderi dimedieograndidimensionidapartedelproprietariononcostituivacertamenteilcasopiùfrequente.Ciòerave-rononsolo,evidentemente,peripossedimentideglientimorali,maanche
23. A.M. Banti, Storia della borghesia italiana…,cit.,p.70.Èinteressantenotarelare-azione dei Milanesi alle richieste avanzate dai Lodigiani al governo per la ricostituzio-ne inprovinciaautonomadiLodi (nel1859 laprovinciadiLodieCremaerastata infattisoppressa,conl’accorpamentodiLodinellaprovinciadiMilano):«Talirichiesterimaseroinascoltateperl’opposizionedellaclassedirigentemilanese–nobilieborghesiproprietaridigranditenuteagricoletraAddaeLambro–cuidiedevoceilconteCesareGiuliniDellaPortaaffermandosprezzantementecheilterritoriolodigianoerapossedimentodeiMilane-si». E. Ongaro, Il contesto storico-sociale di Lodi dall’Unità d’Italia ai primi anni del No-vecento,inAa.Vv.,Lodi e la Banca Popolare. 1864-1914 Gli anni di Tiziano Zalli, Azzano SanPaolo(Bg),2009,p.11.
24. A.M. Banti, Storia della borghesia italiana…,cit.,p.71.L’autorecita,aquesto ri-guardo,illavorodiS.Licini,Milano nell’800: élites e patrimoni,s.l.,1994,pp.7-8.
25.C.Vignati,Lodi e il suo territorio,Milano,1860,pp.101-102.26. Aa.Vv., La Banca mutua popolare agricola di Lodi nel primo centenario. 1864-
1964,Milano,1964,p.17.Nel1857,a frontediunapopolazionedi circa20milaabitan-ti,l’altaemediaborghesiadellacittàdiLodiammontavaapochecentinaiadipersone:462possessoridicase,122possessoridifondi,96procuratorilegalienotai.G.Pirovano,Rap-porto statistico per l’anno 1857 della Camera di Commercio e Industria di Lodi, Lodi,1858, cit. in E. Ongaro, Il contesto storico-sociale di Lodi…,cit.,pp.11-12.
151
perquellidimoltiproprietari,periquali latendenzaadaffittareeratantopiù accentuata quanto più estesa era la proprietà e quanto più distante que-staeradaigrossicentriabitati.Sequindi invicinanzadiLodieCodognomoltipoderieranocondottidaiproprietari,altroveciòavvenivaquasisolodoveaffittuari arricchiti avevanodi recente acquistato terreni.L’eccezioneeradatadallazonadiS.Colombano,dovequasitutteleterreeranocondot-te direttamente dal proprietario (ma in tal caso si trattava di quel piccoloproprietariocontadinodicuisièscrittopocosopra),e inpartedallazonadelPo.Complessivamente,ilrapportotraaffittoeconduzioneineconomiaerafortementesbilanciatoafavoredellaprimaopzione,laqualeinteressavacircaitrequartidelcircondario.AncoraneiprimidecennidelNovecento,lasituazionenoneramutatadimolto(tab.2).
Tab. 2 - Forme di conduzione nel Lodigiano (1931)27
Classi Proprietà imprenditrice
Affittanza Altre forme Superficie complessiva
Ha % Ha % Ha % Ha %
< 3 ha 784 5,7 847 2,6 187 7,7 1.818 3,73-10ha 915 6,6 1.330 4,0 374 15,3 2.619 5,310-20ha 878 6,3 2.164 6,6 275 11,3 3.316 6,720-50ha 3.258 23,5 7.849 23,8 562 23,0 11.671 23,750-100ha 5.159 37,2 11.446 34,7 366 15,0 16.972 34,4100-200ha 2.346 16,9 8.675 26,3 677 27,7 11.698 23,7>200ha 515 3,7 658 2,0 – – 1.174 2,4Totale 13.855 100,0 32.969 100,0 2.441 100,0 49.268 100,0
La forza sociale ed economica dell’affittuario può essere agevolmentecompresasecisirifàadalcunicalcolieffettuatidalBellinzonasulcapitalefinanziario cheessidovevanopossederenel casogeneraledella conduzio-nediunpoderedimediaestensione(circacentoettari),conannessocasei-ficio,sullabasedidatichepotevanoapplicarsiagranpartedelLodigiano(tab.3).
27. Aa.Vv., Il grande canale Muzza…, cit., pp. 301-302; tabella riportata anche in G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento, cit., p. 11.
152
Tab. 3 - Capitale necessario ad un affittuario di un fondo medio con annesso caseificio (1882, dati in lire)28
1. Fondo per tasse di contratto, spese di consegna e fondo di cassa “perimprevedute”
3.600
2.Canoneanticipatopercauzione 24.0003.Anticipazionedispeseincontofitto 3.0004.Scortedigeneri:fieno,granoecc. 20.0005.Attrezzidalavoro 5.0006.Cavalli,n.9paia 7.2007.N.70vacchedalatte 36.0008.Maialiannessialcaseificio 8009.Attrezziperilcaseificio 3.000Totale 103.000
L’importo totale esprime un fabbisogno finanziario pari ad oltre 4,2volte il canone annuo d’affitto, calcolato assumendo un fondo di fertili-tà media e di normale stato di manutenzione29. Cifre che giustificano leconclusioni dell’estensore dell’inchiesta e che danno ragione dell’assolu-tacentralitàdell’affittuarionegliequilibridiunterritoriocaratterizzatodaun’agricolturaditipointensivo:
Lesommedicuidevonodisporregliaffittuaridannogiàunprimoconcettodel-laimportanzadellorocetonelterritoriolodigiano.Essendo[…]ifondipiùestesicondottiquasituttidaaffittuari,sipuòarguirequasisubitoquantefortuneimpor-tanti debbono essere sparse nelle campagne lodigiane tra gli affittuari. Un ter-zoquasidelvaloredel fondodeveesseredispostodalconduttore;qualchescortamaggiore,qualcheguadagno,edessositrovaconfacilitàpossederecapitalicorri-spondentialvaloredelfondoaffittatogli.
Eprosegueponendosignificativamente inrelazionegliaffittuariaipro-prietari, con i primi che sembrano aver ormai acquisito una funzione so-cio-economica che tende quasi a sovrapporsi a quella dei secondi, dandoluogoaduna identificazione anche semantica che si concretizzavanel ter-mine“fittabile”:
28.Lasommatotaleè inrealtàL.102.600.G.Bellinzona,Il circondario di Lodi, cit., p. 322.
29.Soloperfarsiun’ideadimassimadell’entitàdellasomma,tenutoanchecontodellaparzialeattendibilitàdellafontefiscale,siconsidericheilredditomediodiricchezzamo-bilecat.BdeicontribuentidellaProvinciadiMilano iscrittinei ruoliprincipalidel1889(conunredditoimponibilesuperioreaL.10.000),erapariaL.28.974.MinisterodelleFi-nanze.Direzionegeneraledelleimpostediretteedelcatasto, Elenco dei contribuenti pri-vati delle categorie B e C inscritti nei ruoli principali 1889 per un reddito imponibile di lire 10,000 o più,Roma,1889.
153
L’importanzadegliaffittuarinellavitadelnostro territorio, la loropotenzafinan-ziaria,illoroguadagnopersonale,liparificanoaiproprietari,coiqualisonoinfat-ticonfusisotto ilnomedifittabile;nomechesullanostrapiazzacorrispondepiùadagricoltorecheadaffittuario.[…]Ilcetodegliaffittuariedeiproprietaricolti-vatorièquelloanchecheporta,nellacittàdiLodieneiborghiimportantidelcir-condario,commercioelavoro.Icommercianti,iprofessionisti,imediatori,gliuo-minid’affari traggono le loro risorsepiùchealtrodallacircostantecampagna. Ilfittabiledeveconsiderarsicomeilverorappresentantedell’agricolturanell’agrolo-digiano.[…]Siaononsiaproprietariodelsuolo,ilfittabilenelsensonostro,ossiail conduttorediun fondo, esercitauna importante funzione economica e sociale.Egliè,piùcheuncoltivatore,unindustrialeverocheapplicaintelligenzaecapitaliafarvalereleattitudinidelsuolo,asvilupparle,acrearle30.
Gli affittuari erano considerati, insomma, veri e propri capitalisti indu-striali, la cui attività esigeva ladisponibilitàdi ingenti capitali.Essi eranoal centro delle grandi aziende agrarie della zona irrigua, gestite con criteri produttivistici,eguardandoaloroCattaneoeJacinieranogiuntiaparago-narel’irriguolombardoalsistemaagricoloinglesedell’high farming31.Nonmancavanopoi, tra le famigliepiùagiate,membri cheaccedevanoaigra-dipiùaltidell’istruzioneaccademica(comeingegneriodottoriinlegge,adesempio), sancendo così un percorso di ascesa degli affittuari che dovevariguardarenonsololasferaeconomicamaanchequellasociale32.
3. La rappresentanza degli interessi agricoli
Se tuttavia si passa dal piano dell’influenza economica a quello dellarappresentanzadegli interessi, è quantomai evidente unamarcata separa-zionefralecategoriedeiproprietariequelladegliaffittuari,unacaratteri-sticaquestacheèstatamessainluceperl’interaareapadana33.Nelventen-nio post-unitario, l’agricoltura lombarda attraversò una congiuntura assai
30.G.Bellinzona,Il circondario di Lodi,cit.,pp.323-324.31.C.Cattaneo,Dell’agricoltura inglese paragonata alla nostra[1857],orainId.,Sag-
gi di economia rurale,acuradiL.Einaudi,Torino,1939;S.Jacini,La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia,Milano-Verona,1857;M.Malatesta,I signori del-la terra,cit.,pp.99-100,109-110,114;L.Faccini,Affitto in denaro e salari in natura. Le contraddizioni apparenti dell’agricoltura lombarda (secoli XVII-XIX), in Storia d’Italia, Annali 6,Torino,1983,p.652.LadiversainterpretazionefornitadaJacinieCattaneocircairapportitraproprietariedaffittuarièripropostainR.K.Greenfield,Economia e liberali-smo nel Risorgimento…, cit.
32.G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento,cit.,pp.15-16.33. Per una ricostruzione circostanziata del rapporto tra questi due gruppi sociali e del-
lerispettiveorganizzazionidirappresentanzacreatetral’unitàalaprimaguerramondiale,sivedaM.Malatesta,I signori della terra, cit.
154
positiva, nel corsodellaquale la crescitadella rendita–perviadiunau-mento tendenzialedeicanonidiaffitto– fuaccompagnatadaunaumentodeiprofittiagricoli. Inquesto frangente, lafiguradell’affittuario-imprendi-tore trovòunmaggiorespaziodiaffermazione,accrescendo ilpropriopo-tereeconomicoelapropriainfluenzapolitica.Nonerainveceancoramuta-talapercezionecheiproprietariavevanodisestessi«comepernoemetrodivalutazionedeirapportisociali»34. Inquestosenso,persinoinunconte-stodiagricolturacapitalisticaqualeraquellochecaratterizzavalaLombar-diapost-unitaria, l’affermazionedegliaffittuaricomecetomedioallabasedello sviluppoagricolo regionale trovavaunostacolodifficilmente supera-bilenell’influenzaancoradominanteesercitatadallarenditafondiaria.Tale divario aveva poi una diretta manifestazione nella struttura inter-
nadeicomiziagrari,ossiadiquell’istituzionechedovevaesprimerelarap-presentanza locale dell’agricoltura e che lo stato unitario aveva concepitocomestrumentodi saldaturadegli interessi territoriali conquelli naziona-li, sottoponendola al controllo prefettizio35. Il fattoèche icomizinonriu-scironomaiacoagulareintornoasélediversecategorieeconomichecoin-volte nel settore agricolo,ma si risolsero in una partecipazione pressochéesclusivadellaproprietàfondiaria,mentregliaffittuari–comedelrestoeamaggiorragioneimezzadrieibraccianti–nellamaggiorpartedeicasinerimaseroesclusieancheladdoveriuscironoafarneparte(comeaBolognaeaTorinonell’Ottocento,oaPaviaeLodineiprimiannidelNovecento)nonriuscironomai,nellezonedelgrandeaffitto,adesercitareun’influenzasostanziale. Lapoliticadellostatoneiriguardidell’agricolturamiravaquindiadevi-
tareche«le istituzionidecentratediventassero […] luoghidicooperazioneinterclassista anche se sottoposti al controllo dei proprietari terrieri». I ri-schidiquestastrategiasisarebberomanifestatiperòconmaggioreeviden-zanegli anni a venire, così dapoter sostenere che«l’assenza, nel periodopost-unitario,diunareterappresentativo-associativastabilechefavorisselapartecipazione degli affittuari, se non dei coloni, al governo locale dell’a-gricoltura, fu forse uno deimotivi per i quali la questione agraria si pre-
34.Ministero diAgricoltura, industria e commercio (Maic),Notizie intorno alle con-dizioni dell’agricoltura negli anni 1878-1879,vol.III,Roma,1882;Id.,Notizie intorno al-le condizioni dell’agricoltura. Variazione del fitto dei terreni,Roma,1886;M.Malatesta,I signori della terra,cit.,pp.114-115;M.Romani,Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961),cit.,p.46.
35.Icomiziagrariufficiali, istituiticondecretoleggedel23dicembre1866dalgover-noRicasoli,eranoassociazionivolontariediproprietari,dipendentidalministerodiAgri-coltura,industriaecommercioedalprefetto.Essifinironoperaffiancarsiinparteallepre-esistenti società o accademie agrarie.A.M.Banti,Storia della borghesia italiana…, cit., pp.83-85.
155
sentòneidecenniseguenticomeunoscontrodirettotraleclassi,senzacheesistesseroprecedentementestrutturedimediazionedelconflitto»36.NelMilanese, nonostante la tutela statale, i comitati direttivi dei comi-
zi restaronoformatidaisocichedetenevanopossedimentinellaprovincia.Nel Lodigiano questo comportò, all’indomani dell’unificazione nazionale,unamonopolizzazionedel locale comiziodapartedeiproprietarimilane-si,mentregli affittuari continuavanoa rimanerneesclusi.Eraun’istituzio-ne, quella del comizio, che di conseguenza poteva contare su un numeroristretto di soci, considerata la forte concentrazione del possesso fondia-rionellaLombardia irrigua(nellezonecollinoseemontanesiaveva inve-ceunapresenzanumericamentepiùconsistentedisoci,perviadelmaggiorfrazionamentodellaproprietà). Ineffetti,nel triennio1885-86-87,Lodire-gistravaunamediadi68soci,PaviaeMortaradi46;Cremona,conisuoi318sociinmedia,eral’unicaeccezione.Una base sociale generalmente ristretta, dunque, che poneva problemi
ancheperilsostegnofinanziariodelcomiziostesso,ilqualedovevaconta-resullequotedeisociesuicontributideglientipubblici.NelcasodiLodi,un ruolo importante fu giocato daSecondoCremonesi, personaggio chia-ve nell’ambiente locale del secondoOttocento, grande possidente di terrein provincia di Bergamo, consigliere comunale e deputato di Lodi,mem-bro della Società agraria di Lombardia e del consiglio di amministrazio-ne dell’Ospedalemaggiore di Lodi, nonché presidente del locale comiziopertrent’anni.Ilsuoimpegnoeisuoilegamiconlaproprietàfondiariariu-scironoadassicurarealcomiziounfinanziamentocostante,«grazieaicon-tributidellaSocietàagraria,deglientilocaliedeicorpimoralicheaLodi–comenellealtreprovincieincuipredominavailpossessofondiariodegliistitutidibeneficenza–eranoanch’essisocidelcomizio»37.Quello che più risaltava era tuttavia il disinteresse della possidenza nei
confronti del governo localedell’agricoltura edella formula rappresentati-va di stato incarnata nei comizi. E soprattutto traspariva una frammenta-rietàdifondodelleéliteagrariepadane,diversetralorocomeloeranoglisvariaticontestisocio-economicilocaliincuioperavano.Essenonperven-neroaformestabilieduraturedirappresentanza:laLegadidifesaagraria,fondataaTorinonel1885,fusìcapacediesprimereunapropriarappresen-
36.M.Malatesta,I signori della terra, cit., p. 74.37. Ivi, p. 71. SecondoCremonesi fu anche tra i promotori di diverse iniziative indu-
striali, come ilLanificioCremonesi,VaresieC.e laSocietà lodigiana lavori incemento,efusociofondatoredellaPirellidiMilano.Perunosuoprofilobiografico,A.Stroppa,Gli amministratori del Comune di Lodi dal Regno alla Repubblica, inG.Bigatti (a curadi),Il Municipio e la città. Il Consiglio comunale di Lodi (1859-1970),Milano,2005,pp.281-282.
156
tanzaparlamentareperottenerel’introduzionedellatariffadoganaleprote-zionisticadel1887,maunavoltaraggiuntol’obiettivocessòdiesistere.Nonsidiedevita,dunque,adunpartitoagrario,neppurequando,agli inizidelNovecento, furono create l’Interprovinciale e laConfederazione nazionaleagraria, organizzazioni degli agrari padani sorte con finalità antisindacaliinrispostaaldiffondersidelmovimentobracciantile.Maleéliteagrarie,sesi tennerolontanedaformerappresentativeconsolidatesulversantepoliti-co,ebberonondimenosuccessonelcreareun’associazionetecnicatutt’altrochemarginale sotto il profilo economico, laFederconsorzi, fondata aPia-cenzanel1892,pochiannidopol’esaurirsidell’esperienzadellaLegadidi-fesa agraria38.Diverso era il caso degli affittuari. Il calo dei prezzi indotto dalla cri-
si agraria nella primametà degli anni ottanta aveva posto questa catego-ria nella difficile situazione di dover far fronte, nella nuova congiunturadepressiva,acontrattidilocazioneparticolarmenteonerosiinquantostipu-lati inanniprecedentidielevatiprezziagricoli39.Fudunquequello ilmo-mento per gli affittuari di darsi un’organizzazione sindacale con lo sco-podiottenereunariduzionedeicanoni,epiùingeneraleperaffermare,incontrapposizioneaiproprietari,unapropriaautonomalegittimazioneall’in-ternodelsistemafondiariopadano.Riduzionedegliaffittiche,sebbenenongeneralizzata in tutta la Valle Padana, nel Milanese irriguo puntualmen-tesiverificòalrinnovodellamaggiorpartedeicontratti,nelnovembredel1884,cosìcomemessoinevidenza(adesempioperLodieCasalpusterlen-go)conriferimentoalleoperepie, lecuiamministrazioni furonocostrettearivederegliaffittisensibilmentealribasso40. Larichiestadiunriallineamentodeicanoniaiprezzideiprodottiagrico-
liandavapoiacombinarsiconistanzeancorpiùsostanziali,volteamodifi-carelastessastrutturadeicontrattiinparticolareperquantoriguardavauna
38. A.M. Banti, Storia della borghesia italiana…,cit.,pp.86-96;Id.,Gli agrari padani. Problemi di analisi e ipotesi di interpretazione, inS.AdornoeC.Sorba(acuradi),Mu-nicipalità e borghesie padane tra Ottocento e Novecento. Alcuni casi di studio, Milano, 1991,pp.117-121.SullaFederconsorzisiveda,adesempio,A.Ventura,La Federconsorzi dall’età liberale al fascismo: ascesa e capitolazione della borghesia agraria, 1892-1932, in«Quadernistorici»,n.36,1977.
39.IldirettoredellasuccursalediLodidellaBancanazionalenelRegnocosìdescrive-va la congiuntura economica ancora nel 1887: «I vari prodotti del suolo nel 1887 furonopiuttostoabbondantiediottimaqualitàmailbassoprezzodeimedesiminonrimuneral’a-gricolturadellesuefaticheecapitalicheviimpiega.Diconseguenzaavviilgiàlamentatoarretramento[?]nellaclassedeifittabili,qualepoisiripercuotesuiproprietarideifondi».Archivio storicodellaBancad’Italia (Asbi),Segretariato,pratt., n.367, fasc.1,RelazionedelDirettoredellaSuccursalediLodiall’eserciziodell’anno1887.
40.PeririferimentiarchivisticisirimandaaM.Malatesta,I signori della terra, cit., p. 165(nota174).
157
maggioreautonomianellagestionedeifondi.Lacrisiagrariaavevaresoor-mai inderogabile lanecessitàdiunagestionepiùflessibiledella terra, conminorivincoliainuovi investimenti,masuquestopunto,piùchesuquel-lodellariduzionedeicanoni,gliaffittuaridovetteroscontrarsicontrolere-sistenzedellaproprietà.Difattoquest’ultima,neicapitolatidiaffitto,sotto-poneval’iniziativa imprenditorialeaduncontrollocontinuativo,ricorrendoallostrumentodegliindennizzidellemigliorie.Unaspetto,questo,dicuièstata sottolineata la centralità per l’affermazionedella grande impresa pa-dananell’Italialiberale41.Ilrischiosopportatodall’affittuariodinonveder-si riconosciuti (equindicompensati),allascadenzadelcontratto, imiglio-ramentieventualmenteapportatialfondomedianteinvestimentidicapitalitalvolta rilevanti, qualora non esplicitamente autorizzati dal proprietario,costituivainfattiunlimiteoggettivoalliberoeserciziodell’attivitàprodutti-va,adesempioperadattarelecoltivazioniinrelazionealmercato.L’atteg-giamento dei proprietari era, nel complesso, quello di evitare grosse spe-sedapartedegliaffittuari,propriopernonincorrereinindennizzionerosiall’attodellariconsegnadelfondounavoltascadutalalocazione.Tali contrasti affiorarono con particolare evidenza nell’area chiave
dell’affitto lombardo, vale a dire il Lodigiano, dove i conduttori già nel1868erano riusciti a suscitareunadiscussioneall’internodel localecomi-zioagrariosullaquestionedelcontrattodilocazione,conilcoinvolgimentoanchedelCollegiodegliingegneriedegliarchitettidiMilano.Lasoluzio-nedelproblema,tuttavia,eratutt’altrocheaportatadimanoerimasean-chenei decenni successivi al centro delle rivendicazione degli affittuari, iquali entrarono in contrapposizione con i proprietari solo in quelle aree in cuipiùaffermataeralagrandeconduzionecapitalistica.Il crescente peso economico degli affittuari nel ventennio post-unitario
fuaccompagnato,negliannisettanta,dallaformazionediunapropriarap-presentanzaparlamentare.Traideputatielettiadifesadegliinteressidegliaffittuari, unaposizionediprimopiano fuoccupatadaFrancescoCagno-la, avvocato e possidente di Lodi, dove eramembro del comizio agrario.Sindacodiquestocomunedal1872al1878,daquell’anno fuelettodepu-tatopiùvolte(l’ultimanel1890),esenatorenel190142. Già presenti quindi sulfrontepoliticonazionale,gliaffittuari furonoindottidallacrisiagrariaa dare una veste associativa alla tutela dei propri interessi anche a livelloperiferico.Nacque così nel 1883, aMelegnano, l’Associazione italiana deiconduttoridifondi,un’organizzazioneoriginariamentedisoliaffittuaricheintroducevaunelementodinovitànelconfrontoconlaproprietàfondiaria:
41.Ivi,p.109.42. A. Stroppa, Gli amministratori del Comune di Lodi dal Regno alla Repubblica, cit.,
pp.272-273.
158
essa rappresentava«una formacompletamentenuova all’internodel pano-rama delle rappresentanze dell’agricoltura, ancora dominato dai comizi edallesocietàagrarie»,epotevaessereconsiderata«ilprimoesempioitalia-no di un gruppo di interesse, all’interno del quale l’organizzazione econo-micaeraunitaallarappresentanzacategoriale»43.L’associazione era suddivisa in sezioni e nel Lodigiano era presente a
Lodi,CodognoeCasalpusterlengo.All’internodiessa,l’influenzaesercita-tadaquestazonadigrandeaffittoerasenzadubbio tra lemaggiori.BastipensarecheiverticidelladirezioneprovenivanodallazonatraLodieMe-legnano,oppurechenel1885,afrontediunnumerodisocisalitoa1.453membri (con un capitale di circa 101milioni e 150.000 ettari di terrenocoltivato),lasezionediLodicontava325associati,secondasolaaquelladiMilanocheneaveva421.Eanchequandol’associazionefuestesanel1884ai proprietari conduttori – scelta strategica per tenere compattato la cate-goria dei fittavoli e non perdere quelle sezioni, comeNovara, che aveva-nooptatoperlaformulamista–lacomponentepiùfortecontinuòadesse-requelladegliaffittuaridellaprovinciamilanese:l’improntaspiccatamentecategoriale della loro politica sarebbe pienamente riemersa agli inizi delnuovosecoloinoccasionedelrinnovarsidelconfrontoconiproprietari inmateriacontrattuale.Le iniziali richieste da parte dell’Associazione di una diminuzione dei
canoni e di una contestuale revisione dei contratti locali nel senso di unrafforzamento degli affittuari, si inquadravano all’interno di un atteggia-mentoprofondamente liberista,cheescludeva il ricorsoallostrumentoda-ziariopersostenereiprezziericondurliadunlivellopiùequilibratorispet-to agli affitti.Ma l’accoglimento solo parziale delle loro istanze spinse, apartire dal 1885, una grossa parte di essi a spostarsi su posizioni protezio-nistiche, consentendo una ricomposizione dei loro interessi e di quelli deiproprietari che sarebbe proseguita, in nome della difesa della produzione,finoall’etàgiolittiana.D’altraparte, l’incapacitàdimostratadagliaffittuarinellungoperiododi
far frontecomuneadifesadeipropri interessi incontrapposizioneaquellideiproprietari, sembra trovasseuna riprovanella fallita esperienzadell’U-nione delle banche confederate. Ambizioso tentativo di rendere autonomalacategoriadeifittavolianchesotto ilprofilofinanziario,essaavrebbedo-vuto operare a vantaggio dei grandi imprenditori agricoli, fornendo loro icapitali necessari agli investimenti fondiari piuttosto che i capitali di eser-cizio.L’UnionefufortementevolutaepromossadaFrancescoCagnola,al-loradeputatoe convinto sostenitoredelle ragionidegli affittuari, il che la-
43. M. Malatesta, I signori della terra, cit., p. 178.
159
sciavaintravvedereunruolodiprimopianosvoltonellavicendadalgruppolodigiano.Tuttavia,lastessastrutturafederativaprevistaperquestoorgani-smo,checomportavalacreazionediunabancainogniprovinciadovefos-seropresentigrandiaffittuari (con l’istitutocentraleche,nonacaso,dove-vaaveresedeaLodi),eraprobabilmenteilsegnodiunfrazionamentodellacategoriacheavrebbeallafineimpeditodiportareacompimentoilproget-to.Legalmentecostituitanel1887,dopoannidipropaganda, l’Unionenonriuscìariscuoteretragliaffittuariilsostegnonecessario–ancheperchéeraproprioinqueltornoditempochesistavaabbandonandolalogicadirigidaopposizioneallaproprietàfondiaria–egiànel1889fudichiaratasciolta.Nel frattempo, le aspirazioni a creare un’organizzazione degli affittua-
ri su scalanazionale erano statebenpresto accantonate, dalmomento chel’Associazioneitalianalasciòspazioadunapiùcircoscritta–macherispec-chiava la reale influenza del gruppo lombardo – Associazione degli agri-coltori lombardi, sorta nel 189044.Quest’ultima sanciva il riavvicinamentodeiproprietariedegliaffittuari,lecuirispettiveposizionisieranoincontra-tenellacomuneadesioneallapoliticaprotezionistica.Sispiegacosìlacom-presenza all’interno di essa di esponenti di spicco della possidenza quali SecondoCremonesiedi rappresentantidell’alapiù radicaledellacategoriadeifittavoli,comeGiuseppeMoro,chevenivadallefiladell’AssociazionediMelegnano–dicuierastatovice-presidentenel1883–echeavrebberico-perto la stessacaricanel1899 inquelladegliagricoltori lombardi,perpoipresiederetrail1902eil1905ilConsorziodeifittabililodigiani.Tale equilibrio avrebbe peraltromanifestato tutta la sua fragilità al so-
praggiungere di una nuova ondata di instabilità che interessò l’agricolturaitalianaagliinizidelNovecento,quandoacrearemotividitensionenonfu-ronopiùleoscillazionideiprezziquantopiuttostolerivendicazionisalaria-lideilavoratoriagricoli.Difronteapressionicherischiavanodiminacciaresia ilprofitto imprenditorialesia la rendita fondiaria, le reazionidegliaffit-tuari inareapadananon furonouniformi.Se l’atteggiamentoprevalente fuquellodicontinuarenelladifesacomunedegliinteressiinsiemeallaproprie-tà (questa volta contro il fronte dei lavoratori), appianando i contrasti sul-larevisionedeicontrattidilocazione,laddoveilgruppodeigrandiaffittuariavevaacquistatomaggioreforzaecompattezzasiritornòadunastrategiadicontrapposizionecheportòallacostituzionediassociazionidisolifittavoli,tentandodiscaricaresuiproprietaripartedeglioneriderivantidagliaumen-ti salariali.Questomovimentoper la riforma contrattuale si condensò, co-
44.SiaccogliequiladatazionefornitadaM.Malatesta(ivi,p.222).Undiversoannodicostituzione, il 1886, è invece fornitodaF.Rovelli,Die Agrarverfassung der Niederlom-bardei mit besonderer Berücksichtigung der Landarbeiter,Karlsruhei.B.,1908;M.Roma-ni, Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961), cit., p. 79.
160
medurantelacrisiagraria,inalcunezonedellaLombardiadovedominavailgrandeaffittoe lasuadirezione rimanevaancorasotto ilcontrollodiunristrettogruppolocalizzatonelLodigiano:diessocontinuavanoafarpartealcunidiquelli–comeilgiàcitatoMoro–cheinprecedenzaavevanogiàoccupatoposizionidiverticenell’Associazionedeiconduttoridifondi.IlConsorziodeifittabililodigiani,creatonel1902,ful’unicaorganizza-
zionedurevole ediqualchepeso tra le associazionipure che raccoglieva-no esclusivamente affittuari, escludendo pertanto tutte le tipologie di pro-prietari, sia che fossero conduttori o semplici percettori di rendita.Volereincludereunaoentrambediquesteultimecategorie–ossiailmodellopiùdiffuso in area padana – avrebbe inevitabilmente dato vita ad organismiibridiche,secondoigrandifittavolidellazonadiLodi,nonpotevanodav-vero rappresentareconvenientementegli interessi specificidegli imprendi-toriagricoli.Nonèprivodisignificato,aquestoriguardo,cheilprogressi-vorafforzamentodiquestiultimiandassediparipassoconlaconquistadiunpropriospazioall’internodelcomiziolocale(vipreseroparteattivarap-presentantidegliaffittuariqualiSiroFerrari,GiuseppeMoroeLuigiRos-si),andandoascardinareil tradizionalemonopoliochelaproprietàeserci-tava al suo interno e favorendo in questomodo l’accoglimento, nel 1902,diunprogettodicapitolatod’affittocherecepiva,almenoinparte,leistan-zedeiconduttori. IlcasodiLodièdunqueparticolarmenteindicativodel-laforzadeifittavoliinquellapartediLombardia,maaltempostessononègeneralizzabileall’interocircondario.Ineffetti,nelleareedell’irriguodovesisegnalavaunadiscretapresenzadiproprietariconduttorisidiffusepiut-tosto un tipo di associazione che riuniva questi ultimi insieme agli affit-tuari.Questo fu ilcasodiCodogno,doveperò–adifferenzadell’analogaesperienza cremonese, dove a risultare dominanti erano comunque gli in-teressidegliaffittuari–ilprevaleredellacomponenteproprietariaprovocòripetutiscontriconilConsorziolodigiano.
4. Un modello d’industrializzazione dipendente
Ilpesodell’agricolturaall’internodelsistematerritorialelodigiano,con-giunto al lento e sporadico formarsi di iniziative industriali, concentratesiper lopiùnelcampodella lavorazioneedellosmerciodeiprodottiprima-ri, è stato da alcuni indicato come la controprova di una perdurante iner-zia che avrebbe contraddistinto gli ambienti economici locali, responsabi-lidinonaverintrapresoconmaggiorconvinzioneattivitàdiampiorespironell’ambito dellamanifattura, del commercio e della finanza45. Tale lettu-
45. A. De Maddalena, Appunti sull’economia lodigiana nel suo profilo storico, cit., p. 11.
161
raandrebbealmenoinparterivista,nonpotendosisostenerecheil tessutoeconomico locale non fosse stato interessato da unamodernizzazione an-che in senso industriale. Certamente, non si deve neppure incorrere nel rischio opposto di da-
reeccessivopesoadalcunesingoleesperienzeconintentiquasicelebrativi,iqualisiscontrerebbero inevitabilmenteconunarealtà fattadiungruppoeconomicoprevalente–quellodeigrandi affittuari – che, purmostrando-sialquantocombattivosulfrontedellerichiestediriformecontrattualiperfavorire l’ammodernamentodell’impresaagrariacapitalistica,nonriuscìdifatto ad avere lameglio sulla tendenza, di gran lunga dominante in areapadana, a trovareuncompromessocon il bloccoproprietario.Edè altret-tantoverochelacrisiagrariadifinesecoloavevadatoluogoarispostedi-versificateall’internodellospaziolombardo,asecondachesitrattassedellaparteasciutta–chericevetteunmaggioreimpulsoadunosviluppoinchia-ve industriale–ovverodell’irriguo–dove invecesigiunseadunconsoli-damento delle strutture agricole tradizionali e ad un loro perfezionamen-toattraversolasollecitazionedialcunispecificiramidiattivitàindustrialeecommerciale,comefuevidentenel settore lattiero-caseario.Lastatisticaindustrialedel1892segnalavachiaramentequestatendenzaconriferimentoallediversepartidellaprovinciamilanese, laddoveicircondaridiMilano,MonzaeGallaratefacevanoregistrareunaconcentrazionediattivitàmani-fatturieremoltomaggiorerispettoaquellidiLodieAbbiategrasso46. D’altraparte,sesiguardapiùingeneraleallaconfigurazioneurbanadel
territorio regionale, non pare proprio possibile trascurare la forza di attra-zioneesercitatadaunpoloindustriale,commercialeefinanziariocomeMi-lano,unveroepropriocentrodiaggregazionedivecchieenuove impren-ditorialità, come ampiamente testimoniato dal «trasferimento, oltre chedelladitta,anchedellaresidenzapersonaledimoltiuominid’affaricheave-vano iniziato la propria carriera nel Comasco, nel Bustese o in altre areelombarde»47. Fonti dirette attestano con chiarezza l’esistenza di queste di-namiche, cheandavanoad intaccareprofondamente la stessa strutturapro-duttiva della regione: nella relazione sull’esercizio 1885, il direttore del-la succursalediLodidellaBancanazionalenelRegnosottolineavache, se
46.Laprovinciamilanesecontavaallora3.033opificicheimpiegavano142.354addetti:escludendoilcircondariodiMilano,quellidiMonzaeGallarateconcentravano883impre-see62.652dipendenti,controi388e17.602diLodieAbbiategrasso.L.Sabbatini,Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Milano,in«Annalidistatistica»,s.IV,n.65,1893,p.116;M.Romani,Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961), cit., p. 79.
47.S.Licini,Ricchi, ricchezza e sviluppo industriale: la business community milane-se dell’Ottocento, in«Annalidistoriadell’impresa»,n.10,1999,p.538.Sullaforzadiat-trazione“gravitazionale”esercitatadauncentrourbanosull’imprenditorialitàdelterritoriocircostante, sivedaM.Casson,The Economics of Business Culture. Game Theory, Tran-sactions Costs and Economic Performance, Oxford, 1991.
162
i benefici per la bancanon erano stati positivi quanto la favorevole annataperl’agricolturadelcircondarioavevalasciatosperare,lacolpadiciòanda-vaimputataallaconcorrenzaarrecatadallavicinaMilano«conlesuegran-dirisorsefinanziarieeconquelvivofuococheanimabanchieri, industria-liecommercianti».Laconclusioneassumevatonipococonfortanti:«Questamarcia di accentramento, cui molte volte diamo noi stessi poco lodevole esempio[corsivomio]èpiagainsanabile,eseconcostanzaelavorononciadoperiamoaguarirlaneverrannoamiocrederetempipeggioriperquestadegnaCittàanessunasecondanell’attivitàenelleintrapresecommerciali»48. Taleinterpretazionenonapparivanelcomplessotroppodistantedallarealtà,perquantoessarisentissedelpuntodivistadiunabancacheinevitabilmen-tesoffrivadell’incontrastatasuperioritàfinanziariadelcapoluogomilanese.Ciò detto, non sembrameno importante concentrare l’attenzione su un
modellodiindustrializzazionecomequellolodigianochefuinbuonapartedipendentedall’avanzamentodel settoreprimario, e al tempo stessone fusuopromotoreattraversolamodernizzazionedeicanalidiproduzioneedidistribuzione.Avevacosìmododirealizzarsiunsistemaintegratochecon-tinuava a fondarsi sulla lavorazione e commercializzazione del latte e deisuoiderivaticomelevadelrilanciodell’economialocale,colpitadalleflut-tuazionideiprezzinegliannidellacrisiagraria.Unasoluzione,questa,chenondevesorprenderepiùditanto,standoalmenoallerilevazionistatistichechepermettonodiquantificareilpesodelcaseificionelcircondariodiLodirispettoallealtrepartidellaprovinciadiMilano(tab.4).
Tab. 4 - Latterie e caseifici nel Lodigiano e in provincia di Milano – Anni novanta dell’Ottocento49
Circondario Latterie o caseifici Numero degli addetti
Lodi 509 1.234BorghettoLodigiano 25 50Casalpusterlengo 6 20Codogno 13 69Lodi 47 75Sant’AngeloLodigiano 13 39Milano 429 943Abbiategrasso 251 545Gallarate 2 14Monza 6 12Totale 1.201 2.748
48.Asbi,Segretariato,pratt.,n.365,fasc.1,RelazionedelDirettoredellaSuccursalediLodidelleoperazionicompiutenell’anno1885.
49. Maic, Statistica industriale. Lombardia,Roma,1900,pp.380-383.
163
Tale sistemaaltrononera che la risposta conseguente allapresadi co-scienza, da parte dei più attenti conoscitori del settore, delle limitazio-ni connesse alla gestione tradizionale del caseificio, così come si è scrit-topiùsopra.Lasoluzionestava,allora,nelrendereeffettivalaseparazionetra la produzionedel latte e la sua lavorazione, il che, in altri termini, si-gnificava scardinare quell’organizzazione che vedeva la commistione, nel-lo stesso luogo rappresentato dalla cascina, dell’attività agricola e di tra-sformazione50. Il primo tentativo di pervenire a questo risultato fu quellodelle latterie sociali, attraverso cui i produttori conferivano la produzionegiornaliera di latte a un casonegestitodaunoopiù casari e partecipava-noagliutilidellalatteriainproporzionealquantitativodilatteconsegnato.Talemodello,pur ricevendofindaglianni settantadell’Ottocento il soste-gnodelministerodell’Agricoltura, industriaecommercio (Maic),non riu-scìtuttaviaadattecchirenellapianurairriguadovemaggioreeralaprodu-zione di latte. L’obiettivo fu inveceraggiuntograzieall’interventodirettodeicommer-
cianti di formaggi, i quali assunsero una funzione imprenditoriale semprepiùattentaallatodellaproduzione,dapprimadelburroepoianchedeifor-maggi:
Conl’impegnodirettodeinegoziantinellaproduzionedelburroedeiformaggifi-nalmentepotéavvenirequelladivisionedellavorocheilmodellodellelatterieso-cialiproponevainmodoimperfettoecheseparòlaproduzionedellattedallasualavorazione,affermandoilprincipiocheessanoneranecessariasoltantoarendereillattemeglioconservabileetrasportabile,madovevainveceesseredirettaalrag-giungimentodelsuomassimovalorecommerciale51.
In generale, dunque, a rendersi protagonisti della transizione verso ilnuovo paradigma organizzativo non furono tanto i conduttori di fondi,presso iquali l’attivitàdelcaseificiosiera localizzatafinoadallora,ben-sìungruppoemergentedifigureimprenditorialicheavevanolepropriera-dici nell’intermediazione commerciale52. L’incentivo all’ammodernamento
50. Che questa fosse la via da percorrere permodernizzare il caseificio, era sostenu-todaStefanoJacinigiàametàOttocento, ilqualemettevaquindi indiscussione lavisio-neprevalentedichierasolitoattribuireaisolicasarilaresponsabilitàdell’arretratezzadelsettore. S. Jacini, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia: studj economici,Milano-Verona,1856,cit. inG.Bigatti,Dalla “coltura a caci” al caseificio…, cit.,pp.31-32.
51.Vanotato che anchenel sistema tradizionale del caseificio i negozianti di formag-gieranocomunquecoinvoltinellafilieraproduttiva,dalmomentochegestivanolafasefi-nale della stagionatura. F. Mandressi, La nascita del caseificio industriale in Lombardia, cit., p. 579.
52. In realtà, l’affermarsidiun’organizzazione industrialenonandòa sostituirepiena-mente ilprecedentemodello:ancoraneglianniventidelNovecento, lamaggiorpartedei
164
delcaseificiolombardoavevaunadupliceorigine.Daunlato,vieralosti-molooffertodallaforteascesadelladomandaesteradiburroepoidifor-maggi, domanda che esplose soprattutto intorno al 1870: anziché favori-re la crescita del settore così come era tradizionalmente strutturato, essamiseancorapiùanudo i limitidel sistemadiproduzioneabituale,essen-doquesto incapacedigarantire livelliqualitativiaccettabili, specialmenteperpotercompeteresuimercatiinternazionali.Dall’altro,ègiàstatodettocomelacrisiagraria,colpendoconparticolareintensitàlaproduzionegra-naria, quella viticola e quella del gelso, avesse indirettamente contribuitoadincrementarenellezoneirriguelecoltivazioniforaggere53. Furono quin-dil’ultimoventenniodell’Ottocentoeiprimidieciannidelsecolosucces-sivoad imprimereuncambiodipassoalsettore lattiero-caseario. Inque-gli anni la bilancia commerciale diventò positiva, con le esportazioni diformaggichedal1894superaronocostantementeleimportazioni,grazieaprogressiproduttivi chepermiserodi sostituirequesteultime (provenientisoprattuttodallaSvizzera)conprodottichepresentavanocaratteristichesi-milari.FamigliedinegozianticomegliZazzeraeiPolenghisimiseroallatesta,
perlomeno nella bassa pianura irrigua, dell’industrializzazione del caseifi-cio.IlfulcrodiquestetrasformazionifuCodogno,dovedatempoerapre-sentelamaggioreconcentrazionedicommerciantidiburroeformaggidelLodigiano.L’origine commercialedi questefigure imprenditoriali era evi-dentenellaPolenghiLombardo,chesisviluppòapartiredall’attivitàdiduenegozianticodognesi,PietroePaoloPolenghi;essiavviarono l’esportazio-nesulargascaladiburrosoprattuttoversol’Inghilterra,avendointuitoco-megli sbocchi internazionali potessero offrire al caseificio italiano la viapiù immediatadi crescita.L’approvvigionamentodiburroavvenivapressoicasonidellazonadiLodieCodogno,malasuamediocrequalitàconvin-selasocietàadassumere,nel1889,laproduzionedirettadelburroconfer-mentiselezionati:nel1900 laditta,divenutaanonimacolnomediSocietàdi esportazione Polenghi e Lombardo, aveva un’organizzazione incentrata
caseifici presenti nel Lodigianomostrava i tratti tipici della piccola industriamolto fra-zionata,esercitatadalfittabileodalproprietarioconduttorericorrendoacasaristipendia-ti. Inoltre, ilcasodell’importanteproduttoreGiovanniVittadinidiLivragastavaad indi-care la possibilità anche di una origine nonmercantile degli operatori industriali, aven-doegliiniziatolapropriaattivitàcomeagricoltoreeallevatore,perpoidedicarsiinunse-condomomentoall’eserciziodell’industriacasearia.A.Cova,L’economia dell’Ottocento e del Novecento,cit.,p.161;G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento, cit., pp.76e78.
53.Perunaverificaintalsensosivedaadesempio,oltrealLodigiano,ancheilCremo-nese.G.Fumi, Il consolidamento di un’agricoltura di eccellenza, inG.Rumi,G.Mezza-notteeA.Cova(acuradi),Cremona e il suo territorio,Milano,1998,pp.295-327.
165
sugliimpiantirealizzatiaSanFiorano,Lodi,Secugnago,esullecasecom-mercialidiLondraeParigi54. Lasocietàcontinuavaarimanerenellemanidilodigiani,mal’espansio-
necuieraandata incontroaveva indottounallargamentodellacompagineazionariafinoad includerealcuni importanti istitutidicreditoesterniagliambientilocali,comelaSocietàbancariamilaneseelaBancadiBustoAr-sizio, segno di come questa realtà avesse ormai acquisito un’importanzacheoltrepassavaampiamenteiconfinidelLodigiano,sviluppandoun’attivi-tàcommercialeeindustrialechelaponevaaiverticidell’industriacaseariaitalianaeilcuiorizzontediriferimentosiidentificavasemprepiùneimer-catiinternazionali.All’albadellasecondaguerramondiale,«essacontrolla-vatredicilatterieindustriali,dodicicaseifici,duecremerie,unostabilimen-tochimicoper la lavorazionedeisottoprodotti,unaltroper la lavorazionedelcornoartificialeeunsalumificio[…]».IlsolostabilimentodiLodiave-va raggiunto una rilevanza di dimensione europea, essendo ritenuto «daicontemporanei il più importante stabilimento d’Europa per la lavorazionedel latte e dei suoi sottoprodotti, l’unico in cui si effettuasse l’intero ciclo industrialelattiero,sottoprodotticompresi»55. LaposizionecentraleoccupatadallaPolenghinoneraperaltroesclusiva,
dalmomentochefindal1871iPolenghieranoentratiinsocietàconAnto-nio Zazzera, il quale sarebbe stato uno dei protagonisti della nascente indu-stria casearia italiana.Originario diCodogno, dove il padre svolgeva unapiccolaattivitàdi lattaio, loZazzeracontribuì inmododeterminanteall’e-spansionecommercialedelladittaincomuneconiPolenghi.Dopoaverre-cisoilegamisocietariconquestiultimi,eglidiedevitanel1880allaprimalatteria industriale italiana, la Antonio Zazzera e figli, il cui stabilimentoerasituatonellazonaasuddiCodogno.Agli inizidelXXsecolo,quandol’industrializzazionedelsettorepotevaritenersiormaidecisamenteavviata,quest’ultimadittaera, insiemeallaPolenghi, lasolagranderealtàazienda-leoperantenelcaseificiolodigiano:entrambe,tuttavia,avevanounacomu-neorigine,laprimasocietàAntonioZazzeraeFratelliPolenghi.Il passaggio del settore lattiero-caseario verso forme di organizzazione
industriale fu quindi contraddistinto da un’accentuata tendenza alla concen-
54. F. Mandressi, La nascita del caseificio industriale in Lombardia,cit.,pp.580-582.Per una ricostruzione dettagliata della storia della Polenghi fino ai primi anni delNove-cento,sirimandaaN.AriolieF.Cattaneo,La nascita dell’industria lattiero-casearia nel Lodigiano,cit.,pp.305-338,dovesifariferimentoadunastrutturasocietariachesieraan-datacoltemposemprepiùarticolando,conicentridiproduzione,amministrazioneecom-mercio di «Codogno, Milano, Lodi (sede e latteria), Cremona, Londra, Secugnago, SanFiorano,Somaglia,Longhinore,AcquanegraCremonese,Gerolone,Pavia»(p.315).
55.G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento,cit.,p.76.L’autorerico-struisceunquadrocomplessivodellatrasformazionedelcaseificiolodigianoinattivitàin-dustrialefinoallasecondaguerramondiale(pp.64-79).
166
trazione56.Proprio inquesta luceandrebbe interpretata lanascitadi formecooperativevolteacontrastarel’azionedegliindustriali,cheinalcuneareeminacciava di assumere tendenzemonopolistiche imponendo un controlloaccentratodellaproduzionedi latte.Unafiguradiproprietario terrieroco-meAnnibaleRibonifudecisivanelpromuovereformeassociativetraipro-duttoridilatteeformaggidelbassoLodigiano,primafratuttel’esperienzadellaSocietàlodigianalatteriecooperative,costituitasempreaCodognonel1899echediedevitaaduelatterieaCasalpusterlengoeSant’AngeloLodi-giano.L’impossibilitàdiavvalersidiunaretedistributivaconfrontabileconquelladellemaggioriaziendepresentisulmercato, la limitatadisponibilitàdicapitalie la lentacrescitanelnumerodei soci furonoalcunideiprinci-paliostacoliall’affermazionediquestotentativocooperativo,chedopopo-chiannientròinunacrisinonpiùsanabile57. D’altra parte, la presenza nel-la provincia milanese delle quattro maggiori imprese italiane – Galbani,Invernizzi,LocatelliePolenghiLombardo–avrebbe limitatoanche inse-guitoleiniziativecooperativetraagricoltoriallavenditaassociatadel lattemedianteconsorzi,mentreanalogheesperienzenelcampodella trasforma-zionecasearianonpotevanocheavereridottepossibilitàdisuccesso58.La centralità del caseificio nell’economia lodigiana non deve comunque
impedire una lettura equilibrata del tessuto produttivo locale.Nonostante lastoriografia sia pressoché concorde nel sottolineare le inerzie che hanno alungooperatoinquestoterritorio,producendounritardosostanzialenelcam-minodiindustrializzazionerispettoalleareepiùprogreditedellaLombardia,occorrericonoscereipassiinavanticompiutiancheinquestocampo,inpa-ralleloalgeneralemovimentodi trasformazioneeconomicachehapercorsosoprattutto l’Italia settentrionale nel passaggio traOtto eNovecento.Non sipuòprobabilmenteriferirsia talidinamichecomeall’azionediun’imprendi-torialitàdiffusachehapermeatol’interosistemaproduttivolocale,nondime-nospiccanoalcuneesperienzeofigurediintraprendentiinnovatorichehannocontribuitoadiversificarecoltempolestruttureeconomichedelLodigiano.Nonèquestoilluogoperaffrontareindettagliotalitrasformazioni–da
altriperaltrogiàtrattatecondoviziadiparticolari59–maciòchepiùinte-
56.Sipensiche,allavigiliadelsecondoconflittomondiale,glistabilimentidellaPolen-ghilavoravano,nelloroinsieme,«qualcosacome2.500ettolitridilattealgiorno,unterzodell’immensaproduzionedilattedelLodigiano».Ivi,p.76.
57.LeduelatteriefuronorilevatedalladittaIgnazioGründiLocateTriulziedalladit-taLangeSchutzdiTorino.N.AriolieF.Cattaneo,La nascita dell’industria lattiero-ca-searia nel Lodigiano,cit.,pp.338-342;Sulle vicende del caseificio in Italia,in«Italiaagri-cola»,a.63,n.12,dicembre1926.
58.G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento, cit., p. 78. 59.A.Cova,L’economia dell’Ottocento e del Novecento,cit.;G.Fumi,L’economia lo-
digiana tra Ottocento e Novecento, cit.; E. Ongaro, Il contesto storico-sociale di Lodi…,
167
ressaquièporre inevidenzacome,perquantounacerta lentezzanell’in-dustrializzarsi da parte di questo territorio fosse innegabile in confronto alleesperienzedimaggiorsuccessodellezoneanorddiMilano,l’appara-to produttivo agli inizi delNovecento non poteva affatto ritenersi immu-tato rispettoallametàdel secoloprecedente. Icensimenti industrialicon-dotti a cadenze periodiche, infatti, mettevano in luce la non trascurabilecrescita dell’occupazione industriale e del numero degli opifici che con-traddistinse quegli anni60. Intorno al 1890, nel circondariodiLodi si tro-vavano solo il 7,2% delle imprese presenti sul territorio provinciale, e il4,6%dellamanodopera industriale: quest’ultima, in rapporto alla popola-zione residente, aveva ilvaloredigran lungapiùbasso rispettoa tuttiglialtri circondari,pariadappena il3,4%(tab.5).Osservandoperò le risul-tanze censuarie del 1911 edel 1927, si nota undeciso incremento sia delnumerodegliopifici(1.440e3.383,rispettivamente)siadiquellodegliad-detti (12.086 e 16.270). In termini relativi, rispetto al resto della provin-cia, questi valori equivalgono all’8,2% e 8,0%per quanto riguarda il nu-merodiimprese,eal3,5%e3,4%perilnumerodiaddetti:inaltreparole,almeno con riferimento a questi due indicatori e sebbene continuasse adoccuparegliultimipostidellagraduatoria,ilLodigianosembravaaverte-nuto,mediamente, iritmidicrescitafattisegnaredallaprovinciadiMila-nonelsuocomplesso.
Tab. 5 - Imprese e manodopera industriale in provincia di Milano – 1893 circa61
Circondario N. imprese % N. addetti % Popolazione residente
(1881)
Operai/pop. residente (%)
Lodi 218 7,2 5.969 4,6 175.415 3,4Milano 1.762 58,1 62.100 48,3 491.183 12,6Abbiategrasso 170 5,6 5.494 4,3 106.894 5,1Gallarate 484 16,0 23.933 18,6 162.593 14,7Monza 399 13,2 30.991 24,1 189.468 16,4Tot.provincia 3.033 100,0 128.487 100,0 1.125.553 11,4
cit.;A.Premoli,Contributi alla storia dell’industria lodigiana,in«BollettinodellaBancapopolarediLodi»,a.XXIX,n.1-2,1973,pp.24-29.
60. Per un’esposizione sintetica dei principali dati ricavabili dai diversi censimenti, sivedaA.DeMaddalena,Appunti sull’economia lodigiana nel suo profilo storico, cit., pp. 12-15.
61. Ivi,pp.12-13. Idati sullapopolazione residente sono inL.Sabbatini,Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Milano, cit., p. 4.
168
Lacomposizionesettorialedelleindustrielodigianeindicavachiaramenteilprevaleredei settori tradizionalidelcaseificioedel tessile (inparticolareil setificioe il lanificio), iqualiassorbivanogranpartedellamanodopera62. NonèuncasocheperdiversidecennilamaggiorerealtàindustrialedelLo-digiano,sottoilprofilooccupazionale,fosserappresentatadalLanificioCre-monesi, Varesi e c., il primo stabilimento tessile di dimensioni consistenti,fondatoaLodinel1868daGiuseppeVaresi,SecondoCremonesi,LuigiCin-giaeAntonioLombardo.SisarebbedovutoattendereilprimodecenniodelNovecentopervedereaperto,sempreaLodi,unostabilimentodelLinificioecanapificionazionale,destinatoadiventarelamaggiorefabbricadellacittà.Nelquadrodiun tessuto industrialeconcentrato su tali settori, si raffor-
zarono inquegliannialcuniramiproduttivichesi facevanotalvoltaporta-toridiunacapacitàinnovativanonprivadiricadutesulsistemaeconomiconelsuocomplesso.Aquestoproposito,sidistingueva l’attivitàdiMelchior-re Sordi nel campo chimico e meccanico, particolarmente significativa inquanto si collegava strettamente all’attività tradizionale lattiero-casearia:nato a Caviaga da una famiglia di agricoltori, egli fondò a Lodi nel 1881un’officinaperlafabbricazionedicaglioliquidoedeiprimiutensiliemac-chinari per caseificio, fornendo un importante contributo allamodernizza-zionediquest’ultimo63.Nel1908, lostessoSordipartecipò, insiemeadim-prenditori locali come Cesare Castellotti e l’ingegnere Bassano Folli, allacostituzione delle Officine meccaniche lodigiane, che divennero l’impresamaggioredel ramonelcircondario:attiva soprattutto inambito ferroviario,negli anni trenta delNovecento impiegava circa 400operai.Anche l’indu-striadeimaterialidacostruzioneebbeuncertosviluppo,sianellaproduzio-nedilaterizi(sipensialloStabilimentolateriziBernardinellidiCasalpuster-lengo, creato nel 1884) sia in quella del cemento, con la Società lodigianaperlafabbricazionedimaterialidicostruzioneincemento(1874)–unadel-leprimeimpreselocaliadassumerelavestegiuridicadisocietàanonima–eapartiredaglianninovantalaSocietàlodigianalavoriincemento,chepersvariatiannifulaprincipaledelsuosettoreintuttalaprovinciadiMilano64. Quellicitatisonosoloalcuniesempichetestimonianoilprogressivodi-
versificarsidelsistemaproduttivolocale,purinpresenzadiunapersistente
62.Intornoal1893,il25%degliaddettiadattivitànonagricoleeraimpiegatonelcasei-ficio, il17%nell’industriadellasetae il16%inquelladella lana.Importanteeraancheilsettoredellamacinazioneebrillaturadeicereali(15%).G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento,cit.,p.63.
63.IproblemidelcaseificiodovevanoesserebenpresentialSordi,cheavevafrequenta-tolaR.StazionediCaseificiodiLodi,unistitutosperimentalesortoconloscopodicon-tribuire al miglioramento produttivo del settore. E. Bonomi, Melchiorre Sordi pioniere della tecnica lattiera,in«Archiviostoricolodigiano»,s.II,a.IV,1956,pp.74-79.
64.Maic,Statistica industriale. Lombardia,Roma,1900,p.364;G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento,cit.,pp.103-104.
169
prevalenza delle attività di trasformazione legate all’agricoltura. Il quadrocheemergenoneraperaltroomogeneo,consideratoiltendenzialeaccentra-mentodellemaggiori iniziativeindustrialiaLodi,mentreneglialtricentridelcircondario(conlaparzialeeccezionediCodogno)siosservavaunaso-stanziale aderenza adun tessuto economicopocovario e, ancora sulfini-redelXIXsecolo,probabilmentenontroppodifferentedaquellochedove-vaesserestatoneidecenniprecedenti (la tabella inappendicericostruiscelafisionomia industriale deimaggiori centri delLodigianonegli anni no-vantadell’Ottocento).Anche ilcensimentodel1911,mettendoaconfrontoilnumerodiimpreseediaddettipersettoreindustrialenelledueprincipaliareediLodieCodogno,confermavailminorpesorelativocheleindustrielegateall’agricolturaavevanonelcapoluogodelcircondario,atuttovantag-giodelramotessile,meccanico,deimaterialiediliziechimico(tab.6).
Tab. 6 - Imprese e manodopera industriale a Lodi e Codogno – 191165
Lodi CodognoN.
imprese% N.
occupati% N.
imprese% N.
occupati%
Industrieestrattivedel sottosuolo
3 1,3 49 1,4
Industriechelavoranoe utilizzano i prodottidell’agricoltura,della caccia e della pesca
95 39,7 655 18,6 113 49,3 733 33
Industriechelavoranoeutilizzanoimetalli
59 24,7 421 12 39 17 102 4,6
Industriechelavoranoimineraliecostruzioniedilizie, stradali, idrauliche
22 9,2 532 15,1 12 5,2 268 12,1
Industriechelavoranoeutilizzanolefibretessili
40 16,7 1.588 45,2 53 23,1 801 36,1
Industriechimiche 6 2,5 54 1,5 3 1,3 18 0,8Industriecorrispondentiabisognicollettivi
12 5 186 5,3 6 2,6 97 4,4
Associazioni di industrie appartenentiadiversecategorie
2 0,8 31 0,9 3 1,3 200 9
Totale 239 100 3.516 100 229 100 2.219 100
65.Maic,Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10 giugno 1911, vol.IV,Roma,1914,pp.60-63.
170
5. Un sistema bancario fondato sulla cooperazione
Non diversamente da altri centri della Lombardia, il Lodigiano si pre-sentò all’appuntamento dell’unificazione nazionale con un apparato ban-cario circoscritto, si può dire, alla locale filiale della Cassa di risparmiodelle provincie lombarde (Cariplo)66. Aperta nel 1823, stesso anno di na-scitadell’istitutomilanese,essarappresentòpermoltianniilpuntodirife-rimentoobbligatoper la raccoltadel risparmioprodotto in loco.Esponen-tidi spiccodegli ambienti locali entraronoa farpartedellaCommissionecentrale di beneficenza, organo amministrativo della Cassa: si trattava diun’éliteeclettica,presenteneimaggioricentridelpoterelocaleonazionale,comePietroBeonio(sindacodiLodidal1867al1869,poiconsiglierepro-vincialeeindiverseistituzioniqualil’OspedaleFissiraga,l’Ospedalemag-giore e laCongregazione di carità, quest’ultimo il principale istituto dellabeneficenza cittadina) eGiuseppeCornalba (tra i numerosi incarichi pub-blici,fuconsiglieredelComunediLodi,consigliereprovinciale,presidentedelComizioagrario,deputatoeinfinesenatoredelregno)67. La filiale della Cassa di risparmio doveva tuttavia avere una capacità
di penetrazione nel territorio alquanto limitata essendo localizzata nel so-lo centrodiLodi, escludendo così, di fatto, granparte del circondariodaisuoiservizi:provaneerachenel1862siregistravanosolo7.082librettidirisparmio (presumibilmente concentrati nel capoluogo e aree limitrofe), afrontediunapopolazionedelcircondariochenondovevaesseretroppodi-versadai175mila residenti riportatinelcensimentodel188168. Questa ca-ratteristicasimantenneancheinseguito,nonostantechenelfrattempofos-sero stateaperteduefiliali, aCodogno (1863)eaCasalpusterlengo (1883),nel tentativo di intercettare le disponibilità di capitali dei due importan-ticentridelbassoLodigiano.Sesiosservainfattiladistribuzionedellarac-coltatraipredetticentri,èancoraevidentel’accentuatocaratterecentripetodiLodi,chefacevasegnare17.618librettiperoltre22milionidilire,controi4.228contiapertiaCodogno(circa4,6milionidilire)ei1.300diCasal-pusterlengo (circa 1,4milioni). Erano numeri che non davano certo ragio-ne dell’importanza economica di queste due ultime cittadine, tanto più sesiconfrontaquestasituazione,adesempio,conquelladiComo–lasecon-daprovinciaperdepositi raccoltidallaCariplo,dopoMilano– lacuifilia-
66. Per le loro peculiari caratteristiche, non si considerano in questa sede i banchieriprivatieilMontedipietà.
67.A.Stroppa,Gli amministratori del Comune di Lodi dal Regno alla Repubblica, cit., ad nomen.
68. Archivio storico Intesa Sanpaolo (Asi)-Cariplo, Bilanci, vol. I (1857-1868), anno1862.
171
lecittadinacontava, rispettoall’interaareaprovinciale,solo il23%delnu-merodi librettie il26%delrelativoammontare, rispettoal76%e78%diLodi.Conclusionisimili,perquantononcosìmarcate,sipossonotrarreperlaprovinciacremonese(rispettivamente42%e51%)69. Solo negli anni tra le dueguerremondialidiminuì–interminirelativi,nonassoluti–ilcontribu-todiLodiallaraccoltadirisparmio,perviasoprattuttodell’accresciutope-sodiCodognoeall’apertura,nel1928,dellafilialediS.AngeloLodigiano.Ledifferenzeperaltronon si limitavano aquesto,ma riguardavano an-
che la distribuzione dei depositi per classi di grandezza, considerato che nel capoluogolodigiano,almenofinoafineOttocento, iclienticonlibrettisu-periorialle5milalire–valorecertonontrascurabileperl’epoca70–pesa-vanopercentualmentedipiùcheaCodognoeCasalpusterlengo,mentrenel1900ilrapportoapparivainvertito,perviadiunadrasticariduzioneaLo-didelnumerodiclientiappartenentiaquellafascia(graff.1,2e371).Allostato attuale delle ricerche imotivi di tali differenzenon sono facilmenteidentificabilieidatiadisposizionenonconsentonodiformulareconclusio-nicerte,tuttavia,nelcomplesso,nonsembracheallaCassaaffluissedipre-ferenza il risparmiominuto: nel 1890, a Lodi i libretti di oltre 3.000 lireerano,innumero,il10%deltotaleerappresentavanoil43%dellaraccolta;aCodognotalivalorierano,nell’ordine,il4%eil30%;aCasalpusterlengol’8%eil48%72.
Graf. 1 - Distribuzione dei libretti di risparmio per classi di grandezza (lire): percentuale del valore complessivo della raccolta – 1880
69.Asi-Cariplo,Bilanci,vol.VIII(1905-1910),anno1910.70.Siricordichelefontiministerialifissavanoin10milalireillivellodiredditodiric-
chezzamobiledeimaggioricontribuenti.MinisterodelleFinanze.Direzionegeneraledelleimpostediretteedelcatasto, Elenco dei contribuenti privati delle categorie B e C inscritti nei ruoli principali 1889 per un reddito imponibile di lire 10,000 o più, cit..
71.Asi-Cariplo,Bilanci,ad annos.72.Asi-Cariplo,Bilanci,vol.IV(1886-1890),anno1890.
172
Graf. 2 - Distribuzione dei libretti di risparmio per classi di grandezza (lire): percentuale del valore complessivo della raccolta – 1890
Graf. 3 - Distribuzione dei libretti di risparmio per classi di grandezza (lire): percentuale del valore complessivo della raccolta – 1900
Nonfutantol’istituzioneaLodi,nel1865,diunasuccursaledellaBan-canazionalenelRegnoainnovareilcontestoistituzionaledellapiazzalo-digiana.Senzadubbiolasuaaperturaeraunachiaramanifestazionediin-teresse da parte della banca per questo centro,ma il principale istituto diemissione influì solo tangenzialmente negli sviluppi di un’economia agri-colacheesprimevaistanzeacuidifficilmenteessoavrebbepotutodareri-sposta, rivoltocom’era soprattutto al cetocommercialee industriale73.Nei
73.Asbi,Segretariato,pratt.,n.367,fasc.1,RelazionedelDirettoredellaSuccursalediLodiall’eserciziodell’anno1887.
173
primi anni ottanta, ad esempio, lo sconto cambiario esercitato da questasuccursale–vero“termometro”delgradodiinserimentonell’economialo-cale, inquantosuoprincipaleramodiattività–erafortementedipendentedapochigrandinominativi,comelaGambiniPolenghiCirioeC.diBrem-bio, l’unica impresa chimica di importanti dimensioni all’epoca nel Lodi-giano,o laPolenghiLombardioCirioeC.diCodogno,cheinprecedenzasiappoggiavaallafilialecremonesedellaBancanazionale.Ugualmente intensi, se non talvolta persino prevalenti, erano i rappor-
ti interbancari con due nuovi istituti, sorti negli anni sessanta sul model-lotedescodellebanchepopolaricosìcomedivulgatoinItaliadall’operadiLuigiLuzzatti.AllaNazionalericorrevano infattiper loscontosia laBan-camutuapopolareagricoladiLodi,fondatanel1864nelcapoluogoeprimadelsuogenereinItalia,sialaPopolarediCodogno,costituitatreannidopocome a voler affermare una sorta di indipendenza economica di quest’ul-timo importante centro daLodi74. Specialmente con quest’ultima i legamierano particolarmente forti: con essa la Nazionale, intorno al 1882, avviòun’intensaattivitàdicorrispondenza,forseproprioinconseguenzadelpesoassuntodalledittePolenghiall’internodelproprioportafogliocambiarioequindidellamaggioreimportanzacheilbassoLodigianoeraandatoacqui-standoagliocchidell’istitutodiemissione.Ilcheandavaprobabilmenteri-condottoallapiùgeneralelinead’azionealloraseguitadaquest’ultimo,cheavevaampliatol’operativitàistituendounserviziodicorrispondentiaffidatoa banche attive «nelle città dove ilmovimento commerciale ed industrialenon[era]forseabbastanzaattivoperdarvitaadunasuccursale,ma[era]ta-le in sé da poter essere preso in considerazione dalla Banca»75.Ècerto,comunque,chelaveraspecificitàchecontraddistinseilLodigia-
noinambitobancarioful’estesoricorsoallaformulacooperativaqualeso-luzionealladomandadicreditoprovenientedaidiversisettorieconomici76.
74. Occorre comunque rilevare come la succursale lodigiana della Nazionale denun-ciasseapertamentelaconcorrenzadialcuniistitutimilanesiperaccaparrarsiilriscontodelportafoglio delle due popolari. Tra l’altro, grazie alla crescente disponibilità di depositi, la PopolarediLodiavevasempremenonecessitàdiricorrerealriscontodell’istitutodiemis-sione.Asbi,Segretariato,pratt.,n.365,fasc.1,RelazionedelDirettoredellaSuccursalediLodidelleoperazionicompiutenell’anno1885.
75.E.Tuccimei,L’ordinamento e le operazioni della Banca Nazionale nel Regno d’Ita-lia,inAa.Vv.,Ricerche per la storia della Banca d’Italia,vol.I,Roma-Bari,1990,p.236.Suirapportitral’istitutodiemissioneelealtrebanchedelsistema,sirimanda,nellostes-sovolume,alsaggiodiA.Gigliobianco,Tra concorrenza e collaborazione: considerazioni sulla natura dei rapporti fra “banca centrale” e sistema bancario nell’esperienza italiana (1844-1918),pp.295-338.
76.Sulleorigini egli sviluppidellebanchepopolari in Italiafinoalla secondaguerramondialesivedanoisaggidiLuigiDeRosa,PietroCafaroeAlbertoCovainP.Pecorari(acuradi),Le banche popolari nella storia d’Italia,Venezia,1999.
174
LacentralitàdiunafiguracomeTizianoZallinel farsi acceso sostenitoredellaprimabancapopolared’Italia,tantodariceverel’apprezzamentodellostessoLuzzatti, èfin tropponotaperdoveressere ripetuta77. Originario di un’agiatafamigliadicommerciantiinformaggidiLodi,loZallifuunodeipiùattivipromotoridiiniziativeincampoeconomicoesocialedelterrito-rio,soprattuttonelcampodelmutualismoborghese,acominciaredallaSo-cietà generale operaia dimutuo soccorso nel 186178. La Popolare nascevasuquestebasi,diunacooperazionesostenutadalleclassidirigentiediciòsenehaprovascorrendol’elencodeisuoi128promotori79:traessi,afiancodi figure di piccoli commercianti e artigiani, comparivano, oltre alloZal-li(segretariodelComunediLodievice-presidentedellaCassadelprestitod’onore80),altrepersonalitàdiassolutorilievonelpanoramacittadino,comeilsindacodiLodiGiovanniZanoncelli,GaetanoPirovano(presidentedel-laCassa di prestito d’onore ed ex presidente dellaCamera diCommerciodiLodi),AntonioDossena (presidentedella localeCameradi commercio,consiglierecomunale,poisindacodiLodi),l’avvocatoAntonioScotti(con-siglierecomunaleedell’OspedaleMaggiore,nonchéconsigliereprovincia-le),gliingegneriPietroAllara(consiglierecomunaleedell’OspedaleMag-giore), Dionigi Biancardi (consigliere comunale, presidente dell’OspedaleMaggioreedellaCongregazionedicarità)eFrancescoColombani(deputa-toalParlamento).Ne derivava un sistema istituzionale in cui ai tradizionali canali di
espressionedelleélitedirigentiqualierano iconsiglicomunalie lecame-re di commercio, o anche istituzioni come le opere pie, se ne aggiungevaunaltroportatorediunafortecaricadistintivasottoilprofilosocio-econo-mico,comeappuntoeral’appartenenzaaiconsiglidiamministrazionedellaBancapopolare.Suquestiluoghidiformazioneedicircolazionedeiverticieconomici della società lodigiana e sull’importanza del nesso “agricoltura
77.Adesempio,E.Ongaro,Tiziano Zalli: un infaticabile promotore, inAa.Vv.,Lodi e la Banca Popolare. 1864-1914 Gli anni di Tiziano Zalli, cit.,pp.49-95; Id.,Tiziano Zal-li: una vita a vantaggio unicamente del paese,Zingonia,1999;E.C.Colombo,Agli albo-ri del credito cooperativo nel Lodigiano,cit.,pp.28-50;A.Bassi,Tiziano Zalli e la Banca Popolare di Lodi,inAa.Vv.,Lodi. La storia dalle origini al 1945,vol.III,cit.,pp.247-256.
78.Perunadettagliataanalisidell’evoluzionedelmovimentomutualisticonelLodigia-no,fondamentaleèillavorodiE.Ongaro,La fiumana. Storia dei lavoratori nel Lodigiano (1860-1960),Roma,1997.
79. Aa.Vv., La Banca mutua popolare agricola di Lodi nel primo centenario. 1864-1964,cit.,pp.35-41;A.Stroppa,Dalla Società operaia di mutuo soccorso alla Banca po-polare di Lodi, inAa.Vv.,Lodi e la Banca Popolare. 1864-1914 Gli anni di Tiziano Zal-li,cit.,pp.162ss.
80.LaCassadelprestitod’onore fu istituitanel1862, supropostadelloZalli, in senoallaSocietàoperaiadimutuo soccorso.A.Stroppa,Dalla Società operaia di mutuo soc-corso alla Banca popolare di Lodi,cit.,p.166.
175
capitalistica-grandecommercio-rappresentanzacameralee ruolodelcredi-to-rappresentanza politica”, vale la pena citare quanto scritto da uno stu-diosoapropositodell’esistenzadiun“sistematerritoriale”,alcuiinternolaBancapopolare–dallecuifilaprovenivanomoltipresidentidellaCameradicommercio81–occupavaunaposizionediprimopiano:
[…]sistavaassistendoallosviluppodiun’agricolturaprecocementespecializzata,imperniatasullacentralitàdell’affittanzacapitalistica,icuiprotagonisti–fittaiuo-lichespessoaccumulavano ingenticapitali–erano incercadelle formepiùeffi-cacipercristallizzarelapropriaidentitàcollettiva.Laspecializzazioneproduttivarichiedevaampisbocchimercantili[…]einfattifavorìl’ascesadiunnucleodiim-prenditorideditiallacommercializzazionedelprodottoagricolo,diversideiqualiandaronoacomporreleélitecamerali[…].Perassecondarequestoprocessofattodivolumicommerciatisemprepiùrilevantidovevanecessariamenteaffacciarsi ladimensionecreditizia,chenel[Lodigiano]siidentificòconilruolodellaPopolarediLodi.Lacerchiapiuttostoristrettadeiprotagonisticoinvoltielapredominanzadell’ambienterurale[…]esaltavailruolodiraccordo,confrontoemediazionetan-todell’istitutocameralequantodellaBancapopolare,cosìdarenderlidifattode-gli incubatori di classi dirigenti [corsivomio];ilcheèpiùdiun’ipotesi,datocheallacircolazionedelleéliteeconomichetraCameraeconsigliodiamministrazio-ne della Popolare si aggiungeva in genere l’elezione delle stesse persone in con-siglio comunale. Tale assetto assunse i connotati di un “sistema territoriale” cheavrebbevistoaffiancareaquestipolialtriistituti,lacuifinalitàgeneraleeraquelladienfatizzareitrattipiùmarcatamenteimprenditorialidell’economialodigiana82.
Sull’attenzione rivolta dalla Popolare di Lodi alle richieste di creditoprovenienti dall’agricoltura, sulla sua diffusa presenza sul territorio e sul-lasuaazionedistimoloeaccompagnamentodell’industrializzazionediLo-diagli inizidelNovecento,giàèstatoscrittodaaltri83. Indaginipiùmira-tepotrebberosemmaienucleareledifferenzeconlaconsorelladiCodogno–anch’essasostenutaneisuoiprimipassidalloZalli–laqualemostravadipossedere, sulfinire delXIX secolo, una compagine azionaria assaimenofrazionata(532socieuncapitalesocialedi700milalire)rispettoallaPo-polarediLodi (6.713 soci e un capitale di circa1,5milioni di lire), comepurescontavaeffetticambiariperunimportomediopiùchedoppio(1.945
81.Sullebanchecomeluoghidiformazionedelleleadershipdelterritorio,conunespli-citoriferimentoalcasolodigiano,G.Paletta,Alle origini del sistema imprenditoriale ita-liano: le élite camerali dal 1862 al 1944, in G. Paletta (a cura di),Dizionario biografi-co dei presidenti delle Camere di commercio italiane (1862-1944), t. I,SoveriaMannelli,2005,pp.XXXVIII-XXXIX.Nellostessovolume(pp.448-457)sonoriportatelebiografiedeipresidentidellaCameradicommerciodiLodidal1862al1926.
82.F.Samorè,Storia della Camera di commercio di Lodi (1786-2009),Milano,2009,pp.38-39.Sivedainoltreilparagrafodedicatoalleélitecameralilodigiane(pp.101-106).
83.Traglialtri,E.C.Colombo,Agli albori del credito cooperativo nel Lodigiano, cit., pp.42-49.
176
lirecontro857lire),lasciandocosìsupporre,almenoadunprimosguardo,l’esistenzadiunadiversatipologiadisociediclientelatraleduepopolari84. Taleduplicazionedegli istituti creditizi si sarebbe significativamente ri-
presentata anche in seguito, quando sull’onda del movimento sociale cat-tolico furonocreati, nei primi annidelnuovo secolo, ilPiccolo creditoS.Alberto a Lodi (1904) e il Piccolo credito del Basso Lodigiano a Codo-gno (1907), i quali entrarono presto in contrapposizione nel momento incui quest’ultimo rivendicòunapropria sfera territoriale autonoma, in con-trasto con le direttive diocesane che consideravano il S.Alberto la bancadi riferimento dell’intera diocesi85. Quello dei piccoli crediti – unitamen-teallenumerosecasseruralisorteapartiredagliultimiannidell’Ottocen-to86–eraunoschemadicreditocooperativoalternativorispettoaquellodimatrice liberale propugnato dal Luzzatti e impiantato nel Lodigiano dal-loZalli. Inquestomodello cooperativodi ispirazione cristiana, i sacerdo-tieranoinprimalineanelpromuoverelenuoverealtàcreditiziee,ataleri-guardo, spiccava lafiguradidonLuigiCazzamali, attivo sostenitoredelleiniziativeeconomico-socialidelladiocesiedibuonapartedelmondocat-tolicolodigiano:allasuaoperasidevericondurreanchelanascitadelPic-colo credito S.Alberto. Similmente, tra i soci azionisti del Piccolo credi-to codognese comparivano numerosi sacerdoti: uno di essi, donGiovanniQuaini,fuunodeiprotagonistidelsindacalismobianconelbassoLodigia-no, il che probabilmente indicava come il sistema creditizio cattolico fos-se«ilproseguimentopiùefficacedelmessaggiosocialecristianosulpianoeconomicoesociale»87.
84.UnprospettodellebanchepresentinelLodigianoallafinedell’Ottocento,coniloroprincipalidatidibilancio,sitrovainL.Sabbatini,Notizie sulle condizioni industriali del-la provincia di Milano,cit.,pp.44-47.
85.Peruna ricostruzionedel sistemacreditizio cattoliconelLodigiano, conparticola-reriferimentoalPiccolocreditoS.Alberto,sivedaP.CafaroeE.C.Colombo(acuradi),Un’antica nobiltà…, cit.
86. Sulle casse rurali, cfr. in particolare P. Cafaro,La solidarietà efficiente. Storia e prospettive del credito cooperativo in Italia (1883-2000), Roma-Bari, 2001; R. Vigorel-li, Le casse rurali nel Lodigiano (1908-1933),Estrattodal«Giornaledegli economisti»e«Rivistadistatistica»,CittàdiCastello,novembre1934;A.Leonardi,Dalla beneficenza al mutualismo solidale: l’esperienza cooperativa di F.W. Raiffeisen ed i suoi primi riflessi in Italia,inV.Zamagni(acuradi),Povertà e innovazioni istituzionali in italia. Dal Medioe-vo ad oggi,Bologna,2000,pp.551-583;P.Cafaro,E.C.ColomboedE.Berbenni,The Cre-ation and Expansion of the Catholic Cooperative System in Italy, 1874-1922, paper pre-sentatoalXVIconvegnomondialedistoriaeconomica(Stellenbosch-SudAfrica,9-13lu-glio2012).
87. P. Cafaro, Il modello alternativo dei cattolici, in Id. e E.C. Colombo (a cura di),Un’antica nobiltà…,cit.,p.90.SullafiguradidonQuainicfr., traglialtri,E.Ongaro,La fiumana. Storia dei lavoratori nel Lodigiano (1860-1960),cit.;A.Carera,Organizzazione contadina e cattolici nel Lodigiano di inizio ’900,inAa.Vv., Movimento contadino e lotta
177
Aldilàdagliinterventinormativiche,duranteilfascismo,furonointro-dotti nell’intentodi privare ilmovimento cooperativodella sua autonomiaorganizzativa,ècertochesullesogliedegliannitrentaquestoramodelset-torebancario avesseormai acquisitoun’importanza tale da costituire l’as-seportantedell’apparatocreditiziolodigiano.Senepuòavereunaparzialeideaanchesologuardandoal totaledella raccoltadel risparmio imputabi-le allebanchecooperative inconfrontoaquel tradizionale serbatoiodi li-quidità rappresentato dallaCariplo.Nella statistica del 1893, le filiali del-laCassadirisparmiodiLodi,CodognoeCasalpusterlengo,assommavanodepositiperun totaledioltre16milionidi lire,mentre lepopolaridiLo-dieCodognoraccoglievanocomplessivamenterisparmipercirca11milio-ni(comprensividi1,2milionidibuonifruttiferi).Neiprimianniventidelsecolosuccessivo,aLodisiosservavaunacer-
ta diversificazione dell’offerta creditizia, essendo presenti quattro agenziedibanchenonlocali(Bancad’Italia,Bancaagricolaitaliana,CariploeCre-ditocommerciale)etrebanchelocali(PopolarediLodi,PiccolocreditoS.AlbertoeBancadiLodi),mentreaCodognoavevanosedelalocaleBancapopolare e il Piccolo credito del basso lodigiano88.Allafinediqueldecen-nio,ilpesodegliistitutidicreditosullatodellaraccoltaeraormaidecisa-mentesbilanciatoafavoredegliistitutidicreditocooperativo:anchesenzaconsiderare le due principali banche codognesi, questi ultimi registrava-nodepositiperuntotaledi208,5milionidilire(dicui111,3laPopolarediLodi,80,2 ilS.Albertoe17 lecasserurali), rispettoai93,2milionidellefilialidellaCariplo89.Era,questo,unandamentononprivodiconseguenzeperilLodigiano,dalmomentoche,comegiàrilevatodalLuzzattinel1890,dagli istituti cooperativi ci si attendeva un elevato tasso di reimpiego sulterritoriodeicapitaliraccoltiinloco,afrontedeltendenzialeaccentramen-tosuMilanoimpostodallaCariplo90.Allalucediquestistrettilegamiconl’ambiente localeeconlealtre istituzionicheinessooperavano,nondevequindi sorprendere che una banca come la Popolare diLodi si presentas-secomeuncanaleprivilegiatodiespressionedelleélitedirigentilodigiane.
politica nel Lodigiano fine 800 inizio 900, Convegnostorico.Atti,Lodi,18-19aprile1980,pp.49-69.UnelencodegliazionistidelPiccolocreditodelBassoLodigianositrovainAr-chivioperlastoriadelmovimentosocialecattolicoinItalia“MarioRomani”(pressol’U-niversitàCattolicadelSacroCuorediMilano),Fondodocumentibanchecattoliche,n.157,cart. 4, fasc. 4.1.
88. E. Ongaro, Istituzioni economiche nel Lodigiano negli anni venti, cit., p. 132.89. Il dato delle casse rurali è del 1928. R. Vigorelli, Le casse rurali nel Lodigiano
(1908-1933), cit., p. 7;Asi-Cariplo,Bilanci, vol.XII (1926-1930), anno 1930;P.Cafaro eE.C.Colombo(acuradi),Un’antica nobiltà…, cit., p. 218.
90. L. Luzzatti, Il credito popolare agrario, in «Credito e cooperazione», 1° giugno1890,cit.ancheinE.C.Colombo,Agli albori del credito cooperativo nel Lodigiano, cit., p. 33;G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento,cit.,p.116.
178
6. Conclusioni
Insistereoltremisurasullatardivae/oincompletaindustrializzazionedelLodigiano non sembra del tutto giustificato. Non vi è dubbio che, in ter-minicomparativi,quest’areafossemoltodistantedalleesperienzedimag-giorsviluppomanifatturierodellapianuraasciuttalombardatraOttoeNo-vecento:maunsimileconfrontosarebbepoicorrettodaunpuntodivistametodologico?Probabilmenteno,consideratocheipuntidipartenzaeranogiàdiversi,comepureloeranoisistemiagricoliprevalenti.D’altraparte,ilcircondariodiLodinoneraaffattounarealtàimmobile,avendoanziperfe-zionatoneltempounsistemaagricolo-industrialechesifondavasullalavo-razionediquantoprovenivadaunsettoreprimarioaltamenteproduttivoevotatoall’esportazione.L’affittanzacapitalisticaeraloschemagiuridico-economicoentrocuiera
possibile inquadrare lapartepiùconsistentedi taleorganizzazione: la suacentralitànegliequilibridelterritorioèstataampiamenteribadita.Proprioperquesto,èall’affittuariocheoccorreanzituttoguardarenelmomento incuisivoglianotracciarelecoordinatedelleéliteeconomichelodigiane.Eraunafiguracertamentemenoappariscenterispettoaigrandinomichepren-devanoparte ai consigli comunali, alla cameradi commercioo aqualcheistitutodi credito, tuttaviadaessanon sipuòprescindere se l’obiettivo ri-manequellodiandareallafontedegliinteressieconomicidiquest’area.Lostudiodiuna fonte ineditacomequelladei ruolidell’impostadi ricchezzamobile può aiutare a dare maggiore concretezza a questa affermazione91. Essendo essa pur sempre una fonte fiscale, soggetta ad un elevato gradodievasione,nonpuò fornire informazioniprecisesullacapacitàdi redditodelle singolecategorieproduttive,ma, seusatacon lagiustacautela,offrecomunqueunquadrocomplessivodellororispettivopesoe,inparticolare,della forzaeconomicaespressadagliaffittuari.Aciòsiaggiunga lapossi-bilitàdimettere in luce leeventualispecificitàdeidiversicentridelLodi-giano nella distribuzione del reddito, aspetto, questo, di particolare interes-seancheperchésipotrebbero inquestomodovalutare leconseguenzedelprocessodi industrializzazioneche interessòsoprattutto lacittàdiLodie,inmisuraminore,quelladiCodogno92. Tuttavia questo territorio non ha solo saputo esprimere un propriomo-
dello di sviluppo sostenibile, che mirasse alla modernizzazione di quan-togiàdatempoeraafondamentodell’economialocale.Essohaanchedato
91. P. Frascani, Per la storia della stratificazione sociale in Italia: i ruoli dell’imposta di ricchezza mobile,in«Quadernistorici»,n.39,1978,pp.1063-1114.
92. La presentazione dei risultati di questa ricerca, condotta su tale fonte per l’anno1925,saràoggettodiunamiaprossimapubblicazione.
179
vita adun contesto ambientale ad elevatadensità istituzionale.Laperdutaautonomiaamministrativa, con l’abolizionedellaprovinciadiLodi-Cremaall’indomani dell’unificazione nazionale, aveva infatti reindirizzato, si puòdire, le ambizionidella classedirigente localeverso la costruzionediunapropria identità che passasse attraverso il dinamismodi un sistema istitu-zionalericcoediversificato:daquestaprospettiva,
l’intuizionedegliesponentipiùilluminatidellaborghesialodigianafualloraquel-lo di puntare a un primatomorale della città attraverso la fioritura dimoltepliciistituzionisocialiedeconomichechepotesserofaremergereLodialivellonazio-naleequindidarebasisolidealrecuperodell’anticaautonomiaedell’ambitoruolodicapoluogoprovinciale93.
DovevacosìaverefacileascoltoLuigiLuzzatti,quandoalterminediunsuodiscorso tenuto aLodi, affermò che«la grandezza di una città, di unpopolo,nonstanelnumerodeisuoiabitantionellabellezzadeisuoimonu-menti,bensìnellafeconditàdellesueistituzioni»94. Di tutto questo occorre tenere conto nel ricostruire la realtà socio-eco-
nomicadelLodigiano,comepuredialtrearee.LaStazionesperimentaledicaseificiodiLodi,fondatanel1871(acuiseguì,dieciannidopo,unaScuo-ladicaseificioper la formazionedi tecnicidel settore),e laStazionespe-rimentale di praticoltura, istituita nel 1923, erano testimoni, a distanza dioltremezzo secolo l’unadall’altra, di una spiccata sensibilità verso le esi-genze dimodernizzazione espresse da due rami fondamentali dell’econo-mia locale95.Maquesti istituti, chemiravanoadapplicarepiùdavicino ilmetodo scientificoall’attività agricola e casearia, erano inseriti inunqua-droambientaleassaipiùdiversificato.IlComizioepoiilConsorzioagrarioerano altre realtà particolarmente vive in questo territorio eminentementeagricolo:allorointernopuretrovavanovocepersonalitàdiprimopianoco-meGiuseppeBellinzona (tra i suoinumerosi incarichi,vi fuanchequellodisindacodiLodi),ilqualefupresidentedelComizioevice-presidentedelConsorzio e della Società agraria di Lombardia, eGiuseppe Premoli, ve-
93. E. Ongaro, Il contesto storico-sociale di Lodi…, cit., p. 11.94. Ibidem. 95. La direzione della Stazione sperimentale di caseificio fu per lungo tempo affida-
taadunprofondoconoscitoredelsettorequaleCarloBesana.Aluisideveilmeritoprin-cipalediavererealizzato«larivoluzioneindustrialenellalavorazionedei latticini»,siaat-traversoladivulgazionedellenovitàincamposcientificoetecnologicoprovenientidall’e-stero,siaconducendoun’attivitàdiricercaesperimentazioneoriginaleaLodi.A.Stroppa,Carlo Besana e il rinnovamento del caseificio, inP.BattilanieG.Bigatti(acuradi),Oro bianco,cit.,pp.241-270.
180
roeproprioanimatoredelConsorzioesuoprimopresidente96. Soprattutto, ainfluenzareinprofonditàquestoterritoriosembraesserestataladiffusio-nedelmovimentocooperativo, tantonel ramodellaproduzione,quanto inquellodelconsumoedelcredito.IlprimatodiLodinellafondazionedellaprimabancapopolare inItaliaèsolo ilsegnodiunsistemacreditiziocheavrebbe imboccatoanche inseguito,consempremaggioreconvinzione, laviadelcooperativismo.Lacapacitàdidiversificarel’offertadicreditoattra-versodiversetipologiediistituti–dallebanchepopolaridimatriceliberaleaquellecattolicherappresentatedaipiccolicreditifinoasviluppareuntes-sutodicasserurali–haresoaccessibiliiprincipaliservizibancariall’inte-rocircondario,purpreservando icaratterispecificidellesuesingoleparti.LaduplicazionedellemaggiorirealtàistituzionaliaLodieaCodognocon-fermavavisibilmentelapluralitàdiunterritoriocheesigevaformeautono-me di rappresentanza e di iniziative economiche.Ciò valeva non solo nelcredito,conlepopolarieipiccolicreditidiLodiediCodogno,maanchein altri ambiti: si pensi ad esempio alle cameredel lavoro (quelladiLodiinauguratanel1896,quelladiCodognoentrata inattività l’annoseguente)o,ancorprima,aitentatividiinizioOttocentodapartediCodogno«diot-tenerelariattivazionediunaCameradiCommerciofacendovalerelamag-giorericchezzadi trafficieunapiùnumerosapopolazione»97. Tutto questo conferma,unavoltaancora, lacompositaarticolazionediun territoriopursocialmenteedeconomicamentecoesocomeilLodigiano,ilqualefondavailpropriosvilupposuunmodelloagricolo-industrialeche,traOttoeNove-cento,potevaritenersitutt’altrochestatico98.
96.SulConsorzioagrariolodigianosivedaG.A.Torelli(acuradi),Diario di cento an-ni di lavoro al servizio degli agricoltori,Milano,2003.L.Cingia,Un pioniere lodigiano dell’agricoltura: Giuseppe Premoli, in «Archivio storico lodigiano», n. 2, 1955, pp. 139-146.
97.F.Samorè,Storia della Camera di commercio di Lodi (1786-2009), cit., p. 37.98.Dasottolineareè lacontraddizione traun tessutosocio-economicocoesoe l’insta-
bilitàdelquadropoliticoeamministrativo,unacaratteristicaquestachedifferenziainmo-doevidenteLodirispettoaMilano.G.Bigatti,Il Municipio e la città,inId.(acuradi),Il Municipio e la città…,cit.,pp.17-18.
181
Appendice
Imprese e manodopera industriale nei principali centri del Lodigiano – Anni novanta dell’Ottocento99
Lodi Codogno Casalpusterlengo S. Angelo Lodigiano
N.esercenti
N.operai
N.esercenti
N.operai
N.esercenti
N.operai
N.esercenti
N.operai
Macchine per industriealimentari
1 24
Fabbriche di pesiemisure
8 16 2 4 2 2 2 2
Fabbrichedimorsiin ferro fucinato
2 4
Fabbriche di trebbiatricie sgranatoi
1 3
Officineperilgas 1 18 1 3Officineperl’illuminazioneelettrica
1 …
Fabbriche di fiammiferi
1 25 1 6
Fabbriche di oggetti incemento(pianelle,tubiepezzidiversi)
1 52
Fabbrichedi terraglie e maioliche
1 31
Fabbrichedipreparatichimicie galenici
1 14
Fonditedisevo,sapone e candele di sevo
1 2 1 3
Fabbriche di candele di cera, ceresina, ecc.
1 3 1 3
Brillatura del riso 3 13 2 46 3 17 4 27Latterieocaseifici 47 75 13 69 5 20 13 39Estrazione dell’olio daisemi
1 5 1 3 2 5 1 2
Lavorazionedellecarni suine
1 6
Fabbriche di spirito 2 8 1 1 1 1
99. Maic, Statistica industriale. Lombardia,Roma,1900,pp.462-479.
182
Fabbriche di birra 1 3Fabbriche di acque gassose
2 6 1 2 1 2 1 2
Vinispumantigassificati
1 3
Trattura della seta 2 355 1 127Filatura e tessitura della lana, riunite
1 780
Tintura, imbianchimento,apparecchiaturaestampadeifilatie dei tessuti
2 31
Fabbricazionedicordami
3 10 22 134
Conciaerifinizionedelle pelli
3 34 2 38 1 8
Tipo-litografie 6 62 2 36 1 6Segheriedilegnamee trancie da impiallacciatura
1 4 1 120
Fabbriche di carrozze
6 34
Fabbriche di pianoforti
1 3
Fabbriche di attrezzi perfilaturaetessitura
1 10
Lodi Codogno Casalpusterlengo S. Angelo Lodigiano
N.esercenti
N.operai
N.esercenti
N.operai
N.esercenti
N.operai
N.esercenti
N.operai
183
5. Sviluppo economico e istituzioni locali del Lodigiano nel secondo Novecento
di Andrea Salini
1. Aspetti dell’economia lodigiana nella seconda metà del Novecento
Ilsecondoconflittomondialeprodusse,ancheinItalia,graviconseguen-ze,talidaimpedire,nell’immediatodopoguerra,diandarealdilàdellaso-luzionedeiproblemipiùurgentirelativialsoddisfacimentodeibisognies-senzialidacuidipendevalasopravvivenzastessadellepersone.Alivellodipolitica economica non si poteva andare oltre all’elaborazione di un dise-gnoprevalentementefondatosuobiettiviabrevetermine,legatisoprattuttoalla riparazione dei danni bellici1. Negli anni della Ricostruzione anche il Lodigiano visse un periodo di
fortetransizione,segnatodaunmarcatodualismoeconomico,dovutoalla
diversaeconomiadeigrossicomunirispettoaipiccoli:neiprimiinfattiprevalgo-no leattività secondariee terziarie,mentrenei secondi lapopolazioneè inpartepreponderanteoccupatanelleattivitàprimarie,nellequali,comeènoto,è richie-
1. Per una ricostruzione delle vicende italiane nel corso del secondo dopoguerra vi èun’abbondante storiografia. In particolare, si rimanda a:A. Leonardi,A. Cova, P.Galea,Il Novecento economico italiano. Dalla grande guerra al “miracolo economico” (1914-1962), Bologna, 1997, pp. 217-250;G.Mori,L’economia italiana tra la fine della secon-da guerra mondiale e il “secondo miracolo economico” (1945-58), in Storia dell’Italia re-pubblicana,I,La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cin-quanta,Torino,1994,pp.131-230;V.Zamagni,Dalla periferia al centro. La seconda ri-nascita economica dell’Italia. 1861-1990,Bologna,1993;C.Daneo,La politica economi-ca della ricostruzione 1945-49, Torino, 1975; P. Saraceno, Ricostruzione e pianificazione (1943-1948),acuradiP.Barucci,Milano,1974;N.Colajanni,L’economia italiana dal do-poguerra ad oggi,Milano,1990;V.Castronovo,Grandi e piccoli borghesi. La via italia-na al capitalismo,Bari,1988;A.Graziani(acuradi)L’economia italiana dal 1945 a oggi, Bologna,1979;C.Daneo,Breve storia dell’agricoltura italiana. 1860-1970,Milano,1980;G. Sapelli, L’Italia inafferrabile. Conflitti, sviluppo, dissociazione dagli anni cinquanta a oggi,Venezia,1989;L.DeRosa,Lo sviluppo economico dell’Italia dal dopoguerra a og-gi,Roma-Bari,1997.
184
stainprevalenzamanod’operamaschileintipidiaziendeagricoledimediagran-dezzaedafortesviluppodimeccanizzazione,qualisonoquellediffusenelLodi-giano2.
Del resto,nel1951, inoccasionedelprimocensimentodemograficodeldopoguerra,unterzodellapopolazioneattivadelLodigianoeraancoraoc-cupatainagricoltura.Sipassavadal27%delPianoirriguodellaMuzza,al50-55%dellungoPolodigianoedellaGerad’Adda,maanchenellaprimaepiùvasta area eranonumerosi i comuni in cui gli addetti all’agricolturarappresentavanoancorapiùdellametàdeglioccupati3.Parallelamente le grandi aziende agricole gestite da affittuari si trova-
vanomaggiormente diffuse nel Piano irriguo dellaMuzza, dove costitui-vanooltreil60%,mentrelaconduzionedirettadeiproprietari, tipicadelleaziendediminoridimensioni,erapiùdiffusanelLungoPolodigiano,nel-laGhiaiad’Addalodigianaenell’areacollinareattornoaSanColombano.Leaziendeagricoleamaggioredimensione(oltre100ettari)si trovava-
nospecialmenteaBorghettoLodigiano,Brembio,Casalpusterlengo,Codo-gno,CorneglianoLaudense,Lodi,Maleo,Mulazzano,PieveFissiraga,SanMartino inStrada,Sant’AngeloLodigiano,TerranovadeiPasserini,Villa-novaSillaro,VillavescoeZeloBuonPersico.Nel restodel territorio lodi-giano,invece,laproprietàeramoltofrazionata,conmaggiorifrequenzeperleaziendeda5a15ettarieda15a50ettari4. Alla fine degli anni cinquanta Giuseppe Ellena, capo dell’Ispettorato
provincialedell’agricolturadiMilano,cosìdescrivevailLodigianovistodauntecnicoagricolochenesorvolasseilterritorio:
2.L.Sant’Ambrogio,Popolazione ed attività economiche del Lodigiano, Milano, 1958, p. 30. La spinta allamodernizzazione del settore agricolo, rappresentato soprattutto dal-la meccanizzazione, proveniva «dalla crescente industrializzazione della regione da unaparte,edallaevoluzionedeimodellidiconsumodall’altra» (P. Galea, Una trasformazio-ne incompiuta (1945-1962), in G.Rumi,A.Cova,G.Mezzanotte(acuradi),Cremona e il suo territorio,Milano,1998,p.382).ComeosservatoacutamentedaMarioRomani,nonsitrattava«diuna agricolturamortificata e resa succubedello sviluppo industriale: si trattadelsuperamentoinviadirealizzo,perlaforzadifatti,diunmododiconcepireediprati-carel’attivitàagricolaadattoperalcuniriflessisoloafasiprecedentidellosviluppoecono-mico.Insostanza, talesuperamentononsembra tantodoverconsistere,purnonescluden-dole affatto, inmodifichenegli ordinamenti produttivi enegli impieghidel suolo, quantoneicriteridiorganizzazioneedigestionedelleimprese,siafamiliari(costituitedaproprie-tàodaaffittanzecoltivatrici)cheasalariati,epercertopiùdelleprimechedelleseconde»(M.Romani,Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961),Milano,1963,p.207).
3. G. Pellizzi, Spostamenti d’attività delle popolazioni agricole del Basso Milanese e loro correnti migratorie, in Aspetti, problemi, realizzazioni di Milano. Raccolta di scritti in onore di Cesare Chiodi,Milano,1957,p.405.
4. L’economia lodigiana: profilo storico e struttura attuale,Milano,1958,pp.58-59.
185
Anzituttoun terrenopianeggiante,conuna impercettibilecadenzadanordasud,limitatoaest,aovesteasuddatrefiumi,l’Adda,ilLambroeilPo,epotrebbedi-stinguere una serie innumerevole di canali e di rogge intersecantisi fra loro; ve-drebbe inoltre numerosi centri abitati con pochi fumaioli industriali e la pianu-ra punteggiata da cascine, cioè da nuclei aziendali facenti capo ad un gruppo difabbricati (la casa del conduttore, stalle, portici, aia, case coloniche) e circonda-tidaappezzamenti regolaridi limitata ampiezza (3-6ettari), inprevalenzadiunbelverdechiaro–iprati–conaibordifoltifilaridipiantediunverdepiùscuro,dall’ampiomargineombroso.Ilprofanopotrebbeaverel’impressionedisorvolarelaTerraPromessa;iltecnicoagricolo,piùsmaliziato,capirebbeditrovarsiinunazonapernaturadestinata all’eserciziodell’agricoltura,ma resaproduttivadaunasecolarepervicacevolontàdiimprenditori5.
IlpaesaggioagrariodelLodigianorimanevadunquesostanzialmentesi-mileaquellodeisecoliprecedenti,consolidandoqueldualismotrasettoreagricolo“contadino-familiare”esettoreagricolo“capitalistico”,cheavreb-be caratterizzato il territorio lodigiano anche nei decenni successivi, co-memostranoidatiIstatdel1971,secondoiqualile1.967unitàproduttiveagricole esistenti
risultavanocosì suddivise inbasealladimensionedella superficie aziendale:247aziendeconsuperficie inferiorea5ettari (il13%delnumero totale, conunasu-perficie agricola complessiva pari al 7% della superficie agricola totale); 782aziendecon superficie compresa tra5e20ettari (pari al38%delnumero totaleeconunasuperficiepariall’11%diquellatotale);492aziendetrai20ei50etta-ri(25%delleaziende,perunasuperficiecomplessivaparial21%diquellaagrico-latotale);446aziendeconunasuperficiesuperioreai50ettari(24%delleaziendelodigiane,perunasuperficiecomplessivadi41milaettari,ossiacircail61%dellasuperficieagricolacomprensoriale)6.
5. G. Ellena, Panorama agricolo e zootecnico del lodigiano, relazione letta alla Gior-nata dell’economia lodigiana, 12 ottobre 1958, dattiloscritto conservato nella Bibliotecacomunale laudense,Lodi, pp. 1-2. SecondoEllena «anche in futuro l’ordinamento coltu-rale,acuiècollegata laclassicarotazionequinquennale, rimarràpressappocoquellocheè:unlieveritoccoinmenoalfrumento;lostatusquoperilgranoturco(cheservesoprat-tuttopergliusiaziendali); […]unaulterioreestensionedelpratodavicendae forsean-che del prato polifito pluriennale». Sempre Ellena dimostrava di non credere «all’intro-duzionerivoluzionariadinuovecolture»,quali labarbabietola, ilpomodoroe il tabacco,mentreunpossibile sviluppo lo intravedevaper la soia. IlLodigianoavrebbe invecedo-vutosfruttareunasituazionediprivilegiocheglieraofferta«dallaproduzionecontrolla-tadisemeditrifoglioladino;l’unicosemegenuinochesiproduceesipuòprodurresol-tantoqui,e sarebbeunerroreperdere l’occasionediunmonopolio, suggeritodallanatu-ra»(ibid.,pp.10-11).
6.Atti del convegno sul tema occupazione e sviluppo economico del Lodigiano, a cura dell’AmministrazioneComunalediLodi–Consorzioper ilmiglioramentosocioeconomi-codelLodigiano,Lodi,1976,p.40.
186
Inqueglianninelleaziendedimaggioridimensionisiebbe,inoltre,unaprofondaevoluzioneneicriteridigestionedeglianimalienell’assettodelleaziende.Lentamentesidiffusero
la stabulazione libera e lamungitura in sala, il silomais cominciò ad affermarsicomebaseforaggeradellarazione,siaffinòlatecnicadiconservazionedeiforag-gi tramite insilamento,venneromessiapuntopianodiprofilassie terapie idoneealcontrollodellepiùcomunipatologie.Ilmiglioramentodelletecnichedialimen-tazioneediallevamentoeilparalleloprogressogeneticodellapopolazionebovi-nadalatteprodusseroapartiredagliannisessantaspettacolariincrementiprodut-tivi7.
Altrettantodecisafulastradapercorsaversolameccanizzazionedella-voroagricolochevideunsensibile incrementodelladotazionedimacchi-neagricole,grazieaicontributipubblicicheapartiredal1952avevanoal-leggerito il costo di prestiti e mutui8. Per quanto riguarda in particolare l’allevamento, si diffusero innovazioni come lamungiturameccanica e lastabulazione all’aperto, che permisero di ridurre il numerodimungitori einsiememiglioravanolafeconditàdellevacche.La spinta alla modernizzazione del settore agricolo, rappresentato so-
prattutto dalla meccanizzazione, proveniva dalla crescente industrializ-zazione della regione, e dalla evoluzione deimodelli di consumodall’al-tra,comeosservatoacutamentedaMarioRomani,secondoilqualenonsitrattava
di una agricoltura mortificata e resa succube dello sviluppo industriale: si trat-tadel superamento inviadi realizzo, per la forzadi fatti, di unmododi conce-pireedipraticarel’attivitàagricolaadattoperalcuniriflessisoloafasipreceden-tidellosviluppoeconomico.Insostanza,talesuperamentononsembratantodoverconsistere,purnonescludendoleaffatto,inmodifichenegliordinamentiproduttivienegliimpieghidelsuolo,quantoneicriteridiorganizzazioneedigestionedelle
7. G. Succi, A. Sandrucci, La zootecnia lombarda, in L’agricoltura lombarda nel XX secolo,sl,Societàitalianadegliagricoltori,2000,pp.67-68.
8.«Nel1955ammontavanonelcomprensorioa1.805enel1965raggiungono le2.846unità,conunincrementopercentualedel60%circa.Rapportandolaconsistenzadiquestotipodimacchineallasuperficieagraria,siosservachementrenel1955esistevaunatrattri-ceogni41ettari,nel1965ilrapportosiabbassaadunatrattriceogni25,3ettari.Unincre-mentosbalorditivohannosubitoirimorchi(155%circa),mentreperquantoattieneaglial-tritipidimacchinechecompaionodal1962inpoi(mietitrebbie,motofalciatrici,autosemi-natrici,ecc.)laloroconsistenzainvaloreassolutoal1965puòservireadareun’ideadellosvilupposubitoneldecennio,essendoquasiinesistentiall’iniziodelperiodoconsiderato.Sinotiinparticolarel’elevatonumerodellemietitrebbie(167)edellemotofalciatrici(1980)»,G. Ziliani, La dinamica dell’agricoltura nel periodo 1951-1965, in Problemi del Lodigia-no, acuradell’Istituto lombardopergli studieconomiciesociali,vol. I,Milano,1967,p.95.
187
imprese,siafamiliari(costituitedaproprietàodaaffittanzecoltivatrici)cheasa-lariati,epercertopiùdelleprimechedelleseconde9.
RispettoallaprimametàdelXXsecolo,quindi, lafisionomiaeconomi-ca del territoriomutava lentamente verso quel processo di industrializza-zione,acuianchel’agricolturanonpotevasottarsi. Inmodoparticolare,siandavanomodificando i caratteri di un antico equilibro socio-economico,minando la tradizionalesoliditàdiunaorganizzazioneagricola fondatasustrutturecollaudateeconsolidatesinelcorsodeglianni,comeperesempio,la cascina, elemento compendiatore dell’intero sistema rurale, innescan-doconseguentementeunaseriedialterazionidellecondizioni sociali con-nessecon laconseguente frattura tracittàecampagna10.Undualismoche
9.M.Romani,Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961),Milano, 1963,p.207. IlprofessoredellaCattolicacontinuava la suaanalisiosservandoche,«pervenutaaduna struttura generale completamente dominata dai due tipi d’impresa più conformi al-lafaseincorsodellaesperienzaagricola, l’agricolturalombardadevequindiconrinnova-tospiritod’intrapresaaffrontareilcamminodellacompetarazionalizzazionedellesueat-tività di gestioneproduttiva e commerciale.Ciò comporta, specie per quanto concerne leaziendeaconduzionedirettadelcoltivatoreimpegnateadunanettaprecisazionedeldupli-ceruolo(sussidiariooprincipale)chepossonosostenereinunambienteeconomicodi in-tensa concentrazione industriale, la netta priorità degli sforzi diretti alla preparazione cul-turale, tecnica e professionale dei piccoli emedi imprenditori e dei lavoratori, assieme aquellimiranti a far nascere in loro l’indispensabile spirito associativo, nel quadro di unaconformepoliticaagrariagenerale.Cosìaldeclinodella ruralità tradizionalesiaccompa-gnerà lostabilirsidiunnuovoequilibrioagricolo-commerciale, incui laspecializzazionedicompitieladiversitàdifunzioninonsarannopiùlegateadormaiinaccettabilisquilibrinellecondizionidivitaedilavoro,inunacivilearmoniatral’ambienteurbanoequelloru-ralenonpiùcontrapposti»(Ibid.,pp.218-219).
10. In un articolo del 1972, quando ormai queste trasformazioni si erano andate con-solidando,AmosZanibelli,sindacalistacislino,segretarionazionaledellaFisba,esponen-tedemocristianocremoneseeprofondoconoscitoredella realtàpadana,osservava lucida-menteche«oggisipuòdireconcertezzaquantoieripotevaessereprevistoconsufficien-tefacilità; laveravittimadelprogressoagricoloè laclassicacascinapadana, lacuistrut-tura tradizionale raggruppava padroni e lavoratori,macchinari e scorte, attrezzi e bestia-me.Oggilastrutturadellacascinasipresentainmododiversoperquantoriguardagliani-mali,illorohabitat,gliattrezzi,lescorte;inmodoradicalmentenuovoperquantoriguardal’uomo.Lacomponenteumanaavevadatoluogoadunacomunitàoriginale(conlesuelot-te, isuoicontrasti, isuoiaffettiedisuoisingolarirapportiumani).Oggi lacascinaappa-recomeilluogotecnicoovesirealizza,traicampilaproduzione.L’uomoconservalapre-senza,malasuacollocazionenellasocietàsiattuainunambientechepuòessereancoralafrazione,macheprestosaràilcomuneecheinognicasononèpiùlacascina.Questodatoinconfondibile enon contestabile è il fruttodifficilmente reversibiled’una società chehavistoedhavissutolatrasformazionedell’economiaagricola.Dasettorerivoltoall’autocon-sumo, il settorehaunapropriaespressionenelmercato internoed internazionale.Daset-toredove laproduzioneseguivametodi tradizionaliconscarsesperimentazioni, il settoreseguelatecnicaediritrovatidellaricercascientificaviaviadivenutiprevalenti.Dasetto-recheabbisognavadimoltamanodoperaanchesenzatitoliprofessionali,ilsettorepreten-demenobracciaemaggiorequalificazione.Questoquadrolasciaintravedereconchiarez-
188
nel Lodigiano riguardava anche altre polarità (agricoltura-industria; gran-deconduzione-piccoleaziende;Muzza-restodelLodigiano;grandiborghiepiccolipaesi)eframmentavainmodosignificativoilterritorio.Contemporaneamente, comparve in maniera massiccia il fenomeno del
pendolarismodidecinedimigliaiadilavoratorichegiornalmenteraggiun-gevanoMilano, ponendo non pochi problemi alle strutture dellamobilità.Ledirettricidiquestamigrazionequotidianaverso il capoluogo lombardofuronotre:unasurotaia,sull’assePiacenza-Milano;duesugomma:aovestla linea automobilistica da sanColombano e da Sant’Angelo Lodigiano eadestquellachepartivadaCastiglioned’Adda11.Nonostante l’imponente crescitadelpendolarismoverso le industriedel
capoluogo lombardo, il Lodigiano conobbe un proprio sviluppo industria-le, caratterizzato da due tendenze dominanti.Da un lato, risultava ancoramoltodiffusal’attivitàditrasformazionedeiprodottiagricoli, inparticola-re l’industriadi trasformazionedel latte;dall’altro,esistevaunpromettentegruppo di aziende chimiche emeccaniche che stava prendendo il soprav-vento sui quei comparti, in particolare il tessile, che si erano affermati altempodelprimoprocessodiindustrializzazionenazionale.Lastradadiunaindustrializzazionerazionale,intesaabloccareilpreoc-
cupante fenomenodell’emigrazionependolare12 e trasformareun’economia
zacomel’uomo,nonaventeresponsabilitàdiconduzione,sisiamanmanoallontanatodalsettore.Visonorimastisoltantocolorochesonoprofessionalmentepiùformatiosonoas-solutamente indisponibili a trasferimentiper ambienti fuoridalla campagna.L’evoluzioneeconomicapretesadaunquadropoliticodiallargamentodeimercatihacosìinfluitoinunadirezionedallaqualeindietrononsitornaelacascinahasubitolaprofondatrasformazio-nesoprarichiamata.Èun’aziendadiproduzioneditipoagricolodovel’uomo,salvopocheunità, va esclusivamenteperprestare lapropriaoperamadovenon intendevivere con lapropriafamiglia,preferendostareinunacomunità»(A.Zanibelli,La vera vittima del pro-gresso agricolo, in«VitaCattolica»,LVI(1972),24,orainA.Carera,G.Fumi,M.L.Ma-rogna(acuradi),Percorsi di un uomo. Amos Zanibelli. Scritti, interventi, testimonianze, 2 voll.,Roma,1994,p.385).
11.G.Fumi,L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento. Percorsi e protagonisti, CameradiCommerciodiLodi,Milano,2009.
12.«Daunpiùattentoesamedellasituazionerisultachiaroche,anchenell’internodel-le regione settentrionali, la tendenza alla concentrazione industriale opera inmodo assairilevante e determina conseguenze negative di vasta portata: esse si compendiano essen-zialmente neimassicci trasferimenti di popolazione verso i poli di attrazione rappresen-tati dai centri industrializzati o in fase di industrializzazione. Del resto, i dati del recen-tecensimentodimostranocheifenomenimigratorinonsonoinattosoltantodalSudver-so ilNord,maavvengonoanchenell’ambitodelle regioni settentrionali.Nonoccorre sof-fermarsiperdimostrarequantosiapesanteilcostoeconomico,pubblicoeprivato,deitra-sferimentidipopolazione;eadessosiaggiungonoicostisociali,umaniemoralichetut-ti hannopresenti. Inoltre,nelle zonedi emigrazione si accentua relativamente,nello stes-so tempo, il carattere di ruralità, con un conseguente progressivo degradamento dell’am-biente; il ristagnoeconomicocomportaun ristagno socialegenerale; si rende impossibile
189
prevalentemente agricola verso una nuova dimensione industriale ottenneuncontributofondamentaledallalegge29luglio1957,n.635,cheprevede-vasovvenzioniecontributispecialiperlezonericonosciute‘depresse’del-la penisola. Laleggeprevedevachelenuoveimprese,inparticolarelepiccoleindu-
strie,chesiandavanoacostituirenelterritoriodeiComuniconunapopo-lazione inferiore ai diecimila abitanti fossero esenti per dieci anni, dalladata di inizio attività, da ogni tributo diretto sul reddito e cioè dei versa-mentidella tassacomplementare,della impostadi ricchezzamobileedel-leaddizionalivarie. Iprogrammidelleoperedaeseguirsivenivanopredi-
quell’integrazionedei redditiagricolicon i redditi industrialichepermolte famigliecon-tadinepuòrappresentareunincoraggiamentoarimaneresullaterra;equindivieneaccen-tuata la tendenza soprattutto dei giovani ad abbandonare queste zone. Queste considera-zionidimostranocomeunapoliticadilocalizzazioneindustriale,specieperquantoriguar-daleiniziativedimodestaentità,nonpossatrascurarel’esigenzadiundecongestionamen-todellezonepiùaltamenteindustrializzatedelNordediundecentramento,anchenell’am-bitodelle regionicentro-settentrionali,verso leareemeno investitedalprocessogeneraledi sviluppo» (AttiParlamentari, III legislatura–Documenti–Disegnidi leggee relazio-ni, Proposta di legge n. 3719, Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell’Italia centra-le e settentrionale).
Tab. 1 - Industrie nel Lodigiano secondo il Censimento del 1951
Tipo di attività Numero di imprese Numero di addettiAlimentari 266 2.008Estrattive 20 558Lavorazioniminerali 44 436Meccaniche 528 3.072Edili 122 2.285Chimiche 34 871Cartarie 10 29Grafiche 33 99Lavorazionedipelli 45 308Legno 321 2.545Tessili 185 2.498Vestiario 1.055 1.488Produzione e distribuzione
Forzamotrice21 329
Trasportiecomunicazioni 229 1.035Impreseserviziigienici 383 640Varie 28 530
Fonte: Elaborazione dati presenti in P. Cafaro, E. Colombo, Un’antica nobiltà. L’altro credito cooperativo a Lodi nel Novecento,Milano,2009,p.142.
190
spostiecoordinatidaicompetentiministeriesottopostiall’approvazionediunComitatodiMinistri.Perl’attuazionedeiprogrammiprevistidallaleg-gevenne stanziata la somma inizialedi406miliardidi lire, con l’obietti-vodistimolareilsorgeredinuoveindustrieedattivitàinzoneademinenteeconomiaagricola,perfavorirelosviluppodidiversifenomenieconomici,innanzituttoindustriali,maancheartigianalieturistici13.LosviluppoindustrialedelLodigianodipeseingranpartedallapossibi-
litàdiusufruiredelleagevolazionidiquestalegge,comemostrailfattochepiùdel90%dell’incrementodegliaddettinell’industriatrail1961eil1971avvenneproprionei40ComunidelLodigiano riconosciuti comeareade-pressa14. Inparticolare, leagevolazioniprevistedalla leggefavorirono l’in-sediamentodiuna settantinadi complessi industriali chediedero lavoro acirca7.000lodigiani15.Il settore secondario presentava una struttura sostanzialmente dualisti-
cacompostadapiccoleimpreseautonomeconmenodi50addettioperantialivellodimercatolocale,chedavanolavoroal46%deglioccupatinell’in-dustriaeunitàmediograndi,organizzate inmodopiùcapitalisticosiaperquantoriguardaiprocessiproduttivisiaperl’orientamentosuimercatina-zionali e internazionali16.Soprattuttofecelasuacomparsainmisuramassiccial’industriachimica
aCasalpusterlengoeCodogno,coniduestabilimentipiùimportantiditut-toilsuddelLodigiano:laLeverGibbselaMontecatini.Aquesticolossisiaggiunse la JonsManvillemultinazionale nel settore dei refrattari.AncheTavazzanoconobbeunrilevantesviluppo industriale,con l’insediamentoel’espansione dell’attività dell’Elettrosolfuri e il consolidamento della Stai,chegestivalacentraletermoelettrica,laqualeneidecennisuccessiviassun-sedimensioniimponenti.NellostessoperiodoLodivisseunasituazionecontradditoria,conilde-
clinodialcuneaziendestoricheametàannisessanta,quandoentraronoincrisiquasi tutte legrandiaziendedellacittà ealcunedi esse si avviaronoalfallimento,comeleOfficinemeccanichelodigiane,ilLanificioVaresi,oallachiusura,comeilLinificioecanapificionazionale.L’uscitadallacrisie lo sviluppodeglianni settantaebberocomeprota-
goniste altre aziende storiche, come leOfficineAdda, l’Istituto chemiote-rapico italiano, laMelchiorre Sorsi e aziende più recenti come laMotoriBassani.Lagranderistrutturazionedeiprimianniottantachiusedefinitiva-mentel’epocadellamediaegrandeindustria17.
13. Ibid.14. Atti del convegno sul tema occupazione e sviluppo,cit.,p.62.15. Ibidem.16.Ibid., p. 53.17.G.Fumi,L’economia lodigiana, cit., pp. 179 ss.
191
Danon sottovalutare era, inoltre, lo sviluppo dell’artigianato, sia quellodelletradizionalibottegheaconduzionefamigliaresiaquellopiùarticolato,conrapportididipendenzaodicooperazioneodisocietà,ingradodisvi-luppareun’efficaceepreziosaazionediapprendistatodatrasfonderepoiinognicampo,daquelloindustrialeaquelloagricoloaquellodeiservizi.Lamaggiorfrequenzadiaziendeartigiane,circail25%deltotale,appartene-va al settore dell’abbigliamento, all’interno del quale si considerava anchelalavorazionedelcuoioedellecalzature,latessituraericamo,laconfezio-nedipellicce,guantiepelletterie.Seguivanoaltrisettori tradizionalmenteavocazioneartigianale,comeilmetalmeccanico,l’edileeillegno-arredo18. Tralafinedegliannicinquantaelametàdegliannisessantavifuronopa-recchie iniziative che favorironouno sviluppodelmondoartigianale sullastradadi un completo rinnovamento, neimacchinari, nei criteri di lavora-zione,neisistemidiproduzione,nell’organizzazioneeconomicaeammini-strativa.Importante in tal senso fu la legge che prevedeva agevolazioni tributa-
rie a favore dell’ammodernamento delle imprese artigiane, con un’esen-zione«dallaimpostadiricchezzamobilesuunaquotaparial50percentodelredditonettodichiaratoperladuratadi5annienellimitemassimodel50per centodella spesa sostenuta»19. Il beneficio spettavaaquelle impre-seartigianesingoleoassociatechenei5annisuccessiviall’entratainvigo-redellalegge,investivano«gliutiliconseguitinellacostruzioneodammo-dernamento di nuovi impianti come nell’acquisto dimacchinari necessariall’impresa stessa»20. L’auspicio era che questa proposta favorisse un’ulte-riore spinta da parte degli artigiani a rinnovare imacchinari, a costruirenuovi laboratori o comunque ad apportare sensibilimiglioramenti alle at-trezzature.Taleevoluzioneeraritenutaindispensabilesiaperfavorireunri-equilibriotecnicotralevariecategorieimprenditoriali,siaperfavorirel’e-voluzione di tali imprese, «per la auspicabile celere evoluzione necessariaper l’attuazione del trattato del Mec»21.Nel corso dei decenni della seconda metà del Novecento, dunque, la
struttura produttiva del secondario nel Lodigiano fu caratterizzata dallapresenza di un cospicuonumerodi piccole imprese artigianali e, contem-poraneamente,dialcuneaziendeconosciutealivellonazionale,oltreaunacostellazionediimpresecomplementari.
18. L’economia lodigiana, cit.,p.66.19.AttiParlamentari,IIIlegislatura–Documenti–Disegnidileggeerelazioni,Propo-
stadi leggen.1994-A,Agevolazioni tributarie dirette a favorire l’ammodernamento del-le imprese artigiane.
20.Ibidem.21. Ibidem.
192
Aquestoproposito,èinteressanteosservarecheancheseilterritoriolo-digiano non presentava le carattistiche tipiche delle esperienze distrettua-lipropriamenteintese,vieracomunquelapresenzadialcunemedieimpre-sepotenzialmenteingradodiesercitareunafunzionedileadershiplocale:èilcaso,adesempio,dellaPolenghiLombardo,notaaziendalattierocase-aria,laprimaadavercommercializzatoillattesterilizzatoalungaconser-vazione, che rivoluzionò il settore e contribuì sensibilmente ad incremen-tareilconsumodilattetragliitaliani.L’indottochetaleimpresageneravaeraimmediatamentevisibilenellosviluppodellenumeroseaziendeagrico-leezootecnichepresentisulterritorio,nonchénellanascitadidiverseoffi-cinemeccanichenel capoluogo, cheproducevanomacchineagricole, carrimercieimpianticompletiperlelavorazioninelcampoalimentare22. Si trattava, dunque, di un sistema locale in grado di guidare il proprio
processodisviluppoeditrasformazione,capacediraggiungereelevatigra-di di specializzazione, innovazione tecnica, professionalità dei lavoratori,convantaggi siadigrandedimensione, coneconomiedi scala, siadipic-cola,conlaflessibilitàproduttiva.Questidueelementieranoproprioicon-notati fondamentalidell’area sistema,determinatidauna seriedivariabiliconcatenate,chepotevanoessereindividuatecomeifattoridisuccessodelsistemaproduttivolocale.Laflessibilitàerabasatasullapiccoladimensionedegli impiantiprodut-
tivi,sullerelazionitraleimpreseesullavelocitàdirispostaeadeguamentodellePmiallemutevolicondizionieconomiche interneedesterneall’area;inparticolare,essaeragarantitadaduegruppidivariabili,ilprimostretta-mente legatoaiconnotatidellaformazionesociale locale, ilsecondocom-postodavariabiliconnesseallastrutturaproduttiva.Tralevariabilirelativeallastrutturasocialedell’arearientravanolanascitadinuovaimprenditoria,ilconsensosociale,unaprofessionalitàdiffusa,comerisultatodiunasedi-mentazionestoricadiconoscenzerelativealcicloproduttivoealletecnicheutilizzate,laflessibilitàdelmercatodellavoro;quelleconnesseallastruttu-raproduttivaerano,invece,unacrescentedivisionedellavorotraleimpre-se, che facilitava la specializzazione produttiva, e l’introduzione di nuovetecnologie,cheaumentaval’autonomiadellesingoleimprese.Difronteallacrisidelleaziendedidimensionipiùgrandi l’ambienteri-
sposecosìconlavitalitàdeltessutocostituitodallepiccoleemedieimpre-se.Ciò fu possibile anche perché una delle componenti fondamentali del-lo sviluppo locale era la capacità delle imprese di fare sistema, operandoinmodoassimilabileadun’entitàorganicamenteintegrata,capacediconfi-
22. Tracce di neoborghesia nelle piattaforme produttive lombarde. Un viaggio tra Son-drio, Varese, Brescia, Cremona, Lodi e Milano, a curadiUnioncamere lombardia,Mila-no,s.d.,pp.72-73.
193
gurareuncontestoincuiicaratteridaprivilegiareeranoquellicooperativipiuttostochequellicompetitivi,inmodochel’ambientestessopotessefun-geresiadaspaziodisostegno,utileallabuonasopravvivenzadelle impre-segiàoperanti,siadastrutturaincubatriceperquelleinfasediformazione.Allarobustezzadeltessutoproduttivosiaffiancavaquindiunospaziodi
sostegno complesso, in cui le relazioni convergenti tra i diversi attori delprocessodisviluppogarantironolacompetitivitàdinamicadelsistemater-ritoriale.Lapresenzadiquestotessutorelazionalehapermessocosìdisvi-luppare iniziative in grado di favorire e sostenere l’azione individuale, inmodononestemporaneo,permettendoneunpiùefficaceesplicarsi,attraver-so attività volte alla riproduzione del capitale umano, alla diffusione del-lenuovetecnologieeaquelledifinanziamentodelleimpresedelterritorio.Inun talequadro, riacquistavaun ruolosignificativo lapiccolaemedia
dimensione,infortecontinuitàconlastoriadiquestoterritorioperquantoconcernelestruttureorganizzativedelsistemaeconomicoesociale,all’in-ternodiunaculturalocaleingradodiprodurrenorme,tradizioni,compor-tamenticodificatieistituzioniche,neltempoenellospazio,hannoinfluitoinmanierapositivasull’agireeconomico23. Come è noto, infatti, lo sviluppo locale è l’esito dell’attivazione di for-
ze locali che mettono in campo risorse endogene ed esogene ai territoriper progettare e realizzare programmi condivisi, utilizzando tutto il buo-nocheesisteall’internodei luoghi, in raccordocon risorse e competenzeesterne24.
23. G. Garofoli, Industrializzazione diffusa in Lombardia. Sviluppo territoriale e siste-mi produttivi locali,Milano,1983,pp.92-96.
24.Untestodiinquadramentosullosviluppolocaleè:ConsiglioItalianodelleScienzeSociali, Tendenze e politiche dello sviluppo locale in Italia. Libro bianco,Marsilio2005.Sivedaanche:C.Trigilia,Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia,Laterza2005.Leva-riabiliendogenenellosviluppodeisistemidipiccoleimpresesonoanalizzateinA.Bagna-sco, La costruzione sociale del mercato, ilMulino1988.GiacomoBecattiniargomentainmoltisuoitesticome,perparlaredisviluppolocale,occorraprestareattenzioneallediver-sitàprodottedallastoria:vediades.G.Becattini,Mercato e forze locali: il distretto indu-striale, il Mulino 1987; G. Becattini, Distretti industriali e made in Italy. Le basi sociocul-turali del nostro sviluppo economico, Bollati Boringhieri 1998. Spunti sul nesso tra saperi dilungadurata,risorseambientaliesviluppolocalesonoinA.Natali,Risorse ambientali e sviluppo: i saperi e le regole,Artimino2002(scaricabiledalsitowww.eco-eco.it, sezio-ne“Leorigini”).Sempresul temadellosviluppoeconomico localesivedanoanche:Mo-delli di sviluppo locale,Milano,2006;Economia regionale: localizzazione, crescita regio-nale e sviluppo locale, a curadiR.Capello,Bologna, 2004;A.Tulumello,R.Foderà,V.Pipitone, La misura dello sviluppo locale,Milano,2007.
194
2. Le leve dello sviluppo per la modernizzazione del territorio lodigiano
Il temadellosviluppoeradelresto laquestioneprincipalechenellase-condametàdelNovecentosiposedifrontealleclassidirigentilaudensi.Ildestino economico dell’area andava trovato nella ricerca di una continuasintesitrasviluppoagricoloeconcentrazioneindustriale.Già negli anni cinquanta il progresso tecnologico, avviando il proces-
sodimeccanizzazionedell’agricoltura,avevasovvertitotutti irapportichepresiedevanoall’utilizzoeall’impiegodellamanodopera. Ilnumerodiad-detti richiestoperunitàdicolturasieracosìandatoassottigliandosempredipiù,creandoinunprimomomentolanecessitàdell’imponibiledimano-doperapercontenere il fenomenodelladisoccupazione, in seguito supera-to per il contemporaneo formarsi di ampie occasioni di lavoro nel settoreindustriale,per lamaggiorparteperò fuoridal territorio interessato,con iconseguentifenomenidimigrazioneodispostamentopendolare.Naturalmente ciò non presupponeva una marginalizzazione dell’econo-
mia agricola, che andava anzi rilanciata attraverso l’espansione di formeassociative ad ogni livello e di ogni tipo emediante il contributo dell’as-sistenzatecnicaafavoredellepiccoleemedieaziendeagricole,qualecom-ponente dello sviluppo, con una serie programmata di interventi organi-cididiversanaturaedindiversisettoriperconseguirealtilivellidiredditoemigliori condizioni di vita. In particolare, si sollecitava il potenziamen-todelleattivitàdeiCentridiAssistenzaTecnicaeAgraria,iqualiavevanoloscopodimigliorarel’efficienzatecnicoeconomicadelleimpreseagrariee le capacità professionali degli imprenditori e degli addetti all’agricoltu-ra, conprestazioni rivolte, a livellodelle singole imprese, almiglioramen-todelletecnicheedellecombinazioniproduttive,allemodifichedellestrut-tureaziendali,allemodalitàdivenditadeiprodottiediacquistodeifattori,all’assistenzaalledecisioni inmateriadi reperimentoedi investimentodicapitali.Vi era, inoltre, un obiettivo extra aziendale, perseguito attraversolapromozioneelaconsulenzadiattivitàsvolteinformaassociataperl’ac-quisizionee lagestionedeimezzi tecnici, la trasformazionee la commer-cializzazione dei prodotti. Nelmedesimo tempo, l’attivitàdiassistenza tecnicaagrariacomportava
l’erogazionedialtriservizirivoltialmiglioramentodellecondizioniecono-micheesocialidell’ambienteinteressato.Essa,infatti,nell’assolverelapro-pria funzione, compiva un’azione sia formativa-educativa che informati-va: laprima,perchéglielementimessiadisposizionedapartedel tecnicoall’agricoltore valorizzavano le sue capacità, l’intelligenza, il senso di au-to responsabilità per le sue decisioni e le sue scelte; la seconda, perché pre-stando un servizio all’agricoltore,metteva a sua disposizione una serie dinozionitecnicheedeconomicheperlamaggioreefficienzaaziendale.
195
Per la zona agricola del territorio lodigiano le prospettive di sviluppovenneroindividuatenellarazionalizzazionedeimezzidiproduzione,dila-vorazioneedidistribuzionedeiprodottiagricoli;nellacreazionedinuovealternativeocomplementiall’attivitàagricolaperimpiegarelamanodoperainesuberodalleattivitàagricole;maanchenelpotenziamentosubasiasso-ciativedellestrutture,deiservizi,degli impiantiperelevareilgradodiat-trezzaturaedidotazionedeicentriresidenzialial livellodelleattrezzaturee delle dotazioni delle città; nel rinsaldare e far rivivere lemigliori tradi-zionistoriche,culturali, religiose,artistiche,perpetuandolavitalitàdi tuttiqueivaloripositividicuiilterritorioeradepositario;nelrafforzare,infine,eproporzionareirapportidiinterdipendenzaconipoliurbanidimaggioreimportanza,internioesternialterritorioconsiderato25.Ancoraametàannisettantarimanevadiattualitàiltemadellavocazio-
neproduttivadelLodigiano,comeemergedall’interventoche ilprof.Car-loRicciardifecealconvegnosul tema“Occupazioneesviluppoeconomi-codelLodigiano”,organizzatonel1976dall’AmministrazionecomunalediLodi e dalConsorzio per ilmiglioramento socieconomico del Lodigiano.Nellesueconclusionieglisottolineavache
lastrategiageneraledi sviluppodelLodigianocheoccorreassumerecomepuntodipartenzaperdefinire le tatticheogliorientamentidi interventoneisingoliset-tori e sui singoli problemi, sembra essere quella di un potenziamento dell’attua-le specializzazioneproduttivadelcomprensorionell’attivitàagricola, associatoadun impegno di attenuazione e progressiva eliminazione degli squilibri (in termi-nidireddito,dotazionediservizisociali,ecc.)chelastessacomporta.D’altrapar-te,questaprioritàassegnataall’agricolturanondeveesserintesacomeattribuzioneall’attivitàprimaria(purseallargataallaprimatrasformazionedeiprodottiagrico-li)diunruolodimotoredellosviluppodelcomprensorio,inquantolecaratteristi-chee ladimensionedei suoiproblemi (soprattuttodiquellooccupazionale)appa-ionoampiamentealdilàdiognipossibileriorganizzazionedell’attivitàagricola26.
Del resto,giàallafinedegliannicinquanta,AldoDeMaddalenaavevaautorevolmentericordatoche
nonsipuòdimenticare–equi ildiscorsoritorna inchiavestorica–che l’altissi-molivelloraggiuntodall’economiaagrariagiàallametàdelloscorsosecoloèsta-tounosprone,piùomenocoscientementeavvertito,perogniiniziativaaventeca-rattere e destinazione rurale.Unamentalità e una sensibilità acquisite e radicatenelcorsodeisecolinonpossonoessererimosseemodificatecheinunlungope-riododitempo.Oggiperòchel’attivitàmanifatturieradà,senzadubbio,iltonoadogniprogrammadisviluppoeconomicosaràforseopportunochesioperi,ancor-
25. Problemi del Lodigiano,cit.,vol.I,pp.383-391.26.Atti del convegno sul tema occupazione e sviluppo, cit., p. 57.
196
ché con lamassimacautela, un ridimensionamentodella struttura economicadellodigiano.Hodettoconlamassimacautela,chénonbisognadimenticarecheunaricchezzaagricolacomequelladicuibeneficialaterralodigianaèunpatrimoniotroppopreziosoperchépossavenireintaccatoeresomenoefficientedaunapoliti-caeconomicatroppoambiziosaerischiosa27.
Legato a questo temaprioritario vi era l’obiettivo di realizzare una co-erente azione di sviluppo sociale e di ristrutturazione del territorio, deli-neando la“città-territorio”delLodigiano,componendo i fenomenidipro-duzione con i problemi di vita. La razionalizzazione degli insediamentiumanidovevacomportare,infatti, ladotazionediadeguatiservizidicivil-tà,cosìdaassicurarestandarddivita talidaconsentireallecomunità tra-dizionalidiconservare le loro funzioniedaevitare,conseguentemente, lafugadellapopolazionealla ricercadimiglioricondizionidiambienteedivita.Ilproblemariguardavasoprattuttoleabitazionirurali,incuiisalaria-tivivevanoincondizioniprecarieelesivedellalorodignità.Iprimitenta-tividelloStatodiincentivarelapossidenzaamigliorareleabitazioniruralinonebbero troppo successo.Decisiva si rivelò, invece, la legge30dicem-bre1960n.1676,propostadalsegretarionazionaledellaFisbaCisl,AmosZanibelli e da alcuni parlamentari sindacalisti, approvata allaCamera deideputati,doponumerosepropostedileggeeinterrogazioniparlamentari.La legge prevedeva l’impegno finanziario dello Stato per un decennio
conunaspesadi150miliardipercostruirecasecolonicheperuncomples-sodi400milavani.Ilproblemadellacasacontadinanonpotevaforsedirsicompletamenterisolto,macertamentesisarebberegistratounnettomiglio-ramentorispettoallecondizionidisastroseprecedenti.L’elementonuovo era l’ampiezzadellematerie decentrate: in sede loca-
ledovevanoesseredeterminatisiaicriteridicostruzione,chel’ubicazioneelecaratteristichecostruttive,inmododatenercontodelleesigenzelocali,nonperòalpuntodideterminaresituazionidi isolamento28. Si scelse dun-quedicostruireleabitazioninonisolatenellacampagna,mavicineall’abi-tatodeicomunirurali,inmodocheisalariatiagricolifosserointegratinel-lacomunità.La tipologia degli edifici fu prevalentemente quella della casetta unifa-
miliareaschiera,semplicemadotatadituttiiservizi,conunpiccologiar-dinosuldavantie l’ortosul retro.Leabitazionicostruitecon la leggeZa-nibelli furono alcune decine di migliaia in tutta Italia e consentirono aisalariatiagricoliunnuovomododivitaversounavitapiùciviledei lavo-
27. A. De Maddalena, Appunti sull’economia lodigiana nel suo profilo storico,CameradiCommerciodiMilano,Milano,1958,pp.15-16.
28. A. Zanibelli, Così dovranno essere,in«VitaCattolica»,XLVII(1961),4,orainPer-corsi, cit., p. 237.
197
ratorideicampi,secondol’ideabasecislina,cheeraquelladidareunaca-saalcontadinoeallasuafamiglia,peroffrirglicon lacasa lasua libertà.Conunmigliaiodinuovialloggi,ladecimapartecircadeinucleifamiliarioperantinell’agricolturavidesoddisfattaunadelleesigenzeprimarieel’ul-terioreattuazionedelprogrammadicostruzioneavrebbecostituitounadel-lecondizioniperildefinitivoequilibriodelsettoreagricolo,anchedalpun-todivistadegliaddetti.Inqueglianni,infatti,eraripresol’esododallecampagne,facilitatodal-
la rilevante meccanizzazione, dall’impiego di sempre più moderne tecni-checolturali,dallarazionalizzazionedegliallevamentiedei lavoridistal-la,maancheagevolatodaquellacondizionedivitadeicontadinideicentrisparsi nella pianura, del tutto insoddisfacente rispetto alle esigenze di be-nessereormaigeneralizzatesiadoperadeimezzidicomunicazionedimas-sa,perseguendol’obiettivodiunmiglioramentodellacondizionedivitadei
Tab. 2 - Case contadine costruite nel Lodigiano con la Legge Zanibelli
Località Alloggi Costo totale
TerranovaPasserini 12 42.274.923Maleo 16 57.717.620Brembio 14 55.910.060TuranoLodigiano 12 15.410.713Bertonico 9 43.818.870Casalmaiocco 9 43.410.000Casalpusterlengo 9 44.622.110CaselleLurani 9 49.047.330CaselleLurani 4 25.351.970Cavacurta 9 43.890.840Cervignanod’Adda 9 43.817.700CornoVecchio 9 44.044.210CortePalasio 9 43.430.110Crespiatica 9 43.627.160Lodi 9 41.890.640Lodivecchio 9 56.341.900MontanasoLombardo 9 43.041.290Mulazzano 9 55.601.560S. Rocco al Porto 9 43.759.720Somaglia 9 48.709.950Tavazzano 11 53.790.720ValeraFratta 9 44.728.170VillanovadelSillaro 9 43.463.460
Fonte:Vivere di cascina: testimonianze di vita e lavoro nelle campagne lodigiane,Cassa rurale diBorghettoLodigiano,1985,p.178.
198
lavoratori, all’interno di un processo dimodernizzazione di tutto il setto-reagricoloesecondounaconcezionedisviluppoeconomicocheprevedeval’integrazione di questo con quello industriale.In provincia di Milano e, in particolare, nel Lodigiano la costruzione
delleabitazionivennefacilitatadallanascitadicooperativeedili,checon-sentivanodiridurrealivellimoltobassiicosti-vano.Lelocalitàinteressatefurono:BorghettoLodigiano,Brembio,CorneglianoLaudense,CornoGio-vane,CornoVecchio,Maleo,Mulazzano,S.ColombanoalLambro,S.Fio-rano,S.RoccoalPorto,Boffalorad’Adda,Graffignana,Guardamiglio,Lo-di,S.StefanoLodigianoealtre.Un progetto globale di sviluppo del territorio passava, inoltre, dal raf-
forzamento delle infrastrutture, condizione indispensabile sia per l’incre-mento delle attività industriali, soprattutto di trasformazione dei prodottiagricoli, sia per facilitare il movimento delle persone. Ciò avrebbe evita-to,daunaparte,unadellepossibilicausedeglieccessivimovimentimigra-toridella forza lavoro localeverso igrandi centri industriali, inparticola-reMilano,favorendoquindiglispostamentideipendolariinmododapoterraggiungereiluoghidilavorodallezonediabitazionee,dall’altra,avrebbesostenutoiltrafficocommercialelungoledirettricicheinteressavanoilter-ritoriolodigiano.Ilprogressotecniconelcampodeitrasportiedellecomu-nicazioni avrebbe consentito amolti di continuare a vivere nelle zone ru-rali, esercitando tipidiversidi attività accantoaquelle agricole epotendobeneficiaredilivellidiredditoedicondizionidivitaequiparabiliaquelleesistenti incittà.Nelventicinquenniodopolafinedellaguerra il territoriolodigiano, infatti,anzichésubireun’emoraggiademograficahavisto lapo-polazioneabbandonarelecascine,lefrazionieipiccolicomuni,maperin-sediarsineicomunimaggiori,comeLodi,Codogno,Casalpusterlengoo in quellipiùvicini al capoluogo lombardo, comePaullo,Sordio,Dresano, li-mitandosiquindiadunasortadi‘migrazioneinterna’all’area29.Inparticolare,losviluppodeitrasportisugommaedellamotorizzazione
privatanontrovòimpreparatiglientilocalieisuoirappresentanti.Gliin-vestimentinellaretestradaleprovincialefuronoingenti:oltreall’Autostra-dadelSole, chepercorreva il comprensorio lodigiano in tutta la sua lun-ghezza,
l’ossaturadelsistemastradaledelLodigianoeralastradastatalen.9(viaEmilia),insiemeconlastatalen.415(Paullese)per lapartesettentrionaledelcomprenso-rio. […]Sulfiniredegliannisessanta laProvinciaportòa termine l’ammoderna-
29. E. Tarulli, Le condizioni delle abitazioni, in Problemi del Lodigiano,cit.,vol.III,p.90.
199
mento della strada provinciale n. 107 (Lodi-Ospedaletto) e della sua prosecuzio-neconlastradan.106(Ospedaletto-Codogno),cosìdaavereunitinerariodaLodiaCodognodenominato strada provinciale “Lodigiana” sostitutivo della viaEmi-lia.Nelcontempofurealizzata lanuovacirconvallazioneanulareasuddiLodielestradeprincipalivenneromiglioraterettificandoi tortuosi tracciati,ampliando-li,eliminandoipassaggialivello,sistemandogliinnesti,riducendogliattraversa-mentidegliabitatiattraversoalcunevarianti30.
Accantoalpotenziamentodellareteviariaediquellaferroviaria,nelse-condo dopoguerra la grande opera infrastrutturale che interessò il terri-torio lodigiano fu il progettoper la costruzionedel canalenavigabileMi-lano-Cremona-Po. Subito dopo la fine del conflitto bellico, nel momentodella ricostruzionedemocratica e economicadell’Italia, la navigazione in-ternaincominciòarichiamarel’attenzionedelGoverno,deglientipubblicieprivati, dei tecnici edegli operatori economici, i quali constataronochele idroviedelnostroPaese, seppure incorsodi sistemazioneedi comple-tamento,equindimenoefficientidiquelledimoltialtriStatieuropei,po-tevano consentire buone condizioni di trasporto allemotocisterneda 800,da1.000eaddiritturada1.350tonnellatediportata.Ilmezzodi trasportoidroviario presentava dunque condizioni di esercizio particolarmente eco-nomicheeperunalargacategoriadimercipovereepesantieraingradodifarsipreferireaimezziconcorrentidellastradaedellarotaia.Nelcorsodegli annivenneroorganizzatinumerosiconvegniperappro-
fondire l’impattocheun’operadiquesto tipoavrebbepotutoavere sul ter-ritorio lodigiano. Particolarmente significativo fu quello organizzato nelgiugno 1960 aCodogno, con la partecipazione di rappresentanti di enti eamministrazioni pubbliche del Lodigiano, delMilanese, del Cremonese edialtreprovincie limitrofe.L’incontro feceemergereungeneralesostegnodeiterritoriinteressatialtracciatolodigiano-cremonesedelcanale,unpro-gettochedisponevagiàdistudiapprofonditiecheavevaallespalleinvesti-mentiultradecennalidelloStatoperlasistemazioneidraulicadelPoinre-lazioneallasuanavigabilità.Permanevanonaturalmenteanchedubbieperplessità,soprattuttodapar-
te delmondo agricolo lodigiano, come sottolineato daArnaldoGualazzi,esponentedell’Unioneprovincialeagricoltori,inquell’occasione:
Intanto il canale viene a tagliare il comprensorio dellaMuzza che è […] la zo-napiùfertiledellaprovinciadoveleroggediirrigazionesonofrequentissime.[…]Poiilcanale,attraversandovastezone,conservandounaregolarelineadipenden-za,dovràesserefattoparte in trincea:sisupponequindichepossaessere turbatala falda freatica. […]Altropuntochepreoccupagli agricoltori èquesto: sembra,
30.G.Fumi,L’economia lodigiana, cit., p. 151.
200
dalleultimedichiarazionifatte,chel’acquadelcanaledebbaessereinparteattin-taanchedallafaldafreaticaattraversata,anzichéproveniresolodalTicino.Preoc-cupavainoltreche
laleggefondamentaledel1913stabilissechelanavigazioneèl’oggettoprincipaleacuiservonoilaghi,icanali,ifiuminavigabili.Quindiaquestoprimofinesonosubordinatituttiglialtri;oraèevidentechegliagricoltorisipossonopreoccuparechel’usodelleacquedelcanaledebbaessererivoltosoprattuttoaserviregliinte-ressideitrasportiedaultimo,soltantodaultimo,quellidell’agricoltura31.
Per superare gli ostacoli che provenivano dal mondo agricolo, già apartiredagliannicinquanta ilConsorziodelcanalenavigabile, l’enteco-stituito nel 1941 per la costruzione dell’intera opera, aveva studiato co-merimediareaiproblemichel’operaarrecavaall’ambienteagricololodi-gianoesudmilanese,conilcoinvolgimentoanchedegliagricoltoriedellaCongregazionedellaMuzza.Questofatto, insiemeall’interessedellapos-sidenzaauna rivalutazionedeivalori fondiari portò amodificareunpo’l’orientamento negativodi parte delmondo agricolo nei confronti dell’o-pera32. L’ingegner Angelo Parisio, direttore della Congregazione dellaMuzza,riconosceva,adesempio,che«un’operacomel’idrovia,cheanco-rapochiannifapotevaancheritenersinocivaallanostrazona,puòinve-ceoggiesserenonsoloutile,manotevolmentefavorirelosviluppoecono-micodellastessa»33.In realtà rimasero ancora molti dubbi, non tanto per il canale in sé,
quantoperisuoieffettiindiretti,cioèperun’industrializzazionecheavreb-be prodotto conseguenze negative sull’agricoltura lodigiana, anche in ter-mini di disponibilità e di costo della manodopera, come sosteneva l’in-gegner Carlo Biancardi, Presidente del Consorzio di bonifica della BassaLodigiana:«L’esistenzadelcanaleelaconseguenteindustrializzazionedel-la nostra zona non porterà alla economia agricola dei vantaggi, creerà alcontrariodelledifficoltà,comeadesempio l’inevitabileallontamentodallacampagnadellamanod’operaqualificata»34. Chi invece sosteneva lo sviluppo e la trasformazione del Lodigiano da
economiaagricolaadagricola-industrialeeconciòilriequilibriotraledi-
31. Il canale navigabile Milano-Cremona-Po e lo sviluppo economico del Basso Mila-nese.Attidelconvegnodistudi,Codogno,29giugno1960,Milano,1961,p.30.
32.E.Dalmasso,Milano capitale economica d’Italia,Milano,1972,p.100.33. Il canale navigabile, cit., p. 31.34. Ibid., p. 32. Biancardi continuava il suo intervento riconoscendo comunque che
«puressendosicurodelsorgerediquestedifficoltà,poichél’industrializzazionediunazo-naportaun’elevazioneeconomica,conconseguenteaumentodel redditomedio,anchegliagricoltoricodognesidevonoessereincondizionatamentefavorevoliallacreazionedellere-teidroviaria»(Ibidem).
201
verse aree delMilanese si mostrava decisamente favorevole alla creazio-ne del canale navigabileMilano-Cremona-Po, di cui avrebbero certamen-tetrattoprofittoleraffineriedipetrolio,icomplessisiderurgici,leindustriechimiche,glizuccherifici,lecartiere,leindustriedelcemento,deimateria-lidicostruzione,quelleagricoleedalimentari.Ampiorizzontisisarebbe-ro aperti anche alla navigazione commerciale, comegià accadeva inmol-ti Paesi esteri, con il cabotaggio di penetrazione, destinato ad avvicinaresensibilmente le regioni produttrici rivieraschemarittime ai grandi centridell’entroterrapadano,conilmovimentodellemerciedellematerieprimed’oltremare,nonchédeicombustibilisolidieliquidie,infine,conilpiccolocabotaggio,tessutoconnettivodituttelezoneservitedall’idrovia,destinatoadalimentaremiriadidiattivitàedipiccolitraffici35.Cinqueannipiù tardi, ilComunediLodiorganizzòunaltro importan-
tissimoconvegno,intitolatoIl Lodigiano e l’idrovia padana,nelqualeven-nero espresse chiaramente le varie posizioni delle elité locali su questoprogettoconsideratoprioritario in terminidisviluppocomplessivodel ter-ritorio laudense.Comericordato inaperturadall’On.leCamilloRipamonti,già ilconve-
gnodiCodognodel1960al terminedellediscussioniedeiconfrontiave-vasottolineato
l’importanza dell’idrovia padanaproprio aifini della valorizzazione delLodigia-no e l’adesione dei Comuni del Comprensorio, delle organizzazioni della produ-zioneedel lavoroharappresentatolapremessaindispensabileperlapresentazio-nealParlamentodellapropostadileggeN.3265del28agosto1961,divenutapoila leggen.1549del10ottobre1962«Integrazioniemodificazionidella legge24agosto 1941 n. 1044 per la cotruzione del Canale Navigabile Milano-Cremona-Po»,nonchédelleiniziativedipoliticaurbanisticaassuntedaiComuniattraversa-tidalCanale36.
L’adesionedelLodigianoeraconsiderata fondamentalesiaperaccelera-relacostruzionedellanuovaviadinavigazioneinterna,siaperinserireunagrande opera infrastrutturale di questo tipo nel processo di ristrutturazione delterritorio,conl’obiettivodirealizzareunnuovoequilibriofraindustriae agricoltura, superare gli squilibri tradizionali e far raggiungere alla popo-lazionestandarddivitapiùelevati37.Nel susseguirsi degli interventi, pur ribadendo la validità del progetto,
molti sostennero la necessità che il canale venisse inserito nei primi pas-
35. Ibid., p. 45. 36.Il Lodigiano e l’idrovia padana,Attidelconvegnodegliamministratoricomunalie
degliorganismipolitici-economiciesindacali,Lodi,28novembre1965,Lodi,1966,p.12.37. Ibidem.
202
sidellapianificazione territoriale.Perquesto ledecisioninonpotevanori-guardare esclusivamente gli apparati dello Stato e il Consorzio per il ca-nale,malagrandeinfrastrutturadovevaesserecoordinatacongliobiettividellaprogrammazioneeconomicae sociale regionale. Inoltre furonoauto-revolmente manifestate alcune perplessità sulla sostenibilità del progettodalpuntodivistaeconomico-finanziario38. Undato che venne ribadito insistentemente riguardava la costruzione a
Lodi o nelle sue vicinanze di un porto industriale; a questo proposito, ilsindacodiTuranoLodigiano,Pettinari,dichiaròcheLodipotevaessere
ritenutouncentro importantedicomunicazione traparecchieprovinciesulpianointerregionale,oltrealfattocheilComunediLodisitrovanellecondizionidifor-nire iservizinecessari […].NaturalmentenoiamministratoricomunalidelLodi-gianodobbiamo essere d’accordo conqueste opinioni e le dobbiamo fare nostre.Dobbiamo portare avanti la battaglia inmodo unitario, perché nella elaborazio-nedelpianocomprensorialedelcanalesiaconsiderata lapossibilitàdiattrezzarequestazonadelleinfrastrutturenecessarieperfarnediLodiunpoloindustriale39.
Posizione condivisa dal Presidente dell’Unione Artigiani di Lodi, ilComm.Gorla, che nel suo intervento sottolineò il peso determinante del-lacostruzionedelCanalenavigabileMilano-Cremona-Ponellenuovepro-spettivedisviluppodelterritoriolaudense,«maciòpotràavverarsisoloseil porto verrà costruito a Lodi, o quantomeno nelle sue immediate vici-nanze, perché in caso contrario i vantaggi che ne potrebbero derivare sa-rebberodientitàtrascurabile,ocomunquenondeterminantinellasoluzionedefinitivadelproblemadellanostraeconomia»40.Lo stesso sindaco di Lodi, Natale Riatti, nel suo intervento conclusivo
fecenotarecome
lacreazionediun’operacosìvastaecomplessacomesaranno ilportoe l’attiguazonaindustriale,abbisognanodellavicinanzadiuncentrourbanocheoffralaco-moditàdituttiiservizipubblicieprivati:funzionecheLodipuòdegnamenteas-solvere.Uncentro industrialeedeconomicocomequellochene risulterebbeperfunzionare regolarmente non può trovarsi isolato,ma deve avere alle spalle tut-te le infrastrutture economiche e commerciali necessarie. […] In questi terminisiponel’alternativatraipolidiLodiediMelegnano,einordinealleconsidera-zionifattecisembracheilpolodiLodipresentimaggiorivantaggi.Èchiaro,co-meabbiamogiàdelrestosottolineato,chelasceltainunsensooinaltrodipendedal diverso prefiguarsi della dimensione e della direzione dello sviluppo dell’a-reamilanese.Maancheprevedendotaleespansioneneiterminipiùrestrittivinon
38.Perplessitàevidenziateanchedallostudiodell’Ilses(sivedaProblemidelLodigianocit.,vol.III,pp.522-525).
39. Il Lodigiano e l’idrovia padana,cit.,p.56.40.Ibid., p. 74.
203
sipuòignorarechefinoaMelegnanoil territoriosipresentagiàconlecaratteri-stichediun“continuourbanizzato”,cioèfacilmente,pureselentamente,saturabi-le.Laproiezionedi fortiattività industrialiversoLodioffre […] lapossibilitàdioperareunasoluzionedicontinuitàneltessutourbanizzatoconfasceverdidifil-tro, nonché di creare, senza interferire con proiezioni o aree di riserva residen-ziale, adeguate specializzazioni industriali, che, se pure da alcune parti si danno superatecomemodernomezzodipianificazione,tuttaviadebbanopienamenteve-rificarsinelcontestodiunsistema infrastrutturale rigidocomequello idroviario.Restaancorailproblemadellaprecisazioneinsediativaditalielementi,dovendo-si,adesempio,consideraredinecessariaattuazioneancheilpolodiCodogno-Ca-salpusterlengo41.
Tra il 1960 e il 1984 il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po re-alizzò, con fondi propri e contributi statali e locali, il primo tratto di 15chilometri da Cremona e Pizzighettone e il porto di Cremona con l’areaindustriale adiacente, inaugurati ufficialmente nell’ottobre 1969. Il prose-guimento dell’opera, invece, continuò a suscitare molte opposizioni loca-linel territorio lodigiano,alpuntoche l’infrastrutturanonvenneportataatermine,neppure ilprogettoalternativodiBertonico,cuiauncertopuntosiguardòperilrilanciodelprogetto42.Traleideepiùtenacicheilmilieuistituzionaleeculturalelodigianoha
coltivatonegli anniungrande rilievoebbeanche la«ricercadelnesso traistituti di formazione e innovazione economica nel solco delle specificitàlocali»43.Leèlitelodigianiavevano,infatti,inmenteunmodellodisvilup-po che prevedeva la difesa dell’agricoltura e solo successivamente la pia-nificazione degli insediamenti industriali necessari, rafforzando in parti-colare la specializzazione zootecnica e la trasformazione industriale deiprodottiderivati,conunruolodiprimirilievodelsettorelattierocaseario.Una funzione determinante in questo senso venne svolta dall’Istituto
sperimentale lattiero caseario di Lodi, che dopo alcune difficoltà nell’im-mediatosecondodopoguerra,trovònegliannicinquanta,sottoladirezionediEttoreCarbone,laspintaperunrinnovatosviluppocheavrebberestitu-itoall’Istitutolodigianoilruolocheglicompetevaperilpropriopassato44.
41. Ibid.,pp.88-89.42.«Sull’enteper il canalecadde infine l’ombradello scioglimento.Unprimodecreto
del19marzo1994delministrodelTesoronedeciselasoppressione,ilricorsoalTarportòaunasospensiva,undecreto leggedell’annoseguente lohaprorogatoa tutto il1999per-chécompleti l’opera,finchéundecretodelMinisterodelTesorodelgiugno2000 sembraavermessolaparolafine»(G.Fumi,L’economiacit.,p.149).
43. F. Samorè, Storia della Camera di Commercio di Lodi (1786-2009), Camera diCommerciodiLodi,Lodi,2009,p.129.
44. Sulle vicende dell’Istituto si veda:L’Istituto sperimentale lattiero caseario di Lo-di dal 1871 al 1992: un secolo di storia lombarda, Sl, Ministero delle risorse agricole, ali-mentarieforestali,1996.
204
Egliindicòlanecessitàdiunanuovaorganizzazioneperl’Istituto,chefavo-risselaspecializzazionedeglistudidettatadallarapidaevoluzionedellari-cercanelsettorelattiero-caseario,chestavaattraversandoinqueglianniunperiododirapidaevoluzione,alcuisostegnosirivelavaessenzialel’attivitàdiricercadiunappositoistitutosperimentale.Carbone,inparticolare,sug-gerì la creazionediquattro sezionidedicate allaproduzionedel latte, allatecnologialattiero-casearia,allachimicaeallabatteriologia45.Sinoal1961,sotto lasuadirezione, l’Istitutoproseguìnell’azionescien-
tifica e in quella didattica, attraverso la costruzione e l’attività delCentrosperimentaledel lattealimentare, il rifacimentocompletodei localie l’ac-quistodelleattrezzaturedellalatteriasperimentale,lasistemazioneelava-lorizzazione del laboratorio di batteriologia46. A partire da quell’anno poi iniziaronodeicorsidiaggiornamentoperlaureati,dirigentidiindustrielat-tierocasearieefunzionaridelloStatoimpegnatiinattivitàtecnicheedire-zionali negli organi periferici del Ministero dell’Agricoltura.Allabasediquestapluralitàdiiniziativevierailfondamentalecontribu-
to tecnico scientifico al progresso dell’industria lattiero-casearia naziona-le, rispettoallaquale l’Istitutocontinuavaarappresentare ilcentrodicon-fluenzadeiproblemidelsettoreelasedepiùidoneaallalorosoluzione.Esistevano naturalmente anche altri istituti nel Paese che facevano for-
mazione nell’industria lattiero-casearia: la Scuola agraria “AntonioZanel-li”aReggioEmilia,l’IstitutosperimentaledizootecniaaModena,l’Istitu-tocasearioezootecnicoaMantova, ilCentrocaseario“A.Bizzozzero”diParma,l’Istitutotecnicoagrario“G.Pastori”diBrescia,l’Istitutozootecni-coecaseariodiTorinoel’IstitutocasearioezootecnicoperilMezzogior-nodiCaserta.Nessuna,però,potevavantarecomel’IstitutodiLodi,afineannisessanta2.475tecniciformatiavarilivelli,dicui2.315provenientida80provincie italiane e160da26Paesi stranieri. Si trattavadi un risulta-to eccellente, tenendo conto che all’inizio degli anni settanta la ricerca nel
45.Glistudichesiimponevanoechel’IstitutodiLodirealizzerànegliannicinquanta,riguardavano:ilperfezionamentodeimetodidicontrolloedivalutazionedellatte,«inba-seallecaratteristichecasearieodallequalitàmerceologiche»; l’influenzadegli antibioticisullamicroflorasempredellatte;leverifichepraticabilisullecaratteristichefisiche,chimi-cheebatteriologichedelburronaturale,perstabilirnelagenuinità;i«fattoricheagisconosul latte destinato alla caseificazione (scarsa attitudine alla coagulazione, aggiunta di so-stanzeconservantiediantibiotici,refrigerazione,alimentazioneconinsilati,influenzadel-larazza,etc),sugliagentidellamaturazione,sulletrasformazionicheavvengononelcorsodellastagionaturaesulvalorenutritivodeiprodotticaseari»(E.Carbone, Recenti progres-si realizzati dalla sperimentazione dell’industrial del latte in Italia 1954-1958, relazione presentata al congressomondiale della sperimentazione agraria, Roma 7-9maggio 1959,estrattoda«LaRivistadellatte»,settembre-ottobre1959,Lodi,1959,p.9).
46.L’Istituto sperimentale lattiero caseario, cit., p. 132.
205
settorelattiero-caseariosipresentavainItaliainunaposizionepeggioreri-spetto a quella esistente negli altri Paesi del Mec47.
Tab. 3 - Allievi dei corsi di caseificio suddivisi in base alla provincia italia di provienien-za (1881-1968)
Provincia Allievi Provincia Allievi Provincia Allievi
Agrigento 1 Forlì 3 Potenza 6Alessandria 6 Genova 10 Ragusa 3Ancona 11 Gorizia 2 Ravenna 4Aosta 9 Grosseto 2 ReggioC. 4Ascoli Piceno 6 Imperia 1 Reggio E. 25Asti 1 L’Aquila 3 Roma 19Avellino 5 Lecce 3 Rovigo 7Bari 6 Livorno 1 Salerno 7Belluno 29 Lucca 4 Sassari 48Bergamo 41 Macerata 3 Savona 1Bologna 4 Mantova 68 Siena 1Bolzano 6 MassaCarrara 5 Siracura 1Brescia 72 Messina 3 Sondrio 71Cagliari 28 Milano 683 Taranto 1Campobasso 5 Modena 20 Teramo 1Caserta 3 Napoli 11 Torino 58Catania 3 Novara 65 Trapani 7Catanzaro 5 Nuoro 9 Trento 22Chieti 12 Palermo 2 Treviso 35Como 126 Padova 12 Trieste 2Cosenza 8 Parma 36 Udine 45Cremona 348 Pavia 65 Varese 5Cuneo 47 Perugia 4 Venezia 15Enna 2 Pesaro 4 Vercelli 6Ferrara 3 Piacenza 49 Verona 14Firenze 3 Pisa 1 Vicenza 39Foggia 5 Pola(ex.Italia) 3 Viterbo 1
Totale 2.315
Fonte: E. Carbone, L’insegnamento professionale nell’industria casearia italiana. Il contributo dell’Istituto sperimentale di caseificio di Lodi,in«LaRivistadellatte»,settembre-ottobre,1958,p.4.
47. Ibid., p. 141.
206
Tab. 4 - Allievi dei corsi di caseificio suddivisi in base alla nazione di provenienza (1881-1968)
Nazione Numero allievi Nazione Numero allievi
Albania 3 Italia 2.315Argentina 7 Madagascar 2Austria 6 Malta 2Brasile 2 Panama 1Bulgaria 6 Portogallo 4Cile 3 romania 3Colombia 2 Russia 1Cuba 17 Somalia 7Equador 2 Spagna 7Francia 2 Svizzera 7Germania 3 Turchia 1Grecia 66 Uruguay 1Israele 3 Venezuela 2
Totale 2.475
Fonte:G.A.Triulzi,Corsi di specializzazione in tecnica lattiero-casearia, in«LaRivistadel latte»,settembre-ottobre1964,p.6.
Lodisiconfermavacosìcentronevralgicoperilsettorelattiero-caseariosiaper ilsecolodiattivitàdisperimentazionechepotevavantare l’Istitutosperimentalelattierocaseario,siaperlasuacollocazioneinun’areacheaf-fidavaallavigiliadeglianniottantagranpartedelpropriosviluppoancoraalpotenziamentodell’agricoltura,inparticolaredell’allevamentodellavac-cadalatte,edellacorrelataindustriaditrasformazione48, nell’ottica di una «sempremaggiore specializzazionenel campo foraggero-zootecnico,mas-simamenteconnaturatoallanostracampagna,eperciòdiesito tecnico in-discutibilmentepositivo»49.Unorientamentorafforzatoanchedalleprospettiverassicurantidelsetto-
rezootecnico inquegli anni, specienell’allevamentodelbestiameda latteedacarne,dovel’Italiaeradestinataarimanereimportatriceperquantita-tiviconsiderevolielaLombardiasiconfermavalaregioneitalianapiùim-portantedelsettore,conil30%dell’interaproduzionenazionalee lamag-gior concentrazione di industrie casearie50.
48. Atti del convegno sul tema occupazione e sviluppo,cit.,pp.20-57.49.H.Haussmann,Problemi agronomici del Lodigiano, in Giornata dell’economia lo-
digiana,12ottobre1958,dattiloscrittoconservatonellaBibliotecacomunalelaudense,Lo-di, p. 5.
50.P.Ferrari,L’industria del latte in Italia,Piacenza,s.d.,pp.229-230.
207
Quanto fosse radicato l’Istituto nell’economia e nella società lodiginaae lamisuradell’apprezzamentodi cui lo stessogodeva in Italia e all’este-rofraglioperatoridelcompartolattiero-caseariolotestimonianogliinter-ventidegliEntilocali,delleimpreseedelleassociazionidelsettoreel’ap-poggiodell’Associazione exallievi, i quali permiseroall’Istitutonel corsodeidecennidiproseguireconforzaeautorevolezzasempremaggiorinellosviluppodellasperimentazioneenellaprosecuzionedell’istruzioneprofes-sionalesinoagliinizidegliannisettanta–quandoilcambiamentodinatu-ragiuridicanemuterà inparte le attività– creando tecnici e cultoridellescienzelattierio-casearieitalianiestranieri51.Questopermiseall’Istitutodiessereancheneidecennisuccessiviunpuntodiriferimentosicuroperl’in-dustrialattiero-caseariaitaliana,grazieadun’azionescientificaesperimen-tale sempre più incisiva e profonda, in linea con gli straordinari progessidellascienzaeconladinamicitàassuntanegliultimitempidaquestocom-partoproduttivo.
3. Il ruolo svolto dalle élite locali per la formazione di un’identità eco-nomica ed istituzionale lodigiana
Perrispondereaquestesfide,postedaimutamentieconomiciesocialiinatto,sirivelaronofondamentalilevisionielepropostedegliamministrato-ri locali e delle numerose associazioni di categoria presenti sul territorio.Inparticolare,«lacontiguitàdeigruppieconomicipiùdinamicipermiseildispiegarsi di quei rapporti fiduciari che tanta parte hanno avuto nel con-seguimentodellamassacriticanecessariaadarecorpoalla tantoricercataidentità lodigiana»52.Inquesto senso, l’esperienzadelprotagonismodellaclassedirigente lo-
digianapuòessereintesacomeesempioparadigmaticodicomesièrealiz-zatoa livello locale ilmodellodi rappresentanzapluralistachehacaratte-rizzato la società italiana nel corso delXX secolo. I numerosi attori e lavastitàdegliinterventimeriterebberounsignificativoepiùesaustivoappro-fondimento,dicuinonèpossibilequidiseguitodarecontocompiutamen-te.Sièpertantosceltodianalizzarealcuneesperienzevirtuose,oggidefi-nite best practices,dacuièpossibilecogliereinodiproblematiciaffrontatie le soluzioni più significative che hanno guidato in generale le azioniorientateallosviluppo,apartiredallacaratteristicatipicaditerritoridipic-colaemediadimensione,ecioèlapresenzadiéliteche«circolavanomolto
51. L’Istituto sperimentale lattiero caseario,cit.,pp.146-151.52.F.Samorè,Storia della Camera, cit., p. 131.
208
fluidamentetral’associazionismo,lapolitica,ilmondodelcreditosecondounasortadiprincipiodeivasicomunicanti»53.Nell’immediato dopoguerra lentamente si andò ricostituendo anche nel
Lodigianoladimensioneassociativa: iproprietari terrieridiLodieCodo-gnodiederovitaallaloroassociazione,lostessofeceroilGruppodegliin-dustrialilodigiani,l’Unioneartigiani,l’Associazionetraproduttoriagricoli,laLibera associazione commercianti.Altrettanto decisiva fu la costituzio-nediunufficiodecentratodellaCameradiCommerciomilaneseaLodi54, cheavrebbepermessodiaffrontareconmaggiorperiziaepuntualitàipro-blemilegatiallosviluppodell’interoterritoriolodigiano.Mafuronosoprattuttogliamministratoridimoltissimicomunidelterrito-
rio,sostenutianchedaidirigentipolitici,chesimosseroperdarenuovoslan-cio economico e sociale al Lodigiano. Il rinato fermento associazionistico«nonbastavaadunterritoriochesentival’esigenzadifaremassacriticapernonsubireiprocessiavviatidallagrandemetropolidistantesolounatrenti-nadi chilometri.Occorrevauno sforzodi progettazioneper tenere insiemegli interessi e consentire alle intelligenze autoctone di confrontarsi alla ricer-cadisoluzionievocazioninuoveperilLodigiano»55.Emergeva,inpartico-lare,laconsapevolezzadapartedelleélitelodigianediunamarcatadiversitàediunaspecificapeculiaritàneiconfrontidellaProvinciadiMilano.
A questo proposito, un ruolo di aggregazione degli interessi e di incu-batori di idee venne svolto in particolare dall’Atsil e dalConsorzio pro-vinciale per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delLodigiano.Unprimopassoandòconcretizzandonel1957conl’istituzionedell’Atsil
(AssociazioneperlaTutelaeloSviluppodegliInteressidelLodigiano),cheraccolse le municipalità del territorio, animate dal desiderio di procede-reunitenell’affrontareinumerosiproblemichesiandavanoevidenziando.PrimoPresidentefunominatoGiuseppeArcaini,mentresegretarioven-
nesceltoNataleRiatti,entrambidemocristiani,cometuttiglialtricompo-nenti del consiglio direttivo: Francesco Ferrari di Lodi, ErmannoSantellidiCodogno,MariaLanzariniBernabeidiCasalpusterlengo,MarioBecca-riadiSant’Angelo,EmilioBianchidiCasalmaiocco56.Il nuovo organismo associativo favorì una serie di dibattiti e l’elabora-
zionedivarieproposteeapprofondimentipercontrastareinparticolaregliindirizzidelPianoTerritorialeLombardo, chedefiniva ilLodigianocome
53. Ibid.,p.136.54.SullastoriadellaCameradiCommerciodiLodisiveda:Ibid.55. Ibid., p. 114.56.Il Lodigiano: quarant’anni di autonomia,acuradiF.Pallavera,A.Stroppa,Provin-
ciadiLodi,Lodi,2008,p.181.
209
«zonaverdeagricolada tutelare»57.L’Atsil – chedi fattooperavada cata-lizzatoreefacilitatore,dialogandoconentilocaliecategorieeconomiche–giunseaproporreunaseriediemendamentialPianoTerritorialeLombar-do,coniqualisirichiedevano:
Il potenziamento delle comunicazioni stradali e ferroviarie per gestire lamigra-zionegiornalieraversoMilanodioltre17milapersone; lacreazionedi trattiau-tostradali quali la Pavia-S. Angelo-Lodi-Crema-Brescia; il miglioramento dellastatale Emilia. Un capitolo importante era riservato alla auspicata localizzazio-nedellepossibilizoneindustrialinascenti,chesiritenevaavrebberodovutofarri-entrarecirca20milapersoneenellequalisisarebbeanchepotutaimpiegareunalargaquotadellaforzalavoroespulsadallecampagnepereffettodellameccaniz-zazioneagricola.Losforzodipianificazioneproseguiva indicando lapotenzialitàdellezonemetaniferediCornegliano,CaviagaeBasiasco;glisbarramentisull’Ad-da e la Muzza per creare centrali idroelettriche e la possibile istituzione di piccole zoneverdiperlasperimentazioneagraria58.
Due anni dopo la sua istituzione venne nominato Presidente dell’AtsilMarioDosi, al posto del dimissionario Arcaini, mentre la vicepresidenzavenneaffidataall’imprenditoreClodomiroDraghi,giàPresidentedelGrup-podegli industriali lodigiani.Negli anni successivi sulla spinta dell’Asso-ciazioneedeisindacideimaggioricomunidelterritorio(AntonioAllegrieAntonioMontaniperLodi,ErmannoSantelliperCodogno,MariaLanza-riniBernabeiperCasalpusterlengo,MarioBeccariaperSant’AngeloLodi-giano)vennerocostituitiunaseriediConsorzidicomunitàdizonaconl’o-biettivoprincipalediattuarel’industrializzazionedelLodigiano59.Emersero in particolare due ipotesi, l’una diffusa e frazionata, l’altra
concentrata in poche zone, scelte opportunamente. Sulla prima soluzione,infatti,siavanzavanounaseriedicriticità,tracuiquelladicostellare
ilterritoriodiiniziativeindustrialisenzaunconnettivodiinfrastruttureoconretiinfrastrutturaliestesissime,costoseeirrazionali(strade,servizi,reti,allacciamen-tiescarichi).SorgerebberoinogniComuneproblemidicoesistenzafraresidenzee impianti produttivi; le attività industriali commiste a quelle agricole potrebbe-rocondizionarsiedisturbarsiavicenda,dandoluogoadunibridoterritorialechesnaturerebbe le peculiari caratteristiche della zona60.
Relativamente alla seconda, che prevedevapoche e consistenti zone in-dustrialicollocateinposizioniidonee,venivanoinveceelencatiunaseriedivantaggi,chenegiustificavanolapreferenza.Traquesti,
57. Ibid.,p.180.58.F.Samorè,Storia della Camera, cit., p. 124.59. Il Lodigiano: quarant’anni, cit., p. 183.60.Problemi del Lodigiano, cit.,vol.III,pp.59-82.
210
la possibilità di razionalizzare e potenziare i servizi infrastrutturali, realizzan-do economie sul loro concentramento; di favorire la complementarietà fra le in-dustrie stesseo fra le industrieprincipalie leattività sussidiariegenerate;diuti-lizzarelamanodoperadeivaricentri,consentendounafacilealternativaperognisituazionedidisagio;direalizzareunamaggiorerazionalitàepotenzialitàdeiser-viziassistenzialilegatiall’organizzazionedifabbrica,cheincomplessiconvenzio-nati avrebbero trovato la loro dimensione ottimale; di ottenere una netta e facilesegregazionefragliimpiantiproduttivielezoneresidenziali,conreciprocobene-ficiodeiduesettori61.
Neiprimianni sessanta,grazieal concorsodellagente,dellenumeroseorganizzazionidel territorioeallavolontàdimolti amministratoripubbli-ci,cifuunsusseguirsidiconvegni,articoli,presediposizionicheportaro-noallanascitadelConsorzioprovincialeperilmiglioramentodellecondi-zioni economiche e sociali del Lodigiano nel 1965.Al decreto prefettiziodel4maggio1965feceseguitolanascitaveraepropriadelConsorzioLo-digianoil15maggio1965,anchesel’insediamentooperativosarebbeavve-nutosolounannopiùtardi,il15luglio1966,conl’assembleageneraledeirappresentanti dei 66Comuni lodigiani aderenti alConsorzio e degli ottodelegatidelConsiglioProvincialediMilano.PrimoPresidentevenneelettoilconsiglieredemocristianosantangiolinoMarioBeccaria,mentrevicepre-sidenteilsocialistadiLodi,CarloDeGradi62.Enti fondatori risultavano essere la Provincia diMilano e i Comuni di
Lodi,Codogno,CasalpusterlengoeSant’AngeloLodigiano.AvevanodirittodiaderirealConsorziotutti iComunidelterritoriocomprendenteilpianoirriguodellaMuzza,laGhiaiadell’Adda,illungoPo,ilpianoedilCollediSanColombano al Lambro63. Si trattava di una nuova esperienza apparsaperlaprimavoltainItalia,alpuntochesuscitòunvastointeresseanchealivelloparlamentareinquantoconsideratacomeunfattoatipicodellalegi-slazione italiana64.Le sue finalità erano quelle di predisporre la sistemazione urbanisti-
ca del territorio, di sostenere il potenziamento dell’agricoltura, lo svilup-
61.Ibidem.62.LaProvinciadiMilanodetenevail60%dellequote(messeincaricoa8suoidele-
gati),mentreilrestante40%erasuddivisotraicomuniaderentiinproporzioneallapopo-lazione.LasedeeraaMilanoaPalazzoIsimbardi.Ladurataerastabilitain30anni(pro-rogabiledidecennioindecennioalpermaneredegliscopiperiqualierasorto).IlConsi-gliodirettivoeracompostoda15membri.Lespeseordinarieperlagestioneeranoriparti-teal60%acaricodellaProvinciadiMilano,il40%deiComunilodigianiaderenti,mentreper lapartestraordinariaperopereed investimenti il50%eraacaricodellaProvinciadiMilanoeil50%deiComunilodigiani(Il Lodigiano: quarant’anni,cit.,p.185).
63.Ibid.,pp.155-158.64.30 anni del Consorzio del Lodigiano: 1965-1995,acuradiF.Pallavera,M.Steffe-
nini,A.Stroppa,ConsorziodelLodigiano,1996,p.50.
211
podell’industria, ilmiglioramentodei trasporti edelle comunicazioni e ilperfezionamentodellecondizioni igienichedell’area lodigiana.Grazieaglistanziamentidell’Amministrazioneprovincialeedeglialtrientipartecipan-ti,ilConsorziorealizzòimportantiinvestimentinell’ediliziascolastica,conlacostruzionediscuolematerne,medieeistitutiprofessionali,operedifo-gnatura, opere di edilizia abitativa, oltre a importanti iniziative a favoredell’agricoltura e dell’industria.PerMarioBeccaria,primoPresidentedelneonatoorganismo,aspingere
acostituireunconsorziodiComunifuronolepesantiindicazioniperilfu-turodelLodigiano,contenutenelPianoTerritorialeLombardo:
Questo documento programmatico, se fosse stato attuato, avrebbe danneggia-to fortemente gli interessi del territorio, perché con la dizione “zona verde agri-cola da tutelare” in gergo urbanistico avrebbe significato prevedere un’area de-stinata a rimanere esclusivamente agricola.Questo significava che nelLodigianononpotevanosorgerenuoveattivitàproduttive,nuoveiniziativeresidenzialidiunacerta dimensione, nonché nuove vie di comunicazione in quanto tutto ciò avreb-bedanneggiatol’attivitàagricola.Unazona,insomma,destinataarimanerepove-raequindisottosviluppataneiconfrontidell’economiapiùriccaeprogreditadel-laLombardia65.
Difronteaquestaprospettivaleelitèlodigiane,formatedapubbliciam-ministratori, dirigenti, politici, sindacalisti, imprenditori, si opposero una-nimementeedopovariincontriavvenutiaLodipressol’AtsileaSant’An-gelopresso ilCentroStudiAlcideDeGasperi,definironoalcuneproposteinteseafarmodificaresostanzialmenteildocumento.Innanzitutto,«l’agri-coltura, la zootecnia e la produzione lattiero-casearia dovevamo rimanereirrevocabilmente lecomponentiessenzialidell’economia lodigiana,quindi,salvaguardate»66anchepersuperarelagravecrisiattraversataneiprimian-nideldopoguerra,aseguitodell’imponibiledimanod’operaedellaminorcompetivitàdeiprodotti localineiconfrontidiquelli esteri, cheobbligavaa porremano all’ammodernamento e allameccanizzazione delle impreseagricole.Unasituazioneresaancorapiùdifficiledallainabilitàdelleabita-zionideilavoratoridellaterraedallacarenteprotezioneassistenzialeepre-videnzialechediscriminava i lavoratorideicampi67.Lepropostedimodi-ficaalPianoTerritorialeLombardoperevitareunulteriorepeggioramentodelmondoagricoloprevedevano:finanziamentiagevolatiperl’acquisizionedei fondiagricoliedellemacchineagricole, l’incentivazioneper lacoope-razione della produzione, conservazione e commercializzazione delle atti-
65.Ibid., p. 47.66.Ibidem.67.Ibidem.
212
vitàagricole,ilrisamentodelbestiamebovinodamalattie(comelaTbc,lamastite, labrucellosi),nonchéunamaggiorumanizzazionedellecondizio-nidivitadeilavoratoriagricoli.Taliproposte«vennerorecepitetotalmentedalPianoTerritorialeLombardo,conl’appoggiodell’AmministrazionePro-vincialedell’epoca, presiedutadall’Avv.AdrioCasati, conVicePresidenteillodigianoAvv.AlfredoBrusoni»68.Accantoaglistudieaiprogetti ilConsorziodelLodigianointervennea
favoredialcuneindustrieincrisieasostegnodellacooperazioneagricola,oltreafarpresenteagliorganicompetentilacarentesituazionedeitraspor-tisurotaiaesustrada.Affrontòancheilgraveproblemadelleacqueinqui-natedeifiumi,l’inadeguatasituazionedellestrutturescolastiche,ladisagia-ta situazionedelle reti stradali, provinciali e statali; si adoperò inoltreperfavorireiltrasferimentodellafacoltàdiAgrariaaLodieperdareconcretaattuazionealprogettodelCanaleMilano-Cremona-Po69.Emergeva dunque in quegli anni da parte delle amministrazioni locali
lodigianeunamaggiorconsapevolezzadelproprioruolodipropulsoridellosviluppo economico e socialedel territorio.Questa azione consortile con-sentì lamaturazione di una coscienza comprensoriale tra gli amministra-tori pubblici e le popolazioni del territorio, in grado di superare gli angusti confinidegli interessi locali e campanilistici, gettando lebasiper la crea-zionealcunidecennipiùtardidell’istituzioniprovincialediLodi.Inunodeicentripiùimportanti,Codogno,le
iniziativenel campodella cultura e inparticolaredella formazioneprofessionaledeigiovani, l’adeguamentodellestruttureabitativedellacomunitàlargamentesti-molatedall’amministrazionecomunale, l’assunzioneingestionedirettael’ammo-dernamentodei pubblici servizi, le previsioni di sviluppodella città con l’indivi-duazionedellezonedestinateagliinsediamentiindustrialiedaquelleresidenziali,e per i primi anche al di là dei limiti territoriali delComune, la predisposizionedelle infrastrutturequale logica locale indispensabilepremessaal successivo svi-luppoeconomico, leprovvidenzepromossenelsettoredell’agricolturaconilpro-gettodelmercatodeibovini,denotanolaprecisavolontàdelgovernolocale[…]diassumeredirettamenteilcompitodipromuoverepiùaltilivellidivitadellapopo-lazioneamministrata.Sesiaggiunge l’operositàdellealtreamministrazioni loca-li,daCasalpusterlengoaLodi,daMelegnanoaSant’AngeloeaSanColombanoe
68.Ricorda sempreMarioBeccaria che «fu questo un fattomolto importante, perchésuccessivamente il predetto Pianomodificato veniva fatto proprio dal Comitato regiona-ledellaProgrammazioneEconomicapresiedutodaldott.PieroBassetti, ilqualeconosce-vagiàilLodigianoperavercollaboratoconilCentroStudiAlcideDeGasperiinsiemeaipoliticiDott.UmbertoDraconeel’Avv.EzioAntonini.IlCrpeèstatol’organochehapre-paratol’avventodellaRegioneLombardiae,pertanto,dopoaverereditatoilPianoTerrito-rialeLombardodalProvveditoratoRegionalealleOperePubblichehapassatol’importantedocumentoprogrammaticoall’EnteRegione»(Ibid.,p.48).
69.Ibid., p. 51.
213
deicomuniminori tra iqualièdoverosocitare,adesempio, ilComunediSoma-glia,[…]siarrivaallaconstatazionechelavolontàdiriscattodacondizionidivi-tainadeguatealladignitàumanasièmanifestatasulpianodemocraticocomevo-lontà popolare70.
Valelapenanotareche,nonostante ingenerale l’industrializzazione,al-meno parziale della zona, fosse ritenuta una possibile ed accettabile solu-zionedeiproblemidell’area,lamaggiorpartedegliamministratoripubbli-ci locali si rendevanocontodell’impossibilità, almenoabreve termine,dapartediuninsediamentoindustrialedimutareradicalmentelabaseecono-micadiunazonaadaltavocazioneagricolacomeilLodigiano.Perquestomotivo le richieste di insediamento industriale, nellamaggioranza dei ca-si,noneranoindiscriminate,masiconcretavanoinunaformuladi“svilup-pobilanciato”,incuiall’agricolturasarebbestatoriservatoancoraunruolopredominante nell’economia locale.Molti interpretavano questo problemacome la necessità di difendere le caratteristiche peculiari del Lodigiano,mentrealtri lovedevanodalpuntodivistadellecapacitàdell’agricolturaafungeredaeconomiaaffiancatriceedadattenuareilpesodellecrisiecono-miche71.
70.Il canale navigabile Milano-Cremona-Po, cit., p. 14.71. Problemi del Lodigiano, cit., vol. I, p. 29.Nell’indagine realizzata dall’Ilses negli
anni sessanta emergeva che «molte amministrazioni comunali, specie dei comuni grossiomedi,hannocercato,conmaggioreominoresuccesso,dirichiamaredegliinsediamentiindustriali,piùspessoconvenzionandoconl’industriadeterminateinfrastrutture.Inalcunicasi,dovesisonoformatidegliinsediamentiancherelativamentegrossi,leaspettativenonsi sono però pienamente realizzare, sia perché lamanodopera locale non era sufficiente-mentequalificataperessereassunta,siaperchélacrisicongiunturalehalimitatolaportatadell’insediamento.Unaimpressionecheemergedalleinterviste,machedovràessereinse-guitoconfermata,èche,salvoicasiovviamentepiùgravi,ildesideriodegliamministrato-ridiprovocaredeigrossiinsediamentinellazona,sia,almenoinparte,maturatocomere-lazionealpericolodell’isolamentoedell’arretratezza;temendodivenirescavalcatidaipiùimponentiprocessidiindustrializzazioneincorsonellazonanorddellaprovincia,gliam-ministratori affidano le loro speranze alla partecipazione, anche parziale, a questo pro-cesso,senzaperaltroesseresemprecoscientidelleconseguenzecheilprocessostessopo-tràavereper ilLodigiano,soprattuttoperquell’immaginediunLodigianoagricoloepri-vodi conflitto cheper altri versi sembranoaccarezzare. In secondo luogooccorrenotareche,anchesel’areanelsuocomplessononhaavutodegliinsediamentiindustrialirilevan-ti,inqualchecomunesièregistratouncertogradodiindustrailizzazione;èilcasodiCo-dogno,diFombio,diSordio,diqualchealtro.Questaoperadirichiamohaavutosuccessoneicasiincui,alleragionidiconvenienzaeconomicadellalocalizzazione,sisonoassocia-tielementipersonali,qualilacapacitàdiiniziativadell’amminsitratoreoilsuopoterepo-litico.Cisembrainoltrecheabbiaavutograndeimportanzalastrutturadellaproprietàdelcomune,giacchéneicasi incui ilcomunenonpossedevadirettamente learee idoneeoc-correvacheiproprietarilocalifosserodispostiavendereacondizionifavorevoli.Tuttavial’insediamentoindustriale,aquestolivello,nonhaprovocatodellegrossevariazionidiba-senellastrutturaagricoladellazona,comebendimostrailcasodiCodogno,doveaccanto
214
Frail1975eil1977ilConsorziodiedemandatoancheall’IstitutoLom-bardopergliStudiEconomicieSociali(Ilses),chegiàinprecedenzaave-vasvoltounavastaricognizionedeifabbisognidiquestoterritorio,dipre-disporreunPianodisviluppodelLodigiano–rimastoinattuato–fondatosull’interazione tra analisi economico-sociale e pianificazione territoria-le.Nel frattempo si concludeva la fase volontaria dell’associazionismodeicomuni e iniziava la fase istituzionale. Nel 1975 nasceva infatti il Com-prensorio del Lodigiano, ambito locale di un organismo introdotto in tut-talaLombardiadallaleggeurbanisticaregionale,dunqueconcompitipre-valentemente di pianificazione territoriale72. Quando nel 1981 questo tipo di esperienze compensoriali vennero abolite, soloLecco eLodi continua-ronoadesercitareperdelegaregionaletuttelefunzioniattribuitedaicom-piti di pianificazione territoriale.Ciò permise di giungere all’adozione nel1984delPianoterritorialedicoordinamentocomprensoriale,chelaRegio-neLombardiaapprovòdopoaltriquattroanniinsiemealPianosocio-eco-nomicodelLodigiano73.Inessocisiriproponeva
unastrategiadisviluppoediriequilibriodelcomprensoriolodigianosianeicon-fronti dell’area metropolitana milanese e del sistema regionale lombardo, siaall’internodelcomprensorio,partendodaunavalutazioneapprofonditadeiproble-midifondodelLodigiano.Inparticolare:a) ilcarattereinevitabilmentesubordinato–perifericoomarginalechesia–della
locazione delle risorse lodigiane, ossia la sua dipendenza da scelte esogene agli interessiedaiproblemilocali;
b) ilpersistere–purconqualchesegnopiùomenoevidentedicrisieconomica–diunaspecializzazioneagricoladelcomprensorio,conunaqualificazionesem-prepiùspiccatamentezootecnica;
c) l’esaurimentodelprocessodi(relativa)industrializzazionepereffettodiinizia-tive esogene all’area ed il mantenimento di un’accettabile base occupaziona-legrazieallacrescitasiadeltessutoproduttivoartigianaleedipiccoleimprese,sia del tessuto terziario, con una spiccata presenza di attività territorialmentediffusediserviziolocale(ingenereallepersone)[…];
d)in termini di specializzazione produttiva il Lodigiano sembra avere avviato eper alcuni aspetti consolidato una sorta di divisione del lavoro tra pochi po-li terziari, di servizio alle persone ed alle imprese, localizzati nei grandi cen-
ungrosso insediamentochimicosi sonoanchesviluppatedelleattrezzatureconnessealladistribuzionedeiprodottiagricoli.Nelcomplessol’agricolturasembraessereinbuonecon-dizioni,madalleintervistenonètuttaviaemersosesitrattidiunasituazionelegataall’al-to livellodivocazioneagricoladell’areaoadunapositiva trasformazioneemiglioramen-todeimezzidiproduzioneagricoli:laricercaspecificasull’agricolturanelLodigianopotràmeglioapprofondirequestopunto»(Ibid,p.30).
72.G.Fumi,L’economia lodigiana, cit., p. 153.73. 30 anni del Consorzio, cit., p. 147.
215
tri residenziali del comprensorio, ed alcune aree di concentrazione e relativaespansioneindustrialelocalizzateincomunimediopiccoli[…];
e) per quanto concerne la distribuzione territoriale della popolazione residente, laprosecuzionedellatendenzaadunaprogressivaurbanizzazionedellaresidenza–testimoniatadallaulteriore riduzionenelperiodo(1971–1981)dellapercentua-ledeiresidentiinnucleiabitatiecasesparse–sièaccompagnataadunridimen-sionamento, relativo ed inminormisura assoluto, dei grandi centri residenzialidel Lodigiano. Tuttavia, hanno generalmente beneficiato di questo trasferimen-to internodi residenza solo i comunimedio-piccoli che rappresentanonodi im-portantinelsistemacomprensorialedeitrasportie/osonolocalizzatiinmododaconsentireagevoleaccessoaicentridigravitazioneinterniedesternialcompren-sorio;
f) ilsolotipodidualismoesquilibriointernochesembraessersiapprofonditone-gli ultimi anni è quello tra aree comprensoriali a specializzazione agricola ecaratterizzatedascarsaaccessibilitàedareecomprensorialiaspecializzazioneextra-agricolaocomunqueincondizionidigarantireadeguatoaccessoaicentridi servizio interniedesternialcomprensorio.Èsoprattuttonelleprimechesipresentanoancoraisintomidellecomunitàindeclino:calodemograficoeresi-denziale,degradodelpatrimonioedilizio,insufficientedotazioneedaccessibili-tàaiservizisocio-sanitari74.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Socio-Economico, rivi-sto e aggiornato nel 1994, venne dunque approntata la pianificazione ter-ritoriale per la localizzazione di insediamenti di rilevanza comunale ecomprensoriale,ladefinizionedellamagliadellagrandeviabilitàedeitra-sporti, i vincoli per la tutela ambientale, la localizzazione di parchi e ri-serve naturali. Interventi particolarmente significativi che incisero sull’e-conomia e sull’ambiente di tutto ilLodigiano furono anche il progettodiriqualificazionee riutilizzodell’areadell’exRaffineriaSarniGulfe ipro-getti urbanistici e viabilistici diCasapusterlengo,Codogno eCorneglianoLaudense75.Nei trent’annidiattività ilConsorziodelLodigianosiposedunqueco-
meunprecisopuntodiriferimentoperiComunidelterritorio,guadagnan-dosilastimaeilriconoscimentogenerale.Purenell’alternarsidellevicendepolitichediqueidecenni,negli alti ebassidell’impegnooperativomaan-chenellaprevalentetensionecostruttivaunitaria,ilConsorziohapermessodi creare le condizioniper ilvaroe l’attuazionedi importantipresuppostidiprogrammazione,primo fra tuttiquellodell’assettourbanisticoe socio-economico del territorio,ma anche quello dei servizi, della gestione dellerisorseediinteressicomunichepreserocorpo,sostenendoleragionistori-
74. Piano socio-economico, a cura di C. Ricciardi, 1984, par. 3.3, anche inG. Fumi,L’economia lodigiana,cit.,pp.154-155.
75. 30 anni del Consorzio, cit., p. 148.
216
cheedellosviluppocomplessivodelLodigiano,preparandolastradadellasuaautonomiapolitico-amministrativaneglianninovanta76.Paradossalmente, però, proprio negli anni successivi all’istituzione del-
laProvinciadiLodi,cheinteoriahasegnatoilriconoscimentoistituziona-lediunacoesionesocialeeterritoriale“difatto”, ilLodigianosiè trovatoadoveraffrontarenuovieprofondimutamenti,riconducibilientroicanonidellagrandetransizionedelcapitalismoditerritorioitaliano,caratterizzatadaretidirelazionesemprepiùlungheelarghe,daunacrescenteterziariz-zazionedell’attivitàeconomicaedinfinedallagrandeinstabilitàdelconte-stocompetitivocomplessivo, cheha resoestremamentemutevoleuno sce-nario che per decenni era stato stabile e coeso. Con ilmutamento delle forme del produrre, delle reti di comunicazio-
ne,dellacomposizionesocialeedellemodalitàentrocuisiesercital’azionepolitica, è venutomeno anche l’equilibrio che contraddistingueva il pattosocialesucuisifondavalacomunitàterritoriale.Unequilibriochevarico-struitoapartiredainuoviparadigmi incui si articolanoeconomia,politi-caecomposizonesociale,inparticolarefraipossessorideicosiddettibenicompetitividi territorio,chesiconfiguranocomeveriepropribenicollet-tivi,al serviziodellacomunitàdegli interessieconomicidel territorio.Perrealizzareciòoccorreunarinnovatapresadicoscienzadapartediquelsi-stemadiattorichedefinisceilproprioruoloeconomicointornoallagestio-ne di tali beni, come ad esempio le fabbriche del capitale umano e dellaconoscenza,comeleUniversitàelealtreistituzioniformative,leistituzionilocali pubbliche e private, le reti della creatività, del linguaggio, della co-municazioneal serviziodell’impresa, lafinanzae l’intermediazionedide-naro, i brand che danno identità e personalità ai prodotti locali, insommatuttequellerealtàchecontribuisconoaformareogiàcostituisconolenuo-veélite localichiamatea ricostruire ilnuovopattosociale,attornoaun’i-dentitàcomune,crucialeperlefuturestrategiedigovernoedisviluppodituttoilLodigiano.
76.Ibid.,pp.39-40.