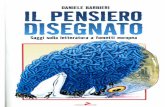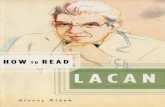Lacan ed il pensiero cinese
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Lacan ed il pensiero cinese
1
Lacan ed il pensiero cinese1 François Cheng
Quello che dirò, questa sera, avrà un legame poco diretto con la psicoanalisi. Questa prima affermazione, che si riferisce a Lacan, può stupire. Senza dubbio, erano le stesse condizioni nelle quali si sono realizzate le nostre riunioni di lavoro. In effetti, allo scopo di farmi sentire a mio agio, e con la preoccupazione di non influenzarmi nelle risposte alle sue domande, mi aveva chiesto espressamente di dimenticare quel poco che sapevo della psicoanalisi in generale e della sua teoria in particolare. Egli voleva, in mia compagnia, visitare o, in molti casi, tornare a visitare, determinati campi del pensiero cinese, questo nella maniera più autentica possibile, studiando i testi nella loro scrittura originale, linea per linea, parola per parola. Inutile dirvi con quale fretta accettai questa proposta. Ero a quell’epoca in piena investigazione, cercando di applicare i metodi fenomenologici o semiotici a diverse pratiche significanti cinesi. I dialoghi che avevo potuto annodare con Gaston Berger, Levinas, Barthes e Kristeva mi avevano sufficientemente convinto delle virtù degli scambi diretti. Quanto di ciò fosse certo con Lacan, è quello che non tardai a verificare. Lacan, con la sua maniera tanto tenace e tanto aperta di interrogare i testi, la sua capacità così pertinente di mettere in risalto la posta in gioco di una interpretazione, contribuiva a rinforzare il mio impulso, a rendere più acute le mie facoltà di discernimento. A tal punto, d’altra parte, che al termine di un periodo di diversi anni assolutamente privilegiato per me, ho dovuto salutarlo per dedicarmi alla redazione di due opere (1) che al momento della loro pubblicazione, nel 1977 e nel 1979, avranno l’onore di interessarlo e di ricevere la sua approvazione. Vale a dire che dall’intenso scambio con Lacan, a volte estenuante per me, io ero, di fatto, il grande beneficiario. In quanto a Lacan stesso, che ottenne lui da questo? Probabilmente nessuno è nella condizione di rispondervi con precisione al momento attuale. Come può un grande spirito nutrirsi di tutti gli apporti che incontra nel suo cammino? Per saperlo, questo esigerebbe senza dubbio una investigazione paziente, minuziosa e soprattutto globale. Eravamo alll’inizio degli anni settanta. L’essenziale della teoria di Lacan era già formulato. Senza dubbio, non si può dubitare del fatto che, in questo immergersi nella cultura cinese, la sua curiosità intellettuale abbia incontrato attrattive, che il suo spirito scrutatore abbia estratto ispirazioni, che, nel cuore stesso della sua teoria, questo o quell’altro concetto abbia incontrato degli echi, perfino dei prolungamenti. Altrimenti, perché tutte queste sessioni accanite che a volte duravano diverse ore e, una o due volte, una serata intera?
1 Testo estratto da Lacan, el escrito, la imagen, autori diversi, pagg. 151/172, Edizioni Del Cifrado, Buenos Aires, Argentina, 2003.
2
Oltre alle discussioni puntuali su diversi temi quali i pronomi personali, le preposizioni, le espressioni di tempo in cinese, studiammo prima di tutto testi scelti uno ad uno da Lacan stesso. In maniera generale, si tratta di testi dei quali aveva letto le traduzioni. Se faccio astrazione di alcuni testi annessi che menzionerò di passaggio, posso citare, in ordine, le opere che seguono: Il libro della via e della virtù, il Mencio e Propos sur la peinture du moine Citrouille amere. Vedremo che questo ordine segue una certa logica, dato che le tre opere in questione corrispondono, a grandi tratti, ai tre livelli costituivi del pensiero cinese: il livello di base che qualificherei cosmo-‐ontologico, poi il livello etico e infine il livello estetico. La prima opera, Il Libro della via e della virtù (2) – il Tao-‐Te-‐Ching – è attribuito a Lao-‐Tsé, il padre fondatore del Taoismo. Lao-‐Tsé sarebbe vissuto nel secolo VI prima della nostra era. Però il testo che conosciamo è una versione più tarda, versione scritta da un insegnamento orale trasmesso diverse generazioni fa a partire da Lao-‐Tsé. L’opera si compone di ottantuno brevi capitoli. I due capitoli che mi propongo di commentarvi si annoverano tra i più determinanti per quel che concerne la maniera in cui i cinesi hanno concepito la Creazione ed il cammino dell’Universo, che in cinese si designa con la parola Tao, che vuol dire la Via. Accade che verbalmente la parola Tao vuol dire anche “parlare”. In maniera tale che, se si permette un gioco fonico in francese, si può dire che il Tao sia dotato di un doppio senso: la Via e la Voce (la Voie, la Voix)*. Il Tao significa dunque un ordine della vita e allo stesso tempo un ordine della parola. Si coglie in questo punto quello che potè interessare Lacan. Di questi due testi un po’ aspri, farò un commento il più vicino possibile a quello che Lacan ed io facemmo insieme. Prima il primo testo (Le livre de la Voie et de sa vertu, cap. XLII): Il Tao in origine genera l’Uno/ L’Uno genera il Due/ Il Due genera il Tre/ Il Tre genera i Dieci-‐Mila esseri/ I Dieci-‐Mila esseri indossano lo Yin ed abbracciano lo Yang/ Attraverso il soffio del Vuoto-‐mediano/ realizzano lo scambio-‐intendimento. Tutte le frasi che compongono questo testo abbordano l’idea del soffio. È qui, non oltre, che conviene indicare un punto centrale: l’idea del soffio si trova nel pensiero cinese. È certo che, molto anticamente, nella maniera in cui i cinesi concepivano l’origine della Creazione, l’idea di una volontà divina non fosse per nulla assente, visto che si riferivano al Signore di Sopra e, più tardi, al Cielo. Non erano assenti neppure i riferimenti a determinate materie, come il Fuoco o l’Humus. Però in un determinato momento, senza dubbio molto presto, seguendo una grande intuizione, optarono per il Soffio, che non era forzatamente in contraddizione con le idee precedenti ma che, logicamente, permetteva loro di raggiungere una concezione unitaria ed organica dell’univeso vivo dove tutto si connette, tutto si sostiene attraverso il Soffio. Per quanto abbiano cercto, non trovarono niente di meglio del Soffio, questa entità dinamica, capace di generare la Vita, insieme allo spirito ed alla materia, l’Uno ed il Molteplice, le forme e le loro metamorfosi.
3
Optando per il Soffio, estrassero rapidamente da esso tutte le conseguenze. Il Soffio è precisamente questa unità di base che struttura tutti i livelli di un sistema organico. È così che, al livello fisico, le materie vive, i nostri stessi corpi, sono concepiti come condensazioni di differenti soffi vitali. Che, al livello etico, quando qualcuno agisce con giustizia ed equità, si dice che la sua coscienza sia mossa dal soffio integro o il soffio della Rettitudine. E che, al livello estetico, la regola d’oro raccomanda di animare i soffi ritmici. Ci sono qui molte cose accostate un poco disordinatamente. Ma state tranquilli, non mi smarrisco. Torniamo al primo testo. Lo commenterò frase per frase. Il Tao in origine designa il Vuoto originale da cui emana il soffio primordiale che è l’Uno. L’Uno si divide in due soffi vitali che sono lo Yin e lo Yang. Lo Yang, che concerne il principio della forza attiva, e lo Yin, che concerne il principio della dolcezza ricettiva, sono virtualmente in condizione di generare i Dieci Mila esseri. Però al Due si aggiunge il Tre, o meglio nel cuore del Due si intercala il Tre. Perciò il Tre non è altro che il soffio del Vuoto-‐mediano che è in questione nell’ultima frase. Questo soffio del Vuoto-‐mediano, questo Tre, è indispensabile? Secondo il pensatore cinese, sì. Dal momento che, senza l’azione di questo soffio all’interno del Vuoto-‐mediano, lo Yin e lo Yang rimarrebbero ciascuno dalla propria parte in un atteggiamento di riserva o si scontrerebbero in una opposizione sterile. Mentre con l’intervento del Vuoto-‐mediano i due partners entrano in un campo allo stesso tempo aperto, distanziato ed interattivo e, attraverso la loro interazione, accedono alla reciproca trasformazione. Il soffio del Vuoto-‐mediano è dunque il contrario di un luogo neutro e vuoto, di un no mans land**. È un’entità dinamica in sé. Di sicuro nasce dal Due, vale a dire che può esserci solo quando c’è il Due. Però una volta lì non si cancella come una semplice raffica di vento passeggero; si fa presenza in sé stessa, un vero spazio di intercambio e scambio, un processo nel quale il Due potrebbe superarsi ed eccedere se stesso. Consideriamo adesso il secondo testo (Le Livre de la Voie et de sa vertu, cap. 1): Il Tao che può essere enunciato/ non è il Tao costante/ Il nome che può essere denominato/ non è il Nome costante/ Senza avere Nome, Principio del Cielo-‐Terra/ L’avere Nome, madre di Dieci mila esseri / Sempre senza-‐avere Desiderio/ per captare il germe/ Sempre l’avere Desiderio/ per prevedere il termine/ stessa uscita ma differente denominazione/ Partecipano del medesimo impulso originale/ Mistero ed altro mistero/ Porta di ogni meraviglia. Il primo testo ci ha informato in merito al meccanismo del Tao su come funzionano i soffi vitali, in particolare il soffio del Vuoto-‐mediano che porta con sé lo scambio tra lo Yin e lo Yang e, da lì, li conduce più lontano, nel processo di cambiamento continuo. Qui, in questo secondo testo, palpiamo una verità più sottile. Certamente il Tao implica il cambiamento continuo, però, nel seno di questa immensa marcia permanente, c’è qualcosa di costante che non cambia? Che non si altera mai, né si corrompe? E allora, risponde Lao-‐Tsé con un convincimento non sprovvisto di ironia:
4
quello che non cambia è il Vuoto stesso. Un Vuoto senza dubbio vivificante da cui si origina il soffio, da cui ciò che è senza-‐avere Nome tende costantemente verso l’-‐avere Nome; ciò che è senza-‐avere Desiderio tende costantemente verso l’-‐avere Desiderio. Ma qui c’è: dal momento che c’è Nome, dal momento che c’è Desiderio, non stiamo più nel costante. L’unico costante, il vero costante, una volta ancora, è il Vuoto da cui sorge costantemente il soffio. Da questa ottica, siamo costretti ad ammettere che il vero essere è in ogni momento il salto stesso verso l’essere, la vera vita è in ogni istante l’impulso stesso verso la vita. Da qui comprendiamo l’inquietudine dei pensatori cinesi per apprendere il Vuoto. Al cuore delle sostanze vive apparentemente più consistenti, più compatte, essi vedono operare il Vuoto ed il suo corollario il Soffio, i quali fanno si che, alla radice dei fenomeni abbondanti, destinati alla fine ad essere deteriorati, ci sia questa fonte costante che, lei, non si esaurisce, né tradisce. È la ragione per la quale è necessario, secondo loro, sostenere i due estremi, sostenere il senza-‐avere Nome ed il senza-‐avere Desiderio per captare il germe, sostenere il senza-‐avere Nome ed il senza-‐avere Desiderio per prevedere il termine. Qui, se si vuole dare un passo in più e formulare la cosa in maniera meno enigmatica, dirò: c’è in questi pensatori cinesi, come più tardi negli artisti cinesi, una preoccupazione costante. Essi cercano di connettere il visibile all’invisibile, il finito all’infinito, o inversamente introdurre il visibile nell’invisibile, e l’infinito nel finito, questo perfino nella stessa vita quotidiana. Ma come, concretamente? Attraverso il Vuoto-‐mediano, rispondono loro. Ciascuno di noi, ogni cosa in sé è una finitezza. L’infinetezza è quello che accade tra le entità vive. A condizione, senza dubbio, lo sappiamo adesso, che le entità in questione stiano in una relazione di scambio e non di dominio, e che tra di esse agisca il vero soffio del Vuoto-‐mediano. Il Vuoto-‐mediano è precisamente questo soffio che viene dal sé del soggetto quando si trova alla vista di altri soggetti e che lo spinge fuori di sé, perché il vivere ed il parlare gli siano indefinitamente possibili. Il Vuoto-‐mediano trasforma il soggetto in progetto, nel senso che lo proietta in avanti, tendendo sempre verso l’insperato, vale a dire verso l’infinito. Il soggetto giustamente non è questo bene gelosamente conservato, il dato, fissato una volta per tutte. La vera realizzazione non sta nello stretto recinto di un corpo misurabile, neppure in una vana fusione con un altro che sarebbe comunque una finitezza, ma l’andare e venire senza fine e sempre nuovo tra le unità della vita, il vero mistero sempre altro. Qui, se si accetta l’idea del soffio, si deve poter ammettere anche la visione secondo la quale anche le nostre sensazioni più intime non si limitano all’interno di un povero guscio d’uovo; esse sono vibrazioni, onde propagate in uno spazio che viene da sé, ma oltrepassandolo infinitamente, in risonanza con la grande ritmica del Tao. Lì sta la definizione stessa dell’estasi. Quello che abbiamo finito di vedere, attraverso i due testi di Le livre de la Voie et de sa vertu, concerne il pensiero taoista. L’opera seguente, che Lacan ha scelto spontaneamente, concerne il confucianesimo, giacchè si tratta del Mencio. In questa
5
occasione, d’altra parte, ci siamo ugualmente interessati ad alcuni passaggi delle Entretiens de Confucius, e di un’altra opera: Le Milieu juste (5). Mencio (371-‐289 prima di Cristo) è considerato un po’ come il San Paolo del confucianesimo. Avrebbe studiato a fianco di un discepolo del nipote di Confucio. Fu pertanto un rifugiato. Però per la sua focosità, per la sua eloquenza, contribuì a propagare le dottrine confucioniste in altre numerose scuole di pensiero. A dispetto della differenza tra le due correnti principali, taoista e confucianista, in particolare per quel che riguarda l’attitudine di fronte alla vita, l’essenziale del confucianesmo conferma, senza dubbio sul piano etico, molti degli elementi di base che abbiamo potuto vedere nei taoisti. In primo luogo: come i taoisti che hanno costruito il loro sistema con l’aiuto di tre elementi, lo Yang, lo Yin ed il soffio del Vuoto-‐madiano, i confucianisti fondarono la loro concezione del destino dell’uomo nel seno dell’Universo sulla triade del Cielo, la Terra e l’Uomo. Motivo per cui è permesso affermare che il pensiero cinese è decisamente ternario. E se si porta l’osservazione un po’ più lontano, si può constatare che, inoltre, c’è una corrispondenza tra il Tre taoista ed il Tre confucianista, nella misura in cui il Cielo concerne il principio Yang, la Terra il principio Yin e dove l’Uomo, questo essere intermediario, deve tenere in conto la doppia esigenza della Terra e del Cielo. Il giusto Mezzo designa qui una legge vitale e costante – non immutabile ma costante – nel funzionamento del Tao, una legge nella quale l’uomo può avere fiducia e della quale deve prorpio avere conto per accomodare la sua vita. Ricordiamo che il Tao non è altra cosa della Creazione in marcia, questa immensa avventura della vita nelle sue continue trasformazioni. Ora, qualunque sia il mistero che sottosta a questo ordine della vita, una cosa è sicura: il soffio primordiale che lo inaugurò mantiene sempre la sua promessa; non si devia, non tradisce. Detto in altro modo, non è capriccioso né insolente. Non cade nell’impusivo o nell’estremo, al punto da diventare imprevedibile. Al contrario, il pensatore confucianista constata che questo ordine della vita si mantiene nella durata; è costantemente affidabile. Cos’è che fa sì che questo ordine della vita sia costantemente affidabile, a dispetto di tante vicissitudini? È che la sua via fondamentale è il giusto Mezzo. Soprattutto non prendiate il giusto Mezzo nel senso di semi-‐misura o di compromesso, non cessano di ripetere i primi confucianisti ed i grandi commentatori che verranno dopo. Il giusto Mezzo è, come la trave centrale di un edificio, l’esigenza stessa della Via, la condizione severa a partire dalla quale la vita può raggiungere la pienezza delle sue potenzialità. È, in realtà, l’esigenza più difficile, mentre il capriccio e la fantasia sono facili, così come l’eccessivo o l’estremo. Secondo Mencio, il giusto mezzo è, tenendo in conto gli elementi presenti, e secondo il principio della vita, quello che si deve fare esattamente in ciascuna circostanza. È la più alta espressione della giustizia. Se è necessario, occorre stare pronti a
6
sacrificare la propria vita per la sua realizzazione. Tutta questa concezione, Mencio la deve essenzialmente a Confucio, che nei suoi Colloqui ebbe diverse occasioni per svilupparla. Ad un discepolo che lo interroga in merito al suo sapere, Confucio risponde di non possedere alcun sapere prestabilito, che il suo sapere è vuoto tanto quanto il Vuoto. Ma che se qualcuno gli si rivolgesse per una situazione umana concreta, egli si sforzerebbe sempre per esaminare la situazione fino ai suoi limiti estremi, prima di proporre, nella misura del possibile, la Via mediana più elevata, la più giusta. In basa a questa attitudine, d’altra parte, egli fece questa affermazione che piacque molto a Lacan: “Quando uno passeggia anche se si fosse in tre, ciascuno è sicuro di trovare nell’altro un maestro, facendo la parte del buono per imitarlo e superarsi, o del cattivo per correggerlo in sé stesso”(6). Questa affermazione ci fa cogliere la prospettiva confucianista secondo la quale, essendo ogni situazione umana intersoggettiva, quello che nasce tra le entità vive, soprattutto quando mirano a cercare il vero, non è qualcosa di astratto né di passeggero. Si incarna in una entità in sé, una specie di trans-‐soggetto, di fatto il vero soggetto, il giusto Mezzo per eccellenza, poiché è lui che permette ai soggetti in presenza di elevarsi, trasformarsi, nel senso della Via. Tanto più che su questo tema la tradizione dei letterati, che toccano il problema del soggetto, concepisce due tipi di io (me): il piccolo io ed il grande io. Il primo concerne il soggetto nel suo stato di individuo ed il secondo il soggetto nella sua dimensione sociale e cosmica (in relazione con la terra ed il cielo). In seno a quest’ultima dimensione, il soggetto deve sforzarsi di pensare ed agire nel senso del bene collettivo, certamente, però soprattutto cosmicamente, accettando l’idea che, se ha il merito di pensare all’universo, in fin dei conti è l’Universo vivo che non ha smesso di pensare a lui, per lui. Egli pensa così come è pensato attraverso tutti gli incontri decisivi. È così che si sente legato. È così che il suo piccolo io si lascia oltrepassare vantaggiosamente. A questo punto del nostro cammino, se occorre, prima di continuare, riassumere in alcune frasi tutto quello che abbiamo finito di vedere, direi, a rischio di ripetermi, che dal Libro dei mutamenti (7), – questa opera iniziale che mediante sessantaquattro trigrammi doppi composti da tratti pieni e da tratti spezzati, prova a raffigurare proprio tutta la complessità delle interferenze e delle trasformazioni quando il soggetto entra in relazione con l’altro e con gli altri -‐, tutti i pensatori cinesi accettano l’idea di una Via che, grazie ad interazioni interne, sia in mutazione permanente. Ma qualunque sia lo stadio della sua evoluzione, qualunque siano le entità vive in presenza, in ogni circostanza c’è, anche solo tra due persone, questo intervallo vitale, questo luogo inaggirabile percepito dai taoisti come il Vuoto-‐mediano e concepito dai confucianisti come il giusto Mezzo. Insomma, non è l’Uno che comanda il Due, ma il Tre che trascende il Due, non dimentico questo commento di Lacan. Qui, uno è in diritto di chiedersi dove risieda la divergenza tra taoismo e confucionismo. In primo luogo c’è in ciascuno una posizione differente: il primo,
7
privilegiando il principio Yin, si riferisce, per così dire, ad un ordine del femminile; il secondo, predicando il principio Yang, dipende prima di tutto dall’ordine del Padre. Poi, possiamo constatare questo. Mentre i taoisti predicano la comunione totale con l’universo vivente, fidandosi della capacità innata e naturale dell’uomo nel suo sforzo di accomodamento, i confucianisti, preoccupati prima di tutto per l’etica, credono che sia buono, e perfino necessario, regolare le relazioni umane mediante il Ly ed il Yue, cioè riti e musica. I riti, si capisce: si tratta di un insieme di attitudini e di gesti con l’obiettivo di creare la buona distanza e la buona misura. La musica, può sorprendere. Senza dubbio, Confucio proponeva differenti tipi di musica per ogni circostanza, spesso poi spoglie, adatte a generare il senso del ritmo e dell’armonia, nelle relazioni che ogni uomo deve mantenere con gli altri. Egli prevedeva le cinque relazioni seguenti: tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra amici e, sul piano istituzionale, tra sovrano e soggetto. Oltre a queste generalizzazioni, c’è un problema in Mencio che interessò particolarmente Lacan, il problema concernente la parola umana. Anche lì si vede la differenza di posizione tra taoisti e confucianisti. In una maniera generale, e direi istintiva, i taosti non hanno fiducia nella parola umana. Secondo loro, una parola troppo proliferante non potrebbe essere più di una forma degenerata dei soffi vitali. Per i confucianisti che credono nelle virtù dell’educazione, e per Mencio in particolare, che incoraggia l’espressione dei sentimenti e dei desideri, la parola al contrario è uno strumento indispensabile. Certo, Mencio non ignora che la parola è a doppio filo: essa può contribuire a raggiungere il vero, così come può corrompere, perfino distruggere. In un passaggio da cui Lacan ha copiato delle frasi, copia che ho conservato con cura (Mencio, cap. II), Mencio enumera davanti ad un interlocutore quattro classi di parole che egli considera deficienti o difettose: parole parziali, parole dissimulate, parole deformate e parole eccessive. Più avanti, Mencio afferma che, per quel che lo riguarda, in principio egli possiede il discernimento di fronte alle parole della gente, di quello che dicono. Al suo interlocutore che gli chiede su cosa fondi questa certezza, risponde che si sforza senza tregua di nutrire in sé il soffio integro o il soffio della rettitudine. Qui fa riferimento a quello che dicevamo un momento fa rispetto al soffio primordiale che, in quanto soffio integro, assicura l’ordine della vita senza mai deviare, senza mai tradire; è il garante della Rettitudine. Anche qui si vede che, almeno per i confucianisti, la parola umana è legata al soffio; in quanto abitata dal soffio integro, la parola umana può raggiungere il vero. Senza dubbio dall’altro lato, da buon confucianista, Mencio esalta anche il ruolo proprio dell’uomo, posto che l’uomo partecipa come terzo all’opera della Terra e del Cielo. Dato che la parola è un soffio, se l’uomo, grazie alla sua volontà e al suo spirito rischiarato, riuscisse a proferire parole giuste, contribuirebbe, a sua volta, a rafforzare il soffio che lo abita e che anima l’Universo. Alla fine, come nutrire in sé questo soffio integro? Per farlo, dice Mencio, occore che tutta la sua volontà, il suo cuore – sede dei sentimenti e dello spirito – tenda a ciò.
8
Soprattutto occorre mettersi in una disposizione di estrema umiltà e rettitudine. Di estrema pazienza anche: non fissare un termine preciso né cercare risultati immediati; non imitare quell’uomo dalle prospettive ridotte, che con il pretesto di aiutare le piante di riso a crescere più rapidamente, le tira verso l’alto e finisce per rovinarle completamente. Mencio non dubita che se si riesce a rispondere a queste esigenze, il risultato sarà assicurato. Nel 1960 alla fine del suo seminario sull’etica della psicoanalisi, Lacan parlò di Mencio dicendo che secondo costui la benevolenza era all’origine naturale dell’uomo. La degradazione venne dopo. Mencio era un appassionato della giustizia. Non ignora le deviazioni, le perversioni, il male, però crede, l’abbiamo detto, nella forza dell’educazione. Lui stesso era stato educato da sua madre che, per sottrarre il suo giovane figlio ad influenze nefaste, non aveva vacillato nel trasferirsi tre volte. Lacan era d’accordo con me nel pensare che i confucianisti probabilmente hanno riposto troppa fiducia nella natura umana. Non hanno scrutato il Male in maniera radicale, né hanno formulato in maniera radicale il problema del diritto per proteggere il soggetto. Questa è la grande lezione che la Cina può e deve imparare dal pensiero occidentale. È certo che Lacan ammirò questo atteggiamento di fiducia dei confucianisti per i quali all’uomo sono dati i beni e gli viene accordato l’accordo con il mondo dei vivi. Su questo tema, d’altro canto, Mencio espose una semplice argomentazione: dal momento che fare il male è la cosa più facile del mondo, che fare il bene è infinitamente difficile, quasi contro natura, e che senza dubbio di generazione in generazione quantità di uomini continuano spontaneamente a fare del bene, bisogna credere che il bene sia senza dubbio innato all’uomo fin dal principio. Altrimenti, nessun Signore di Lì-‐Sopra, nessun Cielo, nessuna Ragione avrebbe la possibilità di imporselo da fuori, retroattivamente. L’ultima opera che abbiamo studiato è un trattato di pittura composto da diciotto capitoli brevi. Intitolato Propos sur la peinture du moine Citrouille-‐amère (8), scritto dal grande pittore Shitao, del secolo XVII. Il desiderio di Lacan di approfondire la sua conoscenza di un testo tanto particolare al principio mi sorprese, poi mi incantò. Non tardai nel riconoscere l’interesse che poteva presentare un testo così per lui e, di ritorno, per me stesso. L’arte calligrafica e pittorica, così come viene praticata in Cina, è un’arte di vita. Mette in pratica, giustamente, tutti gli elementi della cosmo-‐ontologia che abbiamo messo in luce. Nel suo trattato, Shitao ha elaborato un pensiero strutturato, fondato su tutto un insieme di nozioni, a volte tecniche, di cui è difficile dar conto qui. Senza dubbio, segnaleremo alcune nozioni di base sulle quali si era soffermato Lacan, come la nozione di Yin-‐Yun, quella del Tratto unico di Pennello, e infine quella di Recettività. Tutte queste nozioni che dipendono dalla creazione artistica sono in relazione intima con la maniera in cui i pensatori cinesi concepiscono, semplicemente, la Creazione. La prima nozione, per esempio, lo Yin-‐ yun, che alcuni traducono con il caos. Come suggerisce la sua pronuncia, lo Yin-‐yun designa uno stato in cui lo Yin y lo Yang sono ancora indistinti però in virtuale
9
divenire. Lo stato che esso designa non è altro che la promessa della vita, un luogo aperto dove l’impulso del non-‐essere verso l’essere è possibile, perfino immanente. Nella pittura è proprio questo spazio primario quello in seno al quale il desiderio della forma può emergere, e l’atto della raffigurazione può intraprendersi. Nella realizzazione di un quadro, all’ inizio si trova certamente lo Yin-‐yun; ma deve rimanere presente nel corso dell’esecuzione e sussistere fino alla fine, tanto che, nell’ottica cinese, un quadro troppo rifinito è un quadro fallito, in un vero quadro deve rimanere uno spazio sempre virtuale, che tenda verso altre metamorfosi. È in relazione a questa immagine del Yin-‐yun che la seconda nozione, quella del Tratto unico di Pennello, acquista tutto il suo rilievo. Il Tratto unico di Pennello si dispiega dal Yin-‐yun in quanto prima affermazione dell’essere. Esso è l’immagine del soffio primordiale che si dispiega dal Vuoto originale. È per questo che, da lì in poi, si può affermare, come fece lo stesso Shitao, che il Tratto nell’ordine pittorico è l’equivalente del soffio, ne è la traccia tangibile. Il Tratto non è una semplice linea. Per mezzo di un pennelllo, imbevuto nel colore, l’artista colloca il Tratto sulla carta. Per la sua pienezza ed il suo profilo, il suo Yang ed il suo Yin, la spinta ed il ritmo che implica, il tratto è virtualmente ed allo stesso tempo forma e movimento, volume e tintura. Costituisce una cellula vivente, una unità di base di un sistema di vita. E inoltre, in quanto significante poderoso, il Tratto significa sempre più di quello che manifesta. Perché pur essendo in sé stesso una completezza, chiama alla trasformazione che porta in germe. Non cessa di chiamare altri tratti, come proclama Shitao: Il Tratto unico di Pennello contiene in sé i Dieci Mila Tratti. In questo modo, è intorno a questo nodo in movimento, equivalente al soffio, allo stesso tempo l’Uno ed il Molteplice, la traccia e la trasformazione, che la tradizione pittorica cinese, rinnovada da Shitao, ha forgiato una pratica significante che possiede una coerenza organica. Per acquisire l’arte del Tratto, è sufficiente un esercizio assiduo? No, dice Shitao, giacchè si tratta di una disciplina di vita. Per quello, occorre che l’artista sia in condizione di accoglierlo. È qui che interviene la nozione di Recettività. Così come il Tratto deve essere mosso dal soffio, nella stessa maniera occorre che in primo luogo l’artista, nel suo più intimo, sia mosso dai soffi vitali, tanto dallo Yin e Yang quanto dal Vuoto mediano, quegli stessi che sono stati capaci di incarnarsi in bambù e roccia, montagna ed acqua. L’artista deve raggiungere questo grado di disponibilità aperta dove i soffi interni che lo abitano siano in condizione di rivelare quelli che vengono dal Difuori. Il vero Tratto non può che risultare dall’incontro tra soffi interni e soffi esterni. Venerare la ricettività è l’ultima raccomandazione lanciata da Shitao. Quest’ultimo non ignora che vi siano conoscenze conscie e pratiche, ma afferma che la Ricettività è prima e la Conoscenza seconda. Per dirla tutta, la Ricettività è uno stato superiore della Conoscenza, una specie di intuizione piena attraverso la quale captiamo qualcosa che non sappiamo e che senza dubbio in anticipio già sappiamo. Finiamo di trattare l’idea del Tratto. Passiamo adesso dal Tratto alla combinazione di
10
tratti, e dalla combinazione di tratti alle figure disegnate. Tra le figure disegnate più astratte e al tempo stesso più significanti occorre considerare gli ideogrammi che, come si sa, sono un insieme di segni fatti di tratti strutturati ogni volta intorno ad un centro, secondo determinate regole che però offrono varietà infinite. A causa degli ideogrammi, la calligrafia diventò un arte principale. Per la gestualità nell’atto e nel ritmo che essa suscita, la calligrafia esalta l’essere carnale dei sensi, ristabilendoli nella loro dignità piena. Se parlare è un soffio, anche scrivere è un soffio. I segni da tracciare impegnano corpo e spirito di colui che traccia, lo proiettano al di fuori affinchè si realizzi in figure formali ma piene di senso. Piene di senso, abbiamo detto. La parola senso al plurale, cioè il senso dei segni nei quali l’uomo si implica interamente è inesauribile. A proposito di questo, non posso non aprire una parantesi per evocare l’ideogramma yi a proposito del quale Lacan ed io abbaimo avuto una delle discussioni per me più istruttive. Questo ideogramma, che ha come significato originale idea o intenzione, gode di numerose combinazioni con altri ideogrammi per formare tutta una famiglia di termini che girano intorno alla nozione di immagine, di segno e di significazione. È così che, a partire dal nucleo yi, assistiamo alla nascita della seguente serie: yi-‐yu, desiderio; yi-‐ya, mira; yi-‐xiang, orientamento; yi-‐xiang, immagine, segno; yi-‐hui, comprensione; yi-‐yi o zhen-‐yi, significazione o essenza vera; yi-‐jing, stato aldilà del visibile. Dei due ultimi termini, lo yi-‐yi, significazione, implica l’idea della giusta efficacia, mentre lo yi-‐jing, stato non dicibile, implica l’idea di un oltrepassamento in relazione alla parola significata. E tutta questa serie di parole ci inspira la constatazione che, da una parte, il segno è il risultato di un desiderio, di una mira, e dotato di una significazione che senza dubbio non lo esaurisce, e che, dall’altra parte, la vera significazione di un segno può agire efficacemente e l’oltrepassamento del segno non può farsi che a partire da questa stessa significazione. La nostra discussione su questo tema ci portò naturalmente, lo ricordo bene, a riferirci alla concezione decostruttivista del linguaggio e pensammo che se è giusto affermare che il significato di uno scritto è senza sosta differito, questo non impedisce che in ogni situazione specifica, in ogni incontro decisivo, la significazione sia data, nella misura in cui la significazione in questione agisce efficacemente sugli esseri presenti, facendoli accedere, nel migliore dei casi, alla trasformazione. A Lacan piacevano gli ideogrammi – per la loro forma e la loro maniera ingegnosa di suggerire il senso – così come la calligrafia. Egli mi disse che mi invidiava il fatto di poter praticare quest’arte legata al cocreto come una terapia. Mi parlò anche di André Masson, che considerva come un calligrafo occidentale. Nel 1973, ci fu un’esposizione cinese nel Petit Palais. Ci andammo insieme. In mancanza di pitture e calligrafie, contemplammo a lungo gli oggetti, in particolare quelle linee altamente stilizzate, incise sopra il bronzo. Ma quello che affascinava Lacan, senza dubbio, sono questi segni scritti come sistema. Un sistema che è al servizio della parola, seppur mantenendo una distanza in relazione ad essa. Dal momento che ciascun
11
ideogramma forma una unità autonoma ed invariabile, il suo potere significante si diluisce poco nella catena. In questo modo, essendo capace di trascrivere fedelmente la parola, il sistema può anche, per tutto un processo di ellissi volontaria e di combinazione libera, generare al suo interno un gioco aperto, soprattutto nel linguaggio poetico dove, all’interno di un segno e tra i segni, il Vuoto-‐mediano agisce polverizzando il dominio della linearità unidimensionale. A proposito di questo, ricordiamo che mi sono congedato da Lacan intorno al 1974 per consacrarmi proprio alla redazione di un’opera sulla scrittura poetica cinese. Quest’opera, pubblicata nel 1977, attrasse tutta l’attenzione di Lacan. In una lettera datata 22 aprile 1977, mi scrive: “Ho tenuto conto del suo libro nel mio ultimo seminario, dicendo che l’interpretazione – cioè quello che deve fare l’analista – deve essere poetica (parola sottolineata da Lacan)”. In seguito, abbiamo avuto diversi incontri, dei quali uno per me memorabile, nella sua casa di campagna nel corso di una giornata intera. In un articolo per la rivista L’Ane, relazionai in una maniera abbastanza dettagliata quello che ci siamo potuti dire in merito ad un’ottava del secolo VIII, "El pabellón de la grulla amarilla" de Cui Hao. Qui, oggi, mi accontento di evocare una quartina di Wang Wei che studiammo quel giorno, in qualche modo come antipasto. Io gli chiedevo come definisse la metonimia e la metafora. Mi disse che si guardava bene dal farlo. Che a paritre dall’idea della continuità e della similitudine si può sempre approfondire, però l’ importante è osservare il legame tra le due figure nel suo funzionamento. Immediatamente dopo aprì il mio libro alla ricerca di semplici esempi e vi ricavò la quartina di Wang Wei. Lì, ancora una volta, devo dire che ammirai l’olfatto lacaniano. Il poema, intitolato, “Il Lago Qi”, ha come tema una scena di congedo. La scena è descritta da una donna che accompagna il proprio marito fino alla riva del lago suonando il flauto. Mentre lei rimane sulla riva, l’uomo si allontana in barca per un lungo viaggio. Questo è quello che indicano i due primi versi. Il terzo verso dice che, ad un certo punto, nel cuore del lago, ormai lontano, l’uomo si gira. E quest’utlimo verso termina in una maniera un po’ aspra, come un fermo immagine, con questo: Montagna verde cinge nube bianca. Con questo verso siamo in presenza di due metafore, montagna verde e nube bianca, in una relazione di metonimia. Ad un primo livello, l’immagine rappresenta quello che l’uomo effettivamente vede dal centro del lago quando si volta. La montagna dunque raffigura l’essere che rimane lì, sulla sponda, vale a dire la donna; mentre la nube, simbolo dell’erranza, raffigura l’essere che parte, cioè l’uomo. Però, ad un livello più profondo, c’è come un ribaltamento dello sguardo. Posto che nell’immaginario cinese, da sempre, la montagna appartiene allo Yang e la nube allo Yin. In questo caso, la montagna designa l’uomo e la nube la donna. Il verso intero sembra ascoltare la voce interiore di ciascun protagonista. L’uomo montagna sembra dire alla donna: “Sto vagando, però rimango fedelmente lì, accanto a te” e la donna-‐nube sembra rispondere all’uomo: “Sono qui, ma il mio pensiero si fa viandante con te”. In realtà, ad un
12
livello ancora più profondo, quest’ ultimo verso dice quello che per pudore o per impotenza la donna non arriva mai a dire con un linguaggio diretto e denotativo: tutta la relazione sottile ed inestricabile tra uomo e donna. Secondo i cinesi, la nube nasce dalle profondità della montagna, in principio sotto forma di vapore, il quale salendo verso il cielo si condensa in nube. In cielo può vogare un istante a suo capriccio, ma torna verso la montagna per circondarla. È detto nel verso: “Montagna verde cinge nube bianca”. Il verbo cingere, non sottolineato qui, può essere attivo, nel senso di circondare, o passivo, nel senso di essere circondato, in maniera tale che il verso significa allo stesso tempo “la montagna cinge la nube” e “la montagna si lascia cingere dalla nube”. Un legame che alterna attivo e passivo, o inversamente. È tutto? No. Occorre rompere il pudore segnalando il fatto che la nube torna a cadere in qualità di pioggia sulla montagna. Questo fatto possiede un significato più profondo ed una portata più ampia di quello che si pensa. Certamente, si sa che in cinese l’espressione “nube-‐pioggia” significa l’atto sessuale. È molto interessante ma possiamo andare più lontano. La nube che si innalza dalle viscere della montagna, che sale al cielo e che torna a cadere come pioggia per rialimentare la montagna, di fatto incarna l’immenso movimento circolare che lega la Terra ed il Cielo. Da questa ottica, si intravede un po’ il mistero del Maschile e del Femminile. La montagna verde, alzata tra Terra e Cielo, entità apparentemente stabile, è senza dubbio precaria, essendo sotto la minaccia di perdere la sua qualità di verde se non viene alimentata dalla nube. Per quanto riguarda la nube, un’entità fragile, è tenace. Aspira a prendere multiple forme perché porta con sé la nostalgia dell’infinito. Attraverso di essa il Femminile cerca – spezzandosi il cuore – di dire l’infinito che non è altro che il suo proprio mistero (9). Siamo nell’immaginario cinese. Come non segnalare di passaggio la meravigliosa coincidenza in francese dove, foneticamente, l’immagine della donna “nuda” (“nue”) è legata anche a quella della “nube” ("nue") ***. Cosa che ha permesso la ricca ambiguità del poema di Mallarmé che comincia con "A l'accablante nue..." “All’opprimente nube…”. In fin dei conti credo che fosse per braccare questo misterioso Femminile, caro al pensiero taoista, che il dottor Lacan intraprese in mia modesta compagnia, ma con quale ingegnosa pazienza, la sua ricerca cinese.
Traduzione di Laura Pacati BIBLIOGRAFIA: (1) Cheng F., L' Écriture Poétique chinoise, Le seuil, coll. "Points", 1996; e Vide et plein, le langage pictural chinois, Le Seull, col. "Points", 1991. (2) Per la lettura del Libro della via e della virtù, Lacan consultó diverse traduzioni, in particolare quelle di J.J.L. Duyvendak, Jean Maisonneuve, e di F. Houang e P. Leiris * (N. del T.), Via e Voce in francese sono omofoni.
13
(5) Queste tre opere -‐ Dialoghi di Confucio, Mencio, Il giusto mezzo – formano, insieme a Il grande studio, i quattro libri canonici del confucianesimo. Lacan li ha studiati nella traduzione di Séraphin Couvreur (redatta dalle edizioni Kuan-‐Chi, in vendita, a Parigi, nelle librerie Le Phénix Y You-‐feng). (6) Confucio, Dialoghi a cura di Tiziana Lippiello, Torino, Einaudi, 2003. (7) Libro di previsione del futuro la cui versione attualmente conosciuta è attribuita al re Wen dei Zhou, all’incirca mille anni prima della nostra era. (8) Shitao, Propos sur la peinture du moine Citrouille-‐amere, trad. P. Ryckmans, reed. Hermann, 1997.