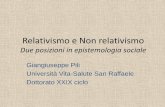Raniero Grassucci_"SITAR -MPic: un primo tentativo di interoperabilità tra sistemi"
Il culto di san Teobaldo in terra veneta: un rapido sguardo dal medioevo a oggi tra continuità e...
Transcript of Il culto di san Teobaldo in terra veneta: un rapido sguardo dal medioevo a oggi tra continuità e...
TEOBALDO DI PROVINSUN ‘CONVERTITO’ TRA FRANCIA E ITALIA
NELL’ETà DI GREGORIO VII
Atti del convegno di studi(Vicenza e Badia Polesine, 19-20 ottobre 2012)
a cura diFrancesco Bianchi
VIELLA2013
Copyright © 2013Istituto per le ricerche di storiasociale e religiosaCopyright © 2013 - ViellaTutti i diritti riservatiISBN 978-88-6728-200-5
Con il contributo di:
Provincia di Rovigo
Comune di Sossano
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Sossano
Comune di Badia Polesine
Centro Studi Berici
Farmacia Dr. Guido Bonetto di Badia Polesine
Zetalinea, tecnologie per il riscaldamento a legna, di Badia Polesine
Spedo, macchine agricole, di Badia Polesine
Parrocchia di San Giovanni Battista di Badia Polesine
viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 Romatel. (+39) 06 8417758fax (+39) 06 853353960e-mail: [email protected]
INDICE
Apertura VII
Alfredo Lucioni, Conversione e conversioni di Teobaldo di Provins 3
Giancarlo Andenna, Brevi considerazioni sul tema: eremiti e papato tra XI e XII secolo 33
Nicolangelo D’Acunto, Teobaldo di Provins, Alessandro II e Pier Damiani 49
Catherine Vincent, L’image de saint Thibaut de Provins dans l’hagiographie médiévale française (XIIIe-XVe siècle): ermite, moine ou prêtre? 65
Francesco Veronese, Il culto di san Teobaldo in terra veneta: un rapido sguardo dal medioevo a oggi fra continuità e discontinuità 89
Francesco G. B. Trolese, Il monachesimo veneto tra Impero e papato nell’età di san Teobaldo (sec. XI) 113
Giorgio Cracco, Teobaldo di Provins: un convertito a Gesù nell’Europa di mille anni fa 147
Tavola delle abbreviazioni 208
Indice delle figure 209
Indice dei nomi 210
89
Francesco Veronese
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA: UN RAPIDO SGUARDO DAL MEDIOEVO A OGGI
FRA CONTINUITà E DISCONTINUITà
Nella ormai plurisecolare storia degli studi sulla figura, la vicenda bio-grafica e il dossier agiografico di san Teobaldo di Provins, non poco interesse è stato a più riprese rivolto agli aspetti relativi al culto a questi tributato: le sue forme, in particolar modo liturgiche; la sua diffusione nello spazio, che ha portato la sua memoria cultuale a radicarsi in almeno quattro Stati europei attuali (Italia, Francia, Germania e Lussemburgo), in regioni dove il santo stesso avrebbe trascorso periodi più o meno lunghi della sua esistenza terrena, stando a quanto affermano le sue Vitae; e le sue trasformazioni nel tempo. Su questi temi si sono soffermati, in maniera più o meno approfon-dita, molti di coloro che si sono occupati di san Teobaldo: da Severo Senesi, monaco camaldolese del XVII secolo autore di una cronaca del monastero di Santa Maria della Vangadizza e molto attento, per devozione personale, a tutto ciò che concerneva il culto di san Teobaldo1; a Godefroy Henschens, cui si deve il Commentarius praevius che introduce l’edizione di una delle Vi-tae di Teobaldo (BHL 8032) nel quinto volume degli Acta sanctorum, Iunii2; a Bonifacio Collina, anch’egli camaldolese, autore, nel 1752, di una Vita di san
1. La seconda parte della cronistoria della Vangadizza redatta dal Senesi si apre con una se-zione interamente dedicata alla vita del santo e ai miracoli da lui compiuti, tratti dal suo dossier agiografico; il prosieguo dell’opera è inoltre punteggiato di riferimenti alle vicende del culto, e soprattutto delle reliquie, di Teobaldo nel monastero polesano. La particolare attenzione per questo santo è del resto affermata già nel titolo della terza e definitiva versione del testo, che recita Fronde sparte della Badia terra nel Polesine con la vita di san Teobaldo confessore. Si rimanda a Il potere della fede. Splendore e tramonto della Vangadizza nelle Fronde sparte del monaco camaldolese don Severo Senesi, a cura di R. Viaro, Treviso 2005 per l’edizione della terza versione delle Fronde sparte; la parte relativa alla vita e ai miracoli di Teobaldo è alle pp. 140-157. Lo stesso Senesi com-pose inoltre una biografia di san Teobaldo, inserita, insieme alle altre opere bio-agiografiche del medesimo autore, nel codice che reca la versione delle Fronde sparte edita da Viaro, conservato in Biblioteca dell’Archicenobio di Camaldoli, ms 638.
2. Acta sanctorum, Iunii, V, Antverpiae 1709, pp. 588-592.
90
Francesco Veronese
Teobaldo in cui pubblicò una versione della Vita agiografica (BHL 8031) lie-vemente diversa rispetto a quella riportata negli Acta sanctorum di giugno3; fino ad arrivare, in tempi più recenti, ad Antonio Mistrorigo, che nel 1950 diede alle stampe una nuova Vita di san Teobaldo a carattere perlopiù devo-zionale4. E questo solo per citare gli studiosi più noti5.
Ancor più recente è poi la comparsa di studi dedicati esplicitamente e in misura preponderante, quando non esclusiva, proprio al culto di san Teo-baldo e alle sue varie espressioni. Fondamentale, in questo senso, è il contri-buto di Corrain e Zampini apparso nel primo volume degli Atti e memorie del Sodalizio Vangadiciense, all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, in cui l’analisi antropologica dei resti del santo conservati nell’arcipretale di Badia Polesine è preceduta da una sorta di rassegna dei principali luoghi e forme della devozione a Teobaldo su entrambi i lati delle Alpi6. Qualcosa di simile, ma dal punto di vista offerto dall’osservatorio francese, fu proposto, sem-pre negli anni Settanta, da Bernard, che si concentrò sul culto di Teobaldo nella regione di Provins7. Al di là di queste pur importanti eccezioni, cui si può forse aggiungere la voce sul santo eremita compilata da Cacciamani per la Bibliotheca sanctorum – risalente grosso modo ai medesimi anni8 –, le questioni legate al culto di Teobaldo non hanno tuttavia più suscitato parti-colare attenzione da parte degli studiosi; men che meno, poi, si è proceduto a un esame di tale culto limitatamente all’area veneta, quella dove, in ambi-to italiano, tale culto sembra essersi maggiormente, se non esclusivamente, radicato.
3. B. Collina, Vita di s. Teobaldo eremita e monaco camaldolese, Bologna 1752; sull’autore vedi la voce di M. Vigilante, Collina, Bonifacio, in DBI, 27, Roma 1982, pp. 58-60.
4. A. Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo. Un santo taumaturgo poco noto, Vicenza 1950.5. Altre opere biografiche e devozionali su san Teobaldo furono composte da: A. Allou,
Vie de saint Thibaut prêtre et ermite, Meaux 1873 (disponibile in formato digitale all’URL: ‹http://www.nd-bermont.fr/content/vie-de-saint-thibaut-par-mgr-allou› [10.11.2013]); I. Porra, Vita di s. Teobaldo, Vicenza 1926; B. Soffiantini, Vita di s. Teobaldo, Rovigo 1933 (anch’esso integral-mente disponibile in formato digitale all’URL: ‹http://theobaldus.org/it/node/4› [10.11.2013]).
6. C. Corrain, P. L. Zampini, S. Teobaldo nella storia e nelle tradizioni popolari, «Atti e memorie del Sodalizio vangadiciense», 1 (1972-1973), pp. 95-118.
7. R. P. Bernard, Saint Thibaud de Provins. Vie, culte, iconographie, «Provins et sa région. Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins», 131 (1977), pp. 89-104.
8. G. Cacciamani, Teobaldo di Provins, in Bibliotheca sanctorum, 12, Roma 1969, coll. 196-197.
91
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
Di estrema importanza si presenta, per questi motivi, l’iniziativa del con-vegno su Teobaldo organizzato dall’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza, e ancor più la proposta di suddividere l’esame del culto di san Teobaldo per aree geografiche diverse, affidate a studiosi diversi, così che i risultati che emergeranno da ciascun contributo possano poi essere posti a confronto al fine di delineare un quadro d’insieme, il più dettagliato, ma al contempo coerente, possibile9. Ringrazio dunque gli organizzatori del convegno per avermi dato la possibilità – e anche la responsabilità – di occuparmi dell’area veneta. Mi preme tuttavia affermare, a mo’ di premessa, come le pagine che seguiranno non costituiscano che una sorta di campio-natura, iniziale e da approfondire in più punti, dei luoghi, dei tempi e dei modi del culto del santo monaco in questa regione; una campionatura gra-vata inoltre non di rado dalla dispersione, quando non dalla vera e propria perdita, delle fonti principali, in particolare liturgiche e documentarie, per lo studio di questi fenomeni, ma anche dalla stessa natura di questi ultimi, per certi versi volatile, soprattutto quando affidata a tradizioni orali e slega-ta da manifestazioni materiali, e perciò riscontrabili dallo storico, quali ad esempio la presenza di altari dedicati al santo.
Gli spunti di partenza per tentare di affrontare il tema di cui intendo trattare, ossia il culto, la memoria, e per certi versi anche l’identità, di san Teobaldo in terra veneta, sono offerti a mio parere dal ricco dossier agiogra-fico di san Teobaldo, che è stato già più volte richiamato, e ancora lo sarà, nelle pagine di questo volume. La Vita Theobaldi, nella sua versione ritenuta più antica e convenzionalmente attribuita all’abate Pietro della Vangadizza10 (non, dunque, quella edita negli Acta sanctorum di giugno11), parlando di un miracolo compiuto dal santo in favore di alcuni pellegrini milanesi giunti
9. Vedi il contributo di Catherine Vincent in questo volume.10. Nella BHL, grande catalogo di tutti i testi agiografici noti redatto dai bollandisti, essa
è indicata con il numero 8031. Il testo (d’ora in poi Vita Theobaldi) è edito in Collina, Vita di s. Teobaldo, pp. 311-332. Sulla sua supposta, ma a tutt’oggi ipotetica, attribuzione all’abate Pietro, derivante da un passo della Translatio alla Vangadizza (BHL 8039; vedi infra nota 15), cfr. P. Tomea, L’agiografia dell’Italia Settentrionale (950-1130), in Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, III, a cura di G. Philippart, Turnhout 2001, nota 76 e testo corrispondente a pp. 131-132.
11. BHL 8032. Vedi Acta sanctorum, Iunii, V, pp. 592-595. Questo testo è stato recentemente tradotto in italiano in Vita di san Teobaldo, a cura di R. Ravazzolo, Selvazzano 2004.
92
Francesco Veronese
a Sajanega per onorarlo, afferma: «Quo tempore contigit Mediolanenses aliquot ad sanctum Marcum orationis gratia euntes, audita fama sancti viri [Theobaldi] odorifera, ad eundem locum [Sallanicam], sicut ex diversis par-tibus ad eum confluebant, accedere»12. Il testo indica dunque che Sajanega, luogo di ritiro veneto di Teobaldo, sarebbe già divenuta meta di pellegri-naggio mentre il santo era ancora in vita, come del resto avvenuto anche in altri luoghi transalpini dove egli aveva condotto le varie tappe della sua esperienza eremitica.
La breve Translatio di Teobaldo a Vicenza, che giustamente Tomea con-sidera un testo diverso e lievemente posteriore alla Vita13, indica come «post tumulationem beati Theobaldi placuit divinae maiestati, annuente beata Dei genitrice Maria, cooperantibus sanctis martyribus Leoncio et Carpophoro, in quorum basilica idem requiescit, mirificare sanctum suum virtutibus et miraculis»14. Il passo, oltre all’evidente volontà di ‘vicentinizzare’ Teobaldo legandone culto e memoria alla cattedrale di Vicenza e alla locale venera-zione per i suoi patroni (la Vergine e i santi Leonzio e Carpoforo), sembra sottintendere l’attivazione, per l’appunto, di un culto per lo stesso Teobaldo all’interno della cattedrale, forse in una cripta preesistente o appositamen-te costruita per ospitarne le spoglie, come sembra attestare la più corposa Translatio di Teobaldo alla Vangadizza15; tale culto sarebbe stato sostenuto e catalizzato dai miracoli di cui parla il testo, di origine con ogni probabilità vicentina. A comprovare e rendere ufficiale il culto vicentino di Teobaldo interviene la lettera papale di canonizzazione del santo emanata da Alessan-dro II tra il 1066 e il 1073, per intercessione dei cardinali Mainardo di Silva Candida e Pier Damiani e su richiesta del popolo vicentino: «et quia procul
12. Vita Theobaldi, p. 324.13. Tomea, L’agiografia del’Italia Settentrionale, nota 76 a p. 132.14. Anche questo testo, designato come BHL 8033 e dunque già dai bollandisti ritenuto au-
tonomo, è edito in Collina, Vita di s. Teobaldo, p. 333.15. La Translatio Vangadiciam (BHL 8039) è pubblicata integralmente in Acta sanctorum ordinis
Sancti Benedicti, a cura di L. D’Achery, J. Mabillon, Th. Ruinart, VI/2, Venezia 1738, pp. 175-181 (dalla cui edizione si trarranno le citazioni del testo), e in G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, II, Venezia 1756, pp. 360-364, 369-372. Collina, Vita di s. Teobaldo, pp. 342-353 riporta solo la prima parte, relativa alla vera e propria traslazione del corpo di Teobaldo da Vicenza alla Vangadizza, espungendo i miracoli compiuti dal santo nell’abbazia.
93
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
dubio cum electis coronatur [Theobaldus] in caelis, praecipimus ut illius memoria, sicut et aliorum sanctorum, solemniter celebretur in terris»16.
Un passo molto simile a quello della Translatio vicentina ricorre proprio nella Translatio vangadiciense, che descrive un nuovo adventus dei resti del santo e l’occursus di popolo radunatosi ad accoglierlo:
immensis […] laudibus monachorum et clericorum, utriusque sexus turba virorum ac mulierum, puerorum ac virginum infinita obvia pertulerunt in basilicam sanctae et gloriosae ac virginis Mariae [Van-gadiciae], ubi multa magnalia ad laudem et gloriam summi Condi-toris per eius praesentiam et intercessionem fiunt, praestante ipso Domino nostro Iesu Christo, qui vivit et regnat in saecula17.
Questi multa magnalia furono, come conferma la continuità di un culto vivo e attivo ancora oggi in Badia Polesine, al contempo causa ed effetto del radicamento del culto di Teobaldo alla Vangadizza.
Questi testi agiografici, che la critica ha (per quanto indiziariamente e ipoteticamente) datato alla seconda metà dell’XI secolo18 – pressoché all’in-domani della morte di Teobaldo –, sembrano insomma delineare una prima mappa dei luoghi di culto del santo in terra veneta, correlata ai passaggi e agli spostamenti dello stesso eremita transalpino o dei suoi resti; una mappa da cui partire quindi alla ricerca delle attestazioni, delle forme e delle prati-che relative a questo culto. E che, del resto, almeno in questi luoghi un culto di Teobaldo vi sia stato (e, come si vedrà, vi sia ancora), appare comprovato, oltreché da quanto si dirà qui di seguito, anche e anzitutto da quegli stessi testi: al di là di un loro possibile utilizzo nella liturgia sviluppata in questi luoghi di culto per i giorni di festa di Teobaldo, utilizzo che almeno in alcu-ni casi sembra comprovato dalle fonti liturgiche19, la loro stessa esistenza, e l’evidente volontà dei loro autori/committenti di esaltare (o fondare) il rap-
16. Per questo testo vedi Acta sanctorum, Iunii, V, pp. 596-597 (cit. p. 596).17. Translatio Vangadiciam, p. 179.18. G. Cracco, Santità straniera in terra veneta (secc. XI-XII), in Les fonctions des saints dans le
monde occidental (IIIe-XIIIe siècle), Rome 1991 (Actes du colloque, Rome, 27-29 octobre 1988), pp. 462-465; Tomea, L’agiografia del’Italia Settentrionale, nota 76 a pp. 131-132.
19. Vedi infra nota 79 e testo corrispondente.
94
Francesco Veronese
porto privilegiato tra il santo e la loro comunità di appartenenza, appaiono indicativi di strategie volte a fare di tali comunità e di tali luoghi dei centri della memoria e del culto dell’eremita francese.
È però lecito porsi, a questo punto, una domanda: oltre a questi luoghi, citati espressamente dal dossier agiografico di Teobaldo, è possibile rintrac-ciarne altri, sempre in area veneta, ove il suo culto sia o sia stato praticato? Se sì, quali?
Come detto in precedenza, le mie ricerche sul culto di Teobaldo in terra veneta sono ancora allo stadio di una semplice campionatura iniziale, di cui si forniscono qui i primi risultati. Forse per questo motivo non mi è stato possibile (non ancora, perlomeno) implementare di molto la mappa cultuale teobaldina disegnata dai più antichi testi agiografici dedicati al santo con ul-teriori attestazioni di luoghi ove il suo culto fosse radicato, ma soprattutto, ai nostri occhi, testimoniato. Non ho, insomma, trovato notizie di forme devozionali in onore di Teobaldo in luoghi diversi da quelli menzionati nel-le agiografie, con la consueta limitazione all’ambito veneto, ché dall’altra parte delle Alpi la situazione è ben diversa. Mi limito a segnalare solo un paio di esempi di carotaggi biblio-documentari che ho provato a eseguire, ma che non hanno dato i risultati sperati. Il primo è preso dalle Rationes decimarum relative all’area veneta e ai secoli XIII-XIV, una fase tutto som-mato alta della storia cultuale di Teobaldo, ma a mio avviso significativa: proprio all’inizio del XIII secolo i camaldolesi subentrarono infatti ai be-nedettini nella gestione del monastero della Vangadizza, e dunque anche del culto locale del santo20. Un momento di svolta, dunque, per tale culto, che, si potrebbe ipotizzare, avrebbe potuto essere al centro di strategie di lancio o rilancio da parte dell’ordine. In effetti, i camaldolesi elaborarono strategie proprie legate a Teobaldo e al suo culto, che andarono nel senso di una revisione identitaria del santo stesso, ripresentato, nelle opere degli scrittori dell’ordine (sul lungo periodo), come monaco camaldolese21; non, però, nel senso di una diffusione spaziale del culto stesso. Questo almeno è
20. Su questa importante fase di transizione, e più in generale per la storia dell’abbazia vanga-diciense dalla sua fondazione all’epoca moderna, vedi l’agile sintesi di G. Vedovato, L’Abbazia di Santa Maria della Vangadizza, in Diocesi di Adria-Rovigo, a cura di G. Romanato, Venezia-Padova 2001, pp. 356-357.
21. Vedi infra note 60-61 e testo corrispondente.
95
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
quanto sembra emergere dalle Rationes decimarum, che non indicano alcun edificio di culto – tra quelli, occorre notarlo, obbligati a versare regolare decima – dedicato al santo in area veneta22; bisogna tuttavia sottolineare come, dalla catalogazione, manchino le chiese della diocesi di Adria, nel cui ambito territoriale23 si trovava appunto la Vangadizza. E proprio a questo aspetto, sebbene da un punto di vista un po’ particolare ma proprio per questo ancor più interessante, si ricollega il secondo esempio. Nel 1792, a seguito della soppressione della Vangadizza decretata tre anni prima dal Se-nato veneziano, alla diocesi di Adria furono annesse dodici parrocchie pole-sane sino a quel momento dipendenti dal monastero e facenti parte della sua dioecesis nullius: vale a dire, le Chiese di Badia, Baruchella, Salvaterra, Cro-cetta, Villafora, Rasa, Barbuglio, Saguedo, Cavazzana, San Martino di Ve-nezze, Borsea e Fratta. Tuttavia, sfogliando il dettagliato catalogo dei luo-ghi di culto del Polesine stilato verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso da Pia e Gino Braggion, non si rinviene alcuna notizia di chiese, o anche solo altari, dedicati a san Teobaldo in nessuna di queste parrocchie, pure direttamente sottoposte al monastero che vantava il possesso del corpo del santo, e che dunque ne era il principale santuario a reliquie, almeno per l’ambito italiano24. Unica, ovvia benché eminente eccezione è la parrocchia-le di San Giovanni di Badia Polesine, dove, nel 1810, il corpo stesso di san Teobaldo, fino ad allora deposto in un altare della basilica monastica della Vangadizza, fu traslato, e dove dunque il culto per il santo eremita proseguì, in molti casi, come avrò modo di illustrare, mantenendo le forme e i modi che lo avevano caratterizzato prima del trasferimento. Prima di quella data, tuttavia, nemmeno in questa chiesa è attestato alcun altare dedicato a Te-obaldo, né altre forme riconoscibili di una devozione nei suoi confronti25,
22. Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae - Histria - Dalmatia, a cura di P. Sella, G. Vale, Città del Vaticano 1941.
23. Ma non giurisdizionale: come noto, il monastero era autonomo dal vescovo locale, e anzi era insignito, sin dal 1123, del privilegio di dioecesis nullius, ossia costituiva, con tutti i suoi posse-dimenti, una sorta di diocesi a sé, in cui l’abate svolgeva le funzioni normalmente di competenza episcopale. Vedovato, L’Abbazia, pp. 354-356.
24. Gli oratori della diocesi di Adria, a cura di P. Braggion, G. Braggion, Conselve (PD) 1985-1986, 3 voll.
25. Ibid., III, pp. 7-11.
96
Francesco Veronese
che pure senz’altro doveva sussistere, stante la vicinanza, anche geografica, al suo santuario a reliquie.
Tali esempi, me ne rendo conto, sono ben lontani dall’essere esaustivi. Occorrerebbe infatti condurre indagini più accurate sulla diocesi adriese, ma anche su tutte quelle chiese, pertinenti a questo come ad altri episcopi, che, per vari motivi, potevano sottrarsi alla rendicontazione decimale, e che quindi non figuravano nei registri impiegati per la compilazione dei volumi delle Rationes decimarum. Bisognerebbe poi condurre ricerche più minuziose su tutte le chiese e parrocchie della diocesi vangadiciense, e sulla possibile presenza in esse anche solo di singoli altari dedicati a Teobaldo, senza con-tare che, anche qualora non se ne trovassero, ciò non escluderebbe a priori la possibilità che il santo fosse ugualmente celebrato nelle liturgie locali. Il lavoro da svolgere, insomma, è ancora molto.
Resta il fatto che, al momento, Sajanega, Vicenza e la Vangadizza appa-iono gli unici centri noti e sicuri del culto di Teobaldo in terra veneta. Sol-tanto due sono le eccezioni a questo quadro in verità piuttosto desolante. La prima, e apparentemente più antica, proviene da una notizia riportata nelle Fronde sparte del Senesi. Al 1132 egli colloca la deposizione di una reliquia del santo nella chiesa veronese della Santissima Trinità, senza specificare il motivo o l’occasione precisi26. Occorrerebbe indagare meglio l’esistenza di eventuali rapporti tra la Vangadizza e questa chiesa di Verona, città nella quale il monastero vantava il possesso, sin dal 1073, della cappella di San Salvatore in corte regia, donatagli da Guelfo, duca di Baviera27. Per il mo-mento, mi limito a semplicemente segnalare questa ulteriore pista.
Una seconda eccezione sembra costituita dalla parrocchia di Santa Ma-ria di Bosco di Rubano, nel Padovano28. In questa località la Vangadizza mantenne, per tutto il basso medioevo e l’epoca moderna, importanti pos-sedimenti fondiari, ottenuti a seguito di una nota permuta effettuata con il comune di Padova nel 1298. L’atto, che presenta sotto forma di scambio una vera e propria sottomissione de facto dell’abbazia alle autorità cittadine padovane, in quel periodo molto attive nell’estensione del proprio dominio in area polesana, dispone il passaggio di beni vangadiciensi siti a Castel-
26. Senesi, Fronde sparte, p. 170.27. Vedovato, L’Abbazia, pp. 351-352.28. Ringrazio il prof. Franco Benucci per questa segnalazione.
97
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
baldo al comune padovano, che in cambio ne cede al cenobio altri, pro-babilmente di recente o imminente messa a coltura, appunto a Bosco di Rubano29. L’area entrava così nell’ambito delle proprietà del monastero, e quindi, si può pensare, anche nella sua sfera di influenza spirituale e devo-zionale, divenendo, almeno in potenza, oggetto di estensione di culti propri alla Vangadizza, come del resto sembra attestare la stessa intitolazione della parrocchiale, Santa Maria, che ricalca quella del cenobio. E, in effetti, la parrocchia di Bosco di Rubano risulta attualmente cointitolata proprio a San Teobaldo di Provins, un culto che, a prima vista, sembra lasciare pochi dubbi, dati i rapporti con il monastero polesano, sulle modalità del suo ra-dicamento, e soprattutto sulla sua provenienza. Eppure, risalendo nel tem-po, tale intitolazione, così come qualunque altra traccia di una devozione per l’eremita transalpino a Bosco di Rubano, non sembra menzionata prima degli inizi del XIX secolo, in un momento, cioè, in cui la Vangadizza non solo aveva perso la sua capacità di controllo su questi terreni, ma aveva an-che cessato, a seguito delle soppressioni napoleoniche, la propria esistenza. Questo è quanto emerge, ad esempio, dalla lettura delle visite pastorali alla parrocchia di Bosco compiute da due vescovi padovani del XVII secolo, le uniche effettuate da presuli patavini, poiché anche quel luogo, come tutti quelli sottoposti alla Vangadizza, rientrava nei diritti di nullius dioecesis del monastero; era dunque compito dell’abate effettuarvi le visite pastorali, e non a caso in entrambe le occasioni si levarono le proteste della comunità monastica nei confronti degli interventi dei vescovi di Padova, considerati (ed effettivamente rubricabili) come degli abusi. Le visite furono condotte dai vescovi Marco Corner nel 1602 e Gregorio Barbarigo, in seguito assurto agli onori degli altari, nel 167030. Nei rispettivi verbali, la parrocchiale di
29. Su questo documento e il contesto storico, politico e sociale da cui trasse origine vedi La permuta tra l’abbazia della Vangadizza e il comune di Padova del 1298. Testo, storia e storiografia di un documento ritrovato, Padova 2006, 2 voll.; in particolare, sui rapporti tra Padova e la Vangadizza a quell’epoca, il contributo di A. Rigon, Il comune di Padova e l’abbazia della Vangadizza alla fine del Duecento, ivi, II, pp. 7-15 (saggio già edito nel 2002), e, sugli effetti pratici del documento nella parcellizzazione delle terre di Bosco, quello di B. Bettio, Bosco di Rubano e la permutatio del 1298, ivi, II, pp. 17-36 (saggio già edito nel 2004).
30. Vedi, tra la vasta bibliografia dedicata a Gregorio Barbarigo, C. Bellinati, Gregorio Barbarigo: un vescovo eroico, Padova 20092 e Gregorio Barbarigo, patrizio veneto, vescovo e cardinale nella tarda Controriforma (1625-1697), a cura di L. Billanovich, P. Gios, Padova 1999 (Atti del conve-
98
Francesco Veronese
Bosco di Rubano appare sempre intitolata alla sola Vergine Maria; nel 1602 è registrata poi la presenza di altri altari, uno o forse due, dei quali non si indica il titolo, mentre nel 1670 gli altari segnalati sono tre (compreso quello maggiore), ma nessuno di essi è dedicato a Teobaldo31. Nessun’altra infor-mazione compare, in questi documenti, a proposito di un possibile culto per questo santo. E, che non si trattasse di una precisa strategia dei vescovi di Padova volta a sminuire eventuali legami cultuali tra la chiesa di Bosco e la Vangadizza, è dimostrato dalla lettera con cui l’abate commendatario del cenobio Pietro Ottoboni, futuro papa Alessandro VIII, denunciò l’irrego-larità della visita – lettera trascritta subito dopo il verbale –, dove la par-rocchiale di Bosco è indicata con il solo, e solito, titolo di Santa Maria32. La storia di questa chiesa è, come spesso accade, lacunosa, e inizia a farsi meglio documentata, e quindi ricostruibile, proprio in età moderna, come dimo-stra anche una recente rassegna biografica dei sacerdoti succedutisi alla sua guida nel corso del tempo33; proprio da questa rassegna, però, non sembra emergere alcuna attestazione di un culto per san Teobaldo a Bosco prima del XIX secolo. Nemmeno l’iscrizione lapidea che ne ricorda la fondazione nel 1394 – dunque a circa un secolo di distanza dalla permutatio del 1298 –, documento altrimenti prezioso e ancora visibile in quanto incastonato in una delle pareti interne della chiesa, parla in alcun modo del santo eremita, né di una sua devozione nel nuovo edificio di culto34. Allo stato attuale delle conoscenze, e pur tenendo presente la possibilità di ulteriori approfondi-menti attraverso lo studio delle visite pastorali compiute dagli abati della Vangadizza e uno spoglio sistematico dell’archivio parrocchiale di Bosco, non si può dunque che concordare con Ireneo Daniele e Claudio Bellina-ti, che pongono proprio agli inizi del XIX secolo l’attribuzione alla chiesa
gno di studi, Padova, 7-10 novembre 1996). Ben più limitato il panorama degli studi sul vescovo Marco Corner, di cui manca perfino la notizia nel DBI; vedi comunque, anche per indicazioni biografiche sul personaggio, A. Lovato, La musica sacra nell’attività pastorale del vescovo di Padova Marco Corner (1557-1625), «Studia Patavina», 34 (1987), pp. 29-50.
31. Vedi rispettivamente Archivio della Curia vescovile di Padova, Visitationes, vol. 16, ff. 118r-119r (19 ottobre 1602) e vol. 40, ff. 99r-105r (17 novembre 1670).
32. Ibid., vol. 40, f. 105r.33. Mi pare che facci bene l’offitio suo. I preti di Bosco di Rubano nella storia, Rubano 2004.34. Il testo dell’epigrafe è riportato in Bettio, Bosco di Rubano, nota 25 a p. 29.
99
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
locale del titolo di San Teobaldo35. Se così stessero le cose, si tratterebbe di una devozione dal radicamento piuttosto recente, o che perlomeno si rende storicamente identificabile solo in una fase a noi tutto sommato prossima. Essa si sarebbe anzi radicata in un momento immediatamente successivo alla soppressione del monastero della Vangadizza, fulcro fondamentale, come si vedrà, del culto del santo in terra veneta, in quanto depositario del suo corpo; quasi come se la chiesa di Bosco intendesse raccoglierne una sorta di eredità.
Pur inserendovi queste due eccezioni, delle quali una deve essere ancora ben indagata e l’altra appare come un fatto cultuale relativamente recente, la mappa dei luoghi veneti del culto di Teobaldo non risulta particolarmente densa, né si discosta di molto da quella tracciata dai testi agiografici; senza contare che proprio i luoghi costituenti tale mappa, e in particolare San-ta Maria della Vangadizza, appaiono, o sono presentati dalle fonti, come i perni di irradiazione del culto di Teobaldo e del suo radicamento tanto a Verona, quanto a Bosco di Rubano. Di primaria importanza per almeno abbozzare un tentativo di comprensione e inquadramento di tale culto è l’analisi delle sue vicende e forme in questi luoghi, cui ora rivolgo la mia attenzione, procedendo in senso ‘agiografico’.
Come detto, il primo luogo veneto che si incontra nel corpus su Teobaldo è l’eremo di Sajanega, una chiesetta forse in origine intitolata ai Santi Er-magora e Fortunato36; una tradizione locale, fortemente influenzata però dalle strategie camaldolesi cui ho accennato, la vuole fondata niente meno che da Romualdo in persona, durante un suo passaggio nel Vicentino, il quale vi avrebbe subito installato una comunità camaldolese, poi estinta-si prima dell’arrivo di Teobaldo37. Il legame con la vicenda biografica del
35. La diocesi di Padova nel 1972, a cura di I. Daniele, C. Bellinati, Padova 1973, p. 119.36. È quanto affermano le Vitae (sia BHL 8031 sia BHL 8032) di Teobaldo, secondo cui il
santo avrebbe ricevuto in sogno la visita dei santi Ermagora e Fortunato, martiri e patroni della Chiesa di Aquileia, «in quorum honore oratorium cellulae eius [Theobaldi] habebatur conse-cratum»: Vita Theobaldi, p. 326.
37. Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo, p. 46, che accetta questa tradizione sulla scia della Storia ecclesiastica vicentina del Barbarano. Anche G. Mantese, Memorie storiche della Chiesa vicentina, II, Dal Mille al Milletrecento, Vicenza 1954, pp. 137-140 sembra accogliere l’ipotesi di un passaggio di Romualdo a Sajanega e di una sua fondazione dell’eremo, che sarebbe però stato intitolato ai santi Ermagora e Fortunato, a suo parere, solo dallo stesso Teobaldo.
100
Francesco Veronese
santo avrebbe fatto sì che proprio a quest’ultimo, in seguito, essa venisse intitolata. Non è però semplice seguire le vicende di questa chiesa, né del culto di Teobaldo, tanto in Sajanega, quanto a Sossano, nel cui territorio plebanale essa era inserita. Di nuovo le Rationes decimarum situano a Sajanega solo un hospitalis, del quale non si riporta il titolo38 ma che Mantese indicò come ospedale templare dedicato a San Giovanni Battista e attestato in un documento del 127339; dunque non identificabile, sembrerebbe di capire, con la cappella fruita da, e poi intitolata a, san Teobaldo40. Le visite pasto-rali dei presuli vicentini a Sossano, che ho consultato solo per campioni, si rivelano anch’esse poco loquaci. La più antica conservatasi all’Archivio Storico Diocesano di Vicenza, quella di Pietro Barbo41 del 16 agosto 1452, riporta la risposta di Angelo Pasquale, sacerdote della parrocchiale di San Michele di Sossano, a proposito dell’esistenza di ecclesiae campestres nel ter-ritorio della sua parrocchia, elencandone inizialmente due, poi depennate, forse a negarne l’esistenza o l’importanza; nessuna delle due (San Floriano e Santa Maria), però, pare identificabile nella chiesa di San Teobaldo42. La visita del vescovo e cardinale Antonio Marino Priuli43, del 5 settembre 1747 – il salto cronologico è, me ne rendo conto, importante –, risulta più det-tagliata e ricca di notizie; ancora una volta, però, al negativo, utili cioè per notare un’assenza, più che una presenza44. Così, l’elenco degli altari della parrocchiale di Sossano porta a escludere che a quell’epoca ve ne fosse uno
38. Rationes decimarum, nr. 2900, p. 253.39. G. Mantese, Memorie storiche della Chiesa vicentina, III/1, Il Trecento, Vicenza 1958, pp.
329-330.40. Ma su questo si discute: S. Lavarda, I Loschi e Sossano. Nobili e contadini in un villaggio vi-
centino (secoli XVI-XVIII), Sossano 2009, p. 38 è invece propenso a identificare l’eremo dei Santi Ermagora e Fortunato (cui egli non sembra attribuire alcun cambiamento di titolazione) nell’o-spedale templare documentato nella seconda metà del XIII secolo, e a distinguerlo da un’altra chiesa di San Teobaldo, «non officiata e posta in prossimità di alcune risaie».
41. Per quanto riguarda il periodo di episcopato vicentino del cardinale Pietro Barbo, poi divenuto papa con il nome di Paolo II, vedi G. Mantese, Memorie storiche della Chiesa vicentina, III/2, Dal 1404 al 1563, Vicenza 1964, pp. 139-146.
42. Archivio Storico Diocesano di Vicenza (= ASDVi), Visite pastorali, Card. Pietro Barbo, b. 1/0533, ff. 20v-21r (16 agosto 1452).
43. Su di lui vedi G. Mantese, Memorie storiche della Chiesa vicentina, V/1, Dal 1700 al 1866, Vicenza 1982, pp. 153-161.
44. ASDVi, Visite pastorali, Card. Antonio Marino Priuli, b. 15/0567, ff. 104r-106v (5 settembre 1747).
101
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
dedicato a Teobaldo. Lo stesso vale per le altre chiese, dipendenti dalla par-rocchiale, visitate dal Priuli: non solo nessuna è intitolata al santo eremita, ma nemmeno al loro interno compaiono altari in suo onore. Unico, tenue appiglio, è la visita della chiesa di Sant’Ubaldo, che il Mistrorigo, ma nel 1950, dice dedicata anche a Teobaldo45. La mancata menzione di tale titolo nella visita del 1747 può allora assumere due significati: o il secondo titolo, teobaldino, non era stato ancora conferito, a quest’altezza cronologica, alla chiesa di Sant’Ubaldo; oppure, peggio ancora, non si era ritenuto neces-sario indicarlo. Ancora una volta, però, questa chiesa non sembra identi-ficabile con l’oratorio di San Teobaldo, che sempre Mistrorigo, e sempre relativamente al 1950, ricorda come un edificio distinto. Si arriva, così, alla contemporaneità, praticamente all’altro ieri. Nel 1946 fu inaugurata e con-sacrata la nuova facciata della chiesa parrocchiale di Sossano, San Michele. In quell’occasione fu stilato un opuscolo sulla storia di Sossano e della sua Chiesa, redatto da un giovane Mistrorigo, da poco subentrato come parro-co46. Certo, l’opera aveva carattere del tutto divulgativo e devozionale; né Teobaldo e il suo culto erano al centro dell’attenzione dell’autore. Tuttavia, è a mio parere interessante notare come, nella parte sulla biografia del santo e poi sulla chiesa di Sajanega a lui dedicata, egli si rifaccia in maniera esclu-siva alle tradizioni locali, faticando non poco a reperire notizie, per quanto ridotte a un trafiletto, sull’oratorio di Teobaldo47. Si conferma tuttavia il culto patronale del santo, invocato in particolare in caso di febbri: il rife-rimento è ai miracoli raccontati nei suoi testi agiografici; una statua a lui dedicata figura tra quelle che ornano la nuova facciata, mentre nella cappella di San Teobaldo si officia il culto una o due volte l’anno, in occasione, si può credere, delle principali feste, a inizio luglio48.
Il quadro sul culto di Teobaldo a Sossano è insomma enormemente lacu-noso e oscuro. Le ripetute mancate attestazioni dell’oratorio a lui dedicato in epoca tanto medievale quanto moderna lasciano aperte tutte le questioni relative al suo status, alla sua continuità di utilizzo (e da parte di chi), al suo ruolo come centro di culto di Teobaldo; senza contare l’assoluto silenzio
45. Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo, p. 47.46. A. Mistrorigo, Sossano. La sua storia, la sua chiesa, Sossano 1946.47. Ibid., rispettivamente pp. 19 (vita di Teobaldo) e 26 (chiesa di San Teobaldo di Sajanega).48. Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo, p. 107.
102
Francesco Veronese
sulle forme stesse di tale culto. Se la Vita del santo si pone come una sorta di mito di fondazione della sua cappella in Sajanega, e la situazione presso-ché attuale così come descritta da Mistrorigo nel 1946 (e di nuovo nel 1950) appare come un punto di arrivo, ciò che sta in mezzo, un lungo mezzo, al momento sfugge quasi del tutto. Sossano sembra mostrarsi luogo di culto di Teobaldo all’indomani della sua morte, e del primitivo investimento sul santo stesso, e nella contemporaneità; ben più difficile è seguirne l’evoluzio-ne in quanto tale, e anche esser certi che esso abbia sempre mantenuto un qualche ruolo nella pur esile mappa tracciata sulla base dei testi agiografici.
Qualcosa di simile è riscontrabile anche per quel che riguarda il secondo luogo della mappa dei luoghi di culto veneti disegnata dalle agiografie, e, stando ad esse, primo luogo di sepoltura del santo, ossia Vicenza, e in parti-colare la sua cattedrale. Siamo infatti piuttosto ben informati appunto sulle origini e i primi tempi del culto vicentino di Teobaldo, legato alla presenza fisica del suo corpo in città. La traslazione del corpo in cattedrale avrebbe anzi potuto fornire, come proposto da Fiaccadori una decina di anni fa, spunto e occasione per ricavare nel complesso altomedievale una cripta, de-stinata a ospitare le reliquie, di cui si hanno riscontri di tipo archeologico; anche pensando, tuttavia, che un simile impianto preesistesse alla traslazio-ne, la testimonianza della Translatio di Teobaldo alla Vangadizza sulla col-locazione del suo corpo in cattedrale è stata comunque letta come preziosa e attendibile attestazione dell’esistenza di tale cripta49. Grazie agli studi di Giorgio Cracco, inoltre, sembra chiaro anche l’orizzonte politico-ecclesia-stico dell’investimento vicentino sull’eremita morto a Sajanega50. Il vescovo locale Liudigerio, transalpino di origine e creatura imperiale, oltreché colui che avrebbe ordinato Teobaldo sacerdote, avrebbe cercato di appropriarsi della sua figura – e, dopo la sua morte, anche del suo corpo – nell’ottica di un’adesione alla politica religiosa dell’Impero di fronte alle istanze rifor-matrici, allora in via di definizione, che la Chiesa di Roma andava metten-do in atto: l’epoca è infatti quella della riforma ecclesiastica dell’XI secolo,
49. G. Fiaccadori, Dalle origini alla prima età gotica, in La cattedrale di Vicenza, a cura di G. Barbieri, Vicenza 2002, pp. 35-37.
50. G. Cracco, Religione, Chiesa, pietà, in Id., Tra Venezia e Terraferma. Per la storia del Veneto regione del mondo, Roma, 2009, pp. 489-494 (saggio già edito nel 1988), e Id., Santità straniera in terra veneta, pp. 462-465.
103
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
o, almeno, della sua prima fase, di restauro e riorganizzazione all’interno della Chiesa stessa, una fase precedente a quella di più aperto scontro con l’Impero per la questione delle investiture51. Il papa rispose di lì a poco con l’ancor giovane e non del tutto cristallizzato strumento della canonizzazio-ne: la lettera di Alessandro II con cui Teobaldo fu elevato agli onori degli altari, non datata ma collocabile tra il 1066 e il 107352, suona infatti come un tentativo di legare in qualche modo la figura dell’eremita, tramite un rico-noscimento ufficiale della sua santità, all’autorità papale. Ma, soprattutto, conferma l’esistenza di un suo culto in Vicenza, poiché la richiesta di san-tificazione di Teobaldo sarebbe giunta proprio dal popolo vicentino53; da notare, invece, il silenzio sull’autorità vescovile.
Dopo questi esordi, ricchi di legami e ricadute sul macrocontesto politi-co-ecclesiastico di quell’epoca, sul culto di Teobaldo a Vicenza siamo, tut-tavia, ben poco informati. Anche qui, a dire il vero, le mie indagini si sono mosse per campioni, e seguendo solo alcune delle possibili piste di ricerca. Da uno spoglio di alcuni dei più antichi calendari/martirologi conservati a oggi nella Biblioteca Civica Bertoliana e prodotti a Vicenza o negli imme-diati dintorni, tutti in verità non più antichi del XV secolo, non mi è stato possibile rinvenire alcuna menzione di san Teobaldo, in nessuno dei giorni a lui comunemente dedicati: né al 30 giugno o primo luglio, date cui, a se-conda dei luoghi o delle tradizioni agiografiche seguite, si suole porre la sua morte, né al 4 luglio, la data tradizionale della sua traslazione in cattedrale. Si tratta, è vero, di calendari appartenuti e/o prodotti perlopiù nell’ambi-to degli ordini mendicanti, e utilizzati nelle loro sedi vicentine; essi sono
51. La bibliografia sulla riforma della Chiesa nell’XI secolo è naturalmente sterminata. Mi limito a rinviare al classico studio di G. Miccoli, Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI, Firenze 1966 (una sua riedizione aggiornata è stata curata dallo stesso Miccoli e da Andrea Tilatti nel 1999). Vedi inoltre La reforma gregoriana y su proyección en la cristianidad occidental. Siglos XI-XII, a cura di J. I Saranyana, Pamplona 2006 (Atti della trentaduesima settimana di studi medievali, Estella, 18-22 luglio 2005); la recente sintesi di S. Gouguenheim, La réforme grégor-ienne, Paris 2010; e da ultimo M. Stroll, Popes and Antipopes: The Politics of Eleventh Century Church Reform, Leiden-Boston 2012.
52. Su questo aspetto vedi il contributo di Nicolangelo D’Acunto in questo volume.53. «Suggerentibus nobis de eo Mainardo et Damiano episcopis, et Vincentiae populo, illum
[Theobaldum] celebri memoria dignum Romana decrevit Ecclesia»: Acta sanctorum, Iunii, V, p. 596. Gli episcopi Mainardus e Damianus sono generalmente identificati nei cardinali Mainardo di Silva Candida e Pier Damiani.
104
Francesco Veronese
dunque particolarmente attenti a ricalcare i santorali propri a ciascun ordi-ne54. Ma anche quelli il cui santorale appare maggiormente caratterizzato in senso veneto, e financo vicentino, come il calendario ms 345 della Biblio-teca Civica Bertoliana di Vicenza (di probabile uso agostiniano/eremitano), tacciono del tutto su Teobaldo55. Gli ordini mendicanti vicentini del XV secolo non sembrano insomma aver accolto il culto di questo santo. Le pos-sibili spiegazioni sono molteplici, e ognuna richiederebbe approfondimenti in merito ai meccanismi religiosi e sociali e ai rapporti di forza all’interno del panorama ecclesiastico vicentino dell’epoca. Da un lato si può pensare che, nell’esclusione di Teobaldo, si esprimessero eventuali istanze di oppo-sizione o non perfetta collaborazione tra questi stessi ordini e l’ambiente vescovile, che fin da un momento immediatamente posteriore alla morte del santo aveva cercato, come si è visto, di appropriarsi del suo culto; ma la presenza dei santi Leonzio e Carpoforo, patroni storici della cattedrale e dell’episcopio di Vicenza, nel santorale del già nominato ms 345 della Ber-toliana parrebbe negare questa ipotesi. Dall’altro lato, può semplicemente darsi che il culto non avesse avuto la forza di diffondersi al di fuori della cattedrale e di imporsi nei nuovi ordini, o, ancora, che esso avesse assunto un valore identitario di primo piano nella liturgia e nella rappresentazione
54. Ho in particolare consultato i seguenti manoscritti conservati in Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza: ms 28, breviario della prima metà del XV secolo di uso domenicano; ms 73, salterio del terzo quarto del XV secolo, proveniente dal convento domenicano vicen-tino di Santa Corona (su questo ms vedi F. Toniolo, Per il catalogo di Girolamo da Cremona: un salterio del convento domenicano di Santa Corona di Vicenza oggi alla Biblioteca Bertoliana, in Sine mu-sica nulla disciplina… Studi in onore di Giulio Cattin, a cura di F. Bernabei, A. Lovato, Padova 2006, pp. 403-408); ms 74, breviario del terzo quarto del XV secolo, di probabile provenienza agostiniana; ms 345 (vedi nota successiva); ms 355, composito, la cui prima parte è costituita da un martirologio e un messale monastici della fine del XV secolo; ms 364, messale romano del primo quarto del XV secolo; ms 591, anch’esso un messale romano forse appartenuto (ma non per forza prodotto) alla pieve di Barbarano Vicentino e datato agli anni Venti del XV secolo. Per una descrizione e un commento storico-artistico di questi manoscritti vedi G. Mariani Canova, Alcuni manoscritti liturgici miniati vicentini e veneti del Quattrocento alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, in Sine musica, pp. 391-401; I manoscritti medievali di Vicenza e provincia, a cura di N. Giovè Marchioli, L. Granata, M. Pantarotto, Firenze 2007.
55. Si tratta di un messale romano dell’ultimo quarto del XV secolo, prodotto per la no-bile famiglia vicentina dei Godi, da utilizzare in una cappella di loro proprietà dedicata a Sant’Agostino in San Michele degli Eremitani di Vicenza: Mariani Canova, Alcuni manoscritti, pp. 394-397.
105
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
del vescovo, tale da renderlo inadatto ad altre identità religiose (di tipo, in questo caso, mendicante), se non addirittura gelosamente difeso in quan-to, appunto, prerogativa episcopale. Purtroppo, per quanto riguarda questi possibili esiti del rapporto tra il culto di Teobaldo e l’identità episcopale vicentina, non mi è stato possibile effettuare riscontri sul materiale liturgico medievale prodotto o utilizzato nella cattedrale vicentina e giunto sino a noi; da pochi mesi trasferiti dalla biblioteca del Seminario Vescovile di Vi-cenza all’Archivio Storico Diocesano della stessa città, i diversi volumi, tra cui invitatoriali, graduali, bibbie, antifonari e sequenziari, datati da inizio XIII al XV secolo, non sono al momento consultabili, poiché sottoposti a catalogazione per il progetto Ecclesiae Venetae56. Dalle loro attestazioni litur-giche si può però ragionevolmente ipotizzare, in un futuro che si auspica prossimo, di rinvenire testimonianze sul culto di Teobaldo in cattedrale, utili a spezzare l’assordante silenzio che lo circonda fino, almeno, alla piena epoca moderna.
È infatti ancora una volta Senesi, che scrisse negli anni Venti-Trenta del XVII secolo, a descrivere, seppur en passant, le forme del culto di Teobaldo nel duomo vicentino. Il 4 luglio, ricorrenza della traslazione, si pronunciava in onore del santo, e presso l’altare a lui dedicato in cattedrale, un ufficio doppio57; sempre da Senesi ricaviamo poi la descrizione di un dipinto del XV secolo, posto nella cappella di Santa Margherita, in cui il santo era raf-figurato con in mano il pane che egli inviò, secondo la Vita, ai genitori in cambio di un salterio58. Il 4 luglio è ricordato come giorno di festa solenne di san Teobaldo nella cattedrale di Vicenza ancora da Mistrorigo59, e del resto un suo dipinto è tuttora visibile in una delle cappelle laterali della basilica.
Anche per Vicenza, dunque, a essere meglio note, documentate e studia-te sono le fasi iniziale e moderna, financo attuale, del culto di Teobaldo. Nel mezzo, a parte le notizie di Senesi, il quadro è ancora tutto da costruire, a partire, però, da una serie di buchi nell’acqua e di silenzi. Nemmeno qui è
56. Per un primo sguardo d’insieme su questi manoscritti vedi I manoscritti medievali, pp. 117-126.
57. Senesi, Fronde sparte, p. 170.58. Ibid., p. 150.59. Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo, p. 103.
106
Francesco Veronese
insomma possibile pronunciarsi, al momento, né sulle fasi intermedie che esso attraversò, né su una sua eventuale continuità nel tempo.
Il discorso si fa diverso, e un po’ meno scoraggiante, quando ci si rivolge al culto teobaldino alla Vangadizza e a Badia, centro polesano di tale devo-zione sin da quando, nel 1810, a seguito della soppressione del monastero, le reliquie furono traslate nell’arcipretale di San Giovanni Battista, dove tut-tora si trovano. Sono soprattutto gli eruditi seicenteschi che si occuparono della storia dell’abbazia, come il nominato Senesi ma anche il Bronziero, a fornire delle ricostruzioni sulle vicende attraversate dal culto e dalla memo-ria di Teobaldo e delle sue reliquie alla Vangadizza. Delle ricostruzioni volte di norma a esaltare il rapporto tra il santo e i camaldolesi, enfatizzandone, e forse addirittura costruendone ex nihilo, un’appartenenza all’ordine sin dalla sua ordinazione monastica da parte dell’abate Pietro60, laddove la Vita origi-naria non specifica né di quale monastero quest’ultimo fosse abate, né quale regola egli seguisse61. Inoltre, anche accettando la sua identificazione con un abate della Vangadizza, dalla storia del cenobio sappiamo che lo stile di vita camaldolese subentrò a quello benedettino solo all’inizio del XIII secolo, per ordine di papa Innocenzo III62: Teobaldo avrebbe dunque fatto parte di una comunità non camaldolese, bensì benedettina, e come tale sarebbe stato consacrato.
Al risalto della gloria di Teobaldo e, per suo tramite, dell’ordine tutto, si affianca ovviamente quello della storia e del prestigio dell’abbazia polesana, depositaria di quel tesoro che sono le sue reliquie; su di esse sia Senesi, sia
60. L’affermazione dell’appartenenza di Teobaldo all’ordine camaldolese si trova già in Senesi, Fronde sparte, p. 140, che probabilmente la dà per scontata in quanto l’eremita sarebbe stato consacrato monaco da Pietro, abate di una Vangadizza già facente parte, a suo parere, della congregazione fondata da Romualdo. L’identità camaldolese di Teobaldo fu di lì a poco riaf-fermata da G. B. Mittarelli e A. Costadoni nel secondo volume dei loro Annales Camaldulenses, dove furono inseriti ampi stralci da una delle Vitae del santo. Anche G. Bronziero, autore nella prima metà del XVII secolo di una Istoria delle origini e condizioni de’ luoghi principali del Polesine di Rovigo, apparsa però a stampa solo nel 1748, accetta l’appartenenza di Teobaldo all’ordine camal-dolese, e così, sulla scia di una ormai lunga tradizione, Collina, nel XVIII secolo. Nemmeno Mistrorigo, Vita di san Teobaldo, la pone in discussione.
61. La Vita BHL 8031 descrive infatti Pietro semplicemente come «Petro abbate, prae omni-bus sibi [Theobaldo] in amicitia iuncto, qui ei eodem anno monachicum schemma sacraverat» (Vita Theobaldi, p. 331).
62. Vedi supra nota 20.
107
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
Bronziero si concentrano particolarmente, delineando i momenti salienti della loro permanenza nel monastero. Il Bronziero riporta alcune parti di un documento del 1097 in cui si attesta la presenza, alla Vangadizza, dei corpi di Primo e Feliciano, martiri e patroni di lungo corso dell’abbazia, e dello stesso Teobaldo63; trascrive poi un’epigrafe datata al 1226, in cui si ricordava il ritrovamento (o forse la ricognizione) dei corpi dei tre santi, voluta dall’abate Orlando64. Nel mezzo si inserisce la citata notizia del Se-nesi sulla deposizione di una reliquia di Teobaldo in Santissima Trinità di Verona, cui fa seguito una polemica con Vicenza, dove, a suo dire, nessuna reliquia del santo sarebbe conservata; ciononostante, egli conferma la cele-brazione della festa del santo il 4 luglio, accompagnata, secondo altre fonti, proprio dall’esposizione di una reliquia teobaldina65. I due autori concorda-no nel collocare nel 1411 una nuova ricognizione dei resti di Teobaldo, e so-prattutto la loro traslazione nell’altare rinnovato su committenza dell’abate Antonio Del Ferro66. In quell’occasione, il corpo fu portato in processione attraverso la «terra di Badia»; a conclusione e suggello della ricognizione, fu inoltre inserita, nell’urna contenente le reliquie, una lamina di piombo re-cante l’incisione «Hic est corpus beati Theobaldi confessoris»67. A conferma dell’ormai consolidato ruolo di Teobaldo come protettore e patrono della regione a quest’epoca, la riforma degli statuti municipali di Badia attuata da Niccolò d’Este nel 1441 faceva divieto agli uomini del marchese di Ferrara, nonché conte del Polesine, di recarsi nelle terre dell’abbazia per esercitarvi la giustizia nei giorni delle principali feste vangadiciensi, ossia quella di san Teobaldo e quella dei santi Primo e Feliciano68.
Nel 1515 – la fonte è sempre Senesi – i monaci di San Martino di Oderzo, camaldolesi dipendenti da San Michele di Murano, commissionarono una serie di dipinti sui grandi santi dell’ordine, tra cui trovò posto Teobaldo;
63. Bronziero, Istoria delle origini, p. 166.64. Ibid.65. Senesi, Fronde sparte, p. 170. A parlare dell’esposizione di una reliquia di Teobaldo il gior-
no della sua festa vicentina è invece Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo, p. 170.66. Bronziero, Istoria delle origini, p. 167; Senesi, Fronde sparte, pp. 198-199, che riporta lo
strumento di ricognizione.67. Ibid.68. Bronziero, Istoria delle origini, p. 166; Corrain, Zampini, S. Teobaldo, p. 101, che però
collocano erroneamente alla stessa data, 1441, la ricognizione del 1411.
108
Francesco Veronese
una sua immagine figurava poi, già da tempo, nella chiesa pievana di San Giovanni di Badia69. Nel frattempo, l’autore delle Fronde sparte aveva avu-to modo di inserire, nelle pagine precedenti, un interessante discorso sulla conformazione interna e sulla disposizione degli altari della basilica mona-stica vangadiciense, lette in base alle valenze del numero cinque e al nome di Maria, patrona principale dell’abbazia. Cinque sono infatti gli altari della chiesa, come cinque sono le lettere del nome della Vergine, ognuna delle quali è associata dal Senesi a un altare; ogni associazione è spiegata in base ai significati simbolici attribuiti tanto agli altari, e ai loro dedicatari, quanto alle lettere stesse. Alla prima lettera A è dunque accostato l’altare che ospita il corpo di san Teobaldo, perché questi è «albo di vesti e di purità»70. Abbia-mo così ulteriore conferma non solo del fatto che Teobaldo facesse ormai parte del santorale proprio del monastero, ma anche e soprattutto del ruolo assegnatogli nella concezione e nella definizione vangadiciensi dello spazio sacro.
Un nuovo, grande momento di rilancio del culto di Teobaldo e delle sue reliquie, l’ultimo di cui Bronziero e Senesi potessero renderci conto, si situa nel primo trentennio del XVII secolo. Tra il 1617 e il 1626, per interessamen-to particolare di Filippo Recanati e – stando a quanto egli ci racconta – dello stesso Bronziero, la cappella dedicata a San Teobaldo nel monastero polesa-no fu restaurata, e il suo altare nuovamente ampliato e abbellito; fu l’occa-sione per un’ulteriore ricognizione delle reliquie, che permise al Bronziero e al Senesi di vedere di persona la lamina di piombo deposta nell’urna nel 141171. A ulteriore conferma delle strategie di appropriazione di san Teobal-do da parte non solo della Vangadizza, ma più in generale dell’ordine camal-dolese, e di rilettura della sua identità monastica in tale senso, l’instrumentum della traslazione e ricognizione delle reliquie, redatto dal sacerdote Sante Pescante, canonico della cattedrale di Chioggia e notaio pubblico, su ordine dell’abate commendatario del monastero Agostino Priuli, indica anch’esso il santo come monaco camaldolese72.
69. Senesi, Fronde sparte, p. 242.70. Ibid., p. 224.71. Bronziero, Istoria delle origini, pp. 169-702; Senesi, Fronde sparte, pp. 298-304.72. Il documento è riportato integralmente in Senesi, Fronde sparte.
109
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
Nuove ispezioni delle reliquie avvennero poi nel 1706, e, più recente-mente, nel 1823 e 184473. Pressoché nel mezzo tra la prima e la seconda di queste date, si situa un’interessante notizia relativa al culto di san Teobaldo a Badia, e soprattutto al modo in cui, nella seconda metà del XVIII seco-lo, le autorità veneziane si rapportassero a questa come alle altre feste po-polari, legate perlopiù alla devozione per i santi, praticate nell’entroterra veneto. I verbali dell’inchiesta condotta a tal proposito tra il 1772 e il 1773 per ordine del Senato veneziano registrano la festa di san Teobaldo a Ba-dia, ricorrente il primo di luglio, sottolineando però che essa si tiene solo da una quindicina d’anni, e che sono in pochi a onorarla, soprattutto nel contado, a causa della sua corrispondenza con un momento di intenso im-pegno nel lavoro dei campi74. Bisogna, naturalmente, saper leggere critica-mente queste indicazioni. Scopo dell’inchiesta era infatti quello di stilare un censimento delle feste popolari, al fine di epurarne il maggior numero possibile, salvaguardando – dal punto di vista spirituale e morale – la salute dell’anima degli abitanti della terraferma veneta da eccessi devozionali che le autorità veneziane credevano sfociare troppo spesso nella superstizione, e – da un punto di vista più concretamente economico – la produttività dei lavoratori veneti, ritenuta troppo frammentata dalla pluralità dei giorni festivi75. Si può dunque ritenere che ogni elemento sfavorevole al perdurare di una festività fosse accuratamente segnalato e sottolineato, come sembra essere il caso della festa di Teobaldo, rappresentata come recente nella sua introduzione, e dunque priva di una lunga tradizione, tale da radicarla sul territorio; ma soprattutto come scarsamente seguita e d’intralcio al lavoro nei campi, in un momento dell’anno in cui esso è invece particolarmente importante e impegnativo.
73. Corrain, Zampini, S. Teobaldo, p. 102.74. «In Badia: primo luglio s. Teobaldo protettore della giurisdizione; ma tal festa da circa
15 anni solamente è stata introdotta, né viene da tutti del paese stesso di Badia osservata, e molto meno nelle ville soggette alla spirituale giurisdizione della medesima, forse per le mas-sime occupazioni della campagna». I risultati dell’inchiesta sono stati pubblicati in Il culto dei santi e le feste popolari nella Terraferma veneta. L’inchiesta del Senato veneziano (1772-1773), a cura di S. Marin,Vicenza 2007; il passo citato è a p. 197.
75. C. Povolo, Uno sguardo rivolto alla religiosità popolare: l’inchiesta promossa dal Senato veneziano sulle festività religiose (1772-1773), in Il culto dei santi, pp. XIX-LXIV.
110
Francesco Veronese
Non è invero possibile, mancando di ulteriori riscontri nelle fonti, veri-ficare l’effettivo grado di partecipazione popolare alla festa di san Teobaldo di inizio luglio nella seconda metà del XVIII secolo76. Dei riscontri sono in-vece disponibili e possibili per quel che riguarda la sua antichità, che appare ben maggiore di quanto non indichi l’inchiesta veneziana. Benché, infatti, in essa non si esplicitino le forme esteriori della ricorrenza, ossia le prati-che concrete messe in atto in onore di Teobaldo, si può ragionevolmente proporre, io credo, che i suoi autori abbiano assistito a una pratica cultuale in particolare, che altre fonti testimoniano già operante almeno dalla se-conda metà del XVI secolo, e che pare caratterizzata da una continuità che perdura tuttora. Si tratta della processione annuale che si tiene in Badia, a partire nei tempi antichi dall’abbazia e poi, dopo il 1810, dall’arcipretale, il primo di luglio, giorno della festa del santo, anche se in certi periodi essa fu celebrata la prima domenica di luglio o comunque attorno all’8, per evitare sovrapposizioni con l’ottava di san Giovanni Battista (patrono della Chiesa di Badia). Ancora il Senesi ce ne dà una descrizione relativa ai suoi tempi: la mano destra di Teobaldo, ritenuta particolarmente capace di compiere miracoli, era trasportata in un’urna decorata con l’immagine in argento del santo in abiti monastici77. Alla processione accorrevano tutti i sacerdoti di Badia e delle altre terre soggette al monastero, a conferma della centralità di Teobaldo nell’anno liturgico vangadiciense78. Sebbene Senesi non specifichi puntualmente il percorso della processione, un suo riferimento alla funzio-ne della celebrazione come protezione da eventi climatici avversi può far ipotizzare che non si discostasse molto da quello tuttora praticato, che pre-vede la benedizione del fiume al sostegno Bova, in cui dall’Adige si diparte l’Adigetto. Già, perché la processione viene tuttora annualmente officiata
76. Mistrorigo, Vita di s. Teobaldo, pp. 105-107, ricorda però un episodio miracoloso che si sarebbe verificato a seguito di una processione in onore di Teobaldo: le acque dell’Adige, in pro-cinto di esondare, si sarebbero invece arrestate per volere del santo. Benché l’autore specifichi che si trattasse non della processione annuale, bensì di un’iniziativa eccezionale legata allo stato di emergenza, sembra comunque di capire che, in un momento non distante da quello fotogra-fato dall’inchiesta, vi fosse una discreta affluenza di popolo a questo genere di riti, pur tenendo presente la gravità della situazione. L’episodio è tratto da B. Soffiantini, Vita di s. Teobaldo, p. 53.
77. Senesi, Fronde sparte, p. 244. Lo stesso Senesi, in quanto nativo di Badia, afferma di avervi partecipato più volte, in gioventù.
78. Ibid., p. 291.
111
IL CULTO DI SAN TEOBALDO IN TERRA VENETA
la prima domenica di luglio, che nel 2012 è coincisa proprio con il primo giorno del mese, e dunque con la festa stessa del santo; segno di un rapporto sempre vivo tra Badia e san Teobaldo.
Le notizie sul culto di Teobaldo alla Vangadizza appaiono dunque più numerose e continue di quanto si è visto per Vicenza e Sossano. Cionono-stante, molte lacune attendono ancora di essere riempite, soprattutto per il pieno medioevo; certo, la dispersione degli archivi, e soprattutto del mate-riale liturgico, della Vangadizza, pone più di un ostacolo a questa ricostru-zione, ma l’importante opera di recupero e risistemazione attuata dal Soda-lizio vangadiciense permette almeno di nutrire speranze di futuri sviluppi e ritrovamenti in questo senso.
Mi avvio a concludere. Mi rendo conto della totale non esaustività di questa ricognizione iniziale, poco più di uno zibaldone di notizie sparse e frammentarie. Penso tuttavia che una riflessione di fondo, sulla base di quanto visto, possa essere comunque condotta a proposito del culto di Teo-baldo in terra veneta. Esso è un culto che, con un gioco di parole, si potreb-be definire locale, localizzato ma non del tutto, e non facilmente, localiz-zabile. Locale, in quanto la sua diffusione appare circoscritta ai pochi centri esaminati, e al più a – non molti – luoghi che con questi avevano particolari legami (perlopiù di dipendenza). Localizzato, proprio perché sin dalla ste-sura dei primitivi testi agiografici è possibile tracciare una mappa indicativa dei suoi principali centri. E però non localizzabile, nel senso di non del tutto definibile e rintracciabile nelle sue concrete forme (specialmente liturgiche), aldilà della processione di Badia e di qualche altro indizio sempre rinvenibile nelle Fronde sparte del Senesi, e comunque sempre riferito alla Vangadizza79. Caratteristica generale della sua storia nei tre luoghi esaminati sembra poi il fatto che essa sia documentata, e quindi ricostruibile e interpretabile, in
79. Come detto, Senesi, al termine della sezione della sua opera dedicata alla vita di san Teobaldo (vedi sopra), annota alcuni inni recitati dalla comunità monastica nella liturgia della festa del santo. I testi traggono spunto dalle agiografie del santo, ed erano inseriti in un breviario che G. Cacciamani, Relazione di carte e documenti relativi all’abbazia di Santa Maria della Vangadizza, esistenti presso l’archivio del Sacro Eremo di Camaldoli, «Atti e memorie del Sodalizio vangadiciense», 1 (1972-1973), pp. 57-60, identifica in Biblioteca dell’Archicenobio di Camaldoli, S. Michele di Murano, ms 742, scritto di proprio pugno dallo stesso Senesi. L’inserimento, pur parziale, di una Vita di Teobaldo nel medesimo breviario conferma l’utilizzo liturgico del testo, suddiviso in lezioni: Senesi, Fronde sparte, p. 157.
112
Francesco Veronese
maniera soddisfacente nelle sue fasi iniziale e attuale, mentre tra questi due estremi si debbano constatare lunghi vuoti, al più intervallati da (non molte) attestazioni puntuali, quasi delle riemersioni di quello che appare come il fiume carsico della devozione per san Teobaldo in quest’area.
Il mio non vuole essere che un punto di partenza, e anzi uno sprone per approfondire le ricerche, lungo i non pochi sentieri aperti che ho cercato di suggerire e i molti di più che, a questo volo d’uccello, mi sono sfuggiti.