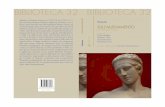Un'esperienza di consulenza filosofica interculturale
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Un'esperienza di consulenza filosofica interculturale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NAPOLI “FEDERICO
II”
MASTER INTERUNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
“CONSULENZA FILOSOFICA”
A.A. 2008-2009
CONSULENZA FILOSOFICA E INTERCULTURA
Candidati:Nicola Castaldo
Pia Pucci
1. L’identità e il riconoscimento nella prospettiva dell’intercultura : un
dibattito aperto
A partire dalla scoperta del cogito cartesiano, la
riflessione sull’identità e sulla soggettività è diventa
una chiave decisiva di comprensione del nostro tempo.
Il cogito apre la nostra modernità filosofica, ma
sappiamo che l’identità cartesiana, rigida e
monolitica, si definisce e si costruisce attraverso
l’esclusione dell’Altro, di ciò che non appartiene al
mondo della ragione. Inevitabile il riferimento
all’importante analisi che Michel Foucault dedicò alla
costruzione della follia, speculare a quella della
ragione cartesiana1. Nella sua Storia della follia, Foucault
scriveva che se c’è la possibilità di pensare una
ragione assoluta, come principio di verità e certezza, è
solo perché è stato compiuto un atto costitutivo
attraverso il quale si esclude ciò che realmente può
minacciare la fondatezza della ragione in modo radicale:
la follia, ciò che la ragione non è. La follia, ovvero
l’altro dalla ragione, può però fondare la mia
saggezza: se penso potrò sempre essere sicuro e al
riparo dalla minaccia dell’insensatezza, la mia identità
non è più costantemente minacciata da ciò che risulta
essere semplicemente “l’assenza d’opera", l’agire non
conforme ad un fine, la mancanza totale di progettualità
nell’esistenza.
Il mondo moderno ha voluto gestire l’Altro, tentando
quando possibile di assimilarlo a sè, o semplicemente di
ignorarlo, finchè tale rigidità escludente si è via via
sgretolata in seguito alle varie critiche interne allo
1 Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, BUR, Biblioteca Univ. Rizzoli, 1972, 1998.
stesso dibattito filosofico: a partire dalla critica
empirista al soggetto cartesiano, fino alla totale
decostruzione dell’identità elaborata da Nietzsche e
Freud, la modernità ha cominciato a fare i conti con
l’impossibilità, per l’uomo, di pensarsi come una realtà
monolitica e completamente trasparente a se stessa e
agli altri.
La questione dell’altro - dell’altro che è in noi e
fuori di noi- è da sempre parte integrante delle
riflessioni filosofiche sull’indentità; e lo è sempre di
più in quanto le società multiculturali sembrano
riflettere proprio tale questione, ponendoci di fronte
alla necessità di trovare delle modalità di
comunicazione con gli altri che salvaguardino identità,
differenze e riconoscimento dei diritti. Chiaramente
sembra essere proprio questo, oggi, uno dei nodi più
difficili da sciogliere : come integrare, realmente, il
problema del riconoscimento dei diritti dell’uomo con
quello della tutela delle differenze? E’ realmente
possibile parlare di diritti universali dell’uomo? Non è
certo questa la sede per affrontare una questione che ,
comunque, resta forse senza risposte definitive. Da
tempo, ormai, il problema del rapporto tra
riconoscimento e identità è al centro di molti
dibattiti. Rifacendoci alle efficaci riflessioni di
Taylor e Habermas2 , potremmo dire che la questione è
sostanzialmente questa: o si persegue una politica
dell’uguale riconoscimento, conferendo pari dignità a
ciò che universalmente è ritenuto “uguale”; oppure si
difende una politica della differenza che riconosca
l’identità unica di ciascuno. Tale politica,
chiaramente, richiede una differenziazione, dunque il
riconoscimento di qualcosa che non può essere condiviso
da tutti. In questo dibattito Habermas e Taylor prendono
una posizione abbastanza netta. Taylor difende la
posizione comunitarista secondo la quale il sistema dei
diritti è inevitabilmente cieco verso le differenze:
2 J. Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano 1998.
ogni Stato dovrebbe dunque anche promuovere una
determinata cultura e minoranza. Laddove è in gioco la
sopravvivenza di determinate comunità è necessario che
il liberalismo dei diritti sappia fare una passo
indietro e sottoporre il proprio sistema uniformizzante
a delle variazioni, scegliendo la sopravvivenza
culturale rispetto al trattamento uniforme. Secondo
Habermas, invece, una teoria dei diritti non è
necessariamente cieca verso le differenze culturali: non
quando alla base del sistema dei diritti ci sono le
reali volontà particolari della società. In fondo,
Habermas nota come una reale politica del riconoscimento
delle minoranze non debba far altro che riconoscere i
suoi membri come “individui” .
Non è possibile, forse, sciogliere questa questione così
problematica dal punto di vista filosofico, ma
sicuramente ciò che può essere condiviso è la
possibilità, e la necessità di pensare realmente all’
identità come ad un progetto, ad un divenire includente
l’altro.
La costruzione di un’identità, infatti, è un processo
che comporta sempre delle scelte: cosa includere o
escludere dai confini della nostra “costruzione” è un
fatto puramente arbitrario; possiamo dire, con Remotti3,
che “l’identità (…) non inerisce all’essenza di un oggetto; dipende invece
dalle nostre decisioni”. Se l’identità è un problema di
confini, decidere l’identità non vuol dire scoprirli,
magari nascosti sotto un’apparenza ingannevole, ma scegliere
in che modo tracciarli, decidere come costruire gli
oggetti, gli individui, e in che modo organizzare la
realtà connettendo e organizzando i suoi diversi
elementi.
Questa scelta di organizzazione è, come si è visto,
totalmente arbitraria e nel costituirsi essa esclude
necessariamente tante altre possibilità di connessioni,
tante altre configurazioni di identità ugualmente
legittime. Esse rappresentano la possibilità di
sovversione delle identità costituite:l’insieme delle3 R. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari, 1996.
scelte potenziali, le possibilità alternative di tagli e
configurazioni che contrastano la rigidità e la pienezza
dell’identità.
Remotti sottolinea come sia inevitabile la tensione tra
identità e alterità: l’identità si costruisce a scapito dell’alterità,
riducendo drasticamente le potenzialità alternative; è interesse perciò
dell’identità schiacciare, far scomparire dall’orizzonte l’alterità
Ma l’alterità ritorna. Le identità che cercano
continuamente di negarla vedono il loro tentativo
frustrato; perché la condizione di particolarità
dell’identità può essere volutamente mascherata e
negata, ma non cancellata: ogni identità avverte così,
in modo più o meno traumatico, più o meno evidente, una
sorta di ferita nel suo intimo, una breccia che mina la
propria illusione di universalità e completezza.
L’alterità rivela, insomma, l’identità come una
finzione, una maschera, indispensabile e irrinunciabile,
ma comunque sempre arbitraria. E’ chiaro che, in una
logica dell’identità pura e forte, l’altro non possa che
assumere le sembianze di un fantasma minaccioso, e come
sia breve il passo dal sentire in pericolo la propria
legittimità all’armarsi e corazzarsi contro ogni
intrusione, oppure a sferrare azioni di soppressione
dell’alterità.
Si può pensare, allora, ad un modo diverso di
concettualizzare il rapporto tra identità e alterità:
non più una tensione conflittuale, di negazione e
rifiuto dell’altro, ma il riconoscimento dell’alterità
non solo nella sua inevitabilità, ma anche nel suo
essere coessenziale all’identità. Ammettere, cioè, che
alterità e identità sono intrinsecamente legate nella
loro formazione: innanzitutto perché l’alterità stessa
viene prodotta dal processo di costruzione
dell’identità; in secondo luogo perché l’identità è
fatta anche di alterità ed è continuamente costretta a
negoziare con essa i suoi confini. In questa
prospettiva, l’identità non è più una costruzione
compatta e immutabile, ma risulta il frutto di un
processo continuo di contrattazione con l’altro, che
viene nel tempo, metabolizzato e ridefinito, come viene
ridefinita e continuamente alterata l’identità.
Oggi più che mai, dunque, si pone l’esigenza di mettere
in discussione una concezione forte dell’identità in
vista di una concreta prospettiva interculturale.
L’interculturalità rinvia ad un impegno comune che ha
come fine l'incontro attivo tra soggetti portatori di
culture differenti, aperti al dialogo, disposti a
modificare e a farsi modificare dagli altri.
L'intercultura è anzitutto riconoscimento dell'altro e
relativizzazione del proprio sistema di valori ed idee
per evitare di spiegare ed interpretare i sistemi di
vita degli altri attraverso le nostre categorie
concettuali. L'intercultura, quindi, richiede di fare i
conti con le proprie contraddizioni interne e di
rimuovere le gabbie concettuali che distinguono le
"nostre" dalle "loro" pratiche.
Le prassi politiche interculturali si differenziano da
quelle multiculturali perché il loro fine è l'incontro e
lo scambio tra culture piuttosto che il mero
riconoscimento dei diritti degli specifici gruppi
sociali. Ma è solo lasciandosi alle spalle l’illusione
della possibilità di una identità forte ed unica che è
possibile, realmente, parlare di inerculturalità; solo
la consapevolezza che ognuno di noi ha tante identità
differenti, è che queste, o almeno alcune di queste,
non sono un dato naturale a cui doversi necessariamente
uniformare, può portare ad una concezione includente
dell’identità4. E’ chiaro che questa è la sfida più
difficile e, volendo usare delle categorie forti , è una
sfida difficile per noi “occidentali” e per il
molteplice mondo dei migranti, in cui spesso il
trincerarsi dietro una forte appartenenza ai gruppi
resta l’unica difesa possibile.
In questo senso tali prassi non possono che essere
lette in chiave progettuale, come l’obiettivo verso il
quale far convergere gli sforzi teorici e pratici di chi4 A. Sen, Identità e violenza,Laterza, Bari, 2006.
non riesce a stare al mondo senza pensare anche al mondo.
2. L’esperienza di tirocinio: un progetto di laboratorio
filosofico su “identità e differenza nella prospettiva dell’interculturalità.
Il nostro tirocinio si è svolto presso lo sportello
Immigrati della Provincia di Napoli. la prima volta che
abbiamo messo piede all'interno dello sportello, ci è
subito parso chiaro che non sarebbe stato facile
ritagliarci immediatamente un ruolo netto e ben definito
all'interno di quella struttura. Lo sportello è
frequentato quotidianamente da una moltitudine di
persone di diversa provenienza: cinesi, sirilankesi,
uomini e donne provenienti dall'est Europa o dal
continente africano; persone giunte in Italia, a Napoli,
per i più disparati motivi che cercano presso quel luogo
un aiuto per orientarsi fra la burocrazia e i mille
problemi quotidiani, grandi o piccoli, che l'Italia di
oggi prospetta allo straniero. Ci sono persone che
chiedono ausilio per un permesso di soggiorno o per
ricevere quanto gli spetta da un datore di lavoro.
C'è poi chi un lavoro non ce l'ha ancora e si reca
presso lo sportello per trovarlo, o, come ci è capitato,
chi è alla ricerca di un familiare venuto in Italia
tempo fa e poi scomparso,recluso all'interno di una casa
di cura o di una prigione.
In questo contesto, non certo facile, operano i
mediatori culturali e gli operatori dell'associazione
Less (Lotta all'Esclusione Sociale) che gestisce per
conto all’Assessorato alla Pace, Cooperazione
Internazionale e Immigrazione della Provincia di Napoli,
lo sportello.
Quotidianamente gli operatori cercano di fare tutto il
possibile per aiutare i migranti che si rivolgono loro,
fornendo servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro, assistenza legale e guida ai servizi, creando
sinergie con tutte le comunità di migranti presenti sul
territorio.
Difficilmente dunque un operatore, impegnato nelle
tante attività che ogni giorno coinvolgono lo sportello,
poteva dire a noi aspiranti consulenti filosofici cosa
fare o come farlo. Dopo una prima fase di
disorientamento, in cui abbiamo dovuto rimboccarci le
maniche per studiare e comprendere il contesto in cui
eravamo chiamati ad operare, abbiamo iniziato, nei
limiti delle nostre possibilità, a dare una mano in ogni
modo nelle varie attività quotidiane dello sportello.
Dal calcolo del TFR fino alla compilazione del modulo
per la richiesta di permesso di soggiorno, ci siamo
impegnati per entrare all'interno dell'istituzione e del
suo funzionamento al fine di comprendere in che modo
fosse possibile agire, con gli strumenti della
filosofia, in una situazione in cui le persone che ci
trovavamo davanti avevano innanzitutto bisogno di un
tetto, di un lavoro, o di assistenza legale.
Durante il lavoro allo sportello siamo venuti a
conoscenza del progetto I.A.R.A. (Integrazione
Accoglienza Rifugiati e Richiedenti Asilo) che è
inserito all'interno del programma nazionale di
protezione per i rifugiati e i richiedenti asilo
(S.P.R.A.R.).
Il progetto I.A.R.A. nasce nel 2004 e fornisce agli
aventi diritto oltre al vitto, un assegno mensile per le
spese personali oltre a assistenza legale e sanitaria,
inserimento scolastico per i minori e dei corsi di
alfabetizzazione . In particolare il progetto prevede 19
posti di accoglienza, suddivisi tra singoli, famiglie e
donne con prole. Fin dall’inizio il progetto si è posto
l’obiettivo di garantire un numero crescente di servizi
di orientamento e tutela ai RARU presenti sul territorio
napoletano, tra gli altri, vengono garantiti i seguenti
servizi: Redazione della memoria personale del
richiedente asilo; Reperimento e traduzione di tutti i
documenti che possano supportare quanto dichiarato dal
richidente asilo in relazione all’asserito fondato
timore di persecuzione; Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale ed accompagnamento ai servizi sanitari; cura
della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno
ecc.
Proprio entrando in contatto con alcuni dei beneficiari
del progetto I.A.R.A abbiamo avuto modo di intraprendere
la nostra attività di consulenza all'interno dello
sportello immigrati.
Le nostre conversazioni nate per caso hanno inizialmente
riguardato l'importanza che la filosofia può avere
nell'aiutare a prendere delle decisioni nella vita di
tutti i giorni.
In particolare, uno dei giovani richiedenti asilo ci ha
parlato di come avesse trovato particolarmente utile per
orientarsi nel mondo le quattro regole del metodo
cartesiano. Da queste conversazioni da prima sporadiche
e poco approfondite , ma poi sempre più puntuali e
frequenti, abbiamo tratto lo spunto per presentare ai
responsabili dello sportello un progetto.
Abbiamo pensato ad un percorso che ci vedesse coinvolti,
assieme ai richiedenti asilo (provenienti in questo caso
tutti da Burkina Faso), in degli incontri organizzati e
regolari, durante i quali poter discutere di tutti
quei temi di cui i migranti fino ad allora non avevano
potuto parlare, non trovando lo spazio per affrontarli
adeguatamente. Quest'idea ha suscitato subito
l'entusiasmo sia dei rifugiati, desiderosi di trovare
anche uno spazio di confronto e di espressione, sia dei
responsabili del progetto I.A.R.A., felici di poter
affiancare alle attività culturali già presenti per i
migranti (corsi di teatro, corsi di lingua ecc.), un
momento di ulteriore crescita non solo per i
partecipanti al progetto ma per gli stessi operatori
dello sportello.
Abbiamo iniziato così ad elaborare un percorso condiviso
che attraverso la lettura di testi filosofici ci
permettesse di trattare l'ampio tema
dell'interculturalità per coinvolgere in nostri
interlocutori in un dibattito che riguarda tutti da
vicino e che è risultato essere di straordinario
interesse per i nostri amici del progetto I.A.R.A.
Il laboratorio
In questo laboratorio abbiamo proposto un percorso di
lettura, dibattito e confronto sul tema dell’identità e
del riconoscimento a partire dall’analisi di alcuni
testi filosofici che riteniamo fondamentali per lo
sviluppo di questa riflessione.
Il progetto è stato inteso sin dall’inizio come percorso
chiaramente aperto: esso è stato dunque modificato ed
arricchito dalle suggestioni che sono emerse nel corso
degli incontri. In particolare un ragazzo ha mostrato un
interesse entusiasmante per questo laboratorio,
contribuendo con testi filosofici da lui cercati
autonomamente e , soprattutto, arricchendo noi stessi
attraverso i racconti, atroci e dolorosi, sulla sua
vicenda e sulla storia del suo Paese da cui è stato
costretto a scappare, a soli 27 anni, per motivi
politici.
Eppure, e questo dovrebbe farci riflettere tanto, in più
occasioni il ragazzo ha addirittura detto di rimpiangere
la violenza e le persecuzioni della sua terra, rispetto
alla non – vita che l’Italia gli sta facendo vivere. In
attesa dell’asilo politico, questa persona è
praticamente in un non luogo, non sa quale futuro lo
attenda e intanto vive un presente in una realtà che
ancora non sa realmente includere. In questa fase
abbiamo messo in atto un'azione di consulenza filosofica
personale rilevando come fosse poco utile rimpiangere
una scelta per ora non reversibile, sottolineando
proprio come le scelte più difficili e in qualche misura
irreversibili, che segnano l'esistenza , siano quelle
che contribuiscono a formare una soggettività forte in
un mondo dove la realtà virtuale del consumismo
imperante, fatta di scelte transitorie , instabili e
riproducibili, da luogo ad una completa de-
soggettivazione delle persone. In ogni caso non
sorprende, dunque, che proprio questa persona legga la
sua cultura di appartenenza come un patrimonio prezioso
da difendere ad oltranza, rifiutando, legittimamente,
qualsiasi discorso di natura universalistica ed
assimilatoria.
Dagli incontri con questa persona, in seguito ne
raccontiamo uno particolarmente significativo, abbiamo
imparato molto anche e forse soprattutto noi.
La struttura di fondo su cui abbiamo lavorato nei vari
incontri è la seguente:
Il cogito e la fondazione del soggetto moderno:
Cartesio, lettura dalle Meditazioni Metafisiche.
La critica empirista al cogito cartesiano: letture di
testi di Locke e Hume.
L’io incontra l’altro:
Hegel e il problema del riconoscimento: letture
dalla Fenomenologia dello
spirito e dalla filosofia dello spirito Ienese.
Il tema del riconoscimento nella prospettiva
psicoanalitica : Lacan, lo stadio dello specchio
Riconoscimento e multiculturalismo
Honnet, lotte sociali per il riconoscimento
Universalismo o tutela delle differenze? :
Habermas e Taylor a confronto
La critica al multiculturalismo
contemporaneo : Slavoj Žižek
Il riconoscimento giuridico dell’uguaglianza
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e
del cittadino
Una critica all’uomo della dichiarazione dei diritti
dell’uomo: Marx
Decolonizzazione e lotte per il riconoscimento :
L'importanza dell'opera di Franz Fanon
3. Un incontro particolare
I nostri incontri si sono succeduti con cadenza
settimanale divenendo sempre più interessanti e
coinvolgenti per tutti i partecipanti. In una prima fase
abbiamo dovuto superare alcune difficoltà prima fra
tutte la diffidenza degli stessi partecipanti. I ragazzi
che hanno partecipato al nostro laboratorio filosofico
erano tutti, come già detto, dei rifugiati politici in
attesa del riconoscimento del proprio status da parte
delle autorità italiane. La lontananza dalla propria
terra, dalla famiglia e le enormi difficoltà che lo
sradicamento dal proprio ambiente culturale e dal
proprio universo simbolico comportano, hanno fatto si
che queste persone non si sentano a loro agio in un
paese che pone loro enormi difficoltà dal punto di vista
burocratico e umano, ostacolando e quasi impedendo il
cammino verso la loro completa integrazione.
Da qui deriva una diffidenza verso l'uomo occidentale
che a volte si rivolge nei confronti degli stessi
operatori dello sportello e, di riflesso, anche verso
noi consulenti filosofici . Abbiamo superato, nel corso
dei nostri incontri, questa diffidenza iniziale
sviluppando un dibattito sempre aperto e franco che ha
permesso ai partecipanti al laboratorio filosofico, di
scoprire l'importanza e l'utilità del pensiero critico e
della discussione dei concetti filosofici. Un secondo
elemento inizialmente problematico è stato la lingua. I
ragazzi che hanno partecipato agli incontri sono tutti
originari del Burkina Faso, e, nonostante parlassero un
buon Italiano, abbiamo dovuto lavorare alla
chiarificazione delle parole e dei concetti chiave dei
testi filosofici che di volta in volta abbiamo
analizzato per permettere di far emergere dal linguaggio
quelle sfumature di senso necessarie allo sviluppo della
discussione filosofica.
Le persone che hanno frequentato il laboratorio hanno
cosi raggiunto un grado di consapevolezza e di
coinvolgimento sempre crescente appassionandosi in
maniera esponenziale alle discussioni proposte. Proprio
durante uno degli ultimi incontri presso la sede dello
sportello immigrati ha avuto luogo un dibattito molto
serrato e animoso che è emblematico del notevole impatto
personale, ma anche socio-politico e culturale, che gli
incontri di consulenza hanno avuto sui partecipanti.
Durante la lettura di un passo di Marx, che prendeva in
considerazione la dichiarazione dei diritti dell'uomo
mettendone in evidenza limiti e contraddizioni
intrinseche, uno dei partecipanti ha preso le difese
della prospettiva universalistica evidenziando come
alcuni valori abbiano un importanza universale al di la
delle specificità culturali pur essendo stati
concepiti, e a volte imposti, dal pensiero
occidentale. A questo punto un giovane rifugiato
politico (di cui abbiamo in
precedenza accennato), costretto a lasciare la propria
terra poco più che ventenne
per aver costituito un'associazione culturale, con lo
scopo di far riscoprire ai suoi
concittadini le origini e l'importanza della cultura
africana, si è lanciato in un'appassionata difesa della
specificità delle culture locali come rivendicazione di
un'identità specifica, rilevando come i concetti di bene
e male, giustizia e ingiustizia, siano relativi alle
singole culture di appartenenza. Avevamo davanti a noi
un'incarnazione del dibattito odierno fra
multiculturalisti e universalisti.
Mentre l'universalista accusava il suo compagno di
difendere pratiche palesemente
lesive della dignità umana quali la pena di morte o la
mutilazione genitale,
femminile, il multiculturalista paragonava,ironicamente,
il suo interlocutore agli intellettuali africani (di
cui parlava Fanon in un passo letto poco prima5) che5 Franz Fanon: I dannati della terra, Einaudi 1961, 2007, Torino.
durante il periodo della colonizzazione europea
dell'Africa si appiattirono su posizioni culturali
occidentali contribuendo dapprima all'affermazione del
regime coloniale, e, durante la decolonizzazione, al
fallimento di ogni prospettiva di rinascita culturale,
politica e sociale dell'Africa. Il dibattito era giunto
ad una contrapposizione frontale da cui era difficile
uscire.
A quel punto nel tentativo di trovare una sintesi
feconda che evidenziasse le contraddizioni interne
ad ognuna delle due posizioni per cercare un terreno di
scambio più fecondo, siamo ricorsi alla lettura di un
breve passo del dissacrante
autore sloveno Salvoj Žižek6. Con l'aiuto del testo del
filosofo abbiamo evidenziato
come il punto di vista dell'universalismo liberale
possa nascondere una posizione di non dichiarata
superiorità eurocentrica. L'universalistà liberale
occupa il posto vuoto dell'universale riempiendolo di6 Slavoj Žiżek, Il soggetto scabroso, Raffello Cortina Editore, Milano 2000
contenuti in apparenza neutri ma in realtà
eurocentrici, tollerando l'Altro solo finchè esso è
l'Altro della cucina etnica, del folclore ecc. ; ma è
pronto a giudicarlo un barbaro o un terrorista non
appena viene a contatto con l'Altro reale.
L'atteggiamento multiculturalista rischia di chiudere
l'altro nella sua gabbia culturale impedendogli rapporti
con le altre culture.
Il filosofo sloveno sottolinea inoltre come la
politicizzazione delle lotte pere il riconoscimento
delle identità possa nascondere il fatto che mai come
nel nostro tempo esiste un'omologazione e uno
sradicamento culturale quasi totale causato dalla
diffusione globale del sistema capitalistico che diviene
l'unico orizzonte possibile della vita umana.
Per questo il sistema ingloba al suo interno le lotte
politiche per il riconoscimento ma è pronto a reprimere
e a soffocare ogni messa in discussione del sistema
stesso. Troppo o troppo poco dunque. Assieme alle
persone presenti all'incontro siamo giunti alla
conclusione che se l'atteggiamento liberale
universalista non riesce a comprendere il radicamento e
la condivisione a volte anche da parte delle vittime di
alcune pratiche socio-culturali dell'Alterità, anche
quando esse appaiono barbare e crudeli ( le vittime
della clitoridectomia la percepiscono spesso come modo
per riaquisire una dignità propriamente femminile);
d'altra parte il multiculturalismo manca di comprendere
che l'Altro è scisso in se stesso ovvero che i membri di
un'altra cultura lungi dall'identificarsi interamente
con le convinzioni sociali possono rifiutarle e
rivoltarsi contro di esse usando come catalizzatore che
da il via alla protesta contro le costrizioni culturali,
proprio il concetto “occidentale” di diritti umani.
Proprio per queste intrinseche contraddizioni interne ad
ogni cultura c'è vera comunicazione solo quando si
lavora assieme, con le proprie specificità, ad un
progetto comune, la solidarietà che si sviluppa in una
“lotta comune”. Abbiamo descritto quanto avvenuto in uno
dei nostri incontri per dare un'idea di come abbaiamo
operato durante le nostre sedute di consulenza
filosofica di gruppo.
La vivacità intellettuale e l'interesse che i
partecipanti hanno dimostrato (chi più chi meno in base
alla possibilità di frequentazione) ci fanno ritenere
sicuramente riuscita quest'esperienza di tirocinio.
L'attività svolta durante il tirocinio ha suscitato
l'interesse non solo dei partecipanti, ma anche di
persone esterne allo sportello, che ci hanno voluto
osservare e prendere parte nelle nostre discussioni
settimanali. Sicuramente molti aspetti del metodo da noi
adottato sono migliorabili e perfettibili, tuttavia come
prima esperienza concreta di consulenza filosofica
riteniamo di aver raggiunto l'obbiettivo di mettere in
campo una prassi filosofica che ha reso tutti i
partecipanti più consapevoli e più aperti alla fine del
ciclo di incontri, in primo luogo noi stessi. Perciò
siamo certi dell'importanza della consulenza filosofica
in ambito interculturale, sopratutto in un periodo di
grande confusione e contrapposizione, al livello
nazionale, su questi temi. Il dialogo ha sempre la
capacità di avvicinare le persone e di abbattere
barriere, un dialogo filosofico può contribuire a
costruire una nuova cultura di convivenza e
collaborazione fra tutti gli attori in gioco in questa
grande sfida dell'integrazione cui il nostro tempo ci
pone di fronte. Ci auguriamo dunque di poter continuare
il nostro laboratorio aprendolo ad un numero sempre
maggiore di persone con l'aiuto dei nostri amici
rifugiati che hanno partecipato alla nostra esperienza
di tirocinio e , confidando nella disponibilità della
direzione dello sportello immigrati, presenteremo un
progetto in tal senso.
Bibl
iografia
Cartesio R. , Meditazioni Metafisiche, 1641, Bompiani,
2001.
Fanon F.,I dannati della terra, Einaudi, Torino 1961, 2007.
Habermas J. ,Taylor C., Multiculturalismo. Lotte per il
riconoscimento, Feltrinelli, Milano 1998.
Hegel F., Filosofia dello spirito Jenese, La terza, Bari,1984,
2008.
Honnet A. , La Lotta per il riconoscimento, IL saggiatore,
2002.
Hume D.,Trattato sulla natura umana, 1740, Editori
riuniti, 1983, 2001.
Lacan J., Il Seminario libro XI, I quattro concetti fondamentali della
psicoanalisi, Einaudi, Torino, 1979 e 2003.
Locke J., Saggio sull’intelletto umano, 1690, Bompiani 2007.
Remotti R., Contro l’identità, Laterza, Bari, 1996.
Žiżek S., Il soggetto scabroso, Raffello Cortina Editore,
Milano 2000.



































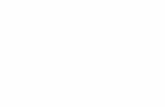




![La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317fdaebc8291e22e0e7df2/la-molteplice-direzione-temporale-nelle-confessioni-dun-italiano-fra-il-varmo.jpg)






![Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63141b0cfc260b71020f6789/unesperienza-etimologica-veneta-per-la-storia-di-mona-padova-esedra-2011.jpg)