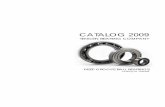Piazzoli, E. (2009). Metodologia Process Drama e Competenza Interculturale. Culturiana, September...
Transcript of Piazzoli, E. (2009). Metodologia Process Drama e Competenza Interculturale. Culturiana, September...
Culturiananº 3/4 2008
nuova serie
Rivista di linguistica, glottodidattica e informazione culturale per insegnanti d’italiano come lingua straniera
Italiano L2: inchiesta sulla certifi cazioneAtti Convegno Teatro e Glottodidattica
€20,00
distribuzionedistribuzione
www.culturiana.it
sommario3/2009
1
4
7
9
11
13
16
19
2425
27
29
31
35
39
INCHIESTA CERTIFICAZIONE ITALIANO L2La lunga strada verso la certifi cazione
di Carolina DragoIT dell’Università Roma 3
Conversazione con Serena Ambroso Professore Ordinario di Didattica delle Lingue Moderne e responsabile dell’Uffi cio della Certifi cazione dell’Italiano L2 presso l’Università di Roma 3
Il CEDILS della Ca’ Foscari Conversazione con Paolo Balboni, Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Università Ca’ Foscari di Venezia e Responsabile del Laboratorio ITALS
CILS, l’acronimo per il certifi cato dell’Università per Stranieri di Siena
Conversazione con la Professoressa Monica Barni, Direttrice Centro CILS – Università per Stranieri di Siena
La DITALS di Siena, la prima delle certifi cazioni didattiche
Conversazione con Pierangela Diadori, Professore Associato in Didattica delle Lingue Moderne dell’Universitàper Stranieri di Siena Responsabile Scientifi co della Certifi cazione DITALS
La CELI dell’Università per Stranieri di Perugia,pioniera delle certifi cazioni linguistiche
Conversazione con la Professoressa Giuliana Grego Bolli, Direttore del CVCL (Centro per la Valutazione e la Certifi cazione Linguistica) dell’Università per Stranieri di Perugia
La Dante Alighieri e il PLIDA Conversazione con Giuseppe Patota,responsabile Scientifi co del PLIDA e Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università di Siena
Casa dei Diritti Sociali: porte aperte agli studenti immigratiLa Comunità di Sant’Egidio e il CELI
RICERCHEIl docente di italiano L2,tanti ruoli per una fi gura complessa
di Maurizio MasellaComunicare retoricamente: la “discesa in campo” di Walter Veltroni Prima Parte
di Maria SquarcioneARTEItalics a Palazzo Grassi, una mostra destinata a fare storia
di Linda De SantisPENNE ADOTTIVEAmara Lakous. Una babele di lingue, l’Italia del futuro
di Stefania BucciarelliIN LIBRERIA
di Tiziana MigliaccioATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE “Teatro e Didattica delle Lingue Moderne”
tenutosi il 12 e 13 Dicembre 2008 presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
1
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
La lunga strada verso la certifi cazione
A navigare su Internet i siti di enti, istituzioni, centri, società e uni-versità che propongono certi-
fi cazione di competenza in italiano come L2, si può avere una sensazione di smarrimento come ogni volta che si incontrano acronimi che “stanno per” e che “rimandano a”. Dietro si-gle, centri, sedi di esame e istituti c’è il meglio che in Italia e all’estero si possa trovare nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, sia a livello di certifi cazione linguistica che didattica che sarebbe poi il pezzo di carta che racconta rispettivamente quanto ita-liano sai e quanto e quale italiano puoi insegnare.
L’Italia arriva tardi alla certifi cazio-ne. Mentre gli altri paesi d’Europa, Gran Bretagna, Francia e Germania in testa, da decenni sono in grado di rila-sciare a chi studia l’inglese e il france-se, un utile, conveniente e spendibile attestato di competenza linguistica, qui da noi accademici, insegnanti e di conseguenza studenti fanno i conti con un malinteso d’origine che si è poi rivelato un pregiudizio duro a morire: quello che l’italiano sia una lingua di cultura, una password per circoli cultu-rali, qualcosa che comunque ha poco a che fare, agli occhi degli stranieri, con la lingua reale e quindi con una spendibilità sociale che non sia quella salottiera e snob del bello stile di Dan-te e Petrarca.
Ad uffi cializzare la certifi cazione arriva l’Europa quando decide che la babele delle lingue comunitarie neces-sita di criteri comuni che attestino la competenza linguistica e comunicati-va del parlante. Nel 1991 il Consiglio d’Europa, nel corso di un simposio intergovernativo, evidenziava l’urgen-za di elaborare un quadro comune di riferimento per l’apprendimento delle lingue. Attraverso l’elaborazione di descrittori dei livelli di competenza lin-guistica si defi nivano ad hoc program-mi di apprendimento e, passo storico, il riconoscimento reciproco delle cer-tifi cazioni nei sistemi di istruzione dei diversi Paesi membri.
Il Quadro Comune Europeo di Ri-ferimento è uno strumento imprescin-dibile, trasparente e coerente che si rivolge a chi è coinvolto nell’insegna-mento e apprendimento delle lingue (docenti, enti certifi catori, studenti, decisori delle politiche linguistiche, creatori di libri di testo). Sono stati individuati sei livelli di competenza linguistica (A1/A2,B1/B2,C1/C2) che possono essere raggiunti da chi studia una lingua. È stata anche predisposta
di Carolina Drago
Inchiesta certifi cazione L2una griglia di autovalutazione che de-scrive nello specifi co le competenze dei sei livelli. La prima istituzione ad elaborare test e rilasciare certifi cati è nel 1987 l’Università per Stranieri di Perugia. Da allora le migliori menti ita-liane del settore, dalle Università per Stranieri di Siena alla società Dante Alighieri dalla Ca’ Foscari di Venezia all’Università di Roma 3 si sono mobi-litate per mettere a punto test, corsi,
master che certifi cassero la capacità linguistica dei parlanti l’italiano come L2 e le competenze glottodidattiche e culturali che un insegnante di italiano deve avere.
A distanza di quasi un ventennio, il ritardo è stato colmato e se non esiste più il problema di parlanti in assenza di certifi cati, ne rimangono altri. L’in-termittenza istituzionale e legislativa innanzitutto. Tra convenzioni e accor-di la latitanza politica è solo in parte colmata ma, di fatto, l’insegnamento agli immigrati, che sono il più gran-de bacino di utenza di lingua italiana da alcuni anni a questa parte, rimane spesso affi data a spinte volontaristiche che non prevedono né attestati né certifi cazioni. E la famosa spendibilità sociale, in un paese dove sono anco-ra troppe le aziende che non hanno idea di cosa siano certi strani acronimi, resta ancora inibita da un disconosci-mento che non permette alla certifi ca-zione di esprimere tutte le potenzialità e i vantaggi.
Intanto il dibattito è aperto, tra chi auspicherebbe un’unica certifi cazione per fornire una bussola agli utenti e tra chi ritiene che il pluralismo rappresenti ricchezza di spunti e terreno fertile per evitare l’appiattimento della ricerca, per una sana e corretta competizione che non può che giovare ad una lingua per molti aspetti in crisi. La diffusione dell’italiano riproduce infatti una geo-grafi a a macchia di leopardo, soffre di antichi pregiudizi d’immagine che re-legano il nostro idioma all’ambito delle lingue di una volta, quelle di cultura appunto, e soprattutto patisce l’attua-le scarsa credibilità economica del no-stro Paese, soprattutto all’estero dove
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
2
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008 fondatori ora si è arrivati a trentuno in
rappresentanza di 26 lingue parlate in Europa. I principali obiettivi dell’ALTE sono:
• stabilire un livello comune di certifi cazione per promuovere la ricognizione transazionale della certifi cazione in Europa• stabilire uno standard comu-ne per tutti i gradi del processo di language – testing • collaborare a progetti comu-ni per lo scambio di idee e di know- how tra i membri.
L’Associazione ha strettamente collaborato alla defi nizione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Framework), messo a punto dal Consiglio d’Europa, dove vengono defi niti 6 livelli di competenza lingui-stica: A1/A2, B1/B2 e C1/C2.
EALTA
E un’associazione professionale tra i language-tester in Europa ed è fi nan-ziata dalla Comunità Europea. Lo sco-po dell’EALTA è quello di promuovere la conoscenza dei principi teorici del
per ogni fabbrica italiana che chiude un certo numero di potenziali parlanti in italiano mettono da parte vocabola-rio e manuali per proiettarsi sullo spa-gnolo e sul cinese, più consoni e glo-bal.Una situazione, quella dell’italiano, che si misura ancora una volta e forse mai come adesso con una sfi da.
La nostra lingua ha bisogno di guadagnare credibilità come veicolo di idee, cultura mercato ed essere il nuo-vo idioma degli extracomunitari che vi-vono e lavorano nel nostro paese e che necessitano di conoscere l’italiano per integrarsi. Dalla Dante Alighieri ai no-stri Atenei per stranieri sono pronti. I materiali didattici esistono e altri sono in cantiere. La certifi cazione avanza in un percorso non facile.
ALTE
La sigla identifi ca the Association of Language Testers in Europe ed è l’ente composto dai membri esaminatori e certifi catori delle lingue. Ogni membro somministra i test per gli esami nella lingua madre del paese di provenien-za. L’ALTE si è costituita nel 1989 su iniziativa dell’Università di Cambridge e di Salamanca. Dagli otto membri
SalvoLapidi in marmo
Dimensioni variabileCourtesy 1000eventi, Milano
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
3
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008language- testing e di incrementare la
condivisione delle pratiche di langua-ge- testing in Europa oltre a formare professionalità che siano in grado di
elaborare test linguistici, sommini-strarli e valutarli. Ogni anno EALTA tie-ne un convegno oltre ad organizzare workshop e corsi di formazione.
A differenza degli Stati Uniti, dove la lingua madre è l’inglese, Eu-rolandia è un continente multilingue. Una differenza di culture e idiomi che si rifl ette nei sistemi educativi.
Era importante stabilire un criterio uniforme di certifi cazione lingui-stica che assicurasse un livello alto di qualità nella erogazione dei test linguistici per stabilire la competenza del parlante. Questo tipo di politica ha condotto a risultati come il “Common European Framework” e lo “Eu-ropean Language Portfolio” che hanno evidenziato il bisogno di un’as-sociazione senza scopo di lucro che si occupasse della organizzazione e diffusione dei test linguistici in Europa. Un obiettivo perseguito attraverso la costituzione di ALTE e EALTA che credono nella cooperazione linguistica internazionale nel rispetto delle autonomie dei singoli stati.
Gli organismi europei della certifi cazione
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
4
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
C ome è nata la vostra certifi -cazione?“Roma Tre” è stata l’ente ini-
ziatore da cui è partita l’idea della certifi cazione, quando ancora ci chia-mavamo Sapienza, in seguito ad un convegno alla Colombella. Eravamo nel 1986. Abbiamo cominciato dal livello C2 il livello avanzato, per poi aggiungere il livello B1 e B2 e adesso abbiamo anche il livello base A2, riser-
vato però soltanto alla Cina, dato che a loro serve certifi care questo livello minimo ai fi ni di ottenere il visto per
il progetto Marco Polo. Quello che di-stingue Roma Tre è che a partire dal livello B2 sottolineiamo il fatto che la competenza linguistica è modulare, non monolitica. Ai primi livelli apprendi i rudimenti delle quattro abilità, men-tre in seguito impari a fare delle cose meglio di altre. Gli studenti di livello B2 devono affrontare necessariamen-te le prove di ascolto e lettura ma poi possono scegliere volontariamente se sostenere la prova di produzione scrit-ta o orale. Per esempio la rifl essione metalinguistica, verifi cata attraverso la prova di grammatica e di conoscenza delle forme e degli usi dell’italiano c’è soltanto per gli studenti di livello di li-vello C2.
Quindi molto importanti sono l’attitudine ed il reale interesse dello studente, le motivazioni
che lo spingono ad apprendere la lingua?
Certamente non soltanto in base
Conversazione con Serena Ambroso
Professore Ordinario di Didattica delle LingueModerne e responsabile
dell’Uffi cio della Certifi cazione dell’Italiano L2 presso l’Università di Roma Tre
IT dell’Università Roma 3
IT è il Certifi cato di competenza generale in italiano come lin-gua straniera. Roma 3 è stata la prima università non per stranieri a mettere a punto la prova, nel 1986, destinata a tutti quelli che vogliono una valutazione delle proprie cono-scenze di Italiano L2. Le prove sono molto simili a quelle del Profi ciency della lingua inglese messo a punto dall’Università di Cambridge, e certifi cano una conoscenza della lingua di livello avanzato – superiore.
di Tiziana Migliaccio
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
5
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
testuale pragmaticamente orientato.
In questa prospettiva a quali modelli glottodidattici vi siete ispirati?
Al nostro. Noi siamo degli inizia-tori. Abbiamo dato agli altri un mo-dello da seguire,un modello basato sull’uso, sull’enfasi data al lessico: i testi sono tutti autentici, le domande sono costruite in base alla salienza o meno dei contenuti. Solo a livel-lo più alto chiediamo la grammatica dell’uso: per esempio l’alternanza dell’imperfetto con il passato prossi-mo. Una lingua è fatta di lessico gram-maticizzato. Quando partiamo per un paese straniero ci portiamo dietro un vocabolario, non una grammatica.
Questo dunque, secondo lei, deve avere una certifi cazione per essere eccellente?
Certo, riconoscere il contesto e utilizzare appropriatamente il lessico. Le ricerche ci hanno detto che a livello avanzato il maggior numero di errori sono nel lessico. Spesso l’uso della lin-gua tradisce, non la regola.
Che cosa si intende per inse-gnante di qualità?
Innanzitutto è bene precisare che un ente certifi catore non può essere una scuola in cui si insegna una lin-gua. Sarebbe come se un fabbricante di giocattoli certifi casse il proprio la-voro. Un buon insegnante deve sape-re come funzionano le lingue e deve
alla competenza, ma anche in base a che cosa devono effettivamente fare con la lingua.
Quali sono stati gli stimoli che vi hanno portato pionieristica-mente nel 1986 all’idea della certifi cazione?
L’idea è nata con Wanda d’Addio Colosimo, che è la maestra della Glot-todidattica, la persona che ha fatto crescere l’idea che insegnare la lingua sia una professione che appartiene alle discipline linguistiche e non a quelle pedagogiche. Mentre faceva parte del Consiglio d’Europa Wanda D’Addio lanciò l’idea organizzando insieme al Ministero degli Esteri questo convegno all’Università per Stranieri di Perugia, perché l’Italia fosse al passo con gli al-tri paesi. Rispetto alle altre lingue eu-ropee, l’italiano non disponeva ancora di una certifi cazione. Aveva intuito la strada che le certifi cazioni avrebbero preso nel futuro: oggi tutto deve es-sere certifi cato, dalle scarpe ai cibi, e quindi anche la competenza di una lingua, poiché costituisce un punto di riferimento. Il Ministero degli Affari Esteri poi ha sostenuto la certifi cazione fi nanziando la sperimentazione che ha visto coinvolti 470 parlanti di tedesco, francese, spagnolo e di inglese prima di mettere a punto la struttura defi ni-tiva dell’esame IT. L’attuale struttura di questi certifi cati è frutto di un grande lavoro di ricerca, ricerca che ha fatto emergere i nodi dell’italiano, le forme e gli usi. Il risultato è stato un impianto
Mario CeroliLe bandiere di tutto il mondo, 1968Terre colorate, elementi di zincoCm 1000 x 200Collezione dell’artista
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
6
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
sapere che non c’è un solo modo di dire le cose ma ci sono “enne” modi: deve partire dalla lingua parlata, fare grammatica in forma prima indiretta poi esplicita, la grammatica dell’uso, del testo, più diffi cile da insegnare rispetto alla grammatica tradizionale. Ci vuole professionalità. Deve sapere di linguistica italiana, deve conoscere i diversi tipi linguistici, per prevenire le possibili diffi coltà derivanti dalla lingua di provenienza, deve sapere come fun-ziona la mente quando apprende una lingua. Deve essere paziente, saper coniugare le restrizioni date dai pro-grammi ai tempi degli studenti.
Perchè, ad oggi, non si è ancora arrivati ad un unica certifi cazio-ne per l’italiano?
Innanzitutto perché non serve: le certifi cazioni sono attive dal 1993-94. Abbiamo tentato un’unifi cazione, ma noi italiani siamo troppo individuali-sti. Ognuno ha la sua proposta, la sua ricchezza, anche se le certifi cazioni rilasciate da enti universitari sono più legate a confronti europei, molto più aggiornate. Altre sono più obsolete. È giusto che non ci sia un monopolio. Sarà il mercato poi a decidere.
Nonostante questo ci avete pro-vato, avete creduto ad un certo punto che fosse possibile...
Abbiamo provato e quindi con del-le argomentazioni abbiamo preso co-scienza dell’inattuabilità di quell’ipote-si. Naturalmente sono diversi i bacini d’utenza: le università per stranieri na-scono come università vocate. Noi sia-mo una struttura incardinata nel Di-partimento di Linguistica che fa parte di uno dei 32 dipartimenti dell’Ateneo, che ha 8 facoltà: noi siamo una delle tante attività che fa Roma Tre. L’italia-no per stranieri non è una specifi cità di questo ateneo, mentre per Siena e Pe-rugia è così: hanno investito più risorse e quindi hanno più visibilità. Noi siamo una bella barca in mogano fatta da un maestro d’ascia contro uno di questi panfi li degli emiri arabi, meravigliosi ma asettici. Siamo un gioiellino.
In che modo si colloca la certifi -cazione dell’italiano rispetto alle certifi cazione delle altre lingue?
Siamo assolutamente alla pari: la nostra viene riconosciuta come un’ of-ferta di qualità. Quando parliamo con i linguisti all’estero ci accorgiamo che parliamo una lingua comune. Quello che ci lega è la qualità, il concepire la
lingua come uso sociale nei suoi valori pragmatici.
Le aziende conoscono la certifi -cazione?
Qualche anno fa vennero tre ferro-vieri dal cantone di Zurigo, dal cogno-me italiano, ma svizzeri da qualche ge-nerazione. Le ferrovie gli hanno pagato il viaggio, il soggiorno, la tassa, perché volevano che la loro lingua fosse cer-tifi cata. La cultura della certifi cazione si sta sempre più radicando, non solo nella scuola, ma anche nel mondo del lavoro si richiede la certifi cazione della lingua così come quella informatica. C’è un progetto chiamato “Certifi ca il tuo italiano” voluto dal Dott. Maurizio Silveri e promosso dal Ministero del La-voro che ha fi nanziato corsi di forma-zione in italiano per stranieri fi nalizzati alla certifi cazione.
Costituisce un vero e proprio va-lore aggiunto…
Certo, un valore aggiunto incredi-bile.
Quanti studenti avete certifi cato da quando esiste la vostra certi-fi cazione?
I numeri più signifi cativi riguarda-no il livello B1 per il quale certifi chia-mo circa un migliaio di studenti l’an-no, mentre di livello C2 circa 150. Un tempo erano più numerosi ma oggi i grandi numeri mi spaventano, avendo collaboratori molto bravi, ma in nume-ro ristretto. Noi siamo assolutamente autosuffi cienti, rispetto alle risorse investite riusciamo a coprire le nostre spese e c’è anche un margine di gua-dagno.
Come nasce l’interesse per l’ita-liano all’estero?
L’italiano non è l’inglese. È una lingua di cultura, ma all’estero viene vista anche come esempio di moda, di immagine.
Il così detto Italian Style?Dobbiamo investire sul passato,
sulla qualità, fornendo anche curiosità, argomenti che appassionino chi legge. Ma sempre legati ad attività di ricerca: il Consiglio d’Europa ci dice che sapere una lingua corrisponde a quante cose sai fare con quella lingua. La necessità di tradurre operativamente queste in-dicazioni ci ha portato a ragionare sul tipo di prova da proporre a studenti di un determinato livello affi nché anche la risposta sia di quel livello.
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
7
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
M a chi è l’“insegnante di quali-tà”? Cosa lo defi nisce, come si comporta, che ruolo ha
nella formazione di chi impara l’italia-no? Parte da queste domande e forni-sce una risposta concreta la CEDILS, la certifi cazione delle competenza in di-dattica dell’italiano come lingua stra-niera o lingua seconda dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’esame è aper-to a cittadini italiani o stranieri con for-mazione universitaria nella Facoltà di Lettere, Lingue e Scienze della Forma-zione ma anche a cittadini italiani non laureati che possano attestare almeno 5 anni di insegnamento dell’italiano agli stranieri nelle scuole di ogni ordi-nie o grado. Le prove d’esame sono in-viate al Laboratorio ITALS della Ca’ Fo-scari per la valutazione. Il Laboratorio ITALS è una struttura del Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Univer-sità veneziana che si occupa di lingui-stica, glottodidattica, pianifi cazione e politica linguistica, formazione dei do-centi di lingua.
Prof. Balboni, la CEDILS la è se-conda certifi cazione per inse-gnanti di italiano dopo la DITALS di Siena che ha fatto in qualche modo da apripista. Quali sono le differenze signifi cative tra le due certifi cazioni?
Le ho fatte tutte e due io e quindi sono sostanzialmente uguali. Quando è nata la DITALS c’è stato un accordo e quando sono venuto a Venezia l’ho ricreata. Si chiama in un altro modo per evitare problemi. Avevo proposto a Siena di spostare i due nomi ma poi alla fi ne non si è realizzato. L’idea che c’è dietro è comunque la stessa. Negli anni poi si sono differenziate. La DI-TALS ha messo al suo interno varie arti-colazioni mentre noi, invece, abbiamo fatto solo la FILS che è una certifi cazio-ne per i facilitatori di italiano L2 nelle scuole. Avevamo anche proposto a Perugia di avere una certifi cazione per procedere tutti e tre, Siena, Perugia e Venezia. Era un ‘idea innovativa di una certifi cazione a punti studiata proprio per favorire l’aggiornamento. Era una certifi cazione che perdeva punti col tempo e che andava mantenuta attra-verso corsi di formazione riconosciuti mutuamente tra le varie università così che chi aveva la certifi cazione a Siena poteva proseguire a Venezia o a Peru-gia. Sono stati fatti tentativi ma alla fi ne non si è mai riusciti a giungere ad una unifi cazione. È stato un pro-blema interno alle università più che un problema teorico. Ormai sappiamo
dalla Comunità Europea che cosa è un insegnante di lingue. Proprio perché non siamo riusciti a convincere le al-tre università ad unifi care il progetto abbiamo aggiunto un progetto qualità (per le scuole e per gli insegnanti) in cui diamo un accreditamento. L’accre-ditamento è una cosa temporanea che parte dalle esperienze di formazione e didattiche che uno ha fatto. É una fotografi a dinamica, una sorta di pas-
saporto professionale.
Oltre a Venezia dove operate? Abbiamo due sedi stabili, ad An-
cona e a Siracusa. Per quanto riguarda la formazione abbiamo un approccio differente. La DITALS ad esempio fa tutta una serie di volumi che in qual-che modo gli insegnanti sono invitati a consultare. Loro pensano: io ti formo e poi ti certifi co. La nostra idea è diversa. Diamo due o tre libri di base di riferi-mento e poi non ci interessa dove ti sei fermato. Facciamo pochissima forma-zione ad hoc. L’idea di partenza era: io non ti faccio corsi, tu studia, fai i ma-ster e tutto quello che c’è da fare e io ti certifi co. Così si evitava un confl itto di interessi. Noi sulla CEDILS abbiamo solo fatto un piccolo libricino per spie-gare come è fatto l’esame. Facciamo due o tre giorni di refreshement, gente che si formata all’estero o in Italia o che ha fatto lingue o lettere e che ha bisogno di due o tre giornate di studio per uniformare gli approcci.
Perché la lingua italiana è arri-vata tardi alla certifi cazione?
Perché la lingua italiana si riteneva una lingua di cultura e siccome la cer-tifi cazione è un concetto mercantile le-gato alla spendibilità sociale tutti quelli che avevano l’idea dell’italiano come lingua di cultura, snob hanno condi-zionato le scelte. Questo ha distrutto in parte l’italiano.
La CEDILS non necessita di tiroci-nio. Come mai?
Per la formazione che facciamo così come per il master, il tirocinio è obbligatorio ma per la certifi cazione
Conversazione conPaolo Balboni, Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari e Responsabile del Laboratorio ITALS
Il CEDILS della Ca’ Foscari
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
8
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
tamente perché potrebbe essere dan-noso. Questa è una straordinaria origi-nalità propria della tradizione italiana. Una seconda caratteristica dell’italiano è che mentre in molti altri paesi c’è stata una accentuazione sul sapere fare della lingua (come in inglese in cui non importa se tu metti una “s” oppure no) , oppure c’è stato un ac-canimento formalistico come nel caso del francese, gli italiani sono riusciti a fare una sintesi tra il saper fare con la lingua e l’accuratezza formale facendo una cosa interessante, cioè prendendo la lingua reale come modello. Ormai il passato remoto e il futuro stanno spa-rendo così come il congiuntivo. L’italia-no non è basato su una lingua alta ma su una lingua viva, corretta ma senza purismo.
Come defi nirebbe un insegnan-te di qualità?
L’insegnante di qualità è un con-cetto dell’Unione Europea ed è una fi gura che ha competenze disciplinari, metodologiche, pedagogiche e capa-cità organizzative. Secondo il modello dell’Unione Europea è un insegnante che deve essere in grado di interagire con altre scuole internazionali.
Che cos’è ITALS Qualità in cui ri-corre spesso il termine eccellenza?
Nella nostra concezione eccellente è un insegnante che rispetto all’inse-gnante di qualità è in grado di conta-giare l’ambiente in cui vive. Con la sua presenza e le sue competenze spinge i colleghi ad andare avanti. Nelle scuole c’è una grande quantità di insegnanti eccellenti ma spesso sono schiacciati dai prèsidi.
CEDILS non è necessario. Sommini-striamo un test dove simuliamo su un foglio la lezione alla lavagna o la co-struzione di una unità didattica. Se un insegnante è stato in classe lo supera altrimenti è chiaro che non ce la fa.
Esiste un problema di ricono-scibilità istituzionale degli in-segnanti di italiano. Come è la situazione?
Io sono l’unico glottodidatta dell’Osservatorio Nazionale per l’In-tegrazione degli Immigrati e sono quello che si dovrebbe occupare della didattica dell’italiano. Siamo riusciti a convincere l’allora Ministro Mussi che occorreva fare un’abilitazione per gli insegnanti di italiano L2 da parte dell’allora Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifi ca. Una volta attivato questo corso ho scoperto che il Ministero dell’Università non aveva detto nulla a quello dell’Istruzione. Ora i due ministeri si sono unifi cati ma che io sappia con c’è ancora una SISS per l’italiano L2. Semplicemente i ministeri non hanno comunicato tra loro.
In un articolo sulla rivista IN it lei parla di una originalità del-la glottodidattica italiana. A cosa si riferisce e in che modo la glottodidattica dell’italiano può dare un contributo alla certifi ca-zione?
L’idea di una originalità della glot-todidattica italiana è stato elaborato in Italia negli anni ’70 e si basa sul concetto che l’educazione linguistica è un blocco unitario e che quindi non si possono insegnare le lingue separa-
Patrick TuttofuocoWalkaround, 2002
10 grattacieli, tecnica mistaDimensioni variabiliMy Private, Milano
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
9
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
S ei livelli progettati e realizzati su misura delle indicazioni con-tenute nel Common European
Framework of Reference del Consiglio d’Europa. Il CILS sta per Certifi cazione di Italiano come Lingua Straniera ed è fi glia della grande ricerca nel campo dell’italiano L2 che può a buon titolo vantare l’Università per Stranieri di Sie-na. Dal 1992 la CILS è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e, in base ad una convenzione quadro, identifi ca gli Istituti Italiani di Cultura all’estero come sede uffi ciale degli esami CILS. Il Centro di Ricerca e Servizi dell’ateneo toscano ha guadagnato una sua indi-pendenza economica e amministrativa ed ha sviluppato attività di ricerca ba-sati sia sui modelli teorico-metodolo-gici di riferimento per la descrizione e l’articolazione dei livelli di competenza linguistico- comunicativa, sia sulle scel-te relative alla sua verifi ca, valutazione e certifi cazione.
Prof.ssa Barni, a che punto è l’Italia con la certifi cazione e perché si è arrivati solo nel 1992 a proporla? A che cosa è dovuto questo ritardo?
In parte è dovuta a una scarsa con-sapevolezza che ci fossero stranieri che avevano bisogno di italiano e l’altro aspetto fondamentale era la mancan-za in Italia della valutazione certifi cata. Nessuno se ne era mai occupato pri-ma. I corsi che faccio io sul testing e che fa Siena sono gli unici due in Italia. Mancando una base scientifi ca si arri-vava in ritardo anche con la creazione dei prodotti. Io per esempio ho dovuto fare corsi all’estero perché qui man-cava la cultura della valutazione della competenza linguistica.
Se lei si fa una bibliografi a su certi temi come la certifi cazione le uniche cose che trova sono quelle di Siena e Perugia. Se fa la stessa ricerca su ciò che succede in Gran Bretagna, trova cinquanta enti che fanno la certifi ca-zione.
C’è un dibattito scientifi co per cui se qualcuno lancia un test che non funziona c’è subito qualcuno che pro-testa e questo tiene viva la ricerca.
Perché in Italia non esiste un’uni-ca certifi cazione?
Credo che un’unica certifi cazione rappresenti un appiattimento della ri-cerca. In Italia si cerca sempre il bolli-no ministeriale. Anche se si fanno più certifi cazioni è il mercato che decide. Credo che quello che è importante sia ciò che si certifi ca e la qualità scienti-
fi ca. Se lei legge i documenti europei dicono che devono essere trasparenti e devono avere ben chiari gli obiettivi che devono raggiungere.
A quali modelli di testing fa rife-rimento la CILS?
Abbiamo lavorato moltissimo su forme di testing che tengano conto delle caratteristiche di variabilità, aper-tura e indeterminatezza di una lingua.
Cerchiamo di dare grande spazio alla creatività e alla capacità di ogni ap-prendente di creare con la lingua. Cer-chiamo di trovare un equilibrio tra le prove chiuse e le prove aperte. L’altra scelta che abbiamo fatto è di valutare tutto a Siena, proprio per evitare che ci sia troppa infl uenza della soggettività.
Come si è evoluta in questi anni la CILS e che cosa prevedete per il futuro?
Cerchiamo sempre di tener conto dei cambiamenti della realtà linguisti-ca contemporanea. Un’altra cura la mettiamo nella selezione dei testi e un criterio fondamentale è quello della paradigmaticità dei testi. Il testo deve essere paradigmatico della realtà.
Qual è il modello glottodidatti-co a cui fate riferimento?
La certifi cazione non deve fare ri-ferimento a modelli di glottodidattica ma fotografa lo stato di competenza che si ha della lingua. La lingua è in-tesa come semiotica sociale e in que-sto senso la certifi cazione è come una macchina fotografi ca che vede a che punto è il tuo stato di apprendimento e conoscenza della lingua.
In che modo può orientarsi uno studente tra le varie certifi cazio-ni? Sceglie solo in base al presti-gio dell’ente certifi catore?
Conversazione con Monica Barni, Professore di Didattica delle Lingue Moderne presso l’Università per Stranieri di Siena. Direttore centro CILS
CILS, l’acronimo per il certifi cato dell’Università per Stranieri di Siena
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
10
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
Uno studente si può orientare leg-gendo le linee guida e i descrittori dei livelli. Deve essere un insegnante a gui-darli. La lettura di ciò che è contenuto nelle linee guida consente poi di provare a fare ciò che è stato fatto nelle sessioni precedenti. Applichiamo le specifi che del quadro europeo di riferimento.
Rispetto agli immigrati, in che modo vi siete attrezzati?
Noi abbiamo un pubblico vastis-simo di immigrati e abbiamo lavorato con loro con moduli A1 e A2. Ci sono alcuni interventi, alcuni progetti del Mi-nistero del Lavoro e ci sono molte realtà sensibili come la Lombardia e la Tosca-na con cui ci sono stati progetti strut-turati e portati a termine con successo. L’anno scorso comunque noi abbiamo testato circa 3500 extracomunitari.
Come vede il futuro della lin-gua italiana?
Va visto in relazione a quello che è il periodo che stiamo attraversando. Fino alla fi ne degli anni ’90 potevamo notare una crescita esponenziale della lingua italiana.
L’espansione della lingua italiana è sempre legata al luogo, alle perso-ne e alle funzione. Adesso, in questo momento di crisi economica caleran-no i consumi culturali e questo avrà rifl essi linguistici. Abbiamo fatto ricer-che collegando i dati economici rela-tivi alla presenza delle multinazionali nel mondo alla richiesta della lingua italiana. Dove c’è una multinaziona-le italiana e una presenza economica c’è una rete strutturata di richieste. Quando si ritirano c’è un crollo della richiesta.
Lucio FontanaAmbiente spaziale, 1968
Legno e gesso biancoCm 330 x 520 x 80
Fondazione Lucio Fontana, Milano
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
11
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
I l 2005 è l’anno di nascita del Cen-tro DITALS dell’Università per Stra-nieri di Siena, il primo contributo
formale per insegnanti di italiano L2, ma la certifi cazione nasce nel 1994. In 14 anni ha attestato oltre tremila can-didati in tutto il mondo. Oltre cento istituzioni tra enti, università, scuole e Istituti Italiani di Cultura all’estero, hanno sottoscritto una convenzione con l’ateneo senese per offrire ai can-ditati la possibilità di sostenere l’esame sul posto nella stessa data in cui l’esa-me viene sostenuto a Siena, un tem-po reale che ha dato vigore e ancora maggiore credibilità alla certifi cazione didattica.
Prof.ssa Diadori, come è iniziata l’avventura della DITALS?
Era venuto a Siena come Professo-re Associato Paolo Balboni, ed io ero ricercatrice di linguistica italiana. Ab-biamo ideato una certifi cazione che permettesse agli insegnanti di italiano all’estero, ricchi di esperienza ma con poca formazione, di frequentare corsi di aggiornamento in vista di una certi-fi cazione. Questo ha preso la forma di una prova che all’epoca era solo scrit-ta e che puntava a combinare teoria e pratica. C’era una prova teorica e due prove applicative.
È un formato che è rimasto anche se poi si è evoluto. All’epoca c’era la prova A di analisi di materiali didattici, la prova B con la costruzione di unità didattiche e la prova C con una bat-teria di domande teoriche. Abbiamo sperimentato questo formato per la prima volta negli Stati Uniti e poi ho continuato ad occuparmene con la collaborazione volontaria di docenti di lingua impegnati anche nei corsi di formazione all’estero. Nel 2005 il Pro-fessore Vedovelli ha istituito un centro con autonomia di spesa di ricerca e servizio dedicato alla DITALS.
La vostra è la prima certifi ca-zione di competenza per inse-gnanti di italiano? Poi è seguita la CEDILS della Ca’ Foscari. Che differenza c’è tra le due?
Nel corso di questi anni la certifi ca-zione DITALS (che è stata completata anche con una prova orale) ha ela-borato un formato basato su quattro prove e la prova orale consiste in una simulazione di due produzioni orali del candidato secondo due quesiti. Una si tratta di una spiegazione a un certo tipo di target e poi la spiegazione di una attività che viene registrata e quin-di mandata a Siena per la valutazione.
La prova è abbastanza diffi cile.
Perché non si va verso un’unica certifi cazione?
Questo è una domanda che è stata fatta molto spesso. Ci sono in realtà pubblici diversi. Noi come Università di Siena abbiamo una rete di contatti che solo in parte si amalgamano. Abbiamo circa 100 enti convenzionati con noi in tutto il mondo che propongono la
DITALS. Ora ad esempio abbiamo con-tatti con la Cina e abbiamo creato una nuova certifi cazione su misura per in-segnanti di italiano ai cinesi.
Quali sono i punti di forza degli insegnanti di italiano in posses-so della certifi cazione rispetto a chi non la ha?
Prima di tutto la nostra è una cer-tifi cazione che punta sull’autonomia. Molto è lasciato al docente che ha la libertà di prepararsi come meglio cre-do ma facendo un tirocinio. L’esame in sé è molto economico ma poi occorre anche un background professionale. Per l’Italia al fi ni dell’inserimento nelle graduatorie degli insegnanti di italiano L2 il Ministero non recepisce. Anche per questo abbiamo creato il master DITALS che contiene al suo interno le due certifi cazioni e porta al titolo di master che dà punteggio per le gra-duatorie.
Quali sono i modelli di testing a cui si fa riferimento?
Rispetto ai modelli europei quelli direttamente coinvolti sono quelli del-la griglia di riferimento dell’ Common European Framework of Reference del Consiglio d’Europa. Il Professor Brian North ha costruito una griglia di de-
Conversazione con Pierangela Diadori, Professore Associato in Didattica delle Lingue Moderne dell’Università per Stranieri di Siena Responsabile Scientifi co della Certifi cazione DITALS
La DITALS di Siena, la prima delle certifi cazioni didattiche
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
12
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
scrittori di competenze. Questa è una griglia dettagliata di descrittori che vengono coperti dal DITALS.
A quali modelli glottodidattici si ispira la vostra certifi cazione?
Siamo sempre nella scia dell’ap-proccio comunicativo di stampo anglo-sassone ma con specializzazioni che si
sono Common European Framework of Reference decisamente orientato alla spendibilità sociale della lingua. Altre importanti suggestioni vengono dalle teorie interazioniste e dalla teoria della processabilità di Tienemann, stu-di che guardano all’acquisizione delle lingue moderne in relazione all’infl us-so che può avere l’input.
Maurizio CattelanBidibidobidiboo, 1995
Scoiattolo tassidermizzato, tecnica mista58 x 50 x 50 cm
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
13
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
C on una storia che comincia nel 1921, splendide sedi nel cuore della città umbra, l’Università
per Stranieri di Perugia è l’antica e pre-stigiosa istituzione italiana nel campo della ricerca e insegnamento dell’ita-liano L2. Dal 1987 l’ateneo rilascia certifi cati linguistici ed ha il primato di essere stata la prima istituzione italiana ad aver operato nel settore della certi-fi cazione della conoscenza dell’italiano L2. Gli esami CELI prevedono 5 livelli progressivi: dall’elementare all’avanza-to, dove per avanzato si intende il par-lante eccellente del CELI 5. Dal 1993 i certifi cati CELI vengono somministrati in tutto il mondo. Da allora ad oggi cir-ca 82.000 candidati si sono iscritti agli esami di certifi cazione dell’Università di Perugia, 11.500 solo nel 2006.
Prof.ssa Grego Bolli, il CELI vanta il primato di essere stata la prima certifi cazione linguistica italiana. Ci racconta la cronaca di come ci siete arrivati?
L’Università per Stranieri di Perugia ha, in realtà, iniziato ad occuparsi di certifi cazione linguistica già, nell’or-mai lontano 1987, producendo esami per il conseguimento di due Diplomi: il Diploma di Lingua Italiana e il Diploma di Lingua e Cultura Italiana. La certifi -cazione CELI ha di fatto sostituito tale primo sistema certifi catorio per l’italia-no generale ed è stata somministrata per la prima volta nel giugno 1993, credo contestualmente ad altre certi-fi cazione per l’italiano.
In che cosa il CELI si differenzia dalle altre certifi cazioni?
Ogni sistema certifi catorio si distin-gue e si caratterizza in base alle proprie specifi cazioni, vale a dire forme varie di pubblicazioni (dai siti web, agli han-dbooks, a pubblicazioni scientifi che) di-stinte a seconda dell’utenza, nelle quali vengono specifi cati contenuti, metodi di verifi ca, criteri di valutazione, con relative scale, punteggi ed espressione dei risultati. Tali specifi cazioni variano necessariamente da una certifi cazione all’altra, o meglio da un sistema certi-fi catorio all’altro, costituendo di per sé un primo, sostanziale elemento di dif-ferenziazione fra le certifi cazioni.
In termini più generali, possiamo dire che, nell’individuare i propri stan-dard di riferimento, la certifi cazione CELI ha fatto riferimento, sin dai primis-simi anni ’90, al lavoro svolto e all’ap-proccio seguito dal Consiglio d’Europa sin dagli anni ’60. Tale collaborazione con le Istituzioni europee è proseguita
e si è rafforzata nel 2000. A seguito della pubblicazione del QCER (Qua-dro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), l’Università per Stranieri di Perugia ha lavorato, in collabora-zione con la Divisione per le Politiche Linguistiche del Consiglio d’Europa, a due importanti progetti di ricerca volti a fornire strumenti che consentissero un’applicazione pratica del QCER nei due settori a cui il documento europeo
si rivolge:verifi ca/valutazione e appren-dimento/insegnamento.
Qual è il modello di testing a cui fate riferimento?
Il modello di CLA (Comunicative Language Ability) elaborato e propo-sto da Lyle Bachman nel 1990, poi ri-preso nel 1996 dallo stesso Bachman e da Palmer.
Perché in Italia non si va verso un’unica certifi cazione?
Perché ne esistono 4 ormai da15 anni, che nel tempo si sono necessa-riamente sempre più caratterizzate, differenziate e distinte, sia all’inter-no, sia all’esterno. Ciascuna delle 4 Istituzioni italiane che si occupano di Certifi cazione linguistica ha investito in questo importante e specifi co set-tore, creando al proprio interno com-petenze ed professionalità specifi che e diversifi cate, alle quali nessuna delle quattro suddette istituzioni può e le-gittimamente vuole oggi rinunciare. Al
Conversazione con la Professoressa Giuliana Grego Bolli, Direttore del CVCL (Centro per la Valutazione e la Certifi cazioneLinguistica) dell’Università per Stranieri di Perugia
La CELI dell’Università per Stranieri di Perugia, pioniera delle certifi cazioni linguistiche
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
14
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
di là di tale realistica considerazione, non ritengo che, in assoluto, un’uni-ca certifi cazione possa dare maggiori garanzie di qualità. L’italiano non è, del resto, l’unica lingua ad avere più di una certifi cazione.
Come si è evoluto il CELI in que-sti anni e quali sono le proiezio-ni per il futuro?
La certifi cazione CELI per l’italiano generale, si è gradualmente distinta e differenziata, da un lato completando la propria scala di livelli con un certifi -cato di livello A1, dall’altro rivolgendosi ad utenze specifi che: immigrati adulti (tre livelli da A1 a B1), adolescenti dai 13 ai 17/18 anni (tre livelli da A2 a B2). Gli esami, sia per immigrati adulti, sia per adolescenti vengono somministrati nel mese di maggio. Le sessioni di esa-mi da due sono diventate oggi quat-tro, in modo tale da rispondere meglio
alle esigenze dell’utenza. In collabora-zione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, il CVCL ha prodotto il CELI 5 DOC, un certifi cato linguistico di livello C2 per laureati stranieri che vogliano iscriversi nelle graduatorie per l’insegnamento nelle scuole italiane. Sono operative dal 2007 due sessioni all’anno di pre-testing (dal lvello A2 al livello C2) fi nalizzate alla creazione di una banca di item calibrati su una scala comune di diffi coltà. Si prevede che dal 2010 sarà possibile rivoluzio-nare completamente l’attuale sistema di lavoro attingendo, direttamente dalla banca gli item per gli esami, che potrebbero di conseguenza essere somministrati più frequentemente di quanto non avvenga ora.
Si sta contestualmente lavorando ad un progetto fi nalizzato alla sommi-nistrazione on line degli esami di cer-tifi cazione.
Mario MerzSenza titolo (una somma reale
non è una somma di gente), 1972Stampa fotografi che, neon
Cm 24 x 24Collezione Merz
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
15
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
É stato infi ne portato recentemen-te a termine un progetto, coordinato dalla prof. Anna Ciliberti, fi nalizzato alla elaborazione e produzione di un certifi cato glottodidattico di I livello.
In che modo può orientarsi lo stu-dente tra le varie certifi cazioni?
Visitando i siti web, procurandosi handbooks e past papers. La traspa-renza delle informazioni è uno dei pri-mi doveri per chi si occupa di certifi ca-zione linguistica.
C’è una grande richiesta di ita-liano da parte degli immigrati? Qual è la vostra offerta al pro-posito?
Il CVCL ha recentemente portato a termine un progetto biennale rea-lizzato in collaborazione con la rete di CTP del X di Modena e del X di Roma, rivolto ad immigrati con scarsa alfabe-
tizzazione e fi nalizzato alla defi nizione di un percorso formativo specifi co che portasse immigrati adulti scarsamente scolarizzati a raggiungere dapprima gli obiettivi di apprendimento indicati dal livello A1 del QCER, per poi proseguire il percorso iniziato fi no al raggiungi-mento di un livello B1.
Come vede il futuro della lingua italiana?
Sinceramente non roseo, poichè manca un sistema coordinato e in quanto tale effi cace di promozione della lingua e con essa della cultura italiana. Oggi, riproponendo una real-tà tutta italiana, tale funzione è spesso affi data alla buona volontà dei singoli, ovviamente troppo poco. In aggiunta l’attuale, avanzante crisi economica globale non credo agevolerà la messa in opera, da parte del governo, di poli-tiche ed azioni mirate a tal fi ne.
Emilio TadiniColor&Co., 1969Acrilico su telaCm 100 x 81Courtesy Fondazione Marconi, Milano
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
16
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
C on un passato glorioso e un presente attivissimo, 500 co-mitati sparsi per il pianeta e
quasi cento in Italia, la Dante Alighieri detiene di certo il primato del contat-to diretto con i bisogni linguistici e culturali di chi cerca la lingua italiana nel mondo, oltre ad essere, in Italia, il punto di riferimento per migliaia di studenti stranieri . Anche la “Dante” non ha mancato l’appuntamento con
la certifi cazione e dai primi anni No-vanta ha istituito il PLIDA, acronimo che sta per Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri. Una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, il plauso scientifi co dell’Università “La Sapien-za” di Roma, il riconoscimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Istruzione e della Ricerca Scientifi ca collocano il certifi -cato linguistico della Dante Alighieri tra quelli più richiesti dagli studenti di lingua italiana. La storica istitu-zione è inoltre il referente, dal 2004, per il Ministero del Lavoro, che le ha affi dato la formazione linguistica dei lavoratori stranieri ancora prima della loro partenza dal paese di origine per l’Italia. Sono sei i livelli rappresentativi stabiliti dal PLIDA, che tengono con-to di altrettante fasi del percorso di apprendimento della lingua e vanno dall’A1 al C2 in progressione di diffi -coltà e corrispondono ai livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa.
Prof. Patota, perché in Italia ab-biamo tante certifi cazioni?
Mi sembra che si stia andando nel-la direzione di un’unifi cazione. Il Mini-stero degli Affari Esteri sta lavorando per un sistema integrato che coinvolga tutte le certifi cazioni che ci sono ora. È un primo passo verso una maggiore armonia della certifi cazione, fermo re-stando la garanzia della pluralità degli enti certifi catori. Originariamente la nostra certifi cazione prevedeva non 6 ma 4 livelli. Dopo il 2004 abbiamo isti-tuito 6 livelli perché abbiamo pensato che uniformarci al Quadro Europeo di Riferimento avrebbe rappresentato un
tentativo “ecumenico” di avvicinarci all’Europa e al suo modello unitario. In questo senso, saremmo felici di mette-re a disposizione di tutti questo model-lo e questa esperienza. A mio avviso, mentre l’attività di ricerca deve essere lasciata alle Università, il servizio della certifi cazione invece, può e deve esse-re garantito anche da altre istituzioni, compresa la nostra, che comunque lo eroga con il plauso scientifi co dell’Uni-versità “La Sapienza” e sotto il con-trollo costante di un Comitato Scienti-fi co formato da docenti e ricercatori di fama internazionale.
Come si colloca il PLIDA rispetto alle altre certifi cazioni dell’ita-liano L2?
Non ci interessa fare concorrenza. Più la lingua italiana sarà certifi cata, più sarà diffusa e meglio sarà insegna-ta. Non c’è certo una gara tra chi ha la migliore certifi cazione. La Società Dante Alighieri ha il compito di dif-fondere la lingua e la cultura italiana nel mondo e si avvale di tutti gli stru-menti di cui sia apprezzata la qualità scientifi ca.
Quali sono i problemi per gli insegnanti di italiano rispetto alla certifi cazione?
La fi gura dell’insegnante di ita-liano a stranieri sconta un vuoto le-gislativo perché non è riconosciuto giuridicamente. Siamo una lingua in crescita e mentre prima l’italiano era una lingua di cultura e quindi presti-giosa grazie alla nostra tradizione, ora è una lingua che occorre anche per lavorare. La Dante Alighieri ha il van-taggio di una presenza capillare nel mondo ed ha anche siglato un accor-do con l’ICE (Istituto del Commercio Estero) per la formazione di lavoratori e quadri che necessitano di conoscere la lingua italiana.
Com’ è la posizione della Dan-te Alighieri rispetto al bisogno di lingua italiana da parte degli immigrati?
Nel 2004 la Società ha stretto un accordo con il Ministero del Lavoro volto a garantire la formazione lingui-stica degli immigrati già nel loro paese d’origine, prima ancora che arrivino in Italia. In questo modo, questi lavora-tori sono facilitati nell’approccio col mercato del lavoro del nostro paese. Esiste sull’argomento un libro con la prefazione del Presidente Giorgio Na-politano che si intitola “Formare nei paesi d’origine per integrare in Italia”.
Conversazione con il Professore Giuseppe Patota,
Responsabile Scientifi co del PLIDA
e Professore Ordinario di Linguistica Italiana
presso l’Università di Siena
La Dante Alighieri e il PLIDA
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
17
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
Inoltre, c’è una buona collaborazione con i CTP (Centri Territoriali Perma-nenti), che funziona bene soprattutto nel nord est. In più, ci sono Comitati come quello di Siracusa che svolgono un’attività di “primo soccorso lingui-stico”, che per importanza è parago-nabile al primo soccorso fi sico, che vie-ne offerto ai migranti di Lampedusa. Il comitato di Siracusa svolge un’attività professionalmente ben qualifi cata e
che è a titolo totalmente gratuito.
Le aziende conoscono la certifi -cazione?
Certamente non tutte. Noi ci diamo da fare, e ne è una prova il nostro ac-cordo con l’ICE . C’è posto per tutti, ma occorre davvero un intervento in favore di un sistema integrato di certifi cazione che potrà essere effi cacemente svolto dal Ministero degli Affari Esteri.
Giuseppe GabelloneL’assetato, 2008Ferro, ferro zincatoCm 120 x 49 x 28Courtesy Studio Guenzani; Galerie Emmanuel Perrotin, Parigi-Miami
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
19
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
G uardare agli immigrati non come agli “altri”, ai diversi, agli estranei, bensì come ai
nuovi cittadini in grado di fornire un nuovo apporto al nostro sviluppo è l’unico modo per prepararsi al nuovo scenario futuro.
Come è stato più volte sottolinea-to dalle associazioni che si occupano a vari livelli di migrazione, l’arrivo e la permanenza di immigrati può appor-tare notevoli potenzialità allo sviluppo locale ma richiede attenzione e acco-glienza nel rispetto di diritti e doveri.
Secondo Caritas e Migrantes nell’ultimo Dossier 2008 il numero di immigrati presenti in Italia, conside-rando anche quelli che non hanno an-cora acquisito la residenza, oscilla tra i 3.800.000 e i 4.000.000 su una po-polazione complessiva di 59.619.290 persone, con una percentuale del 6,7%, leggermente al di sopra della media europea. Favorire la conoscenza della lingua italiana è in questi ultimi anni l’obiettivo delle istituzioni e del volontariato. All’interno dell’offerta formativa globale dell’insegnamento dell’italiano il contributo delle scuo-le del volontariato supera il 40%. Ci sono i Centri Territoriali Permanenti e le associazioni del volontariato e poi ci sono le altre realtà che è diffi cile quan-tifi care. Hanno scuole di italiano per i migranti le parrocchie, le sezioni di partito, i sindacati, gli istituti religiosi.
Roma è la città che da 10 anni detiene il primato dell’incremento del fl usso migratorio. Le statistiche ISTAT parlano di 300.000 stranieri. La do-manda è molto alta. Sono 6400 gli studenti migranti e sono fondamen-talmente due sono le associazioni di volontariato che ne raccolgono il mag-gior numero. La Comunità di S. Egidio attualmente accoglie 2700 studenti e la Casa dei Diritti Sociali 1500.
La Casa dei Diritti Sociali
È un’associazione di volontariato laico impegnata dal 1985 nella promo-zione dei diritti umani e sociali dei set-tori più deboli della popolazione in Ita-lia e nel Sud del mondo. Solidarietà e multiculturalità sono i principi che ispi-rano tutte le attività dell’associazione. Tra queste non poteva mancare quella della scuola di italiano per migranti. C’è in Italia ancora una visione ridut-tiva del sistema partecipativo. Il voto e la rappresentatività non sono ancora considerati importanti. È attivo, però, il dibattito sul diritto di cittadinanza, sul-la partecipazione politica dei migranti
e sul conseguente diritto di voto che hanno portato in primo piano anche il tema della certifi cazione linguistica.
L’Italia ha la normativa più restritti-va d’Europa in materia di naturalizza-zione degli adulti stranieri, mentre non ne ha nessuna in materia di acquisto della cittadinanza per i minorenni. La legge attualmente in vigore risale al 1992 ed è ancora regolata sul prin-cipio dello “ius sanguinis”, cioè sulla
trasmissione della cittadinanza di pa-dre in fi glio indipendentemente dal paese in cui si nasce; una legge nata per tutelare la nazionalità italiana in caso di emigrazione.
Attualmente servono circa 12 anni per avere una risposta alla richiesta del-la cittadinanza da parte di uno stranie-ro. Si tratta del periodo in assoluto più lungo in Europa. La Germania richiede 8 anni, la Francia e la Gran Bretagna 5.L’ultima proposta di legge in materia di cittadinanza è stata bloccata nel suo iter dalla fi ne della precedente legisla-tura. Questo testo unifi cato, discusso in Commissione Affari Costituzionali, modifi cava le norme che riguarda-no il tempo di residenza in Italia ( si passa dai 10 ai 5 anni necessari per la richiesta), ma soprattutto introduceva la norma che prevede la dimostrazio-ne di un buon livello di conoscenza della lingua italiana (A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento), della cultura, della storia e dei principi fon-damentali della Costituzione per l’ac-quisizione della cittadinanza. Proprio in queste ultime settimane l’esigenza di una nuova legge sulla cittadinanza ha portato di nuovo il tema all’atten-zione della politica.
Si sente dal punto di vista norma-tivo l’esigenza di affrontare il tema della certifi cazione linguistica per il migrante. Un argomento che è infat-ti al centro del convegno che la CDS ha organizzato a Roma dal titolo “In-tegrazione sociale a Roma e scuole di
Casa dei Diritti Sociali: porte aperte agli studenti immigrati
“Vivere una sola vitain una sola cittàin un solo paesein un solo universovivere in un solo mondoè prigione.Conoscere una sola linguaun solo lavoro,un solo costume, una sola civiltàConoscere una sola logica è prigione.”
T.Djock Ngana poeta camerunense autore della raccolta di poesie Nhindo Nero
di Stefania Bucciarelli
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
20
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
italiano per migranti”e che ha inserito tra i punti all’ordine del giorno proprio la questione della certifi cazione. E tale è la consapevolezza di questa necessi-tà a certifi care che la Scuola di italiano della Comunità di S. Egidio ha già at-tivato corsi che prevedono il consegui-mento della certifi cazione linguistica.
Abbiamo interpellato Augusto Ve-nanzetti, uno dei coordinatori della Scuola di Italiano della CDS e tra gli organizzatori del convegno, è con-sapevole che non c’è ancora nel vo-lontariato una forte sensibilizzazione alla certifi cazione linguistica, proprio perché attualmente con la legislazione vigente non c’è l’obbligo di certifi care la conoscenza della lingua italiana per ottenere la cittadinanza.
La forza del volontariato
“La questione della certifi cazione non è completamente chiarita, al-meno per quanto riguarda le scuole italiane del volontariato. In un nostro recente convegno noi abbiamo chie-sto un sostegno a livello istituzionale , anche riguardo la questione della cer-tifi cazione. Oggi, se non vado errato, tra le associazioni di volontariato solo la Comunità di S. Egidio ha una cer-tifi cazione, la CILS, che nasce da una convenzione con l’Università di Siena. Anche noi, la seconda scuola di italia-no dopo S. Egidio, dovremmo essere coinvolti su questo tema. Ma la que-stione è ancora irrisolta perchè non potrei dire che noi siamo ancora effet-
Maurizio CattelanBidibidobidiboo, 1995
Scoiattolo tassidermizzato, tecnica mista58 x 50 x 50 cm
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
Franco VimercatiSenza titolo, 1986
6 stampe ai Sali d’argentoCm 373 x 42
Varese, Collezione Panza
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
21
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
tivamente interessati a questo aspetto. Tra l’altro non c’è ancora un interesse da parte degli studenti. Risulta da una nostra statistica che su questa massa di 13.000 persone all’anno intercetta-te per i corsi di italiano, quelli che poi arrivano alla certifi cazione sono molto pochi. È una percentuale molto bassa, anche perchè questo tema non è pub-blicizzato.
Gli stessi migranti alla fi ne fre-quentano questi corsi per esercitare il diritto di cittadinanza, per l’accesso ai servizi di base, per lavorare, per cer-care un’abitazione, per socializzare, ma non con una fi nalizzazione forte all’acquisizione di una certifi cazione. Attualmente con la legislazione vi-gente non c’è l’obbligo di certifi care la conoscenza della lingua italiana per
ottenere la cittadinanza. I requisiti sono altri. Si deve dimo-
strare per esempio di essere residenti in Italia da 10 anni. In un disegno di legge presentato recentemente si par-la di variare la durata obbligatoria di permanenza in Italia. Tutti quelli che fanno sostegno agli immigrati prima o poi impattano con il problema della lingua che è il problema centrale. Se uno vuole assisterli dal punto di vista legale o ambulatoriale, come facciamo noi, si accorge alla fi ne che il problema della lingua è importante. Ogni scuola di volontariato ha il suo metodo e que-sto comporta una grande ricchezza di offerta. Questa attenzione ai problemi pratici e a fi nalità concrete è uno dei motivi per cui non c’è la fi nalizzazione della certifi cazione.”
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
22
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
che la persona apprenda la termino-logia fondamentale e necessaria per il segmento lavorativo in cui è inserito. Abbiamo scoperto addirittura che ci sono istituti che fanno corsi di italiano in 8 ore. Il datore di lavoro si organizza in proprio. Ho visto pubblicità su in-ternet in questo senso. Conosco alcu-ne aziende che hanno provveduto in questo modo. Comunque non c’è un anello di congiunzione automatico tra
Il datore di lavoro si organizza
“Attualmente i cosiddetti “datori di lavoro” non richiedono la certifi ca-zione. Abbiamo scoperto, però, che alcune aziende si stanno organizzan-do per fare una sorta di mini corsi per un approccio alla lingua italiana. Non si tratta di veri corsi di lingua italiana. L’obiettivo è quello di fare in modo
Alighiero BoettiAutoritratto, 1993
Bronzo, sistema idraulico e dispositivo elettrico
Cm 205 x 90 x 60Collezione Agata Boetti
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
23
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
conoscenza della lingua e lavoro.”
Porte aperte agli studenti
“Come scuola abbiamo fatto una scelta. Non formiamo classi. Apriamo le porte e gli studenti entrano. Gli stu-denti sanno che al piano terra ci sono le classi avanzate e al primo piano si fanno, divisi in due classi, lezioni di primo impatto (alfabeto e pronuncia fonetica) e poi lezioni intermedie (au-siliari, genere e numero) Cose molto semplici. In questo modo gli studenti vengono quando vogliono. La lezione dura un’ora e mezza ed è divisa in 3 parti: nella prima si sviluppa l’unità di-dattica, la seconda è una sezione les-sicale e in una terza parte ci si concen-tra sulla conversazione. Il migrante ha un grande problema, quello che non riesce ad assicurare continuità nella frequenza perché deve sopravvivere. Succede che da noi arriva uno studen-te. Frequenta 3 o 4 lezioni. Poi sparisce per 3 settimane perché ha trovato un lavoretto da facchino a Ostia. Quan-do torna, se fosse stato inserito in una classe tradizionale con un programma didattico, avrebbe perso un certo nu-mero di lezioni. Per lui il salto signifi -ca la perdita della continuità. Nei CTP succede questo. Spesso si parte con classi complete e non si sa con quanti studenti si arriva alla fi ne dei corsi.
Nella nostra scuola anche se lo stu-dente sente per 3 volte la lezione sugli aggettivi, che comunque gli fa bene, farà poi cose diverse sulla parte lessica-le e di conversazione. Comunque esce con qualcosa in più. Questo è lo straor-dinario successo di questa scuola. E la folla di studenti ci dà la dimostrazione che il sistema funziona. Se avessimo più spazio riusciremo a raddoppiare il numero di partecipanti. Siamo stati costretti a mettere delle liste fuori per le prenotazioni. A differenza di altre realtà o della scuola pubblica qui non c’è una durata obbligata.
La certifi cazione linguisticacome gabbia
per la “scuola aperta”?
“Non ci siamo ancora posti in concreto il problema dell’adeguatez-za dei corsi. Con la fi nalizzazione alla certifi cazione linguistica si potrebbe pensare a una preparazione specifi ca. Si potrebbero diversifi care i corsi solo per gli studenti che hanno un interesse specifi co in questo senso. Attualmen-te ci preoccupiamo di fornire gli stru-
menti per un inserimento sociale e che lo studente possa interagire. Se invece la fi nalizzazione fosse la certifi cazione è chiaro che le esercitazioni dovranno mirare al superamento di quella fase. Sì, sarebbe possibile anche escludendo la situazione classe.
La certifi cazione, infatti, non pre-vede che il corso sia fatto in un de-terminato modo. È soltanto il supe-ramento di alcune prove. Quindi ogni associazione potrà raggiungere questo obiettivo a proprio modo, con i propri sistemi. Non è quello il problema rela-tivo alla certifi cazione
La nostra associazione insieme a una scuola pubblica, l’Istituto Manin, e ad altre 6 associazioni ha partecipa-to e vinto un bando regionale. È un progetto di insegnamento della lingua italiana a migranti diffuso sul territorio e diversifi cato per fasce orarie e giorni della settimana. In questo progetto c’è la possibilità di ottenere autorizzazio-ne a certifi care la competenza lingui-stica. Però come sempre non c’è una coerenza. Questi corsi sono di 40 ore. Non si può fare una certifi cazione su 40 ore. Ne servirebbero almeno 60. Quindi la certifi cazione che potrem-mo ottenere non sarebbe neanche un CILS, sarebbe un pre CILS, quello che chiamiamo un “livello impatto”.
La certifi cazione non è la nostra priorità. Il migrante ha anche delle passioni, degli hobby e noi cerchiamo anche di sviluppare questa parte. Que-sta è la ricchezza di ricerca che fanno le scuole di volontariato. Lo sforzo grande. Potremo dire che la scuola pubblica, i CTP, che fanno anche un la-voro eccellente, hanno un’attenzione più rigorosa sulla didattica. Mettono in campo la professionalità degli inse-gnanti. Nel volontariato probabilmen-te non c’è la stessa professionalità, ma c’è questa ricchezza della ricerca. Noi facciamo un po’ di tutto. Abbiamo or-ganizzato tornei di scacchi, cercando di sviluppare quella parte di interessi della loro cultura, ogni tanto li portia-mo fuori a fare i turisti per Roma. Ab-biamo organizzato partite di calcetto per i più giovani. E poi normalmente intrecciamo agli elementi propri della didattica elementi di conoscenza della cultura italiana. Analizziamo il sistema scolastico, l’ordinamento amministra-tivo, cosa signifi ca il Sindaco, il Comu-ne e poi ci sono le varie sessioni lessi-cali sui trasporti, sulla sanità e così via.
Ribadisco, quindi. La certifi cazio-ne non è il primo dei nostri problemi. Potrà esserlo un giorno se si porrà l’obiettivo della cittadinanza.”
INCHIE
STA CER
TIFICAZ
IONE L2
24
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
L a Scuola Luois Massignon è una scuola multietnica, nata a Roma nel 1983. Gli studenti iscritti ai
corsi provengono da oltre 100 pae-si. Qui non trovano solo un luogo di studio, ma accoglienza e amicizia.Dall’esperienza della scuola è nato anche un libro di testo, il corso di lin-gua italiana per stranieri “L’italiano per amico” che parte dalla convinzio-ne che uno degli elementi portanti di
ogni corso linguistico è la conoscenza del contesto culturale in cui l’immigra-to è immerso.
I corsi di lingua italiana per stranie-ri della Comunità di Sant’Egidio sono riconosciuti dal 1989 dal Ministero dell’Istruzione (L.1636/40). Gli studen-ti , dopo aver superato l’esame alla fi ne del corso annuale, acquisiscono un diploma riconosciuto presso le Uni-versità italiane ed estere come certifi -cazione di livello.
Dal 2008 la Scuola ha stipulato un accordo con il Centro di Valutazione e Certifi cazione Linguistica dell’Univer-sità per Stranieri di Perugia. Questo accordo consente agli studenti che hanno studiato almeno un anno pres-so le sedi della Comunità di sostene-re al termine del corso l’esame per la certifi cazione CELI, una certifi cazione, quella dell’Università per Stranieri di Perugia, riconosciuta a livello inter-nazionale . È un occasione in più per chi segue i corsi di italiano presso le sedi della Comunità di Sant’Egidio.La struttura dei corsi è rimasta inva-
riata. Non si è sentita l’esigenza di un cambiamento per adeguare le classi al nuovo obiettivo.
Già da qualche anno, infatti, la Scuola di Italiano Louis Massignon ha uniformato i metodi di valutazione ai li-velli e ai descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
L’accordo con l’università di Peru-gia, ha reso necessaria la formazione degli insegnanti. Il corso per formatori ha abilitato la scuola della Comunità di S. Egidio ad essere sede di esame per la certifi cazione CELI per la prova ora-le. I test per gli elaborati scritti, invece, vengono inviati alla scuola dal CVCL dell’Università di Perugia e successiva-mente corretti presso la loro sede.
L’attenzione ai temi della migrazio-ne e il grande lavoro sull’insegnamen-to della lingua ha reso la Comunità di Sant’Egidio molto sensibile anche
al tema dell’acquisizione della cittadi-nanza per gli stranieri che risiedono nel nostro paese.
L’ultimo progetto unifi cato di leg-ge prevedeva un accertamento dell’in-tegrazione sociale e linguistica dello straniero, probabilmente almeno di livello A2, ma non sono specifi cate le modalità di accertamento di questo li-vello di conoscenza della lingua.
Dal 2004 la Comunità di S. Egidio si è fatta promotrice di una proposta di modifi ca della legge sulla cittadinanza, in particolare per quanto riguarda i mi-nori che nascono in Italia da almeno un genitore regolare. Nel 2007 molte associazioni cattoliche hanno aderito a questa azione di sensibilizzazione portata avanti dalla Comunità di S. Egidio e hanno chiesto ripetutamente ai parlamentari di modifi care la legge, soprattutto nelle parti che riguardano la concessione della cittadinanza ai mi-norenni che nascono in Italia o che ar-rivano da minori, a condizione di aver completato qui un ciclo di studi. Si chie-de, poi, di abbassare per gli adulti gli anni di residenza da 10 anni a sei anni.
«Per noi imparare l’italiano è fondamentale, viviamo qui, vogliamo vivere qui, dobbiamo comunicare, per lavorare, per sapere, per trovare amici, per vivere»
Testimonianza di uno studente
della scuola di italiano della Comunità di S. Egidio
La Comunità di Sant’Egidio e il CELI
RICERC
HE
25
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
L’ UPTER, importante e consoli-data realtà romana nel campo della formazione, ha organiz-
zato il maggio scorso un convegno “La lingua italiana come passaporto per la cittadinanza attiva” dedicato all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, in particolare ad “immi-grati”. Nell’ambito dell’incontro, den-so di interventi interessanti, la prof.ssa Carla Barozzi, che da anni dirige il dipartimento Italiano per Stranieri dell’UPTER, ha posto l’accento su un argomento molto attuale e per noi di particolare interesse, vale a dire la fi gura del docente L2/LS nel quadro dell’educazione permanente.
In un contesto politico e sociale in cui un’opinione pubblica sovraeccitata equipara sempre più il termine “im-migrazione” a quello di “minaccia”, Fiorella Farinelli, esperta processi di li-felong learning, ci trova rassicuranti!
In un paese come il nostro, sostan-zialmente monolingue e che fa molta fatica ad entrare in contatto con altre lingue e culture, non è facile consoli-darsi, come dice Vinicio Ongini, esper-to per l’educazione interculturale del MIUR, su quella “via italiana alla scuo-la interculturale” (titolo del documen-to di orientamento prodotto dal MIUR ott. 2007) auspicabile e necessaria. Del resto, il numero di parole conosciute e usate da una popolazione pare sia direttamente proporzionale al grado di democrazia e di uguaglianza delle possibilità nonché dei valori democra-tico-costituzionali della stessa.
Gli “immigranti”, quindi, non solo andrebbero considerati quali impor-tanti “risorse”, ma accolti in modo da garantirne quello che, a detta di Au-gusto Venanzetti, coordinatore della Casa dei Diritti Sociali di Roma, è un essenziale recupero identitario; gli immigrati, infatti, devono poter man-tenere intatte le loro lingue e culture di origine, proprio e anche in virtù del loro stesso rappresentare nuove risorse di una realtà in continua evoluzione.
Un docente di italiano L2, ovvero di italiano in contesto italiano, si troverà nel corso della sua carriera ad avere a che fare con diversi tipi di discenti, ma è chiaro che l’urgenza della sua pro-fessione va a collocarsi su quello stesso binario percorso dal fl usso immigrato-rio che da qualche decennio riguarda la nostra penisola. I nostri studenti sono quindi soprattutto immigrati, adulti o bambini, in diversi contesti: la scuola (elementare, media inferiore o superiore), i CTP per l’educazione degli adulti, e vari corsi di formazione
professionale che prevedano l’inse-gnamento della L2. Una cosa è quasi sempre sicura: per lavorare bene in Ita-lia, bisogna imparare l’italiano, a meno che non si tratti di manager della FAO, o simili, che restano in Italia anche per anni praticando in ogni occasione il loro inglese e andando a costituire una sorta di frozen community, per dirla con Bracalenti, presidente dell’Ist. Psicanalitico di Ricerca Sociale, ma di
“alto livello” socio-economico.Gli immigrati con cui noi docenti
abbiamo spesso a che fare sono altri, sono quelle persone che hanno diffi -coltà a garantire la frequenza ai corsi, per lo stato di precarietà generale in cui si trovano al loro arrivo in Italia. Tra di loro si può trovare ad esempio, come è successo al sottoscritto, un mediatore culturale che, già da qual-che anno in Italia, si chiede quando smetterà di essere considerato un “immigrato” e comincerà ad essere una persona che vive e lavora in Italia. In questa situazione, per nulla sempli-ce per chi la vive, quali sono i compiti dell’insegnante?
Innanzitutto non si può prescinde-re dall’accoglienza, la prima cosa a cui un docente in genere, e in particolar modo un docente di L2 che si trovi ad operare in determinati contesti, deve dedicarsi. Il docente, come ha detto Anna Onorati della Caritas di Roma esprimendosi riguardo a laboratori per bambini, dovrebbe essere spesso e più che altro un facilitatore, prendere per mano i suoi allievi, farli parlare, avere informazioni su di loro per creare un buon ponte con ognuno, e questo non soltanto con allievi bambini.
Nei diversi metodi susseguitisi negli anni, il docente si è ritagliato
Il docente di italiano L2,tanti ruoli per una fi gura complessa
di Maurizio Masella
Ricerche
RICERC
HE
26
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
ruoli sempre diversi, da “maestro di cerimonia” (approccio deterministico e monodirezionale degli anni ’70) è diventato “counselor” (CLL), facilita-tore silente (silent way), organizzatore (project work), ma è in un sapere, e soprattutto in un “saper fare” olistico che risiede la sua professionalità. Lo studente è prima di tutto una persona, e il docente, che non può prescindere da questa totalità di “corpo-mente” nell’ambito di un approccio umanisti-co-affettivo, deve prestare attenzione alle varie “intelligenze”, saperle rico-noscere ed utilizzare in un contesto di cooperazione, in qualità anche di “organizzatore delle risorse”. Il docen-te è ora più di prima un “consulente linguistico” per alunni attivi che hanno consapevolezza del proprio percorso, e per questo la sua azione pedagogica deve essere dinamica e fl essiva.
Nell’ottica di quella che viene chiamata ricerca-azione, il docente di L2 si prepara di volta in volta per la sua classe, e ogni volta in modo specifi co, coniugando teoria e prassi didattica quotidiana, secondo il modello di Kemmins. L’insegnante “ricercatore” che pianifi ca, agisce, osserva, rifl ette e valuta, mira a un cambiamento che può essere attuato solo dal basso della prassi quotidiana, la quale, d’altro canto, non può che muoversi sempre in linea con la teoria. Interessantissimo, a tal proposito, l’intervento di Andrea Villarini dell’Università per Stranieri di Siena sulla possibile via ad una didattica acquisizionale.
Villarini ha parlato proprio della diffi coltà della linguistica acquisizionale, e quindi della ricerca
universitaria e scientifi ca, di adeguarsi alle realtà pratiche dell’insegnamento, e viceversa; basti pensare che la L.A. preferisce di gran lunga condurre le sue ricerche su campioni di apprendenti spontanei, a discapito di quelli appartenenti a contesti di apprendimento guidato, per una presunta maggiore attendibilità e “naturalità” dei risultati conseguiti con i primi. Per la ricerca, quindi, l’insegnante sarebbe una sorta di “manipolatore-distrattore” della competenza linguistica, ed eccoci “affi bbiato” un altro ruolo! Villarini, professore e ricercatore universitario, pronuncia parole “sante”: “affi nché sia possibile un punto d’incontro o di sintesi tra L.A. e didattica in classe, la ricerca universitaria deve ascoltare gli insegnanti, e non solo il contrario…”.
In una realtà educativa in cui si parla sempre più di classi CAD (Classi ad Abilità Differenziate) gli insegnanti devono essere anche “mediatori”, termine abusato ma quanto mai necessario, e rivedere strategie comunicative, strutture, lingua orale usata in classe, ecc., impegnandosi nella formazione continua (LL), aggiornandosi sull’uso di nuove tecnologie, acquisendo una solida base teorica insieme al famoso “saper fare”. Già, perché l’insegnante di L2, aldilà degli eventuali testi e manuali contenenti i cosiddetti “materiali autentici” che egli vorrà o dovrà usare in classe, ma che in ogni caso dovrà saper analizzare e scegliere, rimane, per dirla con Renzo Titone, l’unico elemento genuinamente autentico presente nella classe stessa. Fondamentale sarebbe quindi per lei/lui essere ben consapevole del suo idioletto, così come consigliabile sarebbe, a mio avviso, aver seguito almeno un corso di dizione, per non correre il rischio di costituire un elemento un po’ troppo autentico!
Per fi nire con l’argomento guida di questo numero, menzionerei un punto messo in evidenza da Massimo Vedo-velli, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, riguardante un atteggiamen-to critico da sviluppare nei confronti delle certifi cazioni: la certifi cazione ga-rantisce a chi ce l’ha di poter interagire con autonomia; non si può in nessun modo rischiare che il corso si riduca ad una sorta di addestramento fi nalizza-to all’ottenimento della certifi cazione stessa, anche perché “un conto sono i percorsi formativi, un altro gli esiti certifi catori”, e se lo dice di lui, che di certifi cazione se ne intende…
Luigi GhirriRimini 1977 da “in Scala”, 1977
17 stampe cromogeniche da negativo 24 x 36 mm
30 x 40 cm con corniceEredi di Luigi Ghirri
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzio-
ne, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
RICERC
HE
27
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
D ella durata di una partita di calcio, come è stato detto, il discorso pronunciato da Walter
Veltroni il 27 giugno 2007, nella “Sala Gialla” del Palazzo del Lingotto di To-rino, esposto di fronte ad una platea di leaders politici, militanti e gente co-mune e pronunciato per sciogliere le riserve sulla sua candidatura alla guida del nascente Partito Democratico, può considerarsi un discorso doppiamente fondativo: si pone all’origine sia del suo nuovo ruolo politico, sia dell’iden-tità di un nuovo partito.
Come tutti i discorsi politici fon-dativi, anche quello pronunciato da Veltroni in quella occasione si può ri-condurre alla narrazione di una sorta di “mito delle origini”: è strutturato in base ad una serie di enunciati de-stinati alla fi ssazione ideologica di principi presentati come fondanti e, al pari della narrazione mitica, risponde all’esigenza di darsi una spiegazione della realtà, delle proprie origini, dei propri valori per dominare e organizza-re il proprio universo di riferimento e offrire prospettive sul destino futuro di una comunità che, nello stesso tempo, concorre alla creazione del mito stesso e ne è la destinataria. Il linguaggio del mito, per sua natura oggettivo e collet-tivo, è un racconto esemplare, non più discutibile, che «abolisce la complessi-tà degli atti umani, dà loro la semplicità delle essenze, sopprime ogni dialettica, organizza un mondo senza contrad-dizioni perché senza profondità, un mondo dispiegato nell’evidenza, istitu-isce una chiarezza felice: le cose sem-brano signifi care da sole»1.
Organizzato secondo quella nar-razione naturale2, grazie alla quale si determina una sorta di patto comuni-cativo tra l’emittente e il destinatario del messaggio, che viene implicita-mente invitato «a credere che ciò che gli viene narrato sia effettivamente avvenuto nel mondo dell’esperienza reale»3, fi no a prova del contrario, il discorso fondativo si realizza secondo una struttura che Greimas chiamava del mascheramento oggettivante4 e che è funzionale all’autore nel mo-
mento in cui egli, al pari del racconto mitico, tende alla «fi ssazione di sistemi di valori della società che la politica si assume l’obbligo di realizzare»5.
Nel caso di Veltroni, egli preferisce il modello del “discorso congressua-le”, anche se di vero e proprio con-gresso non si è trattato: da un punto di vista della varietà diamesica «i discorsi congressuali sono solitamente molto lunghi e pronunciati sulla base di un
testo scritto di partenza ben struttura-to nella successione dei contenuti […]. Discorso orale, dunque, con alla base un testo scritto [caratterizzato] da al-cuni fattori concomitanti: l’assenza di contraddittorio, che consente di par-lare senza inferenze, vincoli e interru-zioni; il carattere unidirezionale della comunicazione, in quanto il pubblico ascolta senza interloquire; infi ne, ed è l’elemento più rilevante, la corposità materiale del discorso, in cui possono esprimersi compiutamente l’universo semantico e lessicale di ogni leader e, dunque, le sue specifi che scelte lingui-stiche»6. Sono queste le caratteristiche strutturali che permettono a Veltroni di dispiegare pienamente, in quei 97 minuti, l’identità “semiotica” della propria competenza politica. Landow-ski immagina la competenza come di-
di Maria Squarcione
Comunicare retoricamente: la “discesa in campo” di Walter VeltroniPrima parte
Fidem facere et animos impellere
1 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1957, trad. it. Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 1974, p. 224. 2 Ugo Volli, Manuale di semiotica, Roma-Bari, Laterza, 2000, p.1753 Ivi, p. 1734 Ivi, p.174: «la cancellazione dal testo di tutte le marche dell’enunciazione che possano far pensare ad una parzialità del punto di vista proposto. L’autore si nasconde dietro i fatti narrati e non appare mai in prima persona; di conseguenza i fatti sembrano raccontarsi da soli – donde l’uso di forme cioè impersonali, del “noi” nei discorsi scientifi ci, del presente di defi nizione ecc..»5 Ivi, p. 281. 6 Maria Vittoria Dell’Anna, “Lingua e nuova retorica politica”, in Riccardo Gualdo, Maria Vittoria Dell’Anna, La faconda Repubblica, Lecce, Manni, 2004, p. 45.
RICERC
HE
28
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
visa in due aspetti: «uno relativo alla “capacità” del soggetto, l’altro al suo “desiderio” di realizzare il programma dell’enunciatario-destinatore»7. Il pri-mo campo semantico, quello relativo alla capacità, può essere defi nito «col termine di credibilità, che riassume le modalità attualizzanti del “poter fare” e del “saper fare”. Il secondo ambito può essere invece espresso dal termine affi dabilità, che sintetizza le modalità del “dover fare” e del “voler fare”»8. Queste “azioni” si esplicitano tramite attivatori testuali che propongono la
costruzione discorsiva della compe-tenza del leader e Veltroni gioca quasi tutta la sua immagine sul modello del “dover fare” e del “voler fare”, cioè sull’ambito dell’affi dabilità. Questo modello si attiva fi n dalle prime battu-te del discorso del Lingotto: egli esor-disce con una serie di frasi impersona-li, espresse con infi niti iussivi9: “fare un’Italia nuova”, “riunire l’Italia”, “unire gli italiani”, “ridare speranza ai nuovi italiani”; e ancora, al sesto minu-to, “unire le culture e le forze riformi-ste”, “superare la parzialità”, “dar vita a una forza plurale”. Dall’undicesimo minuto in poi, fi no al ventesimo, una serie di espressioni con sfumatura ius-siva, coniugate al presente (pro futuro) o al futuro10: “il Partito Democratico dovrà saper corrispondere alle nuo-ve domande”; “l’Italia ha bisogno di crescita”, “l’Italia deve crescere, deve crescere e investire sulla sua competi-tività, sul talento e sulla creatività dei suoi ceti produttivi, sull’unicità della sua bellezza e della sua cultura”. Que-sto atteggiamento “volitivo” è teso alla costruzione di un’immagine affi -dabile, più coerente con il ceto politico della Prima Repubblica, che si avvaleva di uomini di apparato che, in quan-to tali, si proponevano come politici competenti e capaci. Ma la Seconda Repubblica, che inaugura un nuovo tipo di politico, l’”esperto”, il “tec-nico”, quello “prestato alla politica”, privilegia una tipologia della quale Berlusconi è l’esempio più evidente, perchè gioca la propria immagine pri-vilegiando l’aspetto del “saper fare” e del “poter fare”, come dimostra il suo discorso della “discesa in campo”: uno degli argomenti costanti per la co-struzione del contratto fi duciario con gli elettori è la nota polemica contro i “politicanti di professione”, che non hanno mai dimostrato di “saper fare” altro se non la politica, a fronte di chi, invece, ha dimostrato, come lui, di “saper fare” l’imprenditore e, perciò, di “poter fare” anche il politico con successo, di “poter” risolvere i proble-mi degli italiani.
continua…
7 Eric Landowski, La société réfl échie, Paris, Seuil, 1989, trad. it La società rifl essa. Saggi di sociosemiotica, Roma, Meltemi, 1999, p. 206. 8 Cristian Vaccari, “Personalizzazione della politica, competenza del leader e negoziazio-ne della fi ducia”, in Semiotica della comunicazione politica, a cura di Giovanni Cosenza., Roma, Carocci, 2007, pp. 82, 83. 9 Cfr. Luca Serianni, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti, Torino, Utet, 1988, p. 445: «L’infi nito presente può trovarsi in frasi affermative e negative di carattere impersonale (infi nito iussivo). Si tratta di un’alternativa dell’imperativo personale che si usa quando ci si rivolge a un pubblico in generale». 10 Ivi, p. 444: «Ha valore iussivo anche l’indicativo futuro che, a seconda dei casi, può fungere da variante attenuata rispetto al modo imperativo oppure può assumere il senso di un imperativo categorico».
Michelangelo PistolettoThe Cubic Meter of Infi nity
in a Mirroring Cube, 1966-2007Specchi, luci al neon, gesso
Cm 300 x 300Courtesy Galleria Continua, Pechino (2008)
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
ARTE
29
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
Maurizio CattelanAll, 20089 sculture - Marmo bianco di CarraraDimensioni variabiliCourtesy l’artista e Marian Goodman, New York
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
S i è inaugurata a Venezia il 27 settembre 2008 nella prestigiosa sede di Palazzo Grassi la mostra
Italics. Arte italiana fra tradizione e ri-voluzione,1968-2008. Una mostra che propone una puntuale panoramica della produzione artistica contempora-nea in Italia. La mostra curata da Fran-cesco Bonami rimarrà in esposizione a Venezia presso le sale di Palazzo Grassi fi no al 22 marzo 2009.
Per l’occasione è stato svolto dal curatore un lavoro molto complesso ed accurato di analisi e ricognizione dell’arte italiana dal 1968 al 2008 che come spiega lo stesso Bonami fu un “anno di svolta per l’Italia dopo il boom e per il mondo che per la prima vol-ta conosce una protesta globale”. La scelta delle opere da parte del curatore si concentra di conseguenza sugli ulti-mi quarant’anni di produzione artistica in Italia e ciò ha portato ad una precisa scelta espositiva. Sin dalle prime sale risulta chiara l’ispirazione di Bonami alla mostra del 1995 The Italian Me-tamorphosis, 1943-1968 presentata al Guggenheim Museum di New York e curata da Germano Celant.
Nelle sale di Palazzo Grassi vengo-no presentate le opere di oltre centro artisti italiani alcuni dei quali emer-genti, altri che avevamo addirittura di-
menticato che attraverso le loro ope-re raccontano le tante facce dell’arte italiana di quel periodo. Certamente tra gli intenti del curatore Bonami c’è da un lato quello di “celebrare qua-rant’anni di complessità e contraddi-zioni nel panorama artistico dell’arte italiana, dall’altro la necessità di rifl et-tere sul perché una realtà così ricca sia stata spesso sommersa dalle maree del
mondo dell’arte contemporanea inter-nazionale.”
Destinata a fare subito storia Italics è stata ancor prima di essere inaugu-rata, al centro di numerose polemiche rivolte in particolare al suo curatore ac-cusato di aver escluso artisti del calibro di Fausto Melotti, Nicola De Maria o Mimmo Paladino di fatto non presenti con le loro opere. Il vero nocciolo della
polemica in realtà è legato al fatto che una mostra del genere non sia stata organizzata da un vero e proprio mu-
seo o da una fondazione bensì da un collezionista privato, François Pinault che di fatto è anche il proprietario di famosissime griffe di lusso.
Tralasciando le polemiche, che del resto accompagnano sempre una grande manifestazione quando essa è destinata a far parlare di sé a lun-go, ed entrando nel vivo della mo-stra già all’esterno di Palazzo Grassi
di Linda De Santis
Italics a Palazzo Grassi, una mostra destinata a fare storia
Arte
ARTE
30
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
l’attenzione del visitatore è catturata dall’Autoritratto di Alighiero Boetti uno dei principali protagonisti dell’arte contemporanea in Italia. Proseguendo nella sala dedicata agli autoritratti ri-saltano su tutti quello di Piero Annigo-ni, opera molto contestata e quello di Salvo che di fatto si autoritrae come un nuovo Raffaello. Il notevole auto-ritratto di Francesco Clemente il quale si ritrae in disegno come un giovane con il pugno chiuso, è stato scelto da Bonami anche per la copertina del ca-talogo della mostra.
Il tema del ritratto e dell’indagine artistica attraverso l’uso del corpo è affi data a Vanessa Beecroft che con il suo Diario del cibo affronta il tema del dolore proponendo fi gure eteree e trasparenti che evocano drammati-cità e angoscia. Così come fa la gio-vane artista Margherita Manzelli che rifl ette sul tema dell’anoressia e su al-tri temi di grande importanza sociale affi ancandosi a Fabio Mauri il quale si concentra su altri temi scottanti quali il femminismo e la protesta sociale in arte. Tra le artiste italiane presenti ri-cordiamo inoltre Carla Accardi, Marisa Merz che stupisce proponendo Fonta-na, una sorta di vasca che rimanda ad un luogo dove viene generata la vita e Paola Pivi che scandalizza con i suoi celebri fondoschiena.
Il percorso espositivo prosegue con i grandi nomi dell’arte contempo-ranea. Al piano terra incontriamo All opera del 2008 di Maurizio Cattelan, mentre l’Arte Povera è rappresentata da Giuseppe Penone con il suo celebre Rovesciare i proprio occhi, e da altri grandi artisti come Merz, Pistoletto e Fabro. La Transavanguardia è felice-
mente rappresentata dalle opere di Cucchi, Clemente, Chia e dal Senza titolo di De Dominicis che si confi gura come un grande cubo di pirite posto all’interno di un sasso su cui sono sta-ti apposti dei segni in grafi te. Prose-guendo veniamo catapultati nel rosso sangue dei Funerali di Togliatti, celebre opera del grande Renato Guttuso al quale rispondono le opere dei giovani artisti Gianfranco Baruchello, France-sco Gennari e Massimo Grimaldi.
Come già detto, nella mostra ven-gono proposti temi di grande attualità oltre alla protesta sociale anche la ma-fi a viene indagata, seppur in maniera astratta, dal Cretto di Burri e palesa-ta nelle fotografi e di grande impatto emotivo di Letizia Battaglia. Infi ne sono proposte tra le sale di Palazzo Grassi i capolavori di Enrico Baj e di Lu-cio Fontana che stupisce sempre con un intenso quanto mai coinvolgente Ambiente spaziale.
Italics è l’occasione per rifl ettere su quanto sia stata, ed è ancora oggi, geniale e unica la produzione artistica italiana. Una mostra destinata a fare storia che pone nuove domande ma che soprattutto ha per protagonisti gli artisti italiani troppo spesso dimentica-ti alcuni talvolta ignorati e ai quali que-sta mostra sembra restituire di nuovo la giusta importanza.Italics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008Palazzo Grassi, 27 settembre 2008 – 22 marzo 2009Campo San Samuele, 323130124 VeneziaTel/ +39 (0)41 523 16 80www.palazzograssi.itInfoline: 199 139 139
Pivi PaolaUntitled, 2005
Stampa fotografi ca montata su alluminio93,5 x 142,2cm
Foto: Hugo GiendinningPivi Paola
Untitled, 2005Stampa fotografi ca montata su alluminio
95,5 x 143cmFoto: Hugo Giendinning
Pivi PaolaUntitled, 2005
Stampa fotografi ca montata su alluminio85,8 x 133,6cm
Foto: Hugo GiendinningPivi Paola
Untitled, 2005Stampa fotografi ca montata su alluminio
94,5 x 134,2cmFoto: Hugo Giendinning
Pivi PaolaUntitled, 2005
Stampa fotografi ca montata su alluminio99,5 x 148,8cm
Foto: Hugo GiendinningPivi Paola
Untitled, 2005Stampa fotografi ca montata su alluminio
88,5 x 142,5cmFoto: Hugo Giendinning
Courtesy Galleria Massimo de Carlo
Gabriele BasilicoContact, 1984
12 ditticiStampa a getto d’inchiostro
Cm 77 x 60 cadCourtesy Studio Guenzani, Milano
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
PENNE
ADOTTIV
E
31
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
Penne adottiveA mara Lakous, giornalista e scrit-tore algerino, vive e lavora in Italia dal 1995.
Ad Algeri si laurea in Filosofi a e ini-zia a lavorare come giornalista radio-fonico di Canale 1, la radio nazionale algerina in lingua araba.
Nel 1995 lascia la sua città natale perchè non si riconosce in quella cultu-ra e nel progetto sociale di quegli anni e arriva in Italia.
Qui si laurea in Antropologia Cultu-rale alla Sapienza di Roma e lavora alla sua tesi di dottorato dal titolo “Vivere l’Islam in condizione di minoranza. Il caso della prima generazione degli immigrati musulmani arabi in Italia”. Lavora come giornalista all’agenzia di stampa Adnkronos International a Roma e nel 1999 pubblica il suo pri-mo romanzo bilingue arabo/italiano “Le cimici e il pirata”, scritto ad Algeri nel 1993.
Nel 2003 pubblica in arabo in Al-geria il suo secondo romanzo “Come farti allattare dalla lupa senza che ti morda” che, riscritto in italiano, esce in Italia nel 2006 per le edizioni E/O con il titolo “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”.
Amara Lakous vince il “Premio Fla-iano” per la narrativa nel 2006 e il pre-mio “Racalamare-Leonardo Sciascia “ 2006. È il romanzo che, tradotto in inglese, francese, tedesco e olandese, diventerà un fi lm, attualmente in lavo-razione e nelle sale nel 2009. Il fi lm ha ottenuto il contributo del Ministero dei Beni e Attività Culturali per il ricono-scimento dell’interesse culturale delle opere prime e seconde.
La storia ruota intorno a un pa-lazzo della multietnica Piazza Vittorio a Roma. L’omicidio dell’inquilino più odiato e chiacchierato, Il Gladiatore, porta alla luce le storie degli abitanti del palazzo, degli ospiti, dei bottegai della piazza in una babele di lingue e di verità in cui si alternano tragicità e comicità. C’è Parviz, il cuoco iraniano, c’è Benedetta la portiera napoletana, ci sono l’algerino Abdallah e la badan-te peruviana Maria Cristina, c’è il pro-fessore milanese con simpatie leghiste e c’è soprattutto Amedeo, il convi-vente della professoressa che insegna italiano agli immigrati, il personaggio intorno a cui ruota tutto il romanzo.
Lei ha lavorato molto sul lin-guaggio. Il romanzo è un labo-ratorio di lingue e di stili. Come lo defi nirebbe?
È vero, è un laboratorio, diciamo così. nel senso lato della parola. Dove
c’è il giallo, ma non è solo un roman-zo giallo. C’è la commedia italiana ma non è solo commedia italiana. C’è il romanzo psicologico, ma non è solo romanzo psicologico. È un testo mol-to ricco con vari stili. Sono state date molte defi nizioni ma io non lo posso defi nire. Ci sono i critici e i lettori che lo possono fare.
A Piazza Vittorio ho vissuto i miei primi anni da immigrato. Lì ho im-
parato anche l’italiano nei corsi della Casa dei Diritti Sociali che aveva la sua sede lì alla ex Centrale del Latte. Sono molto affezionato a questo quartiere e per me Piazza Vittorio è la vera prota-gonista del romanzo. Così ho pensato che fosse giusto metterla nel titolo. È un titolo molto ironico, per prendere un po’ in giro questa teoria di scon-tro di civiltà che è diventata la teoria per spiegare i grandi cambiamenti del mondo dopo l’11 settembre. Non ho mai creduto nello scontro tra culture e civiltà. Lo scontro è tra interessi po-litici ed economici. Le culture non si scontrano. Le culture si amano, si con-frontano. Non c’è nessuna cultura che si è fatta le ossa da sola. Il processo è quello che gli antropologi chiamano acculturazione, quel processo per cui si acquisiscono elementi nuovi quan-do si incontrano due culture. C’è una nuova cultura che nasce perché ogni cultura rinuncia a qualcosa e acquisi-sce valori nuovi.
Che realtà descrive il romanzo? È una fotografi a esatta della re-altà o qualcosa di più?
Ho sempre creduto nella forza del-la letteratura che ha il grande pregio di raccontare non solo il passato e il presente, ma di raccontarci il futuro. I classici sono classici perché sono libri per tutte le epoche. Uno legge un ro-manzo scritto due secoli fa e lo trova di grande attualità.
Il mio romanzo ha avuto una gran-de accoglienza. È stato tradotto in in-glese, francese, tedesco, olandese. C’è
di Stefania Bucciarelli
Amara Lakous.Una babele di lingue, l’Italia del futuro
PENNE
ADOTTIV
E
32
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
stato anche un adattamento cinema-tografi co. Questo per me signifi ca che una realtà locale come Piazza Vittorio diventa una realtà internazionale. Piaz-za Vittorio non è più un quartiere a 5 minuti dalla Stazione Termini a Roma, ma è una realtà umana. E sarà l’Italia del futuro. Io ho sempre detto che se uno vuole conoscere l’Italia del futuro è suffi ciente che vada a Piazza Vittorio. Perché è il futuro nel bene e nel male. Nel male perché ci sono delle chiusure. Ci sono immigrati che vivono in Italia da tanti anni e non parlano italiano, per esempio. Io racconto questo nel ro-manzo. E ci sono realtà positive come la stessa Orchestra di Piazza Vittorio. Musicisti italiani e stranieri si confron-tano con diffi coltà, ma alla fi ne produ-cono arte, producono musica.
Nel romanzo emerge l’incomuni-cabilità, l’impossibilità di dialogo tra culture. C’è uno spazio per la speranza di cambiamento?
C’è una possibilità di dialogo. Per me l’incontro di culture è una grande opportunità, nonostante la realizza-zione sia tutt’altro che facile. C’è il mito della caverna nella “Repubblica” di Platone che, secondo me, descrive molto bene la paura del nuovo. Quan-do i prigionieri sono nella caverna vivono le loro certezze. Sono legati, vedono le ombre rifl esse del fuoco e credono che quella sia la verità. Quan-do uno di loro riesce a liberarsi dalle catene ed esce fuori, la prima cosa che lo colpisce è questa luce che gli fa male agli occhi. Dopo di che comincia a respirare aria fresca, guarda la gente che cammina, scopre il mondo. Quan-do torna a informare i suoi compagni della grande scoperta, loro rifi utano di uscire perché vogliono rimanere con le loro certezze. Io ho sempre messo in discussione queste certezze. Io dico sempre “ non ho certezze”. Mi piace sempre confrontarmi con nuove cultu-re. Per me è un grande arricchimento.
Il romanzo ha una struttura par-ticolare. È una sorta di diario in cui i personaggi raccontano la loro realtà e il protagonista, Amedeo, punteggia il racconto con i suoi ululati e la sua veri-tà. Che valore ha questo grido? Esprime il dolore del migrante?
L’ululato è intanto la metafora di Roma. È un grido, è il simbolo della lupa. Per me Roma è una città straordi-naria, è la mia città. Poi c’è la metafo-ra dell’ululato come grido isolato, non si sa bene se di gioia o tristezza. Ho
sempre guardato all’immigrare come a uno degli atti umani più importanti, più forti. Uno che lascia la propria terra alla ricerca di un futuro migliore è cer-tamente una persona che ha qualità, coraggio, voglia di cambiare e di es-sere padrone della propria vita, invece di rassegnarsi alla condizione della na-scita. Compie questo atto di volontà, di libertà straordinario. È come vivere due vite perché quando si parte si co-mincia una nuova vita. Non a caso nel permesso di soggiorno c’è la data di ingresso in Italia. Io quella data di in-gresso la considero una data di nascita. Quindi alla fi ne l’immigrato vive due vite. La vita precedente gli è stata data così. È nato in un determinato paese, è cresciuto in una determinata famiglia, ha imparato una determinata lingua. Poi quando arriva nel nuovo paese ri-nasce di nuovo e in questa rinascita ha tempo e possibilità di essere artefi ce della propria vita. Quando emigra ha la possibilità di scegliersi una nuova fa-miglia, una lingua, una patria. Questo è un fatto straordinario.
Leggendo il romanzo è inevita-bile il riferimento a Gadda. Si ri-conosce in questo confronto?
Per me è un onore essere accosta-to a Gadda ma per correttezza dico che io sono un bambino nella lingua e letteratura italiana. Ho 13 anni. Quin-di sono un minorenne, un nano, direi, sulle spalle di Gadda. C’è stata una re-censione di Marco Lodoli su “Repub-blica” dove si parla del libro, si fanno i complimenti per il titolo. Poi dopo si dice che questo romanzo non raggiun-ge le ginocchia di Gadda. Alcuni amici si sono arrabbiati. Io invece ho incon-trato Lodoli e l’ho ringraziato. Gli ho detto: “guarda mi hai fatto un com-plimento, perché vuol dire che, se non sono arrivato alle ginocchia di Gadda , sono arrivato ai piedi. Per me è un grande onore.”.
Diciamo che il paragone con Gad-da lo giustifi co con due cose. La pri-ma è la storia, il legame di Gadda con Roma. Questo milanese arriva a Roma e invece di fare il milanese e prender-sela con i mezzi di trasporto che non funzionano, con Roma ladrona, guar-da la città con un’altra ottica, cercan-do di capire la sua ricchezza, la sua profondità. Gadda viene da Milano, dal nord, io da Algeri e ci incontriamo a Roma. Abbiamo quasi lo stesso at-teggiamento. Cerchiamo di guardare oltre i pregiudizi. La seconda cosa che mi interessa in Gadda è il linguaggio. Io credo che un bravo scrittore debba
PENNE
ADOTTIV
E
33
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
avere la sua lingua e il suo stile. Gadda nel “Pasticciaccio” ha inventato una lingua. Io ho seguito il suo metodo, che è stato anche il metodo di Pasoli-ni, cioè di farsi aiutare da altre perso-ne, da amici per la scrittura delle parti dialettali. Per esempio per riscrivere le parti della napoletana mi sono fatto aiutare dai miei amici napoletani, fa-cendo delle domande molto precise, defi nendo anche le parti in cui interve-nire con il dialetto.
Lei ha scritto il romanzo prima in lingua araba e poi in italiano. Ha sempre fatto una distinzio-ne tra trascrizione e traduzione. Perché?
Ho sempre parlato di riscrittu-ra, non di traduzione del romanzo dall’arabo all’italiano, perché durante il passaggio tra le due lingue non ho mai usato un dizionario. Di solito un traduttore non ha la libertà di cam-biare il nome di un personaggio o di aggiungere delle parti alla storia. Io, come autore del libro, ho avuto que-sto potere. Ecco perché non è una tra-duzione. Inoltre sono stato molto for-tunato ad avere un editore come E/O che nasce nel 1989 per far conoscere autori dell’Est Europa in Italia, un edi-tore molto sensibile a questa ricchezza linguistica, a un certo modo di tradur-re. Mi ha dato larghi margini per speri-mentare questo italiano arabizzato. Io continuo a ripeterlo. Il mio italiano è un italiano arabizzato.
Quando ha iniziato a scrivere? Ci sono tre fasi nella mia attività
di scrittore. Nella prima mi sono con-centrato nello studio della lingua ita-liana. Sono stato molto avvantaggiato perché vengo da un paese francofono, l’Algeria, e il francese è la nostra se-conda lingua. Non ho avuto tante dif-fi coltà perché il vocabolario è lo stesso. Ho dovuto,però, lavorare molto sulla pronuncia anche perché io non ho la pronuncia francese.
La seconda fase è stata quella di tradurre in italiano. Ho continuato a scrivere in arabo e tradurre in italiano. Nella traduzione del mio primo roman-zo “Le cimici e il pirata”, nel 1999, ho fatto da consulente a un bravissimo traduttore italiano Francesco Leggio. In quella occasione Francesco tradu-ceva e mi chiedeva delle cose e io gli davo qualche suggerimento. Adesso, però, sono bilingue, sono arabofono e italofono. Diciamo quindi che l’ultima parte di questa seconda fase è stata quella di riscrivere in italiano.
Nella terza fase, quella attuale, scrivo direttamente in italiano. Infatti “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio” l’ho pubblicato prima in arabo nel 2003, ma poi l’ho riscritto io in italiano.
C’è comunque l’esigenza di scri-vere nella propria lingua madre. È per un senso di appartenenza al luogo d’origine, perché l’identità passa per la lingua dei padri?
Ho sempre considerato fonda-mentale questo aspetto della scrittu-ra quando si parla di letteratura della migrazione. Ho sempre detto che uno scrittore che scrive in italiano e non è italiano di origine, quando entra nella letteratura, quando entra nella lingua italiana non entra con le mani vuote. Entra sempre con un bagaglio lingui-stico precedente. Cerco un po’ di por-tare metafore, immagini, modi di dire della lingua araba nella lingua italiana e faccio anche il contrario quando scrivo in arabo. C’è una ricercatrice dell’università di Venezia che ha fatto una ricerca sul mio lavoro. Lei cono-sce l’arabo. Si chiama Maria Nigro e ha fatto uno studio comparativo sui due testi, quello in arabo e quello in italiano. La sua conclusione è molto interessante. Analizzando il linguaggio alla fi ne dice che io quando scrivo in arabo scrivo in un arabo italianizzato e quando scrivo in italiano scrivo in un italiano arabizzato.
Che rapporto sente di avere con la lingua italiana?
Un rapporto da fi glio adottivo. Sono stato veramente adottato dalla lingua italiana. È una lingua che mi piace molto. Adesso fa parte di questo mio equilibrio creativo. Io scrivo in due lingue. Ho trovato la mia strada, il mio stile particolare.
Si parla molto di letteratura del-la migrazione. Ci sono riviste on line che si occupano di questo. Ha senso questa etichetta?
Ho sempre cercato di non soffer-marmi più di tanto sulle etichette. Per me non è un problema. Però per sem-plifi care un pò questa nuova letteratu-ra, comunque, ha bisogno di defi ni-zioni. Anzi io considero la defi nizione “letteratura della migrazione” giusta per me. Per quanto mi riguarda la mia letteratura è una letteratura della migrazione perché la lingua araba im-migra nell’italiano e la lingua italiana immigra nell’arabo. La considero una defi nizione corretta per me anche se io
PENNE
ADOTTIV
E
34
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
vivo uno status amministrativo molto diverso. Io sono cittadino italiano da 3-4 mesi. Ho doppia cittadinanza. Or-mai ho due patrie, due lingue.
C’è però un grande problema quando si parla di letteratura della mi-grazione. Io ho spesso parlato di un rischio, quello di far diventare questa letteratura una letteratura di clown, una letteratura esotica con delle ricette ben precise. Per scrivere un romanzo della letteratura di migrazione ci vo-gliono delle condizioni, delle regole. Ad esempio i temi sono d’obbligo: il razzi-smo, la discriminazione con il rischio è quello di creare scrittori e scrittrici di moda. Vengono invitati in televisione, vengono rappresentati come modelli di successo, parlano italiano, sono bra-vissimi, scrivono, ricevono un sacco di complimenti. C’è questo rischio.
Io credo che la letteratura della migrazione abbia due contributi da dare. Il primo contributo è quello di raccontare la realtà con uno sguardo nuovo perché questi scrittori sono persone che vengono da altre realtà e molto spesso le persone che ven-gono da fuori hanno uno sguardo fresco, hanno una curiosità maggiore, hanno anche la voglia di conoscere il nuovo habitat. Il secondo contributo è linguistico. Loro non devono scrivere imitando .Sbagliano quando cercano di imitare gli scrittori italiani. Devono seguire la propria strada. Devono an-che dare voce alla loro creatività senza mai abbandonare le loro origini lingui-stiche perché sono una grande risorsa.
Quando leggo uno scrittore albanese mi piacerebbe trovare tracce della lin-gua albanese nei suoi scritti in italiano, proverbi, modi di dire, immagini e non trovare le minestre riscaldate, le meta-fore già fatte.
Lei ha lavorato come mediatore culturale. Chi è lo straniero oggi? E chi sono gli italiani?
Gli italiani sono impauriti. Sono impauriti dalla loro memoria che non conoscono, purtroppo. Io sono stato a New York alla fi ne di ottobre per presentare il mio romanzo in inglese. E quindi ho incontrato tanti italo ame-ricani. Sono andato anche a Little Italy. Mi hanno raccontato un sacco di storie. Dai loro racconti viene fuori una verità sconvolgente. Gli stessi pregiudizi che oggi ci sono nei confronti dei Rom, dei musulmani sono stati usati contro gli italiani. C’è un articolo del N.Y.Times del 1882 che racconta l’arrivo di alcuni immigrati italiani a N.Y e la cosa scon-volgente è che la stessa descrizione vale oggi per i Rom. Le donne erano sporche, i bambini cercavano nell’im-mondizia. Gli italiani sono impauriti da questo passato che oggi dovrebbe essere una grande risorsa per capire la realtà dell’immigrazione. Il rischio è quello della guerra tra poveri. Nel mio romanzo lo racconto molto bene. La portiera napoletana invece di prender-sela con il governo se la prende con gli immigrati. Ovviamente fa comodo an-che ai potenti di turno, al governo, ai mass media mettere fumo negli occhi.
Renato GuttusoI funerali di Togliatti, 1972
Acrilici e collage di carta stampate su carta incollata a quattro panelli di compensato
340 x 440 cmMAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna,
deposito permanente della Direzione Nazionale Democratici di Sinistra
Pino PascaliLa vedova Blu, 1968
Legno, pelliccia sinteticaCm 152 x 280
Vienna, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, prestito della Osterreichische
Stiftung LudwigMario Schifano
Compagni, compagni, 1968Smalto e spray su tela e perspex
Cm 200 x 300Courtesy Fondazione Marconi, Milano
Bruna EspositoOltremare, 2006
C-printCm 186,5 x 125
Milano, Federico Luger GalleryUgo NespoloMolotov, 1968
Inchiostro d’India e dattiloscritto su tela24 x 18 cm
Collezione dell’artistaFrancesco Gennari
Ascensione, 2004Legno, marmo bianco cristallino,
vetro, gusci di lumacheCm 95 x 95
Legnano, Collezione Guerciotti, courtesy Zero…, Milano
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
IN LIBR
ERIA
35
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
In libreriaGianluca Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Firenze, Alma edizioni, 2008, pp. 111, € 12,00Non sempre la comprensione delle singole parole che com-pongono una frase consente la comprensione del senso reale della frase stessa. Come sottolinea l’autore di questo testo, conoscere i modi di
dire di una lingua, nella loro unità semantica, può dunque consentire di migliorare la propria competenza comunicati-va attraverso il ricorso ad una lingua pratica, di immediata utilizzazione. Il testo si propone di soddisfare la curiosità di studenti interessati alla lingua viva e alle sue molteplici sfac-cettature ed è adatto sia a studenti di livello elementare che di livello intermedio e avanzato ( livelli da A1 a C2). Strut-turato in 14 capitoli tematici (corpo, cibo e bevande, spazio e luoghi, piangere e ridere, vita e morte, animali, religione, ecc.) il volume percorre la lingua italiana attraverso esercizi di presentazione, analisi e uso delle espressioni idiomatiche e delle forme tipiche del parlato. Il formato di piccole di-mensioni, la grafi ca semplice con pagine in bianco e nero, l’economicità del libro può essere usato come materiale di ausilio socio-culturale all’interno di un corso di lingua.
A. De Giuli - C. Guastalla, C.M. Naddeo, Magari!, Corso di lingua e cultura italiana, Firenze, Alma Edizioni, 2008, pp. 400, libro dello studente+ 2 cd audio, € 35,90Magari è un corso di lingua italiana per stranieri rivolto a studenti di livello intermedio e avanzato (dal B1 al C1 del Quadro Comune Europeo). È particolarmente indica-
to per quegli studenti che, già in possesso di una discreta conoscenza dell’italiano (livello B1), vogliano rinfrescare e perfezionare la loro competenza arrivando a un livello più alto (C1).Magari infatti affronta lo studio di forme, costrutti sintattici, stilemi molto diffusi nella lingua e generalmente poco trat-tati nei testi d’italiano per stranieri. Riprende inoltre argo-menti più elementari e già noti, inquadrandoli da un diverso punto di vista e con maggior approfondimento.Il corso si caratterizza per un forte taglio culturale, con divi-sione delle unità in cinque macro-aree tematiche (Società, Arti, Lingua, Storia, Geografi a), attraverso le quali viene de-lineato un profi lo ricco, articolato e non banale dell’Italia di ieri e di oggi, in grado di illustrare i fenomeni socio-culturali più signifi cativi e di rifl ettere le idee, le tendenze e gli stili di vita emergenti.L’impostazione grafi ca da rivista, con articoli, infobox, im-magini, schemi, approfondimenti, contribuisce a connotare il volume come un’opera nuova e assolutamente originale nel panorama dei manuali d’italiano stranieri.
L.Cusimano - L.Ziglio, Qua e là per l’Italia. Viaggio attraverso le regioni italiane, Firenze, Alma Edizioni, 2008, pp. 192, libro + CD audio € 20,00Il volume propone un percor-so attraverso le venti regioni italiane, presentandone usi, costumi, tradizioni, geografi a e cultura. Il testo si rivolge a studenti di livello intermedio (B1) che vogliano migliorare
le proprie conoscenze della lingua italiana e raggiungere il livello C1.In ogni capitolo vengono proposti testi autentici tratti da quotidiani, riviste, libri, siti internet e interviste audio che presentano aspetti peculiari delle singole regioni, al fi ne di invogliare il lettore ad approfondire la propria conoscenza della cultura italiana. Il percorso didattico prevede attività di comprensione scritta e orale, produzione libera sugli argomenti trattati e spunti di rifl essione su tematiche interculturali. Per ogni unità è previsto inoltre un ricco apparato di esercizi di revisione del lessico, della morfologia e della sintassi. Sono incluse le so-luzioni. Al volume è allegato un CD audio con 20 interviste a personaggi signifi cativi delle varie regioni.
Cittadini R. - Trotta M., Tutto bene! L’italiano in pratica, Milano, Hoepli, 2008, pp. 344, libro + CD audio € 28,00
Il testo prosegue lungo la linea di Benvenuto!, riprendendone l’approccio didattico e il per-corso narrativo. Tutto bene! è un corso di italiano come lin-gua seconda corrispondente al livello B1 del Quadro comu-
ne europeo di riferimento per le lingue. L’approccio didattico alla base dell’opera combina le componenti strutturali con quelle pratico-funzionali della lingua italiana. Tutte le abilità linguistiche trattate sono sviluppate ed esercitate all’interno di contesti pratici che ricreano situazioni comuni del mondo del lavoro e della vita quotidiana. Il percorso didattico è arti-colato in dieci unità, ognuna dedicata a specifi che funzioni espressive, con il relativo supporto strutturale e il necessario bagaglio lessicale. Una trama che lega tra loro le situazioni
di Tiziana Migliaccio
IN LIBR
ERIA
36
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
proposte nelle varie unità e il ricorrere degli stessi personag-gi rendono più coinvolgente l’apprendimento, aiutando lo studente a orientarsi in diversi contesti. Il corso è corredato di un CD-Audio con le registrazioni dei brani e dei dialoghi utilizzati negli esercizi. SommarioIl volume è composto da 10 unità didattiche, da un’ampia sezione grammaticale e dall’elenco, suddiviso per unità, dei vocaboli utilizzati.AllegatiIl CD-Audio allegato contiene la registrazione dei brani e dei dialoghi utilizzati negli esercizi.
C. Caglieris, Parliamo italiano. Lezioni di lingua italiana per stranieri. Milano, Hoepli, 2008, pp. 170, libro + CD Audio € 18,00 Parliamo italiano è un corso di lingua italiana per stranieri che vivono in Italia e che han-no una competenza linguistica di livello intermedio (livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Il testo, concepito per un pub-
blico ampio, tiene conto della frequente disomogeneità del livello di competenza linguistica degli studenti e, per la sua struttura, permette percorsi modulati in termini di svilup-po delle macroabilità linguistiche (ricezione orale e scritta, produzione orale e scritta, e interazione) all’interno di ogni unità didattica. Basato su un approccio comunicativo, il cor-so è organizzato in 10 unità e si articola su tematiche di interesse per chi vive e lavora in Italia, fornendo uno stimolo a discussione, rifl essione e confronto tra le diverse realtà di origine degli studenti. Ciascuna unità sviluppa contenuti e aspetti della grammatica attraverso letture esplorative o intensive, esercizi di scrittura e completamento, attività di ascolto, discussioni di gruppo e giochi di ruolo. In ogni unità, la sezione Lavoriamo sulla lingua of-fre un momento di rifl essione grammaticale sulle strutture linguistiche affrontate, mentre il Riepilogo grammaticale, con una serie di Esercizi mirati, permette una rapida ed esauriente consultazione e revisione delle principali strut-ture della lingua italiana. Completa il volume un Cd-Audio contenente ascolti ed esercitazioni.
Italiano: Pronti, Via! 1, Corso multimediale d’ita-liano per stranieri, a cura di: Gruppo lingua Coordinamento scientifi co: Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni, Perugia, Guerra Edizioni, 2008, pp.245, libro + 3 CD Audio, € 18,00 La caratteristica di questo cor-so è quella di coniugare un approccio comunicativo e una
grammatica intuitiva, dominanti nei corsi da anni, con una
serie di attività di sistemazione ed esercitazione grammati-cale e lessicale che hanno una forte validità, per equilibrare un’acquisizione “spontanea”e un apprendimento “razionale”. Il punto di forza è la sem-plicità di utilizzo sia per il docente che per lo studente.Il volume presenta 8 percorsi formati da tre unità a loro vol-ta divise in sei lezioni. Ogni lezione è un’unità di apprendi-mento della durata di un’ora e mezzo. Ogni unità contiene materiale per almeno 5 ore di lavoro. Ogni percorso forma un modulo autonomo che si conclude con un test. Alla fi ne del volume sono presenti una sezione grammaticale di rife-rimento e un’appendice con materiali (foto, testi, schede) da utilizzare in alcune lezioni.Nel sito www.guerraedizioni.com/italianoprontivia sono pre-senti altri materiali didattici, tra cui il dizionario multilingue dei termini usati nel testo e tutti gli audio in formato MP3.
Maria Angela Cernigliaro, STORIA, Testi e attività didattiche per stranieri. Livello inter-medio-avanzato (B2-C1), Collana L’Italia è cultura, Edilingua, Roma, 2008, pp. 30, € 7
Chi sono gli italiani? Dove vi-vono? Qual è il loro retroterra storico? L’intento di questa preziosa collana, è quello di
dare una risposta a questi e ad altri interrogativi per per-mettere allo studente straniero di orientarsi nella variegata realtà culturale italiana. L’Italia è cultura, ripartita in 5 fasci-coli monografi ci è suddivisa nelle seguenti tematiche: 1 – Storia 2 – Letteratura 3 – Arte 4 – Geografi a 5- Musica, teatro, cinema Il linguaggio semplice e l’abbondante materiale fotografi co, l’inserimento di attività di esercitazione e giochi linguistici, l’economicità rendono questo fascicolo monografi co un’ot-timo strumento didattico di supporto ad un corso tradizio-nale.
T. Marin – S.Magnelli, Nuovo Progetto italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, livello elementare,Roma, Edilingua, III ed. 2008, pp. 200, libro dello studente + Cd-Rom, €
20,30
Nonostante l’ampia diffusio-ne della precedente edizione di Progetto italiano 1, gli au-
tori presentano una Nuova edizione orientata alle teorie più recenti, al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e alle tipologie delle certifi cazioni italiane. Soprat-tutto questa edizione è frutto di una meticolosa revisione resa possibile dalle testimonianze sull’effettiva esperienza in classe degli insegnanti nell’uso di questo libro. Il libro appa-
IN LIBR
ERIA
37
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
re dunque più moderno dal punto di vista metodologico, costituito da un costante alternarsi di elementi comunicativi e grammaticali con l’intento di lasciare all’allievo il compito di scoprire quest’ultima, induttivamente.Il Libro dello studente si presenta arricchito di due nuove pa-gine per unità: una di attività preliminari, che ha lo scopo di motivare gli studenti attraverso varie tecniche di pre-lettura e pre-ascolto; l’altra di brevi attività di autovalutazione. Un lessico più coerente con il Quaderno degli esercizi, dialoghi più brevi e naturali, una maggiore quantità di brani audio l’introduzione di un Cd Rom interattivo, la grafi ca più mo-derna rendono questa nuova edizione effettivamente più aggiornata e più completa.
A. Chiuchiù – G. Chiuchiù, Italiano In, Guerra Edizioni, Perugia, 2008, pp. 256 libro + 2 CD Audio, € 34,00 Volume 1 - Livello A1/A2Il volume di Italiano in è composto da sezioni distinte: 7 Capitoli con: la presentazione di argomenti grammaticali e nozionali-funzionali, la comprensione del messaggio, la produzione guidata e la pronuncia, la sintesi grammatica-
le, le esercitazioni guidate, gli esercizi di completamento, la produzione di microdialoghi da svolgere in coppia, i modu-li per la comprensione e pro-duzione di modelli testuali, le prove di verifi ca periodica, le prove di certifi cazione CILS A1 e A2 e le griglie di autova-lutazione. La galleria fotografi ca con un dizionario attivo e spazi da compilare con le immagini e il vocabolario necessari agli stu-
denti. Il dossier dove raccogliere in modo autonomo i lavori più signifi cativi e datare il percorso di apprendimento. Cul-tura e culture con uno spazio da compilare per una breve rifl essione sugli aspetti interculturali. Le certifi cazioni dove raccogliere e datare i risultati delle prove di verifi ca periodica e degli esami di certifi cazione.Accompagnano il volume 2 cd audio per gli studenti, per le attività da svolgere autonomamente.Il volume nell’insolito formato del raccoglitore ad anelli è costituito da schede.
Enrico DavidBlack Lies, 2004-200514 partiTecnica mista su cartaCm 42 x 55Courtesy Galerie Daniel Buchholz, ColoniaEnrico DavidSign for Lost Mountaineers Hair Grooming Station, 2004Acrilico su compensatoCm 244 x 144 x 144Courtesy Cabinet, LondraEnrico DavidUntitled, 2004-2005Tecnica mista su cartaCm 42 x 55Collezione privataPhotocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
ESPERI
ENZE
38
Culturia
na anno
2 nº 3-
4/2008
Mario MerzSe la forma scompare,
la sua radice è eterna, 1982Tubi in metallo, rete e neon
Cm 178 x 452 x 25Collezione ARTIS
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
39
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08
Atti del Convegno Teatro e Didattica
delle Lingue Moderne tenutosi il 12 e 13 Dicembre 2008
presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di FrascatiTeatro e Glottodidattica: dalle improvvisazioni ludiche
alle formulazioni metodologichedi Carlo Nofri
Il teatro come comunicazione globale. Anche in un’altra lingua.di Caterina Cangià, Università LUMSA - Roma
Teledidattica dell’italiano a stranieri: il caso “In Italia” di Giuseppe Patota, Università di Siena / PLIDA e Isabella Donfrancesco, Rai Educationa
Verso la drammatizzazione. Osservazioni neuroscientifi che e rifl essioni glottodidattiche
di Paolo Torresan e Maria Simona Morosin
Glottodrama in progressdi Tiziana Jacoponi
A come Asinodi Gaia Mormina e Michela Nicolucci
Il lessico della storia attraverso il teatrodi Alessandra Pettinelli e Nicol Martini
Metodologia process drama e competenza interculturale di Erika Piazzoli
Il Teatro di Figura per l’insegnamento dell’italiano L2di Lucia Alessio e Pierangela Diadori
La didattizzazione del copione teatrale: un valore aggiuntodi Anna Comodi
41
47
49
53
58
61
65
69
74
79
Il presente progetto è fi nanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
40
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08
Nell’ambito del progetto euro-peo “Glottodrama” si è tenu-to a Frascati, nei giorni 12-13
dicembre del 2008 presso le Scuderie Aldobrandini, il Convegno Internazio-nale “Teatro e Didattica delle Lingue Moderne”. Dopo il saluto di benve-nuto delle autorità comunali, dell’Uni-versità di “Tor Vergata”, partner del progetto, si sono avvicendati relatori di stampo internazionale, accomunati dallo scopo di fornire un valido con-tributo intorno ad un tema conside-rato ancora pionieristico quale quello dell’emotività, del coinvolgimento e di tutte le sfere messe in campo durante una performance teatrale applicate e sfruttate per condurre su di un livello più partecipato e sentito lo studente di lingua. L’intento è quello di arrivare a formulare un metodo universalmente applicabile, in grado di abbattere, o quanto meno limitare le tradizionali barriere scolastiche, che nel caso degli
studenti di L2 sono amplifi cate dalla estraneità e dalla lontananza da un si-stema complesso qual è una lingua e una cultura altra. Le tecniche teatrali dunque costituiscono un modello di approccio partecipativo e ludico di in-dubbio interesse dal punto di vista di-dattico. Gli interventi hanno testimo-niato i risultati di esperienze condotte “sul campo”: alcuni mediante il sup-porto audio-video, hanno tentato di restituirne momenti e rifl essioni, altri, come l’intervento di Paolo Torresan, di natura prettamente esperienziale, hanno tentato con evidente successo di ricreare situazioni tipo, fornendo modelli riutilizzabili in contesti scola-tici. Riportiamo di seguito le relazio-ni prodotte, con la convinzione che questo potrà costituire una nuova ed interessante prospettiva con cui imma-ginare l’offerta formativa nell’ambito dell’insegnamento delle lingue stra-niere.
41
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08Cari colleghi, è con grande sod-disfazione che apriamo i lavori di questo primo convegno ita-
liano dedicato al tema dei rapporti tra risorse teatrali e glottodidattica. Se il tema non è certo nuovo dal punto di vista delle sperimentazioni sia in Ita-lia che all’estero, certamente nuovo è l’attuale scenario che vede fi orire abbondantemente queste sperimen-tazioni - defi nite globalmente e per comodità espositiva con l’etichetta di teatro glottodidattico - e nuova è la necessità di un confronto tra esperien-ze accomunate dal condiviso richiamo ad una pedagogia olistica e ad un ap-proccio comunicativo con un marcato orientamento umanistico-affettivo.
I temi da discutere in questi due giorni sono molteplici ma riconducibili ad alcune domande fondamentali di natura teorica con immediate ricadute sulla pratica didattica:
1. L’applicazione del teatro all’in-segnamento delle lingue straniere deve essere inteso come una tecnica didattica o come un’autonoma meto-dologia?
2. Quale peso hanno gli obiettivi psicologici e interculturali nell’applica-zione delle risorse teatrali all’insegna-mento linguistico?
3. L’insegnamento delle lingue straniere in che modo e fi no a che punto e deve tener conto degli aspetti paralinguistici e non verbali della co-municazione?
4. È possibile creare un sillabo procedurale che, senza ingabbiare la creatività della classe, soddisfi nel contempo l’esigenza di standardizza-re i programmi di apprendimento e di misurare in modo credibile ed affi -dabile i risultati raggiunti in termini di migliorata padronanza? (La costruzio-ne di un sillabo procedurale altamente predittivo e nuove forme di language testing orientate alla verifi ca della pa-dronanza dei mezzi espressivi orali e di adeguatezza agli scopi comunicativi)
5. Come armonizzare nel modo migliore la collaborazione interdisci-plinare tra docenti e saperi teatrali e glottodidattici? (le competenze inter-disciplinari possono essere riunite in un’unica fi gura o sono necessari più insegnanti? Il concetto dal quale par-tiamo di laboratorio teatrale e di “reci-tazione” in generale sono indifferenti rispetto all’approccio glottodidattico?)
L’applicazione del teatro all’in-segnamento delle lingue straniere deve essere inteso come una tecni-ca didattica o come un’autonoma metodologia?
Non vi è dubbio che molte espe-rienze di applicazione del teatro all’in-segnamento linguistico siano nate in chiave ludica e complementare rispet-to a corsi “uffi ciali” d’apprendimento.
Tuttavia su questa strada in certi casi si è andati così lontano da chiedersi, come ha fatto Caterina Cangià dopo l’esperienza pluriennale del laborato-rio per ragazzi “La Bottega d’Europa”, se questo non sia alla fi ne “il percorso più effi cace e divertente”, in altri ter-mini non “una metodologia” ma “la metodologia” per l’apprendimento di una lingua straniera. In Australia, pres-so la Griffi th University, Erika Piazzoli ha creato addirittura un corso di laurea basato su una metodologia, il “process drama” che utilizza un insieme siste-matico di tecniche teatrali con l’obiet-tivo di acquisire una competenza co-municativa interculturale. Tuttavia altri studiosi, come Pierangela Diadori, ri-tengono non del tutto corretto parlare di metodologia ma piuttosto di un’im-portante “tecnica olistica” che mette
di Carlo Nofri,
Teatro e Glottodidattica: dalle improvvisazioni ludiche alle formulazioni metodologiche
42
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 in gioco tutto l’individuo. Insomma il dibattito è aperto e la questione si de-fi nirà nel tempo lungo delle sperimen-tazioni e delle rifl essioni scientifi che a cui anche questo convegno vuole con-tribuire. Ciò che ci preme sottolineare in questa sede sono invece quattro specifi ci metodologici dell’apprendi-mento linguistico attraverso il teatro che emergono dall’esperienza con prepotente chiarezza. Specifi ci a loro volta terapeutici di due sindromi che rappresentano altrettante criticità di-dattiche.
Innanzitutto lo specifi co semi-otico. Tutti i codici segnici necessari alla comunicazione entrano in gioco e diventano materia d’apprendimen-to: linguistico, paralinguistico (aspetti sovrasegmentali e intonativi), cinesico (gestuale), prossemico (spaziale), ico-nico e musicale. Nessuno spazio viene lasciato quindi alla sindrome del gesto dimenticato, cioè alla sottovalutazione didattica del gesto e del corpo con-trapposti alla parola ed alla mente.
In secondo luogo uno specifi co pedagogico che in parte discende dal primo e cioè la natura necessariamen-te olistica dell’apprendimento in virtù della quale viene messa in gioco l’in-tera personalità dello studente. Oltre a questo va certamente enfatizzato anche lo specifi co neurolinguistico. Infatti in questo approccio apprendi-mentale vengono attivate le strategie cognitive di entrambi gli emisferi cere-brali, sia le modalità analogico-globali che quelle logico-analitiche. Ultimo, ma non per importanza, lo specifi co psicologico e interculturale sul qua-le vogliamo soffermare maggiormente la rifl essione cercando di rispondere al quesito successivo
Quale peso hanno gli obiettivi psicologici e interculturali nell’ap-plicazione delle risorse teatrali all’insegnamento linguistico?
La domanda ci introduce ad una questione che defi niamo con l’espres-sione sindrome della maschera invisi-bile. L’esperienza della recitazione te-atrale e quella dell’apprendimento lin-guistico, soprattutto negli stadi iniziali, hanno molti punti in comune. Innanzi-tutto entrambe hanno come obiettivo la performance comunicativa, l’attore di fronte ad una platea di pubblico, lo studente di fronte ad una platea socia-le. Così come l’attore spesso indossa una costume teatrale per segnalare al pubblico ed a se stesso lo status di personaggio, così lo studente “indos-sa” la lingua straniera, questo nuovo abito comunicativo e sperimenta un
nuovo aspetto della sua personalità. Può rappresentare un’esperienza psi-cologica densa di contraddizioni, se-gnata allo stesso tempo da una sensa-zione di estraneità, nei confronti della nuova lingua, ma anche di crescente familiarità. Frustrazione, imbarazzo e tensione ma anche gratifi cazione e crescita dell’autostima rappresentano lo scenario emotivo lungo il percorso dell’apprendimento di una lingua stra-niera.
In questo senso possiamo afferma-re che, soprattutto all’inizio di questo percorso, quando lo studente si espri-me in lingua straniera, tende a “reci-tare” ed a volte con evidente artifi cio. Agisce cioè in modo fortemente sor-vegliato razionalmente, cercando di conformarsi ad un modello normativo e mirando all’adeguatezza ed effi cacia della propria comunicazione attraver-so la personale interlingua che sta co-struendo.
Un fenomeno inevitabile, che deve essere accettato e legittimato dalla glottodidattica, poiché rappresen-ta un vissuto reale ed una necessaria fase di passaggio verso la naturalezza dell’espressione ed il dominio dello strumento linguistico. Ma questa criti-cità apprendimentale e comportamen-tale può diventare una risorsa da porre al servizio dell’apprendimento.
In realtà, come ben sappiamo, la stessa recitazione teatrale non mira a rendere credibile una fi nzione, a trave-stire di verità la falsità, ma a restituire attraverso la fi nzione scenica, la più autentica e profonda verità emotiva del personaggio. Finalità non dissimile da quella di una buona esperienza di-dattica che dovrebbe puntare sull’ac-quisizione della lingua straniera per liberare i bisogni comunicativi perso-nali dello studente e consentirgli un accesso autentico e creativo all’univer-so sociale della nuova lingua. Pertanto se lo studente che inizia lo studio della lingua straniera indossa i panni di un personaggio, di un altro “Sé”, indossa questa maschera temporaneamente. Durante il processo d’apprendimento si realizza, o dovrebbe realizzarsi, un complesso e progressivo passaggio psicologico dalla percezione della lin-gua straniera come “lingua di altri”, peculiarità di una estranea comunità di parlanti, alla percezione della L2/LS come “propria lingua”, come varietà del proprio bagaglio comunicativo da utilizzare anche in contesti fortemen-te colorati emotivamente, come quelli della sfera personale, nei quali è ne-cessario liberare creatività linguistica
43
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08e mettere in gioco la propria identità. Alla costruzione dell’interlingua sul piano cognitivo corrisponderebbe in-fatti un duplice piano psicologico nel-la percezione del “Sé”. Per dirla con Stanislavskij, si identifi ca una doppia traccia di coscienza: un “io” che parla nella lingua madre ed un “io attore” che parla nella L2/LS. Riteniamo tutta-via che questa maschera invisibile in-dossata dallo studente, e che spesso si manifesta come disagio e impaccio quando si esprime in lingua straniera - un vero e proprio collo di bottiglia grammaticale, lessicale ed espressi-vo - lungi dal dover necessariamente rappresentare un elemento di tensione emotiva e di ostacolo all’apprendimen-to, proprio con la “fi nzione teatrale” debba essere riconosciuta, accettata, materializzata ed esorcizzata. Nell’atti-vità teatrale è naturale diventare pub-blicamente “altro da sé”, diventare temporaneamente “personaggio”.
L’obiettivo interculturale ed espe-rienziale dovrebbe consistere nel ri-unire i due “io” e far cadere sponta-neamente nel tempo quella maschera trasferendo l’intera personalità dello studente nella nuova lingua e non soltanto alcuni aspetti di essa limitati a particolari domini d’uso. Ma poiché da ogni esperienza apprendimentale si esce un po’ cambiati, la costruzione dialettica di un nuovo “Sé” in questo caso può rappresentare una forma di arricchimento e dilatare, con lo svilup-po delle nuove abilità comunicative, i confi ni di un “io” in grado di parteci-pare ad un mondo più vasto di cono-scenze e relazioni umane.
L’insegnamento delle lingue straniere in che modo e fi no a che punto e deve tener conto degli aspetti paralinguistici e non verbali della comunicazione?
Non abbiamo parlato a caso di una sindrome del gesto dimenticato, allu-dendo con questa espressione a tutti agli aspetti paralinguistici e non verbali della lingua bersaglio di apprendimen-to. Tanta glottodidattica si è concen-trata sull’effi cienza comunicativa, cioè sulla coerenza dell’espressione con le regole del codice, ma molto meno sull’effi cacia pragmatica dell’atto co-municativo, cioè sull’orientamento allo scopo nella comunicazione.
Se dico ad uno studente Questa volta sei stato davvero bravo!, ciò può signifi care A) che voglio complimen-tarmi con lui per aver eseguito con successo un compito. Ma può signi-
fi care, applicando la così detta fi gura retorica dell’ironia, esattamente il con-trario, cioè B) non sei stato affatto bra-vo nell’eseguire il compito assegnato. Come posso capire quando l’enunciato ha il senso A) e quando ha il senso B)?. Innanzitutto in base al tono della voce ed all’espressione facciale, ma anche in base al contesto linguistico e situa-zionale. In altre parole posso decifrare il senso di questo messaggio soltanto se possiedo una competenza semio-tica, la capacità cioè di riconoscere e mettere in relazione i diversi codici che costituiscono l’atto comunicativo ed i loro riferimenti extralinguistici. Questa relazione non rappresenta una mera addizione quantitativa dei suoi costi-tuenti ma un prodotto qualitativamen-te diverso poiché l’intero atto comuni-cativo non è semplicemente la somma delle sue parti.
Pertanto la competenza comunica-tiva si confi gura come una competen-za complessa che incorpora anche una competenza specifi catamente semioti-ca e metalinguistica attraverso la quale siamo in grado di decifrare e produrre interazioni complesse tra i diversi codici di segni e di percepire la loro gerarchia funzionale. La natura spesso automa-tica e largamente inconscia di questo processo produttivo e recettivo da par-te dei parlanti nativi non deve farne sottovalutare la complessità di appren-dimento in sede glottodidattica.
Da questo esempio dovrebbe appa-rire chiaro come, i marcatori semantici non verbali siano decisivi in innume-revoli contesti d’uso della lingua, per codifi care o decodifi care un atto co-municativo Un laboratorio linguistico-teatrale si occupa o dovrebbe occupar-si proprio di questi marcatori semantici riequilibrando l’attenzione assegnata all’apprendimento formale delle regole del codice linguistico. Ciò eviterebbe il perpetuarsi di quel dannoso pregiudi-zio, duro a morire nella pratica glotto-didattica, che relega in secondo piano tutta la “non-verbalità” e la sua fun-zione nell’apprendimento linguistico.Ma questi marcatori sono altrettanto decisivi in una prospettiva pragmatica. Come ci ricorda Robert Di Pietro, usare una lingua signifi ca prendere conti-nuamente decisioni circa gli obiettivi, le strategie e le tattiche comunicati-ve. Naturalmente ci sono obiettivi più “semplici” che comportano decisioni strategiche e tattiche altrettanto sem-plici, ma vi sono anche obiettivi piut-tosto complessi che proiettano tale complessità sulle decisioni strategiche e le tattiche.
44
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 Così se l’obiettivo di Cristiano – nell’opera “Cirano di Bergerac” di Ro-stand – è quello di far innamorare la bella Rossana, la strategia (seduzione verbale) richiederà l’impiego di tattiche così complesse (discorsi amorosi) che il giovane e inesperto Cristiano dovrà far ricorso all’aiuto del magniloquente Cirano. Celeberrima è la scena nella quale Cirano, nascosto dietro ad un cespuglio, suggerisce bisbigliando le frasi da declamare al titubante Cristia-no in piedi sotto il balcone della trepi-dante Rossana. Un discorso amoroso ricco di metafore che rende stridente il contrasto tra l’effervescente ed appas-sionata creatività linguistica di Cirano e la piattezza recitativa di Cristiano che ripete le battute senza saper in-fondere un’adeguata forza espressiva. Una tensione comica tra contenuto e scopo della comunicazione sfruttata mirabilmente dal drammaturgo per la riuscita teatrale di questa scena.
È possibile creare un sillabo pro-cedurale che, senza ingabbiare la creatività della classe, soddisfi nel contempo l’esigenza di standardiz-zare i programmi di apprendimen-to e di misurare in modo credibile ed affi dabile i risultati raggiunti in termini di migliorata padronanza?
Una delle criticità che emergono quando si pensa di insegnare una lin-gua straniera attraverso risorse teatrali consiste nella tensione tra metodolo-gia e sillabo, vale a dire nella diffi coltà di individuare contenuti e traguardi certi dell’apprendimento per la natu-ra prevalentemente procedurale del sillabo stesso. La teatralità sia come laboratorio, e cioè drama, che come compiuta rappresentazione testuale, cioè theatre, si sviluppa necessaria-mente nella forma del project-work, o attività-obiettivo nella quale sono i tasks, cioè i compiti, a determinare i contenuti linguistici e non vice versa. I contenuti nascono dal fare lingua e dal fare attività teatrali e non sono imposti da un libro di testo.
Tuttavia poiché i sillabi procedu-rali corrono un rischio di incomple-tezza e parziale casualità a livello di contenuti grammaticali e lessicali, particolare cura deve essere posta nella scelta ed elaborazione di input linguistici e situazionali in grado di generare, con un alto grado di pre-dittività, tutti i contenuti linguistici oggetto dell’apprendimento. In altre parole, se la glottodidattica teatraleambisce a pensarsi non solo in termi-
ni di tecnica didattica ma di compiu-ta metodologia deve saper disegnare percorsi didattici con chiari obiettivi in termini di competenze acquisite corri-spondenti a descrittori misurabili con gli strumenti del language testing.
Altrimenti rischia di non incontrare le esigenze dei sistemi scolastici euro-pei e rimanere confi nato nell’ambito delle esperienze didattiche comple-mentari.
D’altro canto anche gli strumen-ti di misurazione delle competenze e di language testing, che forse in un prossimo futuro potremmo cominciare a defi nire di Communication testing, dovrebbero tener conto in misura cre-scente di questo concetto di compe-tenza comunicativa orientata al per-seguimento di scopi, fotografando in modo sempre più accurato anche le migliorate abilità pragmatiche.
Come armonizzare nel modo migliore la collaborazione interdi-sciplinare tra docenti e saperi tea-trali e glottodidattici?
Se applicare le risorse teatrali all’insegnamento linguistico signifi ca far incontrare due mondi del sapere e dell’esperienza pedagogica, tale in-contro ci pone subito davanti ad un bi-vio, ad una scelta: insegnante unico o pluralismo dei docenti? Sappiamo che non è comune per un insegnante pos-sedere questa duplice competenza, sia come specialista di lingua straniera che come docente di recitazione. Sebbene molti docenti oggi, soprattutto quelli di più recente formazione, abbiano spesso familiarità con tecniche didat-tiche, dalla drammatizzazione al role-play, che attingono al patrimonio delle attività teatrali, è piuttosto raro che abbiano fatto esperienze specifi che di formazione e tirocinio per la conduzio-ne di laboratori teatrali.
Del resto in termini generali, se vogliamo pensare ad esperienze di-dattiche professionalmente fondate, l’improvvisazione, pur basata sull’en-tusiasmo e la buona volontà, non rappresenta un criterio adeguato. Nell’ambito del progetto Glottodrama, ad esempio, abbiamo scelto la collabo-razione e la compresenza in classe di due docenti specializzati. Un’occasione di crescita professionale per entrambi, sia per il docente di recitazione che deve confrontarsi con le problematiche dell’insegnamento linguistico che per il docente di lingua che deve misurarsi con le dinamiche e le tecniche tipiche del laboratorio teatrale. Ne sta nascen-
45
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08do una sorta di “terzo sapere” una sintesi “in progress” tra i due bagagli professionali che rappresenta un valore aggiunto per tutto il progetto.
Ma soprattutto nel caso in cui l’esperienza si basi sulla collaborazio-ne di due o più docenti, è necessario stabilire una base teorica comune, una condivisione di principi peda-gogici che renda la collaborazione fl uida ed eviti contraddizioni e fri-zioni nella conduzione della classe.Ed a questo proposito non sembra indifferente, ad esempio, il concetto di “metodo di recitazione” da cui si parte. Senza entrare troppo approfon-ditamente in questioni oggetto ancor oggi di vivaci dibattiti, probabilmente la cosa migliore da fare per assumere un ragionato punto di vista consiste nel richiamare l’attenzione sull’obietti-vo glottodidattico che accomuna tutte queste esperienze di teatro applicato: apprendere a comunicare in lingua straniera. Ciò al fi ne di semplifi care la questione ed avere a disposizione un solido criterio di orientamento.
Ed a questo punto dopo aver sottolineato ripetutamente il comu-ne terreno di incontro tra teatro e glottodidattica, cioè quel concetto di “performance comunicativa” che rap-presenta l’elemento di convergenza interdisciplinare, è giunto il momento di richiamare anche la differenza fon-damentale, in termini di obiettivi, tra un corso professionale di recitazione e un corso di teatro glottodidattico: nel primo caso la fi nalità è quella di for-mare un attore affi nché rappresenti al meglio un personaggio altro da sé, nel secondo caso, quello dello studente, la fi nalità consiste nel metterlo in grado di rappresentare meglio se stesso.
Pertanto, senza prendere alcuna posizione defi nitiva circa il miglior me-todo per insegnare a recitare, la classica posizione di Diderot, ad esempio - che nel celebre “Paradosso dell’attore” cri-tica chi vive sul palcoscenico una vera emozione esperienziale perché questo ne disturberebbe la naturale e control-lata rappresentazione - sembra poco congruente con gli obiettivi del teatro glottodidattico. La sua idea che l’atto-re debba escludere dal proprio lavoro le emozioni e qualsiasi coinvolgimento personale durante la rappresentazione sul palcoscenico, indipendentemente dalla sua validità ed effi cacia nell’am-bito della formazione dell’attore pro-fessionista, sembra poco in linea con la necessità di liberare la spontaneità espressiva degli studenti “deintellet-tualizzando” un insegnamento tradi-
zionalmente già molto mediato razio-nalmente.
Questa la ragione per la quale, nel contesto del progetto Glottodrama, abbiamo scelto invece un approccio alla recitazione più “emozionalista”. Laddove Diderot affermava, e con lui una lunga tradizione che arriverà fi no a Brecht, la necessità di stabilire una distanza tra sé e il personaggio, abbia-mo ritenuto più utile al perseguimento del nostro obiettivo una teoria della recitazione che ponesse al centro il vissuto dello studente, la sua memo-ria emotiva, la sua verità, così come accade nella scuola di pensiero che da Stanislavskij giunge fi no all’Actors Studio di Lee Strasberg passando per la lezione fondamentale sul rapporto inscindibile tra mente e corpo della biomeccanica di Mejerchol’d.
Un approccio psicologista alla re-citazione che guarda anche ad altre esperienze signifi cative di teatro appli-cato, dal teatro sociale degli oppressi di Augusto Boal, allo psicodramma di Moreno così brillantemente enucleato nell’insegnamento linguistico da Ber-nard Dufeu con la sua Psicodramma-turgia Linguistica.
Le nostre scelte non sono state quindi neutre dal punto di vista ide-ologico e possono tutte essere ricon-dotte ad una sorta di “Pedagogia della liberazione” che pone lo studente ed il protagonismo suoi bisogni culturali e comunicativi al centro dell’azione didattica.
Conclusioni
Una trattazione sistematica di questo tema richiederebbe l’appro-fondimento anche di altre questioni di notevole rilevanza e che citiamo solo come proposta di discussione.
Come può ridefi nire e riorganizza-re lo “spazio classe” un’esperienza di teatro glottodidattico per abbattere la barriera tra mondo scolastico ad extra-scolastico, tra aula e vita?
Come sfruttare al meglio dal punto di vista interculturale la forza del testo “detto” e recitato nel quale si rivela sempre una cultura in azione?
Con quali criteri scegliere, elabora-re od autoprodurre testi drammaturgi-camente effi caci per la classe di teatro glottodidattico?
Rinviamo le risposte al dibattito ed al forum che apriremo dopo il conve-gno sul sito del Glottodrama.
Voglio concludere richiamando i due obiettivi principali di questo con-vegno:
46
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 a) contribuire ad aprire una specifi -ca rifl essione scientifi ca su questo ap-proccio didattico interdisciplinare
b) fare il primo passo verso la cre-azione di una comunità di operatori scolastici, ricercatori e docenti che metta in rete le esperienze nel campo del teatro glottodidattico.
Questo è lo spirito del progetto Glottodrama, una sfi da metodologica aperta al confronto ed al contributo di tutti coloro che ne condividono i prin-cipi pedagogici generali pur nella plu-ralità delle diverse esperienze.
“Il training dei sensi e delle emo-zioni dovrebbero essere una parte es-senziale del nostro sistema educativo, e le procedure e le scoperte per ad-destrare l’attore potrebbero rivelarsi di valore inestimabile a questo riguardo (…) Un problema ancora maggiore
che resta irrisolto nel nostro sistema educativo è quello della comunicazio-ne (… ). Il problema dell’espressione è stato trattato come un processo puramente meccanico che implica la voce, il linguaggio, la retorica, piut-tosto che un mezzo per condividere il proprio modo individuale di fare espe-rienza. Soltanto gli artisti sono riusciti a rompere questo muro usando la loro sensibilità e le loro capacità particolari nel comunicare le proprie esperienze. Tutti gli esseri umani hanno ancor più bisogno di questo, se la vita non deve ridursi a una recita di ruoli (…) È mia ferma opinione che le scoperte ed i procedimenti essenziali per la capacità dell’attore siano ugualmente necessa-ri, se non di più, per il profano…”
(Lee Strasberg, Il sogno di una pas-sione. Lo sviluppo del Metodo)
Carlo Nofri: direttore della rivista di linguistica Culturiana (www.culturiana.it) è laureato in Filosofi a del Linguag-gio e collabora come docente di glottodidattica con il Centro Estivo per Stranieri della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Autore di nume-rosi articoli e pubblicazioni sulla didattica delle lingue moderne, ha mirato le sue ricerche in modo particolare ai rapporti tra linguag-gio e pensiero (vedi “Linguaggio e Mental Imagery”, 1991, Prefa-zione di Tullio De Mauro) ed ai problemi della comunicazione e della glottodidattica. Ha coordi-nato il progetto pilota “Italnet” (Programma Leonardo da Vinci 1995/1998) e attualmente dirige il progetto multilaterale LLP Glot-todrama.
47
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08I l teatro è di per sé altamente mo-tivante. Maley, con toni entusiasti, dice di aver visto «raramente una
motivazione così forte come quella che si nota nei gruppi che lavorano con un insegnante capace in attività di dram-matizzazione» (Maley, 1983, p. 5). Sul versante del semiotico, il fare teatro, unendo alle parole le espressioni del viso, i gesti, gli oggetti, i tratti melodici della voce, e facendo accadere il tutto in un contesto strutturato e identifi ca-bile (grazie alla scenografi a, ai costumi e al trucco) è un contesto di immersio-ne totale nella comunicazione. Anche in un’altra lingua.
Varie sono le tipologie di teatro con le quali gli insegnanti di lingue dovreb-bero acquisire familiarità, a cominciare dal teatro di narrazione. Questo tipo di lettura, non solo trasforma le parole in immagini, il ritmo in emozioni, ma va-lorizza anche il divertimento e la spet-tacolarità della lettura, contribuendo ad aumentarne il fascino e stimolando la curiosità di leggere in prima perso-na anche in un’altra lingua. Nel teatro di narrazione, l’attore abbandona la convenzionalità del personaggio e si propone come persona narrante. Ciò che emerge è l’abilità nel raccontare, abilità fi nalizzata a tenere viva la con-centrazione dello spettatore-ascolta-tore e a instaurare un alto grado di complicità con lui. A tal fi ne, l’attore fa ricorso a strumenti propri della nar-razione più che alla mimesi del teatro, fl ashback, anticipazioni di particolari apparentemente insignifi canti, digres-sioni, citazioni, rettifi che e rifl essioni a posteriori, elementi che consentono un passaggio continuo tra il tempo passato dei fatti narrati e il tempo pre-sente dell’enunciazione dell’attore.
Un’altra tipologia è rappresentata dal teatro delle ombre. Un’altra ancora è quella del Teatrodanza che mette in scena in senso critico il vivere quotidia-no e opera un’analisi del ruolo del cor-po nella comunicazione interpersonale (Gurley, 1984). La pratica del teatro è un linguaggio che assume un valore altamente educativo e comunicativo. Oggi i bambini non si gelano più le mani nell’acqua dei ruscelli e non si lasciano pizzicare la pelle dall’erba dei prati. Conoscono poco la fi sicità del gioco perché hanno poco tempo da spendere a contatto diretto con l’espe-rienza. Il teatro può supplire alla man-canza di esperienza e poi invogliare a viverla in prima persona perché è un gioco serio per raccontare se stessi at-traverso la fi nzione scenica. Attraverso la parola, il gesto, il corpo, il silenzio,
il rumore, si attiva un percorso di nar-razione in cui il gruppo possa manife-starsi e riconoscersi, e in cui ognuno possa affermare la propria identità, in cui possa praticare, attraverso le bat-tute, un codice di comunicazione che non è quello materno.
Uno dei tanti risvolti positivi della didattica attraverso il teatro consiste nel fatto che questa felice forma di co-municazione prende in considerazione
l’apprendimento non solo tramite la trasmissione di informazioni, ma so-prattutto tramite l’esperienza, il con-fronto tra soluzioni diverse, la ricerca personale; favorisce la creazione di spazi per l’espressione, la manualità, la corporeità, superando la priorità data al lavoro individuale. Dà la possibilità a tutti di contribuire all’organizzazio-ne del lavoro e di assumersi respon-sabilità concrete. Il teatro considera il linguaggio come uno strumento per comunicare, per prendere coscienza della realtà e organizzare il pensiero e la conoscenza (Mirabella, 1983). Il pensiero e la conoscenza che si posso-no esprimere e comprendere anche in una lingua diversa dalla propria.
L’importanza del teatro nella di-dattica è legata alla natura del suo linguaggio, al suo «specifi co» che lo differenzia da altri linguaggi. La comu-nicazione teatrale si confi gura come una forma interattiva di linguaggi tra loro diversi: i linguaggi verbali e quelli non verbali, la mimica, il gesto, la pros-semica, la cinesica, gli aspetti prosodi-ci, il linguaggio iconico e il linguaggio
di Caterina Cangià, Università LUMSA di Roma
Il teatro come comunicazione globale.Anche in un’altra lingua
48
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 musicale. Proprio questa specifi cità derivante dall’interattività di vari codi-ci permette al teatro di caratterizzarsi come prezioso strumento formativo in vista di una migliore comunicazio-ne. Il teatro forma l’individuo per lo sviluppo di competenze comunicative/relazionali e creative, per il potenzia-mento della dimensione del sé come l’acquisizione di autostima e di fi ducia in se stessi. Il teatro migliora la comu-nicazione verbale e non verbale e con essa anche la comunicazione dinami-co-relazionale dei soggetti educativi
delle diverse fasce di età di sviluppo evolutivo (Cangià. 1998).
La magia del teatro consiste nello specifi co comunicativo che permette il coinvolgimento emotivo non solo del soggetto che recita e produce signifi -cati scenici (l’attore), ma anche degli spettatori. Cosa resta quando è calato il sipario?
È migliorata la comunicazione, la creatività, il lavoro collaborativo, il sen-so della troupe e l’impegno personale per una riuscita comune.
E questi restano.
BIBLIOGRAFIA
Cangià C. (1998), L’altra glottodidatti-ca. Bambini e lingua straniera fra tea-tro e computer, Firenze, Giunti.
Gurley V., Neuringer A. e Massee J. (1984), Dance and sports compared: Effects on psychological well-being, «Journal of Sports Medicine and Physi-cal Fitness», n. 24, pp. 58-68.
Maley A. (1983), A roomful of human beings, «Guidelines», n. 2, pp. 1-12.
Mirabella M. (a cura di) (1983), Fare teatro: guida completa alla pratica te-atrale, Roma, Gremese.
Caterina Cangià:ha conseguito un Dottorato in Scienze dell’Educazione con spe-cializzazione in Pedagogia per la Scuola e la Comunicazione So-ciale all’Università Pontifi cia Sa-lesiana. Ha fondato e dirige dal 1987 l’Associazione non profi t per l’insegnamento delle lingue “LA BOTTEGA D’EUROPA” (La-boratorio teatrale in Lingua Stra-niera con le Nuove Tecnologie). Dal 1992 dirige e coordina il Fe-stival di Teatro Didattico in Lingua Straniera. È docente stabilizzata presso l’Università Pontifi cia Sa-lesiana nella cattedra di Pedago-gia della comunicazione sociale e mediale, docente invitata presso la Pontifi cia Facoltà di Scien-ze dell’Educazione “Auxilium” per il corso “Nuove Tecnologie e processi d’insegnamento/ap-prendimento”, presso la LUMSA (Libera Università Maria Santissi-ma Assunta), Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, cat-tedra di Didattica delle Lingue Straniere. È membro dell’EARLI (European Association for Rese-arch on Learning and Instruction) e dell’ISAPL (International Society of Applied Psycholinguistics). Dal 2002 è membro della giuria in-ternazionale del Children New Media Prize. L’8 maggio 1999 le è stata conferita la “Mela d’Oro” dall’Associazione Marisa Bellisa-rio con la qualifi ca di pedagogista multimediale.
49
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08Negli anni in cui la televisio-ne cominciò a entrare nelle case degli italiani, la lingua
italiana veniva trattata con molto ri-spetto: lo dimostrano trasmissioni che hanno fatto storia, non solo in campo televisivo, ma anche in campo storico-linguistico e sociolinguistico. La prima fu Non è mai troppo tardi. Condotta dal famosissimo maestro Alberto Manzi, questa trasmissione contribuì a diffondere la conoscenza dell’italiano tra chi non aveva potuto frequentare la scuola dell’obbligo. An-che i conduttori di trasmissioni molto popolari, seguite nel corso degli anni da milioni d’italiani, come Lascia o raddoppia, Campanile sera, Il musi-chiere, Chissà chi lo sa, Portobello e altre, si preoccuparono di utilizzare un italiano parlato che non scadesse ai li-velli più bassi della spontaneità senza controllo, pur concedendo uno spazio sempre più esteso alla partecipazione del pubblico, e agli interventi non pro-grammati e non programmabili degli intervistati.
Fra tutte queste trasmissioni un posto del tutto speciale spetta a Paro-la mia, un gioco televisivo sulla lingua italiana condotto da Luciano Rispoli e “arbitrato” da Gianluigi Beccaria, che ebbe, negli anni Ottanta del Novecen-to, uno straordinario successo di pub-blico e di critica. L’obiettivo di Parola mia era quello di illustrare aspetti della lingua e della letteratura italiana in-trattenendo piacevolmente il pubblico, e fu un obiettivo pienamente centrato da Rispoli e da Beccaria.
Nel 1997 una televisione privata di diffusione nazionale, che allora si chia-mava Telemontecarlo e oggi si chiama La7, trasmise un programma sulla lin-gua italiana intitolato Il campionato della lingua italiana. Conduttore e consulente scientifi co del program-ma furono, rispettivamente, Luciano Rispoli e Gian Luigi Beccaria, cioè gli stessi personaggi che avevano anima-to, anni prima, Parola mia. Il program-ma era così organizzato: due giovani - arbitro il professor Beccaria - si sfi da-vano in una gara consistente in dieci domande sulla lingua e sulla letteratu-ra italiana; chi dei due rispondeva in modo esatto a più domande passava al turno successivo. Generalmente, ma non sempre, queste domande erano agganciate alla cronaca, all’attualità nazionale e socioculturale. Ogni pun-tata, che aveva cadenza settimanale, aveva per ospite un personaggio fa-moso, generalmente un attore noto al grande pubblico che, fra l’altro, legge-
va testi letterari sui quali Rispoli faceva una domanda e Beccaria discuteva in merito alla risposta, con osservazioni sempre molto originali.
In anni più vicini a noi, il direttore di Rai Educational Giovanni Minoli propo-se una nuova edizione televisiva di Pa-rola mia curata da Isabella Donfrance-sco; stessa formula, stessi protagonisti: Rispoli in qualità di presentatore, Bec-caria nel ruolo del professore di italiano
che tutti avremmo voluto avere. Trascorrendo rapidamente dal pas-
sato, sia pure prossimo, al presente, chiediamoci: che rapporto c’è, oggi, fra italiano e televisione?
A proposito del linguaggio usato, oggi, da chi comunica attraverso que-sto mezzo, possiamo distinguere alme-no tre varietà di italiano “televisivo”:
1) la prima varietà è rappresentata dalla lingua delle trasmissioni di infor-mazione e divulgazione politica, cul-turale o scientifi ca medio-alta: è l’ita-liano di programmi come TV7, Quark, Elisir, La storia siamo noi, La macchina del tempo, Passepartout, un italiano che, utilizzando una formula coniata da Francesco Sabatini, possiamo quali-fi care come “parlato serio semplice”;
2) la seconda varietà è rappresen-tata dall’italiano delle trasmissioni di intrattenimento, dai telequiz ai cosid-detti talk show, dai varietà ai cosiddet-ti reality show, un italiano di livello di-rettamente proporzionale alla qualità del programma che veicola: si va dal parlato sciolto e colloquiale di alcuni conduttori (i migliori) al parlato trascu-rato e sciatto del pubblico di trasmis-sioni come Uomini e donne o La vita in diretta o dei protagonisti delle varie edizioni del Grande Fratello, dell’Isola
di Giuseppe Patota, Università di Siena e Isabella Donfrancesco,RAI Educational
Teledidattica dell’italiano a stranieri:il caso “In Italia”
50
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 dei famosi e programmi affi ni; 3) la terza varietà è rappresentata
dall’italiano di quelli che un tempo si chiamavano sceneggiati o teleromanzi e oggi si chiamano fi ction, una varietà anch’essa molto differenziata al suo interno: si va dal “parlato formale” di Incantesimo (non sorprenda que-sta curiosa associazione, confermata dal fatto che anche la letteratura rosa è tradizionalmente più attenta alla norma grammaticale della letteratura senza aggettivi) al “parlato medio” di Un medico in famiglia fi no al parlato “quasi reale” di Un posto al sole o di Agrodolce .
Insomma c’è italiano e italiano, proprio come c’è televisione e tele-visione. La differenza di stile fra Elisir e l’Isola dei Famosi salta agli occhi di chiunque, e alle orecchie di chiunque salta la distanza che passa fra l’italiano garbatamente e ironicamente formale di Michele Mirabella e l’italiano inqua-lifi cabile – sia detto in senso etimolo-gico e non moralistico – di contesse promosse a opinioniste. Fra queste varietà si collocano poi oggetti ibridi, curiose contaminazioni come quella rappresentata dalla lingua di Paolo Bonolis, un miscuglio in cui parole ed espressioni dotte e arcaiche convivono con parole ed espressioni dialettali o intenzionalmente basse: una lingua che alterna espressioni come “prossi-manza costante”, “varieganza” e “la vita generalmente cambia traiettorie d’appoggio del pensiero” a espres-sioni sicuramente meno impeccabili come “lei ambiva alla tastata” e “ho la sensazione che ce l’abbiano posto da qualche parte”.
I tempi sono cambiati, e i gusti del pubblico anche. Sembra che non ci sia più spazio per insegnare l’italiano in televisione intrattenendo il pubbli-co. E invece le cose non stanno così: lo spazio c’è e il pubblico anche, ma è diverso rispetto a quello di Non è mai troppo tardi e di Parola mia. L’attuale destinatario ideale delle trasmissio-ni che hanno la pretesa, il desiderio, l’obiettivo di insegnare la lingua italia-na è, a nostro avviso, il pubblico degli stranieri residenti in Italia, soprattutto quei lavoratori immigrati nel nostro paese per i quali la conoscenza della lingua rappresenta uno strumento di integrazione indispensabile.
A costoro in particolare è dedica-to In Italia, un programma avviato nel 2007 da Rai Educational in collabora-zione con il Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di diffondere aspetti della storia, della geografi a, della so-
cietà civile e fi nalmente della lingua italiana fra i lavoratori stranieri stabil-mente residenti in Italia, creando pre-supposti per una nuova cittadinanza attiva e consapevole. In Italia è una do-cufi ction (la parola macedonia rende bene il carattere composito di questo esperimento, a metà fra il documenta-rio e la fi ction) che ha per protagonisti quattro cittadini stranieri che viaggia-no, nel corso di quaranta puntate, in venti città della provincia italiana e in venti capoluoghi di regione: Salif, Olga, Fela e Anna.
Salif è un uomo di circa 35 anni. È nato in Senegal dove ha vissuto fi no all’età di 23-25 anni, momento in cui ha iniziato a viaggiare in alcuni paesi europei. Ha fatto diversi lavori e solo da pochi anni è in Italia grazie a un pa-rente che è riuscito a fargli avere un permesso di soggiorno. Viene da un mondo polveroso e colorato, e non nasconde la fatica che ha fatto per in-serirsi in un mondo dai colori più sfu-mati e apparentemente più ordinato e asettico come quello europeo. Ama l’Europa ed è convinto che l’Italia sia la sua patria d’adozione, soprattutto dopo che ha conosciuto Olga e ha deciso di creare una nuova famiglia insieme a lei. Olga è una donna cro-ata sui 34 anni. Arrivata in Italia clan-destinamente, si è sistemata presso una famiglia italiana dove ha lavorato come badante. Dopo tre anni in Italia è riuscita a regolarizzare la sua posizione e a ottenere il ricongiungimento con la fi glia sedicenne, Anna. Ha un carat-tere dolce, e dissimula con eleganza una certa timidezza, forzata solo dalla curiosità. È stata lei a innamorarsi di Salif e a insistere perché la loro storia diventasse qualcosa di serio, un punto di partenza per costruire una famiglia. Da poco tempo i due sono sposati e sono alla ricerca di una nuova città in cui trovare un lavoro migliore e vivere come una nuova famiglia.
Fela è il nipote di Salif, fi glio di una sorella che non c’è più, e ora vive con lui. Ha 19 anni. Anna è la fi glia di Olga ed è venuta a vivere con lei in Italia. Ha 16 anni. Due dei tanti motivi di bat-tibecco tra i “fratelli” sono il calcio e la musica: uno impazzisce per la Roma e l’altra per la Juve; lei adora il metal mentre lui va matto per l’hip hop.
Per Fela e Anna il viaggio in Ita-lia è qualcosa di nuovo ed eccitante; rafforza il loro rapporto, nonostante i contrasti tipici della loro età. Per Olga e Salif le cose sono più complesse: mentre Salif dimostra curiosità e faci-lità nell’allacciare rapporti con diver-
Giuseppe Patota: professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università degli Studi di Siena-Arezzo e Direttore del Dipartimento di Letterature Moderne e Scienze dei Linguag-gi nel medesimo Ateneo. È so-cio dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana) e della SILBA (Société Internationa-le Leon Battista Alberti), nonché membro del comitato di redazio-ne della rivista “Studi Linguistici Italiani”. Dal 2004 è responsabile scientifi co della Certifi cazione PLI-DA (Progetto Lingua Italiana Dan-te Alighieri) e direttore scientifi co del Dizionario Italiano Garzanti. Si è occupato di lingua letteraria ita-liana sette-ottocentesca (L’Ortis e la prosa del secondo Settecento, Firenze, Accademia della Crusca, 1987), di sintassi storica dell’ita-liano (Sintassi e storia della lingua italiana, Roma, Bulzoni, 1990; Poiché fra causa, tempo e testo, Roma, Bulzoni, 2005), di storia della grammatica italiana (I per-corsi grammaticali, in Storia della lingua italiana, a c. di L. Serianni e P. Trifone, Torino 1993, vol. I; Ancora sulle Prose e la grammati-ca silenziosa, Milano 2001). Giu-seppe Patota si è inoltre dedicato alla didattica dell’italiano antico e moderno, rivolta in particola-re a studenti stranieri (Nuovi li-neamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2007, tradotta e pubblicata anche in Giappone per i tipi della Kyoto University Press; Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, Roma-Firenze, So-cietà Dante Alighieri-Le Monnier 2003; Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Mi-lano, Garzanti Linguistica, 2006). Recentissimamente ha pubblica-to, insieme a Norma Romanelli, il corso multimediale di italiano per stranieri Percorso Italia (Milano, De Agostini Scuola, 2008).
51
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08se persone nelle singole città, Olga è più cauta. C’è, in lei, il timore di non essere in grado di gestire la nuova fa-miglia allargata in un contesto inedi-to. Ma Olga rivela anche forza e ca-parbietà, sforzandosi di superare una sua naturale diffi denza e riluttanza. È lei che nelle città si appassiona a ciò che vede – piazze, musei, teatri, caf-fè all’aperto – e mostra entusiasmo, a differenza del marito più interessato al lato umano.
Fela e Anna entrano in contatto e “assaggiano” tutto quanto è mondo giovane, dalle palestre alle birrerie, dalle biblioteche ai ritrovi dei ragazzi. Sono attratti – com’è naturale – da quei riferimenti standardizzati delle città italiane: negozi, locali, e così via, per poi accorgersi di differenze e spe-cifi cità dalla lingua dei loro coetanei al modo di fare gruppo insieme. Nel cor-so delle puntate instaurano rapporti via via più intensi con i rispettivi nuovi genitori.
Girata, come si è detto, in quaran-ta diverse città italiane, la docufi ction si avvale del contributo di personaggi locali, che i quattro protagonisti incon-trano in molteplici situazioni, dalle più normali e ordinarie alle più bizzarre e straordinarie.
Ogni puntata della docufi ction è corredata da quattro pillole della dura-ta di cinque minuti ciascuna: Le parole dell’italiano, che offre agli utenti con-tenuti di tipo linguistico e comunicati-vo, Cartoline dall’Italia, che li introduce a una conoscenza storico-geografi ca della città visitata, La Bussola, che orienta e informa su dati e opportunità sociali e Le parole della Costituzione, che illustra alcuni principi fondamen-tali della Costituzione della Repubblica Italiana.
Prima di dire qualche parola in più sulla prima delle rubriche che accom-pagnano il programma, siano consen-tite alcune considerazioni di ordine storico e sociolinguistico. La ben nota “questione della lingua”, per secoli al centro del dibattito intellettuale ita-liano, non può considerarsi esaurita, ma solo mutata nei termini, nei con-tenuti e negli obiettivi: da questione letteraria che fu fi no all’Ottocento, essa è andata via via spostandosi su un piano più generale, investendo anche la società e la politica. A partire dalla seconda metà del XIX secolo essa si è concretizzata nell’obiettivo del “fare linguisticamente gli italiani”, del tutto (o quasi del tutto) realizzato un secolo dopo proprio grazie alla televisione. La sua versione d’inizio del nuovo millen-
nio (quella che potremmo defi nire la “nuovissima questione della lingua”, che segue di quarant’anni la “nuova questione della lingua” di cui discus-se Pier Paolo Pasolini nella prima metà degli anni Sessanta del Novecento) s’identifi ca soprattutto nel problema che segue: come favorire la conoscen-za e la diffusione della lingua italiana, premessa di qualunque possibile inte-grazione, tra i lavoratori stranieri che contribuiscono alla crescita economica (e anche demografi ca) del nostro Pae-se? Della questione si sono occupati, in successione, anche gli ultimi due Presidenti della Repubblica.
Il 24 settembre 2004, in occasio-ne della cerimonia di consegna dei diplomi di certifi cazione PLIDA presso il Palazzo del Quirinale, Carlo Azeglio Ciampi ha affermato: “La prospettiva di chi viene in Italia per studiare e per lavorare deve poter essere il conse-guimento della cittadinanza italiana. Dovrebbe essere possibile ottenerla in un lasso di tempo inferiore a quel-lo richiesto oggi, ma condizionato ad alcuni fondamentali requisiti. Il primo di essi non può che essere la cono-scenza, suffi ciente e certifi cata, della lingua italiana”. Due anni più tardi, nella premessa a un libro curato da Massimo Arcangeli e Alessandro Masi – un libro dal titolo parlante : Forma-re nei paesi d’origine per integrare in Italia – il successore di Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, ha sotto-lineato in prima persona la necessità di aiutare “cittadini di altri stati a in-serirsi nella nostra cultura, attraverso gli atti comunicativi più semplici, quelli che passano attraverso il buongiorno e la buonasera, parole che aprono e chiudono una giornata di fatica quoti-diana, accompagnata, forse, anche da qualche grazie ricevuto e dato”.
Noi crediamo che In Italia possa essere uno di questi aiuti.La parte spe-cifi camente linguistica del programma è costituita, come si è accennato, da una pillola intitolata Le parole dell’ita-liano, scritta sulla base dei materiali offerti dalla docufi ction. Puntata dopo puntata, si utilizzano le battute degli attori per costruire delle micro lezioni di lingua italiana i cui contenuti gram-maticali e le cui funzioni comunicati-ve fanno riferimento ai descrittori dei livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e all’inventario funzionale defi nito dal Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri per i livelli A1 e A2 dell’omo-nima certifi cazione. Occorre precisare che la corrispondenza non è sistema-
Isabella Donfrancesco: giornalista, autrice, regista, lavora in Rai dal 1987 dedicandosi a pro-getti culturali. Tra le trasmissioni di cui si è occupata: Parlato sem-plice, Tema, Parola mia, Passione precaria, Scrittori per un anno, Tv Talk, oltre a numerosi programmi dedicati alla diffusione della lin-gua italiana come Lemma, Navi-gare nelle parole, Calepio, Tecno-logie della lingua, Io parlo italiano e In Italia, coordinate in qualità di autore e di capo progetto. Prima di dedicarsi alla televisione, ha svolto per lungo tempo attività giornalistica ed editoriale, colla-borando a quotidiani e periodici (“L’Informatore librario”, “Paese Sera”, “Il Venerdì della Repubbli-ca” ecc.) e fi rmando traduzioni e cure di numerose opere, qua-li Tutti i racconti di Edgar Allan Poe, Iberia di Arrigo Boito e Dopo Montale.
52
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 tica, e soprattutto che non è totale: In Italia non è un corso di lingua italiana, ma un insieme di materiali di supporto offerti a docenti e apprendenti per ar-ricchire le loro possibilità di lavoro.
Ad ogni puntata di In Italia corri-sponde una serie di esercizi disponibili on line nel sito dedicato alla trasmis-sione. I contenuti linguistici e comuni-cativi di ogni puntata vengono ripresi per essere testati, consolidati e riappli-cati anche in contesti diversi.
Gli esercizi vanno intesi come un’occasione ulteriore di approfondi-mento offerta a un pubblico estrema-mente ampio. Per questo non possono tenere conto di tutte le specifi cità di apprendenti molto diversi tra loro per competenze, tipo di approccio alla L2, origine ecc.; né questi esercizi possono sostituirsi a una pratica di esercizio in classe che dia spazio ad attività colla-borative tra insegnante e apprendenti, e soprattutto tra apprendenti, for-nendo a ognuno suffi cienti occasioni di pratica e di negoziazione nella L2: essi si limitano, per forza di cose, a offrire allo studente altre occasioni di uso linguistico, ponendolo di fronte a strutture, strategie comunicative e compiti sempre adeguati a un certo livello di apprendimento (dall’A1 delle prime venti puntate all’A2 delle altre venti). Le attività proposte vanno dal riconoscimento di forme e strutture alla produzione, fermo restando che il meccanismo di correzione automatica non consente di mettere alla prova gli studenti in produzioni libere con rispo-sta aperta.
Il sistema automatico di verifi ca e correzione delle risposte fa sì che sia-no privilegiati esercizi strutturati, che prevedono univocità delle risposte: scelta binaria come il vero/falso, scel-ta multipla, abbinamento e incastro, completamento sulla base di una lista di soluzioni, cloze, individuazione di informazioni in un testo letto o ascol-tato. Tuttavia, anche nei casi in cui si è ricorsi a esercizi meccanici tradizionali
del tipo delle sostituzioni e trasforma-zioni, si è cercato di contestualizzare le frasi, riferendo l’intero esercizio a una stessa situazione oppure crean-do un rapporto dialogico tra stimolo e risposta. Anche in queste occasioni, abbiamo sempre cercato di arricchire la conoscenza, da parte degli studenti, della realtà socioculturale dell’italiano.
Trattandosi di acquisizione di una L2 a livello-base, molti dei dialoghi e dei testi proposti provengono da ma-teriali autentici successivamente riela-borati per adeguarli al supposto livello di competenza dell’ampio pubblico di In Italia; così si è proceduto anche alla ri-registrazione in studio di testi quali annunci ferroviari o brevi dialoghi, che non sono quindi totalmente autentici, ma assicurano una buona qualità e af-fi dabilità delle registrazioni ottenute.
In ogni serie di esercizi ce n’è al-meno uno basato su una scena tratta dalla puntata relativa di In Italia; esso è intitolato Guarda, ascolta e comprendi e consiste appunto nella comprensio-ne di una sequenza fi lmata, volta ad esempio alla fi ssazione di routine o di contenuti nozionali e funzionali: da come ci si saluta a come ci si presenta, da come si invita a come si accetta o rifi uta un invito, e così via.
Abbiamo menzionato il sito web dedicato alla trasmissione (http://www.initalia.rai.it/), e su questo chiudere-mo. Pensato per una lunga permanen-za dei materiali, quello di In Italia è un sito-vetrina che contiene in primo luo-go il videostreaming e i testi di tutti i prodotti televisivi, presenta la struttura e i percorsi dell’inventario delle funzio-ni comunicative, fornisce informazioni di servizio e collegamenti utili; infi ne propone, come si è detto, esercizi on line. Col che, si capisce, entriamo in un altro campo: quello dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’italiano non attraverso i media tradizionali ma at-traverso i nuovi media, internet in pri-mo luogo. Ma questa, come si dice, è un’altra storia.
BIBLIOGRAFIA
AA. VV. 2008 = AA. VV., Gli italiani del piccolo schermo, a cura di Gabriella Alfi eri e Ilaria Bonomi, Firenze, Cesati.
Ciampi 2004 = Intervento del Presi-dente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della cerimonia di consegna dei Diplomi di certifi cazione della Società Dante Alighieri a studenti stranieri, Roma, Palazzo del Quirinale, 24 settembre.
Cardona 1987= Giorgio Raimondo C., Introduzione alla sociolinguistica, Tori-no, Loescher.
Consiglio d’Europa 2002 = Quadro co-mune europeo di riferimento per le lin-gue, Milano, La Nuova Italia (trad. ital. di Council of Europe, Common Euro-pean Framework for Languages: Lear-ning, Teaching, Assessment, Council for Cultural Co-operation. Education Committee. Modern Languages Divi-sion, Strasbourg, 2001).
De Mauro 2002 = Tullio D. M., L’ita-liano nel mondo, in T. D. M., Massi-mo Vedovelli, Monica Barni, Lorenzo Miraglia, Italiano 2000. I pubblici e le motivazioni dell’italiano diffuso fra stranieri, Roma, Bulzoni, 13-22.
LId’O 2005 = “Lingua italiana d’oggi”, II-2005.
Marazzini 1999 = Claudio M., Da Dan-te alla lingua selvaggia, Roma, Carocci.
Napolitano 2006= Giorgio N., “Noi” e gli “altri”: verso un futuro di integra-zione e di convivenza, in AA. VV., For-mare nei paesi d’origine per integrare in Italia, a cura di Massimo Arcangeli e Alessandro Masi, con la collaborazione di Costanza Menzinger, Roma, Società Dante Alighieri, pp. 7.
PLIDA 2004 = La certifi cazione Plida (Progetto Lingua Italiana Dante Ali-ghieri), a cura di Giuseppe Patota e Lucilla Pizzoli, Roma – Firenze, Società Dante Alighieri - Le Monnier, 2004.
Vedovelli 2001 = Massimo V., La que-stione della lingua per l’immigrazione straniera in Italia e a Roma, in La que-stione della lingua per gli immigrati stranieri. Insegnare, valutare e certi-fi care l’italiano L2, a cura di Monica Barni e Andrea Villarini, Milano, Fran-co Angeli, pp. 17-43.
53
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
081. Movimento, corpo e cervello
Per comprendere come il movi-mento sia importante per l’ap-prendimento presentiamo gli
ultimi sviluppi della ricerca sull’Embo-died Brain, ovvero sul cervello inteso come intimamente connesso al corpo e illustriamo le circostanze in virtù delle quali mente e corpo creano signifi cato attraverso il movimento1.
1.1 Le mappe cerebrali e il senso del sé
La mente e il corpo sono collegati nell’elaborazione delle informazioni e danno vita ad un senso del sé che è incorporato (Embodied): un senso ag-ganciato, per così dire, al corpo e che esiste proprio perché può trovare nel corpo una dimensione che lo sostiene.
Questo è possibile in virtù del ruo-lo che il cervello ha nel rappresentare la realtà. Scrivono Blakeslee M. e S. (2007: 5):
“L’abilità di sentire, muoversi e agire nel mondo fi sico nasce da una ricca rete di mappe del cor-po fl essibili, distribuite in tutto il cervello - mappe che crescono, si riducono e si modifi cano a secon-da dei bisogni”.
Il cervello crea tali mappe del cor-po e dello spazio peripersonale.
Con questo termine intendiamo lo spazio di cui abbiamo bisogno per muoverci quando allarghiamo le brac-cia e le portiamo sopra la testa, dietro alla schiena o quando estendiamo le gambe, disegnando -in questo insie-me di movimenti- dei cerchi. Lo spazio peripersonale si allunga o si restringe in vicinanza delle persone, si estende fi no ad incorporare oggetti, come la forchetta con cui mangiamo o l’auto che guidiamo: questi oggetti diventa-no parte di noi, estensioni del corpo che la mente riesce a controllare an-che se manca il contatto fi sico diretto con l’oggetto (il cibo) o il luogo in cui stiamo agendo (la strada). Queste at-tività di Embodiment sono naturali e non vengono percepite consciamente: sono fl uide e intrinseche, parte del no-stro agire quotidiano.
Dichiarano ancora Blakeslee M. e S. (2007: 7):
“Una mappa può essere defi nita come uno schema dove si stabi-
liscono delle corrispondenze uno-ad-uno tra due cose differenti”.
Una mappa si crea attraverso la combinazione di informazioni prove-nienti da due vie nervose principali:
• una che veicola informazioni di carattere generale come il tatto, la temperatura corporea, e il dolore;• una che veicola informazioni
dettagliate, quali l’esatta posizio-ne nello spazio del corpo e delle sue parti.
Le informazioni provenienti dai sensi - a cui corrispondono precise mappature neuronali - si integrano per creare, appunto, il senso del sé nello spazio. È questo senso del sé che ci permette di muoverci, di agire sulla realtà, di imparare, di esprimere le no-stre emozioni e di comunicare.
1.2 Mappe, memoria e apprendimento
Le mappe del corpo e dello spazio peripersonale originate dal cervello sono capaci di riorganizzarsi. Forma-tesi durante l’infanzia, maturano con l’esperienza e continuano a cambiare durante tutta la vita, mediante proces-si di apprendimento che comportano una ristrutturazione della memoria.
Le mappe del corpo e dello spazio create dal cervello non sono separate da quelle del linguaggio, anzi, è pos-sibile pensare a reti che condividono tratti in comune (Just 2008).
L’apprendimento avviene, in so-
di Paolo Torresan e Maria Simona Morosin
Verso la drammatizzazione. Osservazioni neuroscientifi che e rifl essioni glottodidattiche
1 Pur se il saggio è stato ideato insieme, a Maria Simona Morosin si deve il primo capitolo, mentre a Paolo Torresan il secondo.
54
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 stanza, attraverso l’integrazione di tutte le informazioni che arrivano al cervello attraverso i sensi. Se uno stu-dente viene esposto ad un input multi-sensoriale -ossia un input non solo lin-guistico, ma visivo, tattile o sonoro che si incorpora nello spazio peripersonale attraverso il corpo-, impara di più: la sua rappresentazione nella memoria acquista in stabilità, perché è più di-stribuita e ridondante.
1.3 Linguaggio e movimento
Sostengono Blakeslee M. e S. (2007: 12):
“Il signifi cato è radicato nell’agen-cy, ossia nell’abilità di agire e di scegliere, e questa dipende dall’embodiment [dall’intima con-nessione tra mente e corpo, n.d.T]. Non esiste la coscienza fuori del corpo”.
A differenza di un robot, che può rispondere ai comandi ma manca della facoltà di incorporare la sua intelligen-za in un corpo e di sentire le emozioni, nell’uomo le mappe del senso di sé permettono di capire il mondo circo-stante, di muoversi in esso e di creare signifi cato.
Il linguaggio verbale è, in effetti, una capacità che va ben oltre i confi ni linguistici riconosciuti (comprensione e produzione di frasi o conversazioni): fa uso delle espressioni emotive e del mo-vimento per trasmettere un messaggio. Così che, quando ad una affermazione non corrispondono espressioni emoti-ve tipiche o la prossemica adeguata al caso, l’interlocutore percepisce la con-traddizione e categorizza il messaggio come non vero.
Un’ulteriore affi nità tra linguaggio e movimento si riscontra nella capaci-tà di anticipare gli esiti di un’azione. Come uno spettatore può intuire la mossa di un calciatore, mediante l’os-servazione della tattica, così, in una conversazione siamo in grado di pre-vedere, attraverso l’osservazione dei movimenti e delle espressioni facciali, cosa l’interlocutore abbia intenzione di dire ancora prima che pronunci una parola. Possiamo determinare il suo pensiero e il signifi cato principale del suo discorso osservando come si muo-ve nel suo spazio peripersonale.
Riassumendo, i gesti che accom-pagnano la comunicazione verbale
fanno parte del corpo che si muove nello spazio peripersonale e diventano un’estensione automatica e naturale del discorso (cf. Arbib 2006).
Quando affrontiamo lo studio di una lingua straniera, questi movimenti imbevuti di signifi cato aiutano il di-scente ad interpretare il messaggio e a creare mappe cerebrali comuni che distinguono quel dato signifi cato. A sua volta, le mappe create per la nuo-va lingua si integrano a quelle già esi-stenti2.
1.4 Imitazione e linguaggio
L’imitazione ha un ruolo molto rile-vante nell’apprendimento delle lingue, in quanto coinvolge aree comuni ai sensi e al linguaggio verbale e integra, quindi, informazioni senso-motorie e informazioni semantiche (Morosin 2007).
È possibile imparare un movimen-to e il signifi cato che ad esso corri-sponde attraverso l’osservazione, a cui è connessa la stimolazione dei neuroni specchio (Gallese et al. 1996).
Tali cellule si attivano non solo quando riproduciamo un certo movimento, ma anche quando vi prestiamo attenzione senza che alcuna azione abbia segui-to, o quando ascoltiamo il suono che si accompagna a quella tal azione. I neuroni specchio sono attivi, peraltro, quando viene scorta un’intenzionalità nell’azione, un signifi cato.
Pare che tali strutture siano indi-spensabili all’apprendimento, dal mo-mento che aiutano a creare tra le per-sone quelle mappe comuni del corpo e dello spazio, intrise di signifi catività (cf. Iacoboni et al. 2007). In altre parole, nel momento in cui un individuo imita il comportamento di un altro, riesce a farlo perché nella sua mente sono pre-senti mappe simili a quelle dell’altro.
L’apprendimento passa, perciò, at-traverso il corpo, avviene con il corpo. Di conseguenza, quando impariamo una lingua straniera attraverso tecni-che di drammatizzazione e imitazione, nel processo della memoria sono coin-volte sia le mappe del corpo che quelle specifi catamente dedicate al linguag-gio, in una combinazione personale e unica dell’esperienza, che non è più solamente linguistica, sensoriale o motoria, ma di signifi cato. A sua volta, tale signifi cato è frutto della somma e della rielaborazione delle informazioni linguistiche, sensoriali e motorie. Una
2 Esiste un certo grado di universalità nell’uso dello spazio e del movimento per esprimere signifi cato; tuttavia si dà anche un grado di diversità che il docente può presentare espli-citamente.
Paolo Torresan: si laurea in fi losofi a nel 1999, presso l’Università di Venezia, con una tesi dal titolo “Silenzi nella Bibbia ebraica”. Presso la stessa università segue un Master in Di-dattica dell’Italiano a Stranieri, dal 2000 al 2002 e successivamente, nel 2006, consegue il titolo di Dottore in Linguistica e Filologia Romanza. Dalla tesi di dottorato verrà ricavata la pubblicazione “Intelligenze e didattica delle lin-gue” (Emi, Bologna 2008).
55
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08memoria signifi cativa tende a rimanere più a lungo attiva e accessibile rispetto a memorie create attraverso l’uso di un solo canale sensoriale.
2. Osservazioni glottodidattiche
Nell’ambito della didattica delle lingue il movimento può essere intro-dotto a diversi livelli.
Una distinzione generale può esse-re tracciata tra le attività che compor-tano un uso estrinseco del movimento rispetto all’input linguistico (movi-mento libero), quelle in cui il legame tra messaggio e movimento è defi nito convenzionalmente (movimento as-sociato) e quelle in cui il movimento, invece, è correlato signifi cativamente all’input linguistico. Nei paragrafi che seguono valuteremo distintamente i tre ambiti.
2.1. Attività che comportano un uso estrinseco del movimento
rispetto all’input linguistico
Tra le attività che comportano un uso estrinseco del movimento rispetto all’input linguistico, rientra il cosiddet-to movimento libero, ovvero attività a carattere cinestesico slegate dalla lin-gua. Per esempio:
• movimenti previsti all’interno di attività ludiche (cf. Caon, Rutka 2004);• routine legate alla gestione della classe;• danze;• attività o dinamiche (cf. Feren-cich, Torresan 2005); • attività per promuovere la fi du-cia e la socializzazione (Trust Exer-cises, cf. Almond 2005).
Le attività di movimento libero ri-sultano gradite agli studenti il cui stile di apprendimento è cinestesico, che hanno cioè una particolare predile-
zione per la dimensione operativa, e che si sentono motivati ad apprendere ogni qualvolta è coinvolto del corpo.
Attività di questo genere risultano signifi cative, oltretutto, ai fi ni di:
• una promozione della socializ-zazione; • ridare energia al gruppo (alzano la pressione del sangue e il livello di adrenalina);• un abbassamento dell’ansia3;• un equilibrio neurofi siologico (anche il semplice stretching com-porta maggiore ossigenazione, a vantaggio dell’attenzione).
2.2. Attività che comportano un uso intrinseco del movimento
rispetto all’input linguistico
Con le attività che comportano un uso intrinseco del movimento rispetto all’input linguistico si passa dal livello dello stile di apprendimento cineste-sico (ovvero di preferenza accordata al linguaggio dei gesti), come avviene nelle attività di movimento libero, a quello dell’intelligenza cinestesica. In altre parole, si facilita una elaborazio-ne cognitiva complessa: il movimento non rimane più sullo sfondo rispetto ai contenuti (come, per esempio, nei movimenti previsti all’interno di attivi-tà ludiche), piuttosto traduce o antici-pa signifi cati: vi si salda signifi cativa-mente (cf. Torresan 2008)4.
Le attività che comportano un uso intrinseco del movimento rispet-to all’input linguistico possono essere suddivise in:
• imitazione • esecuzione• mimo• drammatizzazione5
In questa sede consideriamo solo le prime tre, che costituiscono una di-mensione propedeutica all’attività te-atrale vera e propria: all’allievo non è
3 “Many special-needs learners are stuck in couter-productive mental states, and move-ment is a quick way to change them” (Jensen 2005: 65). 4 Tale saldatura rispecchia una affi nità profonda tra linguaggio e movimento, sia a livello ontogenetico che da un punto di vista neuroscientifi co.
La lingua, difatti, nella storia di un individuo, procede per un lungo tempo a fi anco del linguaggio del gesti; si pensi alle ‘costruzioni verticali’ del bambino, ovvero alle singole parole che indicano azioni, oggetti o soggetti (papà, là, ecc., cf. Scollon 1978), o alle frasi birematiche che esprimono ordini e desideri (io bagno; luca palla, ecc.). Da un punto di vista neurologico c’è da notare che in tempi recenti si va sempre più met-tendo in luce l’intima comunicazione tra aree corticali: all’udire la parola ‘colpire’ o ‘calciare’ si attiverebbe non solo nell’area di Wernicke, deputata alla comprensione, ma anche aree legate al movimento (Pulvermüller et al. 2005).
5 Intendiamo per drammatizzazione un sinonimo di attività teatrale, secondo un’accezione ampia, che può coinvolgere anche l’improvvisazione. Per Balboni (1998), invece, la dram-matizzazione è intesa come l’equivalente della riproduzione di un testo.
Maria Simona Morosin:si laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Venezia Ca’ Foscari nel 2003, con una specializzazione in Linguistica Generale. Nel 2008 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Lin-guistica e Filologia Moderna pres-so la stessa università con una tesi dal titolo “Repetition in Lan-guage, Learning and Teaching”. Collabora con il Dipartimento di Linguistica Applicata dell’Univer-sità della California a Los Ange-les, dove tuttora svolge ricerca sull’acquisizione e l’evoluzione del linguaggio.
56
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 ancora richiesta una produzione, piut-tosto dimostra di aver compreso un messaggio mediante performance ci-nestesiche. Riteniamo così di far luce su una dimensione scarsamente esplorata nella didattica delle lingue, a fronte del-le numerose pubblicazioni che sono de-dicate, invece, all’attività teatrale vera e propria.
Consideriamo dunque, in primo luogo, le tecniche imitative. Nell’imi-tazione, il linguaggio non verbale ren-de trasparente il messaggio in LS, ne aumenta la comprensibilità. Si pensi alle attività del Total Physical Response Storytelling [TPRS]: l’insegnante narra una storia in LS, dando enfasi ai ge-sti che accompagnano il racconto. Gli studenti ripetono ogni gesto e ogni battuta.
Lo studente in diffi coltà può essere supportato, durante la riproduzione dei tratti segmentali e sovra segmen-tali della comunicazione, dal contribu-to corale del gruppo.
Un esempio ulteriore, sfruttato nel-la didattica dell’inglese, sono le Action Songs di Goodger (1999): attività di TPRS basate sul testo di una canzone.
Nelle attività di esecuzione l’allievo esegue ordini impartiti dall’insegnante o dai propri pari (Mastromarco 2005; Švecovà 2006). Gran parte di esse si ispirano al Total Physical Response, TPR (Asher 1977). Anche in questo caso vie-ne esercitata l’abilità di ascolto, senza che si richiesta alcuna produzione allo studente, bensì nel rispetto del periodo silenzioso6. Al di là di ordini fi ni a se stessi e privi di autenticità pragmatica (“vai alla lavagna”; “passa la penna a Matteo”, ecc.), tornano utili sequenze di comportamento che fanno capo a compiti complessi, come per esempio: riparare un oggetto meccanico, prepa-rare un piatto, ecc.
Il mimo, rispetto alle altre attività di uso intrinseco del movimento, com-porta maggiore presa di iniziativa da parte dell’allievo.
In gruppo si possono avviare atti-vità di mimo complesse, come il foto-racconto (Micarelli 1999) e il fotoclip
(Vianello 2001), le quali prevedono la trasposizione di testi (rispettivamente, il racconto e la canzone) in sequenze fotografi che.
Si tratta di attività fl essibili, che im-plicano una distribuzione dei ruoli e una negoziazione interna al gruppo(uno scambio, cioè, per stabilire quali foto-grafi e scattare, in che modo, ecc.) e si possono accompagnare ad una fase di produzione scritta (mediante la stesura di didascalie).
Il mimo, inoltre, può valere anche ad elicitare la lingua. In tal caso, an-ziché essere realizzato dagli studenti (che passano così dal codice linguisti-co a quello cinestesico), viene messo in atto dal docente, con la richiesta agli allievi di formulare il contenuto lingui-stico relativo ai gesti mimati: le battute dei personaggi, nel caso di un dialo-go (così avviene nella Ricostruzione di Conversazione, cf. D’Angelo, Zafara-na 2005) o della trama degli eventi, nell’ambito di una storia.
2.3. Attività che comportano un uso regolato del movimento
rispetto all’input linguistico
Nelle attività di movimento asso-ciato, lo studente compie determina-ti gesti, stabiliti convenzionalmente dall’insegnante in corrispondenza a determinati fenomeni linguistici.
Si pensi, a titolo di esempio, a gesti che accompagnano la pronuncia del-le lettere dell’alfabeto, oppure a una marcia che scandisce la suddivisione sillabica, oppure ancora a dei passi che segnalano le occorrenze di certi verbi (per esempio: un passo in avanti in corrispondenza ad azioni future, un passo indietro in corrispondenza ad azioni passate).
Oltre a una funzione analitica (tale per cui contrassegna fenomeni lingui-stici peculiari), il movimento associato può riguardare i contenuti e quindi valere come forma di verifi ca delle comprensione. Si immaginino, a tito-lo di esempio, gesti che equivalgono alle risposte di tipo vero/falso: un pas-
6 Scrive Luise (2006: 83-84): “Ogni persona esposta a una lingua nuova, inizia a compren-derla senza essere ancora in grado, o senza essere abbastanza sicura di sé, per parlarla: attraverso la «fase del silenzio» si passa anche quando si impara la lingua materna, per un periodo che ha una durata variabile da persona a persona.È un periodo importante non solo dal punto di vista psicologico ma anche da un punto di vista cognitivo: è infatti la fase nella quale il soggetto è impegnato ad identifi care, nel fl usso di suoni ai quali è esposto, parole ed espressioni, e a dare loro un signifi cato: solo quando ha identifi cato, riconosciuto, compreso e messo insieme una serie di espressioni, potrà sintetizzarle in una produzioni linguistica autonoma.Rispettare la fase del silenzio, non richiedere forzate e premature produzioni linguistiche autonome signifi ca rispettare i processi di apprendimento del discente e non porre le condi-zioni per l’innalzamento del fi ltro affettivo, per la perdita della motivazione, per l’instaurarsi di un sentimento di inadeguatezza verso la nuova scuola, signifi ca valorizzare i processi di comprensione, che tanta parte hanno in qualsiasi acquisizione linguistica”.
BIBLIOGRAFIA
Almond M., 2005, Teaching English with Drama, Keyway Publishing, Chi-chester.
Arbib M.A., 2006, Action to Language via the Mirror Neuron System, Cam-bridge University Press, NY.
Asher J. J., 1977, Learning Another Language through Action: the Com-plete Teacher’s Book, Sky Oaks, Los Gatos.
Balboni P. E., 1998, Tecniche didatti-che per l’educazione linguistica, Utet, Torino.
Blakeslee S., M. Blakeslee, 2007, The Body Has a Mind of its Own, Random House, NY.
Caon F., Rutka S., 2004, La lingua in gioco, Guerra, Perugia.
Ferencich R., Torresan P., 2005, Giochi senza frontiere. Attività ludiche per l’apprendimento dell’italiano, Alma, Firenze.
Ferencich R., Morosin M. S., 2008, Manuale di suggestopedia moderna, Guerra, Perugia.
Gallese V., Fadiga L., Fogassi L., Riz-zolatti G., 1996, “Action Recognition in the Premotor Cortex”, Brain, 119, 593-609.
Iacoboni M., Kaplan J., Wilson S., 2007, “A Neural Architecture for Imi-tation and Intentional Relations”, in Nehaniv C. L., Dautenhan K., (cur), Imi-tation and Social Learning in Robots, Humans and Animals, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge , 71-87.
Jensen E., 2005, Teaching with the Brain in Mind, ASCD, Alexandria, Vir-ginia.
Luise M. C., 2006, Italiano come lin-gua seconda. Elementi di didattica, Utet, Torino.
Mastromarco A., 2005 (cur.), Imparare l’italiano con il metodo TPR-Total Phy-sical Response, Giunti, Firenze.
Micarelli L., 1999, “Dalla letteratura al fotoracconto”, in Humphris C. (cur.), Uso dei testi letterari e cinematografi -ci, Dilit, Roma, 95-108.
Morosin M. S., 2007, “Mirror Neurons, Meaning and Imitation: Facts and Spe-culations on Language Acquisition”, Studi di Glottodidattica, 4 www.glot-todidattica.net.
Pulvermüller F., Hauk O., Nikulin V. V., Ilmonieni R. J., 2005, “Functional Links between Motor and Language System”, European Journal of Neuro-science, 21, 793-797.
57
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08so avanti se l’affermazione è vera, un passo indietro se è falsa.
Abbinamenti di questo tipo, movi-mento-parola, permettono una riten-zione delle informazioni più strutturata e stabile, per via delle mappe associati-ve complesse in cui la rappresentazio-ne dell’input linguistico si va confi gu-rando, in sinergia con informazioni di tipo visivo, sensoriale o auditivo (Saba-tano 2004; Ferencich, Morosin 2008).
3. Conclusioni
Mediante questo saggio abbiamo esplorato la connessione che avviene a livello neuronale tra movimento, ap-prendimento e linguaggio. In seconda istanza abbiamo presentato attività propedeutiche alla drammatizzazione, che possono risultare particolarmente effi caci ai livelli più bassi di apprendi-mento di una lingua straniera.
Scollon R., 1978, “Una fase realmente precoce. Riassunto informale di uno studio sul linguaggio” in Campioni L., Sviluppo del linguaggio e interazione sociale, Il Mulino, Bologna, 113-129.
Sabatano C., 2004, Come si forma la memoria, Carocci, Roma.
Švecovà H., 2006, Listen and Do, Ox-ford University Press, Oxford.
Torresan P., 2008, Intelligenze e didat-tica delle lingue, Emi, Bologna.
Vianello A., 2001, Il fotoracconto e il fotoclip, Tesi di Master, Università Ca’ Foscari, Venezia.
58
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 Premessa
A Paris l’insegnamento della lin-gua straniera è un servizio che è offerto agli studenti che fre-
quentano corsi di laurea in altre disci-pline tipo storia dell’arte o economia e diritto, non esistono quindi studenti frequentanti quadriennalisti o speciali-sti. Effettivamente non esiste neanche un dipartimento di studi italiani, ma
un servizio che si chiama SGEL (Service General Enseignement Langues).
Il secondo preambolo necessario è che gli studenti francesi o coloro i quali abbiano seguito un corso di studi nelle università francesi non sono abi-tuati ad una pratica orale della lingua in quanto più che d’orale vero e pro-prio si tratta di lettura ad alta voce di appunti scritti o memorizzazione degli appunti presi durante la lezione.
Il discente francese è abituato a scrivere è valutato per le sue compe-tenze scritte e non orali.
Quando al terzo anno d’università o ancora prima alla prova della matu-rità è interrogato oralmente lo studen-te, prepara un testo scelto dal docente lo legge ad alata voce lo traduce e poi in seguito lo commenta.
Questa premessa si rivela neces-saria per far comprendere che l’aver voluto instaurare all’interno del cor-so di studi il progetto Glottodrama è un’innovazione e sperimentazione as-solutamente rivoluzionaria nell’ambito della didattica e della pedagogia fran-cese per l’insegnamento della lingua straniera1.
Formazione e Criteri di scelta della classe Glottodrama
Sulla base del quadro europeo di riferimento dei livelli per la lingua
straniera ci si è accorti che sovente gli studenti hanno diffi coltà a passare dal livello A1 al livello B1 in quanto la tran-sizione per il livello A2 o viene ignorata o non risulta essere effi cace per il sal-to linguistico necessario ad acquistare tale competenza soprattutto a livello di produzione orale.
A Paris 1 vi è inoltre una diffi col-tà supplementare in quanto fi no allo scorso anno non tutte le facoltà preve-devano la frequenza annuale ai corsi di lingua ma solo semestrale.
Da alcuni anni il governo france-se e i ministri della Pubblica Istruzione francese hanno cercato di implemen-tare e rinforzare le abilità orali dei di-scenti anche attraverso la creazione di diplomi di competenza linguistica uni-versitaria (Daeu) che si vengono a so-vrapporre ai diplomi internazionali di competenza linguistica rilasciati dagli Stati Ad esempio il Toefl o Delf o Celi.
Assieme al direttore del diparti-mento SGEL, Professor Ghalib Al Ha-chack, constatato che il servizio rela-zioni Internazionali dell’Università non gestivano i programmi della sezione Long life training, ottenuta l’approva-zione del CEVU (Conseil de la Vie Uni-versitaire), l’assenso del Consiglio di facoltà e la fi rma del rettore abbiamo creato un corso Glottodrama dedica-to agli studenti di Paris1 che avessero studiato l’italiano almeno per un anno o che non lo avessero praticato da al-meno due anni. Le iscrizioni sono state libere e su domanda del discente.
Il gruppo Glottodrama è formato da 12 studenti di formazione diversa (3 studiano economia, 3 storia dell’ar-te, 1 fi losofi a e scienze politiche, 2 arti fi gurative) d’età diverse dai 19 ai 37 anni e di nazionalità diverse. Nel grup-po vi è anche una docente di tedesco, che desiderava sperimentare come discente il metodo per poterlo poi applicare nella sua pratica didattica. I maschi sono solo due.
La classe di controllo è più numero-sa. Raggiunge, infatti, le ventidue uni-tà, ma anche qui la presenza maschile è minima (un solo studente). Quasi tutti sono iscritti al secondo anno e non ci sono grandi differenze di età.
Nella fase intermedia al primo se-mestre il confronto con la classe di controllo sarà fatto con gli studenti dello stesso livello A2.
di Tiziana Jacoponi
Glottodramain progress
1 Queste rifl essioni metodologiche didattiche non si applicano al Fle ( francais langue etrangere) che segue invece pedagogie e metodologie più innovative e che privelgia un approccio orale e in situazione della lingua straniera ma tali tecniche sono riservate solo agli studenti stranieri o sono applicate nell’ insegnamento della L2 da docenti che abiano avuto un percorso di formazione che comprendesse l’ insegnamento del FLE o nelle classi di supporto o all’ estero.
59
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08Struttura della lezionedi Glottodrama
L’aula è dotata di computer, schermo e video proiettore, lavagna luminosa, lavagna tradizionale. La cattedra e banchi devono essere ac-catastati. L’area stage è cosi delimitata dalle sedie disposte in circolo, mentre l’angolo grammatica da alcuni banchi sistemati in modo da favorire il lavoro di gruppo.
La lezione e un’unita didattica cir-colare composta di varie fasi: riscal-damento role play, grammar corner e drammatizzazione è messa in pratica dal docente in perfetta sintonia con l attrice.
Durante le fasi preparatorie e pre-liminari del corso con l’attrice aveva-no individuato una serie di diffi coltà grammaticali e sintattiche su cui far la-vorare i discenti per portarli ad un loro coinvolgimento attivo e a farli diven-tare attori protagonisti del processo di apprendimento secondo la metodolo-gia dell’apprendre a apprendre.
Di comune accordo con l’attrice, ci siamo serviti di input autoprodotti dagli studenti al fi ne di migliorare le loro abilità orali. Bisogna, infatti, tener conto della scarsa abitudine dello stu-dente francese alla produzione orale, per questo motivo il primo obiettivo è stato quello di familiarizzarsi, prendere la parola attraverso la pratica dell’im-provvisazione teatrale.
In genere la lezione comincia con esercizi di riscaldamento teatrali: le pri-me frasi sono pronunciate in gli occhi chiusi; poi, a turno, ognuno ripete la frase di un altro e/o vi aggiunge un ge-sto. Dopo questa prima fase di brain storming per vedere se tutti hanno ca-pito oppure se vi siano stati messaggi poco chiari, si procede con l’autocor-rezione.
L’elemento di correzione e ripas-so grammatical-lessicale si introduce, come si vede, naturalmente nel pro-cesso teatrale. Ad esempio, sulla base delle confusioni riguardante l’uso di “mi piace” e “non mi piace”, oppu-re della differenza tra “il foglio” e “la foglia” si organizzano delle attività di gruppo. Si fi ssa un tempo per la revi-sione della costruzione linguistica, del lessico e della grammatica nel gram-mar corner e si passa poi all’improv-visazione. In scena si rappresenta una mini situazione decisa dall’attrice.
Considerato che la presa di paro-la a carattere personale e intimo è un passaggio necessario per federare un gruppo, si è cercato di creare un ter-reno comune che fosse rappresentato dalla parola individuale liberamente espressa su un tema dato. L’artista enuncia, quindi, un “ordine/tema” in cui sono precisati anche la lunghezza dell’intervento richiesto e alcuni ele-menti che esso deve contenere. Al fi ne di superare il limite “scolastico” tra parola scritta e parola individuale, produrre così una dinamica teatrale interessante, si cerca di mettere l’allie-vo in condizione di affermare la pro-pria parola come se fosse quella di un “Autore” e di appropriarsi della parola scritta in modo singolare.
Si procede quindi con degli enun-ciati minimi (una parola, una frase, poi due frasi….), perché lo studente sia consapevole che “nel minimo c’è il massimo”2 e che la creatività risiede anche nel modo di “recitare” una sil-laba o una sola parola dandole un’in-tenzione propria. Solo dopo si arriva all’interazione e al dialogo. Lo scopo è quello di trasformare la propria pa-rola in una battuta teatralmente inte-ressante. Per il momento si è ancora in questa fase di interpretazione; suc-cessivamente si passerà a quella di ri-scrittura. Dopo la prima performance, si correggono gli errori e si ripete una seconda volta. Infi ne si assegna il com-pito per la volta successiva.
Esempi di input personali: • una cosa da dire ad una persona amata che stiamo stringendo tra le braccia ma da cui si stiamo per separare;• un ricordo d’infanzia da 0 a 6 anni (divertente o triste).
Ora stiamo lavorando sul tema del ricordo e sulla sua rappresentazione.
La classe, che all’inizio non osava parlare ed esprimere la propria opinio-ne, adesso è molto attiva e, cosa im-portante, la parte grammaticale non prende mai il sopravvento.
Un elemento su cui bisogna rifl et-tere e lavorare è dato dalla diffi coltà di creare un tutto organico tra voce, gesto e corpo: alcuni devono lavorare sulla voce più che sul corpo, mentre altri si esprimono con il corpo, ma non sono comprensibili. È stato introdotto una sorta di registro su cui l’insegnan-
2 Si intende un solo enunciato ma chiaramente rappresentato ad esempio far capire la differenza tra non mi piace e mi dispiace attraverso un gesto e con solo l’utilizzo di queste brevi frasi.
60
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 te annota le criticità, le questioni su cui rifl ettere e i punti da sviluppare. A questo si aggiunge il normale registro delle lezioni.
Descrizione unita tipo
Attivazione attivitàEsprimere un emozione un senti-
mento• una cosa che piace o non piace a un altro del gruppo
L’attrice enuncia un “ordine” che contiene di solito anche la lunghezza dell’intervento richiesto e alcuni ele-menti che esso deve contenere. Nella fase successiva gli studenti a coppie scelgono i propri personaggi e prepa-rano un role-play orale sulla situazio-ne data.
Immaginarsi nel futuro tra 20 anni
Per la parte grammaticaleSaper esprimere i propri gusti, le
proprie sensazioni uso dei verbi di ter-za coniugazione come dormire, forma negativa, imperativo, forma interroga-tiva le preposizioni semplici e articolate i numeri, le date il maschile e il fem-minile dei sostantivi e degli aggettivi. Articoli determinativi, indeterminativi, aggettivi qualifi cativi
Differenza tra lei e tu.
Elementi di criticitàUna delle maggiori criticità nell’at-
tuazione del progetto e stato l’inseri-mento dei nuovi studenti che sono ar-rivati alla spicciolata durante le prime lezioni. Dovevano integrarsi al gruppo. Inoltre l’assenza di dispositivo scenico reale non ha facilitato inizialmente la libera espressione orale.
Tutti gli studenti manifestano inoltre una diffi coltà oggettiva nell’oc-cupazione prossemica dello spazio, ad usarlo per saper farsi sentire, evi-denziando così la mancanza di coor-dinamento tra corpo e voce. Notiamo inoltre che questi studenti, devono superare anche un ulteriore diffi col-
tà quella di essere attivi e non subire passivamente, non devono scrivere o copiare ma esprimersi.
Punti di forzaL’improvvisazione sul tema, in cui
gli studenti possono ispirarsi anche al proprio vissuto personale L’insegnante di arte drammatica non mostra qua-si mai, infatti, come si deve fare un esercizio; questo per evitare eventua-li reazioni di blocco psicologico negli studenti.
Ogni studente ha ricreato un pic-colo pezzo della sua storia passata la provenienza, le aspettative, i deside-ri e le differenze che trova. È spesso l’insegnante di lingua che, mettendo in gioco la proprie capacità di espres-sione teatrale, dà l’esempio di come è necessario investire la scena. Lavorare insieme sul ricordo ha permesso loro di aprirsi di unirsi. Il lavorare inoltre sul come trasformare la propria parola in “battuta” teatralmente interessante e un esperienza per loro entusiasmante. È un lavoro di interpretazione. Così come e un esperimento interessante vedere quale e la loro idea dell‘Italia a cosa si lega il loro desiderio di studiare e di conoscere la cultura italiana.
Valutazione e verifi caGli studenti saranno valutati alla
fi ne del primo semestre (valutazione intermedia) attraverso due verifi che una scritta e una orale. Nel corso del semestre sono stati periodicamente monitorati attraverso test predisposti dal docente che vengono fatti esegui-re in parallelo nelle due classi (Glotto-drama e classe di controllo). Si tratta di due prove in comune, composte da un esercizio di comprensione testuale con domande di comprensione e di individuazione di parole chiave e da una mini-produzione guidata che pre-vede un racconto o una scenetta. Per la verifi ca intermedia si scelto un testo prodotto dal gruppo di Culturiana di-sponibile sul sito.
Tiziana Jacoponi: la sua formazione e i suoi interes-si sono il frutto di molteplici in-fl uenze. Francesista, si è occupa-ta di didattica dell’insegnamento del Francese lingua straniera. È stata referente per il progetto eu-ropeo Leonardo. Attualmente sta scrivendo una tesi di Dottorato in cotutela tra Paris X Roma Tre (sotto la direzione di Laurence Schifano e Di Giorgio De Vin-centi), su Cristina Comencini o la cinescrittura al femminile in Italia dal 1994 al 2006. Alterna queste ricerche con attività di formatrice in italiano giuridico e degli affari. Ha al suo attivo alcune pubblica-zioni e numerose partecipazioni a convegni internazionali di let-teratura italiana. È collaboratrice della rivista degli italiani in Fran-cia “Focus”.
61
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08
Rifl essioni pedagogiche sull’insegnamento dell’italiano a migranti attraverso il teatro
Forti di esperienze come quella condotta a Ravenna dal regista Marco Martinelli, la scuola di Di-
dattica Teatro della Cooperativa Socia-le Cotrad, è stata ed è tuttora, una tra le poche esperienze pedagogiche in cui l’arte teatrale si fa complice dell’in-segnamento dell’italiano L2, all’inter-no di un contesto sociale complesso quale una classe di migranti, siano essi adulti, adolescenti o bambini.
Le nostre sperimentazioni didatti-che si muovono attraverso luoghi di segregazione sociale: case famiglia, centri di accoglienza, dormitori, i no-stri studenti provengono spesso dalla strada. Le rifl essioni pedagogiche na-scono da intuizioni che costantemente contribuiscono a migliorare l’approc-cio didattico relazionale con i grup-pi. Portiamo la scuola in luoghi dove l’accesso al sapere è sopraffatto da interventi obsoleti di assistenzialismo emergenziale. Sinteticamente ciò che interessa la nostra ricerca è soddisfare la sete d’apprendimento degli alunni, usufruendo del teatro come mappa di riconoscimento delle più disparate modalità di espressione dell’altro, qui inteso come entità migrante, soggetto tradotto ed in traduzione costante, a nostro avviso, sano portatore di espe-rienze culturali. Durante ogni anno scolastico emergono molteplici richie-ste di sostegno da parte degli studen-ti, siano esse di carattere psicologico, sociale o formativo che investono tra-sversalmente i vari momenti della rela-zione multiculturale nella scuola e tra scuola e società. Il percorso di Didattica Teatro ha condotto esplorazioni peda-gogiche le cui prospettive si fondano sui seguenti presupposti:
• L’educazione è per noi un con-tributo che la scuola offre alla ri-costruzione individuale delle diverse identità. Per questo è ne-cessario scommettere sulla ri-con-quista dell’immaginazione da par-te dell’alunno, sia esso minore o adulto, come istinto - guida, mo-tore di ricerca di nuovi segni per scrivere storie di nuovi individui.• In contesti sociali in cui l’italiano è sinonimo di dimenticanza è im-portante tutelare la lingua madre. Preferiamo rispettare la gerarchia delle necessità individuali degli alunni, abbandonando così l’in-
dottrinamento e curando invece il ricordo del migrante con costanti baratti tra gesti e parole per far emergere le vere necessità di co-municazione degli studenti.• Intendere il teatro non come strumento d’apprendimento ma come mappa universale in cui sono inscritte le memorie ance-strali dell’essere umano.
Il teatro, voce e movimento
La lettura, come la scrittura, pri-ma d’essere un processo produttivo, è un gesto del corpo. Un testo prima di essere letto viene ingerito e digerito attraverso il movimento. Come la pa-rola anche il silenzio attraversa la cor-rente della gestualità. Illich2 sottolinea il fatto che il ricordo corrisponde all’at-tivazione di sequenze ben precise di comportamenti muscolari, con i quali le espressioni verbali sono collegate, la musica dei mietitori ne è un esempio.
Così i segni non verbali traducono per primi le intenzioni di ogni essere umano, e la parola nata dal movimen-to stimola il ricordo. L’essere umano, prima ancora di comunicare attraverso le combinazioni alfabetiche, esprime problematiche e necessità attraverso il movimento all’interno di un qualsivo-glia spazio di relazione. La scelta dello spazio teatrale è stata quindi funziona-le. Il palco conforta e seduce, protegge e dona libertà di movimento al di là dei vincoli della comunicazione codifi cata. Così all’interno dello spazio teatrale è possibile comunicare ad altri individui, diversi e complementari, saperi com-plessi e necessità non ascoltate. Lo spazio vuoto sarà sempre quel luogo in cui l’attenzione verso l’altro cresce rinnovando codici e arricchendo iden-tità. L’arte teatrale contempla l’energia umana nella sua totalità.3
La Lingua italiana come il Teatro
di Gaia Morminae Michela Nicolucci
A come Asino
Come posso contrastare la mia natura asinina? Non posso… non posso… non pooossssooooooo! Sono condannato da queste orecchie spropositate sono condannato ad ascoltare i lamenti tutti i lamenti con queste orecchie non me ne perdo uno. Chi si lamenta perché ha fame chi si lamenta perché ha sete chi si lamenta perché non respira chi si lamenta perché lo torturano e chi si lamenta perché gli rubano i fi gli e li vendono al mercato come cipolle. Io li ascolto tutti quei lamenti e quelle voci stridule come il gesso sulle lavagne tutti registrati qui in questa zucca d’asino. Non fare l’asino mi dico io a me. È una parola. Come posso contrastare la mia natura asinina?1
1Siamo asini o pedanti? in Teatro Impuro di Marco Martinelli, Danilo Montanari Editore 2006, pp. 54-55.
2 Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura. Illich I., Milano, Raffaello Cortina Editore,1994,pag.56-57.
3 Il teatro ed il suo doppio. Artaud A., Torino, Giulio Enaudi Ed., 2000.
62
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 sono, in classe, privati del proprio pri-vilegio gerarchico interno all’universo della conoscenza, per diventare stru-menti di creazione per nuovi linguag-gi. I nostri riferimenti artistici spaziano dal teatro antropologico alla ricerca del teatro delle Albe, all’entusiasmo del teatro dei viandanti. Il teatro per noi travalica il rapporto consueto tra pensiero e azione, supera il legame dell’attore con la propria vitalità artisti-ca, si scinde dalla necessità produttiva dell’opera fi nale.4 Il rapporto tra pen-siero e azione è per noi più radicato nel ricordo dell’essere umano, stimo-lato dalla realtà quotidiana, ri-defi nito attraverso la Cultura del migrante.
Insomma per noi fare teatro è an-che solo condurre una classica lezione di grammatica italiana sopra il palco di un qualsiasi teatro della città, per of-frire ai nostri ragazzi maggiore libertà d’interazione, restituendo l’integrità culturale fatta di quei codici e di quei segni troppo spesso nascosti per paura di riscoprirsi diversi.
I deserti di Kabul
La nostra esperienza con i ragaz-zi dei centri accoglienza per minori non accompagnati di Roma, nasce dall’istinto di portare il teatro in questi non-luoghi di contenimento.
Se si chiede a un ragazzo prove-niente dall’Afganistan Conosci il tea-tro? il gesto che mimerà in segno di risposta, sarà un’ondulazione della testa seguita da una linguaccia e dalla ripetizione in farsi, o se va bene in ita-liano, della parola tavolo.
Il teatro a Kabul non esiste, tanto meno per i ragazzi di strada. Esistono invece persone che salendo sui tavoli raccontano, cantano e danzano. Que-sto è il teatro per i ragazzi di Kabul: un momento in cui ridere, tra uomi-ni, delle storie dei grandi. L’età media degli adolescenti che lasciano l’Afga-nistan è di quindici anni. L’Italia è la meta da raggiungere sui propri piedi attraverso interi Stati. La fuga è ten-tata per due, tre volte, con la paura e la certezza che un errore può costare il rientro a casa. In classe a volte qual-cuno di loro si alza, dirigendosi verso la mappa del mondo. Il dito attraversa i confi ni disegnati sulla cartina, il naso segue il ricordo.
Questi sono alcuni dei ragazzi cui insegniamo la lingua italiana attraver-so il teatro, ragazzi per cui il deserto affettivo presente somiglia alle intime
e immense distanze percorse. La sperimentazione è iniziata tre
anni fa all’interno di uno dei centri accoglienza di Roma. L’intento iniziale non era quello di creare un prodotto teatrale ma quello di capire quali e quante potessero essere le richieste pedagogiche di questi adolescenti, quello di scoprire inoltre modalità di espressione nuove e adeguate alle esi-genze espressive.
Gli incontri si svolgevano all’in-terno della sala mensa, uno spazio abbastanza grande ma privo di porte. L’apertura al passaggio casuale dei ra-gazzi in classe, è stata per noi una no-vità assoluta. Settantacinque ragazzi si alternavano ogni settimana attratti dalle attività teatrali senza un preciso obiettivo, se non quello di sperimen-tare in un pomeriggio sensazioni di serenità.
La nostra esperienza pedagogica fi no al quel momento era stata creata sull’importanza del legame tra scrittura e lettura attraverso il teatro. Certi che la vasta gamma di varianti registiche dell’arte teatrale potesse compren-dere ogni sfaccettatura della fantasia umana, usavamo il teatro come testo bianco su cui tradurre i movimenti in parole. Ci sbagliavamo?
Già dal primo incontro i nostri docenti intuirono che in quel viavai d’identità spezzate la lingua italiana era sinonimo di gerarchia, di gabbia, di potere imposto e disprezzato. Una delle paure più grandi dei ragazzi era dimenticare la propria lingua madre. Alla domanda: Perché l’italiano non ti piace? La risposta quasi sistematica era: Perché poi non ricordo come si dice in mia lingua.
Da parte nostra si faceva molto forte la necessità di capire e conosce-re quest’isola di solitudini complesse e fortemente radicate. Allo stesso tem-po ci interrogavamo su come scardina-re la diffi denza dei ragazzi nei nostri confronti e nei confronti della lingua straniera che andavamo a insegnare.
Il nostro istinto ci condusse al com-promesso del poco. Il primo passo fu di trovare un modo per tutelare la lingua madre, valorizzandola. Furono utiliz-zati dei testi in farsi, uno tra tutti una collezione di proverbi tradotti in per-siano. Un proverbio letto in farsi, oltre a stimolare l’ilarità dei ragazzi, diveniva occasione di discussione culturale circa le diverse norme di comportamento, riportando alla memoria presente co-dici che racchiudevano vissuti.
4 La canoa di Carta. Barba E., Bologna, Il Mulino, 1993.
63
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08Il secondo passo fu quello di co-struire insieme ai ragazzi una variante pedagogica divenuta col tempo pila-stro della nostra didattica: lo scambio tra pari. La lingua madre veniva ricor-data, parlata e valorizzata attraverso lo scambio linguistico. Come il Potlach per il teatro così il baratto linguistico permetteva, a insegnanti e studenti, di acquisire e conquistare parole e pen-sieri nuovi.
La conquista maggiore per gli in-segnanti coinvolti in questa esperienza fu di essere attesi dagli alunni. I ragazzi continuavano a parlare poco l’italiano ma questa nuova modalità di relazio-ne con i maestri scardinava negli animi tutti quei preconcetti gerarchizzanti della relazione tra adulto e ragazzo. Quindi? Avevano superato la paura dell’altro e della lingua italiana?
Cercavamo d’insegnare l’italiano con modalità non invasive. Osservam-mo che lo scoglio più grande contro cui la nostra canoa di carta si sareb-be potuta scontrare era il non-detto. Molti degli adolescenti in questione, infatti, preservavano ricordi traumatici legati al rapporto con ciò che noi rap-presentavamo, ovvero la scuola.
In Afganistan la scuola è intesa come momento importante di crescita per il bambino ma purtroppo è stretta-mente legata al lavoro sin dalla tenera età. Inoltre molti dei ragazzi incontrati, non erano in grado di scrivere o leg-gere. Le loro comunicazioni giornaliere si basavano, in patria sul dialetto, una volta passata la frontiera, su un espe-ranto di parole tradotte in varie lingue. Capitava spesso di chiedere con l’inter-mediazione dei compagni più grandi, anche solo risposte verbali di concetti semplici come da dove vieni? o cosa ti piace? e riconoscere negli enunciati un miscuglio di parole francesi, ingle-si, arabe o persiane. Questa tipologia di risposte era spesso accompagnata da mimiche facciali che esprimevano, non solo incertezza, ma anche paura di non farcela. L’idea per questi ragazzi è che se non impari la lingua italiana non trovi un lavoro e che il futuro non è immaginabile senza l’aiuto di qual-cuno. Ogni occasione simile a quella descritta fi niva con la frase: “non ca-piscio” o “lascia”. Come se l’accetta-zione del fallimento fosse l’unica via d’uscita.
Come suggerisce il metodo mon-tessoriano5 o il buon senso di Freinet,6 abbiamo deciso di puntare tutto sul
fare. Operando chirurgicamente sui vari esercizi teatrali da noi assimilati abbiamo puntato tutto sul tatto e sul ricordo. La carta è diventata sabbia, le lettere sono uscite dalla lavagna di-ventando grandi oggetti da intagliare e decorare a piacimento. Abbiamo intuito che in quel complesso mondo di silenzi e richieste dovevamo sempli-cemente lasciare lo spazio alle man-canze affi nché fossero i ragazzi stessi a soddisfare la propria sete attraverso l’unico modo che avevano di comuni-care, ovvero il silenzio del movimento. Un altro saccheggio a nostro avviso necessario è stato privare le lettere dei propri nomi. I suoni d’ogni lettera sono intonazioni della voce, strumento del corpo. Le combinazioni tra consonati e vocali diventano frammenti di canzoni in costante cambiamento. Una volta ottenuta la fi ducia intellettuale dei ra-gazzi stimolando la memoria, lascian-do sedimentare il ricordo del suono e della forma, siamo riusciti ad attutire la distanza mentale tra il non so e il posso.
L’ultimo passo di questa esperienza sempre in divenire è condurre i ragazzi alla scoperta della lettura. Far com-prendere che anche attraverso una lin-gua lontana dalla propria il potenziale umano può esprimersi, traducendo il pensiero in azione verbale.
La scoperta avviene attraverso parole chiave. Siamo dell’idea che l’attinenza alla verità sia caratteristica fondante dell’essere insegnante, così come l’umiltà dentro e fuori la classe. Le prime parole che i ragazzi leggono sono evocative del loro percorso di vita: mare, asino, piedi, viaggio, piog-gia…tutto deve condurre al ricordo, ovvero all’esigenza di comunicare le proprie avventure a nuove fi gure di riferimento attraverso la lingua italia-na. La magnifi cenza della scoperta che prova un ragazzo nel momento in cui comprende la lingua seconda come strumento, come chiave di lettura di nuove esperienze è un attimo la cui intensità conoscerete già tutti.
Aperture
Le classi di Didattica Teatro sono ad oggi una decina, prevedono più li-velli di produzione e fruizione della lin-gua italiana e sono state immaginate come una porta aperta ed accessibile al sapere per tutti gli studenti. Non esi-ste uno standard di accesso, non sono
5 Il segreto dell’infanzia. Montessori M. Milano, Garzanti Libri, 1999.
6 La scuola del fare. Freinet C, Bergamo, Emme Edizioni, 2002.
Gaia Mormina:è la coordinatrice della Scuola Didattica Teatro Cotrad. Il centro Cotrad è una scuola d’italiano per migranti attiva sul territorio del I Municipio da tre anni, che offre la possibilità di apprendere l’ita-liano, lingua seconda attraverso le pratiche teatrali. Ogni classe d’italiano è infatti accompagnata dalla messa in scena delle nozio-ni apprese. Gli insegnanti di DT sono infatti docenti esperti sia di teatro per migranti sia di percorsi di educazione formale per adulti e minori in lingua italiana L2. Se da un lato, quindi, s’insegna la lingua italiana l2 come strumento di inserimento nella vita sociale e lavorativa del paese di acco-glienza, dall’altro si permette agli alunni di cimentarsi in percorsi ar-tistici di crescita e di condivisione culturale. Le classi di DT teatro abbraccia-no diversi livelli di apprendimento dall’alfabetizzazione degli alunni alle lezioni avanzate, classi com-poste da residenti stranieri desi-derosi di approfondire la lingua italiana. La scuola ha collaborato e con le seguenti strutture: Cen-tro di Accoglienza Virtus Ponte-mammolo, Casa Famiglia Ain’ Karim, Cappellania S.M della Luce- Missione Latinoamericana, Centri per Minori non accompa-gnati- Caritas, Città dei Ragazzi, centro di accoglienza per minori,. centro di accoglienza per minori Epochè, Diffrenza Donna. Infi ne la scuola di Didattica Teatro è sta-ta invitata durante l’anno 2007-2008 a presentare un laboratorio teatrale aperto agli studenti delle scuole medie e superiori durante la manifestazione interculturale INTERMUNDIA 2008. Grazie an-che alla gentile collaborazione della scuola media statale Manin.
64
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 contemplati i test d’ingresso tra un li-vello ed un altro, tutto mira e sprona all’autonomia dell’individuo ed alla co-operazione nell’apprendimento.7
Non esistono libri di grammatica in classe, né tantomeno fotocopie, è possibile introdurre testi trovati da in-ternet a patto che si presentino agli alunni nella loro integrità o gli si for-nisca la fonte. Così i testi di letture o letteratura teatrale, fumetti o racconti brevi, tutto viene proposto nella sua in-tegrità, i libri si sfogliano si annusano, si toccano con cura. Solo dopo essere entrati in confi denza con lo strumento didattico, l’insegnante legge o fa leg-gere alcuni brani. A scuola i libri vanno e vengono, si mischiano si raccontano, a volte si legge anche solo la prima pa-gina, insomma, ogni strumento didat-tico è proposto rispettando la verità e la relazione tra pari.
Preferiamo defi nirci con le parole di altri, una non-scuola, piuttosto che un sistema scolastico d’inclusione per
migranti. Nel frattempo le scuole d’italiano
L2 si moltiplicano, l’emergenza dei migranti o immigrati o stranieri snerva le istituzioni molto più di quanto non faccia il cercare soluzioni pedagogiche adeguate a tali emergenze e, non es-sendo come scuola d’italiano ricono-scibile o defi nibile ai più, il nostro lavo-ro è stato criticato o addirittura declas-sato come non-luogo di gioco, isola felice in cui non combinare nulla, una scuola per asini! Per fortuna i ragazzi che vivono dentro o fuori dal centro arrivano a scuola, quando vogliono e soprattutto appena sentono la neces-sità di essere visti per quello che sono: ragazzi in crescita. Alcuni s’iscrivono ai percorsi pubblici per ottenere la certi-fi cazione d’istruzione secondaria. Uno tra tutti Abbas, che in una telefonata, mi dice che trova diffi cile la linguistica italiana e la storia, chiedendomi a cosa possano mai servire per diventare par-rucchiere.
7 Ibid, pag 28.
65
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08L’idea di un laboratorio sull’uso del teatro come strumento per insegnare il lessico delle materie
disciplinari in una dimensione pedago-gica multiculturale è nata dall’osserva-zione, nella veste di facilitatore lingui-stico, di alcune classi di scuola media superiore di primo grado composte da studenti nativi e non nativi di varia pro-venienza. Le diffi coltà degli alunni non nativi a comprendere i manuali delle materie disciplinari sia dal punto di vi-sta lessicale sia da quello testuale ha evidenziato la necessità di cercare me-todologie che comportassero il coin-volgimento delle varie forme di intel-ligenza possedute dagli apprendenti, molte delle quali purtroppo trascurate nell’ambito di un insegnamento-ap-prendimento di tipo tradizionale. Una possibile proposta di soluzione per le problematiche riscontrate durante l’os-servazione ci è sembrata l’uso del tea-tro come strumento glottodidattico.
Nello specifi co si è iniziato a speri-mentare l’insegnamento del lessico del linguaggio disciplinare della storia inte-grando tecniche teatrali e pratiche più tradizionali. È stato creato un progetto avente come destinatari parlanti nativi e non nativi inseriti nella scuola media inferiore del comprensorio di Perugia in sperimentazione da due anni circa. Attualmente sono in corso laboratori linguistico-teatrali in due scuole supe-riori di primo grado: la scuola B. Bonfi -gli di Corciano (2° anno di attività) e la scuola B. DI BETTO di Perugia (1° anno di attività).
Nella prima edizione del laboratorio (otto incontri di due ore ciascuno, a.s. 2007-08) abbiamo concentrato l’at-tenzione sul lessico relativo al campo semantico dell’’impero’ focalizzando gli interventi sulla fi gura e sull’operato di Carlo Magno. Nell’anno scolastico in corso (2008-09) il progetto è stato am-pliato e ha come titolo ‘L’Europa unita: percorso linguistico teatrale dall’im-pero romano ai giorni nostri’(otto in-contri di due ore ciascuno, a cadenza settimanale e in orario curricolare). Si è ritenuto opportuno scegliere la storia, fra le tante discipline curricolari, per la notevole astrazione del lessico usato, la diffi coltà concettuale insita nella materia e l’alta densità di parole lessi-cali riconducibili ad unità polisemiche del Vocabolario di base.
Il laboratorio e la ricerca condot-ti hanno come obiettivi lo studio dei processi afferenti l’uso del teatro come strumento di facilitazione nell’appren-dimento del lessico relativo alle materie disciplinari (in particolar modo il lessi-
co della storia), il miglioramento delle competenze linguistiche e comunicati-ve degli alunni stranieri e la creazione di un clima collaborativo interculturale che contribuisca alla crescita e allo svi-luppo dell’individuo. Al fi ne di favorire un’acquisizione più ‘stabile’ del lessico, si privilegia un approccio più globale, che migliori la qualità dell’apprendi-mento mediante l’acquisizione di com-petenze non verbali, l’abbassamento
dei meccanismi di autodifesa come il fi ltro affettivo, il miglioramento della socializzazione e dell’integrazione fra alunni italiani e non nativi, un recupe-ro di nozioni e funzioni progressivo e sempre più ampio e il miglioramento delle competenze fonologiche. Gli in-contri si basano sull’uso di testi tratti dai manuali di storia per le scuole me-die superiori di primo grado. Vengono quindi forniti input testuali di varia ti-pologia (grafi ci, cartine storiche, brani, mappe concettuali, ecc.) che vengono esplorati, studiati e ri-creati in collabo-razione con gli apprendenti al fi ne di agire sulla motivazione e sull’affettività per ‘comunicare e fare’ con la lingua.
Nella strutturazione delle attività si è fatto riferimento in particolare all’ap-proccio lessicale (Lewis 1993). Consi-derando infatti che le parole vengono memorizzate come chunks, ovvero unità lessicali, e che il fattore frequen-za facilita l’inserimento delle stringhe negli slot di memoria, il testo teatra-le, nel nostro caso frutto di attività di improvvisazione e di rielaborazione del testo ad opera degli apprendenti, viene suddiviso in stringhe/battute da leggere ad alta voce o memorizza-re. La scoperta dei neuroni specchio, inoltre, che sembrano essere dotati della proprietà di attivarsi sia quando a compiere l’azione è il soggetto stesso sia quando il soggetto osserva gli altri fare la stessa cosa, supporta dal punto di vista scientifi co l’effi cacia riscontra-ta empiricamente del così detto ‘ap-prendistato a bottega’ tanto praticato in ambito attoriale. Poiché non sempre gli apprendenti presentano una dispo-nibilità naturale e spontanea ad un approccio di questo tipo, è necessario
di Alessandra Pettinellie Nicol Martini
Il lessico della storia attraverso il teatro
66
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 prevedere un lavoro di adattamento a certe pratiche didattiche.
È stato subito chiaro che un ap-proccio fi sico al teatro fosse fon-damentale, date le similarità che accomunano questa tipologia di inse-gnamento della lingua e la formazione dell’attore, fondata sulla pratica. Chi “va a bottega” apprende nuove tec-niche osservando coloro che da più tempo le praticano, poi le prova sul palcoscenico, cercando di adattarle alle proprie possibilità. Un attore im-para facendo, il corpo è suo strumento espressivo, ma anche strumento di co-noscenza, basti anche pensare che un copione viene memorizzato facendo corrispondere alla sequenza di parole una partitura di movimenti. L’età degli apprendenti ha poi infl uito sulla scelta: operare con un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni preclude, secondo la nostra opinione, l’approccio più psico-logico richiesto dal metodo di imme-desimazione, tanto da poter risultare un ostacolo ad un sistema di appren-dimento che necessiti, dati i tempi di lavoro, di un rapido abbassamento dei fi ltri affettivi. Si è quindi scelto il corpo come strumento e il gioco come lin-guaggio, fatto di regole che i ragazzi già conoscono e che naturalmente li pongono al centro del lavoro. Per la struttura di ogni unità si è deciso di seguire le tappe di un importante mo-mento teatrale, quello della creazione di uno spettacolo. Essendo l’ambito di lavoro dell’insegnante di recitazione quello del Teatro Ragazzi, si è preso come modello il processo delle prove di uno spettacolo per l’infanzia, il cui punto di partenza è un testo, favola o fi aba, con un linguaggio specifi co, a partire dalle cui suggestioni si improv-visa, per poi tornare sul testo stesso e giocare con la parola per giungere ad una sua più profonda comprensione. Il momento della messa in scena è il risultato dell’intero processo creativo ed il testo fi nale è diverso, più ricco e maturo di quello di partenza.
Gli otto incontri sono strutturati in quattro macro-fasi: la fase di riscalda-mento, l’avvicinamento al testo, la pre-sentazione del testo, le attività di the-atre e la conclusione ludico-distensiva.
Nella fase di riscaldamento ven-gono proposti esercizi teatrali di base, che permettono agli apprendenti di familiarizzare con la situazione e l’ambiente di lavoro e alle conduttrici del laboratorio di osservare il gruppo-classe al fi ne di valutare il livello di competenza dell’italiano come L2 e, soprattutto, la disponibilità al lavoro
proposto, l’abitudine a lavorare con il corpo, la volontà di mettersi in gioco e il grado di socializzazione tra i vari componenti.
Se si considera il corpo un impor-tante strumento, è necessario che esso venga accordato con semplici esercizi di scioglimento, respirazione ed ar-ticolazione del suono. Questa prima fase si svolge con il gruppo disposto in cerchio, col tempo diventa un piccolo rito, che gli apprendenti conoscono bene e sanno riprodurre autonoma-mente. Poiché il riscaldamento è sem-pre correlato alle esigenze linguistiche dell’incontro, si cerca di introdurre l’ar-gomento dell’unità giocando su temi ed atmosfere che esso suggerisce, recuperando gli item lessicali corri-spondenti, in particolare nella seconda fase, che prevede una serie di esercizi più complessi. Si è deciso in questo caso di dar vita ad una vera e propria improvvisazione guidata. Con una mu-sica di sottofondo, scelta in funzione del tema della lezione, attingendo al genere world music per promuovere l’aspetto interculturale dell’attività, si ricrea una situazione storica e geo-grafi ca in cui reagire agli input forniti dalle insegnanti. Nell’unità inerente l’Europa sotto l’Impero di Augusto, ad esempio, è stata ricreata l’atmosfera di un accampamento romano in Cire-naica, la notte prima della battaglia. Guidati dalle insegnanti, gli studenti hanno cominciato a muoversi utiliz-zando il proprio corpo per esprimere emozioni (paura), o sensazioni fi siche (caldo) e successivamente interpretare i protagonisti della scena: lo schiavo, il soldato, l’imperatore in trionfo. Ve-rifi catasi la necessità di fi ssare gli item lessicali introdotti, si è deciso di con-cludere l’attività fi ssando fi sicamente i personaggi in una scena organizza-ta, ma immobile, in cui ognuno degli apprendenti interpretasse una fi gura, congelata in un’azione che la caratte-rizzasse. Si è creato in pratica un ta-bleau vivant, strumento rivelatosi nel tempo estremamente utile, proprio perché, in forma di gioco, permette agli apprendenti di agire l’informazio-ne acquisita.
Nella fase di avvicinamento al te-sto, vengono create delle attività che abbiano come obiettivo principale la facilitazione di certe stringhe lessicali, la consapevolezza dell’esistenza di di-verse intonazioni parafoniche e della possibilità di usare la propria creatività per apprendere item lessicali nuovi. A tale scopo si sono rivelati estremamen-te effi caci tecniche tratte dall’improv-
Alessandra Pettinelli: laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Pe-rugia e, successivamente, specia-lizzata nell’insegnamento dell’ita-liano lingua non materna presso l’Università per Stranieri di Peru-gia. Docente nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia e presso istitu-ti universitari americani. Facilitatri-ce linguistica presso scuole della Provincia di Perugia. Attualmente lavora come ricercatrice a proget-ti relativi all’’uso del teatro come strumento nell’insegnamento del lessico dei linguaggi disciplinari nella scuola multiculturale’. Ha recentemente scritto un articolo dal titolo ‘Il laboratorio teatrale nella classe mistilingue’ per la ri-vista ‘Culturiana’ specializzata in glottodidattica. Attualmente sta curando la pubblicazione di un testo per l’insegnamento dell’ita-liano attraverso il linguaggio di-sciplinare della storia.
67
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08visazione teatrale, come ad esempio il già citato tableau vivant. La creazione di un ‘quadro vivente’ si basa sul pro-cesso di lessicalizzazione del concetto proposto. Il parlante con una compe-tenza minima partirà dal ‘quadro vi-vente’, lo concettualizzerà e quindi lo riconoscerà nella parola lessicale forni-ta. Il parlante avanzato seguirà invece il percorso opposto: partirà dall’unità lessicale, per concettualizzarla e quindi agirla nella forma del tableau. Vengo-no proposte parole lessicali semplici (es. l’imperatore), combinazioni di parole (es. acclamare l’imperatore) e collocazioni (es. usurpare il trono). Ad ogni apprendente viene poi assegnata una parte del testo, con la quale co-minciare a sperimentare: ognuno leg-gerà la propria “battuta” utilizzando un dato colore, non necessariamente correlato al contesto, ma netto, come netta deve essere l’emissione vocale, in modo da risultare comprensibile ai compagni. Le parole lessicali del lessi-co disciplinare diventano quindi ma-teriale di gioco, utilizzati come titolo di tableaux vivants, o come termine di partenza in un gioco di associazioni di idee eseguito in cerchio, con una pallina da lanciare di volta in volta al compagno che dovrà sperimentare l’aspetto polisemico di un termine, ad esempio “sistema” e le sue possibilità di comparire in diverse combinazioni.
La fase di presentazione del testo prevede la pratica della lettura dram-matizzata o l’osservazione e la rifl es-sione nel caso di cartine, immagini, oggetti, ecc. Alla domanda “come scegliere il testo” si è risposto con un’altra domanda: “è opportuno sce-gliere un testo quando si trattano lin-guaggi disciplinari?”. Si ritiene infatti che nel caso dei linguaggi disciplinari la selezione del testo più adatto sia meno importante rispetto ad altri lin-guaggi specialistici. Il linguaggio della storia non presenta una testualità net-ta, se non altro meno classifi cabile in categorie di altre discipline, il lessico usato, inoltre, è estremamente vasto e ogni intervento risulterà pertanto sem-pre incompleto e parziale. Nel caso dei laboratori descritti i testi sono stati selezionati in base al fi lo conduttore e si è scelto di usare come fonte i ma-nuali adottati dalle classi coinvolte nel progetto. Il primo approccio prevede una lettura silenziosa, seguita da una a voce alta, neutra, priva di connota-zioni parafoniche.
Si passa quindi alla fase successi-va, ovvero il momento della messa in scena (theatre), che non può prescin-
dere da due fattori: il copione e la mo-dalità di rappresentazione di questo. Si è stabilito che il testo della piccola produzione fi nale fosse scritto dagli studenti, con l’obbligo di utilizzare le parole lessicali introdotte nelle unità di apprendimento; questo per giungere ad un ulteriore consolidamento degli item lessicali e di capacità di utilizzo degli stessi e perché, dati i tempi ri-stretti del laboratorio, risulta più age-vole memorizzare e recitare un testo prodotto da sé, piuttosto che uno fornito da altri. Per quanto riguarda la modalità di messa in scena, anche in questo caso la durata del laborato-rio ha imposto la scelta di creare un breve video, piuttosto che uno spet-tacolo. In otto incontri, infatti, non è possibile preparare un ragazzo al pic-colo trauma che l’esibizione davanti ai coetanei porta con sé. La realizzazio-ne di un video, invece, permette agli studenti di sperimentare il momento dell’azione teatrale e di fare la cono-scenza di linguaggi e materiali nuovi e affascinanti in una situazione protetta, senza rinunciare a produrre qualcosa di fruibile da insegnanti e compagni. L’esperienza dello scorso anno ha avu-to come risultato un breve Tg storico sull’incoronazione di Carlo Magno ad Imperatore del Sacro Romano Impero. Gli studenti interpretano i personaggi storici ed i giornalisti, ma sono anche cameraman, fotografi , registi, in grado di dar vita ad un prodotto che non sarà impeccabile dal punto di vista tecnico, ma che è comunque godibile e utile a comprendere le abilità acquisite dal gruppo e i miglioramenti da appronta-re al lavoro delle insegnanti. A questo proposito si ritiene sia giusto sottoline-are l’importanza che una produzione fi nale ha in questa esperienza. L’idea di dover realizzare un prodotto teatrale a compimento del laboratorio, infatti, fornisce un obiettivo molto stimolante per gli studenti, che rimangono sem-pre concentrati sul lavoro e ne giovano dal punto di vista della motivazione. E’ necessario che la produzione fi na-le sia esteticamente valida, anche se non tecnicamente perfetta affi nché gli apprendenti si abituino alla ricerca di accuratezza, al piacere di applicarsi alle attività proposte. Per i due labora-tori in corso in questo anno scolastico il prodotto fi nale sarà un montaggio di brevi scene che raccontino ogni epoca storica trattata, sempre scritte e realiz-zate dagli studenti. Il lavoro di mon-taggio verrà realizzato mediante un semplice programma di editing video, disponibile all’interno di uno dei più
Nicol Martini: si forma all’interno di Fontemag-giore Teatro Stabile d’Innovazio-ne, compagnia nella quale lavora dal 2002 come attrice in vari spet-tacoli, tra cui quelli attualmente in replica nel circuito nazionale di Teatro Ragazzi e, come operatri-ce, partecipando alla conduzione di laboratori teatrali nelle scuole del centro Italia, all’interno della sezione femminile della Casa Cir-condariale di Perugia e con i ra-gazzi della Associazione Italiana Persone Down. Collabora con il C.I.S.B.i.T (Centro Internazionale Studi sulla Biomeccanica Teatrale) di Perugia dal 2006, anno in cui comincia un percorso formativo col maestro Gennadi N. Bogda-nov.
68
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 diffusi sistemi operativi. Dinanzi alla possibilità di delegare l’operazione di montaggio ad un esperto esterno si è scelto di lavorare autonomamente per dimostrare che ogni insegnante in possesso di conoscenze informatiche di base, può creare un video o un cor-tometraggio. Il vantaggio di lavorare con dei video consiste nel poter mon-tare scene realizzate in tempi diversi, anche con soggetti differenti, aspetto non da sottovalutare in questo tipo di laboratori per propria natura sempre aperti a nuovi ingressi e ad eventuali uscite dell’ultimo minuto.
La fase ludico-distensiva consiste nella rievocazione di riti in chiave in-terculturale con pratiche corporee su basi musicali o su ritmi creati dagli ap-prendenti usando le proprie risorse fi -siche (es. percussioni usando il proprio corpo o suonando strumenti musicali). L’attività fi nale consiste quindi in una sorta di gioco rituale che riproduce i suoni di un temporale, usando il corpo e la voce. Effettuato in cerchio, a luci spente ed occhi chiusi è un momento vissuto con partecipazione dai ragazzi, che lo personalizzano, aggiungendo di volta in volta nuovi suoni. Si è inoltre chiesto loro di fornire di volta in vol-ta piccoli giochi o fi lastrocche tipiche della cultura d’origine da condividere col gruppo.
Lo spazio usato nel caso del labo-ratorio teatrale qui descritto non è mai lo spazio classe tradizionale. All’inizio non si è posto il problema dello spazio di lavoro e casualmente si è iniziato a lavorare, nel caso della scuola media B. Bonfi gli di Corciano, nella cucina della scuola, mentre nel caso della scuola media B. di Betto di Perugia, nel teatrino scolastico. Entrambi gli spazi sono dotati della strumentazione e dei sussidi necessari per svolgere le attività previste (televisore, proiettore
video, lavagna, stereo, lettore dvd). In entrambi gli ambienti è possibile oscurare completamente lo spazio di lavoro. Gli ‘oggetti di scena vendono interamente creati dagli studenti con materiale presente in classe, colori, cartoncini bristol, colla, colori. In alcuni casi gli apprendenti hanno espresso il desiderio di costruire a casa particolari dettagli dei costumi o effetti di scena (es. il fumogeno costruito da un ap-prendente come macchina del fumo).
Ogni incontro è inteso come fase di una ricerca sull’insegnamento del linguaggio disciplinare della storia attraverso il teatro come strumento glottodidattico e viene infatti videore-gistrato, rivisto e commentato insieme ad insegnanti di italiano L2 e a profes-sionisti del teatro.
Durante tutto l’arco del laboratorio sono previste delle verifi che di achie-vement in corso mediante feedback o testing diffuso. Si è preferito non usare la modalità del testing formale per non generare ansia e per evitare il conseguente innalzamento del fi ltro affettivo.
La conduzione-animazione viene fatta da due soggetti, uno di forma-zione teatrale specializzato nel teatro ragazzi e l’altro con una formazione di tipo glottodidattico coadiuvati da partner istituzionali (le scuole coinvol-te nel progetto) con i quali vengono elaborate le modalità degli interventi e la creazione del gruppo di lavoro che è costituito da un massimo di 15 ap-prendenti per il 90% non italofoni.
La realizzazione dei laboratori è stata possibile grazie a fi nanziamenti pubblici ottenuti mediante Fontemag-giore Teatro Stabile di Innovazione e l’Associazione l’Alfabeto che fornisce corsi di italiano L2 nelle scuole del comprensorio di Perugia, nonché gra-zie al sostegno delle scuole stesse.
Bibliografi a
Aglioti S. M. e Fabbro F., 2006, Neu-ropsicologia del linguaggio. Il Mulino, Bologna.
Cardona M., 2004, Apprendere il lessi-co di una lingua straniera. Aspetti lin-guistic, psicolinguistici e glottodidatti-ci. Adriatica editrice, Bari.
Corda A. Marello C., 2004, Il lessico. Insegnarlo e impararlo. Guerra, Peru-gia.
Gallarini C., 1992, Palcoscenico e dintorni. Manuale di esercizi teatrali. Mursia, Milano.
Garavaglia V., 2007, Teatro educazio-ne società. Utet, Torino.
Ježek E., 2005, Lessico. Classi di paro-le, strutture e combinazioni. Il Mulino, Bologna.
Lewis M., 1993, The lexical approach: the state of ELT and a way Forward. Hove, Language Teaching Publica-tions, UK.
Rizzolatti G. e Sinigaglia C., 2006, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio. Raffello Cortina Edi-tore, Milano.
Spolin V. (2005), Esercizi e improvvisa-zioni per il teatro, ed. Audino
69
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08Origini del Process Drama
Le origini della metodologia si possono ricondurre agli anni ‘60, in parallelo all’emergere della psi-
cologia umanistica. In particolare, l’in-glese Peter Slade è il primo educatore teatrale a considerare tecniche di reci-tazione non soltanto come un mezzo per formare gli attori, ma anche come uno strumento per sviluppare crea-tività e crescita personale; al collega Brian Way, nel 1959, viene riconosciu-to il merito di credere e applicare per primo la fi losofi a di Slade all’insegna-mento nelle scuole inglesi. Negli anni ’70, Gavin Bolton porta avanti questa tradizione e la concettualizza in un trattato, defi nendo questo approccio pedagogico drama in education. Bol-ton forma, con l’educatrice Dorothy Heathcote, un metodo di taglio co-struttivista basato sull’improvvisazione, attraverso il quale l’insegnante si met-te in gioco tanto quanto i partecipanti nel laboratorio. Da allora, trent’anni di ricerca e applicazione pratica hanno reso la metodologia legittima, sia con discipline scientifi che che umanistiche in un contesto anglosassone.
All’inizio degli anni ’90 Cecily O’Neill, rispettata esponente della metodologia, conia l’espressione pro-cess drama come sinonimo di drama in education. Nell’ultimo decennio, O’Neill ha contribuito enormemente alla consolidazione del metodo, con pubblicazioni e laboratori di formazio-ne in tutto il mondo.
Process drama e glottodidattica
O’Neill, in collaborazione con la linguista Shi-Mei Kao, effettua nel 1992-93 uno studio empirico tramite il quale applica, per la prima volta, il process drama alla glottodidattica, sinergia che defi nisce “liberatoria” (Kao & O’Neill, 1998). La ricerca, con-dotta all’università di Cheng Kung, a Taipei, rivela che questo approccio infl uisce positivamente sulla motiva-zione, abbattendo il fi ltro affettivo degli apprendenti e sviluppando una consapevolezza di registri linguistici appropriati a diversi contesti. Questi risultati hanno incoraggiato altri ri-cercatori a sperimentare la sinergia fra process drama e glottodidattica, dando vita a diversi studi. Piazzoli ne cita tre, partendo dalla giapponese Araki-Metcalfe, che ha applicato la pedagogia del process drama all’inse-gnamento del giapponese LS (2001) e inglese LS (2007) con bambini di scuo-
le primarie; Renee Marschke, educatri-ce che ha usato questo approccio per insegnare francese LS in una scuola media superiore (2004) e Madonna Stinson, ricercatrice che ha collabora-to con diverse università di Singapore usando il process drama inglese L2 ad indirizzo specialistico (2006). Sep-pur in ambiti e contesti diversi, que-sti studi sono arrivati a simili risultati per quanto riguarda il potenziale della
metodologia nell’incrementare com-petenza comunicativa in una L2/LS.
Process drama e consapevolezza interculturale
Piazzoli prosegue sulle orme di que-sti ricercatori, considerando non solo la competenza comunicativa ma anche la consapevolezza interculturale nel suo progetto di ricerca alla Griffi th University (2008). Obiettivo della ricerca era infat-ti identifi care strategie per aumentare la CIC usando la metodologia process drama. La defi nizione di competenza interculturale ripresa da Piazzoli si rifà al modello di Byram (1997), secondo il quale la CIC si può identifi care come “quella consapevolezza nell’incontro con l’altro tramite un processo che non si basa solo sull’esperienza, ma anche sulla rifl essione, sull’analisi e l’azione che porta ad un decentramento dei propri modelli culturali e ad una trasfor-mazione di coscienza” (Alred, Byram & Fleming, 2003). Partendo da questo concetto, la ricercatrice ha cercato di mettere in luce strategie concrete per trasformare questo modello teorico in un’applicazione pratica, avvalendosi della tesi di Fleming, secondo il quale la struttura del process drama si presta particolarmente all’educazione inter-culturale (1998, 2003).
di Erika Piazzoli
Metodologia process drama e competenza interculturale
70
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 Struttura del Process Drama
Il process drama utilizza tecniche di recitazione teatrale a scopi didattici, ma non mira alla creazione di un co-pione o spettacolo fi nale; al contrario si concentra sul processo, caratterizza-to da una serie di attività collegate fra loro che si snodano secondo un per-corso didattico ben defi nito dove sia gli studenti che l’insegnante si metto-no in gioco per creare un contesto im-maginario. La metodologia si distacca sostanzialmente dallo psicodramma di Moreno o da esercizi di recitazione te-atrale mirati alla creazione di un testo. Infatti, nonostante il process drama si basi sul principio dell’ improvvisazione teatrale, si differenzia da quest’ultima in quanto non prevede brevi attività sconnesse fra loro, ma utilizza un’am-pia gamma di attività proprie della metodologia che vengono organizzate e proposte in tre fasi principali. Nella fase iniziale, viene introdotto come spunto di partenza uno stimolo, o pre-text, una piattaforma di lancio per il percorso immaginario. Il pretext, che può essere un’immagine, un testo, una canzone o altro servirà da fi lo condut-tore per tutte le attività seguenti. Nella fase dell’esperienza, il partecipante si calerà nel mondo del pretext per vi-vere ed ampliare la sua realtà tramite scenette, o episodi, concatenati l’un l’altro con salti spazio-temporali im-maginari, per spronare alla rifl essione su conseguenze di causa-effetto. Nella fase fi nale, un’attività di de-briefi ng di discussione e/o scrittura creativa aiute-rà il partecipante ad esternare i proces-si implicitamente acquisiti. Finalmente, una ricapitolazione linguistica aiuterà i partecipanti a rinforzare il vocabolario emerso nella fase introduttiva e quelle strutture linguistiche incontrate duran-te il percorso didattico. Per dimostrare la struttura del process drama Piazzoli trae spunto da un esempio concreto di unità didattica, centrata sulla tematica delle diffi coltà di integrazione delle co-munità Rom nelle città italiane.
Esempio di unità didattica
Per iniziare un laboratorio process drama si prevede un’ attività di riscal-damento e conversazione, prima di in-trodurre il pretext selezionato. In que-sto caso, Piazzoli utilizza una fotografi a di un campo nomadi nella periferia di Roma (vedi foto). Dopo un brainstor-ming su vocabolario ed espressioni ri-levanti, la prima attività proposta nella fase iniziale è teacher in role, strategia
pedagogica portante del process dra-ma, secondo la quale l’insegnante si cala nei panni di un personaggio re-lazionato al pretext. In questo caso, Piazzoli si trasforma in Radi, nome immaginario del bambino Rom in pri-mo piano. L’obiettivo della strategia, è coinvolgere il gruppo in una interazio-ne con il personaggio. Teacher in role prevede che l’insegnante si immerga in un ruolo, adattandosi al registro linguistico e status del personaggio. Confrontarsi con questa realtà ha cre-ato forte empatia nei partecipanti, che hanno in seguito ricreato una scena di realtà quotidiana del campo nomadi tramite tableau vivant. Segue l’attività del “coro greco”, in cui i partecipanti, a gruppi, hanno dovuto interpretare un testo usando timbro, colore, ripe-tizione, intensità.
I tre testi (una poesia di anonimo Rom, un elenco di tipici stereotipi sugli zingari, l’articolo 21 della carta dei di-ritti fondamentali dell’Unione Europea sulla discriminazione) hanno contribu-ito a creare l’atmosfera e il simbolismo necessari per immergersi nella fase dell’esperienza. In questa fase, tramite salto spazio-temporale, l’insegnante trasporta il gruppo ad una settimana prima della fotografi a, quando Radi si accorge che il suo migliore amico è gravemente ammalato per malnu-trizione. Radi cerca quindi di aiutarlo chiedendo ad un genitore italiano di un compagno dell’asilo €50 per com-prare dei medicinali. Il genitore, stizzito e scocciato, rifi uta. Questa la situazio-ne di partenza per l’attività di role-play proposta dove i partecipanti, in cop-pie, devono interpretare i due punti di vista in un gioco di persuasione.
Mediante un altro salto tempora-le l’insegnante informa che Radi, non essendo riuscito ad ottenere i soldi dall’adulto, ha poi sottratto €5 dalla giacca del compagno; la maestra, ac-cortasi del fatto, segnala il furto alla direttrice che convoca una riunione di classe straordinaria.
Questa la situazione di partenza per l’episodio seguente, una dram-matizzazione della riunione di clas-se, dove i partecipanti interpretano i genitori dei bambini, sia italiani che extracomunitari, guidati l’insegnante che nei panni della direttrice dell’asilo, personaggio volutamente intollerante e provocatorio.
Quest’attività ha sprigionato una forte tensione drammatica, forza con-duttrice e motivante nell’atto comu-nicatorio; i partecipanti si sono infatti coinvolti in un dibattito sul problema
Erika Piazzoliha presentato la metodologia Pro-cess Drama e la sua ricerca presso la Griffi th University, per la quale ha creato e sperimentato un nuo-vo corso basato sulla sinergia fra process drama e glottodidattica, con l’obiettivo di individuare stra-tegie per aumentare la consape-volezza interculturale.
71
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08dell’educazione dei fi gli, la sicurezza e la tolleranza nelle scuole. A seguire, ultima attività della fase dell’esperien-za è un’improvvisazione guidata, tra-mite la quale i partecipanti, nei panni di bambini Rom, sono alla fermata dell’autobus per aspettare il servizio che li porta a scuola.
Questo episodio, che rappresenta il fulcro della fase dell’esperienza, è centrato su una circolare emessa dal Comune di Milano il 17/12/07 secon-do la quale bambini senza permesso di soggiorno non avrebbero avuto il diritto a iscriversi in scuole materne lombarde.
La circolare, attualmente ritirata, è servita da spunto per fare vivere ai partecipanti, in prima persona, l’espe-rienza di aspettare un autobus che, da quel giorno, non sarebbe più arrivato. In quest’episodio dunque, ambientato una settimana dopo la circolare, i par-tecipanti si sono confrontati con una realtà diversa e scioccante, vissuta dal punto di vista di un bambino. Nella fase rifl essiva, l’attività ‘vicolo della co-scienza’ aiuta i partecipanti a sfogare la tensione accumulata.
Formando due fi le parallele, il gruppo si cala nei panni della voce del-la coscienza della direttrice dell’asilo, colpevole, sempre secondo il percor-so immaginario ideato da Piazzoli, di avere enunciato il furto e infl uenzato l’emissione della circolare. L’insegnante quindi, camminando in mezzo alle due fi le parallele con costume e oggetti di scena della direttrice, funge da stimo-lo per esternare i sentimenti dei par-tecipanti. Infi ne, un’attività di scrittura creativa completa il laboratorio, dando la possibilità di rielaborare l’esperien-za tramite la stesura di una lettera dal punto di vista della maestra di Radi, di un genitore, di un assistente sociale o altro, a scelta del partecipante. Risulta evidente come l’unità didattica, intera-mente proposta nella lingua bersaglio, sia stata programmata in modo da sti-molare le quattro abilità.
Alla fi ne della fase di scrittura, che conclude il percorso didattico, si pro-pone una ricapitolazione linguistica e, a seguire, il forum comunicativo per discutere la tematica affrontata. In questo caso l’argomento, poco co-nosciuto nella realtà culturale Austra-liana, era particolarmente adatto alle necessità specifi che dei corsisti, che venivano infatti incoraggiati a sceglie-re proprio quelle tematiche lontane dalla loro realtà e che non conosce-vano, in sintonia con la struttura del corso stesso.
Struttura del corso
Usando “Sotto paga! Non si paga” di Fo e Rame (2007) come piattaforma di lancio, lo scopo del corso era fare sperimentare, analizzare e rifl ettere i partecipanti su alcune realtà socio-cul-turali dell’Italia contemporanea trami-te sei laboratori process drama di 2 ore ciascuno. La struttura del corso preve-deva che i partecipanti si trovassero a discutere e identifi care, di settimana in settimana, una tematica socio-cultura-le emersa dalla lettura della commedia, per poi approfondirla insieme tramite un laboratorio la settimana seguente. In questo modo, settimanalmente i partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi e monitorare la propria crescita e sensibilità interculturale. Le tematiche scelte dai corsisti, illustrate dalla relatrice con i rispettivi pretext abbinati al percorso didattico, com-prendono: protesta e azione collettiva come mezzo per esprimersi dagli italia-ni, il senso dell’umorismo e il pessimi-smo cronico, diffi coltà di integrazione delle comunità Rom nelle città italiane, l’identità collettiva del lavoratore pre-cario, la satira come arma per convi-vere con cicli di corruzione politica e il fenomeno del bigottismo in Italia.
Questa struttura ciclica del corso, tipica del percorso metodologico di ricercazione, prevedeva l’alternarsi di fasi di applicazione pratica e fasi di rifl essione. Così facendo è stato pos-sibile modifi care, di settimana in set-timana, strategie di insegnamento per assecondare le esigenze dei corsisti, monitorate tramite diversi strumenti di ricerca.
Tra questi, i fi lmati dei 6 laboratori, le trascrizioni dei forum comunicativi, 10 interviste individuali e un DVD di 20 minuti composto da spezzoni di 3 attività selezionate per ogni laborato-rio, montate e presentate come input iniziale per un intervista di gruppo (fo-cus group) alla fi ne del corso. Inoltre, per monitorare la ICI, la ricercatrice ha proposto un’ attività di concept map-ping, anch’essa svolta al termine del corso, per costruire una mappa delle connessioni interculturali implicita-mente acquisite durante i laboratori. I dati fenomenologici ottenuti da questi strumenti di ricerca hanno prodotto, tramite un’analisi induttiva, risultati positivi, presentati in seguito.
Risultati della ricerca: strategie
A partire dall’esempio concreto di un’unità didattica, Piazzoli mostra
Libri raccomandati sul Process Drama:
Kao, S. M. & O’Neill, C. (1998) Words into Worlds: Learning a Second Language through Pro-cess Drama. London: Ablex Publi-shing Corporation.
Needlads, J. & Goode, T. (2000) Structuring Drama Work: a Han-dbook of Available Forms in Theatre and Drama. Cambridge: Cambridge University Press.
Owens, A. & Barbers, K. (2005) Mapping Drama. Melbourne: Phoenix Education.
72
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 alcune strategie del process drama utilizzate per creare e manipolare, a seconda del caso, empatia e/o di-stacco verso personaggi e situazioni. Concettualizzando la distanza come un continuum, la ricercatrice propo-ne che, alterando gradi di distanza fra l’apprendente e il personaggio interpretato, è stato possibile manipo-lare gradi di identifi cazione che a loro volta hanno stimolato i partecipanti a sviluppare consapevolezza intercultu-rale. Ad esempio, nell’unità didattica sull’integrazione Rom, descritta sopra, i partecipanti sono stati incoraggiati ad identifi carsi prima con Radi, il bam-bino Rom, poi con i genitori italiani convocati a seguito del furto e pre-occupati per la sicurezza dei loro fi gli. Tale identifi cazione, resa possibile dalla strategie pedagogica teacher in role, è stata abbinata al concanenarsi di punti di vista contrastanti.
Questo netto cambio di percezio-ne, riproposto volutamente più volte, ha contribuito a creare una sensibilità culturale nei confronti dell’altro carat-teristica del modello di CIC di Byram (1997).
Distanziamento
Un’altra strategia per aumentare la CIC illustrata è il distanziamento (distancing), introdotto inizialmente da Heathcote e Bolton in un convegno all’università di Durham nel 1998. Se-condo questa strategia pedagogica, i partecipanti vengono esposti ad un ter-zo modello culturale, diverso sia dalla cultura originale che dalla cultura ber-saglio, per favorire un decentramento dei propri codici culturali. Per esempio, nel laboratorio sulla protesta collettiva, Piazzoli ha invitato i partecipanti a ca-larsi nei panni di giornalisti giapponesi che lavorano per una rivista di italiani-stica in Giappone. I giornalisti doveva-no poi recarsi in Italia per scrivere un reportage sull’Italia, cercando di salva-re il loro posto di lavoro e l’onore, mi-nacciato dalla possibilità di chiudere la casa editrice. I giornalisti, dopo avere preparato un’intervista a loro scelta, si vedevano coinvolti, loro malgrado, in una manifestazione di tranvieri, scena ripresa dal pretext dall’apertura della commedia “Sotto paga!”. La protesta non solo impediva loro di raggiungere il luogo dell’appuntamento, ma li ave-va costretti ad improvvisare un’intervi-sta di emergenza con i manifestanti. In questo modo, i partecipanti erano stati in grado di rivivere elementi della cultura italiana, alla quale erano ormai
stati condizionati ad associare determi-nati elementi, con una visuale comple-tamente diversa. Ricchi di questa pro-spettiva, i partecipanti erano poi stati in grado di traslare le loro impressioni nel dibattito del forum comunicativo, terza strategia descritta dalla relatrice per aumentare la CIC.
Tramite queste strategie era stato possibile rendere esplicite le percezioni culturali dell’apprendente verso la sua cultura d’origine e il suo ruolo di me-diatore culturale fra questa e la cultura bersaglio, favorendo quella che Byram defi nisce la competenza comunicativa interculturale (1997). Piazzoli propone un modello di crescita interculturale che, partendo dal decentramento dei propri codici culturali, ha portato la maggior parte dei partecipanti del pro-getto a rivivere l’esperienza con l’altro, permettendo, a sua volta, una crescita della consapevolezza interculturale.
Il modello proposto interpreta questo processo come un percorso di crescita graduale, il cui sviluppo è sog-gettivo e strettamente correlato con la motivazione personale ad apprendere la lingua straniera.
Produzione spontanea
La ricerca conferma inoltre che il process drama infl uisce positivamente sulla motivazione del discente, agevo-lando l’interazione sociale e di nego-ziazione in un contesto stimolante sia a livello cognitivo che affettivo, facili-tando una produzione più spontanea. La ricerca suggerisce che questa meto-dologia è effi cace per ridurre il fi ltro af-fettivo dei discenti e ridimensionare la gerarchia insegnante/studenti, crean-do le condizioni necessarie per instau-rare la sinergia culturale fra docente e studenti che è alla base dell’educazio-ne interculturale. Su queste premesse, i risultati della ricerca confermano l’im-portanza di ruolo, contesto e tensione drammatica (intrinseca al percorso di-dattico del laboratorio) per sviluppare disinvoltura nelle proprie abilità comu-nicative.
Tecnica didattica o metodologia autonoma?
Rispondendo ad uno dei quesiti posti dal Dr. Nofri in apertura del con-vegno, Piazzoli riporta che, se all’inizio della ricerca aveva ipotizzato di usare il process drama come una metodologia autonoma, l’esperienza le ha sugge-rito che questa rappresenta piuttosto una tecnica didattica da integrare
Bibliografi a
Araki-Metcalfe, N. (2001) Where is Tora? Implementing Process Drama in Japanese Language Classes at an Au-stralian Primary School. Master Thesis: The University of Melbourne.
Araki-Metcalfe, N. (2007) The Wa-terhole: Using Educational Drama as a Pedagogical Tool in a Foreign Lan-guage Class at a Public Primary School in Japan. Parkville: University of Mel-bourne.
Alred, G., Byram, M. & Fleming, M. (eds.) (2003) Intercultural Experience and Education. Clevedon: Multilingual Matters.
Bolton, G. (1979) Towards a Theo-ry of Drama in Education. London: Longman.
Bolton, G. & Heathcote, D. (1998) Teaching Culture through Drama. In: Byram, M. and Fleming, M. (eds.) Lan-guage Learning in Intercultural Per-spective. United Kingdom: Cambridge University Press.
Byram, M. (1997) Teaching and As-sessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
Fleming, M. (1998) Cultural Awareness and Dramatic Art Forms. In: Byram, M. and Fleming, M. (eds). Language Lear-ning in Intercultural Perspective. Uni-ted Kingdom: Cambridge University Press.
Fleming, M. (2003) Intercultural Ex-perience and Drama. In: Alred, Byram & Fleming (eds.) (2003) Intercultural Experience and Education. Clevedon: Multilingual Matters.
Fo, D. & Rame, F. (2008) Sotto Paga! Non si paga! Torino: Einaudi.
Kao, S. M. & O’Neill, C. (1998) Words into Worlds: Learning a Second Lan-guage through Process Drama. Lon-don: Ablex Publishing Corporation.
Liu, J. (2002) Process Drama in Se-cond Language and Foreign Language Classrooms. In: Braure, G., (ed.) Body and Language: Intercultural Learning Through Drama. Westport: Ablex Pu-blishing.
Marschke, R. (2004) Creating Context, Characters and Communications: Fo-reign Language Teaching and Process Drama. Brisbane: QUT, School of Cul-tural and Language Studies in Educa-tion.
O’Neill, C. (1995) Drama Worlds: A Framework for Process Drama. Heine-mann: Portsmouth.
73
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08all’approccio comunicativo. A questo riguardo fornisce alcuni suggerimenti pratici per mantenere un equilibrio fra fl uency e accuracy onde evitare uno sbilanciamento fra forma e signifi ca-to: integrare il laboratorio-classe con ricapitolazioni linguistiche, non solo alla fi ne della fase rifl essiva, ma anche dopo ciascun episodio, integrando la ricerca presentata con uno studio più recente (Marschke, 2004) e con le rac-comandazioni di un teorico del process drama LS (Liu, 2002).
Verso una sinergia fra glottodidattica
e recitazione
Infi ne, i risultati della ricerca iden-tifi cano un fattore fondamentale che il docente di lingue straniere, privo di esperienza nel campo del teatro, deve tenere in considerazione nell’adottare con successo il process drama: la ten-sione drammatica. Questa viene intesa
Stinson, M. (2008) Process Drama and Teaching English to Speakers of Other Languages. In: Manuel J., Hughes J., Anderson, M. & Arnold, R. (eds.) Dra-ma and English Teaching: Imagination, Action and Engagement. Oxford: Ox-ford University Press.
Slade, P. (1954) Child drama. London: University of London Press.
Way, B. (1967) Development Through Drama. London: Longmans
come quella curiosità elettrizzante che spinge un lettore a leggere un libro tutto d’un fi ato, ad anticipare la scena di un fi lm o, nel caso della didattica teatrale, a coinvolgersi pienamente in una attività immergendosi nel contesto immaginario. Questo fattore, intrinse-co alla riuscita del laboratorio e diret-tamente relazionato alla motivazione, se sottovalutato può compromettere la validità e l’effi cacia della sinergia fra recitazione teatrale e glottodidatti-ca. Alla luce dell’esperienza riportata, Piazzoli identifi ca l’abilità del creare e sostenere tensione drammatica come la principale lacuna che un docente di lingue straniere deve colmare per riuscire ad implementare un approc-cio teatrale in una classe L2. Proprio questo concetto vedrà la ricercatrice impegnata in un dottorato di ricer-ca a partire dal 2009, per studiare la correlazione fra tensione drammatica, competenza comunicativa e consape-volezza interculturale.
74
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 Lo spettacolo (dal mimo, al can-to, alla danza, al teatro) è stato spesso associato all’educazione
e alla linguistica educativa2: questa di-mensione interattiva e “festosa”, che vede il coinvolgimento di vari codici e canali comunicativi, si coniuga infatti con i più diversi obiettivi didattici, fra cui quello dell’insegnamento della lin-gua straniera.
Seppur con alterne fortune nelle
diverse epoche storiche e nelle varie aree geografi che, il teatro in partico-lare (inteso come “rappresentazione teatrale”) è stato sempre legato all’ap-prendimento della lingua non materna: dalla semplice ripetizione e imitazione del parlato del docente, alle tecniche di simulazione più strutturate, come la “drammatizzazione” o il “role-play”, introdotte negli ultimi trent’anni del secolo scorso con l’approccio comuni-cativo di origine anglosassone3.
Anche se non è terminologicamen-te corretto parlare di un “metodo” di insegnamento linguistico riferendoci
all’uso del teatro, si tratta certamente di una “tecnica olistica”, che mette in gioco tutto l’individuo, con la sua lin-gua ma anche con i suoi codici espres-sivi non verbali (l’abbigliamento, i ge-sti, la postura del corpo, le espressioni del viso, le modulazioni della voce),4 con le sue emozioni e con i suoi sensi (vista, udito, tatto), in una sorta di ap-prendimento “multimediale” e “mul-timodale”. In questa prospettiva, fare teatro in una lingua straniera rappre-senta un’esperienza psicologicamente forte e signifi cativa, che può abbassare il fi ltro affettivo, accrescere l’autostima e favorire l’acquisizione, se vissuta po-sitivamente, secondo quanto viene il-lustrato da alcuni approcci umanistico-affettivi, di ambito nordamericano5.
Ma “fare teatro in lingua stranie-ra” non rimanda solo ad una simula-zione pedagogica o a un’emozionan-te scoperta di sé: è anche un evento socialmente signifi cativo, realizzato fra pari e fi nalizzato alla rappresentazio-ne per un gruppo di persone estranee al progetto6. Il piacere legato alle fasi della rappresentazione si fonde qui con quello legato all’apprezzamento del pubblico, ma colloca l’acquisizio-ne anche nel quadro dell’uso veicolare della lingua, dell’apprendimento col-laborativo e del confronto intercultu-rale, secondo i principi dell’approccio orientato all’azione e alla spendibilità sociale dei saperi, come suggerito dal Quadro Comune Europeo di riferimen-to per le lingue.7
Fare teatro nella classe di italiano come lingua straniera rimanda anche ad altre questioni: quella della lingua e quella delle tipologie di testi. La lingua
di Lucia Alessio e Pierangela Diadori1
Il Teatro di Figura per l’insegnamento
dell’italiano L2
1 Questo contributo è frutto di una stretta collaborazione fra le Autrici (concezione, di-scussione, elaborazione); tuttavia, la responsabilità di redazione fi nale va ripartita nel modo seguente: Pierangela Diadori è autrice del paragrafo 1; Lucia Alessio è autrice dei paragrafi 2 e 3.
2 Basti ricordare il suo ruolo nella formula pedagogica dei Gesuiti come parte integrante della formazione dei giovani nel XVI secolo.
3 Sul teatro come strumento glottodidattico rimandiamo, fra gli altri testi di ambito anglosasso-ne, a: Butterfi eld A., Drama through language through drama, Banbury, Kemble 1989; Holden S., Drama in language teaching, Harlow, Longman 1981; Maley A., Duff A., Drama techniques in foreign language learning, ELT Documents 77/1, The British Council 1977; Schewe M., Shaw P. (a cura di), Towards drama as a method in the foreign language classroom, Frankfurt am Main, Peter Lang 1993.
4 Cfr. Elam K., Semiotica del teatro, Bologna, Il Mulino 1988.
5 Ci riferiamo in particolare al “Natural Approach”, alla “Total Phisical Response”, al “Silent Way” e alla “Suggestopedia” . Sui metodi di insegnamento delle lingue straniere cfr. Ho-watt A.P.R., A history of English language teaching, Oxford, Oxford University Press 1984; Serra Borneto C.(a cura di), C’era una volta il metodo, Roma, Carocci 1998.
6 Così lo intende Caterina Cangià, distinguendolo dal “drama” (modalità di fi nzione de-stinata alla rappresentazione scenica in classe) e da “theatre” (attività extracurricolare, allo scopo di mettere in scena un prodotto di giovani attori). Cfr. Cangià C., L’altra glottodidat-tica. Bambini e lingua straniera fra teatro e computer, Firenze, Giunti 1998.
7 Cfr. Consiglio d’Europa, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge, Cambridge University Press 2001 (trad. it. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valu-tazione, Firenze, La Nuova Italia 2002) ( <http://culture.coe.fr/langues>)
75
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08del teatro italiano “colto”, dalle origini ad oggi8, mette in gioco continuamen-te le diverse varietà linguistiche (scritto e parlato, lingua standard e dialetti, italiano colloquiale e italiano lette-rario) e il prestigio di certe tradizioni teatrali regionali (come quella veneta o quella napoletana). Ma a fi anco del teatro che nasce come testo letterario (anche se pensato per la scena) esisto-no anche altri fi loni, più orientati verso l’oralità, l’improvvisazione, l’azione, come il teatro di fi gura (noto anche come “teatro dei burattini”).
Il teatro di fi gura
Il teatro di fi gura presenta carat-teristiche proprie rispetto a quello di attori e un linguaggio specifi co9 che si può rivelare favorevole all’appren-dimento dell’italiano L2. La fi ssazione dei personaggi a una maschera, anche verbale, rimanda a caratteri e tipi uni-versali che possono rappresentare un punto di partenza per lo sviluppo delle competenze linguistiche e un luogo di confronto interculturale. L’assenza di un testo drammatico e la presenza di convenzioni e schemi narrativi fi ssi permettono di sfruttare la creatività degli apprendenti attraverso l’improv-visazione e insieme di inserirla entro un contesto comunicativo semplifi ca-to rispetto a quello della interazione spontanea. Questo genere teatrale è pertanto più aderente alle esigenze degli apprendenti, anche ai livelli ini-ziali di apprendimento.
La caratteristica “stilizzazione” del teatro di fi gura ne fa uno strumento di facile leggibilità; il fatto che la real-tà più che imitata venga rievocata in modo simbolico, lo libera dai vincoli spazio- temporali del teatro di attori, permettendo di trasferire facilmente su di esso elementi fantastici ed emotivi. Il fatto che gli attori non appaiano diret-tamente sulla scena permette di proiet-tare sui personaggi caratteristiche che non necessariamente si sarebbe dispo-sti ad attribuire a sé stessi, superando quell’istintivo imbarazzo che impedisce di parlare una lingua che non si domini ancora perfettamente e abbassando il fi ltro affettivo. Per questi motivi il tea-tro di fi gura viene spesso usato anche in contesti terapeutici e riabilitativi e può rappresentare un valido strumen-to di integrazione. Il teatro dei burattini
oltre a essere inserito entro una ricca tradizione popolare italiana, rappre-senta una delle poche testimonianze della Commedia dell’Arte, che tanta infl uenza ha avuto sul teatro di tut-ta Europa. Date le sue caratteristiche espressive legate alle varietà dialettali, la lingua che lo caratterizza può essere utilizzata come un ponte tra varietà e lingua standard, percorribile in entram-be le direzioni a seconda dei bisogni degli apprendenti.
Dal punto di vista pratico il teatro dei burattini fi gura richiede tempi brevi di realizzazione e mezzi minimi di alle-stimento, può essere quindi facilmente adattabile al lavoro in classe anche in assenza di spazi scenici veri e propri. Si presta inoltre ad un’organizzazione del lavoro in piccoli gruppi.
Il laboratorio di teatro di fi gura, ol-tre a utilizzare le tecniche centrate sul gesto e la parola proprie del laborato-rio teatrale, offre l’occasione di stabi-lire numerosi scambi comunicativi nel momento in cui si decida di far costru-ire i burattini agli apprendenti.
Esperienze con il teatro di fi gura per l’insegnamento
dell’italiano L2.
Riporteremo i risultati di tre espe-rienze, da noi fatte con apprendenti dalle diverse caratteristiche. Le espe-rienze sono sempre state inserite in un project work che aveva come macro obiettivo fi nale l’allestimento di una rappresentazione per un pubblico se-lezionato.
Le prime esperienze con questo genere teatrale nella classe di italiano L2 hanno avuto luogo al Liceo Scienti-fi co Piero Gobetti a Bagno a Ripoli (Fi) dove le classi quarte, che hanno come seconda lingua il tedesco, e gli studen-ti della Sophie Charlotte Oberschu-le (Gymnasium) di Berlino fanno dal 1988 uno scambio in cui gli studenti tedeschi passando una settimana a Bagno a Ripoli, ospiti delle famiglie dei loro coetanei italiani. In seguito gli studenti italiani soggiornano una set-timana a Berlino. La mattina, quando i ragazzi italiani frequentano le lezioni scolastiche, gli studenti di Berlino se-guono un corso di lingua italiana che si svolge nei locali del liceo Gobetti in concomitanza delle lezioni. Il corso di
8 Cfr. Trifone P., L’italiano a teatro. Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa, Istituto Poligrafi co Editoriale Internazionale 2000.
9 Cfr. Allegri L., Per una storia del teatro come spettacolo; il teatro di burattini e di mario-nette, Centro studi e archivio della comunicazione, Università di Parma, Parma 1978.
76
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 italiano L2 di solito prevede 14 ore di lezione frontale suddivise in 4 giorni. L’idea del teatro dei burattini è nata dal desiderio di trovare un’attività che fosse motivante e adatta a questi par-ticolari apprendenti, dando un senso all’esperienza del contatto con la lin-gua italiana che per la maggior parte di loro sarebbe probabilmente rimasto senza seguito (gli studenti infatti non studiavano italiano a scuola). Nel 2003 è stato allestito il primo laboratorio di teatro di fi gura che impegnava circa 4 o 5 ore del tempo disponibile, al quale ne sono seguiti altri quattro, organiz-zati con alcune variazioni (partendo da un testo riadattato dall’insegnante nel 2003, da un testo scritto apposi-tamente per gli studenti nel 2004, da testi prodotti dagli studenti sulla base di un copione nel 2005, nel 2006 e nel 2007, dalla autonoma costruzione sia dei burattini che dei testi da parte degli apprendenti nel 2008). Nel corso degli anni l’esperienza si è senza dub-bio arricchita e nell’ultima sperimen-tazione sono state anche impiegate tecniche centrate sulla consapevolezza corporea e l’articolazione fonetica. Nel 2004, 2005 e 2008 è stato sommini-strato un questionario riguardante in particolare l’aspetto motivazionale e l’impatto emotivo dello spettacolo sugli apprendenti, il ruolo dell’inse-gnante e l’aspetto sociale, oltre a un giudizio sull’infl uenza di questa atti-vità sull’apprendimento dell’italiano L2. Dai risultati dei questionari appare chiaro che questa attività rappresenta qualcosa di nuovo e inusuale nel qua-dro dell’insegnamento delle lingue straniere. Ciò determina una qualche insicurezza negli apprendenti sul suo valore didattico. Gli studenti si sento-no rassicurati dal sapere, momento per momento, quello che andranno ad ap-prendere, pertanto fanno affi damento sulle attività più strutturate rispetto a quelle più libere. In secondo luogo è evidente il valore motivante del pro-getto teatrale, come anche della possi-bilità di esprimere la propria creatività costruendo i burattini e inventando le storie. Ciò ci sembra confermato dal fatto che la stragrande maggioranza degli studenti ha dichiarato di essersi ben preparata per la rappresentazione e che il giudizio sulla rappresentazio-ne sia stato molto positivo. L’impegno messo dagli apprendenti nella costru-zione dei burattini nel laboratorio del 2008 mostra come anche questa atti-vità sia molto motivante, sebbene non sia stata sempre realizzabile per ragioni di tempo. Quanto all’aspetto emotivo,
emerge che l’aver dato agli studenti la possibilità di creare essi stessi le storie ha permesso loro di usare un livello di lingua adeguato alle loro possibilità, contenendo la loro ansia e dando loro la sicurezza di aver raggiunto il proprio obiettivo. Viene confermata anche l’importanza del lavoro autonomo e di gruppo, dove il naturale timore di un giudizio da parte dei compagni e dell’insegnante viene compensato dal piacere di lavorare insieme. Emerge inoltre con evidenza il ruolo dell’inse-gnante come co-autore e consulente, fonte di aiuto e di collaborazione. Ciò è dovuto, a nostro parere, dal molti-plicarsi delle occasioni di scambio indi-viduale che si verifi ca durante questo tipo di attività, che permette una di-versifi cazione degli interventi e un più diretto coinvolgimento da parte degli studenti nello scambio comunicativo. Dall’analisi della comunicazione in classe emerge infatti la preponderanza degli scambi individuali insegnante-studente e studente-insegnante du-rante il laboratorio. Più del 50 % degli studenti, in tutte e tre le sperimenta-zioni, ritiene infi ne che organizzare una rappresentazione con i burattini aiuti nell’apprendimento della L2, in particolare sia coadiuvante rispetto alla competenza fonetica e fonologica.
Nella seconda sperimentazione si è svolta con gli studenti americani del Benedectine College (Atchinson, Kansas) in Italia per lo Spring Semester 2008. Gli studenti svolgevano un pro-gramma di Study Abroad nella strut-tura residenziale di villa Morghen, a Settignano (Firenze), presso il Tolomei Cultural Institute, dove si è svolto an-che il laboratorio. Gli studenti oggetto della sperimentazione frequentavano, assieme ai loro compagni dello stesso livello, un corso di lingua italiana di li-vello A1-A2 che prevedeva 74 ore di lezioni frontali e 50 di studio individua-le. Il laboratorio di burattini è iniziato la quarta settimana del programma, svolgendosi due volte alla settimana per 10 ore complessivamente com-preso lo spettacolo. Le interviste di 5 apprendenti che avevano seguito il la-boratorio di burattini sono state messe a confronto con quelle di un numero corrispondente di studenti che aveva-no frequentato lo stesso corso di ita-liano L2 svolgendo, parallelamente al laboratorio di burattini, altre attività integrative. Abbiamo anche sommi-nistrato due test, uno per verifi care il riconoscimento del lessico utilizzato nel corso di Italiano L2, l’altro per ve-rifi care, a distanza di tempo, il ricono-
Lucia Alessio: Laureata in Filosofi a presso l’uni-versità degli Studi di Firenze. Ha insegnato, a partire dal 1985, l’italiano a stranieri in vari enti pubblici e privati (Istituto Italiano di Cultura a Vienna, Deutsches Institut Florenz, Centro Linguisti-co Università di Firenze, Vander-bilt University). Si è specializzata alla Scuola di specializzazione in didattica dell’italiano come lin-gua straniera dell’Università per Stranieri di Siena con una tesi sul teatro dei burattini nella classe di L2. Ha tenuto un Workshop sul teatro di fi gura italiano presso il Centro Linguistico dell’Università di Firenze e presso l’Istituto Italia-no di Cultura di Amsterdam. At-tualmente insegna storia e fi loso-fi a al liceo e sta per concludere un Dottorato di Ricerca in Linguistica e Didattica della lingua italiana a stranieri presso l’università per Stranieri di Siena. Ha pubblicato: Teatro dei burattini nell’insegna-mento della Lingua2, in Language Teacher Education and Training: Italy and Europe. Educazione e Formazione dei docenti L2: Italia e Europa, CEFTrain Day – Giorna-ta CEFTrain (Firenze, Italiy, 7 May 2005) a cura di Elizabeth Guerin, 2005; Il teatro dei burattini come strumento didattico, in P. Diado-ri, La DITALS Risponde 4, Guerra, Perugia 2006; con Andreina Sga-glione Invito a teatro. Insegnare italiano a stranieri attraverso testi teatrali italiani, Edilingua, Atene 2007.
77
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08
scimento del lessico utilizzato durante il laboratorio di burattini.
Dall’analisi dei dati abbiamo potu-to constatare per il gruppo che aveva frequentato il Laboratorio:
• una maggiore accuratezza fonologica;• una maggiore accuratezza e complessità morfologica;• una maggiore appropriatezza nell’uso del lessico;• una maggiore competenza semantica;• una maggiore produttività;• una competenza pragmatica più sviluppata.
L’ultima sperimentazione è stata messa in atto presso la Fraternità del-la Visitazione, una casa di accoglienza per donne con fi gli a Pian di Scò (Arez-zo). Il laboratorio, di circa 40 ore di-stribuite in 20 settimane, ha coinvolto sia donne italiane che straniere prove-nienti da paesi diversi (Albania, Roma-nia, Camerun) la cui lingua presentava tratti di fossilizzazione.10 Il laboratorio è iniziato dalla costruzione dei burat-tini con la tecnica della carta-colla. Le donne avevano come scopo fi nale la rappresentazione di uno spettacolo per i propri fi gli e per gli altri bambini
di Pian di Scò che sarebbe avvenuta in occasione del carnevale presso il locale circolo ACLI. In questa occasione è sta-to possibile osservare quanto la costru-zione dei burattini sia essenziale per la motivazione e come rappresenti uno straordinario “pre-testo” drammatico. Qui infatti si realizza quella unità tra creatività e operare concreto che è alla radice di ogni atto creativo. Le storie sono infatti scaturite dai burattini stes-si. Le partecipanti erano state invitate a pensare a una storia che rappresen-tasse un messaggio per i propri fi gli: ne sono nate spontaneamente cinque brevi rappresentazioni, ognuna delle quali integrava alle tradizioni del pro-prio passato una visione sul presente e sul futuro mettendo in scena i timo-ri, i desideri e le speranze di ognuno. In ogni storia era anche presente una canzone, una fi lastrocca, un verso poetico nella propria L1, e in questo modo il laboratorio è divenuto anche un momento di incontro e confronto tra culture diverse.
Dopo lo spettacolo è stato sommi-nistrato alle partecipanti un questiona-rio simile a quello usato per gli studenti tedeschi nella sperimentazione al liceo Gobetti, dal quale è risultata la portata
apprendenti giovani-adultianalisi comparativa tra un gruppo sperimen-
tale e un gruppo di controllo
apprendenti adolescenti e adulti immigrati
analisi qualitativa sulla percezione del laboratorio
tipo di prova obiettivi della valutazione tipo di prova obiettivi della
valutazione
• analisi dell’intervista registrata in uscita
• interazione faccia a faccia parzialmente strutturata (entrambi i gruppi)
• accuratezza fonologica
• produttività (numero di parole media di parole-frase)• appropriatezza
morfologica
• conoscenza e usodel lessico
• competenzametalinguistica
• competenza pragmatica e sociolinguistica
• analisi del questionario in uscita
• percezione dell’attività laboratoriale
• percezione del gruppo
• valutazione dellapartecipazione dei conduttori del laboratorio• valutazione dell’utilità del laboratorio per lo sviluppo della competenza linguistica
10 Cfr. Vedovelli M.., “Fossilizzazione, cristallizzazione, competenza di apprendimento spontaneo”, in: A. Giacalone Ramat, M. Vedovelli (a cura di), Italiano lingua seconda / lingua straniera. Atti del XXVI congresso della società di linguistica italiana. Siena, 5-7 no-vembre 1992, Bulzoni, Roma 1994, pp. 519-548.
Schema delle prove utilizzate
78
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 positiva dell’esperienza sia per l’inte-grazione nel gruppo e nella comunità di Pian di Scò, sia per l’apprendimento della lingua italiana per le partecipan-ti straniere. Molte di esse infatti, pur avendo un buon livello di competenza, presentavano tratti di fossilizzazione e nel corso dell’attività hanno avuto modo di rendersi conto dei limiti del-le proprie capacità espressive e della necessità di progredire nell’apprendi-mento dell’italiano.
Sintetizzando i risultati di queste pur limitate e parziali esperienze cre-diamo di poter concludere affermando che il teatro dei burattini possieda un intrinseco valore per l’apprendimento dell’italiano L2:
valore affettivo: permette di utilizzare le tecniche di drammatizzazione evitando
Pierangela Diadori: è Professore Associato in Didat-tica delle Lingue Moderne (L-LIN-02) e Direttore del Centro DI-TALS dell’Università per Stranieri di Siena. Insegna “Teoria e storia della traduzione” e “Progettazio-ne didattica per l’italiano come seconda lingua” presso l’Univer-sità per Stranieri di Siena, dove è responsabile del percorso “italia-no L2/LS”. Dal 1998 al 2005 ha tenuto per affi damento i corsi di “Didattica dell’italiano L2” pres-so l’Università degli Studi di Ge-nova. Nell’ambito della linguistica e della glottodidattica, oltre a numerosi articoli, ha pubblicato: “L’italiano televisivo” (Bonacci, Roma 1994), “Le varietà dell’ita-liano” (Bonacci, Roma 1998, con C. Coveri e A. Benucci), “Senza parole. 100 gesti degli italiani” (Bonacci, Roma 1993). Ha scrit-to anche manuali di italiano per stranieri: “Viaggio nel nuovo ci-nema italiano”, (Certosa, Firenze-Atene 1997, con M. Continanza); “Pro e contro 1 e 2” (Bonacci, Roma 1997 e 1999, con P. Barki), e ha curato i volumi “Insegnare italiano a stranieri” (Le Monnier, Firenze 2001), “La DITALS rispon-de” collana di 4 volumi (Guerra, Perugia 2005 sgg.) per la forma-zione. Attualmente sta lavoran-do a una ricerca sul parlato del docente nella classe di italiano L2 (progetto CLODIS) e coordina il progetto di ricerca interuniver-sitario “Linguaggio giuridico in ambito italo-tedesco: traduzione e insegnamento linguistico ad apprendenti stranieri”, fi nanziato dal MIUR nell’ambito dei proget-ti di internazionalizzazione per il triennio 2005-2008.
tuttavia di esporsi personalmente;valore didattico:permette agli apprendenti di esprimersi a partire dalla loro in-terlingua;permette di calare l’apprendimen-to linguistico in un contesto d’uso che può variare all’infi nito;permette lo sviluppo di abilità pragmatiche e interculturali;consente una didattica della varia-zione sociolinguistica;permette di trasformare la classe in un laboratorio dove si sviluppa-no abilità pratiche e competenze sociali e dove la lingua è usata per scopi comunicativi autentici;valore psicologico: permette agli apprendenti di pro-iettare su un oggetto altro da sé la nuova identità scaturita dall’in-contro con la L2.
79
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08A proposito delle parole didatti-ca, didattizzare, didattizzazio-ne, osserviamo che nei dizio-
nari della lingua italiana esiste solo la parola didattica, di cui viene fornita, ad esempio, la seguente defi nizione: Parte della pedagogia che ha come oggetto lo studio delle tecniche e dei metodi dell’insegnamento (Voca-bolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, Zanichelli, Bologna, 2006). Etimologicamente, questa parola de-riva dal verbo greco didàskein, che si-gnifi ca insegnare.
Curiosamente, non troviamo in al-cun dizionario della lingua italiana le parole didattizzare e didattizzazione ma, se andiamo a consultare la rete, troviamo centinaia di occorrenze di questi due termini sia in riferimento alla didattica dei testi delle varie disci-pline, dalla fi losofi a alla storia, dalla lingua straniera alla matematica, che in riferimento alla didattica dei vari generi di testo: letterario, pubblici-tario, fi lmico, canzonettistico, televi-sivo, radiofonico, fumettistico, ecc.
Didattizzare e didattizzazione, rife-riti all’unità di insegnamento/appren-dimento centrata sul testo, sono due termini che indicano tutti i processi che si possono attivare affi nché ogni elemento del testo stesso sia profi cuo nel percorso di apprendimento di una lingua e di una cultura straniera.
In particolare, se facciamo riferi-mento specifi co all’insegnamento del-la lingua italiana come lingua straniera, per didattizzare un testo si intende :
Individuato il testo da porre al centro del lavoro didattico, costruire intorno ad esso un percorso comples-so e coerente, secondo i principi che regolano l’andamento dell’unità di in-segnamento/apprendimento, affi nché ogni informazione contenuta nel testo ed ogni elemento del testo stesso di-ventino lo spunto per apprendere o approfondire tratti della lingua e della cultura italiana.
Didattizzare un testo, comunque, non signifi ca necessariamente costru-ire intorno ad esso un’unità di inse-gnamento/apprendimento completa di tutte le sue fasi. Signifi ca essenzial-mente renderlo accessibile, compren-sibile nelle sue varie componenti, e utile nel percorso di apprendimento di una lingua e della relativa cultura che lo studente sta mettendo in atto.
È opportuno, ogniqualvolta sia possibile, usare il testo autentico nel-la didattica dell’italiano a stranieri. È necessario presentare alla classe testi autentici di vario genere (pubblicità,
canzone, istruzioni d’uso, fi lm, in-formazioni, notiziari, carte storiche, geografi che, programmi televisivi, te-atrali, radiofonici, di concerti, di sagre, lettere personali, commerciali, favole, fi abe, rappresentazioni teatrali, fi ction originali, talk show, telefonate, ecc.), trasmessi da diversi mezzi (radio, tele-visione, carta stampata, rete, telefono, posta, ecc.) .
Spesso, l’insegnante che si trova a
costruire da sé i materiali didattici, fi -nisce per considerare delle fonti usuali da cui trarre i propri testi anche perché più comode da reperire e da utilizzare: il brano letterario, l’articolo di giornale, la canzone. E non si considerano altri generi di testo che invece offrono nu-merosi spunti in più alla didattizzazione.
Prendiamo in esame allora il testo teatrale, nello specifi co un brano da ‘Non si paga, non si paga’ di Dario Fo:
Antonia: Sono stata proprio for-tunata ad incontrarti…che se no, non so proprio come ce l’avrei fat-ta a trasportare tutta sta roba.
Margherita: ma si può sapere dove hai trovato i soldi per com-prare tutta sta roba?
Antonia: Te l’ho già detto, mica l’ho comprata, l’ho vinta coi punti qualità…in un sacchetto di deter-sivo poi ho trovato una moneta d’oro…
Margherita: Sì, valla a raccontare a un’altra…la moneta d’oro!
Se osserviamo con attenzione, ve-diamo che il testo teatrale è l’unico te-sto, oltre al parlato spontaneo faccia a faccia, in cui il produttore (gli attori che recitano il testo scritto dall’autore) e il destinatario (il pubblico) si incontrano realmente; è un testo molto vicino al parlato per la brevità delle frasi, per la
di Anna Comodi
La didattizzazione del copione teatrale: un valore aggiunto
80
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 densità di soluzioni retoriche (ironia, metafora, anacoluto, iperbole, ecc), per i nessi di coordinazione e di subor-dinazione spesso mancanti o collocati in posizioni inusuali, per il disordine degli elementi all’interno delle frasi e del discorso, per le diverse forme della presa di parola e dell’interruzione, per la presenza di tratti extrasegmentari, per il lessico adottato.
È un testo che offre spunti per un’analisi a diversi livelli in quanto met-te in gioco, oltre al linguaggio verbale così vicino a quello spontaneo, tutta la serie dei linguaggi integrati: il linguag-gio della mimica e della gestualità, l’intonazione, il linguaggio dell’abbi-gliamento (vestemico), degli oggetti (oggettuale) e dell’uso del corpo nella relazione con gli altri ( prossemico).
Se poi la didattizzazione del copio-ne teatrale prevede l’organizzazione di una rappresentazione fi nale con l’at-tivazione di tutti i processi necessari, allora sì che lo studente diventa il vero protagonista; non tanto e non solo come attore, ma con tutti i compiti che si trova a svolgere in un laboratorio teatrale: regista, attore, suggeritore, musicista, gobbista, fotografo, came-raman, truccatore, costumista, sceno-grafo, trovarobe, redattore di inviti e locandine, ecc.
Il fatto è che i processi che ruota-no intorno alla didattizzazione del co-pione teatrale vanno a coinvolgere la sfera dell’affettività, che è un fattore molto importante per la buona riuscita dell’apprendimento; l’insegnante non dovrebbe mai ignorarla o sottovalutar-la. Egli è solo un intermediario fra la lingua e l’allievo e deve agire come un animatore in un’atmosfera di gioco e di piacere che è una condizione essen-ziale per una reale acquisizione.
Per tutto questo ed altro si rimanda alla rivista Culturiana, Teatro e Glottodi-dattica dell’italiano, n. 2-2007, che de-dica il primo numero della nuova serie a ‘Teatro e glottodidattica dell’italiano’.
CHE COSA SIGNIFICA DIDATTIZZA-RE UN TESTO:
Organizzare intorno al testo autentico, secondo principi teorici condivisi, una serie di attività affi n-ché il testo stesso risulti utile all’ac-culturazione e all’apprendimento della lingua.
Nell’ambito della glottodidatti-ca, CHE COSA SIGNIFICA TESTO:
La centralità del testo nel proces-so di insegnamento/apprendimento di una lingua straniera è uno dei punti salienti del Framework, il documento
di riferimento per l’insegnamento e la valutazione emanato dal Consiglio d’Europa (1996, 2002). In esso si legge che ‘il testo è al centro di ogni comuni-cazione linguistica. È il legame esterno ed oggettivo fra il produttore e il rice-vente, sia che essi comunichino faccia a faccia che a distanza’.
Se poi consideriamo l’etimologia latina della parola testo, vediamo che essa deriva da textus, da cui deriva anche la parola tessuto. E come un tessuto è il risultato di un mirabile in-treccio di fi li di materiale, di colore, di spessore e di consistenza diversi, an-che il testo, come unità comunicativa, è il risultato di un mirabile intreccio di parole che, per la scelta che opera il parlante sul registro linguistico, sull’or-dine delle parole, sugli elementi che le collegano, sull’ordine delle frasi, sugli elementi che le collegano, sulle forme retoriche di cui si colorano, danno luo-go ad un testo sempre diverso.
• Quando un docente deve costru-ire materiali didattici per il proprio corso o quando vuole mettere in atto una interruzione del fl usso delle unità contenute nel manuale adottato, incontra due problemi:
1. Individuare il tipo e il genere di testo adatto alla classe
(bisogni specifi ci linguistici e comunicativi; competenze pre-gresse, metodi di studio adot-tati, età, cultura di apparte-nenza, ecc.)
2. Progettare una unità di in-segnamento - apprendimento idonea alla classe e adatta al testo prescelto
(Porre un unico testo al centro del lavoro didattico o più testi; nella fase di avvicinamento fa-cilitare, semplifi care o adattare il testo o i testi prescelti; indi-viduare le strategie da attivare per il percorso adottato; ecc.)
I tipi fondamentali di testo sono: Descrittivo, Narrativo, Argomentativo, Informativo, Regolativo o Prescrittivo.I generi di testo sono vari e pro-vengono da: letteratura, cine-ma, radio, televisione, teatro, canzone, fumetto, pubblicità, giornale, saggistica, indicazio-ni d’uso, opera lirica, annunci economici, linguaggi settoriali,
81
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08arte, favola, ecc. Il testo autentico è al centro dell’unità di insegnamento – apprendimento.
T Manipolazione
E
Avvicinamento SRifl essione grammaticale
T Ritorno
consapevoleal testo
O
La presentazione degli aspetti cul-turali avviene precipuamente nella fase di avvicinamento e di ritorno consape-vole al testo.
Alcuni testi, quali quello del fi lm, del teatro, dell’arte, del fumetto, della canzone, della televisione, dell’opera lirica, della pubblicità, ciascuno per le proprie specifi che caratteristiche, per-mettono di attivare strategie diversifi -cate che facilitano l’acculturazione e l’apprendimento della lingua.
Osservando in particolare il lin-
guaggio teatrale, esso si rivela mol-to vicino alla lingua parlata per: • la varietà e la fl essibilità delle forme di apertura, interruzione e chiusura del discorso
(beh, allora, insomma, mah, senti, guarda, no, dicevo, co-munque, okay, ecc.)
• il procedere per coordinazione piuttosto che per subordinazione
• la scarsa presenza di connettivi; la pausa o la punteggiatura al posto della congiunzione; l’uso di con-nettivi di alta frequenza
Piove. Non esco. – Gliel’ho det-to, fra noi è fi nita. – Non gli do soldi, che non studia. – Non gli do consigli, che faccia quello che vuole
• i fenomeni di ridondanza lessicale
(Bello sto fi lm, proprio bello. – Oh, bello! Me l’avevano detto che ‘sto fi lm era bello un bel po’)
• la presenza di tratti extraseg-mentari;
(esclamazioni, risate, fonosim-boli, schiarite di voce, colpi di tosse, ecc.)
• il frequente ricorso a forme en-fatiche;
(Mi sono bevuto un litro d’ac-qua dalla sete. – Mi sono fatto una dormita! – Io, per Natale, la pelliccia di visone, la voglio!! – Sei tu che mi hai cercato)
I requisiti del copione da didattiz-zare:
Il copione da didattizzare deve rispondere ai criteri di scelta del testo autentico posto al centro del lavoro didattico:
1. Autenticità(in questo senso, il copione può essere originale, adattato, rielaborato, creato ad hoc)
2. Brevità
(bisogna prevedere ripetuti passaggi sul testo, in fase di ‘lavoro didattico’ e di ‘labora-torio teatrale’)
3. Ricchezza e varietà di tratti di italianità
(lingua, storia, geografi a, terri-torio, costume, mentalità, tra-dizioni, regionalismi, ecc.)
4. Rispondenza ai requisiti fonda-mentali del testo (R.A. de Beau-grand e W. Dressler)
(coerenza, coesione, intenzio-nalità, accettabilità, informa-tività, situazionalità, interte-stualità)
Il lavoro sul testo teatrale:
• attenua l’importanza del docente • moltiplica la direzionalità nella comunicazione nel laboratorio te-atrale
• mette in campo tutto il corpo (le camminate, le posture, le risate, la stretta di mano, la mimica, la gestuali-tà, la vestemica, la prossemica)
• mette in campo le emozioni (il co-lore della parola e della frase)
• mette in campo la voglia ed il bi-
82
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 sogno di giocare
• mette in campo le diverse forme di intelligenza (logica, linguistica, spaziale, musicale, cinestetica, inter-personale, intrapersonale, naturalisti-ca, esistenziale) (Howard Gardner)
• mette in campo le esperienze af-fettive e cognitive pregresse
• permette un uso diverso dello spazio-aula
• con la presa del ruolo attenua l’importanza dell’errore
• facilità l’interdisciplinarietà (può coinvolgere gli insegnanti di diverse discipline: educazione fi sica, artistica, musicale, storia, geografi a; la collabo-razione con istituzioni del territorio: Comune, Regione, Provincia, Camera di commercio, Museo del costume, Bi-blioteca, Azienda di Promozione turi-stica, le famiglie degli studenti, ecc.)
Dal punto di vista più specifi ca-mente linguistico:
• permette di esercitare l’apparato fonatorio con molteplici attività (intonazione, volume, tempo, pause, consonanti doppie/scempie: capello-cappello, vocali aperte/chiuse: vénti-vènti, accento: rubrica-rubrìca, ecc. )
• permette diversi tipi di lettura (in-tenzionale, espressiva, articolatoria, re-citativa, per gruppi di signifi cato, ecc.)
• permette giochi vocali il gioco dei numeri (sei due !!), gli scioglilingua (C’era una volta una palla di pelle di pollo fatta da Apelle fi glio di Apollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apel-le, fi glio di Apollo.), le onomatopee (ingorgo, schizzo, miagolare, abbaia-re), l’uso delle vocali per commentare (Eeh! Uuh!), ecc.
• favorisce il parlato faccia a faccia
• favorisce la compensazione delle differenze in classe (compiti per tut-ti: regista, aiuto regista, presentatore, attori, voce fuori campo, mimi, coreo-grafi , ballerini, costumisti, scenografi , sceneggiatori, truccatori, colonna so-nora, fotografo di scena, cameraman, gobbista, suggeritore, redazione per la pubblicità, cronista, ecc.) Per vedere quali attività e strategie
permette di attivare la didattizzazio-ne di un testo teatrale, analizziamo la quarta unità del copione didattizzato: Io, la pelliccia di visone, la voglio!! di Anna Comodi.
QUARTA UNITÀ
Le camminate e le posture
Il modo di camminare, a piccoli o a grandi passi, con le spalle curve o dritte, a testa alta o bassa; il modo di sedere, a busto indietro o proteso in avanti, con le gambe accavallate o unite, con le braccia conserte o libe-re; il modo di tenere le mani, rivolte verso l’interlocutore o appoggiate sul ventre, in movimento o in tasca o in-trecciate dietro la schiena; sono tutti elementi che tradiscono la personalità e l’emotività di una persona.
• Ad esempio, come cammina: ➔ l’arrogante
➔ il timido
➔ il pensieroso
➔ il freddoloso
➔ la pettegola
• Prendiamo un banco e una sedia, mettiamo di fronte due studenti e ve-diamo come siede, durante un esame, lo studente ➔ sicuro
➔ insicuro
➔ ansioso
e come siede e si atteggia il professore ➔ arrogante
➔ autoritario
➔ distratto
• Diamoci la mano e vediamo come stringe la mano una persona: ➔ estroversa
➔ timida
➔ fi duciosa
Facilitazione del testo
Ma andiamo! ➔ Ma che dici! ➔ Ma non dire stupidaggini! ➔ Ma dove hai la testa!
83
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08
L’essenziale è ➔ L’importante è
• Nelle situazioni problematiche, l’es-senziale è non perdere la calma.• In viaggio, l’essenziale è avere sem-pre con sé il passaporto e lo spazzolino da denti.• Vieni a dormire da me, ma porta solo l’essenziale.
Scrivere che cosa è essenziale per:
vivere studiare lavorare viaggiare
ANALISI DEL TESTO
1. Ascolto globale
2. Riascolto segmentato
3. Lettura globale silente
4. Rilettura analitica
Padre: Ma andiamo, se è in otti-me condizioni, se è nuovissima?Madre: Che cosa?Padre: La tua pelliccia.Madre: Quale pelliccia?Padre: Quale? La vecchia, no!Madre: Lo vedi, anche tu dici che è vecchia?Padre: Mi fate perdere la testa...Figlia: Oh, no! L’essenziale è non perdere la testa. Anche perché senza testa non si può...
(da Achille Campanile)
5. Rilettura fi nale articolatoria.
1. “Adiectio”.• Dividere la classe in gruppi e far riscrivere il testo, aggiungendo aggettivi, preposizioni, avverbi, congiunzioni, dove è possibile.• Ogni gruppo rilegge il testo che risulta dopo l’adiectio.
2. Dettato – clozeL’insegnante detta il testo inte-grale della pagina precedente e lo studente scrive le parole mancanti negli spazi vuoti.
Padre: Ma andiamo, se è in ottime condizioni, se è ____________?Madre: Che cosa?Padre: La tua ________.Madre: Quale pelliccia?Padre: Quale? La vecchia, no!
Madre: Lo vedi, anche tu _______ che è vecchia?Padre: Mi fate perdere la testa...Figlia: Oh, no! __________ è non perdere la testa. Anche perché senza ________ non si può...
PER CONCLUDERE
Il volume
Parlando, si può regolare il tono della propria voce proprio come si fa con il tasto della radio e della televisio-ne, pronunciando parole e frasi a volu-me basso, medio e alto; combinando il colore, il tempo e il volume, parole e frasi assumono signifi cati diversi.
Ad esempio, pronunciamo la paro-la arrivederci
a. con colore di simpatia a volume alto
b. a tempo lento a volume basso
E pronunciamo la frase Hai avuto proprio una bella idea
a. con colore di entusiasmo a tempo veloce b. con colore di rabbia a volume basso
IL COPIONE DELL’ATTORE
Nel seguente testo indicate con una matita le pause che vi sembrano op-portune (che si sommano a quelle richieste dalla punteggiatura), sottoli-neate le parole che volete colorire e mettete un simbolo : -- (tempo lentissimo), - (lento), + (veloce), ++ (velocissimo); (volume altissimo),➔ (volume medio), (volume basso)
per indicare il tempo e il volume con cui pronunciarle. A fi anco del testo, annotate i gesti necessari per sottoli-neare alcuni momenti.
Padre: Ma andiamo, se è in ottime condizioni, se è nuovissima?
Madre: Che cosa?Padre: La tua pelliccia.
➔ ➔ ➔ ➔
➔
➔
84
Teatr
o e Di
dattic
a dell
e Ling
ue M
odern
e Frasc
ati 12 -
13 dice
mbre 20
08 Madre: Quale pelliccia?
Padre: Quale? La vecchia, no!
Madre: Lo vedi, anche tu dici che è vecchia?
Padre: Mi fate perdere la testa...
Figlia: Oh, no! L’essenziale è non per-dere la testa. Anche perché senza te-sta non si può... (completare in modo spiritoso).
Anna Comodi: è ricercatrice in Didattica delle Lingue Moderne presso l’Univer-sità per Stranieri di Perugia, dove insegna Lingua e Cultura italiana nei corsi di Lingua e traduzione francese – italiano ai livelli C1 e C2. Fa parte dell’équipe, coordi-nata dalla professoressa Anna Ci-liberti, che si occupa della forma-zione e dell’aggiornamento degli insegnanti di italiano come LS in loco e all’estero. È coordinatrice didattica dei corsi di formazione e di aggiornamento istituzionali dell’Università. Si occupa della formazione e dell’aggiornamento di insegnanti di italiano L2 nelle classi mistilingue della scuola ita-liana. Dal punto di vista scientifi -co, ha pubblicato lavori sull’Unità Didattica, sulle caratteristiche e sulle modalità di presentazione dei linguaggi settoriali, sul lin-guaggio dei giovani, sull’uso del testo autentico, sull’insegnamen-to della lingua italiana a stranieri in linea con il Framework, sulla didattizzazione di testi di vario genere, sull’uso del teatro nell’in-segnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri, criteri e spunti operativi per la didat-tizzazione del copione teatrale, ha redatto il Sillabo dei Corsi di Lingua dell’Università, ha redatto parte del corso di lingua (livello intermedio) del corso di laurea ICON. Ha pubblicato lavori per lo sviluppo della abilità di produ-zione orale a livello elementare e lavori per lo sviluppo delle abilità integrate a livello intermedio, co-pioni teatrali didattizzati.
Bruno MunariFilopeso (doppio quadrato), 1981
Tubi in alluminio, corda colorata e piomboCm 240 x 50 x 60
Mantova, Corraini Arte ContemporaneaBruno Munari
Filopeso (quadrato), 1981Tubi in alluminio, corda colorata e piombo
Cm 260 x 60 x 60Mantova, Corraini Arte Contemporanea
Photocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione
e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
LE FOTO CulturianaI di copertina:Luciano FabroL’Italia d’oro, 1971Bronzo dorato92 x45 cmCollection ARTISPhotocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
II di copertina:Getulio AlvianiInterrelazione cromospeculare, 1969Ambiente, materiali variCm 210 x 420 x 420Accademia Carrara, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, BergamoPhotocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
III di copertina:Luigi GhirriRimini 1977 da “in Scala”, 197717 stampe cromogeniche da negativo 24 x 36 mm30 x 40 cm con corniceEredi di Luigi GhirriPhotocredit: Santi CalecaItalics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008.INSTALLATION VIEWS, Palazzo Grassi
Rivista di linguistica, glottodidattica e informazione culturale per insegnanti d’italiano come lingua straniera
Direttore editoriale:Carlo Nofri
Direttore responsabile:Carolina Drago
Comitato scientifi co:Rino Caputo, Pierangela Diadori, Andrea Gareffi , Florinda Nardi, Carlo Nofri, Pietro Trifone
Redazione:Stefania Bucciarelli, Linda De Santis,Carolina Drago, Tiziana Migliaccio,Maria Squarcione, Giulia Todini,Roberto Tomassetti
Segreteria di redazione e amministrazione: Linda De Santis, Giulia Todini
Grafi ca ed impaginazione:Franco Mascioli, Luca Mascioli
Stampa:Tipografi a Ericom,Bucarest (Ro)
Editore Novacultur SrlVia Bocca di Leone 36 00187 Roma Tel: ++39 06 99700347Fax: ++39 06 99701566E-mail: [email protected]@culturiana.it www.culturiana.it
Periodico semestraleAutorizzazione del Tribunale di Velletri N. 13/07 del 3/7/2007
Abbonamenti (due numeri l’anno):Italia 20 Euro- Estero 30 Euro
distribuzione:Bonacci editoreVia degli Olmetti 3800060 FORMELLO Roma RM (Italia)tel: ++39-06.90.75.091fax: ++39-06.90.40.03.26e-mail: [email protected]://www.bonacci.it