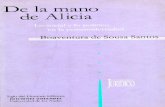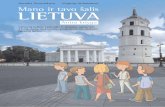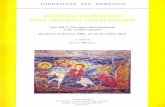La mano del Padre Cesari con una lettera inedita
Transcript of La mano del Padre Cesari con una lettera inedita
Studi per Gian Paolo Marchi
a cura di
Raffaella Bertazzoli, Fabio FornerPaolo Pellegrini, Corrado Viola
premessa di Nadia Ebani
ESTRATTO
Edizioni ETS
001_pagine editoriali ok_001_pag.edit. 17/10/11 15.40 Pagina 3
www.edizioniets.com
© Copyright 2011EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884672993-4
Questo volume è stato pubblicato con il contributodel Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
dell’Università degli Studi di Verona
001_pagine editoriali ok_001_pag.edit. 17/10/11 15.40 Pagina 4
* Si sono citati in sigla il «Giornale Ligustico» (GL) del padre Spotorno (1827-1829) e A.Cesari, Lettere ed altre scritture, a cura di G. Guidetti, Libreria salesiana, Torino 1896 (L).
1 Il ligustico [G. Bertolotto], Per un leone e una mano, in «Giornale Ligustico», XXII(1897), pp. 163-168, con sintesi di precedenti polemiche a seguito del proprio articolo sulla«Nuova Rassegna» del 1893. Cita la mano già A. Neri, Due lettere inedite di Antonio Cesari, in«Giornale Ligustico», V (1878), p. 432. A «Monsignor Rossi e la mano del Padre Cesari» Giu-seppe Pasolini, all’epoca Confaloniere di Ravenna, dedica un capitolo delle sue Memorie(Galeati, Imola 1880). Cfr. G. Guidetti, Antonio Cesari: giudicato e onorato dagli italiani, s.e.,Reggio Emilia 1903, p. 317, dove si legge la didascalia della fotografia inviata dall’allora biblio-tecario della Berio: «come si vede si tratta delle falangi incastrate in una mano di cera sopra uncuscino di seta». Stefano Rossi (Colla, oggi Coldirodi 1803 - 1857) nel 1853 legato apostolico aRavenna fece riesumare il cadavere del Cesari, ivi morto nel ‘28 e gli diede monumentale se-poltura in Duomo, con gli onori della cronaca: «Volle allora l’illustre prelato Rossi, che quellevenerande ossa coperte della s. tonaca de’figli di s. Filippo Neri, fussero legalmente ri-conosciute, e recitate le preci, e ribenedettele coll’acquasanta, accompagnolle al nuovo apposi-to e ben murato avello, con pergamena entro tubo vitreo fasciato di bandone, riferente le mem-orie di quella traslazione; contemplò egli per l’ ultima volta il teschio in cui si accolse tanto sen-no, e la bocca donde uscì tanta evangelica sapienza, e tanta copia di care eleganze di nostrafavella, ed in ultimo velò colle sue mani il volto dell’uomo famoso, tributo estremo di religiosafiliale pietà» (Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Emiliana, Venezia 1859, vol XCIII, p.238). Il Rossi scrisse memorie erudite (una su Colombo) e raccolse le sue prose sacre ed acca-demiche nel 1844 e nel ‘57. Memorabile anche come anni prima annunciò da Civitavecchia nel1842 al Segretario di Stato Lambruschini la morte a Parigi del locale console di Francia, HenriBayle: «par lui dans ses romans répandus sous le faux nom de Frédéric (sic) Stendhal nous fontplaindre la manière dont il fut brisé par la Justice divine» (Stendhal, Correspondance générale:1837-1842, par V. Del Litto, Champion, Paris 1999, p. 602). Fu bersaglio di Carducci nel suodiscorso commemorativo per il venticinquesimo del XX settembre: «Dovevano tollerare […]monsignor Stefano Rossi delegato apostolico in Ravenna, scrivente nel 1851 al governatore di
STEFANO VERDINO
LA MANO DEL PADRE CESARI(E UNA SUA LETTERA INEDITA)*
Alla Biblioteca civica di Genova da metà Ottocento si è conservata una ma-no destra «sotto una campana di vetro, in una sala della Beriana»; ma alcunidecenni dopo ad un erudito locale appariva «negletta» non meno che ignota,tanto da stimolarlo alla ricerca di un’identificazione e da un consulto nei Pro-cessi verbali del Municipio di Genova del 1857 risultò essere «la mano destradel dottissimo padre Antonio Cesari», legata alla biblioteca per testamento daMons. Stefano Rossi1.
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 783
784 Stefano Verdino
Faenza che per correggere i ragazzi delle scuole indisciplinati s’intendesse con il comandante laguarnigione austriaca che li facesse da’ soldati austriaci vergheggiare al pancone?»(G. Carducci, Prose 1859-1903, Zanichelli, Bologna 1909, p. 1264).
2 F. Della Peruta. Polemiche letterarie e civili nella Genova di Mazzini e Spotorno, in Giam-battista Spotorno (1788-1844), a cura di L. Morabito, Istituto Mazziniano, Genova 1990,p. 263.
Non furono pochi in seguito gli inchiostri nazionali di indignazione, di ri-chiesta di restituzione alla salma. Ma la mano rimase alla Berio, ora ufficial-mente identificata e riscontrata ancora nel 1939 come «curioso cimelio» (E.Apolloni, Guida alle biblioteche italiane, Milano, Mondadori). Provvide ilbombardamento del 1942 a cancellarne la contestata esibizione.
Ma a spiegare il perché proprio a Genova e alla Berio il feticista prelato ab-bia legato la reliquia non bastano le ragioni di territorialità patria. Con quel-l’insolito lascito Monsignor Rossi voleva anche rendere omaggio all’ombra diun suo caro maestro e amico, il barnabita padre Spotorno, primo prefetto del-la Biblioteca e strenuo ammiratore dell’Oratoriano veronese.
Il destino del padre Spotorno è stato duplice, da un lato apprezzato comeimprescindibile erudito locale, dall’altro ricordato con ironia o fastidio comeperfetto campione della reazione, politica e letteraria. Al convegno del suo bi-centenario, oltre vent’anni fa, le due immagini si rincorrevano di pagina in pa-gina ed i due interventi sul critico ‘militante’, rispettivamente di Della Perutaed Edoardo Villa, proponevano – con un ricco scavo documentario – su que-sto più controverso aspetto un’immagine non del tutto univoca. Lo Spotornodi Della Peruta è visto da una prospettiva mazziniana, confermando il perso-naggio inquisitorio già tratteggiato da Neri e Mannucci «con uno spregiudica-to uso della sua influenza spinto talora sino al limite della delazione»2; lo Spo-torno di Villa è inteso impoliticamente, incavato nell’erudizione, nel locali-smo, ma non senza un tratto di passionalità.
A suo agio nella Genova governata dal suo confratello e maestro Lambru-schini, il padre Spotorno allestisce i suoi monumenti eruditi (Colombo e laStoria letteraria) con un localismo certo volutamente fuorviante l’internazio-nalismo del pervasivo romanticismo, ma capace di intercettare un bisogno an-che di territorialità, di patria (minuscola) del tempo, tutta gestita al passato,per chiudere la vista al futuro. E successivamente – alla partenza per Parigidell’amato Arcivescovo – si getta nella militanza delle Gazzette, con mossa ac-corta, in modo da occupare clericalmente uno spazio nuovo e molesto, giàben avviato in molte città italiane. La sua «esasperata ligusticità» – scrive Vil-
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 784
La mano del padre Cesari 785
3 E. Villa, La critica letteraria di G.B. Spotorno, ivi, p. 311.4 Anche Cesari a Giuseppe Manuzzi: «nelle pitturette fiamminghe è maraviglioso» (28 feb-
braio 1828, L, p. 567).5 Recensendo le Canzoni pastorali di Girolamo Pompei (Silvestri, Milano 1827): «Non è
però facile a conghietturare quanto buon viso sien per far loro i Romantici, contro alla cuiscuola presenta un’ invincibile prova di fatto non solo il Pompei in Italia, ma eziandio il Ges-sner in Elvezia, i quali a ragione chiamar si possono i Teocriti de’ tempi moderni» (GL I, 1827,p. 383).
la – si motiva come surrogato identitario per il perduto stato, ma funziona an-che come un lato di un triangolo (con l’Italia e l’Europa, un’Europa infrancio-sita, ovviamente) culturale, basato su osmosi omeopatiche ma costanti, ai finidi costruzione (o ricostruzione) di una identità classicista, rilevante per un fi-ne pedagogico, che finora non è stato particolarmente messo in luce, se nonda Villa, in un passaggio, a proposito delle recensioni a romanzi di «Autorifiacchi e di nessuna notorietà», se non per «porre sotto processo un genere ela sua funzione diseducativa»3.È possibile pertanto ricostruire un progetto educativo (o rieducativo) del
padre Spotorno e del suo «Giornale ligustico», non solo in termini censori,ma anche propositivi, senza nulla togliere (anzi) al suo conclamato spirito rea-zionario. Villa ha già ben messo in luce la parte del «Ligustico» su Leopardi,sbiffato di passaggio, e sull’intoccabile Manzoni, plaudito obtorto collo, mavale la pena per entrambi ricordare due brevi rimarchevoli malignità. PerLeopardi nel ’27 ovvio silenzio sulle terribili Operette morali, ma sobria recen-sione al commento petrarchesco, con questo perfidissimo plauso «Le gentiliSignore, per le quali scrive il conte Leopardi, potranno d’ora in poi così beneintendere le Rime di Messer Francesco, come le ariette del Metastasio» (GL I,1827, p. 100). Nello stesso anno per I promessi sposi si plaude al «Quadrofiammingo di molte figure»4 (GL I, 1827, pp 678-679), ma si conclude consi-gliando l’autore a decidersi per essere uno storico e nulla più:
Egli è già glorioso tra’ Romantici; egli è grande nel genere de’ romanzi: egli ha un intellettosgombro da’ sistemi, un cuore scevro, a quanto ne pare, da vili passioni: conosce gli uomini; salegare i fatti particolari alle cause universali; non rifiuta la noja di frugare ne’ MSS: piacciagliuna volta pertanto di voler essere un valente storico italiano (p. 679).
Se è chiaro cosa il «ligustico» non voleva, meno a fuoco è il progetto pro-positivo, certo antiquario nel prospettare gli idilli del defunto Pompej comeantidoto ai Romantici5, ma non poi del tutto cieco, come dimostra la costante
055_VERDINO_005A_CHIESA 19/09/11 12.50 Pagina 785
786 Stefano Verdino
6 Della Peruta, art. cit., p. 266, che però fa riferimento solo agli interessi per il purismo delCesari.
7 «Chiuderemo questi brevi cenni, con ammonire i giovinetti studiosi a non lasciarsi darad intendere che l’illustre Cav. Monti non ad altro abbia inteso con la |proposta e 1’Appendice,che ad avvilire e il Cesari e gli Accademici della Crusca. Riguardo al chiarissimo Veronese, in-genuamente protesta di avere in molta stima quel valente letterato, e lo celebra come uno de’più bei lumi dell’ italiana letteratura. Né queste parole verran nuove a chiunque sia informatoche grande consonanza di opinioni si trovava tra il Monti ed il suo genero Conte Perticari; ed è
simpatia per il Foscolo, colto con precisione – nella Necrologia del Pinde-monte – in simbiosi con questi, tramite un azzeccato paragone all’arte:
Ugo Foscolo diede quel suo carme sui Sepolcri. Pindemonte lo seguì, ma come sanno segui-re i gran maestri, originalmente. Se il primo t’incanta col terribile pennelleggiar di Michelange-lo; t’alletta il secondo col grazioso colorir del Correggio (GL III, 1829, p. 25).
Foscolo viene anche chiamato in causa per il suo dantismo ed impiegato arinforzare il dantismo del ben diverso padre Cesari:
Che se gli studiosi vedranno consentire in un medesimo giudizio e il Cesari e il Foscolo co-tanto dissimili e per gli studj e per l’indole, ed amendue innamorati di Dante, avverrà forse chenon più si contenda intorno al vero amor patrio dell’Alighieri, e ne verrà nuova luce alla grancontesa del pregio de’ Trecentisti (GL I, 1827, p. 483).
Il padre Cesari costituisce il fiore all’occhiello del «ligustico», che non fache encomiarlo fin dalle prime pagine e lo avrà come maggiore collaboratorenell’ultimo anno di vita6. Questi è salutato sul primo numero come «l’infatica-bile P. Cesari , cui tanto debbe la dolcissima nostra favella», mentre viene lun-gamente recensito per le Bellezze di Dante e difeso da un attacco della «Bi-blioteca italiana», in modo davvero integrale, tanto da gustarne persino la se-condaria attività poetica e difendendone il formalismo («l’anonimo giornalistarimbrotta il Cesari di collocare le bellezze della poesia nelle sole parole. Manoi crediamo col filosofo e Poeta Zanotti, gran parte della poesia consisterenelle parole», GL I, 1827, p.43). Peraltro questo ha una giustificazione di tipopedagogico (contro il contenutismo romantico), che è il vero scopo – al di làdelle polemiche – del «ligustico» e della stessa vita di studioso del padre Spo-torno. Proprio chiudendo la polemica con il periodico lombardo il «Ligusti-co» chiama in causa i «giovinetti studiosi», sostenendo l’inconsistenza di unattrito tra Monti e Cesari per via dei buoni rapporti del genero Perticari conl’«illustre veronese»7. Si può dubitare della logicità transitiva del ragionamen-
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 786
La mano del padre Cesari 787
notissima la lettera di quest’ ultimo filologo in lode del P. Cesari; lettera cosi onorevole al Vero-nese, che più grande elogio non potrebbe questi, né vorrebbe desiderare» (GL I, 1827,pp. 166-167).
8 Allora primo Direttore Spirituale e Professore delle Scuole Pubbliche di Genova; scrisseDei dittongi, versi e metri, ossia, Della versificazione italiana (1838); Vita di Gesù Cristo com-pendiata ad uso della studiosa gioventù (1843) ed i versi di Il ritorno di Apollo (1831).
9 Sulla fortuna del Cesari vedi i cenni di dissenso del giovane Mazzini a Salvatore Betti:«Voi vedete le lasciviette toscane del buon Cesari starsi a fianco dell’Orlando furioso» (Edizio-ne Nazionale, vol. I, Galeati, Imola 1906, p. 90); a Sismondi (1832): «Perché le biblioteche po-polari presentano Omero, e le prose del Cesari – due estremi della catena, – al popolo che nonintende né l’uno né l’altro, invece di presentare manuali di storie patrie e insegnamenti di virtùcittadine» (ivi, vol. II, 1907, p. 5).
to, ma è chiaro lo scopo, di presentare agli educandi giovinetti come compat-to e vigoroso il fronte classicista. A rinforzo ancora un altro nome è pedagogi-camente speso, l’ottuagenario abate Colombo, ancora un prete e ancora unvecchio, recensito per i suoi Opuscoli (Parma 1827) questa volta da un siglatoB., che potrebbe essere il redattore Antonio Bacigalupo8:
Tra molti uomini di lettere, onde vantasi ora l’Italia, i più arreticati in uno o in altro partito,non d’altro si travagliano che di accendere e dilatare una indegna guerra civile, e a tutt’altro sipiacciono di rivolgere il loro ingegno che al vantaggio e alla gloria della lor patria. Pochi altriattendono a rendere con dotti scritti immortale il lor nome: i meno poi son quelli, che possanoe ad un tempo vogliano dar mano amica agli studiosi giovinetti, e scorgerli pel miglior sentieroalle cime del vero sapere, e d’ogni colta e gentile disciplina. I gran letterati non degnano inchi-narsi, i piccoli non bastano a cosi lodevole e ben locato uffizio. Onde tanto maggior gloria tor-na al chiarissimo Ab. Colombo 1’avere spese le sue fatiche in questi opuscoli, i quali lo pongo-no al paro dei più acuti e tersi filologi che onorino al presente il suolo Italiano, e riescono insie-me di buono e gradito pascolo all’ingegnosa gioventù (GL I, 1827, p. 561).
Anche in questo caso la vista pedagogica è primaria, come la volontà di ac-creditare una posizione super partes, fuori dell’«indegna guerra civile» di neo-classici e romantici. Per quanto desueta, il primario investimento in positivoche i preti del «ligustico» intendono fare con maestri come il Cesari e il Co-lombo è una sorta di rilancio dell’Eloquenza sacra.
La scommessa è meno peregrina di quanto si possa pensare e rientra in unaoffensiva canonica del clero, consapevole della funzione organica del preteverso larghi strati di popolazione e del suo ruolo educativo, solo insidiato, manon rimosso dal ciclone napoleonico. Proprio il Cesari della Restaurazione nedava diuturna prova ed il vasto e duraturo successo della sua Vita di Cristo,costruita con sequenze oratorie, lo confermano per tutto il secolo9, quel
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 787
788 Stefano Verdino
10 Con vero entusiasmo scrive il 25 ottobre ’27 ad Antonio Chersa a Ragusa: «sebbene leopere mie fossero quivi ben note a non pochi, vi trovai però tanto desiderio delle medesime introppi più altri; che io mi credo farne uno spaccio assai largo, ajutato dal caldo favore del Sig.Di Negro» (A. Cesari, Delle lettere, a cura di G. Manuzzi, Passigli, Firenze 1845, vol. I, p. 154).Prima del viaggio (22 settembre) sempre al Chersa a proposito dei Sermoni sacri del Di Negro«Egli si mostra uomo assai religioso e divoto» (p. 153).
11 In particolare con il milanese Antonio Lissoni: «Io ho molte copie delle opere mie, lequali vorrei vendere, e viemeglio tutte d’un tratto. […] Io non ci veggo altra stiva che questa,che due o tre de’ più grossi libraj, fatta società le comprassero tutte: ed essi, avendo assai largocommercio e facendo il vantaggio di un 30 o anche 35%, ne starebbero tuttavia bene» (20 set-tembre 1827, L, p. 507). E ancora: «Quello che dice della stima ecc. che ha di me l’Italia, laprego di restringerlo a Lei solamente: che certo se io fossi così ben voluto dall’Italia, come sonoda Lei, io non dovrei stentare, studiarmi, sudare, tribolare come feci per 50 anni e fo’ tuttavia,stillandomi il cervello; senza però aver potuto porre alla mia famiglia (per sola la quale io trava-glio) un fondamento sicuro e quieto al mantenere la vita […]. Ella vede, che dopo tante operestampate (e dirò anche), da non pochi lodate, io non ebbi mai una buona riscossa, non pensio-ne, non assegnamento, non onorario, né altro, che mi rispondesse di qualche frutto: ma sonodovuto andar sempre piluccando il vivere a minuto; come quelli che vivono del tradurre le al-trui opere dal Franzese» (li 2 del 1828, L, pp. 532-533); e poi: «Delle cose mie trova ella nessunamante?» (s.d., ma gennaio 1828, L, p. 541). Molto interessante l’epistolario del Cesari per do-cumentare l’affanno e la ricerca di guadagno di un poligrafo, nonché per avere notizie su com-pensi dell’embrionale mercato delle lettere, come quello di traduttore dal latino, ancora al Lis-soni: «Egli [lo Stella] mi pregò già di tradurgli le lettere di Cicerone offrendomi di Milano l. 20il foglio. Io accettai il prezzo; senza obbligarmi a tradurle tutte» (25 febbraio 1828, L, p. 564).
«Cesari, il quale sa ricavare da’ Libri santi continue istruzioni, scoprendo an-cora con particolar diligenza quel sottil veleno di seduzione, che all’età nostrainfelice si viene spargendo nell’eletto gregge di Cristo», come già scrivevaSpotorno nel ’22 prefacendo Ruth Lezioni sacre (Genova, Stamperia arcive-scovile) del domenicano Tommaso Buffa.
A partire dal suo soggiorno genovese nell’autunno del ’27 (dal 5 al 10 otto-bre) il Cesari ebbe in Genova una prediletta interlocutrice per lo «spaccio»delle proprie opere10, tema ossessivo degli ultimi anni del suo epistolario conpiù interlocutori11, come ne scrive il 28 gennaio 1828, al confratello padre Gi-rolamo De Negri, in Genova:
Io ho (me le confesso da capo) una grossa mia famiglia, della quale io sono il sostegno o ilPadre da molti anni e vorrei poterle dare uno stato sicuro e fermo: il che non ispero altrondeche dallo spaccio delle mie stampe: da che tanti miei studj non mi fruttarono altro, che di po-terla mantenere a spilluzzico: di che ringrazio Dio cordialmente (L, p. 546).
Il successo mondano del suo soggiorno genovese aveva decisamente illuso
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 788
La mano del padre Cesari 789
12 A Valerio Fontana: «Altri tre degli anni ho io guadagnati col viaggio di Genova» (13 no-vembre 1827, L, p. 516).
13 Omaggiato dal Cesari di un Sonetto sulla sua celebre Villetta, cfr. gli atti del Convegnosu Di Negro, in stampa, per l’Accademia Ligure.
14 A padre De Negri: «Il M.se Gio. Carlo Di Negro mi scrisse meraviglie dell’ardore de’letterati Genovesi del leggere le cose mie: e già ne ho mandate a lui non poche; delle quali mipromette buon spaccio. Or che sì? che per mezzo del P. De’ Negri, si spargeranno anche fra’Preti ed i religiosi!» (li 27 del 1828, L, p. 545). Analogamente ad Agostino Pendola, stampato-re: «Egli [Di Negro] s’adopera nello spaccio delle cose mie co’ nobili ed altri secolari letterati.Ella col Clero e co’ Religiosi» (14 Febbraio 1828, L, p. 558).
15 Ne scrisse a più riprese al Padre De Negri: «Le opere sono care? la spesa del porto gros-sissima, e inevitabile: si fa loro il vantaggio del 30, o 40 per 100. E or che vogliono averle in do-no? Ella faccia per altro da padrone» (16 aprile 1828, L, p. 582). E ancora: «Denari non ebbipunto. Anche delle cose che ella mi chiese e le mandai, ella nulla spaciò, eh? Le pare che in Ge-nova faccia freddo? Oh! son care! Ma ella ebbe pure da me la podestà di darle col vantaggioche ella credea: e pure, nulla» (25 luglio 1828, L, p. 617).
16 Non ci furono rapporti diretti (Spotorno era assente quando Cesari fu in Genova), il cita-to padre De Negri era il tramite («Quanto al Direttore del Giornale Ligustico, credo che eglivorrà qualche brano di forte eloquenza, tratto dalle opere mie già stampate. Se così è, mandan-done io alcune copie torrà quello che più gli piaccia: massime delle orazioni che ho poste nel fi-ne di ciascuno de’ 5 tomi della Vita di G. C. Quanto a Sordi Muti: io, tornato da Genova, hoscritto e recitato nella nostra Chiesa due ragionamenti sopra questa materia. Se egli volesse stam-pare cotesti, glieli manderei; ed egli me ne darà un numero ragionevole di copie: trovando ioperò modo di mandargli il manoscritto, senza ingrassare la posta e spolpar me», L, pp. 546-547).
17 Su impianto dell’autore come scrive nella citata lettera al Pendola: «Quanto a’ brani con-
il povero oratoriano veronese12, che progettava una doppia azione editoriale,con nobili e letterati, tramite il cortese marchese Di Negro13 (per cui vedi lalettera inedita in appendice), con i religiosi tramite il quasi omonimo sopra ci-tato padre filippino14. Anche se i progettati guadagni di stampe non ci furono(amareggiando non poco il Cesari nei suoi ultimi mesi)15 ed il marchese DiNegro gli risultò a dir poco inadempiente:
Il maggior punto è quello del M. di Negro, anche questo mancherebbe. In breve: io gli man-dai copie per franchi 30653… Tra posta, dazio, legatura spesi non poco, feci il vantaggio del 50p. %. Mi mandò testè franchi 205.44, colla nota delle opere che gli sono rimase; che sono assai:ed ella dice; L’assicuro che tutte le cose sue sono vendute, eccetto una Vita di G. Cristo, ec. Checosa è questa? volle forse il Di Negro scherzare? ovvero altro? Per carità: ella vede termine nelquale io sono con tale persona. Mi raccomando al suo amore. […] O Genova! Genova!» (alpadre De Negri, 25 Luglio 1828, L, pp. 617-618).
Resta il fatto che egli fu come adottato dal «Ligustico» e da Spotorno16,che nel contempo fu editore delle sue Orazioni sacre17, ribadendone, nella
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 789
790 Stefano Verdino
siderevoli di eloquenza, io le aveva scritto che dalla mia vita di Gesù Cristo se ne potevano ca-vare di qua e di là non pochi» (L, p. 556). Le Orazioni sacre stampate nel ’28 dal Pendola si ar-ticolano in quattro tomi (in sigla VC il riferimento alle riprese dalla Vita di Cristo, ed. 1817): IPel SS. Natale - Per la festa di S. Pietro - In lode del B. Aless. Sauli - In lode di S.Vincenzo Fer-reri - Al popolo Veronese; II Per li Dolori di Maria Vergine [VC14] - Per la Festa delle Reliquede’ Santi [VC6] - Sopra l’amar i nemici [VC4] - Sopra il Matrimonio [VC1] - Vantaggio, cheabbiamo per Cristo sopra lo stato della giustizia originale [VC2]; III Sopra la Verginità [VC7] -Sopra il pericolo delle ricchezze [VC8] - Sopra l’amor cristiano [VC5] - I cattivi non possonodolersi di non essere amati dai Preti [VC9] - Sopra il giudizio finale [VC10]; IV Sopra il Santis-simo sacramento [VC11] - Sopra la passione di Gesù [VC12] - Timore e conforto da prenderedal mistero della Predestinazione [VC13] - La mortificazione che Cristo comanda, ci libera dasomma molestia, e ci dà tutta la felicità possibile in questa vita [VC15] - Sopra il vestire disone-sto [VC3]. Successivamente Spotorno fa stampare le Novelle in due volumi, sempre per Pendo-la (1829), e la Vita breve di San Luigi Gonzaga (de Carli, Genova 1830), nonché l’opuscolo Fa-vole russe del Kriloff imitate in versi italiani da Antonio Cesari (Parodi, Genova 1828).
18 Cesari ne progettava una stampa completa nel piano delle sue stampe genovesi, comescrive nella citata lettera a Pendola: «manderò altresì le mie Rime piacevoli, di che Le parlai:delle quali la metà fu già stampata, è un pezzo, e finite le copie; l’altra metà uscì in fogli volantio perduti»; ed era pronto – nell’indisponibilità genovese ad un contratto pecuniario – a richie-dere un congruo compenso in natura: «Io veramente aveva pensato di darle ad un prezzo ragio-nevole in denaro: come feci di altre cose mie, ma volendomi dar copie in quella vece […] nonso se a dimandarne 200 sia ardire» (L, p. 557). Le Rime saranno invece edite postume a Milanoda Silvestri (1832).
19 Vicino ai giansenisti e amico del Degola, che scrisse sulla sua opera; ma in fama di ‘santo’super partes. Cfr. la voce di A. Dolci, in DBI, vol. IV, 1962, pp. 433-434. Ragionamento stampa-to (con il citato sonetto per Di Negro) poi anche dal nipote Pietro Cesari: Due ragionamenti diAntonio Cesari dell’Oratorio sopra le cose da lui vedute in Roma e recitati nella sua chiesa dopotornato di la l’anno 1822. Si aggiunge l’altro dopo il suo viaggio di Genova (Ramanzini, Verona1830).
prefazione, il portentoso ruolo medicale contro la peste degli errori: «Nè glierrori soltanto manifesta, e confuta, ma ne mostra, e ne sbarbica, quasi direi,l’occulta radice». Sul «Ligustico» la sua ‘mano’ lasciò non poche tracce: oltrel’offensiva delle sue rime piacevoli18, merita menzione soprattutto il «Ragio-namento» La scuola de’ Sordomuti, sull’opera del padre Assarotti19, il cui ri-tratto è davvero un’efficace trascrizione dell’emaciata illustrazione che com-pare nelle stampe d’epoca:
Chi nol conoscesse e nulla sapesse dell’operato da lui; nella prima vista direbbe: questi èuscito testé da pestilenzial malattia, non ancora in lui spenta del tutto, mostrando lui nell’aspet-to un uomo consunto e quasi dalla forza d’un velenoso morbo trasfigurato. Ma chi sa, quale siastata co’sordi la sua vita da forse quaranta o più anni, intende e crede le fatiche durate intorno aque’ miseri sì lungamente avergli rasciutto ogni sugo e vigore del corpo, e maceratolo e struttosiffattamente. A me certo, nel primo aspetto di lui, parve vedere una mummia, o uno scheletro
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 790
La mano del padre Cesari 791
20 «Il P. Assarotti creò colle sue mani in bocca loro il parlare; ed io, io medesimo (non l’avrei creduto se nol vedea) ho udito un di que’ muti leggere con articolate e chiare parole, allasfilata alcune righe di scritto, fatto da lui medesimo, o da altro de’ suoi compagni: e da un altroio mi sentii salutare col mio proprio nome e cognome scolpito. Deh Dio! che cosa è impossibilealla carità da voi seminata nel cuore degli uomini» (GL II, 1828, pp. 141-142).
21 Nel confronto tra Manzoni e Cesari: «siamo in presenza di due sensibilità teologiche divalore non poi così disuguale, ma lontanissime: da una parte c’è Pascal, dall’altra, mettiamo,san Francesco di Sales, se non sant’Alfonso» (G.P. Marchi, Per la monaca di Monza e altre ricer-che intorno a Manzoni, Libreria Editrice Universitaria, Verona 1993, p. 31).
22 Ragguardevoli orazioni del Cesari reazionario Ricorda ai Veronesi, che i danni e le enormiesazioni, che patirono al tempo del dominio francese, furono castigo di Dio per aver molti di essinegate le limosine alle chiese, e profanate le feste et tempi (1814) e I cattivi non possono dolersi dinon essere amati dai preti, ovviamente comprese nella silloge genovese. Quest’ultima particolar-mente interessante per uno studio, da farsi, su Cesari apologeta della Restaurazione: abile l’inci-pit in medias res con avviso dell’avvento del profetizzato tempo della persecuzione anticristiana(«Ce l’avea già predetto Gesù Cristo nostro maestro, spezialmente a noi banditori delle suedottrine, che per cagion sua noi saremmo odiati da tutti gli uomini […]. Non è oggidì condi-zion di persone più malvolute, ed odiate più fieramente di noi preti dai filosofi, come si chia-
d’uomo con un resticciuolo di vita; o piuttosto ho veduto in lui un vivo eloquentissimo panegi-rico della carità divina, e della virtù della religione di Gesù Cristo, che mi trasse dagli occhi lelagrime (GL II, 1828, p. 52).
Il tema della carità (di cui l’Assarotti è affilato strumento) è il perno dell’o-razione, che ripropone la forza taumaturgica della carità cristiana20 contro lacontraffazione della filantropia laica, parolaia e improduttiva, inetta a dar laparola ai muti:
Dopo le sperticate cose, che dell’amore fraterno scrissero e ripeterono in tanti libri, i filosofidel nostro tempo; i quali intesero a svergognar Gesù Cristo e la sua religione, introducendo essinel mondo la carità, e sostituendola a quella di lui; dopo tutto ciò (dico) parea che da loro sidovesse il mondo aspettare quest’ opera di tanta fatica, ma di tanto bene però degli uomini, iquali piangendo, loro la dimandavano. Ben ci bisognava un amore caldissimo: ed essi ce l’avea-no promesso, e millantato le mille volte. Ma l’amore non è parole: egli è fatti, e fatti maraviglio-si. Ed i nostri filosofi nulla ce ne hanno mostrato: anzi soffersero che i Frati ed i Preti togliesse-ro loro la mano, e l’onore di quest’opera si fruttuosa (GL II, 1828, p. 142).
Miracoli come «fatti» e non parole, secondo una fede tradizionale, che fudel Cesari come ha osservato Gian Paolo Marchi21. Un tradizionalismo co-munque d’attacco, intrigante per la modalità di costruzione del discorso traironie ed epigrammaticità, con doppio ludibrio dei «filosofi», sbugiardati nel-la vanità delle promesse di nuova società, accusati per il loro anticlericalismodi aver «tolto la mano» ai preti per «opera sì fruttuosa»22.
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 791
792 Stefano Verdino
mano, del nostro tempo», A. Cesari, Orazioni sacre annesse alla Vita di Gesù Cristo, Silvestri,Milano 1842, p. 43). Astuto il definire «nuova vostra inquisizione» la polemica anticlericale(«Vorreste per avventura rimettere in piedi una nuova vostra inquisizione, dopo aver bestem-miala e levata dal mondo la nostra? egli si pare ben certo: conciossiachè voi per questo ci tribo-late, ci bandite la croce addosso, ci screditate; e se un nonnulla diciamo che a voi non piaccia,ci accusate alla giustizia per nemici dello stato», p. 46); infine è atto di carità per l’umanità peri-clitante pregare lo sterminio di codesti ‘cattivi’ («noi pregherem Dio, che o con flagelli, o convergogne ed infamie, e con snervamento del lor potere, ed altre temporali calamità, li maceri edomi, e atterri cosi, che perfino il lor nome venga in eterna dimenticanza», p. 49).
23 P. Rebuffo, Della Eloquenza sacra. Lettere, Ligustico, Genova 1853. Sono quindici e alcu-ne «corsero in volgo per le stampe del Ligustico, figlio pubblico da me introdotto». Si citanoGiordani e Leopardi per l’eloquenza (p. 62) e, plaudito il modello Segneri, si passano in rasse-gna con lode i contemporanei Buffa, Barbieri, Villardi e «Cesari che al postutto non ebbe travivi sacro scrittore che valesse a tenergli bordone» (p. 63). Ridicolizzato da Maria Mazzini inuna lettera (7 maggio 1836) al figlio: «Agli studenti di filosofia uno di questi giorni certo preteRebuffo, professore cattolico, credo, spiegava come la parola favola significasse cosa non vera.A questo tratto di sublime erudizione gli studenti si posero a dire ora che anemmo. Padre Re-buffo si pose a rampognarli del poco rispetto al professore, minacciandoli di ricorrere al depu-tato, al Ministero e, quando non la finissero, al proprio Sovrano. A questa ultima tremenda mi-naccia un grido generale si alzò ripetendo: a ora sì che anemmo» (Lettere a Mazzini di familiaried amici 1834-1839, a cura di S. Gallo e E. Melossi, Galeati, Imola 1986, pp. 245-246).
24 Probabilmente Jean Brumault de Beauregard, vescovo d’Orléans dal 1823.25 Fascicolo uscito in evidente ritardo, dopo il luglio 1830.
Così nel «Ligustico» vi è una strategia dell’oratoria, che vanta anche unaserie cadenzata di Lettere sulla predicazione (indirizzate a don Fidelmo), stila-te da don Sincero (padre Rebuffo) e poi da lui in seguito raccolte in volume23.Da notarsi una replica di Fidelmo (Spotorno?), di esortazione a fare traduzio-ni in buona lingua della più gagliarda oratoria francese da Boussuet in poi.Può sembrare un po’ lunare questa richiesta, ma è anche il segno di una voca-zione introflessa del «ligustico» scritto da preti intenti a parlare anche (e so-prattutto) ai preti, per corroborarne le forze nel mondo avverso. E la riprovaè data dall’esempio di traduzione che don Fidelmo acclude: un’omelia del ve-scovo d’Orleans24, dopo la rivoluzione di Luglio e il suo sconcerto in ambitoecclesiastico, segno di «avvenimenti rari fra le genti, ma che il Vangelo ha pre-detti, pressura gentium, di cui i nostri maggiori provarono gravi e memorabiliesempj» (GL III, 1829, p. 592)25, rincuorando tuttavia la diocesi che l’ordine(buono, tutto sommato) regna a Parigi. I modelli del Grand Siecle si intreccia-no dunque con il lavoro artigiano sulla buona lingua e l’attualità politica esembra essere la primaria ricetta di una campagna di predicazione vasta e‘buona’ per contenuti e lingua, offerta al clero educatore, teso a non mollareun campo in cui era ancora ben attivo.
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 792
La mano del padre Cesari 793
26 La lettera si conserva alla Biblioteca Universitaria di Genova (ms b VIII 20 /35); ne citaun passaggio Neri nel ricordato studio.
Le soluzioni per una nuova apologetica furono sappiamo solo episodiche,anche se in qualche caso ragguardevoli come il successo dei famigerati Dialo-ghetti e successivamente la nascita di un moderno giornalismo clericale tra«Civiltà cattolica» e don Margotti. L’oratoria sacra costituirà ancora un genereattivo ma non mi pare che la formula prospettata dal «Ligustico» sia poi risul-tata vincente: proprio il crescente populismo del genere – per forza di cose –rendeva difficile l’esercizio della buona lingua del Cesari. La fortuna naziona-le del padre Barbieri, per di più in fama di liberale, lo conferma. Né Spotornoriuscì poi ad avere udienza neppure a Genova. In una lettera (per gran parteinedita26) al nostro mons. Stefano Rossi, il padre Spotorno manifesta per Ge-nova una sorta di forfait, sulla via della liquidazione della scialba prosecuzio-ne del «Nuovo ligustico»:
Il nostro clero dorme pacificamente senza logorarsi gli occhi su i libri; e piacesse a Dio chefosse vero ciò che ne pensa V.S. Ill.ma e Rev.ma cioè che «in perizia di moralisti niuno l’avan-zi». L’Em.mo Lambruschini, sommamente disgustato di trovare un clero così pellegrino neglistudj, si adoperava di scuoterlo dal letargo; ma chiamato a servire in ardui negozj la S.Sede, tut-to ricadde nel sopore primitivo; anzi va crescendo la negligenza e perciò l’ignoranza.Degna di un dotto e zelante Prelato sono le osservazioni sulla guerra che si fa alla Chiesa di
Cristo, specialmente colle asserzioni filosofiche de’ Tedeschi, e il bisogno di armarsi con gli stu-di migliori a difesa della Madre comune. Non mancano i soggetti capaci a pigliar la penna percontrapporre a’ libri malvagj i libri buoni, ma sono ignoti o negletti, specialmente da molti Ve-scovi, che assediati da persone nè studiose nè zelanti, li dispregiano apertamente. Aggiungasiche i più idonei non avendo nè benefizj nè aiuti, possono pregare il divin Fondatore della Chie-sa a confonderne gli avversarj, ma non hanno i mezzi di operare per la buona causa. Alcuni po-chissimi escono fuori con libriccini così inetti e pieni di tanti errori, che in luogo di giovar reca-no danno o disdoro. Veglia per altro il Signore a difesa del Suo Regno; e i grandi progressi dellaComp. di Gesù ci deggiono consolare, sperando che darà molti e grandi campioni della verità.Roma poi non mancherà certamente di eccitare lo zelo di tanti dotti uomini che ad essa da ogniparte concorrono, e potendo con beneficj ed onori premiarne le fatiche, sono sicuro che iltrionfo de’ nemici non sarà senza confusione e sconfitta (22 agosto 1838).
In questo disarmo (fidente della finale vittoria, solo nel fervorino finale),chissà se il padre Spotorno entro di sé andava rivedendo il giudizio troppo li-mitativo dato sul Promessi sposi, la cui formatività era stata invece ben ricono-sciuta proprio dal suo modello, dal padre Cesari, consapevole dei buoni fruttidella molesta pianta del romanzo, a paragone dei modi della propria arte del
055_VERDINO_005A_CHIESA 19/09/11 12.50 Pagina 793
794 Stefano Verdino
27 La lettera, autografa in un biglietto, ripiegato in due carte, scritto solo sulla prima (rectoverso) è conservato nel fondo Di Negro della Biblioteca Berio di Genova (m.r. Aut. I 2. 29).
28 Francesco Bocci (Chianciano 1752 - Genova 1828), già docente di Lettere Italiane all’U-niversità di Genova, al presente console di Toscana, «a lui [Di Negro] mi condusse la sera in-nanzi del mio partire» (A Chersa, in A. Cesari, Delle lettere, cit., p. 155); cfr. necrologia di D.Valeriani, in «Antologia», XXXI, luglio-settembre 1828, pp. 174-175.
29 Girolamo Rosasco, cfr. al p. De Negri (27 del 1828, L, p. 545). 30 Cfr. citata lettera al p. De Negri: «quel bel prete, fatticcio, rubicondo, mi mostra assai
calda brama d’aver le cose mie» (p. 546).
dire: «Quel romanzo è un trionfo della virtù; e farà troppo più frutto, che nes-sun altro quaresimale» (L, p. 567).
APPENDICEUNA LETTERA DEL CESARI AL MARCHESE GIO. CARLO DI NEGRO27
Timbro Verona 19 dicembre [1827]Ill.mo e Caris.mo Sig.re ed Amico
Il principio della sua lettera de’ 10 mi fece cader il cuore, e mi dolse quasi d’ aver concepitotroppo larghe speranze. Se non avremo a far co’ libraj, poco di bene ci verrà fatto, che essi mi-rano sempre a’ più grossi mercati. Ma mi racconsolai un poco, sentendo, che ella prendea sopradi sé (com’io già prima mi aspettava) il carico di questa faccenda: che certo a migliori mani ionon poteva essere raccomandato. Se è vero tutto ciò che ella mi disse del merito delle operemie, e dell’ardente desiderio che ne è costì: ed io medesimo l’ho ben veduto: non posso dubita-re di un largo spaccio. E ci bisogna solamente chi riscaldi gli animi: del resto, sono costì tantiletterati e persone ricche, nobili e gentili, nelle quali dee esser facile mettere del fuoco, cioè rac-cendere quello che c’è. Ella che di tutti è il primo, e tanto tenero del mio bene, ed ha tanta gra-zia ed autorità co’ primarj della sua illustre città, è la persona più acconcia a questa opera; e do-po lei, il Cav. Bocci28, persona di sì raffinato gusto e giudizio nella cosa delle lettere. Se egli vo-lesse leggere le cose mie, e gli piacessero, mi pare esser certo, che accordandosi con lei, mette-rebbe fiamme di belli e nobili desiderj negli altri. E tutto ciò mi fa sperare assai, del buon esitodella faccenda. Sazïato poi il desiderio delle persone gentili e studiose, allora potrebbesi aver ri-corso a’ libraj; a’ quali (prendendone qualche centinajo di copie) potremmo largheggiare nelvantaggio del prezzo: nella qual cosa io voglio che ella operi liberamente, come farebbe di cosesue; ed io approvo fino ad ora ogni cosa che ella farà. Fra le persone che io trovai calde d’averele opere mie fu il Professor teologo del Seminario29, del cui nome non mi ricorda. Egli è unabella persona e fatticcia30, non vecchio: e fui seco a pranzo nella villetta de’ R.P. Filippini, fuordi Genova: il qual mi pregò di mandargli le opere mie. Dunque, secondo il consiglio di Lei,manderò a Genova di costà le 12 copie di ciascuna opera mia: è veramente, che delle piccole eminute ne mandai 24 copie, come ella troverà notato, essendo facile lo spacciarle, e della Lin-gua due sole. Forse questa prima spedizione ne chiamerà un’altra maggiore. Intanto, per nongittar tempo, aspettando la venuta della balla presente, io vorrei pregarla di mandare in sua let-
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 794
La mano del padre Cesari 795
31 Cfr. al Lissoni: «ripregai lo Stella per un Librajo Reyceud di Torino; al quale mandai (orsarà due anni) alcune copie delle cose mie da vendere; e nulla ebbi anche di denaro» (1 novem-bre 1827, L, p. 515); allo stesso Lissoni chiede aiuto per quest’«altra briga»: sollecitare il Rey-ceud per mandare le rimanenze di sue opere al marchese Di Negro (23 marzo 1828, L, p. 570).
32 Sulle «gherminelle» del Canevello cfr. al De Negri (16 aprile 1828, L, p. 581).33 La stessa questione venti giorni dopo al De Negri del 9 gennaio 1828 (L, pp. 538-539);
«fagottino» poi ricevuto, cfr. citata lettera al De Negri del 27 gennaio (L, p. 545).34 Edita a Verona presso Paolo Libanti, a spese dell’autore, 1828.35 Faustino Gagliuffi, improvvisatore in latino cfr. gli Atti del Convegno su di lui dell’Acca-
demia Ligure, Genova 2009; più volte citato dal Cesari nella sua corrispondenza con il Chersa.36 «Per le troppe cortesie fatteci nella nostra dimora costì» cfr. al De Negri (li 9 del 1828,
L, p. 538).
tera al libraio Reÿceud di Torino31 questo mio viglietto, col quale ella potrà aver subito il nume-ro delle opere mie, che troverà qui notate: e con queste copie ella potrà gittar la prima scintilla,che forse leverà qualche poco di caldo, finché arrivi la balla. Mi prendo anche l’ardir di pregar-la d’un’altra cosa. Io temo che sia rimasa in cotesta dogana (per colpa mia) un fagotto, ch’iospedii un mese fa, a cotesto librajo Canevello32, e non ne ebbi risposta. Vorrei dunque che ellail facesse avvisare, che la riscuotesse dalla dogana: massime che nel detto fagotto c’era un fagot-tino al P. Compiano Filippino, da mandargli, e veggo che non l’ha avuto33, non avendo rispostoad una mia lettera, scrittagli appena giunto io a Verona. Di grazia solleciti il Canevello che man-di il fagottino al P. Compiano dicendogli della mia lettera a lui scritta. Mi perdoni queste bri-ghe. Mille grazie de’ pr. versi scritti alle Vite de’ SS. padri. Le mando il Capitolo promesso. Loraccomando alla sua fede e prudenza, essendo cosa gelosa, come ella vedrà. Il cav. Bocci è per-sona da leggerglielo; ed aspetto il parere di Lei e di lui. Ho anche altro da mandarle, il che faròal più presto. Stamperò forse in breve la orazion Pro Milone di Cicerone da me tradotta34; edella sarà de’ primi ad averla. Mille ossequi al Gagliuffi35 chiarissimo, ed agli altri Signori da’quali fui per riguardo di Lei tanto onorato. Li miei compagni sono ricordevoli delle gentilezzeinfinite36 da Lei ricevute e mi comandano di farle riverenza. Godrò le cose di Lei che mi pro-mette, ed attiverò la fecondità della mia specchiata pietà e dottrina. Segua ad amarmi come fa,ed a credermi
Tutto Suo Servo ed AmicoAntonio Cesari da V.
055_VERDINO_005A_CHIESA 13/09/11 15.33 Pagina 795
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di settembre 2011
059_INDICE DEL VOLUME_005A_CHIESA 13/09/11 15.38 Pagina 879