Inediti di fine Cinquecento alla Chiesa Nuova: Giovanni Balducci e Paul Bril
Una chiesa rupestre inedita nel centro storico di Grottaglie
Transcript of Una chiesa rupestre inedita nel centro storico di Grottaglie
18XX1.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITANEL CENTRO STORICO DI GROTTAGLIE
INTRODUZIONE
Nonostante possieda un patrimonio culturale cospicuo e signifi-cativo 1, il territorio di Grottaglie ha sempre suscitato un tiepidointeresse nei ricercatori di archeologia e storia dell’arte medievale;posta alle estreme propaggini orientali dell’arco jonico, al confinesettentrionale del Salento (Fig. 1), tale area ha pagato la sua posi-zione limitanea, con il risultato che le conoscenze in nostro possessosui secoli del medioevo sono scarse, frammentarie e si limitano adalcuni rapidi accenni in contributi di ordine più generale 2.
1 Rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti alla famiglia Vestita, la quale da anni of-
fre il fondamentale supporto logistico alle nostre ricerche e al già Assessore al Turismo
del Comune di Grottaglie arch. Vito Nicola Cavallo, che ha fortemente voluto la pub-
blicazione dei risultati di questa ricerca. Tale lavoro è stato inoltre possibile grazie alla
preziosa e insostituibile collaborazione di G. Baldacchino, O. Di Lorenzo, S. Catacchio,
F. Rollo, T. Larenza e C. Focarazzo, a cui va la mia gratitudine.2 G. BLANDAMURA, La Baronia Arcivescovile e il Castello Episcopio, Taranto, 1933; C. CAFFO-
RIO, Santa Maria della Mutata, Taranto, 1954; ID., Riggio, casale disabitato del territorio di Grotta-glie, Taranto, 1961; R. JURLARO, Ceramica medievale da Monte Salete (Taranto), in Cenacolo, IX -X (1979 - 1980), pp. 11-16; M. PELUSO, P. PIERRI, Cripte e affreschi nell’Agro di Grottaglie, Man-duria, 1981; R. QUARANTA, S. TREVISANI, Grottaglie. Vicende - Arte - Attività della città della cera-mica, Manduria, 1986; S. DE VITIS, Archeologia Medievale a Grottaglie: la “Lama di Pensiero”,Grottaglie, 1988; S. MENCHELLI, Monte Salete, in Bibliografia topografica della colonizzazione grecain Italia e nelle isole tirreniche, a cura di G. NENCI E G. VALLET, X, Pisa – Roma, 1992, pp. 473-475; una ricostruzione della storia di Grottaglie basata sul solito clichè di una occupazione ere-mitica delle gravine e sul mito di Rudiae si ritrova in F. STEA, Grottaglie: la primogenita dell’Ar-chidiocesi tarantina. Profilo storico, in Taranto: la chiesa / le chiese, a cura di C. D. FONSECA, Fasano,
18XX2.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO2
Pur tuttavia, se da un lato, negli ultimi anni, tre campagne diricognizione sistematica di superficie 3 e alcuni studi su singoleemergenze archeologiche 4 hanno dato delle prime parziali rispostealle domande sullo sviluppo degli insediamenti rurali della zona,dall’altro le informazioni sulla genesi e la trasformazione dell’attua-le centro storico rimangono insufficienti e lacunose 5.
1992, pp. 357-383; R. QUARANTA, Grottaglie nel tempo. Vicende - Arte - Documenti, Lecce, 1995;P. PARENZAN, La Gravina di Riggio, Fasano, 1995; R. CAPRARA, Società ed economia nei villaggi ru-pestri, Fasano, 2001, pp. 148-156.
3 A. ATTOLICO, M. MICELI, G. BALDACCHINO, Indagini archeologiche in agro di Grottaglie:nuove acquisizioni sul terriotorio in età medievale, in Atti del V Congresso Nazionale di Ar-cheologia Medievale (Foggia - Manfredonia, 1-3 ottobre 2009), a cura di G. VOLPE e P.FAVIA, Firenze, 2009, pp. 390-395; A. ATTOLICO, Fonti scritte ed evidenze archeologiche per unalettura delle trasformazioni demiche di un’area a nord est di Taranto: il territorio di Grottaglie trale fine dell’antichità e il medioevo (secoli VI-XIV), in Le aree rupestri dell’Italia centro meridionalenell’ambito delle civiltà italiche. Conoscenza, salvaguardia, tutela, Atti del IV Convegno Inter-nazionale sulla Civiltà Rupestre (Savelletri di Fasano, 26-28 novembre 2009), a cura di E.MENESTÒ, Spoleto, 2011, pp. 339-353; G. BALDACCHINO, Indagini archeologiche lungo le viedella transumanza: i tratturelli tarantino e Martinese nel territorio di Grottaglie, in Le aree rupe-stri dell’Italia. cit., pp. 355-363; A. ATTOLICO, M. MICELI, Insediamenti rupestri medievali diarea pugliese: i casi delle gravine dei Pensieri e di Riggio nel territorio di Grottaglie, in Insedia-menti rupestri di età medievale: l’organizzazione dello spazio nella mappatura dell’abitato. Italiacentrale e meridionale. II Convegno Nazionale di Studi (Vasanello , 24-25 ottobre 2009), acura di E. DE MINICIS, Roma, 2011, pp. 133-145; A. ATTOLICO, M. MICELI, Casali rurali dietà medievale in agro di Grottaglie (Ta): alcune riflessioni sugli insediamenti rupestri. Problemi eprospettive di ricerca, in Villaggi, comunità, paesaggi medievali. Atti del Convegno Internazio-nale di Studio (Bologna 14-16 gennaio 2010), a cura di P. GALETTI, Spoleto, 2012, pp.733-753.
4 Per la chiesa maggiore di Riggio cfr. M. FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentalebizantina in Puglia, Milano, 1991, pp. 190-191; M. MICELI, Insediamenti rupestri nel territoriodi Grottaglie: la chiesa maggiore di Riggio. Analisi archeologica e stratigrafica, in Le aree rupestridell’Italia cit. (n. 3), pp. 365-376; A. ATTOLICO, Cultura artistica bizantina in un territorio anord est di Taranto: la decorazione pittorica della chiesa maggiore della gravina di Riggio a Grot-taglie, in Le aree rupestri dell’Italia (n. 3), pp. 381-393; G. CARONE, Indagini archeometrichesulle decorazioni pittoriche della chiesa maggiore della gravina di Riggio, in Le aree rupestri dell’I-talia (n. 3), pp. 395-409; per la decorazione pittorica della chiesa rupestre presso MasseriaLo Noce cfr. L. SAFRAN, Scoperte salentine, in Arte Medievale, VII (2008), p. 84; M. FALLA CA-STELFRANCHI, La pittura rupestre in Terra d’Otranto: nuove acquisizioni, in Le aree rupestri dell’I-talia cit. (n. 3), pp. 237-241.
5 Per un primo studio cfr. A. ATTOLICO, S. CATACCHIO, Nuovi dati per lo studio di uncasale di “successo”: testimonianze di età medievale nell’ex gravina di San Giorgio a Grottaglie(TA), in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila, 12-15 set-tembre 2012), a cura di F. REDI, A. FORGIONE, Firenze, 2012, pp. 395-400.
18XX3.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 3
Alla luce di tali silenzi è apparso dunque pertinente proporreuno studio di dettaglio su una chiesa rupestre inedita che occupa lospalto nord occidentale dell’ex gravina di San Giorgio, solco vallivo,che insieme a quello di Sant’Elia, costituiva con buona probabilitàil confine naturale dell’abitato negli ultimi secoli del medioevo 6.
Oggi la gravina non è più visibile, ma è occupata da una stra-da 7 che, partendo dal parcheggio del celebre Quartiere delle Cera-miche, sale verso il Castello Episcopio in direzione sud ovest - nordest, colmando un dislivello altimetrico di circa 18 m; il riconosci-mento dei fronti rocciosi, avvenuto localizzando e rilevando porzio-ni di pareti e unità rupestri oggi sotto la superficie di calpestio, hapermesso di valutare l’estensione dell’evidenza geomorfologica (per-fettamente integrata nella “linea delle gravine” dell’arco jonicoorientale) e di ipotizzare un utilizzo antropico precoce della stessa,testimoniato anche dal recente ritrovamento, in uno dei terrazza-menti, di materiali di età romana 8.
L’edificio di culto fu rinvenuto nel corso dei lavori di ristruttu-razione di Palazzo Vestita, a circa 80 m in linea d’aria dal comples-so del Castello (Fig. 2); le testimonianze orali riportano che la grot-ta, completamente ricolma di terra, ospitava un forno per la cotturadi alimenti fuori scala, probabilmente mai usato, la cui rimozione
6 Non vi sono documenti che attestino un’originaria dedicazione della gravina a San
Giorgio, pur tuttavia ritengo che il toponimo trasmessoci della tradizione orale possa es-
sere verosimile, in considerazione della grande diffusione del culto del santo nel territo-
rio di Grottaglie e più in generale nell’arco jonico stesso, come attestato dai numerosi
toponimi e dalle decorazioni pittoriche della chiesa della gravina di Riggio, del santuario
della Madonna delle Grazie presso San Marzano, della scomparsa chiesa di San Nicola a
Faggiano e della chiesa di San Giorgio a Laterza, cfr. M. MILELLA, I Cavalieri di Dio. Ico-nografia dei santi cavalieri negli affreschi pugliesi, in Le Crociate. L’Oriente e l’Occidente da Urba-no II a San Luigi 1096-1270. Catalogo della mostra (Roma - Toulouse 1997), a cura di M.REY-DELQUÈ, Milano, 1997, pp. 214-217; per il santuario di San Marzano cfr. L. DEROSA,Tra Puglia e Basilicata: gli affreschi del santuario rupestre della Madonna delle Grazie, in Dalla“defensa” di San Giorgio alla “lama” della Madonna delle Grazie. Il Santuario rupestre di SanMarzano (TA), a cura di C. D. FONSECA, Galatina, 2001, pp. 91-104; per Faggiano cfr. C.GELAO, Schede nn. 6-7-8, in La Pinacoteca Provinciale di Bari. Opere dall’XI al XVIII secolo,a cura di C. GELAO, Roma, 1998, pp. 47-50; per Laterza cfr. C. DELL’AQUILA, Laterza Sacra,Manduria, 1989, pp. 116-120.
7 Si tratta dell’attuale Via Crispi. Coordinate: 40° 31’ 57’’ N, 17° 25’ 50’’ E.8 I materiali sono attualmente in fase di studio a cura dell’equipe del prof. A. Fornaro
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
18XX4.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO4
ha poi rivelato l’esistenza dalla chiesa rupestre. Purtroppo tale scavonon fu condotto stratigraficamente, per tanto non disponiamo di se-quenze affidabili in grado di chiarire, non solo la cronologia relativadelle eventuali strutture, ma anche le modalità di inizio e fine dellediverse fasi di vita: fortunatamente, invece, possediamo ancora unabuona quantità dei materiali rinvenuti, salvati nel coso dello sterroda alcuni ceramisti locali 9.
È indubbio, che alla luce della completa assenza di dati stragra-fici sicuri, lo studio di tale edificio di culto offre allo stesso tempoenormi potenzialità, ma anche diverse, rilevanti insidie; se infatti lachiesa costituisce in ogni caso una delle prove più convincenti delpopolamento della gravina in età basso medievale e apre alla possi-bilità che il centro storico di Grottaglie si sia evoluto, parimenti acasi di Matera, Ginosa, Massafra e Palagianello, da un originarionucleo semirupestre, per contro è doveroso tenere in considerazionei limiti delle testimonianze orali, verificando sul campo ogni infor-mazione e tenendo una linea interpretativa cauta, confermata, se èpossibile, da altri elementi esterni.
A tal fine si è deciso innanzitutto di valorizzare i dati oggettiviancora in nostro possesso: si è preceduto per tanto alla documenta-zione e alla lettura delle relazioni tra le unità stratigrafiche negativedell’invaso, secondo una metodologia ormai consolidata, partendoda un rilievo, realizzato nell’ambito del progetto comunitario Cultu-ral Rupestrian Heritage in the Circum Mediterranean Area. Common In-dentity, New Perspective 10, eseguito con tecnologia laser scanning. Idati desunti da questo tipo di esame sono stati poi incrociati conl’analisi delle architetture, degli affreschi e dei materiali: di que-
9 Il territorio della provincia di Taranto è oggetto quotidianamente di atti di vanda-
lismo che determinano la scomparsa di un cospicuo patrimonio culturale, che potrebbe
essere alla base del rilancio economico dell’intera area. Nella vicina “cripta delle nic-
chie” presso la gravina dei Pensieri, ad esempio, si continuano a rilevare continui furti
di affreschi: ho potuto personalmente constatare che un’iscrizione che adornava la parete
settentrionale, da me fotografata solo qualche mese prima della stesura del presente arti-
colo, è scomparsa a causa di uno “stacco” operato da sconosciuti. È evidente che, più
che attraverso mezzi coercitivi, dimostratisi completamente inefficaci e spesso contro-
producenti, sia necessario riaprire un dialogo con le popolazioni locali e promuovere
iniziative tese alla creazione di un nuovo senso di responsabilità, in grado di prevenire
questi e altri crimini verso i testimoni della nostra memoria comune.10 www.rupestrianmed.edu
18XX5.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 5
st’ultimi, essendo questo contributo principalmente finalizzato allostudio dell’edificio, si darà notizia unicamente dei reperti funzionalialla comprensione di alcuni aspetti del culto della chiesa, mentreper garantire un approfondimento specifico si rimanderà ad altra se-de la pubblicazione completa della restante parte 11.
Si tratta, come evidente, di uno studio preliminare, teso a darerapida comunicazione alla comunità scientifica delle evidenze recu-perate, la cui rilevanza si ritiene essere particolarmente significativaper lo studio del territorio; i risultati raggiunti devono essere quin-di considerati provvisori e suscettibili di aggiornamenti, dovuti alprosieguo delle indagini condotte sugli stessi materiali e sullestrutture di altra natura ancora visibili all’interno dell’area di Palaz-zo Vestita.
LETTURA STRATIGRAFICA
Lo spazio ipogeo della chiesa era probabilmente in origine unagrotta naturale il cui fronte si estendeva in direzione nord ovest -sud est oltre i limiti dell’attuale invaso. L’analisi della superficierocciosa immediatamente soprastante l’ingresso della chiesa ha in-fatti messo in evidenza la linea di frattura lungo la quale avvennelo stacco di una porzione consistente della parete calcarenitica 12
(Fig. 3): tale crollo avvenne in un periodo precedente la fase di fre-
11 Per la ceramica invetriata policroma del contesto di Palazzo Vestita, proveniente
dalla chiesa rupestre e dalla cosiddetta “cisterna 2”, cfr. A. ATTOLICO, S. CATACCHIO, Theglazed polychrome ware from the Palazzo Vestita context at Grottaglie, in Post Classical Archaeo-logy in Apulia and Southern Italy. Proceedings of the First Colloquium of Italian Ph.D. ofPost Classical Archaeology (Bari, 26-27 giugno 2012), a cura di A. ATTOLICO, c.s.; è inol-tre in preparazione ad opera di chi scrive e del dott. Sarcinelli un contributo specifico suldeposito volontario rinvenuto dietro l’affresco di santa Barbara.
12 In tutto l’arco jonico il crollo naturale di intere porzioni dei fronti rocciosi delle
gravine è fenomeno molto diffuso, dovuto all’azione degli agenti atmosferici sulla fragile
calcarenite locale. Per approfondimenti cfr. V. COTECCHIA, D. GRASSI, Dissesti statici e sta-to di conservazione dei manufatti dei “Sassi” di Matera (Basiliata) in rapporto agli aspetti fisicidel territorio e alla attività antropica, in Geologia applicata e Idrologia, X (1975), pp. 55-105;EID., Aspetti geologici e geotecnici dei principali centri rupestri medievali della Puglia e della Luca-nia, in Habitat - Strutture – Territorio, Atti del III Convegno Internazionale di Studio sullaCiviltà Rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia (Taranto - Grottaglie, 24 -27 settem-bre 1975), a cura di C. D. FONSECA, Galatina, 1978, pp. 141-156. In questo caso sono sta-
18XX6.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO6
quentazione medievale accertata 13, le cui tracce si individuano sullafacciata del nuovo fronte, al di sotto di una quota oltre la qualemancano segni di escavazione antropica ed è possibile rilevare unforte deterioramento della roccia dovuto agli agenti atmosferici.
Nel corso della prima fase di occupazione si procedette a unaregolarizzazione della planimetria, intervenendo sulle pareti e il sof-fitto dall’ambiente, sulla cui estensione si individuano ancora centi-naia di tracce interpretabili come le impronte della penna del pic-cone sulla superficie di impatto (Fig. 4) (fase I); tali evidenze diforma rettangolare si dispongono parallelamente una all’altra conun intervallo variabile e presentano un modulo medio 9 cm circa,molto simile a quello rilevato in altri contesti rupestri di età me-dievale documentati nella regione 14. La tessitura di tali unità stra-tigrafiche negative permette di ipotizzare che i cavatori, partendodall’attuale ingresso, la cui posizione per tanto deve essere conside-rata originaria, procedettero in direzione sud - nord, per poi deviareall’altezza della parete settentrionale verso est (Fig. 5): il vano risul-tante, di forma irregolare, era chiuso su tre lati dalla parete roccio-sa, mentre su quello meridionale doveva essere scoperto a causa delsopracitato crollo del fronte. Per questa ragione si provvide alla rea-
te rilevate anche una serie di rasature posteriori di cui però è difficile stabilire la cronolo-gia relativa.
13 Non è possibile escludere che tale ambiente fosse occupato con destinazioni d’uso
diverse da quella abitativa o cultuale in un periodo precedente, ma i rilievi effettuati
non hanno messo in evidenza tracce in grado di stabilire le modalità di questa occupa-
zione e la sua cronologia.14 R. ROTONDO, A. ATTOLICO, Lettura stratigrafica di architetture in negativo: il frantoio
A di Masseria San Domenico (Savelletri di Fasano - Br), in Dall’habitat rupestre all’organizza-zione insediativa del territorio pugliese (sec. X - XV). Atti del III Convegno Internazionalesulla Civiltà Rupestre (Savelletri di Fasano, 22-24 novembre 2007), a cura di E. MENESTÒ,Spoleto, 2009, pp. 310-321. Si deve specificare però che per tali strumenti semplici a per-cussione diretta si rileva una certa inerzia funzionale nelle forme nel corso dei secoli delmedioevo: per tanto la sola individuazione di unità stratigrafiche negative rispondenti atali caratteristiche di forma e dimensione, in mancanza di altri dati incrociati, non può es-sere al momento considerata di per se datante per un arco cronologico più specifico. Man-cano infatti studi mirati che, partendo da un campione significativo di contesti datati concertezza su base regionale, permettano di elaborare delle griglie cronotipologiche in gradodi fornire maggiori informazioni al riguardo. Per alcune riflessioni metodologiche di que-sto tipo, cfr. E. DE MINICIS, Introduzione, in Insediamenti rupestri medievali della Tuscia. I. Leabitazioni, a cura di E. DE MINICIS, Roma, 2003, pp. 9-20.
18XX7.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 7
lizzazione di un avancorpo in materiale deperibile, testimoniato sul-la facciata da 9 incassi per travi lignee di forma pseudorettangolare(Fig. 6), secondo una tecnica edilizia documentata anche negli abi-tati di età medievale della gravina di Riggio e Pensieri nello stessoterritorio di Grottaglie 15 (Fig. 7). Gli alloggi per il sostegno dellacopertura esterna 16, oggi tutti in cattivo stato di conservazione, sidispongono orizzontalmente a un’altezza media di 3,4 m dal pianodi calpestio attuale della chiesa e presentano dimensioni che si ag-girano tra i 20 cm di larghezza e i 30 cm di altezza; tre ulterioriincassi 17 di proporzioni leggermente maggiori sono posti a circa 10cm più in basso rispetto a tale allineamento: difficile stabilire la lo-ro funzione, ma il fatto che uno di essi intercetti parzialmente ilprofilo dell’- US 27 potrebbe far pensare a un rinforzo o a una so-stituzione successiva di parte della struttura.
Per quanto attiene l’interno dell’invaso, il piano di calpestionon doveva essere regolare, ma presentava una pendenza gradualeda sud verso nord; sulla parete settentrionale fu realizzata una nic-chia trapezoidale 18 (Fig. 8): la parete di fondo di tal evidenza nonpresenta un andamento rettilineo verticale, ma si allarga in direzio-ne nord per circa 30 cm, formando un angolo acuto di 13°: questacaratteristica, insieme all’ampia superficie piatta interna e un forodi forma rettangolare posto sul fondo a un’altezza di 120 cm 19,concorre a qualificarla come un piano di appoggio collegato a unadestinazione residenziale o produttiva dell’ambiente 20, come par-
15 ATTOLICO, MICELI, Casali rurali di età medievale cit. (n. 3), pp. 733-753, fig. 6. L’uti-lizzo di tale soluzione sembra particolarmente diffuso in questo tipo di insediamenti; re-centemente ho potuto constatare che anche in un contesto cultuale come la “cripta dellecento nicchie” presso la gravina di Pensieri si realizzarono avancorpi di questo tipo: riten-go che sia ormai necessario allargare la ricerca alle diverse tecniche edilizie adottate perquesti edifici, nella cui costruzione la componente rupestre non era affatto esclusiva.
16 - UUSS 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.17 - US 38, 39, 40.18 Misure - US 46: 91 x 144 x 50 cm19 - US 87. Sulla superficie del piano non ci sono fori o altri elementi che permetto-
no di qualificarla come una “nicchia laboratorio”, cfr. R. CAPRARA, F. DELL’AQUILA, Peruna tipologia delle abitazioni rupestri medioevali, in Archeologia Medievale, XXXI (2004), pp.457-472, in particolare p. 463, fig. 5.
20 L’angolo della parete di fondo, lasciando uno spazio più ampio all’altezza del piano
di appoggio sarebbe infatti funzionale alle attività lavorative o semplicemente domesti-
che.
18XX8.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO8
rebbe confermato anche da alcuni confronti con le abitazioni rupe-stri di età basso medievale della Madonna della Scala a Massafra 21
o anche geograficamente più lontani come le analoghe nicchie dietà mediobizantina delle cucine dell’insediamento di Selime Kalesiin Cappadocia 22. Posta a 35 cm più a ovest sulla stessa parete si ri-leva una nuova struttura composta da sedici nicchie di forma pseu-doquadrangolare disposte su quattro linee orizzontali parallele a unintervallo medio di 8 - 9 cm: il modulo di tali quadrati è compresotra i 28 e i 31 cm, mentre la loro profondità si aggira tra 21 e i 24cm. In virtù di tali caratteristiche e dei confronti con analoghi am-bienti la cui destinazione d’uso appare più certa come i casi di Rig-gio 23, Massafra 24, Laterza, Castellaneta e Crispiano 25, per limitarciall’arco jonico, l’interpretazione più probabile è quella di colom-baia 26, ipotesi questa che sarebbe confermata anche dal verificarsidi alcune condizioni strutturali e topografiche ottimali, quali la so-praelevazione di 98 cm rispetto all’ipotetico piano di calpestio 27,l’esposizione a mezzogiorno 28 e l’affaccio sul solco vallivo in dire-zione dell’apertura della grotta 29. Dal punto di vista stratigrafico,
21 R. CAPRARA, La gravina di Madonna della Scala e il sistema delle gravine di Massafra,in La Gravina di Madonna della Scala di Massafra. Natura, storia, archeologia, tutela, MartinaFranca, 1995, pp. 43-84.
22 V. KALAS, The byzantine kitchen in the domestic complexes of Cappadocia, in Archaeology ofthe countryside in Medieval Anatolia, a cura di T. VORDERSTRASSE e J. ROODENBERG, Leida,2009, pp. 109-127, fig. 7.
23 ATTOLICO, MICELI, Insediamenti rupestri medievali di area pugliese cit. (n. 3), p. 143,fig. 9b.
24 Gli abitati di Madonna della Scala e Trovanza in particolare, cfr. CAPRARA, Societàed economia nei villaggi cit. (n. 2), pp. 239-245.
25 ID., Società ed economia nei villaggi cit. (n. 2), pp. 239-245.26 Il numero estremamente limitato di celle fa pensare ad un allevamento di tipo do-
mestico; un caso analogo è stato documentato nell’insediamento di Petruscio presso
Mottola, cfr. F. DELL’AQUILA, L’insediamento rupestre di Petruscio, Cassano Murge, 1974, p.62.
27 Tale sopraelevazione aveva lo scopo di non permettere agli eventuali predatori di
raggiungere i nidi.28 Tali condizioni erano già prescritte dai trattati di età romana, cfr. COLUMELLA, De
Re Rustica, VIII, 8.2,4; VARRONIS, De Re Rustica, III, 7.29 A queste andrebbero aggiunte il posizionamento in una zona limitanea dell’abitato,
la presenza di vicini bacini idrici e una quota altimetrica sensibilmente alta rispetto al
fondo della gravina: tali condizioni, seppur probabili, sono al momento indimostrabili
poiché non conosciamo né la disposizione topografica dell’abitato né l’esatta altimetria
18XX9.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 9
non essendoci rapporti diretti, non è possibile stabilire la cronologiarelativa di tali evidenze, le quali teoricamente potrebbero apparte-nere anche a fasi di occupazione diverse 30: del resto un indizio intal senso è dato anche da un’altra unità stratigrafica di forma ret-tangolare 31 che si sovrappone in facciata alle - UUSS 27 e 28, laquale potrebbe essere uno degli indicatori rimasti di un parziale in-tervento sulla grotta di cui si ignora l’entità.
In un periodo compreso tra la fine del XIII e la prima metà diquello successivo la grotta cambia completamente destinazione d’uso eil suo spazio viene utilizzato per la realizzazione di un edificio di culto(Figg. 9 - 10) (fase II). Non si conoscono al momento le ragioni di talescelta topografica 32, la quale potrebbe essere legata alle trasformazioni“urbanistiche” conseguenti all’ascesa politica e demografica del casale,che i documenti collocano proprio in questi decenni 33, tuttavia si deveregistrare una vera propria riqualificazione di questo spazio, che avven-ne con una serie di interventi strutturali.
della gravina in età medievale. Per uno studio sui colombai medievali del Lazio setten-
trionale in cui tali elementi sono considerati in relazione a un’ampia casistica cfr. V. DE-
SIDERIO, La colombaia rupestre nel Lazio settentrionale: un esempio di attività economico-produttiva,in Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive. Italia centrale e meridio-nale. Atti del Convegno di studio (Grottaferrata, 27-29 novembre 2005), a cura di E. DE
MINICIS, Spoleto, 2008, pp. 481-514.30 Un elemento necessario, ma non sufficiente a dimostrare il contrario sarebbe la
valutazione della posizione di tali strutture in rapporto all’ipotetica planimetria origina-
ria: considerando le dimensioni dalla parete settentrionale in quella fase, sembrerebbe vi
sia una razionale divisione della superficie rocciosa. Pur tuttavia non sono riuscito ad in-
dividuare nella letteratura archeologica casi in cui all’interno di una colombaia non inte-
ressata da fasi di occupazione successive vi sia una nicchia che presenti le medesime ca-
ratteristiche tecniche di quella grottagliese; a questo va inoltre aggiunto che l’occupazio-
ne per scopi produttivi o residenziali di un ambiente adibito all’allevamento di colombi
era, a giudicare dai dati fin ad ora raccolti nei villaggi rupestri, del tutto non funzionale.31 Misure - US 58: 21 x 99 cm.32 Un indizio potrebbe essere dato dalla vicinanza all’area del Castello, ma non ci so-
no dati a sufficienza per poter ipotizzare null’altro che un semplice collegamento con le
strutture del pianoro soprastante, di cui si ignora completamente l’entità.33 Nel 1297 l’Arcivescovo Enrico ottiene da Roberto duca di Calabria che « quod ca-
sale Saletum at alia congregarentur Casali Cryptalearum ab belli discrimina »: ho già avuto mo-do di sottolineare che il fatto che si indichi Grottaglie come il luogo più idoneo dal pun-to di vista difensivo è il sintomo del ruolo di primo piano assunto dal casale sullo scorciodel XIII secolo. Per l’analisi della documentazione di età medievale relativa al territoriocfr. ATTOLICO, Fonti scritte ed evidenze archeologiche cit. (n. 3), pp. 339-353.
18XX10.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO10
Innanzitutto fu eliminato l’avancorpo in materiale deperibile el’invaso fu chiuso a meridione con la realizzazione di un muro 34, dicui una porzione è stata inglobata nell’angolo sud est della pareteodierna, a partire dalla quota di 2 m dal piano di calpestio attua-le 35 (Fig. 11): tale alzato è caratterizzato da file regolari di blocchidi calcarenite squadrati e rifiniti, che si dispongo su filari parallelialti 25 cm, legati da un composto di malta e terra rossastra caratte-rizzata da inclusi di varia granulometria (Fig. 12). Tali caratteristi-che, seppur con lievi varianti dovute dal tenore diverso dell’opera,si riscontrano in altri fabbricati di Grottaglie datati con più sicu-rezza al XIII - XIV secolo come la torre e alcune porzioni dellemura del Castello Episcopio (Fig. 13), e permettono quindi, purcon le dovute riserve 36, di confermare un inquadramento cronologi-co compatibile con la costruzione della chiesa.
Anche il piano roccioso dell’area meridionale dalla grotta fu re-golarizzato; l’ingresso fu posizionato nell’angolo sud occidentale,presso l’accesso originario della cavità 37, ma fu arretrato di circa unmetro per permettere l’allineamento con il nuovo muro di chiusurae dotato di una rampa di scale intagliata direttamene nella pietra(Fig. 14); la contemporaneità della realizzazione dei gradini con lacostruzione della chiesa è provata anche dal rapporto sincronico ditali unità stratigrafiche negative con l’abbassamento di 160 cm delpiano roccioso che si operò nella restante porzione sud orientaledell’ambiente per consentire l’allineamento verticale interno tra lanuova parete meridionale e la roccia su cui essa si fondava 38 (Fig.15). Il piano di calpestio ricavato doveva dunque avere una quota
34 USM 57: la posteriorità rispetto all’avancorpo in materiale deperibile è assicurata
dal fatto che il muro copre uno degli incassi per travi della fase precedente (- US 33).35 Lo stesso proprietario ha confermato che, al momento dell’intervento nella grotta,
le rovine di tale muro si estendevano su tutto il limite meridionale della chiesa.36 Manca, infatti, uno studio specifico sulle tecniche murarie di età basso medievale
del territorio tarantino, che permetta di inquadrare con maggiore precisione questo tipo
di evidenze.37 Con acceso originario si intende l’apertura iniziale da dove partì l’escavazione della
grotta nella prima fase; non si conosce però il punto di accesso dell’avancorpo in mate-
riale deperibile di cui si ignora completamente l’estensione.38 Gradini: - US 103; taglio verticale parete sud: - US 61. Tra i gradini e il taglio vi
è un angolo di 90° e non si rilevano sovrapposizioni: tale elemento induce a ritenerli
parte del medesimo progetto planimetrico.
18XX11.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 11
molto prossima a quella attuale e, a giudicare dalle testimonianzeorali degli operai che eseguirono lo sterro, la roccia non fu messa inpiano, ma si optò per una semplice sistemazione in terra battuta 39.
L’individuazione di alcune tracce di piccone e di una piccolaascia 40 (Fig. 16), che si sovrappongono a quelle precedentementedescritte 41, rende probabile che in questa fase vi fu una nuova par-ziale regolarizzazione del soffitto e dei perimetrali, soprattutto inprossimità degli angoli e dalla parete orientale, la quale fu comple-tamente modificata per la realizzazione della zona presbiterale (Fig.17). In tale area furono scavate tre absidi voltate, a sezione trape-zoidale 42, che furono inquadrate all’interno di una quinta architet-tonica, realizzata in negativo 43, costituita da tre archi poggianti suquattro pseudo colonne tortili 44, impreziosite da finti capitelli ca-ratterizzati da linee diagonali parallele. L’altare centrale 45, realizza-to a blocco su parete, fu avanzato rispetto all’arco absidale di 9 cm,ma lateralmente fu lasciato agganciato alla struttura mediante due
39 Ovviamente in questo caso si tratta di un’informazione non verificabile, se non
operando un nuovo scavo all’interno della chiesa; pur tuttavia il dato mi sembra abba-
stanza verosimile, poiché il pavimento in terra battuta era abbastanza consueto all’inter-
no delle chiese in rupe di età medievale del territorio. Oggi il pavimento è costituito da
un piano molto simile a un coccio pesto, realizzato nel corso dei lavori di ristrutturazio-
ne dell’edificio.40 Si tratta di un’ascia di piccole dimensioni, la cui lama ricurva non superava i 20
cm, utilizzata nel medioevo per eseguire le rifiniture, dopo che il piccone aveva esegui-
to lo scavo più grossolano, cfr. DE MINICIS, Introduzione cit. (n. 14).41 Queste nuove tracce, che intrattengono un rapporto di posteriorità con quelle de-
scritte nella fase precedente, mantengono un modulo pari ai 9 cm, ma mostrano inter-
valli meno regolari e direzioni di impatto diverse.42 Misure, da nord verso sud: - US 92: 72 x 113 x 50 cm; - US 93: 98 x 138 x 66
cm, - US 94: 70 x 111x 35 cm. Tali absidi sono state interessate in epoca contempora-
nea dalla deprecabile installazione di tre faretti; tutte le azioni di ristrutturazione sono
indicate in pianta come fase V.43 Le cornici probabilmente sono state pulite nel corso dei lavori di recupero dell’e-
dificio con alcune azioni di raschiatura (fase V).44 - UUSS 111, 112, 113, 114: altezza media 180 cm. Le colonne centrali sono state
parzialmente integrate nella loro porzione inferiore per 30 cm circa a partire dal piano
di calpestio con un discutibile restauro “in stile”; la colonna sita nell’angolo meridionale
appare in parte intergrata e in parte ricostruita con i pezzi originali. Si rimanda alla fig.
18 l’individuazione degli interventi della fase V.45 Misure - US 118: 80 x 108 x 67 cm. Il piano dell’altare è stato regolarizzato nel
corso dei lavori di ristrutturazione (fase V).
18XX12.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO12
piccole lingue di roccia ribassate 46; immediatamente sopra la suasuperficie, sulla parete di fondo, in posizione centrale, fu realizzatauna piccola nicchia voltata, profonda 15 cm 47. Sul soffitto, in corri-spondenza dello stesso altare, venne incisa una croce potenziata in-scritta in un cerchio 48 (Figg. 18-19).
Sulla parete opposta della chiesa, immediatamente dopo la finedella scala, a un’altezza di 130 cm dal suolo, fu ricavata un’acqua-santiera mediante lo scavo di una nicchia voltata 49 al cui internovenne realizzato un foro per l’alloggio di un contenitore cerami-co 50: il reperto, ancora in situ, è una ciotola di ceramica in invetria-ta policroma in bruno, verde e rosso, databile entro la fine del XIIIsecolo (Figg. 20-21).
Altre modifiche furono apportate alla chiesa in un periodo suc-cessivo la realizzazione del suo impianto originario (fase III); pressoil lato sinistro della scala in roccia, a una quota di circa 1 metrodal suolo, nello spessore della parete occidentale fu ricavata perasportazione di materiale una nuova colonna tortile, caratterizzatanella sua estremità superiore da un capitello liscio composto da unechino e un collarino di piccole dimensioni (Fig. 22); l’introduzionedi tale elemento architettonico era probabilmente funzionale a unatrasformazione parziale dell’area, poiché il setto roccioso occidentalefu scavato per la realizzazione di un arco che, partendo dalla stessacolonna, si dirigeva verso l’ingresso, probabilmente scaricando sulperimetrale meridionale (Figg. 20, 22). Non è dato sapere il motivodi questo intervento poiché la parete non si è conservata, ma non èescluso che si sia voluto creare un accesso occidentale alla cripta,
46 Misure, da nord verso sud. - US 119: 9 x 72 cm; - US 120: 8 x 69 cm.47 Misure - US 95: 36 x 40,5 x 15 cm.48 - US 128. Tale elemento, che in questo caso ha la funzione di differenziare lo
spazio liturgico, si pone come naturale trasposizione in ambito ipogeo della cupola e
trova confronti nel vicino santuario della Madonna delle Grazie a San Marzano, nella
chiesa di Bufalo Petruscio a Mottola, nella cripta di San Salvatore a Giurdignano e, in
area materana, presso la Madonna delle Virtù, la Madonna della Croce, Sant’Antonio
Abate e San Donato, cfr. F. DELL’AQUILA, A. MESSINA, Le chiese rupestri di Puglia e Basili-cata, Bari, 1998, pp. 82-85.
49 Misure - US 142: 29 x 39 cm. Anche in questo caso si deve rilevare purtroppo
l’installazione di un faretto sulla superficie superiore della struttura.50 - US 143. Il piano in cui la ciotola è alloggiata è stato consolidato nel corso dei
lavori di ristrutturazione.
18XX13.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 13
garantendo in questo modo una maggiore quantità di luce all’areapresbiteriale. Un indizio in tal senso risiede nel fatto che, probabil-mente nello stesso arco di tempo, furono realizzati simmetricamentedue porta lucerne ai lati delle absidi 51: tali elementi, composti datre nicchie poste a una altezza di 150 cm, dovevano infatti avere lafunzione di illuminare lo spazio liturgico, evidentemente troppobuio a causa dello scarto di quota tra il piano di calpestio esterno equello della chiesa 52 (Figg. 8, 11, 17). Del resto l’attenzione a que-sta zona dell’ambiente sembra anche confermata dalla realizzazionedi un gradino presso l’abside centrale 53: non vi sono tracce che per-mettano di capire se esso sostituì una struttura precedente o se fu co-struito ex novo, tuttavia le strutture oggi visibili poggiano sull’altaredella prima fase (Figg. 17 - 18). Per quanto riguarda la cronologia èpossibile ascrivere questi interventi in un periodo compreso tra il XV eil XVI secolo: la loro posteriorità rispetto alla fase precedente è assicu-rata non solo dalla valutazione stilistica della colonna tortile e dei por-ta lucerne, che appaiono dei prodotti rinascimentali, ma anche dall’a-nalisi tecnica dalle tracce di escavazione del nuovo arco, per la cui rea-lizzazione vengono adoperati strumenti diversi per modulo e forma daquelli individuati nelle fasi precedenti 54.
La fine della fase cultuale della grotta è segnata da un’azioneche compromette la zona presbiteriale (fase IV): nel corso del XVIsecolo nell’angolo sud orientale della parete absidale venne sfondatol’affresco di santa Barbara per permettere la deposizione volontariadi alcuni oggetti 55 (Figg. 17, 18, 23). Tale interpretazione è statapossibile in seguito alla valutazione dai dati ricavati in parte dainuovi rilievi e in parte dallo studio della totalità dei materiali, che
51 - UUSS 84 e 85. Il porta lucerne del muro perimetrale meridionale è stato par-
zialmente integrato in uno dei suoi angoli.52 Non si conosce l’aspetto del muro di facciata meridionale, per tanto non si è in
grado di stabilire dove potessero essere poste le eventuali finestre; pur tuttavia, conside-
rando che il setto murario poggia sulla roccia a una altezza di 160 cm dal piano di cal-
pestio della chiesa, esse non potevano essere troppo vicine alle absidi.53 Misure USM 148 : 160 x 13 cm.54 In questo caso le tracce mettono in evidenza che dopo una prima lavorazione con
un piccone molto simile a quello usato nelle fasi precedenti, furono utilizzati strumenti
da taglio che garantivano una maggiore omogeneità alla superficie.55 - US 51: il taglio, di forma ellittica, elimina tutta la porzione meridionale dell’ab-
side nella zona di raccordo tra il vecchio fronte roccioso e il muro di facciata.
18XX14.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO14
hanno permesso di correggere la lettura preliminare del contesto 56
e di elaborare una ipotesi interpretativa coerente con quanto rileva-to nello studio delle tracce in negativo dell’edificio. Ovviamente lamancanza di una sequenza affidabile dei depositi terrosi lascia deimargini di ipoteticità che non sarà possibile colmare, anche perchénon si conoscono le modalità di selezione e di raccolta dei materia-li, ma nonostante questo è stato possibile comprendere come il de-posito sia il risultato di una serie di azioni composite e distinte.Tra i reperti recuperati dall’area retrostante l’affresco, infatti, è statoisolato un gruppo di oggetti, pressoché integri, coerenti dal puntodi vista sia qualitativo che cronologico: tra essi vi sono un consi-stente gruppo di monete, alcune medaglie di piccole dimensioni,una placchetta, una croce pettorale e una croce astile in bronzo,un’altra croce astile in argento, venticinque ciotole e una brocca ininvetriata policroma (Fig. 24). Tali manufatti, i quali vanno verosi-milmente interpretati come frutto di un occultamento, hanno cometermine cronologico ultimo una moneta di XVI secolo; tale limitesembra essere condiviso anche dalla restante parte dei frammenticeramici, tra i quali si annoverano attestazioni di invetriata policro-ma e di acroma dipinta, che essendo molto più incoerenti e in cat-tivo stato di conservazione potrebbero essere interpretati come partedella terra di riporto usata per sigillare il contesto. A questi primidue gruppi, dopo uno iato di quasi quattro secoli, ne va aggiuntoun altro composto da alcuni piatti di XIX secolo: analizzando laparte superiore dello spazio retrostante l’abside meridionale è possi-bile notare che essi erano parte di una colmata di terra, pietra, mal-ta e ceramica 57, posta a una quota di circa 2 m dal luogo del ritro-vamento degli altri reperti, realizzata per permettere la costruzionedei piani pavimentali delle strutture soprastanti la chiesa (Fig. 25).
In ogni caso, a giudicare dai dati in nostro possesso, sembra cheentro la fine del XVI secolo non solo la zona presbiteriale, ma tuttala struttura ipogea della chiesa sia stata interrata 58, poiché anche i
56 ATTOLICO, CATACCHIO, Nuovi dati per lo studio di un casale cit. (n. 5).57 Questa tecnica era usata a Grottaglie fino agli anni cinquanta del secolo scorso.58 Come è già stato rilevato la cavità ipogea è stata rinvenuta ricolma di terra e pie-
tre. Non è possibile invece dare conto della presenza del forno fuori scala: i testimoni
concordano nell’affermare che avesse delle dimensioni non funzionali e che non fosse
mai stato usato per la mancanza di qualsiasi segno di cottura, ma non vi è alcuna possi-
18XX15.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 15
frammenti recuperati nel corso dello svuotamento della parte cen-trale della stessa non vanno oltre quel periodo: vi sono attestazionidi invetriata monocroma, policroma, in bianco e blu e acroma di-pinta, ma mancano completamente le produzioni posteriori, cheteoricamente pur dovevano essere riconoscibili a chi effettuò lo ster-ro 59. Non si conoscono le ragioni che possano aver indotto a talescelta, né tanto meno è possibile stabilire se tra l’occultamento de-gli oggetti e la completa defunzionalizzazione della grotta siano in-tercorsi alcuni decenni, pur tuttavia forse tale evento andrebbe inse-rito nel quadro di un’ulteriore trasformazione che interessò l’interaarea a partire dall’inizio XVII che vide, con modalità che per adessoci sfuggono, la riorganizzazione dell’immediato sopraterra 60.
GLI AFFRESCHI
La decorazione ad affresco, se si fa eccezione per la superficie in-terna dell’acquasantiera, interessa unicamente la parete orientaledell’invaso ed è concentrata esclusivamente nelle absidi della chiesa(Fig. 17): attualmente versa in un buono stato di conservazione, an-che se in alcuni porzioni è possibile notare un principio di deterio-ramento forse dovuto ad alcune infiltrazioni 61. Tutte le figure sonoperfettamente integre, fatta eccezione per quella dell’abside destra,la quale, pur rimanendo del tutto leggibile, è stata interessata da
bilità di riscontro. Sulle ragioni per le quali fosse stato costruito in un momento o di
poco precedente o successivo all’interramento non è possibile esprimersi.59 Questo dato, che ovviamente deve essere considerato in modo critico per le ra-
gioni esposte sopra, deve essere però messo in relazione alla totale assenza di frammenti
in tutta l’area della chiesa; esso appare verosimile anche alla luce del fatto che nel terri-
torio produzioni come la maiolica sono molto conosciute e non appare chiaro il motivo
per il quale esse potrebbero essere state ignorate o sottratte, quando invece altre tipolo-
gie ceramiche e materiali di valore sono stati consegnati al proprietario.60 L’età moderna fu un periodo molto florido per Grottaglie, soprattutto per via del-
la fortuna delle sue botteghe figuline; gran parte degli edifici del noto Quartiere delle
Ceramiche fu costruito in quei secoli e anche la parte più antica conobbe una nuova
importante stagione edilizia, cfr. R. QUARANTA, Grottaglie nel tempo. Vicende – Arte – Do-cumenti, Lecce, 1995, pp. 44-62.
61 Gli affreschi sono stati sottoposti ad alcune indagini archeometriche non invasive
da parte della squadra di ricerca dell’Università di Kanazawa (Giappone).
18XX16.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO16
un taglio realizzato per la collocazione di un deposito volontario 62
(Fig. 23).Da un’analisi autoptica della stratigrafia degli intonaci, confer-
mata dalla lettura della sezione del taglio sopra descritto, emergeche le unità stratigrafiche di rivestimento visibili sembrano non co-prire un apparato decorativo precedente; gli affreschi occupano per-fettamente le superfici delle absidi e intrattengono con esse e con ilresto delle strutture architettoniche in negativo un rapporto di po-steriorità, dato che ci permette di inquadrarli cronologicamente inun momento immediatamente successivo la conclusione del primoimpianto della chiesa (fase II).
Tutti i soggetti sono ritratti a mezzo busto, secondo un “mo-dello iconico - votivo” 63, particolarmente diffuso in Italia meridio-nale tra XIII e XIV secolo 64: le immagini, rappresentate in modoparatattico, senza alcun nesso tra loro, sono concepite come vere eproprie trasposizioni su parete di icone lignee; esse sono campite al-l’interno di una cornice rosso ocra, larga tra i 4 e gli 8 cm, che inalcune aree è superata e coperta dalle aureole e dagli arti dei Santi,con un effetto di movimento verso l’interno dell’ambiente che con-corre a dare profondità alle figure, la cui volumetria tenta di sta-gliarsi dalla parete, anche per mezzo del contrasto cromatico tra leimmagini e il fondo di colore blu scuro inteso.
Nessuna delle immagini è corredata da un’iscrizione che reca ilnome del santo, forse per l’estrema riconoscibilità dei soggetti rap-presentati. Nell’abside sinistra è infatti ritratto san Nicola, stante,frontale, benedicente con la mano destra, mentre nella sinistra tiene
62 - US 51, cfr. supra il paragrafo sull’analisi stratigrafica.63 Tale modello deve essere inteso, parafrasando M. Falla Castelfranchi, “in senso
squisitamente orientale” come “(...) una immagine tagliata spesso a mezzo busto (...),
possibilmente ad altezza d’uomo, per agevolare il rapporto di tipo empatico che si viene
a creare con il fruitore” cfr. M. FALLA CASTELFRANCHI, La decorazione pittorica delle chieserupestri del territorio di Monopoli, in La Puglia tra grotte e borghi. Atti del II Convegno Inter-nazionale sulla Civiltà Rupestre (Savelletri di Fasano, 24-26 novembre 2005), a cura di E.MENESTÒ, Spoleto, 2007, p. 140. Nel caso in esame ritengo che tale rapporto venga espres-samente cercato dall’ignoto artista mediante l’espediente del superamento della cornicepittorica.
64 M. FALLA CASTELFRANCHI, La cultura artistica bizantina in Puglia, in Arte in Pugliadal Medioevo al Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 feb-braio - 30 aprile 2010), a cura di F. ABBATE, Roma, 2010, p. 93.
18XX17.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 17
un libro chiuso, la cui copertina, di colore giallo scuro, è caratteriz-zata al centro da una croce decorata da tre file di perline bianche eagli angoli da due archi concentrici (Figg. 26 - 27). Il Santo recatutti gli elementi del tipo iconografico di tradizione bizantina 65: ilcapo scoperto fortemente stempiato, la barba e i capelli canuti resicon pennellate bianche e alcuni tratti di nero; indossa i consuetiabiti vescovili, con l’omofórion dai bordi perlinati, caratterizzato dacinque croci potenziate color ocra, corredate da quattro punti di co-lore giallo posti negli angoli retti formati dai bracci. Dalla tunica amaniche larghe di colore rosso (felónion), il cui panneggio è reso darigide linee scure e gialle, emergono solo i bordi delle maniche (sti-chárion), composte da una fascia campita di elementi decorativiromboidali riempiti da croci e perline di colore bianco, e del collo,reso troppo geometricamente da un quadrato che reca sul lato infe-riore un motivo decorativo a linee verticali parallele.
Nell’abside centrale, in posizione dominante, è rappresentata lafigura di Cristo, stante, che leva la mano destra nel segno della pa-rola e nella sinistra tiene un libro aperto dai bordi perlinati, decora-to sia nella parte superiore che in quella inferiore da una serie dicerchi concentrici bicromi intervallati da puntini gialli, sulle cuipagine corre l’iscrizione Ego / sum / lux⏐2⏐mun/di. 66 (Fig. 28). Ilvolto, inquadrato da una capigliatura fluente che ricade sulle spalle,presenta una folta barba resa a piccoli ciuffi. Il suo abbigliamentoconsiste in una lunga tunica rossa dalle pesanti maniche larghe, resecon un panneggio costituito da spesse linee parallele verticali, e daun mantello di colore chiaro, bordato da un motivo decorativo apiccoli cerchi, che avvolge la figura partendo da dietro le spalle.Dalla tunica emerge parte di una veste gialla, caratterizzata da ottofile parallele di perline bianche, le cui maniche e il collo sono deco-rati con una fascia di elementi romboidali intervallati dai consuetipuntini chiari.
In basso, quasi all’altezza dell’altare, una nicchia di piccole di-mensioni presenta una cornice ocra su cui compare un motivo deco-rativo del tutto simile a quello del libro e un fondo giallo vivo su
65 M. S. CALÒ MARIANI, L’immagine e il culto di san Nicola a Bari e in Puglia, in SanNicola. Splendori d’arte di Oriente e d’Occidente, a cura di M. BACCI, Milano, 2006, pp.107-116.
66 Gv, 8,12.
18XX18.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO18
cui si staglia al centro una croce latina potenziata, dalle estremitàfortemente apicate, di colore rosso: nei quattro spazi creati dall’in-tersezione dei bracci quattro elementi tricuspidati di forma triango-lare di colore grigio (Fig. 29).
Santa Barbara è raffigurata nell’abside di destra: stante, in posi-zione frontale, la mano destra tiene una lunga croce astile di colorebianco, simbolo del martirio, mentre la sinistra è aperta, nel segnodella preghiera (Fig. 23). Il suo abbigliamento è particolarmente ri-cercato: la veste, di colore rosso, caratterizzata da alcune pieghe pa-rallele che cadono rigide verso il suolo, presenta al centro alcunericche rifiniture composte dai sei spazi rettangolari campiti alterna-tivamente da quadrati color porpora e cerchi color sabbia; i polsinisono impreziositi da rombi color bruno, sovradipindi da linee epunti sulla tonalità del giallo, mentre il collo è composto da duefasce, una a motivi triangolari e l’altra concepita come una serie dilinee parallele di punti bianchi interrotti al centro da due cerchibeige. Il mantello, fermato all’altezza del petto da una fibula discoi-dale, alterna i toni del bruno e azzurro chiaro: alcune lumeggiaturebianche rendono le pieghe del panneggio, tentando, con risultatiincerti, di dare volumetria alla figura; il bordo è composto da unafascia continua di colore giallo vivo delimitata da puntini bianchi,al centro della quale si ripete lo schema di un ovale color porporaattorniato da quattro cerchi grigi, forse con l’intento di rappresen-tare alcuni preziosi. Anche i gioielli della santa appaiono particolar-mente ricchi: la collana è composta da “pietre” di colore bruno egiallo e da un ciondolo circolare grigio; gli orecchini, a forma dianello, presentano due pendenti globulari dello stesso colore 67. Unnastro color porpora, caratterizzato da una decorazione perlinata,passa tra i capelli raccolti e ricade sul collo in due strisce di tessutopiù larghe, campite da una decorazione geometrica 68.
67 Per un approfondimento sugli orecchini cfr., all’interno dello stesso volume, M.
RIZZI, “Ornamenta”: tipologia e diffusione degli orecchini negli affreschi rupestri di area pugliese.68 É già stato rilevato come l’uso femminile di acconciare i capelli usando nastri e
stoffe di varie dimensioni fosse una moda di derivazione orientale diffusa nel Mezzo-
giorno normanno svevo, cfr. X. MURATOVA, Su alcune particolarità iconografiche del ciclo ve-terotestamentario della chiesa di Santa Maria di Anglona, in Santa Maria di Anglona. Atti delConvegno Internazionale di Studio (Potenza - Anglona, 13-15 giugno 1991), a cura di C.D. FONSECA e V. PACE, Galatina, 1996, p. 128. Nel caso di Grottaglie, sulla base di alcuni
18XX19.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 19
La scelta di rappresentare questi due santi è perfettamente coerentecon il quadro culturale del territorio pugliese tra il XIII e il XIV seco-lo. La presenza di San Nicola infatti non sorprende: le dedicazioni e leattestazioni figurative del santo di Myra nelle chiese rupestri e subdialiin Italia sono numerosissime e risalgono anche a un periodo precedentela translatio delle reliquie a Bari 69; esso è senza dubbio uno dei santimaggiormente rappresentati non solo nel Mezzogiorno d’Italia, ma an-che in molte aree del Mediterraneo orientale, in particolare a Cipro 70 enei villaggi rurali della regione greca della Magna 71, che non a casosembra aver avuto nel corso del basso medioevo diversi punti di con-vergenza artistica con le coste pugliesi 72. La grande diffusione dellasua immagine nell’agro tarantino, vero e proprio punto d’incontro trala cultura latina e quella bizantina, ben si spiega alla luce della figura“ecumenica” del Santo, venerato tanto in Oriente quanto in Occiden-te 73: tale diffusione ebbe un nuovo incremento in età crociata in virtùdel più sistematico contatto con Bisanzio e la Terra Santa, dove cappel-le e altari a lui dedicati sono documentati a Betlemme, presso il lagodi Tiberiade, nelle vicinanze del Santo Sepolcro e all’interno del Tem-plum Domini 74.
confronti datati con maggiore certezza, ritengo che l’acconciatura di Santa Barbara sia dainquadrare cronologicamente nel corso del XIV secolo.
69 Per i toponimi legati a San Nicola prima della traslazione delle sue reliquie nella
città di Bari, cfr. A. PERTUSI, Ai confini tra religione e politica. La contesa per le reliquie di S.Nicola, tra Bari, Venezia e Genova, in Quaderni Medievali, 5 (1978), pp. 10-13; M. FALLA
CASTELFRANCHI, La pittura rupestre bizantina in Terra d’Otranto: nuove acquisizioni, in Le areerupestri dell’Italia centro meridionale cit. (n. 3), pp. 225-226.
70 D. D. TRIANTAFYLLÓPOULOS, Il culto e l’immagine di san Nicola a Cipro, in San Nicola.Splendori d’arte (n. 65), pp. 117-126.
71 La grande devozione verso il santo è probabilmente dovuta alle sue qualità di in-
tercessore e alla sue virtù miracolose, rispondenti ai diversi aspetti della vita della popo-
lazione dei villaggi, cfr. L. SAFRAN, The art of veneration: saints and villages in the Salentoand the Mani, in Les Villages dans l’Empire byzantin (IV-XV siècle), a cura di J. LEFORT, C.MORRISSON e J. P. SODINI, Parigi, 2005, p. 188.
72 M. PANAYOTIDI, Quelques affinités intéressantes entre certaines peintures dans le Magne etdans l’Italie méridionale, in Ad Ovest di Bisanzio. Il Salento medievale. Atti del Seminario In-ternazionale di Studio (Martano, 29-30 aprile 1988), a cura di B. VETERE, Galatina, 1990,pp. 117-125.
73 G. OTRANTO, Il cammino dell’Angelo e di S. Nicola, in Nicolaus. Studi Storici, 42-43(2011), p. 17.
74 M. BACCI, Osservazioni sulle metamorfosi occidentali dell’immagine di San Nicola, in Nico-laus. Studi Storici, 42-43 (2011), p. 183.
18XX20.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO20
Come si è già anticipato, dal punto di vista iconografico il di-pinto grottagliese deriva da più antichi prototipi di matrice bizan-tina elaborati in Oriente nel corso dell’alto medioevo 75: in Pugliail modello si ritrova precocemente nella cripta di Santa Marina eCristina a Carpignano Salentino 76, nell’abside della cripta dei SantiStefani a Vaste 77 e a Santa Marina a Muro Leccese 78, per poi dif-fondersi in seguito, con lievi varianti, in tutta la regione nel corsodei secoli successivi 79. Tuttavia l’esempio in esame trova su scalalocale più stringenti confronti iconografici con affreschi cronologi-camente più vicini e particolarmente influenzati dal Mediterraneoorientale, quali la raffigurazione del santo omonimo nella chiesa diSan Biagio presso San Vito dei Normanni (fig. 30) 80 e la secondafase della decorazione di San Nicola a Mottola 81; a questi riferi-menti bisogna inoltre aggiungere una serie di icone, tra cui si se-gnalano, tra le altre, alcune provenienti dal monastero di Santa Ca-terina sul Monte Sinai, che raffigurano il santo a mezzo busto 82 (difine XII e fine XIII secolo) e la celebre icona conservata nella Pina-
75 N. LAVERMICOCCA, L’”imago depicta” di Myra: le origini della iconografia di San Nicola,in Il segno del culto: San Nicola: arte, iconografia e religiosità popolare, a cura di N. LAVERMI-COCCA, Bari, 1987, pp. 19-26; M. FALLA CASTELFRANCHI, Ante laterali di un trittico con le figu-re dei santi Pietro e Paolo, Nicola e San Giovanni Crisostomo, in San Nicola. Splendori d’arte cit.(n. 65), pp. 188-189; M. BACCI, San Nicola. Il grande taumaturgo, Roma - Bari 2009, pp.73-98.
76 FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), p. 37.77 FALLA CASTELFRANCHI, La pittura rupestre bizantina in Terra d’Otranto cit. (n. 4), pp.
225-226.78 M. FALLA CASTELFRANCHI, La chiesa di Santa Marina a Muro Leccese, in Puglia Prero-
manica, a cura di G. BERTELLI, Milano, 2004, pp. 193-205.79 Per la citazione dei numerosi esempi pugliesi cfr. CALÒ MARIANI, L’immagine e il
culto di san Nicola cit. (n. 65), pp. 107-116.80 FALLA CASTELFRANCHI, La pittura bizantina in Salento (secoli X-XIV), in Ad Ovest di
Bisanzio cit. (n. 72), pp. 154-157.81 N. LAVERMICOCCA, Il programma decorativo del santuario rupestre di San Nicola a Motto-
la, in Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno in Italia meridionale. Atti del IIConvegno Internazionale sulla Civiltà rupestre nel Mezzogiorno d’Italia (Taranto - Motto-la, 31 ottobre - 4 novembre1973), Taranto, 1977, pp. 291-334.
82 Nelle icone citate San Nicola è accompagnato da altre figure, quali gli angeli, il
Cristo e la Vergine, che non compaiono nell’esempio grottagliese, cfr. N. P. SEVCENKO,Scheda II.6. Icona agiografica di San Nicola, in San Nicola. Splendori d’arte cit. (n. 65), pp.207-208; C. CHOTZÁKOGLOU, Scheda II.7. Icona con San Nicola a mezza figura, in San Nicola.Splendori d’arte cit. (n. 65), pp. 208-209.
18XX21.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 21
coteca Provinciale di Bari, ma originariamente parte dell’arredo li-turgico della chiesa di Santa Margherita presso Bisceglie, per laquale sono già state più volte sottolineate influenze sinaiche e ci-priote, con tangenze, per le scene narrative, con l’Historie Universelleminiata a San Giovanni d’Acri 83. I riferimenti potrebbero conti-nuare, ma ci si limiterà a segnalare che tale iconografia compare in-fine anche in una serie di insegne di pellegrinaggio, attestate intutta Europa, di cui un esempio, datato tra XIII e XIV secolo, èstato recentemente rinvenuto nel corso dello scavo del Convento diLargo Abate Elia nel centro storico di Bari (Fig. 31) 84.
Anche la raffigurazione di santa Barbara è un elemento abbas-tanza comune per il territorio in esame; il culto della martire infat-ti aveva conosciuto a partire dall’alto medioevo una buona diffusio-ne in tutto il Mediterraneo Orientale 85, in particolare in Siria, inEgitto, a Bisanzio, a Cipro 86 e in alcune aree della Grecia 87; inItalia si diffuse probabilmente in seguito alla prima dominazionebizantina 88, ma il numero più consistente di dedicazioni e rappre-sentazioni è da attribuire al Medioevo maturo: nel Mezzogiorno at-testazioni in ambito rupestre si registrano in Campania, a Calvi e aRavello, in Basilicata, a Matera, e ovviamente in Puglia. A Grotta-
83 M. MILELLA LOVECCHIO, Scheda n. 25. San Nicola e storie della sua vita, in Icone di Pu-glia e Basilicata dal Medioevo al Settecento. Catalogo della mostra (Bari, 9 ottobre - 11 di-cembre 1988), a cura di P. BELLI D’ELIA, Milano, 1988, pp. 122-123; P. BELLI D’ELIA, Sche-da n. 3. San Nicola e storie della sua vita, in La Pinacoteca Provinciale di Bari. Opere dall’XIal XVIII secolo, a cura di C. GELAO, Roma, 1998, pp. 6-8. M. Falla Castelfranchi , contra-riamente gli altri autori citati, ha proposto una datazione vicina al 1198, anno della con-sacrazione della chiesa, Cfr. FALLA CASTELFRANCHI, La decorazione pittorica delle chiese rupestridel territorio di Monopoli cit. (n. 63), p. 141.
84 M. CIOCE, S(anctus) N(icolaus): un’insegna di pellegrinaggio dallo scavo del convento diLargo Abate Elia, in Nicolaus. Studi Storici, 42-43 (2011), pp. 205-215.
85 R. APRILE, voce Barbara, in Bibliotheca Sanctorum, Roma, 1961, coll. 760 -767.86 Si ricordi, a titolo di esempio, la raffigurazione della santa nella chiesa della Pana-
ghia nel villaggio di Moutoullas, cfr. D. MAURIKI, The wall painting of the Church of Pana-ghia at Moutoullas, Cyprus, in Byzanz und der Westen. Studien zur Kunst des europäischen Mit-telalters, Vienna, 1984, pp. 171-213.
87 Nella regione della Magna Barbara è la santa che conta il numero maggiore di de-
dicazioni cfr., SAFRAN, The art of veneration: saints and villages cit. (n. 71), p. 180.88 Una delle prime raffigurazioni della santa è documentata intorno alla metà del VII
secolo a Roma, presso la chiesa di Santa Maria Antiqua, cfr. G. MATTHIAE, Pittura roma-na del Medioevo. I. Secoli IV - X, Roma, 1987, fig. 166.
18XX22.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO22
glie la santa è ritratta secondo un’iconografia consolidata in Terrad’Otranto che trova il suo confronto più antico nell’immagine af-frescata sull’ultimo pilastro meridionale della chiesa di Santa Mariadella Croce a Casaranello 89, un modello questo che rimarrà presso-ché invariato fino agli ultimi secoli dell’età medievale (Fig. 32).
Sul piano più propriamente stilistico gli affreschi sono da in-quadrare nella complessa e articolata temperie artistica pugliese del-la prima metà del XIV secolo 90. Se infatti da un lato essi appaionocome un prodotto conservatore, agganciato alla locale tradizione bi-zantina, ancora in parte influenzata dai modelli tardocommeni, -inevitabile punto di riferimento artistico per l’intero territorio joni-co, da cui l’ignoto autore eredita la frontalità, la staticità, il pan-neggio rigido delle figure e la ricchezza degli ornati delle vesti -dall’altro tali dipinti sono portatori di suggestioni culturali diverse,la cui direttrici si dispiegano, senza contraddizione, allo stesso tem-po verso est, nella cultura figurativa orientale mediata dalle espe-rienze artistiche dei regni latini di oriente, e verso occidente, nelladirezione più marcatamente continentale del raffinato linguaggiopittorico angioino.
Le affinità con l’arte cosiddetta “crociata” - intesa come espe-rienza dagli esiti eterogenei, caratterizzata dalla fusione tra la tradi-zione pittorica locale siriana con quella bizantina e occidentale 91 -
89 M. FALLA CASTELFRANCHI, La chiesa di Santa Maria della Croce a Casaranello, in Pu-glia preromanica cit. ( n. 78), pp. 172-173.
90 V. PACE, Pittura del Duecento e del Trecento in Puglia, Basilicata e nell’Italia meridionale“greca”, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano, 1985, pp. 451-459; P.LEONE DE CASTRIS, Pittura del Duecento e del Trecento a Napoli e nel Meridione, in La pittura inItalia cit., pp. 461-512, in particolare pp. 461-476; FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumen-tale cit. (n. 4), pp. 213-283.
91 Non vi è una definizione univoca di tale fenomeno artistico e diversi sono i pareri
sul ruolo assunto da alcune realtà territoriali quali la Terra Santa, Cipro e la Puglia; la
disamina di tale problema va oltre i limiti del presente contributo, per tanto si rimanda
per alcuni approfondimenti alla seguente bibliografia, cfr. H. BUCHTAL, Miniature paintingin the Latin Kindom of Jerusalem, Oxford, 1957; K. WEITZMANN, Icon painting in crusader kin-dom, in Dumbarton Oaks Papers, XX (1966), pp. 51-83; M. D’ELIA, Aggiunte alla pittura pu-gliese del tardo Medioevo (la cripta del Crocefisso ad Ugento), in Scritti di Storia dell’Arte in onoredi V. Procacci, a cura di M. G. CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO e P. DAL POGGETTO, Milano,1977, pp. 62-67; V. PACE, Presenze e influenze cipriote nella pittura duecentesca italiana, inCorso di cultura sull’arte Ravennate e Bizantina, XXXII (1985), pp. 259-298; D. MAURIKI,
18XX23.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 23
si coglie nei grandi occhi, nei volti piatti e larghi, interessati dauna scarsa connotazione chiaroscurale, nella simmetria dei volti ris-petto all’asse della sottile canna nasale, mentre i primi elementidella nuova maniera di gusto francese, inaugurata forse solo qualchetempo prima a Santa Maria del Casale a Brindisi 92, sono ravvisabiliin alcuni dettagli, quali, i menti perfettamente ovali segnati da unapiega della pelle, i colli slanciati, l’accentuazione della forma agmi-dale degli occhi e il colorito accennato delle gote.
Del resto anche i confronti formali delle singole figure riman-dano ai decenni di trapasso tra i due secoli; il san Nicola di Grotta-glie trova infatti alcuni raffronti con affreschi datati alla fine delXIII secolo come il medesimo santo delle chiese di San Giovanni inMonterrone 93 (Fig. 33a) e di San Nicola dei Greci 94 (Fig. 33b) aMatera, e di San Nicola a Mottola 95; alcuni convincenti riferimentiperò si riscontrano soprattutto in esempi inquadrabili all’inizio onel corso del secolo successivo, come il san Nicola della Cattedraledi Nardò 96, della Cripta del Crocefisso a Ugento 97(Fig. 33c), dellachiesa rupestre della Celimanna a Supersano 98 (Fig. 33d) e infine
Thirteenth - Century Icon Painting in Cyprus, in The Griffon, n.s., 1-2 (1985-1986), pp. 9-112; FALLA CASTELFRANCHI, La pittura bizantina in Salento cit. (n. 80), pp. 157-164; B.KÜHNEL, L’arte crociata tra Oriente e Occidente, in Le Crociate. L’Oriente e l’Occidente cit. (n. 5),pp. 341-353; J. FOLDA, Crusader Art in the Holy Land, from the third crusade to the fall ofAcre, 1187 - 1291, New York, 2005, in particolare pp. 511-527; P. BELLI D’ELIA, Il ruolodella Terra Santa nell’origine e nella diffusione delle immagini di devozione. Esempi della Puglia,in La Terrasanta e il crepuscolo della crociata. Oltre Federico II e dopo la caduta di Acri. Atti delconvegno di Studio (Bari - Matera - Barletta, 19-22 maggio 1994), a cura di M. S. CALÒ
MARIANI, Bari, 2009, pp. 287-302.92 M. S. CALÒ MARIANI, La chiesa di S. Maria del Casale presso Brindisi, Fasano, 1967.93 LA SCALETTA, Scheda 104. San Giovanni in Monterrone, in Chiese e asceteri rupestri di
Matera, a cura di M. PADULA, C. MOTTA e G. LIONETTI, Roma, 1995, p. 152.94 LA SCALETTA, Scheda 120. San Nicola dei Greci, in Chiese e asceteri rupestri cit. (n. 93),
pp. 159-160.95 Mi riferisco in particolar modo all’ultima fase pittorica della chiesa, cfr. N. LAVER-
MICOCCA, Il programma decorativo del santuario rupestre cit. (n. 81).96 FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), pp. 193; EAD., La pittura bizan-
tina in Salento cit. ( n. 80), p. 192.97 Si noti il particolare del libro molto simile a quello di Grottaglie, cfr. FALLA CA-
STELFRANCHI, La pittura bizantina in Salento cit. (n. 80), p. 185; EAD., La decorazione pittoricadella cripta detta del Crocifissso ad Ugento, in La Cripta del Crocefisso ad Ugento. La storia, glistudi, le nuove acquisizioni, a cura di M. C. DE MATTEIS, Presicce, 2006, pp. 39-55.
98 M. FALLA CASTELFRANCHI, La decorazione pittorica bizantina della cripta della Celiman-
18XX24.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO24
della fase trecentesca della chiesa dei Santi Stefani a Vaste 99, esem-pi quest’ultimi tutti accumunati dall’essere concepiti come vere eproprie icone su parete 100.
Anche per santa Barbara i confronti più immediati sarebbero dariferire a un gruppo abbastanza omogeneo di dipinti che si datanotra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo: tra essi si annoveranole sante Barbara e Agata di Santa Lucia a Brindisi 101, la santa Sofiadella Madonna degli Angioli a Matera 102, la santa Barbara del san-tuario della Madonna delle Grazie a San Marzano 103 (Fig. 34a), del-la chiesa di Santa Barbara a Ginosa 104 (Fig. 34b) e di San Nicoladei Greci 105 (Fig. 34c); anche in questo caso però paralleli più chepertinenti, soprattutto per ciò che concerne l’impostazione della fi-gura e alcuni dettagli, quali le mani lunghe affusolate e la resa del-l’incarnato delle labbra, possono essere stabiliti anche con altre ope-re di diversa qualità pittorica datate con più certezza nel corso delXIV secolo, come la santa Margherita di S. Maria della Lizza adAlezio 106 e le raffigurazioni di santa Caterina nelle chiese della Buo-na Nuova a Massafra 107 (Fig. 35b), di San Giovanni Evangelista a
na, in Supersano. Un paesaggio antico del basso Salento, a cura di P. ARTHUR e V. MELISSANO,Galatina, 2004, pp. 69-80.
99 FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), p. 233.100 Cfr. supra a n. 63 le considerazioni in merito questa particolare scelta iconografica.101 M. GUGLIELMI, Gli affreschi del XIII e del XIV secolo nel centro storico di Brindisi, Mar-
tina Franca, 1990, pp. 90-93.102 LA SCALETTA, Scheda 13. Madonna degli Angioli, in Chiese e asceteri rupestri cit. (n. 93),
pp. 95-96, tav. IV.103 DEROSA, Tra Puglia e Basilicata cit. (n. 6), pp. 91-104.104 Ringrazio il dott. Vincenzo Stasolla per avermi permesso di visitare la chiesa, che
purtroppo versa in pessime condizioni di conservazione. L’affresco di Santa Barbara, an-
cora visibile qualche anno or sono, ora è quasi del tutto scomparso, cfr. P. BOZZA, M.
CAPONE, Le chiese rupestri di Ginosa, Ginosa, 1991, p. 64-67.105 L’impostazione dei due affreschi è pressoché identica, cfr. LA SCALETTA, Scheda 120.
San Nicola cit. (n. 94).106 Per un’analisi del modello architettonico dell’edificio cfr. FALLA CASTELFRANCHI,
Pittura monumentale cit. (n. 4), pp. 222-233; M. S. CALÒ MARIANI, Echi d’Oltremare in Terrad’Otranto. Imprese pittoriche e committenza feudale fra XIII e XIV secolo, in Il cammino di Geru-salemme. Atti del II Convegno Internazionale di Studio (Bari - Barletta - Trani, 18-22maggio 1999), a cura di M. S. CALÒ MARIANI, Bari, 2009, pp. 258-261.
107 R. CAPRARA, La chiesa rupestre della Buona Nuova a Massafra, Firenze, 1979, in parti-colare pp. 45-81.
18XX25.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 25
San Cesario di Lecce 108 (Fig. 35c) e - in particolar modo - di SantaMaria del Casale a Brindisi 109 (Fig. 35d).
Per ciò che riguarda il Cristo raffigurato nell’abside centrale iriferimenti potrebbero essere altrettanto numerosi, tuttavia ci si li-miterà a segnalare che, come si è avuto modo di verificare per glialtri affreschi, se da un lato è ineludibile il legame con alcune pit-ture più antiche, come ad esempio il Cristo Pantocratore di San Ni-cola a Mottola e di Santa Croce a Ginosa 110 (Fig. 36b), o di stampo“crociato” 111, come il San Sebastiano della chiesa del Santo Sepolcroa Barletta 112 (Fig. 36c), della fine del XIII secolo - vicino all’esem-pio grottagliese per una certa resa “geometrica” del volto - dall’al-tro appare ormai evidente un avvicinamento a esperienze successivedi altra matrice culturale, come la raffigurazione del Mandylion diSan Cesario di Lecce 113 (Fig. 36d).
Per quanto attiene la decorazione dell’acquasantiera, l’interpre-tazione appare sicuramente più complessa. Come è stato già sottoli-neato nel paragrafo precedente, l’analisi stratigrafica e architettonicatenderebbe considerala parte del progetto originario della chiesa 114;questo dato sembrerebbe confermato, pur dubitativamente a causadelle modalità di rinvenimento della grotta, anche dalla prima let-tura della decorazione pittorica 115. Lo spazio interno, infatti, appare
108 É necessario segnalare però che la qualità pittorica degli affreschi di San Cesario è
notevolmente superiore rispetto ai dipinti grottagliesi. Desidero ringraziare i dipendenti
dell’amministrazione comunale che mi hanno consentito l’accesso alla chiesa. Per un’a-
nalisi stilistica degli affreschi cfr. V. PACE, Affreschi dell’Italia meridionale “greca” nella primametà del XIV secolo, in Deæani et l’art byzantin au milieu du XIVe siècle, Extrait du recueildes travaux Deèani et l’art byzantin au milieu du XIVe siècle. XIX Colloque scientifiquede l’Accademie serbe des sciences et des arts, (Beograd-Deèani 1985), Beograd, 1989, pp.109-118; FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), pp. 213-214.
109 P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze, 1986, p. 159 ss.110 BOZZA, CAPONE, Le chiese rupestri di Ginosa cit. (n. 104), pp. 50-53, fig. 24.111 Per la definizione del termine cfr supra n. 91.112 PACE, Pittura del Duecento e del Trecento in Puglia cit. (n. 90), p. 453; per uno studio
sull’intero edificio cfr. A. AMBROSI, Architettura dei crociati in Puglia. Il Santo Sepolcro diBarletta, Bari, 1976.
113 FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), pp. 213-214; EAD., La culturaartistica bizantina in Puglia cit. (n. 64), p. 91.
114 Cfr. supra il paragrafo Lettura stratigrafica.115 La presenza della ciotola in invetriata policroma non può essere determinante in
questo senso, poiché il reperto deve essere considerato un semplice termine post quem.
18XX26.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO26
caratterizzato sui bordi dalla raffigurazione di due colonne tortiliche, ispirandosi alla quinta architettonica della zona absidale 116,reggono un arco costituito da un motivo composto da dieci elemen-ti pseudorettagolari ornati da un punto di bianco (Figg. 20, 21,37). Sul fondo di colore giallo, all’interno di una cornice rossa de-corata da altri elementi bianchi, un motivo fitomorfo, dal corpo dicolore rosso, decorato da alcune sfere bianche, è composto da unalinea verticale diritta dalla quale dipartono simmetricamente sei“rami”.
Il soggetto rappresenta iconograficamente un unicum nel territo-rio pugliese e non vi sono al momento confronti diretti tali da po-ter permettere una lettura univoca; pur tuttavia, alla luce dei lega-mi artistici emersi dall’analisi degli affreschi della parete orientale,è forse lecito chiedersi, pur con molta cautela e solo a livello diipotesi, se tale decorazione non sia una semplificazione del temadell’Albero della Croce (o Albero della Vita) 117, rappresentato proprionel corso del XIV secolo a Santa Maria del Casale 118 (Fig. 38) e aSan Paolo a Brindisi 119. Se tale supposizione fosse verificata ci tro-veremmo ancora una volta di fronte a una committenza colta inambito rupestre, poiché la collocazione dell’Albero all’interno del-l’acquasantiera rinvierebbe a un preciso messaggio escatologico dimorte e rinascita, perfettamente coerente sia con il ruolo simbolicodell’acqua e in particolare dell’aspersione, intesa come ricordo delsacramento del battesimo 120 - morte e rinascita per eccellenza - sia
116 La stessa raffigurazione compare anche in una placchetta in bronzo proveniente
dalla zona retrostante l’affresco di Santa Barbara datata tra il XIII e il XIV secolo.117 C. LAPOSTOLLE, voce Abero di Iesse, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, I, Roma, 1991,
pp. 308-313.118 CALÒ MARIANI, La chiesa di S. Maria del Casale cit. (n. 92), pp. 61-66.119 GUGLIELMI, Gli affreschi del XIII e del XIV secolo cit. (n. 101), pp. 126-127. Un ulte-
riore esempio di questa rappresentazione è attestato anche al pian terreno di Torre Ale-manna presso Cerignola, cfr. S. MANACORDA, Torre Alemanna. Un ciclo pittorico medievale inCapitanata, Cerignola, 1997; M. S. CALÒ MARIANI, La pittura, in Capitanata Medievale, a cu-ra di M. S. CALÒ MARIANI, Foggia, 1998, pp. 194-195, fig. 17; P. BELLI D’ELIA, Segni e im-magini delle Crociate nel Mezzogiorno normanno-svevo, in Il Mezzogiorno normanno svevo e le cro-ciate, Atti delle quattordicesime giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 2000), acura di G. MUSCA, Bari, 2002, p. 345.
120 E. BASSAN, voce Acquasantiera, in Enciclopedia dell’Arte Medievale cit. (n. 117), pp.108-113.
18XX27.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 27
con il significato generale dell’Albero della Vita e in particolare dellemeditazioni contenute nel Lignum Vitae di san Bonaventura - lequali sono alla radice dell’elaborazione del medesimo tema di SantaMaria del Casale 121 - che nell’ambito delle riflessioni sulla morte diCristo alludono spesso in modo preciso al concetto di Cristo fonte -Cristo sorgente 122. Si tratta, evidentemente, di una proposta interpre-tativa che andrebbe approfondita, ma che confermerebbe, insiemead altri elementi di cui si dirà in seguito, una lettura in chiaveprettamente occidentale dell’edificio di culto.
DISCUSSIONE
Al termine di tale studio è forse possibile riassumere i dati raccoltie discutere alcuni temi che necessitano qualche approfondimento.
In primo luogo il riconoscimento di fasi precedenti all’edificiosacro ha permesso di comprendere che sullo spalto settentrionaledella gravina di San Giorgio una grotta naturale viene occupata perscopi produttivi in un periodo precedente l’inizio del XIV secolo:non si hanno a disposizione dati diretti per stabilire se nella stessaarea fosse un caso isolato, ma la presenza di numerose cavità ipogeeantropiche individuate poco lontano su entrambi gli spalti dell’in-vaso e la grande quantità del materiale ceramico rinvenuto all’inter-no della chiesa 123 fanno supporre l’esistenza di un abitato, per altro
121 CALÒ MARIANI, La chiesa di S. Maria del Casale cit. (n. 92), pp. 61.122 « (...) quod a fonte, scilicet cordis arcano, profusum, vim daret Sacramentis Eccle-
siae ad vitam gratiae conferendam, essetque iam in Christo viventibus poculum fontis
vivi salientis in vitam aeternam »; « (...) ut haurias de fonti bus Salvatoris. Hic enim est
fons egrediens de medio paradisi, qui, in quatuor divisus capita et in corda devota diffu-
sus, fecundat et irrigat universam terra »; « Hoc noss oleo sacro perunge huiusque tor-
rentis desiderabilibus, guttis sitibundas refocilla fauces arentium cordium, ut in voce
exsultationis et confessionis decantemus tibi cantica laudis, experientia teste probantes,
quotiamo apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen », cfr. SANCTI BONA-
VENTURAE, Opuscola Mystica, Lignum Vitae, 30, 47, edizione Opere di San Bonaventura. Opu-scoli Spirituali, a cura di A. CALUFETTI, Roma, 1992, pp. 244-245, 260-261A. Per una in-troduzione sulla spiritualità del santo cfr. BLASUCCI, La spiritualità di San Bonaventura, Fi-renze, 1974.
123 Alla luce dello studio dei reperti è infatti probabile che si tratti di materiale di
riporto.
18XX28.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO28
attestato dalle fonti a partire dall’età normanna, di cui però si igno-ra completamente l’entità 124. Dal punto di vista delle tecniche cos-truttive, il rinvenimento sulla facciata di alcuni incassi per travi li-gnee amplia i casi di ambienti, già rilevati nello studio dei villaggimedievali delle gravine di Riggio e Pensieri 125, realizzati con unatecnica mista che estende la superficie del vano ipogeo mediante larealizzazione di un avancorpo in materiale deperibile (Figg. 5, 6, 7).
In seguito ad alcune trasformazioni dell’area, probabilmente do-vute al ruolo di primo piano assunto dal casale sullo scorcio delXIII secolo, la grotta in precedenza occupata da una modesta co-lombaia viene completamente riqualificata per la costruzione di unedificio di culto, che integra lo spazio ipogeo con una parete di fac-ciata costruita in alzato 126, secondo una soluzione architettonica giàsperimentata nello stesso distretto geografico nel XII - XIII secolo,come documentato dagli esempi di S. Maria della Valle 127 e di S.Maria de Armenis 128 presso Matera. La planimetria dai volumi com-patti (Figg. 9, 10), pari a circa 16 m2, trova confronti per la suaimpostazione architettonica con alcune aule presbiteriali di area ma-terana 129, mentre le absidi di forma trapezoidale richiamano molte
124 Il fatto che le evidenze archeologiche siano state rinvenute in un contesto rupestre
non è una condizione sufficiente per ipotizzare un insediamento esclusivamente in grot-
ta, poiché la realizzazione del Castello e della Chiesa Matrice nel corso dello stesso XIV
secolo lascia intendere che, almeno in quel dato momento, il pianoro soprastante fosse
considerato parte del casale stesso. Del resto in tal senso vanno anche i dati raccolti nel
corso delle ricognizioni condotte nel territorio, che dimostrano un’intesa occupazione
medievale del sopraterra di molti villaggi ipogei, cfr. n. 3.125 Cfr. n. 3.126 Non ci sono dati per ipotizzare l’aspetto di tale facciata, ma è improbabile che essa
abbia previsto la realizzazione di elementi di pregio, poiché nel corso dello sterro pare
che non sia stato rinvenuto nessun elemento architettonico degno di nota.127 A realizzare la facciata in questo caso fu Leorio, un magister tarantino della seconda
metà del XIII secolo, cfr. LA SCALETTA, Scheda 1. Santa Maria della Valle, in Chiese e asceterirupestri cit. (n. 93), pp. 89-91; DELL’AQUILA, MESSINA, Le chiese rupestri cit. (n. 48), p. 58; M.S. CALÒ MARIANI, Puglia e Terra santa. I segni della devozione, in La Terrasanta e il crepuscolodella Crociata cit. (n. 91), pp. 68-74, fig. 59.
128 LA SCALETTA, Scheda 96. Santa Maria de Armenis, in Chiese e asceteri rupestri cit. (n.93), pp. 148-149.
129 Mi riferisco in particolar modo alle aule presbiteriali di S. Vito alla Murgia e di
Santa Lucia alle Malve, cfr. LA SCALETTA, Scheda 18. San Vito alla Murgia, in Chiese e asce-teri rupestri di Matera cit. (n. 93), pp. 99-100; ID., Scheda 105. Santa Lucia alla Malve, inChiese e asceteri rupestri di Matera cit. (n. 93), pp. 152-154.
18XX29.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 29
delle chiese dell’insediamento medievale di Palagianello 130, ma sidistinguono da esse per il fatto di non essere superfici accessibili, maquasi delle grandi nicchie il cui scopo è quello di ospitare la raffigura-zione iconico - votiva dei santi titolari della chiesa (Fig. 17).
L’impostazione della parete come una quinta architettonicascandita dal ripetersi di superfici chiuse in cui trovano posto le im-magini venerate trova numerosi precedenti in ambito rupestre nelcorso di tutto il Medioevo, in virtù proprio della natura parattaticadel linguaggio architettonico e artistico applicato in questi contesti;tuttavia la rappresentazione di archi poggianti su esili colonne trovai suoi confronti più prossimi nella trasposizione su affresco di ques-ti elementi che si incontra a Santa Margherita a Mottola 131, a SanVito vecchio a Gravina 132, a San Giovanni in Monterrone 133, a Ma-tera, e più tardi, nel XIV secolo, nella chiesa di San Giovani Evan-gelista a San Cesario di Lecce 134 e nelle chiese di San Paolo 135 eSanta Lucia 136 a Brindisi.
I particolari della decorazione “scultorea” rispondono a un gustotipico dell’età crociata: le cornici delle archeggiature, incise profon-damente nella roccia con un tratto continuo, oltre a dare una spinaascensionale alla bassa parete absidale, contribuiscono a creare nota-zioni chiaroscurali, accentuate dai solchi obliqui delle pseudo colon-ne, le quali vennero probabilmente percepite come un elementodistintivo della chiesa stessa, poiché il loro disegno fu riproposto apiù riprese, non solo nella superficie interna dell’acquasantiera (Fig.
130 San Nicola, Santi Eremiti, chiesa “anonima della pendice est”, San Gerolamo, R.
CAPRARA, L’insediamento rupestre di Palagianello. Le chiese, Firenze, 1980, pp. 15-35, 37-60,61-68, 101-118; per la chiesa di San Gerolamo più recentemente D. CARAGNANO, F. DEL-L’AQUILA, La chiesa rupestre di San Gerolamo a Palagianello, in Riflessioni. Umanesimo della Pie-tra, 35 (2012), pp. 145-152.
131 FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), p. 111, fig. 96; DELL’AQUILA,MESSINA, Le chiese rupestri cit. (n. 48), pp. 219-221.
132DELL’AQUILA, MESSINA, Le chiese rupestri cit. (n. 48), p. VIII.
133 LA SCALETTA, Scheda 104. San Giovanni in Monterrone cit. (n. 93), tavv. XX-XXII;DELL’AQUILA, MESSINA, Le chiese rupestri cit. (n. 4), p. 94.
134 FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), pp. 213-214; EAD., La culturaartistica bizantina in Puglia cit. (n. 64), p. 91.
135 GUGLIELMI, Gli affreschi del XIII e del XIV secolo cit. (n. 101), pp. 124-146.136 Mi riferisco in questo caso agli affreschi dell’abside della cripta, cfr. EAD., Gli affre-
schi del XIII e del XIV secolo cit. (n. 101), pp. 42-97, in particolare pp. 66-67.
18XX30.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO30
37), ma anche in una placchetta bronzea rinvenuta dietro l’affrescodi santa Barbara (Fig. 24d) e nel piedritto di età rinascimentale. Ildettaglio della colonna tortile non trova però confronti diretti in al-tre chiese del territorio, se non nell’unico caso della Madonna delleVirtù a Matera 137 (Fig. 39), i cui modelli architettonici in passatoerano stati messi in relazione ad esperienze siriache e più general-mente orientali, spiegate alla luce dell’arrivo a Matera nella primametà del XIII secolo delle sorores penitentes provenienti della chiesadi Santa Maria e Tutti i Santi di Accon 138. Pur non volendo trovareun legame così diretto tra un particolare decorativo e l’apporto dicontributi allogeni 139, si deve nondimeno rilevare che il tema com-pare spesso nella rappresentazione di parti architettoniche presentiin reperti mobili legati in qualche modo all’esperienza artistica deiregni latini di oriente 140 (Fig. 40); del resto una influenza mediata eindiretta di suggestioni provenienti da quel contesto culturale nonstupirebbe, poiché il casale di Grottaglie era prossimo all’antico
137 LA SCALETTA, Scheda 117. Madonna delle Virtù, in Chiese e asceteri rupestri cit. (n. 93),pp. 159-160, tav. LII-LIII; DELL’AQUILA, MESSINA, Le chiese rupestri cit. (n. 48), pp. 204-205.
138 C. FOTI, Ai margini della città murata. Gli insediamenti monastici di San Domenico eSanta Maria la Nova a Matera, Venosa, 1996, p. 70 ss.; oggi si tende a ridimensionare oquanto meno a non dare per certa la presenza della chiesa nelle disponibilità delle mona-che agostiniane nei secoli del basso medioevo, se non altro per l’assenza di documenti chene provino la proprietà cfr. F. PANARELLI, Le origini del monastero femminile di Santa MariaLa Nova tra storia e storiografia, in Da Accon a Matera: Santa Maria la Nova, un monasterofemminile tra dimensione mediterranea e identità urbana (XIII - XVI secolo), a cura di F. PANA-RELLI, Berlino, 2012, pp. 1-57; C. ANDENNA, Da Moniales Novarum Penitentium a sorores ordi-nis Sanctae Mariae de Valle Viridi. Una forma di vita religiosa femminile fra Oriente e Occidente(secoli XIII-XV), in Da Accon a Matera cit., pp. 59-130.
139 Sarebbe infatti necessario studiare in modo più approfondito la chiesa rupestre ma-
terana e cercare di comprenderne con maggiore precisione le fasi costruttive e gli even-
tuali riferimenti architettonici.140 Si pensi, a titolo di esempio, al cosiddetto “ciborio di Wolfgang” dell’inizio del
XIII secolo o a reperti provenienti da aree geograficamente più vicine come i polittici
di Monopoli conservati al Museum of Fine Arts di Boston, datati XIV - XV secolo e messiin relazione, seppur indirettamente, con altri esempi analoghi presenti sugli altari dellechiese appartenenti ai Cavalieri Gerosolimitani, cfr. G. BRESC-BAUTIER, Le imitazioni delSanto Sepolcro, in Le Crociate. L’Oriente e l’Occidente cit. (n. 5), pp. 246-250; M. S. CALÒ MA-RIANI, Considerazioni sulla cultura artistica nel territorio a sud-est di Bari tra XI e XV secolo, inSocietà, cultura, economia nella Puglia Medievale. Il territorio a sud-est di Bari in età medievale.Atti del Convegno di Studi (Conversano, 13-15 maggio 1983), a cura di V. L’ABBATE, Ba-ri, 1985, pp. 385-425, figg. 18-20.
18XX31.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 31
percorso della via Appia che collegava i porti di Taranto e Brindi-si 141 ed era probabilmente un punto di passaggio di merci e perso-ne, come del resto è stato recentemente messo in evidenza daglistudi eseguiti sulla decorazione pittorica della chiesa rupestre incontrada Lo Noce 142 e in parte dagli esami condotti sui materiali(Fig. 24c).
Lasciando da parte l’analisi delle derivazioni artistiche, il cuistudio meriterebbe ben altro spazio, la presenza stessa dell’acqua-santiera merita di essere brevemente approfondita. Nel medioevotale struttura era collegata all’uso, assente nella chiesa Orientale,ma diffuso in Occidente dall’età post carolingia, dell’aspersione, in-tesa come pratica di segnarsi all’ingresso delle chiese o prima diqualunque orazione per ricordare ed estendere l’efficacia sacramenta-le del battesimo; le prime attestazioni sono documentate nell’Euro-pa occidentale (soprattutto Francia e Italia settentrionale) a partiredall’età romanica e i tipi più diffusi contemplano anche la soluzionedel recipiente ammorsato al muro, generalmente nella parete di in-gresso 143. L’esempio grottagliese condivide questa posizione e forsepotrebbe essere letto come un’ulteriore riproposizione della pratica,ampiamente documentata, di imitazione in ambiente ipogeo di unparticolare architettonico tipico delle chiese subdiali. Pur tuttavianel corso dell’analisi tecnica è stato già messo in evidenza come es-so non trovi precedenti in Puglia: forse è lecito chiedersi se questodato sia il risultato di un’incapacità interpretativa dovuta alle pessi-me condizioni di conservazione di molte altre evidenze simili 144 ose si sia intercettata una delle prime attestazioni di un uso chesembra poi diffondersi in età moderna, come attestato dal caso dellachiesa ipogea dei Santi Medici a Ginosa 145 (Fig. 41).
141 BALDACCHINO, Indagini archeologiche lungo le vie della transumanza cit. (n. 3).142 Nell’intradosso di una arcata della chiesa L. Safran ha riconosciuto il probabile
committente, un viaggiatore di nome Daniele, il quale è caratterizzato dal caratteristico
cappello a falda larga, cfr. SAFRAN, Scoperte salentine cit. (n. 4).143 BASSAN, voce Acquasantiera cit. (n. 120), pp. 108-113.144 Una struttura simile, privata del contenitore per l’acqua, non ha elementi facil-
mente riconoscibili per giungere in modo immediato a un’attribuzione funzionale, so-
prattutto se interessata da un forte deterioramento o da azioni posteriori.145 BOZZA, CAPONE, Le chiese rupestri di Ginosa cit. (n. 104), pp. 85-91, fig. 42. Ritengo
che la mancanza di confronti per il XIII - XIV secolo non sia una condizione sufficienteper posticipare alla fase rinascimentale la realizzazione dell’acquasantiera: i dati archeologi-
18XX32.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO32
In ogni caso, questo legame con scelte architettoniche tipichedella chiesa occidentale sembra confermato dall’interpretazione del-l’affresco dell’acquasantiera stessa, dall’assenza di qualsiasi divisoriotra bema e aula, ma anche dal rinvenimento di una brocca con orlotrilobato in invetriata policroma, che presenta nella parte inferioreun’iscrizione latina con il primo rigo del Salmo 96, Cantate DominoCatincu(m) Novum (Fig. 42); ad essa vanno aggiunte la già citataplacchetta in bronzo e una ciotola, le cui iscrizioni in greco presen-tano alcune incertezze che denunciano un uso poco consapevole ditale lingua. Se però l’eventuale presenza di clero latino non sorpren-derebbe in epoca angioina, più difficile è stabilire un legame diret-to tra la liturgia e le evidenze della parete absidale. In particolareper la nicchia di piccole dimensioni sopra l’altare maggiore, chetrova un confronto pertinente ancora una volta a Palagianello nellachiesa dei Santi Eremiti 146, non si può andare oltre un ovvio legamecon il rito eucaristico, suggerito anche dalla raffigurazione dellacroce, simbolo per eccellenza del sacrificio di Cristo 147. A giudicaredagli studi editi 148 non vi sono dati statisticamente sufficienti perstabilire se l’esistenza di tale nicchia in posizione centrale sia alter-nativa all’uso di prothesis e diaconicon , sia perché esempi come laMadonna della Croce a Matera 149 tenderebbero ad escluderlo, sia
ci, architettonici e storico artistici raccolti mi sembrano infatti abbastanza coerenti nell’as-segnare questa evidenza al momento della costruzione della chiesa.
146 CAPRARA, L’insediamento rupestre di Palagianello cit. (n. 130), p. 43, fig. 10; p. 52,fig. 13.
147 In altri casi privi della nicchia, come la “cattedrale” di Casale Petruscio a Mottola,
alcune croci vengono incise sulla parete absidale sopra l’altare, cfr. DELL’AQUILA, MESSINA,Le chiese rupestri cit. (n. 48), p. 89.
148 Altri casi di nicchie di questo tipo sono attestati a San Cipriano in agro di Taran-
to, cfr. R. CAPRARA, Le chiese rupestri del territorio di Taranto, Firenze, 1981, p. 145; SanAndrea, San Gerolamo, Santa Lucia e Serrapizzuta a Palagianello, cfr. ID., L’insediamento ru-pestre di Palagianello cit. (n. 130), p. 83, fig. 29; p. 110, fig. 43; p. 125, fig. 51; p. 167,fig. 68. Si tratta però di esempi eterogenei il cui studio andrebbe affrontato caso per caso,non solo studiando gli edifici con metodo stratigrafico, ma cercando di comprendere l’in-tero contesto abitativo e territoriale, mediante ricognizioni, rilievi e studi di archivio ingrado di fornire elementi di cronologia assoluta.
149 LA SCALETTA, Scheda 27. Madonna della Croce, in Chiese e asceteri rupestri cit. (n. 93),pp. 105-106, tav. VII. Sarebbe necessario verificare però se le tracce presenti all’internodell’abside appartengano alla stessa fase.
18XX33.HAJ 2/4/13
UNA CHIESA RUPESTRE INEDITA 33
perché anche nello stesso caso in esame non possiamo stabilire se ecome venissero utilizzati i piani delle “absidi - nicchie” laterali 150.
Infine, gli affreschi. Alla luce dell’analisi stilistica ritengo chevadano datati nel corso della prima metà del XIV secolo: in tale di-rezione vanno le considerazioni fin qui esposte e molti altri detta-gli, tra cui il colorito bruno della pelle delle figure 151 e l’acconcia-tura di Santa Barbara, elementi tipici di uno specifico arco cronolo-gico. L’autore fu probabilmente un pittore locale di tradizione bi-zantina, aggiornato ad alcune delle tendenze artistiche più recenti:nelle immagini infatti si coglie l’esito incerto di chi, pur tentandodi rendere alcuni elementi nuovi, come la volumetria delle figure eun certo tratto coloristico, ha inevitabilmente come modelli di rife-rimento la frontalità e la bidimensionalità della tradizione prece-dente. Il risultato non è univoco, poiché se da un lato coglie lo sco-po di rappresentare delle vere e proprie icone a parete, dall’altro lenovità sperimentate portano a dei disequilibri come la sproporzionedelle varie parti del corpo delle figure, la non perfetta riuscita dialcuni dettagli come le orecchie e un eccessivo impaccio nella resadei panneggi.
Alla luce delle informazioni acquisite, credo che l’edificio possaessere considerato di carattere privato, anche se non vi sono elemen-ti che possano confermare o smentire un’eventuale destinazione d’u-so funeraria, la quale al momento non appare testimoniata da nes-suna evidenza prossima alla chiesa; non si conosce neanche la dedi-cazione originaria, ma è probabile che essa vada ricercata in uno deisanti affrescati nelle absidi laterali, il cui culto - lo si è già sottoli-neato - è ampiamente documentato in tutto l’arco jonico nel corsodel medioevo. Per quanto riguarda la committenza, ammesso che sivoglia stabilire un legame tra i reperti del deposito volontario e laprima fase della chiesa stessa 152, non è da escludere che si tratti diun personaggio con una certa disponibilità economica, forse un es-
150 Del resto una ipotesi del genere, al momento improbabile, necessiterebbe di essere
provata da un serio approfondimento sulla liturgia, che incroci i dati delle fonti scritte
con tracce archeologiche datate.151 Tale colorito bruno si riscontra in alcune pitture del XIV secolo di Alezio e di
Ugento, cfr. FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumentale cit. (n. 4), pp. 222-233; EAD., Ladecorazione pittorica della cripta detta del Crocifissso cit. (n. 97), p. 45.
152 Il deposito fu verosimilmente chiuso nel XVI secolo, nascondendo oggetti anche
18XX34.HAJ 2/4/13
ANGELOFABIO ATTOLICO34
ponente del clero: in tal senso andrebbero alcuni indizi, quali la co-nstatazione della prossimità dell’edificio all’area del Castello Episco-pio, che nel XIV secolo diverrà sede del vescovo di Taranto 153, e ilrinvenimento di oggetti in qualche modo collegati alla liturgia o almondo ecclesiastico, quali le croci astili, la brocca e una serie diciotole, tra cui si distingue un esemplare la cui decorazione - unafigura umana barbata, vestita di una lunga tunica, seduta su untrono, che con la mano destra regge una croce, mentre con la sinis-tra benedice - richiama le rappresentazioni delle Autorità Spiritualicontenute negli Exultet dell’Italia Meridionale (Fig. 24b).
Come appare evidente dunque, i riferimenti emersi alla basedella realizzazione sia architettonica che artistica della chiesa hannomesso in evidenza la presenza di un sostrato culturale variegato epluristratificato, aperto, in virtù del vicino passaggio di importantiarterie di comunicazione, a nuovi e significativi apporti provenientidal Mediterraneo: un contesto di difficile interpretazione, la cuicompleta comprensione non si può che rimandare al prosieguo de-gli studi sui materiali e sugli altri insediamenti, che sapranno dare– si spera – ulteriori elementi per la decodificazione di un territoriotanto complesso quanto affascinante.
più antichi, i quali però ci danno forse delle informazioni sul tipo di frequentazione del-
l’area tra la fine del XIII e l’inizio di quello successivo.153 A prescindere dal momento esatto della realizzazione del Castello, i documenti
mettono in evidenza che l’intero casale era di proprietà del vescovo sin dall’età
normanna.
TAV. IA. ATTOLICO
Fig. 1 - Carta politica della provincia di Taranto con indicazione del territorio di Grottaglie.
Fig. 2 - Veduta del centro storico di Grottaglie con localizzazione dell’ex gravina di San Giorgio(elaborazione A. Attolico).
TAV. II A. ATTOLICO
Fig.3-Grottaglie(Ta),proprietàVestita:ingressodellachiesarupestre
(fotoA.Attolico).
Fig.4-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima:traccedipiccone
(fotoA.Attolico).
A. ATTOLICO TAV. III
Fig. 5 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima: rilievo laser scanner con indicazione dell’estensionedella grotta nel corso della fase I (rilievo Aesse Progetti Matera, elaborazione A. Attolico).
Fig. 6 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, prospetto sud: alloggi per travi lignee(foto A. Attolico).
TAV. IV A. ATTOLICO
Fig. 7 - Grottaglie (Ta), gravina di Pensieri, spalto est: abitazione rupestre (foto A. Attolico).
Fig. 8 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, parete nord: rilievo laser scanner con indicazionedegli interventi pertinenti alle diverse fasi di occupazione (rilievo Aesse Progetti Matera,
elaborazione A. Attolico).
A. ATTOLICO TAV. V
Fig. 9 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima: rilievo laser scanner(rilievo Aesse Progetti Matera, elaborazione A. Attolico).
Fig. 10 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima: planimetria(rilievo Aesse Progetti Matera, elaborazione A. Attolico).
TAV. VI A. ATTOLICO
Fig.11-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,paretesud:
USM
57(fotoedelaborazioneA.Attolico).
Fig.12-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,paretesud:
prospettocampioneUSM
57(rilievoA.Attolico).
A. ATTOLICO TAV. VII
Fig. 13 - Grottaglie (Ta), Castello Episcopio, mura occidentali: dettaglio della tessitura muraria(foto O. Di Lorenzo).
Fig. 14 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima: modello virtuale con particolare delle scale(rilievo Aesse Progetti Matera, elaborazione A. Attolico).
TAV. VIII A. ATTOLICO
Fig. 15 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima: rilievo scanner laser con veduta da ovest(rilievo Aesse Progetti Matera, elaborazione A. Attolico).
Fig. 16 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, abside centrale:tracce di ascia di piccole dimensioni (foto A. Attolico).
A. ATTOLICO TAV. IX
Fig. 17 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, zona absidale: veduta (foto. Attolico).
Fig. 18 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, parete est: rilievo scanner laser con indicazionedegli interventi pertinenti alle diverse fasi di occupazione (rilievo Aesse Progetti Matera,
elaborazione A. Attolico).
TAV. X A. ATTOLICO
Fig. 19 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, soffitto: croce incisa (foto A. Attolico).
Fig. 20 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, parete ovest: rilievo scanner laser con indicazionedegli interventi pertinenti alle diverse fasi di occupazione (rilievo Aesse Progetti Matera,
elaborazione A. Attolico).
A. ATTOLICO TAV. XI
Fig.21-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteovest:
acquasantiera(fotoA.Attolico).
Fig.22-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteovest:
colonnatortileearcointagliatonellaroccia(fotoA.Attolico).
TAV. XII A. ATTOLICO
Fig. 23 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima, parete est, abside meridionale: santa Barbara(foto A. Attolico).
Fig. 24 - Grottaglie (Ta), chiesa rupestre anonima: selezione di alcuni reperti provenientidal deposito volontario occultato dietro l’affresco di santa Barbara (foto A. Attolico).
A. ATTOLICO TAV. XIII
Fig.25-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteest:particolaredellostratodi
preparazionedeipianidicalpestiodellestrutturesoprastantilachiesa(fotoO.DiLorenzo).
Fig.26-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,parete
est,absidesettentrionale:sanNicola(fotoA.Attolico).
TAV. XIV A. ATTOLICO
Fig.27-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteest,
absidesettentrionale:particolaredisanNicola(fotoA.Attolico).
Fig.28-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteest,
absidecentrale:Cristo(fotoA.Attolico).
A. ATTOLICO TAV. XV
Fig.29-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteest,absidecentrale:
particolaredellanicchiasopral’altare(fotoA.Attolico).
Fig.30-SanVitodeiNormanni(Br),chiesarupestre
diSanBiagio:sanNicola(fotoA.Attolico).
TAV. XVI A. ATTOLICO
Fig. 31 - Bari, Museo Nicolaiano: insegna di pellegrinaggio (da CIOCE 2011).
Fig. 32 - Casarano (Le), chiesa di Santa Maria della Croce: santa Barbara (foto A. Attolico).
A. ATTOLICO TAV. XVII
Fig. 33 - a) Matera, chiesa di San Giovanni in Monterrone: san Nicola (foto A. Attolico); b) Ma-tera, chiesa di San Nicola dei Greci: san Nicola (foto A. Attolico); c) Ugento (Le), chiesa del Cro-cefisso: san Nicola (da FALLA CASTELFRANCHI 2006); d) Supersano (Le), chiesa della Celimanna:
san Nicola (foto A. Attolico).
TAV. XVIII A. ATTOLICO
Fig.34-a)SanMarzanodiSanGiuseppe,santuariodellaMadonnadelleGrazie:santaBarbara(daDEROSA2001);b)Ginosa(Ta),chiesadiSantaBarbara:
santaBarbara(fotoV.Strasolla);c)Matera,chiesadiSanNicoladeiGreci:santaBarbara(fotoA.Attolico).
A. ATTOLICO TAV. XIX
Fig.35-a)Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteest,absidemeridionale:santaBarbara(fotoA.Attolico);b)Massafra,chiesadellaBuona
Nuova:santaCaterina(fotoA.Attolico);c)SanCesariodiLecce(Le),chiesadiSanGiovanniEvangelista:santaCaterina(fotoA.Attolico);d)Brindisi,
chiesadiSantaMariadelCasale:santaCaterina(fotoA.Attolico).
TAV. XX A. ATTOLICO
Fig.36-a)Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteest,absidecentrale:Cristo(fotoA.Attolico);b)Ginosa,chiesadellaSantaCroce:Cristo(daBOZZA
CAPONE1991);c)Barletta,chiesadelSantoSepolcro:sanSebastiano(fotoA.Attolico);d)SanCesariodiLecce(Le),chiesadiSanGiovanniEvangelista:
raffigurazionedelM
andy
lion(fotoA.Attolico).
A. ATTOLICO TAV. XXI
Fig.37-Grottaglie(Ta),chiesarupestreanonima,pareteovest:
particolaredell’acquasantiera(fotoA.Attolico).
Fig.38-Brindisi,chiesadiSantaMariadelCasale:
Alb
ero
dell
aC
roce(fotoA.Attolico).
TAV. XXII A. ATTOLICO
Fig.39-Matera,chiesadellaMadonnadelleVirtù:
particolaredellepseudocolonne(fotoO.DiLorenzo).
Fig.40-Ratisbona,Diozesanmuseum:CiboriodiWolfgang
(daBRESC-BAUTIER1997).































































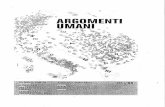
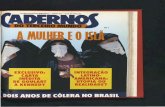
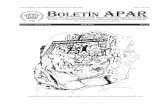
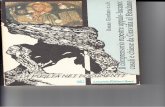







![Chiesa dell'Annunziatella [Roma]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ebadf4c5c8fb3a00e5599/chiesa-dellannunziatella-roma.jpg)





