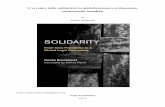Un’abduzione aberrante. Recensione e commento di Luigi Zoja, Paranoia, 2011
Prove d'antropogonia. Per una lettura di "Lagrima caddi" di Vigolo, in Il commento. Riflessioni e...
Transcript of Prove d'antropogonia. Per una lettura di "Lagrima caddi" di Vigolo, in Il commento. Riflessioni e...
ANDREA GIALLORETO
PROVE D’ANTROPOGONIAPER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
I
Estremi e distanti, il dio e l’uomo come il mezzogiorno e lamezzanotte. Tutto ciò che era posto nel dio, nell’uomoveniva tolto.
Giorgio Vigolo, Della poesia come fondamento
Fin dai primissimi tentativi di forgiarsi una strumentazione idonea arivestire di armonici e di preziose coloriture timbriche la sonorità di unaparola – il Verbo poetico – chiamata a levarsi sui piani del Canto spiegatoquando non del Carme, fin dalle prime sistemazioni della sua Ars poeticaGiorgio Vigolo ha individuato un fertile terreno d’esercizio teorico e di pra-tica espressiva nella triangolazione di nuclei d’irradiazione simbolica tenace-mente persistenti. Tali mots-clés, fra i quali sottolineo ai fini dell’argomenta-zione termini quali parola (col suo omologo poesia, ben ancorato alla radiceetimologica) creazione, destino, segnalano dietro i mitologemi percussiva-mente ricorrenti nell’opera dell’autore romano un intreccio di tensioni chedalla sfera onirica e del subconscio – fonti di sollecitazioni direttamenterifluenti nell’invaso artistico anche se sostanzialmente non traducibili nel-l’alfabeto freudiano1 e psicoanalitico – procedono verso la fissazione di una
201
1 Il lavoro di riproposizione di materiali d’archivio intrapreso – tra gli altri – da Paola Frandini offrel’occasione di cogliere ‘in flagrante’ lo scrittore nell’atto di dar sfogo alle proprie idiosincrasie, ai malu-mori per la disattenzione di cui si trova ad essere vittima, e a risentite osservazioni che difficilmente avreb-be licenziato per la pubblicazione senza smussare gli spigoli della propria vis polemica. Ecco, ad esempio,un giudizio fortemente limitativo sul grande viennese: «Freud è in fondo un cattivo moralista e un peg-
cifra classicamente risolta nella composita fusione di elementi tecnico-arti-gianali e di più instabili inquietudini dello spirito nel crogiolo di una vera epropria ‘etica della creazione’. Dall’ambito del duro apprendistato al domi-nio della forma, consustanziale al pensiero, si approda di necessità alla con-cezione della parola plasmata dall’artefice come concreto seppur traslatosegnacolo del travaglio della creazione operata tanto sulla materia molle – ilfango originario – quanto su quella refrattaria del linguaggio artistico (archi-tettonico, petroso, michelangiolesco: definizioni valide per molte prove diVigolo da Conclave dei sogni del ’35 ai I fantasmi di pietra e a La fame degliocchi, frutti esemplari dello stile tardo che collocano l’autore entro una costel-lazione letteraria illustre2). Per restare in prossimità dell’associazione, tuttal-
ANDREA GIALLORETO
202
giore psicologo. Un fantasista, un enigmista che come scrittore di libri gialli si invaghisce del preteso ince-sto potenziale che vede alla base della psiche. Il est un terribile simplificateur, che compie il peggiore pro-posito di sconoscenza dell’anima umana con la reductio ad unum di affetto e di libido. Riferendoci a quel-lo già scritto sulle case e le sue stanze, Freud ha fatto dell’anima umana un locale unico. Si mangia, sidefeca, si dorme tutti insieme […] è stato il profeta dei vagoni piombati. Secondo Freud le nevrosi dipen-dono da ambizione e astinenza – ma egli non considera invece le più frequenti nevrosi da abusi […].L’astinenza ben praticata, invece, dà euforia, serenità, guarisce il nervosismo». «La diagnosi delle tenden-ze regresse è quasi sempre fantastica: è un processo alle intenzioni» (V, 151)». Il brano è tratto dal quin-to quaderno dello zibaldone vigoliano e si può leggere in Paola Frandini, Nei quaderni di Giorgio Vigolo,in «Nuovi Argomenti», quinta serie, ottobre-dicembre 2003, 24, p. 331 in nota.
2 Vigolo ben figurerebbe in una rivisitazione critica della variabile letteraria individuata da LucaLenzini nella maturazione da parte di poeti giunti alla soglia della vecchiezza di uno «stile tardo» conno-tato da peculiarità che si distaccano dai modi consueti dell’opera pregressa finendo con l’instaurare unfitto dialogo traversato da lampi epigrammatici, da insorgenze ironiche o parodiche e da improrogabiliinterrogazioni. L’acredine con la quale il vecchio poeta saluta il presente che gli avvizzisce davanti agliocchi nel degrado e nella corruzione testimonia di una senescenza condivisa con l’intera compagine dellarealtà italiana: «Siamo destinati a morire / non solo di anni e di mali / ma avvelenati di tristezza, / tradi-ti / vilipesi / in quanto più amammo. // Il secolo ci si corrompe / attorno / prima ancora del nostro cada-vere» (Siamo destinati, in I fantasmi di pietra, Milano, Mondadori, 1977, p. 62, d’ora in poi FP). L’autoredi componimenti quali Siamo destinati, Farfalle nere, Corale, È il durare della mia vita, sonetto dell’ombrarisponde al richiamo ultimativo dell’oltre reimpostando i rapporti tra il sentimento dell’esistenza che siva esaurendo e la parola, sentita ora sempre più come insufficienza necessaria, labile strumento capacetuttavia di ripresentare alla memoria i rari momenti d’esenzione, di tregua al patire offerta dalla contem-plazione delle manifestazioni misteriose dell’energia naturale; il tenore di parecchi componimenti, alme-no a partire da Canto del destino, inclina alla presa d’atto di uno scacco cui nemmeno la scrittura puòporre rimedio. Quando tutto sembra consumato, ogni goccia d’inchiostro è più preziosa di una stilla disangue perché contiene, almeno in potenza, la summa dell’esperienza, l’Erlebnis da convertire in imma-gini e racconto se la mano è ferma, l’inchiostro non va disperso e basta all’impresa quel poco di vita cheavanza: «L’inchiostro versato / nella valigia fece una nera gora, / la notte mi svegliai con quel pensiero, /ne trasalii come per un rimorso: / la nera gora era passata nell’anima. // Ora ne sorrido guardandola / adasciugarsi al sole nel giardino, / tento variazioni sul tema: / Macbeth già disse, s’è versato il vino / dellavita, il poeta / può dirlo del suo inchiostro. // Inchiostro versato porta male / come l’olio e il sale / quan-do si rovescia sulla tavola. / Ed ecco ora trovata la morale della mia favola, / ecco che non sorrido più. /La morsa della notte mi riafferra, / la nera gora d’inchiostro cancella / l’ultimo poco bianco della mia vita»(L’inchiostro versato in La luce ricorda, Milano, Mondadori, 1967, pp. 387-388, d’ora in poi LR).L’estremo rigoglio di una vena che pareva disseccata, rinsecchita in un amaro rivolo di sentenze lapidariee di rievocazioni dolorose si risveglia dunque al tocco della più solerte delle divinità ispiratrici, ma l’ap-prodo alla dimensione metafisica si compie ormai senza lo slancio romantico della ricomposizione del-l’unità perduta con la «caduta» nell’esistenza («mistico inebriamento nel grande accordo maggiore
tro che peregrina e occasionale, operata dallo scrittore tra la facoltà generandi(scribendi) del poeta e quella creandi di Dio gioverà scorrere un brano tratto dalparagrafo intitolato La caduta originaria del saggio capitale di poetica del gio-vane Vigolo, ossia Della poesia come fondamento, scritto nel 1929, pubblicatonel 1962 su rivista insieme ad altri scritti inediti e finalmente leggibile inappendice alla monografia di Alberto Frattini, Introduzione a Giorgio Vigolo. Itermini della questione e il lessico adottato sono chiarissimi, al di là del boz-zolo metaforico la cui intelaiatura costituisce uno dei passaggi obbligati perl’attitudine dell’autore a concepire il pensiero in forme sature di espressività:
Il creare in sé, che è l’intimo nucleo della poesia, contiene i termini di creatore edi creatura non distinti e opposti, ma assolutamente interfusi, giacché il creatorenon crea che se stesso e il creare è il suo modus essendi…È solo nel momento tra-gico in cui l’immagine si travaglia nella partenogenesi dell’altro, che si satura disé medesima fino al distacco, in cosa creata, della sua stessa pienezza. Questodistacco è la repulsa di una saturazione che si pone come esigenza d’un opposto,d’un antitetico, e determina con ciò la transizione all’altro da sé o meglio la nega-zione di sé che è la vera creazione e cioè distacco in cosa creata: parto3.
Nel sistema abbozzato dal giovane autore, da poco liberatosi dalla tute-la della figura-guida ‘virgiliana’ di Arturo Onofri, vengono a coincidere Ge-
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
203
dell’Intiero, dell’Uno-Tutto, dell’en kai pan» secondo quanto si legge nel saggio vigoliano su Hölderlin),piuttosto come un viaggio tra ombre e riecheggiamenti di derivazione virgiliana e dantesca. Ce ne faavvertiti un testo di solenne compostezza e rigore come Corale: «La musa della morte / mi s’inghirlandadi rose di fuoco / e offre il ramo d’oro al re delle ombre / perché mi lasci passare di là. / Sento che la miamusica è alla fine, / ma d’ogni lutto l’anima si sgombra / e il canto spiega tutte stese l’ali / a un sole chel’illumina dal fondo. // Mio cuore, ti prevali / di questo estremo evento, il più profondo, / il più severodell’umano dramma / dove ai dadi giocammo il divenire: / ed il vivo preludio, / il patetico adagio, / loscherzo arioso e folle / scendono all’ampia foce del finale. / Tra gore dritte, vorticose e scure, / misterio-se figure / già appaiono sul cerchio delle rupi / intonando le note del corale». (FP, p. 54). Il processo di«sprofondamento» stigio procede fino alle ultime propaggini de La fame degli occhi (Roma, EdizioniFlorida,1982), che inscena un residuo di bramosìa e di attaccamento alla vita. L’ossessione è comunquequella del tempo, costante nell’intero corpus in prosa e in versi «solo che qui – segnala Anna Dolfi – l’e-terna, vigoliana impossibilità di misurare il tempo si è mutata in tempo decurtato di ogni durata possi-bile. Alle voragini aperte nella continuità temporale, che lasciavano spazio alle frane di secoli (ma da lìalle leggende, al mondo onirico), segue un continuum vitale minimo sul quale i ricordi del passato, sfo-cati, si affacciano a prospettare mondi vietati, interruzioni proibite. È come se fosse interdetta ormaianche la possibilità del sogno, come se quel pelago, quei marosi di un sogno vagamente psicanalitico untempo inseguito fino nelle segrete della storia individuale (il descensus averno come il tentativo di ripe-scare al fondo della propria anima i ricordi deformati dall’alterata visione infantile, perpetuati e ripropo-sti in tutta l’età adulta), fossero sostituiti dagli incubi impotenti di un «cervello decrepito», incapace difingere gli antichi sogni e gli antichi ardori, di bruciare la realtà e l’incubo alla vampa eroica del Trovatore»(Anna Dolfi, Vigolo e il ‘cadere dell’ombra’, in In libertà di lettura. Note e riflessioni novecentesche, Roma,Bulzoni, 1990, pp. 29-30).
3 Giorgio Vigolo, Della poesia come fondamento, in appendice ad Alberto Frattini, Introduzione aGiorgio Vigolo, Milano, Marzorati, 1984, pp. 131-132.
nesi della vita e crescita della parola suscitata dal dolore dell’esistenza cherompe il «silenzio creato» con la manifestazione della dismisura dell’uomorispetto ai confini e alla sacralità della natura, romanticamente letta comeproiezione immanente dell’ombra del divino. L’entità che sovrintende all’ar-chitettura del cosmo è identificata col moto che spinge alla nominazione, alrapprendersi in parola, immagine, suono del pulviscolare «limo» fatto dicolori, presenze, sensi e sovrasensi da cui germina la coscienza:
La divinità è il creare: anzi la divinità è un attributo umano del creare: un attri-buto che riassume gli altri attributi di infinito, eterno, onnipotente, onni-sciente ecc. Ma ciò che importa non sono gli attributi, è la sostanza. E lasostanza, è appunto questo creare, di cui la mente umana non può formularepiù elevata definizione, che identificandolo al creare poetico: alla poesia4.
Del segno (1938), ulteriore passo in avanti verso una definizione di sé edel proprio operare rispetto agli scritti che preludono al passaggio dalla coe-sistenza di prosa e verso (secondo uno stilema invalso in età vociana) alleprime raccolte poetiche, investe anche l’uomo della potenzialità della crea-zione. Essa agisce come una luce riflessa emanata dalla sorgente divina peraccompagnare il poeta in un tragitto di autorivelazione, di presa in caricodella responsabilità orfica del dichter, il poeta tramite tra il mondo dello spi-rito e i regni della vita naturale.
Il poetare è un atto in cui l’anima si riporta alle condizioni originali del pro-cesso creativo di sé e del mondo: poesia è il modo e la sostanza di tale proces-so in quanto partecipato e autorivelato all’uomo: è, in altri termini, la Parola,il Dio che passa al Creare, è il calore nel punto che si fa luce e suono5.
Il passaggio del fuoco creatore dal dio-demiurgo all’uomo segna peròl’immissione nel puro circolo della rappresentazione oggettiva dell’essere difattori imponderabili di pena e di ansia, congeniti alla fragilità dell’indivi-duo. Massima rimarrà sempre la divaricazione tra la nobiltà del compito ela debolezza del depositario del potere di dare voce alle cose, e ciò sarà ra-gione nelle stagioni seguenti di un teso agone con i limiti della propria «mi-seria» corporale. Vigolo può sembrare talvolta sfiorato dall’ala della crisiepistemologica che a inizio secolo aveva condotto Hofmannsthal a denun-ciare in Ein brief l’estraneità delle cose al senso che l’io vorrebbe loro im-porre. Ad esempio, un capitolo di Canto fermo presenta lo spaesamento del
ANDREA GIALLORETO
204
4 Ivi, p. 142.5 Ivi, p. 171.
primo uomo negli spazi «disanimati» del «mondo creato»; Adamo, ancorainconsapevole del suo dono e incapace di accordare la cetra di Orfeo, è let-teralmente risucchiato dall’identità plurale e metamorfica della realtà nuovache lo attornia e che attende da lui il battesimo che la faccia esistere simbo-licamente:
Non il dolore degli uomini, ma quello più accorato delle pietre, delle cose iner-ti e mute io portavo su me; non come Dio per gli uomini, ma come uomo perdare un’anima alle cose, mi agguagliavo ad esse e per esse mi disanimavo. Nonmi sapevo più io, avevo perduto il mio nome come si perde un oggetto per via.Ed ero tornato la creatura spersa, sola nel creato, che ha paura, che ha freddo,il primo animale nato allora, che si guarda d’attorno la terra solitaria e infini-ta: Adamo6.
Al contrario, nel breviario di poetica l’investimento è nella totalità gene-rante dalla parola (ignara di qualsiasi depauperazione, almeno fino al momen-to del tragico redde rationem coi fantasmi di una vecchiaia insidiata dalla decre-pitezza e dalla morte7), e la posta della scommessa è altissima. Anello di con-giunzione tra celeste e terrestre, corpo prestato all’inafferrabilità delle idee,delle passioni intellettuali raffinate al bagliore della filosofia, la parola è consa-crazione e condanna ad un tempo; difatti mai Vigolo conseguirà quella misu-ra, quell’equilibrio che dovrebbe mitigare, secondo le teorie del poeta diTubinga, l’accensione di sentimenti esacerbati, il dolore della separatezza e lanostalgia dell’unità infranta. Basti ricordare qui la testimonianza diretta chel’autore ha affidato a Pietro Gibellini: «la mia poesia ha la sua radice più tragi-ca in un trauma; e più ancora che critici e filologi, vorrei che mi esplorassero– in una patologia indubbiamente autentica, quanto diversa e allergica – psi-chiatri e neurologi. La mia poesia è sempre un test psichico da analizzare, ildiagramma delle curve di una febbre (visioni, sogni, incubi, terrori) che dallamia prima adolescenza mi martirizza. Poesia pagata cara»8.
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
205
6 G. Vigolo, Adamo o della solitudine, in Canto fermo, a cura di Bruno Nacci, Milano,Greco&Greco, 2001, pp. 80-81.
7 Il cono d’ombra e di trascuratezza da parte degli apparati culturali che avvolse Vigolo nei suoiultimi anni, se ha stimolato un cambio di passo nella produzione poetica (a tutto vantaggio della com-plessità della sua figura artistica), non ha fatto venir meno l’indole generosa e alacre del poeta, come hasottolineato Magda Vigilante: «se da un lato Vigolo considerava la propria solitudine come il segno diuna personalità che «non può emergere dal fondo uniforme del secolo, se non contrapponendosi ad essoin una dissonanza dolorosa», dall’altro era ugualmente convinto che il poeta «è destinato a promuoverela più profonda comunione degli uomini», scoprendo un significato universale nelle proprie esperienzetrasfigurate dalla poesia» (Magda Vigilante, Giorgio Vigolo (1894-1983), in «Studi Novecenteschi», XXIV(1997), 54, p. 259).
8 Da una lettera del 29 giugno 1977, in Pietro Gibellini, Giorgio Vigolo, in «Alfabeta», VIII (1986),81, p. 3 (citata nel commento di Giuliana Rigobello alle Poesie religiose e altre inedite cit., p. 74).
Il travaglio della creazione travasa nella modalità della ri-creazione,attraverso i mezzi dell’arte, l’affanno della rottura del silenzio – la stille höl-derliniana più che l’idillica ruh cara al Goethe lirico – come il disequilibrioprodotto dalla comparsa dell’uomo, creatura dolorante esposta agli attacchidi oscuri «mostri» che «fanno le cacce» a un orfano smarrito e assediato daifantasmi; la commossa invocazione alla madre sigilla l’io poetico, mai comeora autobiografico, nel tenebroso carcere della psiche piagata, abbandonatadalle immagini consolanti che più non giungono dal «lontano» (quale veritàpsicologica nell’indefinitezza di questo avverbio sostantivato!) in cui si èspersa l’ombra della madre:
Madre, mia madredove sei nel lontano?dove ti sei sperduta dopo la morte,che più non mi mandi la tua immaginee deserti sono i miei sogni,ma meno della mia vita?Io sto quaggiù lo vedi in quale pericolostrani mostri mi fanno le cacce, girano intorno intorno alla poca rupe.
La figura della madre è parte del vasto destino che vede la nascita degliuomini come uno «staccarsi» dall’indifferenziato grumo divino («la bontàindivisa») per precipitare in una realtà di parvenze effimere che velano gliocchi di visioni e affollano le notti di incubi indecifrabili («ambigue larve»).Del resto, come ha ben visto Bruno Nacci, l’attività onirica per lo scrittoreromano è una spessa cortina di miraggi, non sempre e soltanto forieri dimomenti d’esenzione dal male dell’esistenza. La fitta matassa del sonno sdi-pana i segreti chiusi nell’animo turbato facendo sì che la scrittura si risolvain «una modulazione all’interno di una placenta onirica da cui sembra nonci sia scampo»9; in tale ‘hypnomachia’ che impegna l’inconscio del poeta l’ap-pello alla madre assume l’intensità di una preghiera, culminando nellarichiesta («schiariscimi gli occhi») di dissipare le ombre che offuscano laragione e impediscono di ristabilire la comunicazione affettiva rotta dallamorte:
Madre, se esisti ancora in qualche punto dell’universo
ANDREA GIALLORETO
206
9 Bruno Nacci, Destino dei sogni, come introduzione in G. Vigolo, La città dell’anima, a cura diGiuliana Rigobello, Milano, Archinto, 2003, p. 12.
o sei tornata alla bontà indivisada cui ti staccasti nel nascere, fammi sentirediminuita la mia solitudine, schiariscimi gli occhi, che io giunga a rivederti nell’alto del tuo sereno,
e smetta di scorgere al tuo posto le ambigue larve che ti nascondonoal figlio10.
da questa lotta derivano l’orgoglioso titanismo di Vigolo e il confronto conla notte, fermentante di visioni, che produce una scrittura densa, corporea,per dare soffio vitale all’immateriale: spettri di luce, morgane, larve di unpassato che rifugge dai compiacimenti dell’erudizione perché è rivissuto esofferto, è immagine dello scoperchiarsi delle tombe in uno scenario di rovi-ne e apocalissi (Roma, anzi la «Roma di Vigolo» proverbiale quintessenza distorie arcane e invenzioni fascinose). Il tempo del singolo, il suo attraversa-mento della pena del vivere col fardello del corpo, rispecchia un più vastotempo escatologico che prende sovente le mosse da situazioni sedimentatenella coscienza religiosa dell’umanità. Così lo sconcertante episodio dellaresurrezione del dio morto in croce (identificazione piena dei destini del-l’uomo e di Dio) che tanto di frequente torna a visitare le pagine vigoliane èamplificazione su uno sfondo di universalità del trauma che afflisse lo scrit-tore e che ricorrendo alle formule di Otto Rank può essere circoscritto tra leconseguenze del trauma della nascita. Per il seguace dissenziente di Freudcon la resurrezione «non si ha che una ripetizione e una riproduzione delprocesso della nascita, su cui la sublimazione in senso etico-religioso hapotuto operare grazie al superamento nevrotico del trauma originario11». Daqui probabilmente la torsione che Vigolo imprime al significato dell’ascesaal cielo di Cristo facendone uno sgomentevole riemergere del dolore del-l’abbandono, del distacco che colpisce Creatore e creatura, marcati da unainsanabile ferita, quella della solitudine (sperimentata come il peggiore deimali dal poeta nella sua maturità di autorecluso12) richiamata dal diaframma
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
207
10 Grido alla madre, in LR, pp. 285-286. 11 Otto Rank, La sublimazione religiosa, in Il trauma della nascita, Rimini, Guaraldi, 1972, p. 136. 12 Nulla può nemmeno la forza di resistenza della scrittura di fronte agli assalti della solitudine:
«Sopra l’immenso muro di granito / non puoi graffire il minimo segno, / così sul blocco della solitudine/ è vano sogno incidere parole» (Il silenzio, in LR, p. 287). Con ben altro spirito di collaborazione alla
di separatezza ben evidente in Lagrima caddi, il testo che si esaminerà piùavanti. In quella poesia, una dolente «favola della genesi» (ma si potrà pen-sare anche a una «storia del buon Dio» di sapore rilkiano), con accenti diterso lirismo e una malinconica accettazione della nostra sorte di imperfe-
ANDREA GIALLORETO
208
costruzione di un’opera che preservasse la memoria dell’uomo sancendone l’alleanza con il divino, in con-trapposizione alla morte e al tempo, si ponevano gli artisti-artigiani che elevarono al cielo le grandi cat-tedrali. Vigolo tenta di frequente l’assimilazione per metafora della tecnica che presiede al poiein con ilpaziente lavoro dei maestri lapicidi, capaci di liberare le forze spirituali celate, imprigionate anzi, nellamassa inerte della pietra. Sarebbe superfluo sottolineare quanto questa zona di riflessione debba ad unmaturo sostrato di letture (che qui è possibile solo ipotizzare) dal grande decadentismo europeo: dalRuskin delle Stones of Venice (i cui riverberi illuminano ad esempio tante oasi meditative – vere anse sag-gistiche – frapposte nelle tragiche vicende degli eroi e delle eroine di Thomas Hardy) a Matthew Arnold,al saggio ruskiniano di Proust che introduce la sua versione de La bibbia di Amiens. La saldezza, nonchél’eleganza, degli edifici sacri nasceva dalla condivisione di uno spirito che, anelando al sacro, vivificava lamateria bruta, attraverso la liberazione della luce, dell’armonia delle forme, dal bozzolo opaco che le serra.Emblematica una delle poesie di più potente risalto immaginifico dell’intera produzione dello scrittoreromano, L’impronta, che ben esplicita la consustanzialità di materia e spirito concludendosi, dopo lamirabile descrizione del «fossile» angelico racchiuso tra gli strati geologici profondi, con lo schiudersidella vita sulla terra, sbocciata dall’«inerte salma d’un dio»; ecco la prima metà del testo con l’abbracciodella pietra sulla creatura in sonno millenario: «Dentro le pagine spesse di roccia / che col suo peso l’al-pe incuba opprime / è stampata d’un angelo la forma / come in un libro ove fu chiuso un fiore. / Nelduro impasto di rupe e di ferro / quella celeste immagine s’impresse / gittata nella tenebra; la pietra /come cera rispose alla sua impronta. // Ora le volte sotterranee, i curvi / gomiti delle grotte, gli archi, ivani / sono cava figura / e calco delle membra in questi porfidi / come inciso cameo dentro la terra. /L’inverso d’una statua. Non aria / la circonda, ma pietra: aria è il suo corpo. // Sulla roccia granita di sca-glia, / incrostata di mica e di quarzo / balena l’ala occhiuta del serafino: / e nell’acuta volta tra lo sfarzo /dei metalli e le vene di rubino / la faticosa scapola s’incastra / e in uno slancio di volo ancora la pietra sol-leva». L’idea dell’incavo di pietra da cui scaturisce la forma, come tante «nodose» giunture della gram-matica lirica del Vigolo di Conclave dei sogni possono far pensare alla rimeditazione del Michelangeloscultore e poeta, entro il quadro di un petrarchismo che nell’itinerario artistico del nostro è prima ogget-to di confronto, poi di svuotamento dall’interno di un sistema di rappresentazione dell’irrealtà ben radi-cato nel codice lirico italiano. È questa una delle vie che conducono Vigolo alla sua particolarissima sin-tesi tra la celebrazione dell’antico, delle serpeggianti forze numinose da un canto e della purificazione insenso cristiano della realtà oscura in luminosità scorporata dall’altro. Si legga un brano dal titolo assaiindicativo del «sincretismo» cui si accennava, Accordi di sacro e d’antico in cui allo slancio verticale dellegrandi cattedrali si sostituisce la più familiare «cassa armonica» rappresentata da quello scrigno sonoroche sono le chiese romane (e il ductus del tratto si conforma a qualche capitombolo barocco nell’esplora-zione degli spazi concavi, uterini, delle basiliche): «Di padre in figlio, gli antichi maestri edificatori dichiese, si tramandarono questo elementare concento delle sante caverne: e accordare ad esso i lor grandistromenti di pietra era un segreto quasi di liutai, una finezza d’orecchio che riusciva a istituire alla basedel tempio, a imprigionare quasi nelle sue fondamenta quella nota fondamentale. Il peso arcano dellamateria e l’aereo dei vuoti ancor oggi in queste basiliche è equilibrato in modo che la sostanza del sacroedifizio ad ogni vibrar d’organi, ad ogni squilla di vespri, commemora quel timbro unico e originario. Eal sapiente riscontro delle navi e delle absidi, delle cupole e dei portali è affidato tutto un labile magiste-ro d’echi e di silenzi, un non fortuito giuoco dell’aria che circola e modula in leggere volute pe’ vani dellachiesa come il murmure ondoso che è prigioniero delle conchiglie» (G. Vigolo, Accordi di sacro e d’anti-co, in Canto fermo cit, p. 31, il paragrafo – unità sintattico-semantica fondamentale per la paratassi strut-turale della prosa vigoliana – è rubricato sotto la titolazione di Chiese d’estate). Il tema del lavorìo di scavoper rivelare il bene racchiuso tra spesse pareti di roccia slitta poi dal piano degli intenti artistici a quellodella similitudine tra il tagliapietra intento alla sua opera e l’uomo che stoicamente si dibatte in cerca dipercorsi di salvezza: «Taglia pure con ogni arte la pietra / della tua vita, il nero / filone del destino / sem-pre vi riapparirà» (Il tagliapietra, in G. Vigolo, Poesie religiose e altre inedite cit, p. 82).
zione e di transitorietà viene proposto nel rapporto tra l’uomo e il suo crea-tore l’incontro impossibile di due fragilità diversamente motivate.
La figura del corpo martirizzato del figlio di Dio, accostando due incon-ciliabili come l’essenza imperitura del divino e la carne votata alla morte, costi-tuisce per l’autore un potente collettore di visionarietà e uno strumento dichiarificazione sul piano intellettuale e filosofico. Se a prevalere sono lo «scan-dalo» dell’accostamento e il contrastato profilo di una violenza perennementein grado di attentare alla salvezza dell’uomo (si veda la scena «caravaggesca» deI giocatori: «giù nella grotta dei martiri / ch’era taverna di militari / i crocifissibrillano su pozze / di sangue; e lì presso / i veterani / giuocano ancora / a cartestregate. // Su una carta piange Maria / il Figlio straziato, / su un’altra Veneregli occhi / volge languida e si pettina / gli aurati capelli sul mare / che mutacolore. / Moventi figure, numeri / di pianeti gittano / sul tavoliere / ad altegrida blasfeme; / poi mischiano i grandi / tarocchi e si fissano / nel giuoco dif-ficile e scuro»13), se dunque l’iconografia sacra è sfruttata come ausilio per unapoesia di resa espressionista, nondimeno tale motivo ha consentito al giovaneVigolo intento a precisare i criteri della propria arte di sviluppare un discorsodi ampio respiro. I termini di questa interrogazione sui fondamenti della poe-sia come creazione (contraltare ad una realtà di rovine e colossali macerie chesembra procedere per forza di distruzione) sono gettati già negli abbozzi teori-ci dei tardi anni venti riproposti da Frattini col consenso dello scrittore (la cuicostanza nel perseguire una idea di poiein non passibile di oscillazioni eccessi-ve è ben nota). L’eccezionalità del legame tra le persone del crocifisso e delpoeta è postulata come condizione ineludibile di accesso alla dimensione spi-rituale della parola:
Fu un poeta, che pronunciò le parole: dio crocifisso. In queste due parole eglimetteva in contatto il positivo e il negativo, congiungeva i due poli del mondo,il sì e il no, la vita e la morte […]. Noi non avvertiamo più tutta la repugnan-te contraddizione, l’aspra acerba avversità di quei due termini, stretti insiemeper forza; con la violenza inaudita di cui è capace solo la fantasia. Per costrin-gere in un solo simbolo due opposti così irreducibili, occorre in realtà unaforza, un’energia da misurarsi a numeri di stelle: una potenza di cui non abbia-mo esempi14.
Così l’antitesi estrema a livello concettuale evolve in direzione di un‘ossimoro della rappresentazione’ ingenerando un urto capace di sprigionare
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
209
13 I giocatori, in LR, pp. 59-60. Per una discussione sul tema cristico in Vigolo si legga Jean Robaey,Tra Cristo e Caronte: la «poetica assoluta» di Vigolo, in «Archivi del Nuovo», 2006, 18-19, pp. 53-78.
14 G. Vigolo, Della poesia come fondamento cit., p. 110.
energia poetica, con il significativo corollario di investire il poeta del ruolodi sacerdote dello spirito, segno inequivoco del contributo vigoliano alla risa-lita delle quotazioni del «mestiere di poeta» (fenomeno interessante dalpunto di osservazione delle implicazioni sociologico-letterarie per la pun-tualità e il sincronismo con altre esperienze coeve, da Ungaretti al Campanada poco «riesumato» nel 1928). Cediamo nuovamente la parola all’autoreper le conclusioni: «il miracolo compiuto dalla poesia fu appunto quell’im-magine unitaria in cui il dio e la morte furono contemporaneamente proiet-tate in uno stesso ente. Cozzo violento, irragionevole, assurdo: una di quel-le immagini che per la loro intensissima originalità sconvolgono la mente,rasentando la follia»15. Ma è sul versante della traduzione artistica di tali pro-positi che Vigolo consegue i risultati di maggior spicco liberandosi dell’ipo-teca di letture eclettiche nel cui folto groviglio lo scrittore farà ordine attra-verso un’attenta opera di selezione e di decantazione (delle prime influenzesopravviveranno e acquisteranno di peso i romantici tedeschi, l’incrocioBelli-Hölderlin, l’ancoraggio alla linea Petrarca-Tasso-Leopardi). Un passodell’appendice poetica di Canto fermo (1931), poi rescisso dalla versioneaccolta ne La luce ricorda, il consuntivo della propria non certo copiosa pro-duzione in versi allestito da Vigolo nel 1968, testimonia della pregnanzadella figura del Crocifisso nell’immaginario dell’autore. La chiusa di Erebo,con un distico finale dal terribile rintocco, investe della «ferita» del dio mar-tirizzato il complesso dei mondi, un universo che vive e pulsa del propriogiacimento di dolore e disperazione (come un corpo umano piagato):
…di dietro i monti levarsi vediamo su fino allo zenitil crocifisso immenso delle costellazioni.
Il Cristo trafitto è sospeso alla croce dei venti: pende nell’etra il suo corpo piagato di mondi.
La creazione rappresenta il principiare della sofferenza e assai più che unpresagio di morte e consunzione in un contesto di eternità e beatitudine: ilsenso del divenire spezza le barriere dell’universo-giardino dell’eden e ciproietta verso le «porte aperte della morte». Oltre ai rimandi orfici e pitago-rici, si può ipotizzare la presenza di qualche ricordo dello spiritualismo«cosmicizzato» di certe poesie del Tommaseo («di tue pupille il raggio, / l’au-ra de’ tuoi respiri, / l’umor delle tue lagrime, / il sangue de’ martiri, /com’onda in ampi giri, / in ogni cosa viva / si spandea per la terra, e al ciel
ANDREA GIALLORETO
210
15 Ivi, p. 115.
saliva», La creazione e la redenzione diffusa). Ma la mancanza di edonismo,congiuntamente ad una tornitura letteraria più incline alla meraviglia diattriti e juncturae enarmoniche e barocche che all’euritmia di Tommaseo oall’enfasi degli afflati metamorfici onofriani, ci fanno azzardare una propostadi raffronto con un autore ben noto a Vigolo. Jean Paul Richter, il più fecon-do traduttore in lingua letteraria dei messaggi onirici che la notte ci tra-smette, ha lasciato testimonianza nelle due versioni del Discorso del Cristomorto di una potente immaginazione apocalittica centrata sull’offuscamentodelle fonti vitali, delle forme naturali e delle speranze umane. Il cosmo cheemerge dai testi cui si è fatto riferimento è una plaga di solitudine e abban-dono rispecchiante il terrore dell’uomo di fronte al nulla infinito che minac-cia la fragile consistenza della materia e che nemmeno il sacrificio del Diofattosi carne e sangue riesce a volgere in direzione di interpretazioni più pla-cate e «antropocentriche» dell’enigmatica desolazione del cosmo; questo simostra in aspetto di congerie entropica di rovine attirate dal vortice delvuoto, trappola impensabile per la vocazione conoscitiva della ragioneumana. Il Discorso del Cristo morto dall’alto edificio del mondo, annuncianteche non vi è nessun Dio, pezzo onirico inserito all’interno del romanzoSiebenkäs (1795-96), attribuisce al Figlio un parricidio filosofico in odore didottrina ateistica: «E quando alzai lo sguardo all’immenso mondo in cercadell’occhio divino, esso mi fissò con un’orbita vuota, senza fondo; e l’eternitàsi stendeva sopra il caos e lo erodeva e ruminava se stessa». Da una lagrimadi quell’occhio, se non cieco almeno impossibilitato a riconoscersi nellosguardo della creatura, Vigolo farà iniziare la vicenda di sofferenza e di tra-vaglio dell’uomo.
Questo antecedente jeanpauliano di rabbrividente baluginìo romantico(mal contenuto da architetture retorico-stilistiche ancora di impianto eluminismo neoclassici) costituisce un efficace antidoto ai turgori wagnerian-nicciani della ciclica visione cosmogonica dell’ultimo Onofri, a cui Vigolocon Lagrima caddi contrappone una gemmea, malinconica antropogonia.Non si insisterà mai a sufficienza nel distinguere la prospettiva vigolianadalle volute liberty e dal credo steineriano di Onofri16. L’allontanamentodalle posizioni dell’antico mentore coincide con la condanna di una conce-
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
211
16 Come ha rilevato Marco Ariani nel suo studio sul poeta di Conclave dei sogni: «In Vigolo l’ar-monia non è, come in Onofri, una estetica parvenza sensuale del cosmo, ma, più dolorosamente, è dise-gno segreto, perduto al momento di un incomprensibile peccato primevo, occulto oltre le muraglie del-l’incubo, da inseguire e percepire solo per istanti privilegiati, duramente pagati con l’inevitabile ricadutanella propria durata d’uomo. Dunque, mentre in Onofri il misticismo diviene struttura eterna del pen-siero e della Natura che vi si riflette e identifica, in Vigolo la musa mistica è ansia, contraddizione, dico-tomia tra sguardo e cosalità, ascensione vertiginosa e ricaduta abissale» (Marco Ariani, Vigolo, Firenze, LaNuova Italia, 1976, p. 11).
zione dell’arte fumosa ed equivoca, segnata dall’involuzione della chiarezza ra-zionale in dogma incapace di distinguere le ombre dalla realtà. I poeti della sa-pienza magica avrebbero barattato l’autentica facoltà di ricreare il mondo at-traverso la parola con il gioco delle prospettive e delle immagini mirificheproiettate con luce ingannevole nella caverna che ci vuole prigionieri e illusi:
Maghi, teosofi, alchimisti, occultisti ecc. son tutti accumunati nella folle pre-tesa di voler praticare la poesia. Le loro presunte rivelazioni e teofanie non sonoper essi che barlumi discontinui e casuali del sovramondo poetico, a loro lam-peggiati per occasionali contingenze. Essi son coloro che hanno intraveduto lapoesia, la quale resta per loro un mondo occulto, cioè interdetto dalla loro stes-sa predestinazione pratica e lucrativa. Ma di codesti spiragli della poesia essiintravedono i supremi processi immaginali, le incandescenti potenze del verbo;e s’illudono di poter applicare codesti processi e modi, assolutamente intrinse-ci ed esclusivi della poesia, al mondo naturale; di poter inserire gli arbitri divi-namente gratuiti della ispirazione nelle strettoie deterministiche di un mondoschiavo delle cause e degli effetti17.
Si tratta dunque di un tradimento dei valori e delle finalità autentichedella composizione poetica volto a perpetuare l’equivoco di una trasmuta-zione del mondo, quando il terreno di intervento dell’arte non può che risie-dere nell’animo dell’uomo. Inoltre il ventaglio dei riferimenti che la dottri-na esoterica occidentale poteva offrire a Vigolo era ben più vasto delle ambi-gue formule steineriane: rievocando un colloquio avuto con l’autore, AlbertoFrattini ha riportato nella sua monografia un convincente quadro di «ascen-denze» sul crinale del binomio poesia-magia: «per approfondire la comples-sa genesi di certo esoterismo di Vigolo su altre fonti occorrerebbe scavare(secondo indicazioni accennatemi da lui stesso): da Pico della Mirandola alPolifilo (strano romanzo allegorico – didattico – iniziatico del XV secolo, daltitolo Hypnerotomachia Poliphili), da Paracelso (medico naturalista, filosofo,scienziato interessato anche alla magia; nato in Svizzera visse tra la fine del
ANDREA GIALLORETO
212
17 Ivi, pp. 138-139. Lucio Felici, tra i pochi incondizionati estimatori dello scrittore romano, haindividuato con acume le divergenze tra l’operare del nostro e il «sistema» onofriano: «Vigolo ha rifiuta-to le soluzioni esoteriche onofriane, vivendo il sogno – a differenza del suo antico sodale – come zona diesplorazione delle matrici più segrete, ma anche più certe, dell’esistenza, e non come veicolo di fuga e dialienazione. Egli non si lascia travolgere dal raptus onirico che inebria e stordisce debilitando le facoltàconoscitive, bensì sforza la memoria e la fantasia fino a cogliere l’atto di nascita delle proprie visioni, fidu-cioso di conquistare, al termine della ricerca (o, meglio, del facilis descensus Averno), una più esattacoscienza di sé. Per tale via l’allucinazione si tramuta in eccezionale chiaroveggenza e approda a una sortadi nuovo umanismo, nello stesso modo che – sul piano formale – la ribollente materia «satanica» tendea ricomporsi entro le linee ferme e armoniose di una salda architettura neoclassica» (Lucio Felici, GiorgioVigolo, in «Studi romani», XXX, gennaio-marzo 1982, 1, p. 68).
Quattrocento e la prima metà del Cinquecento) a Jacob Böhme (misticotedesco del Seicento) a Goethe»18.
Come andrà intesa allora l’equiparazione tra poesia e creazione? E qualisintonie, precorrimenti, allusioni, schermaglie d’intertestualità potrà farvalere il poeta nell’atto di dare forma a opere conseguenti a una poetica«assoluta»? Si è discusso sull’estraneità o meno di Vigolo alla poesia pura, pernon parlare della koiné ermetica da cui lo distinguono procedimenti e tecni-che19 (la grammatica lirica insomma, prima e più che la «sintassi» di undiscorso sui fini della parola e i suoi orizzonti di irraggiamento: nel presenteda eludere in nome di un tempo maggiore a venire o nell’eterna ricorrenzadi un «divenire immobile», proprio del mito).
La «provocante finitezza del suo stile» (Falqui20) mal si concilierebbecon le arditezze analogiche e la propensione all’astratto della lirica ermeticacontrasterebbe con la vocazione plastica, architettonica (e quindi razionale)di tante composizioni vigoliane. Ma l’immaginario barocco con i suoi spes-sori di pietra e le sue scabre accensioni cromatiche è per Vigolo il correlati-vo di una condizione di stasi vitale, di blocco all’interno delle prigioni delcorpo e del tempo: cosicché ogni volta che lo spirito si libera dalle catene deltranseunte e della vita effimera si dissolvono in aeree tessiture di suono letortili architetture barocche: si badi, identificate con effetti d’incubo o d’il-lusione (le magie borrominiane di Sant’Ivo alla Sapienza) e non viste comeoggettiva rispondenza alla realtà naturale che ha invece i connotati del pae-saggismo romantico (le vedute di Roma e dell’agro romano filtrate dalla sen-sibilità nordica dei pittori scesi in Italia per il grand tour). Con gli anni, lagrana lirica si stempera e assottiglia dalla congestione di masse in torsione diConclave dei sogni al dettato «romantico» di Canto del destino, per poi ritro-vare una più disseccata cifra barocca e materica nelle poesie della vecchiaia.Il barocco cessa di essere «semplice appesantimento di forme eterne, con-template con buddistica ebrietà»21 per divenire la forma storica assunta dal
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
213
18 Alberto Frattini, Introduzione a Giorgio Vigolo cit., p. 27. 19 Cfr. M. Ariani, Vigolo cit., p. 59: «Strutturalmente, una simile tecnica di radicali contrapposizioni
semantiche, provoca una tipologia compositiva a strati sovrapposti in vere e proprie partiture sequenziali,dinamizzate dalla giustapposizione e non mediante piani simbolici sovrimpressi o interpolati (come, nel-l’ermetismo, funziona la tecnica analogica): Vigolo riesce così ad ottenere un massimo di clarté espositiva (inquanto i legami semantici non sono allentati o sovvertiti, ma messi a confronto mediante fitti processiaccumulativi) in coincidenza con un massimo di rifrazione suggestivo-sensitiva degli enunciati (grazieall’impiego di estese fasce connotative di tipo ipercromatico-tattile). Con questi mezzi, nei momenti miglio-ri, Vigolo riesce a sfondare la quadratura visuale estraendone insolite profondità scenografiche dove il sognosi fa volumetria dalle amplissime escursioni diametrali, gli oggetti acquisiscono sfasature da incubo graziealla distanza o vicinanza al punto di fuga, e alle ardue ellissi logiche e semantiche che ne conseguono».
20 Enrico Falqui, Il silenzio creato, in Novecento letterario, serie prima, Firenze, Vallecchi, p. 476.21 «Il mondo che allora, freschi e ammirati del gigantismo hebbeliano, non ci pareva barocco, oggi
ci si rivela tale; e perciò, spesso un po’ succube di D’Annunzio; con questa vantaggiosa differenza però:
romanticismo a Roma, e romanticismo per Vigolo significa rifiuto delle ten-denze disgregatrici proposte dalle avanguardie storiche nell’arco dei primidue decenni del Novecento; difatti, come ha osservato uno dei suoi piùrecenti interpreti, «la riproposta del romanticismo di Vigolo, piuttosto cheuna sopravvivenza di impressioni e di convenzioni letterarie, finisce per con-figurarsi come un comandamento poetico e morale insieme, come esplicitavolontà di non mescolarsi all’incompiutezza novecentesca»22.
Alcuni, in particolare Aldo Camerino, hanno evidenziato un’area comu-ne di interscambi ravvisabile nel gruppo della rivista «Circoli», i cui collabo-ratori risentirono del magistero ungarettiano; ma anche con questa suggesti-va ipotesi critica non ci si discosta dal piano incidentale dei prestiti, dei cal-chi metrici, di singole immagini e maniere. Se egli sembra tralasciare i modipiù evidenti del retaggio simbolista (ma non senza l’attraversamento diMallarmé e una meditata lettura di Rimbaud), i richiami a quel contesto dis-seminano l’opera poetica (si pensi a un componimento come Andromaca) ecostituiscono un ponte di collegamento con le esperienze di Quasimodo,Gatto e degli ermetici fiorentini assecondando – per dirla con Donato Valli– «il perpetuarsi di quella spinta orfica che, continuando nei poeti dellaseconda generazione, costituisce l’anello di congiunzione con la terza gene-razione novecentesca, che è considerata ermetica nel senso proprio e stori-co»23. Particolare e intrinseca alle ragioni espressive di Vigolo resta la mistio-ne sincretistica attraverso i simboli universali degli apporti del cristianesimo edella cultura classica; una coesistenza, questa, che propende spesso per il re-cupero del secondo elemento, connaturato alla tradizione capitolina e italiana,e risulta quindi nettamente distinto dalle forme dell’adesione religiosa degliermetici. Siamo invece di fronte a «un boreale spiritualismo cristiano-paga-
ANDREA GIALLORETO
214
che in D’Annunzio il barocco si muoveva, e di quel suo moto esaltandosi e turbandosi assumeva, e ridu-ceva a immagine nel vortice del mobile scenario, anche la reazione dei sentimenti i quali per entro gliesterni aspetti, avrebbero dovuto circolare e distinguervisi, mentre che in Vigolo il barocco diventa sem-plice appesantimento di forme eterne, contemplate con buddistica ebrietà» (Raffaello Franchi, Cantofermo in «Solaria», VII, gennaio 1932, p. 60).
22 Cristiano Spila, Difesa dei romantici di Giorgio Vigolo: apologia o patologia?, in Scrittori in catte-dra, a cura di F. Calitti, Roma, Bulzoni, 2002, p. 214.
23 Donato Valli, Ermetismo e dintorni: la poesia dal 1920 al 1940 in Storia generale della letteratura ita-liana, a cura di Nino Borsellino e Walter Pedullà, Milano, Federico Motta, 2004, XIII, p. 324. Di parere dia-metralmente opposto Marco Ariani che nega affinità tra percorsi creativi assai distanti: « la vera e propria fisicaoniromantica che trascorre per Conclave dei sogni segna uno scarto nettissimo dalla ricerca della parola puraperseguita almeno dal versante più mallarmeano di quegli anni, da Ungaretti, da Quasimodo, dal primo Luzi.La parola, in Vigolo, viene radicalmente implicata in un descensus Averno costretto a scontare tutte le impuritàdella durata quotidiana, senza potersi ribaltare nel verbo distillato o rivelato, nella ungarettiana «limpida mera-viglia» sottratta alla vita e salvata dalla vita: la preistoria stessa della poesia vigoliana non coincide con quelladell’ermetismo, se non per interferenze obbligate che riguardano tutta l’esperienza poetica novecentesca» (M.Ariani, Introduzione a G. Vigolo, Poesie scelte, Milano, Mondadori, «Oscar», 1976, p. 11).
neggiante di chiara origine teutonica»24, secondo la formula un po’ ad effet-to ma sostanzialmente veritiera coniata per il collega da Giorgio Caproni, ealla luce di questa coniugazione italo-tedesca sarà da leggere l’accostamentodi Vigolo a Hölderlin con un infittirsi di traduzioni durante gli anni trenta25
culminato nel volume einaudiano del 1958. Quest’ultimo rappresenta il pre-ludio, e non solo per la contiguità cronologica, della raccolta Canto delDestino, pubblicata da Neri Pozza nel 1959, il cui titolo stesso deriva dareminiscenze hölderliniane (l’Hyperions Schieksalslied, testo incluso tra le tra-duzioni approntate da Vigolo). A questa raccolta, poi confluita per la quasitotalità nel ricapitolativo La luce ricorda, appartiene Lagrima caddi, uno deimomenti di tangenza massima, oltre che con il moderno classicismo roman-tico del dichter di Tubinga, con una costellazione di autori novecenteschi cheinscenano i tormenti della creazione sotto metafora poetica (o viceversa):dall’amico Girolamo Comi, con il persistente ricorso alla «favola» di Adamoed Eva, al mito edenico di Quasimodo, all’Ungaretti teso all’ascolto del«primo grido» del giovane giorno, al trascolorare tra il sensibile e l’invisibiledel Betocchi di Realtà vince il sogno. Scommessa ardita quella di ammini-strare attraverso la parola i rituali della creazione, ma questo azzardo costi-tuisce una prerogativa del poeta, la cui religiosità trascende la precettistica eil concreto appiglio a un ordine chiuso di valori per espandersi in un aneli-to di santità nell’abbraccio dell’universo intero; come ha scritto HermannBroch nel suo Poesia e conoscenza, «nell’organizzazione generale della vitanessuno è simile al santo come il vero artista. Anche questi vive in un visio-nario isolamento e supera l’isolamento nella dedizione al tutto (almeno altutto dell’aldiqua), sicché anche per lui servitù e libertà coincidono. L’artistaè partecipe di una grazia dura, una grazia però che non distrugge il suo nar-cisismo ma semplicemente lo assoggetta ad una disciplina»26. L’ebrezza diquesta sfida ai limiti della condizione umana della creatura che si fa (ri)crea-trice si sconta con i momenti di crisi che annichiliscono il fragile io tenen-dolo in bilico «sul ciglio di vertigine» da cui origina la caduta nel tutto indif-ferenziato:
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
215
24 Giorgio Caproni, Canto del destino, in Scatola nera, Milano, Garzanti, 1996, p. 122. 25 «Cominciai a tradurre l ‘Hyperion (2 libri) nel 1931 e tratti dell’Empedokles, proseguii con le Odi,
le Elegie, gli Inni. Alcune di queste traduzioni vennero pubblicate da vari periodici. Nella rivista «Circoli»dell’ottobre 1935: Brot und Wein; nel «Meridiano di Roma», aprile ’37: Wie wenn am Feiertage, Am Quellder Donau, Der Einzige; nello stesso, in agosto ’37: Mein Eigentum; in «Prospettive», 15 dicembre ’39:Patmos, con una nota su Hölderlin e la Poetica Assoluta; in «Poesia», Mondadori, gennaio ’46: Der Ister eVersöhnender, der du nimmer geglaubt» (G. Vigolo, Saggio introduttivo in F. Hölderlin, Poesie, Torino,Einaudi, 1958, p. LXVII).
26 Hermann Broch, Poesia e conoscenza, Milano, Lerici, 1965, p. 155.
Chi mi tenne che allo struggente invitonon mi lasciassi cadere? E nel vortice d’aria perduti i sensi come sull’ultimo cuscino di pietà, uscissi dal crudele ago dell’individuo?27
II
Nessuno forse prima di Vigolo aveva riunito un sensoacutissimo del transitorio a una tecnica riproduttricedell’immobile ed eterno.
Gianfranco Contini
Dopo aver cercato di restituire le coordinate della poetica vigoliana ègiunto il momento di affrontare direttamente la poesia che si è scelto dicommentare, consapevoli della necessità di aprire fronti sempre diversi nel-l’incontro-scontro con il testo, secondo quanto evidenziato da MassimoFusillo quando ha sottolineato una «sorta di paradosso intrinseco all’opera-zione commento, che ne costituisce in fondo il fascino maggiore: seguirepasso dopo passo il respiro del testo, il suo ritmo interno, e contemporanea-mente scomporlo e smontarlo dalle prospettive più svariate»28. Riproducoper comodità il testo nell’edizione definitiva accolta nel volume mondado-riano La luce ricorda (1967):
LAGRIMA CADDI
Temo del giorno e della notte fuggo gli oscuri vuoti ove cadendo indietro nell’età riaperte io mi rinvolgoalla prima spirale della nascita e salgo 5sopra fulminee scaleil ciglio di vertigine d’onde qui scesi.
ANDREA GIALLORETO
216
27 La vertigine, in LR, p. 196, vv. 12-18. 28 Massimo Fusillo, Commentare, in Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di Mario Lavagetto,
Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 44.
Lagrimacaddi da un occhio immemoriale, in pianto 10rigai l’immenso viso. Sono un uomo. Amara stilla: ma trafitta splendi dei raggi ancora di quel viso e il diorecline come in frantumato specchioin te si guarda e accende un mondo, un altro 15sé d’esistenza effimera: la gocciola estasiata in iride si frange.
Lagrima caddi è il venticinquesimo componimento della sezioneEnchiridion di Canto del destino così come appare in LR, mentre nell’edizio-ne Neri Pozza costituiva il secondo tassello della sezione Canto del destino(quinta delle sette originarie ridotte a due nel volume successivo) occupan-do il ventisettesimo posto nell’architettura complessiva di CD. Il testo restasostanzialmente invariato nel passaggio tra le raccolte separate da meno di undecennio: Vigolo apporta piccole modifiche come la scomparsa delle dieresidi rïaperte ed estasïata in LR, il v. 5 offre salgo [ colgo (CD) scelta che, oltread eliminare la rima rinvolgo:colgo, sostituisce lo sforzo continuato (proba-bilmente di un’intera vita) al balzo ratto che proietta d’improvviso sullasoglia che funge da diaframma tra il tempo e l’eterno (su questo «ciglio divertigine» bisognerà ritornare più avanti), infine il sé del v. 16 è il prodottodella scomparsa della maiuscola che appariva in CD. Costante rimane lastruttura metrica classicamente organizzata sull’alternarsi di endecasillabi esettenari in linea con una soluzione aperta nella stessa raccolta ai canali piùdiversi di ordinamento, selezionati di volta in volta in ragione dei contenutisemantici29. Ben diverso si presenta il panorama variantistico se prendiamoin considerazione le stesure precedenti la stampa in volume (appunti mano-scritti, bozze corrette, dattiloscritti) consultabili tra le carte del FondoVigolo, conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
217
29 «[…] l’alternarsi nel Canto del destino, di forme metriche regolari, dalla chiusura estrema delsonetto alle sequenze di versi regolari, con forme più aperte, con dissonanze anche dure di accento e diritmo. Da un lato, cioè, un discorso poetico che, per la precisa coscienza della sua situazione al di là delleattuali determinazioni temporali, in un clima spirituale, quale è quello orfico, liberato dalla temporalitàesteriore per assumere interamente il tempo della vicenda d’anima, non misurabile con gli strumenti sto-rici oggettivi, tende a racchiudersi entro le forme metriche più astratte, separate dal presente, giustifican-do così a ogni livello una concezione poetica di restaurazione idealistico-romantica diversificata dallacomune condizione contemporanea; dall’altro lato, invece, l’accoglimento delle forme corrose, dellestrutture di crisi, tipiche della poesia novecentesca, in un inserirsi, entro il discorso poetico, di una for-mulazione di tragicità e di interiorità meno sicura di sé e della sua autorizzazione autonoma, come ine-vitabile necessità di rispecchiare la storia interiore sullo sfondo storico oggettivo» (Giorgio BàrberiSquarotti, Poesia del secondo Novecento, Milano, Mursia, 1978, p. 95).
Emanuele II di Roma30. Si giustificano quindi le confessioni dell’autore allostudioso che più si è addentrato nel labirinto della variantistica vigoliana,Pietro Gibellini: «il maniaco tormentarmi nella mia officina ha avuto sem-pre lo stesso furore ossessivo (che è poi un originario contrasto fra Vigoloprosatore e Vigolo versificatore, poeta in entrambi)»31. Rubricate sotto lasegnatura A.R.C. 16 Sez. D. II/5, diverse carte dattiloscritte propongonomateriali preparatori del libro edito da Neri Pozza; gran parte dei fogli pre-senta correzioni minime poi riscontrabili nelle edizioni a stampa; ad es. carta110: oltre i punti già elencati presenta 16 versi accorpando i vv. 4 e 5 allaprima spirale della nascita e colgo, introduce al penultimo verso il termineparvenza (parvenza effimera poi corretto in esistenza effimera più radicalenella constatazione del destino dell’uomo), presenta una semplice virgola alv. 11 (rigai l’immenso viso, sono un uomo > rigai l’immenso viso. Sono un uomo)rafforzata nei testi editi con l’introduzione di un punto che stacca netta-mente il sintagma tingendolo di consapevolezza e stoicismo, infine Dio al v.13 è ancora scritto con la maiuscola. Identica a questa qui descritta la ver-sione di c. 39, tranne per lo stacco dei vv. 4 e 5. L’esemplare di c. 211 siapprossima molto al testo di LC correggendo Dio in dio, e riportando esi-stenza effimera, sono un uomo preceduto dal punto, e colloca a margine l’in-dicazione tipografica diretta a ripristinare la dislocazione a scalino del v. 8evidentemente saltata per errore materiale. Ho lasciato in coda la versione dimaggior interesse che più si discosta dal testo edito: si tratta del dattilo-scritto di c. 375 che presenta una sequenza intermedia completamente cas-sata che modifica in parte la fisionomia di una poesia così perfettamentecalibrata da schivare il rischio dell’espressione gnomica o della lamentazio-ne sulle sorti dell’uomo. Vediamo prima le varianti delle parti note. Al v. 3rinvolgo è la correzione di un precedente io ripercorro barrato da un trattodi cancellatura orizzontale: è superfluo notare come risulti di maggiore effi-cacia la soluzione accolta in volume che contribuisce al drammatico avvi-tarsi su se stessa della vita inghiottita dalla vertigine spiraliforme delle etàtrascorse. Il v. 9 reca le tracce di un originario qui caddi da occhio seguito dauna parentesi tonda che racchiude anche il verso successivo, che si presen-ta nella forma rigai l’immenso viso: ora son uomo corretto in corso d’opera insono un uomo introdotto stavolta da un punto e virgola. Al v. 12 abbiamodai raggi ancora di quel viso per il definitivo dei raggi; Dio è con la maiuscolae troviamo parvenza invece di esistenza effimera. Infine l’ultimo verso pre-
ANDREA GIALLORETO
218
30 Devo alla cortesia della Dott. Magda Vigilante l’occasione di esaminare le carte relative a Cantodel Destino, a lei e al personale della sala Manoscritti il mio vivo ringraziamento.
31 Lettera a Pietro Gibellini datata 8 maggio 1976, in A. Frattini, Introduzione a Giorgio Vigolo cit.,p. 184.
senta un’alternativa abbandonata scritta a penna blu: nell’estasi di un iride sifrange che nella soluzione accolta, grazie al rallentamento impresso dall’ini-ziale estasïata, ben rende anche attraverso il gioco delle assonanze lo stato diabbandono mistico che porterà l’io-stilla di pianto al dissolvimento neltutto.
Trascrivo integralmente la parte lasciata cadere, che era inserita subitodopo il v. 10 (rigai l’immenso viso. Sono un uomo) e prima dell’attuale v. 11il cui incipit recita Amara stilla…
Particella di Lui, del suo doloreEffuso, in queste membra mi ritrovoPer un attimo appena del suo fermo eternoinfinito, per e sol eterno: solovivere: e solo l’attimo che impiegauna stilla a cadere è il breve solcod’anni in cui fugge il mio durare umano.
Questa parte è cassata con una barra obliqua: ciò si spiega perché l’in-serzione di tali versi nulla aggiunge alla concentratissima forza metaforica deltesto, esplicitando eccessivamente alcuni snodi come la chiarificazione del-l’assimilazione tra la stilla di pianto grondante dal viso e la particella deldolore divino rappresentata dall’uomo. Ancora si appesantisce il tutto con ilrilievo platonico del corpo come carcere le cui catene saranno presto spezza-te («in queste membra mi ritrovo / per un attimo appena del suo eterno /vivere), motivo svolto con ben altro esito in diversi componimenti dell’au-tore32. Allo stesso modo i versi finali, non privi di lapidaria sentenziosità(assai felice è quel «breve solco / d’anni in cui fugge il mio durare umano»,filtrato magari dal Petrarca cui pure rinvia il verso iniziale della poesia Temodel giorno e della notte fuggo), sciolgono didascalicamente la similitudine tralo scorrere dispersivo della goccia e il fuggire dell’esistenza.
«La religione contiene un’infinita malinconia. Se dobbiamo amare Dioegli dev’essere bisognoso d’aiuto. Fino a qual punto il cristianesimo ha assol-to questo compito?33»; questo frammento di Novalis sulla religione può aiu-tarci nell’approcciare uno dei temi presenti in Lagrima caddi: la necessitàreciproca e il rispecchiarsi di due debolezze che costituiscono l’asse del lega-
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
219
32 «Improvviso ebbi orrore / del corpo: officina dei mali, / groppo di dolori in agguato. / Per met-terti ai tormenti, / anima, fu studiato questo corpo, / complicato di perfidi congegni; // macchina di tor-tura / per farti confessare / una colpa che non hai, / per poterti dannare / innocente» (Officina dei mali,in LR, pp. 90-91).
33 Novalis, Frammenti, Milano, Rizzoli, «Bur», 1987, p. 258.
me tra l’uomo e il dio. Il prolungato esercizio di traduzione di liriche höl-derliniane ha arricchito non soltanto la strumentazione tecnica a disposizio-ne del poeta romano, ma ha illuminato zone rimaste in ombra della sua poe-tica confermando in aggiunta alcuni postulati teorici risalenti agli anni dellaformazione. Il confronto con il poeta svevo ha altresì rafforzato la ricerca daparte di Vigolo di una religione della poesia i cui percorsi (i cui «sentieriinterrotti») incrociano quelli della religione codificata soltanto quando que-sta si presenta sotto l’aspetto di simbolo universale (simbolo succedaneo delracconto mitico degli antichi) portatore dei segni di rinascita e quindi collo-cato in una dimensione non compiuta. Del resto – come ha scritto Giam-piero Moretti – «tradurre Hölderlin vuol dire essere puntuali all’appunta-mento con la parola intesa come spazio per un’attesa, l’attesa del divino edella sua manifestazione»34. Il confronto con il poeta tedesco (cui si devonoimportanti scritti sulla tragedia e sul tragico che non sono passati inosserva-ti da Vigolo, depositario della tradizione poetica dello stile tragico, come hapiù volte affermato), il rapporto stabilito con quel modello scisso tra classi-cità e inquietudini moderne avviene sulla base di un comune desiderio difondere nella misura del classico nitore il dramma del divenire e l’attesa del«dio venturo», di cui Cristo rappresenta l’elemento cardine nel suo speri-mentare entrambe le condizioni, quella dell’uomo e quella del dio.
Si legge nel denso Saggio introduttivo alla traduzione delle Poesie: «l’un-tergehen (il trapassare, il dileguare) è la negazione tragico-dialettica dell’indi-viduale e del momento positivo che continuamente travalica nell’altro edefluisce nel Tutto. Da ciò l’importanza che nella poesia hölderliniana hannoi fiumi, in cui lo scorrere e il perire si determinano come la struttura delfenomeno nella sua costanza, che è costanza di un continuo dileguare, muta-re, vagare dei molti per tornare all’Uno»35. L’elemento liquido, l’acqua deigrandi fiumi (facile per Vigolo fare del Tevere l’attivatore mnestico più effi-cace della sua scrittura «biografica») o quella decantata e quintessenziata ingoccia di pianto, «amara stilla», emblematizzano il destino eracliteo del flui-re delle cose. Ebbene il Dio di Lagrima caddi, privo della figura di media-zione del Cristo, che accetta di farsi perituro, di scorrere, è l’essere che igno-ra e si oppone al dileguare pur essendone l’origine. Condannato all’eternaimmobilità si china stupito sulla sua emanazione mortale, l’uomo, che ha ladurata di breve attimo prima di consumare la propria individualità e reim-mettersi nel gran circolo dell’essere. È questo tentativo di comprensione del-
ANDREA GIALLORETO
220
34 Giampiero Moretti, L’incontro nella parola. Vigolo traduttore di Hölderlin, in Conclave dei sogni.Giornata di studi per il centenario della nascita di Giorgio Vigolo, 18 novembre 1994, a cura di LeonardoLattarulo, Carmela Santucci, Giuliana Zagra, Roma, BVE, 1995, p. 61.
35 F. Hölderlin, Poesie cit., p. XV.
l’altro da sé a governare la specularità, il doppio movimento che sostiene iltesto in esame. Lo aveva sottolineato lo stesso Vigolo a proposito del poetadi Brot und Wein: «il grande conflitto tragico di universale e singolo, ripor-tato nella elementarità ontica, starebbe quindi fra le due egoità dell’Organicoe dell’Aorgico che s’incrociano cercando di aspirarsi a vicenda, di scambiar-si l’uno con l’altro. Gli dèi hanno bisogno di uomini per sentire («candauli-smo degli dèi») gli uomini degli dèi, per durare – poiché la personalità inti-ma dell’uomo manca della forza, della consistenza, della universalitàdell’Aorgico»36. L’uomo è chiamato a fissare in volto il creatore quasi a ren-derlo certo, anzi a rassicurarsi entrambi, di un’esistenza effimera (per l’irri-soria durata o per l’incapacità a sperimentare il divenire e il mutamento): ilnuovo Adamo riconosce la propria natura di seme gettato sulla terra, e l’i-nermità stessa lo fa incolume: «Iddio mi prese e mi lasciò sui monti / tra ifili dell’erba supino, / che in me specchiassi i suoi cieli profondi / giorno enotte senza muovermi mai, / e se scendeva pioggia di tempesta / qual sememi facessi macerare / e non portassi invidia alla lodola / che tanto più su dime / poteva gioire leggera. Anni grandi e puri / ho passato su quella zolla; /infuso nell’alto silenzio / gli umani pensieri mutai» (l’incolume).
Se l’aspirazione dell’uomo è di attingere «il diapason fremente dell’uni-sono» (Dopo paurosi giorni), il dio vive una dimensione monca, ha bisognodell’uomo per conoscere quel mondo che ha creato ma di cui non fa parte,relegato com’è nell’assenza di tempo e di spazio. Così la creazione divieneprolungamento del creatore, protesi sensibile del grande infermo dell’uni-verso, il dio morente:
D’UN DIO CHE MUORE
O velenosa luceche tingi il giorno d’apparenze amichee celi il fitto orrore
d’una piaga tremenda al petto occultadel dio morente di cui siamo il maleoscuro;
e nostra gioia, nostro senso felice d’esistere, gli amori,
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
221
36 Ivi, p. XIX. Claudio Varese ha colto il risvolto oscuro di questo legame: «Nel suo saggio suHölderlin, Vigolo ha sottolineato lo slancio degli dei verso gli uomini, quasi un processo inverso a quel-lo che spinge la terra verso il sole: è un motivo potente, perché corrisponde all’idea dell’Olimpo rove-sciato, della bellezza degli Inferi e corrisponde insieme a quel senso del rapporto dialettico fra due poliestremi, sul quale si muovono Le notti romane» (Claudio Varese, Giorgio Vigolo, in Occasioni e valori dellaletteratura contemporanea, Bologna, Cappelli, 1967, p. 133).
i sogni, – è quando più duole in lui l’assiduapena e più febbre l’arde37.
È l’uomo a costituire la fonte del male incurabile che attanaglia il dioimpotente protetto dalla cortina della «velenosa luce», è l’uomo con la suabrama e la sua capacità di travalicare la realtà mediante la tavolozza onirica.Creatore e creatura possono solo rimandarsi all’infinito la propria immagi-ne, magari distorta «come in frantumato specchio» per la perdità dell’unitànel molteplice che è prerogativa dei mortali. Ma proprio nel momento deldistacco (quando la lagrima cade dall’immenso viso) si generano i presup-posti per la ricongiunzione, il ritorno alla matrice, che spesso in Vigolo sitraduce in un disperato desiderio di ritrovare il fantasma materno contrad-dicendo le leggi del tempo e facendolo scorrere a ritroso, in una «fuga / deisensi tornati alle origini»:
È il tempo che balza all’indietro,è il fiume che sale sul monte; riavvolto alla spira del fonte il figlio ritorna alla madre.
L’amore abbracciato alla morte conosce il folgore uguale del cielo che tocca la terra, che brucia la luce e sotterra l’azzurro nel minerale38.
Proprio una «fuga» a capofitto produce l’effetto di avvitamento a spira-le nella prima metà di Lagrima caddi segnata dall’angosciosa impasse che l’iolirico sperimenta nel suo rapporto con un tempo vuoto, desertificatosi intor-no alle spoglie del presente. Lo schema chiastico del v. 1 (temo del giorno edella notte fuggo) ben esemplifica l’inanità delle alternative a disposizione: aprevalere però è la spinta vertiginosa, forma estrema del descensus averno. Ilsusseguirsi di inarcature ad ampia gittata ingenera nel testo quel moto a spi-rale che rappresenta per Vigolo una ricorrente immagine sostitutiva del pre-cipitare del tempo39. Le tortili forme delle cupole barocche, l’arabesco dei
ANDREA GIALLORETO
222
37 D’un dio che muore in LR, p. 98.38 Il fiume che sale sul monte, in LR, pp. 252-253. 39 «Tema eternamente barocco, la spirale simboleggia l’ipotesi che un ritorno possa esserci, ma non
in forma uguale bensì in un modo straniato e (parzialmente) irriconoscibile. La spirale non solo indica laripetizione ciclica della storia, ma può rappresentare in qualche modo la volontà di umanizzare la natu-ra, ossia la natura giunta alla propria totale autocomprensione. Il pensiero-spirale mostra che solo nelritorno è possibile arrivare a esprimere perfette le cose e gli esseri illesi in un sogno immutabile» (Cristiano
vicoli e delle strade della Roma medioevale, il gorgo delle acque tumultuosedel Tevere in esondazione costituiscono solo alcune occorrenze di questomotivo nelle prose della Città dell’anima e delle Notti romane, ma è in poe-sia che l’attrazione verso il fondo, il sotterraneo sul piano spaziale, il passatosempre più remoto in relazione alla temporalità, assume il suo drammaticospessore:
Discendono i cieli nell’architettura sacrata del cosmo per lunga spirale, in fughe di scale che girano avvolte la chiocciola enorme;
e giungono al fondo del tempio vivente laggiù dove dormonoin tombe di sonno supini gli dei40.
Così, facendo appello ai propri ricordi infantili, il poeta fattosi «Carontedi se stesso» trasfigura il tracciato della familiare via Merulana in una pro-spettiva che inghiotte l’ora presente avviando la risalita del corso della vita:«O mia strada scavata in fondo all’anima, / sono io che ti percorro o il miofantasma / sul riversibile fiume risale / e a ritroso rinaviga la vita / dalla suafoce verso la sorgiva?41». Nella poesia che analizziamo il recupero del tempoperduto diviene caduta precipite «nell’età riaperte» che si spalancano come ilterreno sotto i piedi della carrozza in una celebre pagina vigoliana di medi-tazione sugli sconvolgimenti della storia e delle civiltà scomparse; l’io stessoè coinvolto nella torsione (mi rinvolgo: un gesto di imitazione fetale sipotrebbe azzardare) che lo fa retrocedere verso la meta agognata: la primaspirale della nascita, e nascita è parola battesimale per l’opera creativa diVigolo visto che sotto questo segno si inaugurava il suo Conclave dei sogni 42.La scenografia adottata per rendere concreta e visualizzabile questa discesaspirituale è quella consueta dell’immaginario piranesiano: le «fulminee scale»
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
223
Spila, Le meditazioni musicali di Giorgio Vigolo, in G. Vigolo, Diabolus in musica, Rovereto, Zandonai,2008, p. XIII).
40 La chiocciola, in LR, pp. 114-115.41 Via Merulana, in LR, pp. 410-411. 42 «Oh, senso primo / della nascita! abbaglio / inebbriato dell’anima, da oscuri / regni e silente eter-
nità, calata / alle feste del sangue» (Nascita, in LR, p. 16, vv. 12-16).
variano le egualmente oniriche «delirate scale d’incendio» di Andromaca,mentre più complesso è il ricorso alla formula «ciglio di vertigine» il cuisenso liminare, di diaframma tra dimensioni e stadi dell’esistenza individua-le e dell’umanità intera, ricorda altri luoghi dell’opera dello scrittore. Di tale«soglia estrema» reca il sigillo un testo diversamente modulato su accordiintimistici, rasserenanti e liricizzati, Ritorno di sera:
Di memoria in memoria alle perdutevite del cielo tornare mi sembra, e su laghi di larghi argentei fiori, quanto più si rimembral’anima di que’ suoi lontani albori. E sento ormai che del corporeo mondoogni apparenza trema e si dilegua; questa è la soglia estrema ove il pensiero degli umani è spento; qui d’un alto spavento io provo il gelo e, se tornare anelo, non so la via che riconduce in terra43.
Giunti su quel ciglio «il pensiero degli umani è spento», si è sottopostia una sorta di lavacro che deterge l’anima dalle scorie temporali e spegne lapercezione della propria unicità all’interno degli spazi sgomentevoli dell’u-niverso. Non si può tornare sui propri passi una volta innescato il processodi ritorno all’origine, e non si può più contare sullo schermo protettivo rap-presentato dalle ore felici, dai «cari inganni», dalle illuminazioni e dai mo-menti di visione; l’esenzione, lemma capitale nel vocabolario filosofico vigo-liano in quanto tregua dalle pene raggiunta attraverso lo smemoramentonella pura contemplazione della natura e dell’arte, non può più proteggeredal disvelarsi del destino di riassorbimento nella realtà prima: a fronte diquesta esperienza decisiva anche le gioie dell’esenzione stingono in un palli-do velo di sogno dal quale si rischia di risvegliarsi sul «ciglio di vertigine»:
Finché difeso io resti in questo guscio screziato di sogni e di favole, in questa siepe altissima di nuvole che come fenice d’intorno m’avvolge aurata e d’intimonelle sue piume balenío di gemme lungi alla sera splende,
ANDREA GIALLORETO
224
43 Il ritorno di sera, in LR, p. 24, vv. 28-38.
o miei dèmoni, voi dalle stupende ali, fatemi incolume nel puro cerchio sopra le tempeste, fate che dal mio sogno non mi desti sul ciglio di vertigine44.
L’incrinatura rappresentata dall’isolamento grafico del termine «lagri-ma» attiva la trasposizione dell’incubo di caduta in «favola» sovraindividua-le, novello mito antropogonico. Ed è da questo punto che la focalizzazionetrascorre dall’io lirico all’essere immortale di cui l’uomo è emanazione dolo-rosa, lacrima, «amara stilla» che scivola giù da un «occhio immemoriale»: suquesto aggettivo si concentra la caratterizzazione del dio che ignora il dive-nire, la transitorietà, il carico dei giorni di cui assomma la vita dell’uomo. Sequesti può tornare nel seno del creato grazie alla sua capacità di scrivere e dicancellare il proprio libro della memoria, al dio è negato l’incontro conquanto non è la sua stessa immobile, immensa autocontemplazione. Il mise-ro uomo, «particella di Lui, del suo dolore effuso», scopre la propria nobiltà(seppure riflessa, impregnata dei raggi della luce divina) nell’atto stesso delriconoscimento della propria fralezza, dell’inconsistenza del suo essere peri-turo. Sarà proprio attraverso l’uomo che questo dio bisognoso di aiuto potràconoscersi e riappropriarsi del mondo che ha creato. Il dio è colto in un gestodi avvicinamento alla creatura (recline) che giunge al riconoscimento dell’i-dentità tra lui e l’uomo, tra il viso e la gocciola che se ne diparte, tra il Tuttoe l’uno («come frantumato specchio / in te si guarda»). La disseminazionedella natura divina in una molteplicità infinita di microscopiche compo-nenti della sua stessa sostanza illumina finalmente lo splendore di un mondoche replica l’ente supremo («un altro / sé d’esistenza effimera») potenzian-done le possibilità di sentire, di percepire, di scoprire il dolore come la gioiache investe la gocciola (il diminutivo è spia di tenerezza prima che sottoli-neatura delle dimensioni ridotte della stilla di pianto). Il testo iniziato in unclima d’incubo notturno si chiude sul «capriolare» della gocciola sulla qualedi nuovo si sposta l’attenzione: «la gocciola / estasiata in iride si frange»: èancora il gioco dell’uno e del molteplice; la goccia vive la propria dissolu-zione come una intensificazione estatica, la fiammella trasparente che assor-be i raggi del volto divino si scopre iride di colori e di forme. Lagrima caddiè una poesia che dispone attorno a un asse verticale (la caduta «a piombo»
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
225
44 Esenzione, in LR, pp. 329-330. Interessanti le notazioni di Giuliana Rigobello: «Essere, Divino,Esente sono termini per indicare Dio, ma con sfaccettature differenti. Nell’Essere si individua il fonda-mento dell’esistente; il movimento che si instaura tra soggetto e oggetto è scambievole, mentre negli altridue epiteti è unidirezionale: dal basso all’alto, dalla terra al cielo, da ciò che sta dentro a ciò che sta fuori,oltre, da chi è implicato nel tragico dell’esistere a chi ne è immune» (G. Rigobello, commento a G.Vigolo, Poesie religiose e altre inedite cit., p. 57).
nell’esistenza, nella morte e nella rinascita) un largo ventaglio di temi45 cari all’e-laborazione letteraria del poeta romano. Pur con questo respiro estremamenteconcentrato, il componimento rifugge da ogni sospetto di intenzione gnomica odi rispondenza a precisi stilemi che pure gli dovevano essere impliciti conside-rando la frequenza di motivi affini in autori ben conosciuti da Vigolo.
Declinato in modalità gnomico-sapienziali è ad esempio un testo goethia-no che imposta il topos del raffronto uomo-labile goccia d’acqua: «L’anima del-l’uomo / somiglia l’acqua: / viene dal cielo, / risale al cielo / e ancora alla terra /deve tornare, / vicenda eterna» (Canto degli spiriti sulle acque46). Il nume tutela-re di questa poesia, come di tutta la raccolta di cui fa parte, è l’amatissimoHölderlin, specie quello del Canto del destino di Iperione che contrappone la con-dizione degli dei all’impermanenza che connota il divenire dell’uomo; riporto leultime due strofe delle tre che compongono la lirica del poeta svevo che anchenella disposizione tipografica richiama la spirale della caduta:
Senza destino, come lattanteChe dorma, respirano i superi;
Serbato casto In umile gemma
È in eterno fiorirePer loro lo spirito
E gli occhi beati Brillano in tacita
Eterna chiarità.
Ma a noi non è datoIn luogo nessuno posare,
Dileguano, cadono, Soffrendo gli uomini
Alla cieca, da una Ora nell’altra,
Come acqua da scoglio A scoglio gettata
Per anni nell’incerto giù47.
ANDREA GIALLORETO
226
45 «I miti stessi più radicali dell’imagery vigoliana sono sottoposti ad una palinodia che li rovesciae infrange: la notte, un tempo attesa come sollievo ed esenzione dalla vita ed evasione nel rifugio dei sognie del meraviglioso, è ora temuta come un abisso senza fondo in cui si precipita; la spirale e le scale, primasegni euclidei della salvazione, varchi da cui oltrepassare nell’iperuranio degli archetipi e dell’incolumitàmetatemporale, conducono ad una vertigine che è solo inizio ciclico della scesa, platonico mito di Ersenza ritorno; lo specchio, segno del doppio e della rifrangenza del miracolo nella grigia quotidianitàdell’Erlebnis, è frantumato-, la gocciola, l’acqua, altra volta mitico veicolo soteriologico, si frange in unairide istantanea e imprendibile come i colori della sera» (M. Ariani, Vigolo cit. p. 87).
46 Wolfgang Goethe, Poesie diverse, trad. di Mario Specchio, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, «IMeridiani», 1997, vol. I, tomo I, pp. 600-601.
47 Friedrich Hölderlin, Poesie cit, p. 35.
Infine, con brusco salto cronologico, vorrei accostare a questi caposaldidel sentire classico-romantico un campione della poesia che si veniva realiz-zando negli anni d’esordio di Vigolo; pure nel caso del Quasimodo di Òboesommerso (1930-1932), da cui prelevo Alla notte, il mito e l’apparato teolo-gico prendono le vesti di una raggrumata sintesi della sorte umana, unaprova d’antropogonia che ci propone le parole chiave del testo vigoliano, lanotte, il distacco dalla matrice prima, il pianto, la necessità dello smemorar-si (qui è però l’Adamo-uomo a essere «immemoriale»), la conoscenza sosti-tuita dal dolore come strumento d’apprensione:
Dalla tua matriceio salgo immemore e piango.
Camminano angeli, muti con me; non hanno respiro le cose; in pietra mutata ogni voce, silenzio di cieli sepolti.
Il primo tuo uomo non sa, ma dolora.
I tratti riconducibili a un percorso religioso («nella mia poesia è rimasta[…] regressa e sotterrata nel profondo una fortissima istanza religiosa»48)non possono impedire di riconoscere anche in Lagrima caddi quel saporeboreale (ma anche classico-mediterraneo) caratteristico di una poesia sincre-tica, cristano-pagana, lirico-tragica, persino tentata dalla contaminazionecon la prosa (si pensi al ricorso sistematico agli enjambements) di cui si nutree con la quale stabilisce un rapporto simbiotico. Gli stessi temi pervadono lerighe continue quanto quelle isolate («il verso – scriveva Barthes – non è quelche fa uno stacco e un urto?»49), la scansione è sempre dettata dall’ossessio-ne del tempo che rovina sulle vicende umane, ossessione del pensiero e pul-sione ritmica che trovano per esprimersi le stesse parole, intrecciano le stes-se metafore:
Par quasi che la fiumana dei popoli si sia messa d’un tratto a fuggire per unachina ripida; s’affretti ora velocissima e schiumante in una stretta di rupi. Quipresso la pianura si rompe sugli abissi e il turbine della cascata precipita i suoicandidi cavalli da versanti vertiginosi. Ecco i nostri anni veloci: la fuga dei
PROVE D’ANTROPOGONIA. PER UNA LETTURA DI «LAGRIMA CADDI» DI VIGOLO
227
48 G. Vigolo, Ideario, V, 84 cit. in P. Frandini, Nei quaderni di Giorgio Vigolo cit., p. 320. 49 Roland Barthes, Sollers scrittore, Milano, SugarCo, 1979, p. 51.