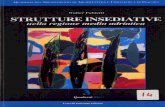Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina (fine...
Transcript of Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina (fine...
© 2012 Firenze University Press – ISSN 1824-7601 (online)
F o r u m Studi Slavistici IX (2012): 243-271
Giovanna Siedina
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina
(fine del XVII-inizio del XVIII secolo)
1. La poesia neolatina ucraina dei secoli XVII-XVIII è strettamente legata all’istru-zione scolastica, particolarmente quella ricevuta nelle classi di poetica e retorica in scuo-le quali il Collegio Mohyliano e le sue filiali. Infatti, praticamente tutti i poeti ucraini di questo periodo avevano compiuto i loro studi al Collegio mohyliano o in scuole affini ed avevano pertanto assorbito e fatto propria la concezione della poesia in esse insegnata.
Secondo questa concezione la poesia doveva contribuire all’educazione di uomini de-voti, incoraggiando la virtù e dissuadendo dal vizio perché il suo scopo fondamentale era il perfezionamento morale di coloro che la praticavano.
La via migliore per raggiungere questo scopo era la rappresentazione di azioni umane esemplari, che erano pertanto da ritenersi l’oggetto principale della poesia1. A causa del ruolo fondamentale della persuasio in una poesia così concepita, quest’ultima era forte-mente legata ai generi della retorica2. In effetti, dalle composizioni poetiche della cerchia
1 Cf. una delle definizioni della poesia che ricorre più spesso nelle poetiche: “Poesis est ars hominum actiones effingens easque ad vitam instituendam carminibus explicans” (la citazione è tratta dal manuale Lyra variis praeceptorum chordis... instructa..., 1696, e risale a Pontano [Ponta-nus 1594: 5; cf. anche Masljuk 1983: 26]. Il manoscritto di questa poetica si trova all’Instytut Ru-kopysu della Nacional’na Biblioteka Ukrajiny a Kiev [in seguito NBU IR] con la collocazione 501 П/1719; la citazione è tratta dal f. 4v.).
2 Nella gran parte delle poetiche kieviane lo scopo della poesia viene individuato, seguendo Orazio (Ars poetica, vv. 333-334), nel docere e delectare a un tempo: cf., ad es., Idea artis poeticae (1707, NBU IR, coll. ДА / П 420, f. 7r.) “... cujus finis est juxta Horatium, aut prodesse aut delectare, aut utroque modo juvare vitam humanam”. Al delectare era generalmente assegnato il compito di incitare a compiere il bene, al docere quello di dissuadere dal compiere il male. Cf. quanto afferma l’autore di Camoena in Parnasso Kijovo Mohileano (1689, NBU IR, collocazione 658 / 449 C, f. 119v.) citando gli stessi due versi di Orazio: “Necessitas seu utilitas, et finis poeseos est in effictione morum huma-norum: ut homines imitatione bonorum trahantur ad bonum malorum fuga et liberentur ab exitio. Porro duplex est finis poetices. Primus, ut delectatione sui metri raperentur homines ad aliquod bo-num faciendum. Secundus, ut doctrina sua deterreant poetae homines a malo, ut testatur Horatius”. Al tempo stesso, l’idea che i poeti siano i custodi della fama, e quindi della gloria, è ripetuta spesso dagli autori delle poetiche, che talvolta citano Orazio (cf. in particolare T. Prokopovyč che in De arte poetica libri tres cita Carm. IV, 9, 25-28 a sostegno dell’idea che solo la poesia può conferire immortalità cele-
244 Giovanna Siedina
mohyliana, possiamo dedurre che i professori rappresentavano le azioni umane (e con esse esemplari modelli di virtù) in due modi principali: attraverso differenti specie di poesia en-comiastica (che apparteneva al genus demonstrativum), e con diverse specie del genus deli-berativum3. Per quanto attiene alla poesia panegirica, i professori del collegio come oggetto del loro encomio sceglievano personaggi che erano conosciuti e (relativamente) ‘accessibili’ ai loro studenti e con i quali fosse per loro più facile identificarsi, in special modo dignitari ecclesiastici connessi al collegio, ma anche leader militari, primo fra tutti l’etmanno Ivan Mazepa4. In tal modo, la creazione/presentazione di modelli esemplari di virtù andava di pari passo con la celebrazione della propria istituzione e di quanti contribuivano alla sua prosperità. Tenendo conto dell’importanza del Collegio Mohyliano come principale cen-tro culturale e di formazione dei futuri quadri della vita politica ed ecclesiastica dell’Ucrai-na (come anche della Moscovia), è abbastanza naturale che i personaggi con esso connessi fossero i principali destinatari delle diverse specie della poesia nel genere dimostrativo.
Proprio una siffatta comprensione della poesia spiega la preminenza accordata alle specie della poesia epica, il cui fine precipuo era di suscitare il desiderio della virtù5. Nel-la poetica particolare, nella quale venivano illustrati nel dettaglio i diversi generi poetici della poesia latina, alla poesia epica viene infatti dato un posto di primo piano. In alcune poetiche mohyliane, dopo l’illustrazione dettagliata dell’oggetto e della composizione del poema eroico6, insieme all’illustrazione dei ‘pregi’ e dei ‘difetti’ (vitia) del suo metro, l’e-
brando “prisca gesta” e “heroicas virtutes” degli antichi. Allo stesso scopo questi versi di Orazio sono citati in Idea artis poeticae, NBU IR, due mss., collocazioni: ДА / П 420 е 505 П / 1721). Altri autori (Camoena in Parnasso Kijovo Mohileano, cit., f. 119r.), per esprimere lo stesso concetto si servono dei versi di Orazio “Dignum laude virum Musa vetat mori / Caelo Musa beat.” (Carm. IV, 8, 28-29b).
3 La divisione ricorrente della poesia nelle poetiche mohyliane nei tre generi della retorica testimonia del suo carattere applicato e della funzione politico-sociale che le era assegnata. Il genus demonstrativum comprendeva encomi, odi gratulatorie, odi salutatorie, odi vituperatorie, descrizio-ni di battaglie, di trionfi e altri tipi di odi panegiriche; al genus deliberativum appartenevano odi che contenevano una qualche dottrina morale, il cui scopo era o di incoraggiare la virtù o di scoraggiare il vizio. Infine, il genus iudiciale includeva lamenti, invettive (odi esecratorie, anche chiamate dirae), dediche (vota), suppliche. Quest’ultimo genere è il meno rappresentato nelle poetiche mohyliane.
4 Sulla poesia panegirica dedicata a Mazepa, cf. fra gli altri Sazonova 2004, Radyszewski 2004, Siedina 2007 e Siedina 2008.
5 La poesia epica (epos, carmen heroicum) dall’antichità e fino all’epoca del tardo Barocco fu considerata nella riflessione teorico-letteraria come il genere poetico modello, la poesia perfetta (perfecta poesis, secondo l’espressione di M.K. Sarbiewski), e fin dal primo Medioevo fu grandemen-te richiesta nella poesia dei nuovi Stati europei. Cf. la definizione che troviamo nel manuale Hymet-tus extra Atticam…: “Epopeia quo ad rem est imitatio illustrium actionum virorum illustrium car-mine hexametro per narrationem ad amorem vel desiderium virtutis excitandum ordinata” (NBU, IR, coll. 315 П / 122, f. 16r.).
6 Il suo oggetto, seguendo il detto oraziano (Ars poetica 73), veniva indicato come “res gestae heroum, regum, ducum, tristia bella, eventus bellorum varij laudes inclitae eorum” (cf. Camoena in Parnasso Kijovo Mohilaeano, cit.).
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 245
sametro dattilico, troviamo ascritte alla poesia epica altre specie poetiche che hanno per oggetto le azioni illustri di uomini illustri in diversi ambiti della vita. Fra di esse troviamo il poema genetliaco, il poema epitalamico, il poema encomiastico, il poema eucaristico, l’epicedio, e diverse altre7. Certamente, l’affermazione che le scienze, l’intelletto, le arti e le qualità morali e spirituali sono superiori alle gesta belliche contiene un riferimento ne-anche troppo velato all’oggetto della propria poesia e testimonia dell’espansione dei temi della poesia epica8, che considera tutte le attività dell’intelletto nobili e degne di essere celebrate quanto le gesta militari sui campi di battaglia. Questa comprensione della poesia epica riflette l’approccio rinascimentale al carmen heroicum, che era chiamato ad andare oltre la celebrazione di “res gestae regumque ducumque et tristia bella”, come Orazio aveva definito l’argomento del poema eroico.
Da quanto detto, si comprende come il concetto di virtù occupasse un posto centrale nella poesia epico-panegirica di questo periodo. Per capire quale fosse il suo contenuto e come esso venisse convogliato, ho analizzato quattro componimenti epico-panegirici, de-dicati ai due personaggi che sembrano essere maggiormente celebrati nella poesia neolati-na ucraina di questo periodo nell’ambito, rispettivamente, del potere politico-militare e dell’autorità ecclesiastico-religiosa: Ivan Mazepa e Joasaf Krokovs’kyj. Diverse odi e ora-zioni panegiriche dedicate a Mazepa in polacco, latino e slavo-ecclesiastico sono state già analizzate9, mentre non ci risulta che sia stata oggetto di studio l’opera panegirica in latino di Petro Armašenko Theatrum perennis gloriae, dedicata a Mazepa e pubblicata nel 1699 a Černihiv, e recentemente tradotta in ucraino10. Pertanto, per quanto attiene a Mazepa, dopo aver analizzato i passi rilevanti del poema epico del 1702 da me precedentemente tradotto e analizzato (Siedina 2007), mi soffermerò su questa opera. Per quanto riguarda invece la figura di Krokovs’kyj, rettore del Collegio Mohyliano (1689-90 e 1693-1697), successivamente Archimandrita del Monastero delle Grotte (1697-1707) e infine Metro-polita di Kiev (1708-1718), mi concentrerò sul poema Entheus poeta, da me tradotto e analizzato di recente (Siedina 2012), e su un’orazione panegirica scritta in occasione della sua elezione a metropolita.
7 L’elenco più dettagliato è fornito dall’autore di Fons Castalius, che enumera e descrive brevemente ben venti specie di poesia epica (cf. i fogli 142r. e 142v. di Fons Castalius, NBU IR, coll. ДС / П 239).
8 Sulla labilità dei confini tra la poesia epica e la poesia encomiastica che ha le sue radici nella teoria didattica rinascimentale dell’arte, vedi Hardison 1962: 43-67 e 71-72.
9 Cf., fra gli altri, Radyszewski 2004, Sazonova 2004, Siedina 2007, Siedina 2008, 10 La traduzione ucraina, dal titolo Teatr vičnoji slavy, è reperibile online sul sito del periodico
“Siverjans’kyj litopys”, <http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2009/2009n06/2009n06r08.pdf>. Que-sta pubblicazione, pur meritevole, soffre dello stesso difetto delle non numerose pubblicazioni di opere neolatine in traduzione ucraina, ossia la mancanza dell’originale latino a fronte, ciò che non consente di ricostruire la poetica delle reminiscenze che le caratterizza e di valutarne appieno il valore. Peraltro, gli originali latini, per lo più manoscritti o in stampe antiche, sono sempre di difficile reperibilità.
246 Giovanna Siedina
Certamente, il fatto che i due personaggi celebrati fossero rappresentanti l’uno del potere ecclesiastico, l’altro di quello politico-militare, comporta di già di per se stesso ac-centi differenti nel contenuto del concetto di virtù. L’interesse di questa indagine risiede pertanto proprio nell’individuare e analizzare i punti di contatto per avere un quadro più chiaro dei valori propagati attraverso la poesia e della loro scala gerarchica, come anche dell’uso di citazioni e reminiscenze poetiche per avvalorarli.
2. Il poema epico del 1702, scritto da Ilarion Jaroševyc’kyj e inserito nel suo corso di poetica Cedrus Apollinis11, celebra in 241 versi le conquiste militari di Mazepa, culminate nella presa di Azov del 1696 da parte dell’esercito russo e cosacco ucraino. L’autore del poema, fin dai primi versi, stabilisce un nesso diretto fra le vittorie militari e la virtù. Così, contrastando l’indugiare di Fabio il Temporeggiatore (cunctator), che raramente portò ai Romani vittorie, con l’agire deciso dell’etmanno ucraino, Jaroševyc’kyj afferma:
Bella geri virtute docens12 animoque manuqueNon numero supplet. Virtus prodigia vitae,Et tumulo speratus honos et fama superstesIam vada iam salebras, inextricabilae sylvae.
Insegnando che le guerre sono condotte dalla virtù, dall’animo e dalla manoE non dal numero. La virtù offre meraviglie alla vita,E l’onore sperato e la fama superstiti al tumuloOffrono ora passaggi, ora ostacoli a una selva inestricabile.
L’autore non si sofferma sul contenuto della virtù di cui dice essere portatore Mazepa, e tuttavia possiamo supporre che essa fosse da intendersi non solo come valore militare (ἀρετή), ma anche come virtù morale (ἀνδρεία), alla quale si univa la fede cristiana. Infatti, poco dopo nel poema viene introdotta la figura di San Giovanni Battista, il Precursore, santo patrono di Mazepa, di cui si mette in evidenza il ruolo di protettore dell’esercito cosacco. San Giovanni Battista è però messo nella posizione che precede Marte e quindi implicitamente dichiarato superiore al dio della guerra13.
Poco più avanti, viene inoltre chiarito che due sentimenti tra di loro interconnessi de-vono muovere gli animi dei combattenti cristiani a difesa della vera fede: il primo è la pietas, e cioè un profondo senso del proprio dovere verso lo stato, la divinità e la famiglia. Il se-condo è la religio, che è da intendersi in senso cristiano, come rispetto della ‘vera fede’ (non ‘eretica’), come l’unico sentimento che può spingere al sacrificio di sé per un bene superiore (la cristianità ripristinata con la vittoria sugli infedeli). Mazepa pertanto ha trionfato sugli infedeli proprio perché è portatore di questi due sentimenti, e quindi per il suo essere un
11 NBU, IR, coll. ДС / П 241, ff. 84r.-89r.12 Il soggetto è Mazepa.13 Cf. Siedina 2007: 96-97.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 247
combattente cristiano. Questa sua caratteristica è adombrata anche dalla croce che appare nel suo stemma, e che viene menzionata dall’autore come garanzia di protezione divina.
2.1. I motivi della virtù di Mazepa e del suo essere un combattente cristiano, che sono solo accennati nel poema epico summenzionato, nel quale, appunto, prevale la componen-te epica su quella panegirica, sono invece trattati diffusamente in Theatrum perennis gloriae del 169914.
Si tratta di un’opera epico-panegirica, scritta per celebrare le stesse conquiste militari degli anni 1695-98, е apparentemente declamata alla presenza dell’etmanno a Baturyn15. Essa è così composta: dopo il lungo titolo, si trova una poesia iniziale sullo stemma di Maze-pa, a cui segue una prefazione panegirica in prosa. Un’‘ode tributaria’ apre quindi l’opera; ad essa segue una lunga parte in prosa, intervallata da parti in versi, che ha il compito di amplifi-care, spiegare e argomentare le lodi per le gesta di Mazepa, sinteticamente espresse nelle due poesie in una serie di tropi ‘standard’, ad es. l’assimilazione di Mazepa a Ercole, ad Achille, a Ettore, ad Alcibiade, come anche l’allegoria del teatro della gloria perenne. Infine chiude l’opera un’ode che ha lo scopo di riassumere poeticamente il plauso all’etmanno ucraino.
Il carattere panegirico appare manifesto fin dai primi versi sullo stemma di Mazepa, nei quali l’autore chiama Apollo e le Muse a celebrare l’etmanno. In questa prima poesia, fin dalla terza strofa viene sottolineato il fatto che Mazepa è un capo militare cristiano, ciò che è adombrato dalla croce del suo stemma, che è detta farsi gioco, beffarsi delle frec-ce barbare (“barbara tela ridet crux tua laurifera”), e che lo rende invincibile (invictus). Il contrasto fra la luce della cristianità e la ‘barbarie’ degli infedeli è il leitmotiv che percorre tutta l’opera. Tuttavia, già in questa prima poesia l’autore sottolinea che è la virtù di cui è portatore Mazepa a garantirgli vittorie e gloria. Cf. i versi 13-16:
Nil sterile est ubi virtutis cultura moratur, Crescit et in ferro, laeta feraxque seges.
14 Il titolo completo recita: Theatrum perennis gloriae, illustrissimo ac magnificentissimo domi-no D[omino] Ioanni Mazepa Duci Exercituum Sacrae Caesareae Maiestatis Zaporoviensium strenuis-simo. Tum ex heroicis gestis, tum ex Illustribus Aviti stemmatis Decoribus, Tum ex Senatoriis Virtutibus Obsequiosae Minervae Dextera fabricatum. Atque Tributariae Venerationis ergo, per devinctissimum suo nomini et cultui Petrum Armaszenko praesentatum nec non dedicatum. Anno quo Coelestis Heros Theatralem ovans peregit scenam. Typis Czernihoviensibus SS. Triadis, 1699. Quest’opera non è da confondersi con il panegirico Capitolium perennis gloriae, scritto in occasione dell’arrivo di Mazepa a Kiev nel 1690 dagli allievi del Collegio Mohyliano (e brevemente descritto in Barvins’kyj 1920).
15 Questa notizia è reperibile al sito <http://navigatori.ucoz.ru/publ/12-1-0-589>, ma non ne ho trovato conferma altrove. Purtroppo quasi nulla si sa dell’autore, Petro Armašenko. Le uniche fonti che registrano la pubblicazione di quest’opera (Sumcov 1885: 33, Kameneva 1959: 42) non dicono pressoché nulla del suo autore, se non che apparteneva all’élite culturale di Černihiv. Theatrum peren-nis gloriae è registrato al n. 748 del catalogo di Zapasko-Isajevyč ( Ja. Zapasko, Ja. Isajevyč, Pam’jatnyky knyžkovoho mystectva: kataloh starodrukiv, vydani na Ukrajini, I (1574-1700), L’viv 1981-1984).
248 Giovanna Siedina
Dum tua continuo solida virtute rigatur Ansa, tulit Palmam comparem Olympiacae.
Non c’è niente di sterile laddove ci si cura di coltivare la virtù, Anche nella spada cresce un raccolto lieto e abbondante.Finché la tua spada è incessantemente irrigata dalla ferma virtù, Raccoglie una palma uguale a quella olimpica.
Similmente, nella poesia che segue e che propriamente apre l’opera, sono le virtù di Mazepa a far sì che egli superi Ercole, perché egli ha sconfitto un nemico ben più temibile dell’Idra o Medusa sottomessa dal leggendario eroe. Cf. i versi 1-12 della suddetta ode:
Caelo vetustas intulit Herculem,Mirata monstris letiferam manum Flammisque stellatus refulget Saxificae Domitor Medusae.Si poscat aequo clara sub arbitroVirtus honores, impiger Hercules Mazepa concedet priores Iure Tibi, volucerque Perseus;Nam Multiformi, Tu numerosius,Hydra, Medusa, pestiferum magis Monstrum repressisti, impetusque Prodigij retudisti inanes.
L’antichità ha portato Ercole in cielo,Ammirando la Mano mortifera per i mostri, E stellato di fiamme rifulge, Il vincitore della medusa, che trasformava in sassi.Se la chiara virtù chieda onori sotto un equoArbitro, o instancabile Ercole Mazepa, concederà i primi di Diritto a te, e alato Perseo;Infatti tu hai sottomesso un mostroPiù numeroso della multiforme Idra, più pestifero Di Medusa, e hai respinto i vani Assalti del mostro.
Se è dunque la virtù di Mazepa che gli garantisce così grandi imprese, in cosa essa propriamente consiste, qual è il suo contenuto? Per comprenderlo bisogna leggere attenta-mente l’orazione in prosa che segue. In essa l’autore glorifica le gesta militari dell’etmanno usando a fini retorici l’abbondante arsenale metaforico-lessicale fornito dalla mitologia e dalla storia pagane in un crescendo di similitudini con personaggi sia storici che leggendari, le cui gesta sono eguagliate e spesso superate da quelle di Mazepa. L’allegoria del teatro fa da sfondo a questa celebrazione, ed esso, afferma l’autore, quasi fosse una reggia di Febo, ri-
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 249
splende molto più di Pharos, o della via trionfale allestita da Roma per Scipione o Pompeo, e da Cartagine per Annibale. E risplende non per l’oro o per una lega di oro e bronzo che imita le fiamme, ma per la virtù e per Marte (cioè per l’arte della guerra). Come vedremo a breve, l’arte della guerra, espressa dalla metonimia Marte, non è un qualcosa di a se stante e indipendente rispetto alla virtù, ma una conseguenza di essa. Da un lato infatti alla virtù di generale (virtus ducalis) di Mazepa sono spesso apposti gli aggettivi “sacra” o “heroica”; dall’altro, l’autore sottolinea il fatto che chi ha a fondamento del suo agire la virtù, non si cura dell’inclemenza del tempo e dell’instabilità dei fati (“ridet nimirum fatorum incle-mentiam quidquid virtutis basibus innititur […] nec inter irrequietos temporum recense-tur casus cui virtus subest in fundamentum” – “indubbiamente tutto ciò che si appoggia sul fondamento della virtù irride l’inclemenza del destino […] e non viene enumerato fra gli avvenimenti irrequieti dei tempi chi ha a fondamento la virtù”). Le due idee sono colle-gate: chi è portatore di una virtù sacra, che cioè viene da Dio, non dipende dall’incostanza del destino e pertanto non se ne cura; al tempo stesso proprio perché proveniente da Dio, questa virtù porta a compiere gesta soprannaturali, fuori dal comune, eroiche appunto. Il concetto che la virtù è alla base delle imprese eroiche di Mazepa è ripetuto ed ampliato a più riprese nelle righe e pagine successive. Il poeta, servendosi di un topos consueto della poesia panegirica, sottolinea che l’eroicità e l’unicità delle doti umane, intellettuali e mili-tari di cui è portatore Mazepa era visibile in lui fin dalla nascita, e pertanto la sua superiorità in tutto ciò che intraprende, e che lo avvicina alla divinità, è innata in lui. Tuttavia, a diffe-renza di altri nati da sangue nobile, ma che non hanno dato seguito alla nobiltà ereditata e hanno tralignato, Mazepa ad essa ha aggiunto la virtù e queste sono le due solide colonne del suo teatro di gloria perenne, afferma l’autore. Ed è proprio la virtù di cui egli è portatore che lo innalza al cielo.
È chiaro che una siffatta virtù, capace di far compiere a colui che la possiede azioni fuori dal comune, eroiche, appunto, può solo venire da Dio. E infatti, quando l’autore passa a declinare le molte singole virtù (“profluvium virtutum”) che la compongono, al primo posto egli mette la religione, definita “basis et fundamentum regnorum” (“base e fondamento dei regni”). Del resto, afferma l’autore, la funzione di propagatore zelantis-simo della gloria divina è già contenuta nel nome Ioann, e anche questo accenno al topos del nome concorre alla predestinazione di Mazepa (cf. Sazonova 2004: 470 ssg.). La sua religiosità e devozione si esplicano, fra l’altro, nelle sue generose donazioni per il restauro e la costruzione di chiese: anche qui il poeta/oratore abbellisce la sua orazione con una serie di metafore e similitudini volte a sottolineare la straordinarietà delle azioni dell’etmanno ucraino. Così, i materiali usati per restaurare le chiese hanno un tal pregio, che esse supe-rano in magnificenza il tempio di Apollo a Delfi; o ancora, uguagliano lo splendore dei marmi pari, e la loro bellezza risplendente di oro e argento puri emula la reggia di Febo16.
16 Sulle numerose donazioni di Mazepa per il restauro di chiese e monasteri e in generale sulla sua attività a sostegno della Chiesa ortodossa in Ucraina, cf. Mycyk 2004.
250 Giovanna Siedina
La seconda virtù è la prudenza, che è detta brillare più di tutta la porpora (cioè del potere imperiale) ed essere stata impressa fin dall’inizio da Dio nell’animo di Mazepa. La religione unita alla prudenza, afferma l’autore, sostengono il mondo; così lo Stato, allegori-camente rappresentato con la nave Argo (“Reipublicae Argo”), se portato avanti da queste due virtù, che lo reggono come ancore fermissime17, non teme tempeste, venti impetuosi o naufragi, ma giungerà sicuro alle isole fortunate18.
Nel suo elogio della prudenza, l’autore afferma che essa è molto migliore e molto più utile della forza fisica e di fatto la eguaglia alla sapienza, affermando “melior est sapientia, quam vires, et vir prudens, quam fortis” (“è preferibile la sapienza alla forza, e un uomo pru-dente è migliore di un uomo forte”). E per rafforzare questa affermazione, egli ricorre ad una citazione tratta da Argonautica di Gaio Valerio Flacco (I sec. d.C.), leggermente modificata19:
Non solis viribus aequumCredere: saepe acri potior prudentia dextra.
Non nelle sole forze è giusto credere:Spesso la prudenza è superiore a una severa destra.
Armašenko prosegue quindi con un confronto fra la prudenza e la solertia (cioè l’in-gegno), da una parte, e la forza fisica dall’altra e sottolinea come in battaglia spesso conti molto più una corretta decisione presa al momento giusto rispetto a un esercito numeroso ma privo di capacità di giudizio. E anche qui, per corroborare la sua affermazione, ricorre ad una citazione, che si trova fra i Monosticha attribuiti ad Alcuino20, e con ogni probabilità ha origine biblica:
Vir prudens animo est melior, quam fortis in armis.
L’uomo saggio d’animo è migliore di quello forte nelle armi.
Proprio questa sapienza, afferma Armašenko, è posseduta dall’etmanno ucraino, de-finito “Atlante della Patria”, superiore ad Argo dai cento occhi, e i cui consigli sono detti migliori dell’Oracolo del tripode Apollo delfico.
17 L’ancora era nello stemma di Mazepa18 Sul mito delle isole fortunate, che secondo Omero si trovavano all’estremo Occidente,
vedi Manfredi 1993.19 Cf. Argonautica, lib. IV, vv. 621-622: “sed te non animis nec solis viribus aequum / cre-
dere: saepe acri potior prudentia dextra.”. L’opera, un poema epico in otto libri sulla conquista del Vello d’oro, glorifica Vespasiano per le sue conquiste in Britannia e per avere così favorito i viaggi nell’Oceano similmente a come il Ponto Eusino era stato aperto dalla nave Argo. Argonautica è una libera imitazione e rielaborazione dell’opera omonima di Apollonio Rodio.
20 Cf. Silvestre 1962: 256, n. 4. Cf. anche Qoèlet. 9, 16: “È meglio la sapienza della forza”, e 9,18: “Meglio la sapienza che le armi da guerra”.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 251
Quanto alle altre virtù di Mazepa, che sono strettamente legate alla prudenza, l’autore elenca in primo luogo la giustizia temperata dalla clemenza (“justitia clementiâ tempera-ta”). Proprio per questa sua virtù, che gli permette di trasformare l’ira in mansuetudine, di punire le offese con la benevolenza, la figura di Mazepa viene quasi sacralizzata. Alla cle-menza è strettamente associata la modestia, definita “maximum principum ornamentum”, che l’autore illustra con esempi di uomini politici e leader militari della storia romana. La particolarità di Mazepa, che si trova raramente in uno stesso principe, è quella di unire la modestia alla maestà. Per questa sua caratteristica, nonostante tutte le vittorie e le glo-rie militari, Mazepa, sottolinea l’autore, non è posseduto dalla superbia, ma al contrario considera tutti ugualmente degni, con tutti parla, tutti consiglia. E questa mansuetudine e modestia non sono opposte alla fortezza, al coraggio, ma al contrario ad essa sono inestri-cabilmente legate: infatti, afferma l’autore, forte è colui che è libero dalle passioni e non si lascia vincere dai turbamenti dell’animo. L’ultima parte dell’orazione si caratterizza per il crescendo di lodi e l’accumulazione delle virtù di Mazepa: con questo espediente l’autore amplifica ulteriormente la rappresentazione dell’etmanno ucraino come un concentrato di virtù che lo rende un eroe cristiano chiamato alla santità. Così, alle virtù nominate si aggiunge la bontà (beneficentia), che rende Mazepa partecipe di ogni povertà che vede at-torno a sé. Nella conclusione dell’orazione, Armašenko, ricapitolando le virtù di Mazepa, ad ognuna di esse accosta un personaggio dell’antichità che l’etmanno ucraino ha superato: “Eminet hic magnanimitas, qua Scipiones, Sapientia qua Caesares, Religio qua Pompilios, comitas, affabilitas, constantia qua omnes duces superasti: O theatrum stupendum tam orbi rarum quam Patriae fortunatum. Hinc exegisti iam monumentum aere perennius” (“Eccelle qui la magnanimità, nella quale hai superato gli Scipioni, la sapienza, nella quale hai superato gli imperatori, la religione nella quale hai superato i Numa Pompilio, la gene-rosità, la gentilezza, la costanza, nelle quali hai superato tutti i generali: O teatro stupendo, tanto raro per il mondo quanto fortunato per la Patria. Per questo hai eretto ormai un monumento più perenne del bronzo”). Seguono i versi 2-5 della celebre ode di Orazio III, 30 che introducono l’ode conclusiva:
Regalique situ pyramidum altius,Quod non imber edax, non Aquilo inpotensPossit diruere aut innumerabilisAnnorum series et fuga temporum.
Più elevato della regale struttura delle piramidi,Tale che né la pioggia edace, né Aquilone impotentePossano distruggerlo, né l’innumerevole successioneDegli anni e il corso dei secoli.
Anche se l’autore afferma che è stato Mazepa come le sue molte virtù a erigere un tale monumento, e nonostante i topos modestiae di cui è costellata l’orazione, il paragone implicito fra sé stesso e il classico latino è evidente. Proprio nella conclusione in prosa che
252 Giovanna Siedina
segue all’ode, l’autore dichiara la sua incapacità a esprimere pur con tutti gli ornamenti della retorica una lode che possa eguagliare l’altezza e la grandezza dell’etmanno ucrai-no. Tuttavia subito dopo volutamente ‘contraddice’ se stesso, quando chiede a Mazepa di tollerare che in questo teatro, come nell’opera di Omero, sia abbracciata l’Iliade dei suoi fatti e delle sue virtù” (“patiare capi in hoc Theatro ac si in nucleo Homeri facto-rum virtutumque tuarum Iliadem”), in tal modo implicitamente paragonando se stesso a Omero. E di nuovo immediatamente smentisce le proprie parole, affermando che nel futuro scrittori più ragguardevoli con coturni più grandi celebreranno l’etmanno come merita. E per sottolineare l’immortalità delle gesta di Mazepa, l’autore conclude citando i versi 503-506 dell’Edipo di Seneca, riferiti in quel contesto a Bacco, ai quali aggiunge il suo verso conclusivo. Cf.:
Lucida dum current annosi sidera mundi, Oceanus clausum dum fluctibus ambiet orbem Lunaque dimissos dum plena recolliget ignes,Dum matutinos praedicet Lucifer ortusSemper honos, nomenque tuum laudesque manebunt.
Finché le chiare stelle dell’antico mondo seguiranno il loro corso,Fino a quando l’oceano circonderà con le sue acque la terra imprigionataE la luna piena raccoglierà ancora la sua radiosità perduta,Finché la stella del giorno annuncerà il sorgere del mattinoSempre rimarranno l’onore, il tuo nome e le tue lodi.
Come vedremo a breve, le virtù attribuite a Joasaf Krokovs’kyj non si discostano di molto da quelle attribuite a Mazepa, anche se gli accenti sono diversi, stante la differente funzione sociale dei loro ‘possessori’.
3. Delle diverse poesie dedicate a Joasaf Krokovs’kyj e da me pubblicate, tradotte e analizzate, ho scelto di concentrarmi su quelle nelle quali il concetto di virtù è maggior-mente presente, Entheus poeta (1699) di Josyp Turobojs’kyj e un’orazione panegirica scrit-ta per l’occasione dell’ascesa di Krokovs’kyj al soglio metropolitano (1708). Entrambe le opere sono state da me analizzate in Siedina 2012; pertanto qui mi concentrerò solo sui passi rilevanti per il nostro tema.
3.1. La poesia Entheus poeta si trova nel corso di poetica di Josyp Turobojs’kyj, profes-sore di poetica e retorica del Collegio Mohyliano e futuro professore e prefetto dell’Acca-demia Slavo-greco-latina di Mosca e futuro brillante panegirista di Pietro I21.
Il tema centrale del poema, ossia la virtù di Krokovs’kyj e il suo essere ispirato dalla sapienza, rivela l’intenzione dell’autore di inserire l’archimandrita e futuro metropolita in quello che Natalia Pylypiuk definisce “the project, initiated in the 1690s, which – through
21 Per maggiori notizie su Turobojs’kyj cf. Siedina 2012: 98-101.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 253
visual and textual means – endeavored to portray Mazepa and Iasyns´kyi as protectors and benefactors of Wisdom’s abode, i.e., the collegium and St. Sophia, the cathedral church of Kyivan Rus’”22. Tenendo in considerazione il fatto che Krokovs’kyj era allora archimandri-ta del Monastero delle Grotte, si può affermare che anche questa fondamentale istituzione della Chiesa ortodossa nell’Etmanato, insieme alla sua protettrice, la Vergine Maria, Madre di Dio, erano incluse nel suddetto progetto23.
Il poema si trova sui fogli 21v.-25v. del manuale di poetica Hymettus extra Atticam24 ed è presentato come un esempio di silva, che il nostro autore caratterizza succintamente come “Carmen epicum brevius tractans vel historiam veram vel fictam, vel laudem vel vitu-perationem alicuius, caeteraque his similia” (“poema epico che tratta brevemente una storia vera o finta, la lode o il vituperio di qualcuno, e altre cose simili”)25. Mentre certamente appartiene al genus demonstrativum, il poema non è facilmente classificabile, poiché mostra caratteristiche tanto di un panegirico, quanto di un carmen gratulatorium, e di un carmen genethliacum26.
Il poema, che consta di 263 versi, può essere grosso modo diviso in tre parti e ad esso viene data la forma di un dialogo fra il poeta, da un lato, e Apollo e quattro delle muse, dall’altro. L’espediente retorico di porre la lode di Joasaf sulla bocca degli dèi la rende au-torevole e persuasiva.
Nel titolo il poeta si definisce “Entheus poeta”, ciò che allude ad una concezione neoplatonica del poeta come qualcuno ispirato da un furor divinus e al tempo stesso un agente passivo delle muse27. Data la lunghezza di quest’opera, citerò solo le parti rievanti,
22 Pylypiuk (in corso di stampa); cf. anche Pylypiuk 2004.23 Cf. Averincev 1972, in cui l’autore in maniera affascinante ricostruisce l’evoluzione del
concetto di σοφίa nella cultura greca e giudaico-cristiana, e si sofferma a lungo sull’interpretazione (lettura) sofiologica della figura della Vergine Maria.
24 Il suo titolo completo è: Hymettus extra Atticam duplici tramite neovatibus scandendus, seu Poesis bipartita tum ligatae tum solutae orationis praeceptionibus instructa Roxolanaeque iuventuti in Collegio Kijovo Mohil [sic!] proposita anno quo Turca ab deleto pax nata gubernat in orbe hIC Do-MInans terrIs Cara feraXque VIret. Il manoscritto si trova alla Sezione Manoscritti della Biblioteca Nazionale dell’Ucraina a Kiev (NBU IR), con la collocazione 315 П / 122.
25 L’attribuzione delle silvae alla poesia epica in questo e in altri manuali mohyliani, sembra riflettere una certa confusione dei confini fra l’epica e la poesia encomiastica che ha le sue radici nella teoria rinascimentale dell’arte (cf. Hardison 1962: 43-67 e 71-72). Tutti i generi tradizionalmente ascritti alle sylvae/silvae, nonostante i loro diversi temi e forme, contenevano l’elemento encomia-stico (cf. la loro trattazione in Scaliger 1561: Liber III, capitolo C e seguenti), ciò che è evidenziato anche in alcune poetiche mohyliane (cf., ad es., il manuale Cunae Bethleemicae, NBU IR, coll. 499 П / 1729) (cf. anche Niedźwiedź 2003: 63-64 e 174-175).
26 Sebbene il poeta affermi che il suo poema è stato scritto per il compleanno dell’archimandrita, esso non può essere ascritto tout-court al carmen genethliacum, poiché quest’ul-timo veniva generalmente scritto in onore di un neo-nato.
27 Per un’utile rassegna della teoria della frenesia, o impeto divino dei poeti, da Platone fino all’epoca pre-moderna, vedi Curtius 1979: 474-475.
254 Giovanna Siedina
riassumendo il resto. Il poema si apre con l’immagine del poeta afferrato dall’ispirazione poetica e portato nell’etere. Da lì egli viene trasportato fino alla cima del Parnaso dal cavallo alato Pegaso. Una volta che il poeta, a cavallo di Pegaso, si avvicina al Parnaso, questa visione incute terrore al suo cuore, e quando egli viene portato sulla sua cima, l’e-strema luminosità dei fuochi eterni e la paura davanti allo sconosciuto luogo sacro gli fanno perdere i sensi. Una voce apparentemente divina si volge quindi al poeta e lo invita a lasciare andare la sua eccessiva paura, poiché egli viene trasportato verso la sua patria, la sede dei poeti. La successiva raffigurazione di Apollo e delle muse è divisa in due parti: nella prima (vv. 69-78), ognuna di esse è intenta a raccogliere una diversa pianta o un diverso fiore, mentre nella seconda (vv. 80-89), le muse sono raffigurate ognuna nell’atto di svolgere la propria arte o scienza con gli attributi e gli strumenti corrispondenti. Le singole descrizioni sembrano riecheggiare la famosa poesia Nomina musarum, la cui attri-buzione è controversa. Esse sono però anche ricordate nel famoso dizionario multilingue di Ambrogio Calepino, da cui potrebbe averle tratte il nostro autore. Come che sia, egli le varia creativamente, e i frequenti enjambements aggiungono movimento a questa sce-na, trasmettendo un’atmosfera di gioiosa cooperazione fra le sorelle. Una volta che esse hanno preparato e accordato i loro strumenti, Apollo e il coro delle muse sono visti dal poeta nell’atto di partire per una destinazione a lui sconosciuta. Questa partenza gli dà il coraggio di parlare e di cercare di fermarle, e la sua accorata richiesta di dirgli dove sia-no diretti è efficacemente resa dalla amplificatiо verborum dei loro nomi e dal successivo chiasmo: esse sono chiamate “Pimpleae Vates placidae”, “mitis sorores Parnassi”, “Vigiles Divae laticisque biformis”, ciò che indica il loro essere poetesse, sorelle e dee. Il poeta ri-corre alla amplificatio sententiarum nella sua richiesta di informazioni su quali tipi di gesta esse si accingano a celebrare, e quindi in quale tipo di genere esse si accingono a cantare, genethliacum, epithalamium, o altre diverse specie di poesia encomiastica: panegirico, epi-nicio, gratulatio, elogia. Questi versi possono essere considerati anche poesia sulla poesia, nella quale il poeta richiama l’attenzione sia sulla predominanza del genere dimostrativo che sulla propria incarnazione pratica delle prescrizioni che egli dà ai suoi allievi: infatti i versi 95-98a precedentemente nel manuale erano stati usati da Turobojs’kyj per esempli-ficare l’esordio per interrogazione del poema encomiastico o panegirico.
Al tempo stesso, la sua insistenza sulla celebrazione delle gesta militari in una serie di domande (vv. 100-104), caratterizzate da un uso aggettivale che constrasta fortemente con quello riservato alle muse e ad altri generi di poesia, è inteso ad enfatizzare non la gloria che le vittorie militari portano ai loro artefici, ma piuttosto l’orrore, la crudeltà e il dolore che la guerra causa. Questo è rimarcato dalle locuzioni “trucem arenam”, “cruore madentes lusus”, “spicula duri ferri conspersa cruore”, e dall’immagine di uno squamoso Marte: non c’è nessuna gloria duratura nelle azioni di guerra, sembra affermare il nostro autore. Per contrasto, la nascita di un bambino, evocata da Imeneo, è un avvenimento gioioso, mentre la celebrazione di altri eventi e personaggi storici, come anche di dignitari ecclesiastici, a cui si accenna nei versi 105-108, ha una connotazione neutra. Cf. i versi 92-108:
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 255
Ast mihi iam sensus animosque audacia fandi Restituit. Supplex ergo tum talia dixi: Phaebe pater nobis spes unica, Vos quoque posco95 Pimpleae vates placidae, mitisque sorores Parnassi, vigiles divae laticisque biformis, Dicite quo celeres cursus gradusve veloces Figitis? An Lucina deûm partusque reducunt? An Hymeneus laetis revocat succendere thedas100 Ignibus? autve trucem scuamati Martis arenam Bellonaeque cruore madentes visere lusus Complacuit? Ferri cecinisse ve spicula duri Hostili victorum acie conspersa cruore? Vincentumve comas lauro coronare placebit?105 Aut ubi praecelsi sedem fixere senatus Regnorumve decus placuit celebrare Coronis? Caesareosve paludatus28, mitrasve celebres? Tempora praesuleis aut insignita Tiaris?
E a me l’audacia di parlare già restituì i sensi e il coraggio. Allora io supplice dissi queste cose: “Padre Apollo, nostra unica speranza, e anche voi prego,95 O placide poetesse pimplee, e sorelle del dolce Parnaso, e vigili dee dell’acqua biforme, Dite dove dirigete i celeri corsi o i passi veloci? Forse Lucina e i parti degli Dei vi conducono indietro? Forse Imeneo vi richiama ad accendere le fiaccole con lieti100 Fuochi? O vi piacque vedere la truce arena dello squamoso Marte E i divertimenti grondanti di sangue Di Bellona? O [vi piacque] aver cantato le punte della dura spada Ricoperte di sangue dall’esercito nemico dei vincitori? O vi piacerà coronare di alloro le chiome dei vincitori?105 O vi piacque celebrare con corone dove eccelsi senati collocarono La sede o il decoro dei regni? O i generali di Cesare, o le celebri mitre? O le tempie insignite dalle tiare vescovili?
La parte centrale del poema (vv. 115-232) contiene la congratulazione per l’occasio-ne del compleanno di Krokovs’kyj. Ciò che è altamente significativo è il fatto che la lode è posta sulla bocca di Apollo e di quattro delle nove muse, cioè Clio (musa della storia), Calliope (musa della poesia epica), Urania (musa dell’astronomia), e Polinnia (musa della poesia sacra, degli inni sacri e dell’eloquenza). La scelta delle muse non è casuale, come vedremo a breve.
28 Forse errato per “paludatos”.
256 Giovanna Siedina
Nel discorso di Apollo troviamo le caratteristiche tipiche del genere: la dea Lucina, che presiede ai parti, gli antenati gloriosi e nobili, e la virtù di Krokovs’kyj che lo porta a grandi raggiungimenti. Questa insistenza sulle virtù morali (il termine “virtù” ricorre 10 volte nei versi 117-224, come il merito maggiore di Joasaf, anticipa l’opposizione fra azioni di pace e il coltivare le scienze umane e divine, da un lato, e l’arte della guerra, dall’altro.
Effettivamente, la virtù è detta aver legato a sé Krokovs’kyj fin dalla sua nascita. Allo scopo di illustrare le fasi della sua crescita, che è sia fisica, sia morale e rappresenta un avan-zamento nella scienza e nella dottrina religiosa, il poeta, attraverso la voce di Apollo, ricor-re a una metafora romana. All’inizio la virtù lega a sé Krokovs’kyj con un amuleto d’oro (aurea bulla): in Roma la bulla venive messa al collo dei vincitori e dei figli dei nobili, e successivamente anche ai figli dei nati liberi; successivamente il tutoraggio, per così dire, del giovane Joasaf è preso da Pallade ed Apollo: una volta che l’amuleto viene tolto dal giovane collo29, Pallade intreccia con il suo pollice sacro una toga praetexta, cioè la veste esteriore dei figli dei romani nati liberi, ciò che sembra indicare una sorta di infusione della sapienza in lui. Apollo adorna le tempie di Joasaf con nastri di alloro e così fa Hermes, ed essi sono la giusta ricompensa per il fatto che Krokovs’kyj coltiva la poesia e l’oratoria, come anche per la sua funzione di protettore delle arti liberali in qualità di rettore del Collegio mohyliano. Diventato adulto e indossata ormai la toga libera, Joasaf eccelle sia nella virtù che nella conoscenza delle lettere, nella dottrina delle cose sacre e nella saggezza spirituale, cioè nella sophia. Ciò che Apollo sottolinea è il fatto che, nonostante sia ormai un’autorità religiosa, egli non ha mai abbandonato il suo amore per la letteratura, anzi arde di esso in un grado mai raggiunto da Mecenate o da Alessandro il Macedone (il grande)30. E così, la virtù di cui Joasaf è portatore riflette, almeno in parte, quella tendenza della filosofia rinascimentale che associava la saggezza speculativa con la virtù morale e l’azione civica31. Krokovs’kyj, nella raffigurazione di Turobojs’kyj, sembra la ‘perfetta’ incarnazione della trasformazio-ne umanistica “of wisdom from contemplation to action, from a body of knowledge to a collection of ethical precepts, from a virtue of the intellect to a perfection of the will”32. Inoltre, la virtù che Turobojs’kyj attribuisce a Krokovs’kyj, specialmente nei vv. 125-136, sembra rispecchiare la definizione erasmiana della virtù come virtus cum eruditione li-berali coniuncta, che Rice definisce “one idea of wisdom peculiarly characteristic of the Renaissance”33. Questa idea della saggezza come una combinazione di virtù e sapere è una
29 Cf. Properzio, Elegie, IV, 1, 131-132.30 L’autore probabilmente si riferisce, fra le altre cose, al lavoro di Krokovs’kyj di supervisio-
ne e di preparazione per la stampa di diversi testi religiosi nella sua posizione di archimandrita del Monastero delle Grotte, come anche del suo Acatisto a Santa Barbara del 1698 (cf. Marker [in corso di stampa]: 9-13). Queste stesse attività di scrittore e curatore di Krokovs’kyj sono parte del suo ‘portare la luce della religione fuori dalle ombre’ del verso 130.
31 Cf. Rice 1958: 149-177.32 Ibidem: 149.33 Ibidem: 213-214.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 257
concezione profondamente cristiana: effettivamente, da un lato la sapientia è concepita come la conoscenza di un Dio il cui attributo principale e la cui natura profonda è la virtù, e come una imitazione attiva di Cristo. Dall’altro, eruditio è un apprendimento concepito come un processo morale, la cui funzione è di avere “vere opinioni” sulle cose, e “to know what is good and what is bad in order that we may virtuously follow the good and flee the bad. […] Wisdom unites the ethical insights of learning with the practice of virtue”34. Seb-bene la concettualizzazione della saggezza elaborata dalla élite culturale mohyliana richie-da ulteriore approfondimento, la celebrazione di Krokovs’kyj, in questa e in altre poesie, sembra inserirsi nel summenzionato progetto ‘sapienziale’ del quale parla N. Pylypiuk.
Al fine di celebrare Joasaf in modo degno, Apollo usa un topos ricorrente nelle poetiche mohyliane, che è quello dell’abbandono del Parnaso greco in favore di quello mohyliano o kieviano. Ciò indica e mette in evidenza che il valore delle proprie acquisizioni letterarie non è in nulla inferiore a quello degli antichi classici, e al tempo stesso intende asserire la propria attiva partecipazione nella più ampia cultura europea. Ecco qui di seguito i versi 109-141:
Hoc ubi prolatum sincero corde patebat110 Divis, en subito dignati sistere gradum. Pieridum princeps hinc sacro fatus ab ore: Quid mea deposcis vates actusque viasque? Ignorasve diem sacram illuxisse Iosaphi [sic!] Natalem, magni Rossorum Luminis inquam? 115 Cuius sic unas spectesve35 genusve Lucina Nobilem spectavit generoso sanguine natum; Nec nasci fuerat satis, ipsa ast Virtus ad alta Prognatum esse videns voluit sibi nectere bullam. Iamque puer magnae subito rudimenta ferebat 120 Indolis, ac parvo regulabat corpore virtus. Mox ubi bulla rudi demissa est aurea collo Praetextam Pallas sacrato pollice nevit Ac ego lauratis decoravi tempora vittis, Hermes facundo posuit quoque vertice laurus. 125 Haec ubi deposita est, toga iam quoque libera sumpta Creverat ac virtus juvenis crescentibus annis, Inde sophum lauro rutile [sic!] ambivere corollae, Abdidit alma decus superumque scientia rerum. Nec licuit tantum saecli lattere [sic!] tenebris 130 Lumina quin ferre36 vel religionis ab umbris Aut huic conferret celsâ virtute decorem; Contulit et verae pietati iuncta venustas
34 Ibidem: 161.35 Probabilmente errato per “species”.36 Dal punto di vista metrico qui sarebbe corretto “ferret”.
258 Giovanna Siedina
Doctrinae, Sophia atque supernarum arbitra rerum, Post classes rossis doctè se tradita rostris135 Nec modo desistit literarum ast flagrat amore Qualis Maecenas fuerat nusquam Macedoque. Hunc igitur nostrâ celebrem quo dignius oda, Linquo Parnassum patrium sed pegma reposco Plausurusque sibi dulci modulamine vocis 140 Annosa laurus sincerè votaque porto. Nec ubi profatus sacra protinus ora repressit.
Quando ciò che avevo proferito con cuore sincero, fu manifesto 110 Alle divinità [le Muse], ecco subito si degnarono di fermare il passo. Allora il principe delle Pieridi proferì dalla sacra bocca: “Perché o vate chiedi le mie cose, e i miei atti e le mie vie? O ignori che è sorto fulgido il sacro giorno natale di Joasaf, Della grande luce dei Ròssi, dico? 115 Di questo così Lucina guardò i sembianti unici o il genere, Il nobile nato da sangue generoso; Né nascere era stato abbastanza, ma la stessa virtù, vedendolo nato Per compiere alte cose, lo volle legare a sé come un amuleto d’oro37. E già da bambino subito portava i rudimenti di una grande120 Indole, e la virtù governava il piccolo corpo. Non appena l’amuleto d’oro fu tolto dal rude collo, Minerva intrecciò con il sacro pollice la pretesta, Ed io decorai le tempie con bende di alloro, Anche Ermete pose allori sul facondo capo. 125 Quando questa fu deposta, e fu ormai assunta anche la toga libera38 Crescendo gli anni, era cresciuta anche la virtù del giovane, Per cui le vermiglie corolle cinsero il saggio di alloro, La benefica conoscenza degli dèi distolse lo sguardo [di Joasaf ] dalla bellezza
delle cose. E non fu lecito che uno tanto grande fosse nascosto nelle tenebre 130 Del mondo, senza che portasse le luci della religione fuori dalle Ombre o a questa conferisse decoro con l’eccelsa virtù; E contriburono anche la bellezza della dottrina unita alla Vera pietà, e la saggezza arbitra delle cose superiori, Avendo abilmente affidato sé stessa dopo le flotte ai rostri ròssi;135 E non solo non desiste dall’amore per le lettere, ma arde di esso Come mai avevano fatto Mecenate e il Macedone. Dunque, affinché io celebri questo più degnamente con la nostra ode, Abbandono il patrio Parnaso ma richiedo un pulpito
37 Presumibilmente l’autore voleva dire che la virtù aveva messo l’amuleto al collo del piccolo Joasaf e non alla virtù, ma avrebbe dovuto usare “ei” invece di “sibi”.
38 Cioè virile.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 259
E per applaudire a lui39 con dolce modulazione della voce 140 Da una vecchia epoca sinceramente porto allori e voti”. Né quando ebbe parlato, chiuse subito la sacra bocca.
La prima musa a parlare è Clio, chiamata a collocare i meriti di Joasaf su uno sfondo storico-mitologico. Facendo eco al discorso di Apollo, essa afferma che le qualità e la virtù di Joasaf portano dalla cima del Parnaso a sotto il tetto nativo che appartiene a lei. Allo scopo di illustrarle, il poeta mette sulla bocca di Clio una serie di paragoni con personaggi storici e mitologici, che sono scelti in quanto offrono exempla perfetti di ogni virtù. L’elen-co fornisce una buona esemplificazione di copia verborum, l’abbondanza lessicale usata per illustrare la varietà dei modi nei quali una idea basilare può essere espressa in latino. Ecco qui di seguito i versi 142-160:
Clio post roseo renidens haec protulit ore: Nostros, Aoniae cultor, si noscere calles Est animus, ducunt virtus meritusque40 Iosaphi145 Vertice Parnassi misso sub tegmen avitum, Nempe meum mandare aptus quoque tempora fastis Magnorum: superat questum virtutibus abbas Tum factis. Ceciditque sibi frux carius ultro Iustus Aristides, Themis, gravesque Catones,150 Antonij pietas, sors atque Polycratis ipsa, Magnus Alexander famâ tum nomine celso, Herculis invictum robur, durique labores, Pompeius constans, magni clementia Titti41. Sobrius ac Zenon, Sapientia sacri Solonis,155 Religioque Numae, quid plura loquar? Virtutis Nobile praecelsae dicas hunc esse theatrum, Quo capiant cuncti vitae rudimenta decorae. Hic igitur longum magno quo crescat in aevum Nomine, serta fero roseis implexa corollis160 Magnaque longevis referam sua nomina fastis.
Poi Clio rifulgente queste cose disse con la rosea bocca: “O cultore dell’Eonia, se desideri conoscere i nostri Sentieri, la virtù e i meriti di Ioasaf ci conducono,145 Lasciato il vertice del Parnaso, sotto il tetto avito, Appunto il mio; adatto anche ad affidare i tempi ai fasti42
39 Anche qui l’autore usa “sibi” invece di “ei”, cioè a lui.40 Dovrebbe essere “merita”.41 Probabile lapsus calami per “Titi”.42 Fasti ha il significato di ‘grandezze’, cioè ciò che rende il tempo fastoso, grande.
260 Giovanna Siedina
Dei grandi, l’abate supera il lamento con le virtù e poi con le Opere. E convennero con lui43 con molto diletto spontaneamente uomini
onesti [quali] Il giusto Aristide, Temi, e i gravi Catoni,150 La pietas di Antonio, e la stessa sorte di Policrate, Il grande Alessandro dal nome allora eccelso per fama, L’invitta forza di Ercole, e le dure fatiche, Il costante Pompeo, la clemenza del grande Tito. E il sobrio Zenone, la Sapienza del sacro Solone,155 E la devozione di Numa, perché dovrei aggiungere altro? Potresti dire che questo è il nobile teatro dell’eccelsa virtù, Affinché tutti apprendano le prime nozioni di una vita degna. Dunque, affinché questo cresca con un grande nome per un Lungo tempo, porto serti intrecciati con rosee corolle160 E riferirò i loro grandi nomi a fasti longevi.
La prima virtù, la giustizia, è rappresentata dallo statista ateniese Aristide, da Temi (la dea della giustizia), e dai due Catoni (Catone il Giovane e Catone il Vecchio).
La virtù della pietas è impersonata da un certo Antonio (forse quel Marco Antonio oratore, nonno del famoso generale e triumviro)44; per quanto riguarda Policrate, la ragione della sua scelta può risiedere nella sua prosperità, come anche per il suo essere, quantunque tiranno, illuminato45. Il duro lavoro è ben rappresentato da Ercole e dalle sue fatiche; le altre virtù che Joasaf possiede sono compendiate da personaggi della storia greca e romana: Pompeo per la costanza, l’imperatore Tito per la clemenza, Zeno di Cizio, il fondatore del-la scuola stoica di filosofia, per la sobrietà, Solone per la sapienza, infine Numa Pompilio, il secondo re romano, per la devozione religiosa. In conclusione, la sede di Joasaf è detta essere il teatro dell’eccelsa virtù, dove ognuno può imparare i primi rudimenti di una vita onorevole.
Il discorso di Calliope è costruito come una serie di domande formulate per amplifica-re il concetto che la poesia epica è chiamata a celebrare non solo le gloriose imprese militari del passato (evocate dall’Iliade di Omero, dalla Farsalia [Bellum civile] di Lucano e dalla Tebaide di Stazio), ma anche coloro che si sono distinti per meriti morali e spirituali, ciò che è un luogo comune della poesia panegirica in onore di Krokovs’kyj. Questa affermazio-
43 Anche nel senso di ‘si adattarono a lui’.44 L’ipotesi che l’autore si possa riferire a Antonij il fondatore, insieme a Feodosij, del Mona-
stero delle Grotte di Kiev, anche se non è da scartare del tutto, ci pare improbabile visto il contesto classico-pagano dei personaggi citati come modelli di virtù.
45 Come tiranno di Samo (538-522 a.C.), Policrate vi costruì un acquedotto, un grande tem-pio a Hera, e un palazzo. Nel 522 egli celebrò un’inusuale doppia festa in onore dell’Apollo di Delo e di Delfi. Sotto il suo governo Samo attirò scultori, scienziati e poeti, fra i quali Anacreonte.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 261
ne, richiamando l’attenzione sulla poesia di Turobojs’kyj, attesta la sua comprensione del perfetto eroe e dell’espansione del tema eroico di cui ho detto su.
Che una vittoria morale sia superiore ad una militare è anche sottolineato dall’acco-stamento, attraverso poliptoti, di parole con la radice di “victoria”, quali “vincere”, “victor”, “victrix”: in uno stesso verso, cioè nei versi 183 e 187, troviamo le parole “victrix” e “virtus”, e “vincerit” e “virtus” rispettivamente. Questo accostamento, anche attraverso l’allittera-zione, crea una potente associazione fra la virtù e la vittoria sui propri sensi e le proprie passioni che la prima permette di raggiungere. Inoltre, nei versi 184-186, la musa afferma che solo coloro che sono capaci di governare le redini di un animo contenuto, frenato (cioè solo quelli che coltivano la virtù) sono capaci di ottenere vittorie militari. Dal momento che il personaggio qui celebrato è l’archimandrita del più importante monastero ortodosso dell’Etmanato, è sottinteso che la vittoria viene da Dio. Cf. i versi 161-194:
Vix sacro Clio finivit ab ore loquelas Scalpriger interea chalibem marmorque subornat Calliopè, nostramque movent miracula mentem. Quo tandem properet seu quos heroas amico 165 Carmine contendat celebrare ac marmore duro Nec latuit divam mens nostra attonita vatem Subridensque sacro nobis haec ore locuta: Quid tandem nostros vates miraris ad actus? Quid dubiumve movent scalprumque silexque?170 Haeccine sola putas scuamato credita Marti? Nervum clara aut tantum nota acta referre Quos Bellona sua victores aegide fecit Aut quos Iliace celebrat victoria Troiae, Bellaque Pharsaliae, celebris vel diruta Thebeis? 175 Credita non tantum saxo mea scalpra fatigat Gloria Archivorum, aut victor post bella Gradivus, Famae vivacis pernotos ire nepotes Altum sollicitans multo gravate46 cothurno; Gestit et innocuus sua victor saxa iugali 180 Refrenare, quibus solido det nomina seclo. Nec melius saevus victores ensis adaptat Sero laudandos post praelia crede nepoti Quam victrix proprij virtus firmissima sensus. Non qui devictis dominatur gentibus, at qui185 Frenati felix animi moderatur habenas Carpaciam molem in sua mandat lucra revinci. Vincerit47 effrenos natu Krokovia virtus,
46 Cioè “gravatae”.47 Errato per “vicerit”.
262 Giovanna Siedina
Cum sensus, animos libitu pro rite gubernans, Praefixam valeant haud quo transcendere metam, 190 Marmora dura fero scalpro scindenda profundè: Altius aeternae teneant quo stigmata famae. Krokovi faciamque orbi fluitare verendum Nomen marmoribus, laudum non absque trophaeis. Protulit innocuae posuitque silentia linguae.
Non appena Clio terminò di parlare dalla sacra bocca Come un cesellatore nel frattempo prepara una spada e il marmo Calliope, e i miracoli muovono la nostra mente. Dove dunque la divina profetessa si affretti o quali eroi si 165 Sforzi di celebrare con il carme amico e con il duro marmo Alla nostra mente attonita non sfuggì, E sorridendo ci disse queste cose con la sacra bocca: “Perché infine o vate guardi meravigliato ai nostri atti? O quale dubbio muovono lo scalpello e la selce?170 Queste sole cose ritieni affidate allo squamoso Marte? Che l’arco riferisca soltanto i fatti illustri e noti, Gli uomini che Bellona rese vincitori con il suo scudo, O quelli che la vittoria di Troia celebra in troiano, E le guerre della Farsalia, o le distruzioni della celebre Tebe?175 Affatica i miei scalpelli con la pietra non solo la gloria degli Achei e me affidata, o Marte vincitore dopo le guerre, Che sollecita i notissimi nipoti di vivida fama, gravata da un Pesante coturno, ad andare in alto mare; Anche l’innocente vincitore desidera mantenere le sue pietre180 Per la moglie, con le quali possa dare i nomi a un tempo solido. Né, credimi, la feroce spada prepara vincitori, che Dopo le battaglie tardivamente il nipote dovrà lodare, meglio48
Della virtù fermissima, vincitrice del proprio senso. Non chi domina su popoli sconfitti, ma chi felice modera185 Le briglie di un animo frenato, comanda che la mole Carpata sia vinta a suo vantaggio. La virtù krokoviana avrà vinto gli sfrenati per nascita, dal Momento che conduce i sensi e gli animi secondo la propria volontà In modo giusto, affinché non riescano a superare la meta 190 Prefissata. Porto marmi duri da scindere profondamente con Lo scalpello: affinché più in alto tengano i segni di una fama eterna. E farò fluttuare nel mondo con i marmi il reverendo nome Di Krokovs’kyj, non senza trofei di lodi”. Questo svelò e impose il silenzio all’innocua lingua.
48 Il senso dei versi 181-183 è che la spada non produce più vincitori della virtù.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 263
L’accento posto sulla superiorità delle vittorie morali su quelle militari nelle parole di Calliope non è casuale anche tenendo conto dell’anno in cui il poema fu scritto, il 1699. Effettivamente, i tre anni precedenti avevano visto un massiccio spiegamento di forze degli eserciti russo e ucraino cosacco, con la partecipazione dell’etmanno Mazepa, per conquistare le fortezze di Kizikermen e Azov. L’assedio alle fortezze, particolarmete a quella di Azov, ave-va causato numerose vittime. Oltre a ciò, la partecipazione delle forze ucraine cosacche alle campagne della Russia contro la Turchia e la Crimea era stata quasi una costante del governo di Mazepa. In aggiunta, non era ancora svanita la memoria del periodo della Rujina, che per circa 30 anni (1657-1687) aveva precipitato l’Ucraina in una spirale di conflitti intestini, violenza e crescente declino. E pertanto la costante, quasi quotidiana esperienza del conflitto armato è certamente alla base del desiderio di pace che traspare dai versi 161-193. Tuttavia, oltre a questo, l’idea centrale, espressa nei versi 184-186, è che anche le vittorie militari sono portate dalla virtù: una simile idea viene espressa da Turobojs’kyj nel suo manuale di retorica del 1700, Cornucopiae artis oratoriae…49, in un sermone sulla saggezza, Oratio in laudem Sa-pientiae. Il concetto centrale dell’orazione è contenuto nella frase di Cicerone, sulla quale è costruita: “Sapientia nihil est praestantius” (“Niente è più eccellente della saggezza”). Dopo aver lungamente argomentato i frutti della saggezza e dell’ingegno, l’autore afferma che solo la saggezza permette vittorie militari che sono stabili e il cui risultato è duraturo. Nell’asser-zione sull’impossibilità di ottenere stabili vittorie senza la sagezza, si può leggere anche un implicito desiderio di pace, perché solo quest’ultima può permettere di coltivare la saggezza. Dell’opinione di Krokovs’kyj a questo riguardo è testimonianza il suo appello alla pace, di alcuni anni più tardi, contenuto nell’Introduzione da lui scritta all’edizione del 1702 del Paterik del Monastero delle Grotte50. Come ha evidenziato Marker, attraverso un abile uso di allegorie e citazioni bibliche, e attraverso la narrativa visuale a lui offerta da una incisione commissionata per questa edizione, Krokovs’kyj, mentre celebra Pietro vittorioso sull’Otto-mano infedele, al tempo stesso lo invita a desistere dall’imbarcarsi in nuove guerre di offesa.
La parte conclusiva del poema è incentrata sulla glorificazione di Joasaf come ‘pro-tettore’ della Vergine del Monastero delle Grotte, alla quale Turobojs’kyj si augura che l’archimandrita Krokovs’kyj conferisca una nuova età dell’oro.
3.2. Infine, una serie di considerazioni sulla virtù attinenti al nostro tema si trova-no nell’orazione panegirica di Ivan Narol’s’kyj, scritta in occasione dell’elezione di Joasaf Krokovs’kyj a metropolita (cf. Siedina 2012, cap. 4)51.
49 Così recita il titolo completo: Cornucopiae artis oratoriae omni genio eloquentiae fructu ad genium et ingenium gentis Roxolanae accomodo. Fecundae in Kijovo Mohilaeani Athaenei promptua-rio neo Rhetori oblatae anno quo faecunda Virgo Puritatis fructum generi humano salutiferum propo-suit. 1700. Il manoscritto si trova alla NBU, IR, collocazione ДС/ п 240.
50 Cf. Marker (in corso di stampa): 16-29.51 Quest’opera, che si compone, oltre all’orazione, di due panegirici in versi che si trovano ri-
spettivamente prima e dopo di essa, è conservata alla sezione manoscritti della biblioteca dell’Acca-
264 Giovanna Siedina
Il tema principale attorno al quale essa è costruita è quello della virtù, come afferma il poeta stesso: “Prima est Eloquentiæ meæ materia Tuas prædicare Virtutes” (“La prima ma-teria della mia eloquenza è predicare le tue virtù”). L’autore si serve di molteplici citazioni di autori latini e neo-latini per sostenere i suoi argomenti. Così, egli apre la sua prolusione con una citazione un po’ modificata di Seneca “Virtus extollit hominem, et supra astra locat mortales”52 (“la virtù eleva l’uomo e pone i mortali sopra gli astri”), e così facendo sot-tolinea subito l’appartenenza di Krokovs’kyj alla sfera divina. E infatti è lo splendore della luce che promana dalle virtù di quest’ultimo a illuminare la mente del poeta, ed esso è detto essere ancora più potente della luce emanata dal sole, personificato da Febo: in quest’af-fermazione è percepibile l’allusione alla supremazia delle virtù e della protezione cristiana rispetto a quelle pagane. Così infatti afferma l’autore: “Felix est, qui illustribus Phæbi exhi-laratur radijs: felicior inquam, dum qui illustrioribus supremâ Luce splendentium virtutum Tuarum fulgoribus solennes Tibi ad Electam Tua53 Archipræsuleæ virtutis coronationem animatur in applausus” (“Felice è chi viene rischiarato dagli illustri raggi di Febo; più felice, dico, chi, dai fulgori delle tue virtù splendenti, più illustri della suprema Luce, viene inco-raggiato da te a solenni applausi verso l’eletta incoronazione della tua virtù arcivescovile”). Proprio per il suo ruolo di difensore della virtù, l’autore afferma che l’ascesa di Krokovs’kyj al soglio metropolitano è stata il frutto di un volere unanime sia di Dio, sia del popolo e sia del clero ortodosso, che lui riassume con una sineddoche nel termine “religio”.
Quello che però è il sommo merito di Joasaf è il modo in cui esercita le sue virtù e dispiega le sue opere, e cioè la sua umiltà, che con un’espressione iperbolica l’autore dice destare lo stupore del mondo e del genere umano. Così, il suo occupare il primo posto, la dignità metropolitana, per grandezza è accostato al suo porsi per ultimo per umiltà (“Stu-pet orbis humanumque miratur genus, infimâ in humilitate siquidem magnas geras virtu-tes, præclara exerceas opera, et tam humilis altum ascendas Honoris subsellium, postremus humilitate, primus Magnitudine Primatem Dignitatis Principem occupas gradum” - “Il mondo si stupisce e il genere umano si meraviglia, poiché in infima umiltà porti grandi virtù, eserciti chiarissime opere, e così umile ascendi l’alto soglio dell’Onore; ultimo per umiltà, primo per grandezza, occupi il primo e più alto grado della dignità”).
L’autore ricorda quindi brevemente l’elezione di Joasaf, e l’unanimità della sua ac-clamazione da parte di una grande folla al suo arrivo alla cattedrale di Santa Sofia, centro storico della metropolia kieviana, è sottolineata da una citazione di Marziale riferita all’im-peratore Tito:
demia delle Scienze dell’Ucraina di L’viv (L’vivs’ka naukova biblioteka Akademiji Nauk Ukrajiny im. V. Stefanyka), con la collocazione Fond Bavorovs’kyj, N. 851.
52 La modifica è attribuibile al fatto che Seneca allude ai beni materiali, mentre il nostro autore vuole solo sottolineare il pregio della virtù. Cf. quanto afferma Seneca: “virtus extollit ho-minem et super cara mortalibus conlocat” (“la virtù eleva l’uomo e lo pone sopra le cose care ai mortali”) (Seneca, Epistulae Morales, LXXXVII, Lucilio suo salutem).
53 Probabile lapsus calami per “tuae”.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 265
Vox diversa sonat populorum vox tamen una Cum verus Patriæ, diceris esse pat er 54.
Suona una voce diversa dei popoli, e tuttavia una sola voce Allorquando sei detto essere il vero pa d r e della Patria.
Il carattere iperbolico di questa immagine, nelle intenzioni dell’autore, emerge dal confronto implicito dei due contesti: Marziale qui celebra l’inaugurazione del Colosseo da parte di Tito, e parlando della immensa arena, cita i popoli soggiogati da Roma e annessi al suo impero che il Colosseo è in grado di ospitare: le loro lingue molteplici, ma anche indistinte e confuse (diversa), sono come unificate nell’unica lingua che le accomuna, nella caratteristica acclamazione latina pater patriae55.
In questa espressione si percepisce l’augurio e il desiderio che Joasaf continui la politi-ca del suo predecessore Varlaam Jasyns’kyj di riorganizzazione, consolidamento e prosperi-tà morale e materiale della Chiesa ucraina. Infatti proprio Varlaam è nominato poche righe più sotto: l’autore, usando una citazione di Virgilio sottolinea infatti che come il nome di Joasaf e la sua elezione sono noti in molti luoghi (“Nobilis et fama multis memoratur in oris” – “Nobile e ricordato per fama in molte contrade”, Virg., Eneide, VII, 563)56, così l’Oriente e l’Occidente adoravano Varlaam. L’autore introduce poi una contrapposizione che è una costante nei testi dedicati a Joasaf Krokovs’kyj, ed era evidentemente un motivo e una preoccupazione abbastanza diffusa fra l’élite culturale kieviana, ossia quello dell’oppo-sizione fra virtù morali, potremmo dire, e virtù militari. Così, con similitudine iperbolica, Varlaam è detto avere un nome e una gloria più grandi di quelli del conquistatore del mon-do, il Macedone: infatti, mentre al primo spontaneamente gli animi si erano sottomessi grazie alla sua umiltà e alla sua celebrata virtù, il secondo aveva vinto il genere umano grazie alla forza delle armi.
Similmente Joasaf, che enfaticamente è detto essere venerato dai quattro continenti Asia, Africa, Europa, America, e dall’universo intero (“integer … orbis”), viene mostrato come colui che è capace di sottomettere gli animi umani non con la forza, ma con le frecce della clemenza. E per mostrare la superiorità della virtù e della sapienza rispetto alla forza delle armi, Narol’s’kyj ricorre ad una citazione che risale a Diogene Laerzio, ma con ogni probabilità è stata desunta dall’autore da altra fonte: “Ensis et clypeus excutiuntur, Sapiens autem ac virtute præditus nunquam non armatus est, adèoque vinci non potest”57 (“La spa-
54 Marziale, De spectaculis III, 11-12 (“Vox diversa sonat populorum, tum tamen una est / cum verus patriae diceris esse pater”).
55 Farrell 2001: 3-4. 56 Virgilio definisce così la valle dell’Ansanto in Irpinia.57 La citazione è stata probabilmente ripresa da Narol’s’kyj da fonte più tarda. Essa si trova,
ad esempio in una raccolta di Apophtegmata, ex probatis grecae latinaeque linguae scriptoribus a Conrado Lycosthene collecta…, 1602 (<http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/lycosthe-nes/lycosthenes1/Lycosthenes_ apophthegmata_2.html>), ed è attribuita al libro 6, cap. 1 (Anti-
266 Giovanna Siedina
da e lo scudo vengono strappati, ma l’uomo sapiente e dotato di virtù non è mai disarmato, e perciò non può essere vinto”).
Sulla linea della superiorità della virtù rispetto alla forza militare, Narol’s’kyj affer-ma che la massima protezione per gli esseri umani è proprio la virtù: “Virtus mortalibus maximum est scutum”: solo la virtù permette all’arcivecovo di trionfare senza combattere guerre, senza spargimento di sangue (“et citra bella sine sanguine triumphas” – “e trionfi senza guerre, senza sangue”).
Il discorso dell’autore introduce poi un altro concetto, quello che le cariche e gli onori debbono essere assegnati non per la propria appartenenza familiare, potremmo dire, ma per i propri meriti (“potiùs ego malim sanguini non plus debere, quàm meritis” – “io piut-tosto preferirei non più dovere al sangue, che ai meriti”). E Narol’s’kyj chiama M.K. Sar-biewski a supporto della sua affermazione che l’elezione debba essere dovuta alla sola virtù: “A virtute datis utar honoribus, tanquam deposito” (Lyr. II, 6) (“Mi servirò degli onori dati dalla virtù, come di un deposito”). Proprio per questo la porpora di Joasaf è detta essere più splendida della porpora tiria; amplificando la lode delle virtù di Joasaf, l’autore afferma poi che il neo metropolita è stato accolto dalla sophia, chiamata “erudita Princeps Ecclesiarum” (“erudita principessa delle Chiese”). Con il termine sophia l’autore si riferisce tanto alla cattedrale di Santa Sofia di Kiev, fulcro della metropolia kieviana, quanto alla Sapienza divina indicata nel titolo del primo panegirico. Il fatto che Joasaf sia portatore della sophia è significato anche, nel sottotesto, dall’allusione al topos del nome: infatti, facendo l’ana-gramma del nome Ioasaph si ottiene, anche se imperfettamente perché c’è una “a” in più, il nome sophia. Questo gioco di rimandi crea una stretta associazione fra l’arcivescovo e la volontà divina che lo ha voluto alla guida della metropolia kieviana.
Narol’s’kyj ritorna quindi, amplificandolo, al motivo con cui ha cominciato la sua ora-zione e cioè che è l’immensa virtù di Joasaf a conferire al retore la capacità di lodarlo: infatti afferma “ad superos vita non fama nos evehit” (“la vita, non la fama ci innalza verso i celesti”). Pertanto, nulla possono gli oratori che riempiono le loro orazioni di espressioni ampollose e di lodi sperticate (e con i quali l’autore sottilmente polemizza), e anche “Delphicus suo hic cum oraculo obmutesceret Apollo, et aurea Mercurij sileret facundia in ineffabili Tuæ virtutis et gloriæ præconio” (“l’Apollo Delfico qui rimarrà muto con il suo oracolo, e l’aurea facondia di Mercurio rimarrà silente nell’inesprimibile encomio della tua virtù e della tua gloria”). Proprio per sottolineare il carattere sovrumano delle virtù del metropolita, l’autore aggiunge poi l’epigrafe “Non plus ultra”. Utilizzando quindi abilmente la figura della preteri-zione, Narol’s’kyj dice che passerà sotto silenzio i meriti di Joasaf, e tuttavia poi si dilunga ad illustrare le buone ‘arti’ con le quali Joasaf istruisce la patria perché conduca una vita degna, e successivamente racconti ai posteri dei meriti dell’arcivescovo. Infatti, sottolinea l’autore,
stene) delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio. Questa stessa citazione si trova in un commentario ai Proverbi di Salomone R. P. Corn. Cornelii a Lapide e Societate Iesu, olim in Lovaniensi, postea in Romano Collegio Sacrarum Litterarum Professoris Commentarius in Salomonis Proverbia, Venezia 17172, cap. III: 53.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 267
come professore Joasaf non solo ha istruito i suoi discepoli nelle discipline da lui insegnate, sintetizzate nell’espressione “eruditae litterae” (e cioè poetica, retorica, filosofia), ma anche nel culto divino (teologia) e nella virtù sia privata che pubblica affinché conservassero onesti costumi. Così, se Joasaf è paragonato a Isocrate, celebre retore ateniese, maestro di molti uomini insigni, i suoi discepoli, le cui menti sono state plasmate grazie a lui, sono parago-nati a Teopompo (nato ca. 380 a.C.), famoso storico greco, discepolo di Isocrate. Cf.: “Hic labor, hoc opus Tuum erat, eruditis mentem Literis excolere, cùm fueris Professor Kijovo-mohileano in Collegio, Tuos discipulos arte bonâ, tam Divino cultu, quàm Sapientiâ, tam privatâ quam publicâ virtute morum proborum conservatores erudiebas. Isocratis profectò solers Tua disciplina erat, quâ non Effori [sic!]58 indigentes calcaribus, segnitieique supinæ dediti, verùm sublimes Theopompi ingenio prodiêre in solidius Patriæ Fulcrum, majus Dei suæque gloriæ incrementum, perennius Tui nomen, dignum sæculis, auro cedroque inscul-pendum” – “Questa era la tua fatica, questa la tua opera, di sviluppare la mente con lettere erudite, dacché fosti professore nel Collegio Kievo-Mohyliano, educavi i tuoi allievi con buona arte, tanto nel culto Divino, quanto nella Sapienza, tanto nella virtù privata quanto nella pubblica come conservatori di costumi onesti. Certamente la tua disciplina era solerte di Isocrate, con la quale non Efori indigenti di stimoli, e dediti alla supina inerzia, ma Teo-pompi sublimi per ingegno uscirono fuori, per un più solido fulcro della Patria, un maggiore accrescimento di Dio e della sua gloria, un più perenne nome tuo, degno dei secoli, da essere scolpito con oro e cedro”).
Nella parte finale della sua orazione, di nuovo Narol’skyj torna al tema principe, quello della virtù che unica è in grado di portare il genere dell’eloquenza ad altezze sublimi. Nuo-vamente l’autore ricorre ad espressioni e paragoni volutamente oltre il limite della verosi-miglianza, per sottolineare con veemenza la superiorità delle virtù cristiane di Krokovs’kyj, rispetto a personaggi famosi e a simboli della gloria dell’antichità pagana. Così, per le sue virtù la gloria di Joasaf è eccelsa e supera i simboli e i portatori della gloria romana; infatti: “In Te semper relucent Valerij illi gloriæ nomina Romanæ, Ducum Pupuræ, insignes in Te resplendent Regum Trabeæ, cùm primus omnia illa, virtute Tuâ superasti” (“In Te sempre rilucono quei Valeri nomi della gloria romana, le Porpore dei Generali, insigni risplendono in Te le trabee dei Re, in quanto per primo con la tua virtù hai superato tutte quelle cose”). Così, sono la virtù e la carica di Joasaf che parlano per lui, che tessono le sue lodi, e solo per la sua virtù e la sua generosità Joasaf vuole eccellere sugli altri mortali, cf.: “Gaudes legiti-me conscientiæ bonis, nullâque præterea re, quàm virtute, vis cæteris eminere mortalibus; adeoque cum Divina facias humanam sortem non erubescis.” (“Tu godi legittimamente dei beni della coscienza e, oltre a ciò, in nessuna cosa se non nella virtù tu vuoi eccellere sugli altri mortali; e invero facendo cose divine, non ti vergogni della sorte umana”).
58 Eforo (ca. 400-330 a.C.), come Teopompo, fu discepolo di Isocrate, ma assai meno bril-lante. Cicerone in Bruto 204 narra che Isocrate diceva di Eforo che aveva bisogno di sproni, mentre di Teopompo che necessitava di briglie. Questa stessa contrapposizione fra i due allievi di Isocrate riprende Narol’s’kyj.
268 Giovanna Siedina
4. Dai passi qui analizzati possiamo trarre alcune conclusioni che dovranno successi-vamente essere confermate o precisate dall’analisi di un corpo maggiore di testi nei quali viene elaborato il concetto di virtù.
Quello che accomuna le opere encomiastiche qui analizzate in onore di Ivan Mazepa e Joasaf Krokovs’kyj e che quindi sembra emergere come una concezione ampiamente diffu-sa e costante dell’élite religioso-cultrale ucraina del periodo seconda metà del XVII-prima metà del XVIII secolo, è la preminenza data alle virtù morali rispetto alla forza militare e alle sue conquiste. Nelle opere qui analizzate, infatti, si insiste sul fatto che le virtù morali (fra cui la sapienza, un sincero sentimento religioso, la prudenza, la magnanimità) e quindi la capacità di governare le proprie passioni in modo che esse non intralcino il sereno eser-cizio dell’ingegno, sono alla base di ogni raggiungimento, tanto nel campo della religione, che dell’istruzione, della cultura, e nella conquista e nell’esercizio del potere. Al tempo stesso, il fine di ogni esercizio della virtù, tanto nel campo delle arti e delle scienze, quanto in quello politico-militare, deve essere la glorificazione di Dio, che della virtù è il generoso dispensatore. Per questo le conquiste militari hanno valore solo se sono espressione delle virtù morali e intellettuali che vengono da Dio, altrimenti sono puro esercizio della forza il cui effetto e i cui risultati non sono destinati a durare a lungo. Questa concezione della vir-tù nella poesia e nella prosa neolatine qui analizzate è argomentata facendo frequente ricor-so a citazioni di autori latini e neolatini, e quindi attraverso una poetica delle reminiscenze che ha lo scopo, da un lato, di avvalorare quanto viene affermato, dall’altro di dimostrare che le ‘verità’ espresse dai classici citati hanno trovato viva ‘incarnazione’, si potrebbe dire, nella propria epoca e nella propria cultura.
Anche se la questione necessita di ulteriore approfondimento, ci sembra che la con-cezione della virtù che emerge dai testi qui analizzati rifletta una spiccata consonanza, da un lato, con la tendenza della filosofia rinascimentale che associava la saggezza speculativa con la virtù morale e l’azione civica, dall’altro con la definizione erasmiana della virtù come virtus cum eruditione liberali coniuncta, che Rice definisce “one idea of wisdom peculiarly characteristic of the Renaissance”59.
Bibliografia
Askočenskij 1856: V. Askočenskij, Kiev s drevnejšim ego učiliščem Akademieju, I-II, Kiev 1856.
Averincev 1972: S. Averincev, K ujasneniju smysla nadpisi nad konchoi central’noj apsidy Sofii Kievskoj, in: Drevnerusskoe iskusstvo i chudožestvennaja kul’tura domongol’skoj Rusi, Moskva, pp. 25-49.
Barvins’kyj 1920: B. Barvins’kyj, Slidamy hetmana Mazepy, “Zapysky Naukovoho To-varystva im. Ševčenka”, CXXIX, 1920, pp. 119-123.
59 Rice 1958: 213-214.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 269
Brogi 2004: G. Brogi, The Hetman and The Metropolitan. Cooperation Between State and Church in The Time Of Varlaam Jasyns’kyj, in: G. Siedina (a cura di), Mazepa e il suo tempo: storia, cultura, società – Mazepa and His Time: History, Culture, Society, Alessandria 2004, pp. 417-444.
Curtius 1979: E.R.Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, trad. dal tedesco di W.R. Trask, London-Henley 1979.
Farrell 2001: J. Farrell, Latin Language and Latin Culture: From Ancient to Mo-dern Times, Cambridge 2001.
Hardison 1962: O.B. Hardison Jr., The Enduring Monument. A Study of the Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Practice, Chapel Hill 1962.
Kameneva 1959: T.N. Kameneva, Černigovskaja tipografija, ee dejatel’nost’ i izdanija, “Trudy Gosudarstvennoj biblioteki SSSR im. V.I. Lenina”, III, 1959, pp. 224-383.
Manfredi 1993: V.M. Manfredi, Le isole fortunate. Topografia di un mito, Roma 1993.
Marker 2010: G. Marker, Staffing Peter’s Church: Organizational Politics and the Journeys of Kyivan Clergy in the Early Eighteenth Century, “Kyjivs’ka Akademija”, VIII, 2010, pp. 79-91.
Marker (in corso di stampa): G. Marker, Love One’s Enemies: Ioasaf Krokovs’kyi’s Advice to Peter in 1702, “Harvard Ukrainian Studies”, XXIX, 2007, 1-4 (in corso di stampa).
Masljuk 1983: V.P. Masljuk, Latynomovni poetyky i rytoryky XVII-Peršoji polovyny XVIII st. ta jich rol’ u rozvytku teoriji literatury na Ukrajini, Kyjiv 1983.
Mycyk 2004: O.Ju. Mycyk, Hetman Ivan Mazepa jak pokrovytel’ Pravoslavnoji cerkvy, in: G. Siedina (a cura di), Mazepa e il suo tempo: storia, cul-tura, società – Mazepa and His Time: History, Culture, Society, Ales-sandria 2004, pp. 401-416.
Niedźwiedź 2003: J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w., Kraków 2003.
Pontanus 1594: J. Pontanus, Poeticarum institutionum libri III, Ingolstadt 1594.
Pylypiuk 2004: N. Pylypiuk, The Face of Wisdom in the Age of Mazepa, in: G. Siedina (a cura di), Mazepa e il suo tempo: storia, cultura, società – Mazepa and His Time: History, Culture, Society, Alessandria 2004, pp. 367-400.
Pylypiuk (in corso di stampa): N. Pylypiuk, Catherine of Alexandria’s Crown of Golden Liberty, in: Ukraine and Europe: Cultural Alternatives, Encounters and Negotia-tions (in corso di stampa)
Radyszewski 2004: R. Radyszewski, Hetman Mazepa w polskojęzycznych panegirykach Jana Ornowskiego i Filipa Orłyka, in: G. Siedina (a cura di), Mazepa e il suo tempo: storia, cultura, società – Mazepa and His Time: History, Culture, Society, Alessandria 2004, pp. 489-502.
270 Giovanna Siedina
Rice 1958: E.F. Rice Jr., The Renaissance Idea of Wisdom, Cambridge, Mass. 1958.
Sarbiewski 1684: M. Sarbiewski, Lyricorum Libri IV, Cambridge 1684.
Sazonova 2004: L.I. Sazonova, Getman Mazepa kak obraz panegiričeskij: iz poetiki vostočnoslavjanskogo barokko, in: G. Siedina (a cura di), Mazepa e il suo tempo: storia, cultura, società – Mazepa and His Time: History, Culture, Society, Alessandria 2004, pp. 461-487
Scaliger 1561: J.C. Scaliger, Poetices Libri septem, Lyon 1561.
Siedina 2007: G. Siedina, Un poema epico neolatino su Ivan Mazepa, “Studi Slavisti-ci”, IV, 2007, pp. 85-115 (on-line al sito: <http://ejour-fup.unifi.it/index.php/ss/article/view/2123/2044>).
Siedina 2008: G. Siedina, Bellica virtus: la celebrazione di Ivan Mazepa nelle poetiche kieviane. Spunti di riflessione, in: M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina (a cura di), Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff, II, Firenze 2008, pp. 571-581.
Siedina 2012: G. Siedina, Joasaf Krokovs’kyj nella poesia neolatina dei suoi contempo-ranei, Bologna 2012.
Silvestre 1962: H. Silvestre, Un cliché per étudié: “Fortis in armis”, “ALMA (Archi-vum Latinitatis Medii Aevi)”, Bulletin du Cange, XXXII, 1962, pp. 255-257 (consultabile on-line al sito: <http://hdl.handle.net/2042/3172>)
Sumcov 1885: N. Sumcov, Istorija južno-russkoj literatury XVII veka, I, Charkiv 1885.
Il concetto di virtù nella celebrazione epico-panegirica nella letteratura neolatina ucraina 271
Abstract
Giovanna SiedinaThe Concept of Virtue in Ukrainian Neo-Latin Еncomiastic Literature (End of the 17th-Beginning of the 18th century)
The present article illustrates the ways in which Latin literature is used to express the con-cept of virtue in Ukrainian Neo-Latin eulogistic poetry and prose devoted, respectively, to a repre-sentative of military-political power (hetman I. Mazepa) and of religious-ecclesiastical authority ( J. Krokovs’kyj). From the textual analysis, it emerges that moral virtues are given preeminence over military power and its victories. The texts analysed also stress the need for moral virtues (among which wisdom, sincere religious feeling, prudence, magnanimity) for all achievements, in the fields of religion, education and culture, as well as for conquering and exercising power.
The author stresses quotations from Latin and Neo-Latin authors that poets and orators ad-duce to demonstrate the above-mentioned thesis. She also throws light on how literary reminis-cences are used, on the one hand, to ‘validate’ what is being asserted, on the other, to demonstrate that the ‘truths’ expressed by the Classical authors cited have found living ‘incarnation’, as it were, in one’s own time and one’s own culture. Although the issue requires further in-depth analysis, the concept of virtue that emerges from the texts analysed seems to reflect a marked consonance, on the one hand, with that tendency of Renaissance philosophy that associated speculative wisdom with moral virtue and civic action, on the other with the Erasmian definition of virtue as virtus cum eruditione liberali coniuncta, which Rice defines as the “one idea of wisdom peculiarly characteristic of the Renaissance”.
Keywords
Neo-Latin Poetry; Early-Modern Ukrainian Literature; Ivan Mazepa; Ioasaph Krokovs’kyi.