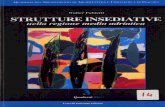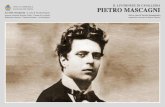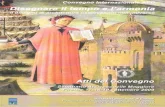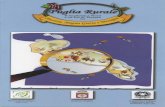Prima della Puglia. Terra di Bari e il sistema regionale in età moderna
I gastaldi nella Puglia longobarda
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of I gastaldi nella Puglia longobarda
BIZANTINI, LONGOBARDIE ARABI IN PUGLIA
NELL’ALTO MEDIOEVO
Atti del XX Congresso internazionale di studiosull’alto medioevo
Savelletri di Fasano (BR), 3-6 novembre 2011
2012
VITO LORÉ
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA
1. Prima di entrare nel merito dell’argomento, sono necessariedue premesse minime. Prenderemo in esame le testimonianze re-lative in generale agli ufficiali ducali e principeschi, quindi nonsolo i gastaldi, a vario titolo presenti sul territorio apulo, o in rela-zione con esso. Come vedremo subito, in alcuni contesti non èinfatti possibile distinguere con precisione fra compiti e prerogati-ve dei gastaldi e di altri ufficiali.
La seconda premessa riguarda la documentazione. Essa consistein primo luogo di diverse decine di atti, in rari casi pervenuti intradizione diretta, per la maggior parte trascritti in cartulari mona-stici. Per un primo periodo, che copre buona parte dell’VIII seco-lo, si tratta quasi esclusivamente di diplomi ducali e principeschi,noti quasi tutti attraverso il Chronicon di S. Sofia di Benevento 1.S. Sofia ricevette anche donazioni da privati, ma la tradizioneconfluita nel Chronicon ce ne conserva memoria solo attraverso idiplomi principeschi di conferma 2, secondo una precisa scelta di
Ringrazio Jean-Marie Martin per alcune preziose osservazioni in margine al testoletto a Savelletri.
1. Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), I-II, a cura di J.-M. MARTIN, conuno studio sull’apparato decorativo di G. OROFINO, Roma, 2000 (Fonti per la storia del-l’Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores, III*-III**). I diplomi dei duchi di Bene-vento, in gran parte giuntici attraverso il Chronicon, sono stati editi anche in Codice Di-plomatico Longobardo, a cura di L. SCHIAPARELLI e C. BRÜHL, IV/2, I diplomi dei duchi diBenevento, a cura di H. ZIELINSKI, Roma, 2003 (Fonti per la Storia d’Italia, LXV).
2. Vedi per esempio Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), II, 14 (719); III, 4 (748);III, 30 (742) = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), nn. 5, 32 (questi due casi so-no un incrocio « tra charta e precetto ducale »), 16; Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota1), I, 4 (774); I, 12 (774); I, 17 (774). Molti altri esempi riportati ibid., in I, 1. Del restola sezione del codice che comprende il cartulario vero e proprio porta il titolo di Liber
VITO LORÉ250
selezione documentaria. A partire dall’inizio del IX secolo la seriedei diplomi si interrompe quasi del tutto, sia per S. Sofia che nel-le altre tradizioni di Montecassino e di S. Vincenzo al Volturno,fino a quel momento ancora balbettanti; compaiono invece nu-merosi gli atti privati, perlopiù donazioni pervenuteci attraverso ilChronicon Vulturnense 3 e la variegata documentazione cassinese,che comprende per il IX secolo originali variamente editi, riferi-menti a documenti perduti in testi narrativi, primi fra tutti i Chro-nica Monasterii Casinensis, e le trascrizioni contenute nel Registrodi Pietro Diacono, di cui Jean-Marie Martin sta coordinando l’e-dizione 4. A partire dalla fine degli anni trenta del IX secolo ri-prende la serie dei diplomi principeschi, ma la documentazionerelativa alla Puglia longobarda conosce complessivamente una de-cisa flessione, che segna anche la fine della nostra indagine.
La sfasatura fra i due blocchi di testimonianze non è soltantocronologica, ma anche geografica. Il grosso delle donazioni privateviene dalla Puglia centromeridionale, mentre i diplomi copronopiù fittamente la Puglia settentrionale. In ultimo le fonti narrative:l’Ystoriola di Erchemperto 5 e il più tardo Chronicon Salernitanum 6
ci parlano in modo dettagliato delle figure e soprattutto delle pre-rogative militari di alcuni gastaldi, fra cui quelli di Acerenza, al li-mite estremo dell’area che qui ci interessa, in un territorio quasi
preceptorum: il riferimento ai diplomi (praecepta) come oggetto unico della compilazione èesplicito.
3. Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, I-III, a cura di V. FEDERICI, Roma,1925-1938 (Fonti per la Storia d’Italia, LVIII-LX).
4. Qui si farà riferimento a documenti editi soprattutto in E. GATTOLA, Ad historiamabbatiae Cassinensis accessiones..., I, Venetiis, 1734, rist. an. Cassino, 1994; E. CUOZZO eJ.-M. MARTIN, Documents inédits ou peu connus des archives du Mont-Cassin (VIIIe-Xe siècles),in Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge, CIII (1991), pp. 115-210; e a notiziedesunte dai Chronica Monasterii Casinensis, hrsg. von H. HOFFMANN, in M.G.H., Scripto-res, XXXIV, Hannover, 1980. Fondamentale per il censimento e la corretta datazionedella documentazione d’archivio meridionale dell’VIII e del IX secolo è J.-M. MARTIN
et alii, Regesti dei documenti dell’Italia meridionale 570-899, Roma, 2002 (Sources et docu-ments d’histoire du Moyen Âge, V).
5. ERCHEMPERTUS, Historia Langobardorum Beneventanorum, curante G. WAITZ, inM.G.H., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hannover, 1878, rist.an. ibid., 1964, pp. 234-264.
6. Chronicon Salernitanum, ed. U. WESTERBERGH, Stockholm, 1956 (Acta UniversitatisStockholmensis. Studia Latina Stockholmensia, III).
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 251
del tutto non coperto dalla documentazione d’archivio. È un mo-saico da ricomporre con attenzione. L’immagine che ne uscirà sa-rà molto sfumata: le presenze fisiche di gastaldi e altri ufficiali nel-la Puglia longobarda erano probabilmente meno numerose diquanto a prima vista la documentazione farebbe credere e il lororuolo per diversi aspetti sfuggente.
2. La geografia amministrativa della Puglia longobarda dovevaessere molto complessa, espressione delle diverse densità e destina-zioni delle proprietà fiscali. Come Jean-Marie Martin ha notatosulla scorta di alcune osservazioni di Pierre Toubert 7, la termino-logia dei diplomi ha più a che fare con la gestione fondiaria checon il governo del territorio, per la Puglia come per tutto il duca-to beneventano. Actus, iudiciaria, subactio – un termine su cui tor-neremo fra poco – sono innanzitutto ripartizioni del fisco ducale.In effetti, nella documentazione di VIII secolo, questo è pratica-mente l’unico aspetto visibile, rimanendo del tutto in ombra leprerogative militari e giurisdizionali degli ufficiali e, più in gene-rale, i modi del governo territoriale. Questo prevalente aspettofondiario dà conto di alcune particolarità. In alcuni casi l’actus nonsembra avere un capoluogo ed è determinato in relazione a untoponimo rurale o al nome del titolare. Così, per esempio, l’unicaspecificazione dell’actus comprendente la selva, concessa nel 747dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano in Strata, probabil-mente situato presso Taranto, è il riferimento al suo titolare, il ga-staldo Rotulus (un nome che avvicina alla servitù rurale più che al-la nobiltà beneventana dell’VIII secolo) 8; invece fra la Puglia set-tentrionale e il Molise attuali l’actus Silva Nigra e l’actus Raiano
7. J.-M. MARTIN, La Pouille du VIe au XIIe siècle, Roma, 1993 (Collection de l’ÉcoleFrançaise de Rome, CLXXIX), nota 398 a p. 227. Sulle istituzioni della Longobardiameridionale, più recentemente IDEM, La Longobardia meridionale, in Il regno dei Longobardiin Italia. Archeologia, società, istituzioni, a cura di S. GASPARRI, Spoleto, 2004 [Istituzioni esocietà, IV], pp. 337-339 sul ducato, 344-345 sul principato.
8. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), II, 19: « qualiter nominata silba a Rotulogastaldio nostro per nostram iussionem vobis tradita est, qui fuit de acto nominati Rotu-li » = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), n. 31. Un condoma di nome Rotulus,residente « in Canni » (forse Canne della Battaglia, presso Canosa), fu concesso nel 774da Arechi II a S. Sofia, che contestualmente fu confermata nel dominio sullo stesso mo-nastero di S. Stefano in Strata: Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), I, 8.
VITO LORÉ252
comprendevano estensioni di terre incolte, i gualdi, oggetto nel-l’839 delle concessioni del principe Radelchi I al suo tesoriereTotone 9. Ma in generale l’actus è sempre evocato come partizio-ne delle proprietà pubbliche e il titolare come amministratore delfisco, anche quando egli controlla spazi ampi, a volte di molto ec-cedenti un singolo territorio cittadino. Nel 747, contemporanea-mente alla selva del gastaldo Rotulus, il duca Gisulfo II concesse almonastero di S. Stefano in Strata due schiavi « de actu Canusino,quam modo Theutpald gastaldio nostro tenere videtur » 10. Nel764 il duca Arechi II concesse al gastaldo Muncolanus due schiavi« de atto Cassianense, quem modo Cunari gastaldio nostro tenerevidetur » 11. Sono di certo il taglio alto, il carattere pubblico delladocumentazione conservata dal Chronicon Sanctae Sophiae a faremergere con prepotenza l’aspetto fondiario delle istituzioni duca-li sul territorio; ma non si tratta probabilmente di una casualità.Nel regno di Pavia i diplomi regi assai raramente fanno riferimen-to ad actus o iudiciariae per localizzare i beni fiscali oggetto delleconcessioni 12, eppure sono del tutto analoghi per tipologia e con-tenuto a quelli del Chronicon.
Torniamo ora alla Puglia. Il Nord della regione pare il cuoredel fisco ducale, come emerge dalla serie dei diplomi dei duchi 13
9. Ibid., III, 35.10. Ibid., II, 20 = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), n 29. Sull’estensione
del distretto canosino vedi più avanti, testo corrispondente a nota 94.11. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 29.12. In Codice diplomatico longobardo, III/1, a cura di C. BRÜHL, Roma, 1973 (Fonti per
la Storia d’Italia, LXIV), n. 44 (772) si fa riferimento a « Spoletinis, Firmanis, Ausemaniset Beneventanis finibus », a « finibus Reatinis » e a « finibus Pennensis » per localizzarebeni di varia provenienza, non tutti fiscali. Nei diplomi dei duchi di Spoleto editi inCodice diplomatico longobardo, a cura di C. BRÜHL, IV/1, Roma, 1981 (Fonti per la Storiad’Italia, LXV) sono frequenti i riferimenti a territoria e a fines per la localizzazione deibeni pubblici concessi (cfr. per es. nn. 3, a. 745; 5, a. 746; 16, a. 761; 19, a. 766 ecc.).Sulla struttura del regno longobardo vedi S. GASPARRI, Il regno longobardo in Italia. Struttu-ra e funzionamento di uno stato altomedievale, in Il regno dei Longobardi in Italia cit. (nota 7),e in particolare le pp. 22-42 sul fisco regio e ducale nel regno e su altre fonti regie direddito; S. M. COLLAVINI, Duchi e società locali nei ducati di Benevento e di Spoleto nel secoloVIII, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso internazio-nale di studi sull’alto medioevo (Spoleto-Benevento, 20-27 ottobre 2002), Spoleto,2003, pp. 159-163 specificamente sui ducati di Spoleto e di Benevento.
13. Le attestazioni di proprietà pubbliche in territorio pugliese nei diplomi ducali so-
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 253
e com’è confermato dal denso dossier delle concessioni emanateda Arechi II nel 774 14, subito dopo la sua assunzione del titoloprincipesco, seguita alla conquista carolingia del regno longobardo.Nei diplomi di età ducale, insieme con la Puglia, sono largamentepresenti nell’assise fiscale la città di Benevento e l’area ad essa piùvicina, ma lì le concessioni riguardano spesso beni pervenuti al fi-sco da defunti, per mancanza di eredi o altro; beni, cioè, che nonrimanevano a lungo nel fisco, ma ritornavano subito in circolo. InPuglia gli actus erano numerosi e disomogenei. Accanto a partizio-ni minori, come Silva Nigra, troviamo actus più classicamente cen-
no le seguenti: I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), n. 4 (718); Chronicon SanctaeSophiae cit. (nota 1), II, 1 (724): Lesina; III, 31 (724): Ascoli Satriano; III, 9 (740): Si-ponto; II, 6 (745): presso Lesina; II, 20 (747): Canosa; II, 19 (747): Taranto? = I diplomidei duchi di Benevento cit. (nota 1), nn. 12, 13, 15, 24, 29, 31; Chronicon Vulturnense cit.(nota 3), I, n. 32 (754): Barletta, Bitonto = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1),n. 40. Beni fiscali nel territorio molisano più vicino alla Puglia: Chronicon Sanctae Sophiaecit. (nota 1), III, 30 (742): presso il torrente Saccione = I diplomi dei duchi di Beneventocit. (nota 1), n. 16. Beni fiscali a Benevento o dintorni e in altre aree del ducato: Chro-nicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), II, 14 (719): Salerno; III, 1 (720): Greci; II, 4 (721); I,22 (722): fra Avellino e Benevento; II, 3 (723): Benevento; II, 12 (723): Benevento; II,1 (724): Benevento; II, 2 (726): Benevento; II, 8 (742): Benevento; I, 23 (742): Bene-vento; I, 24 (743): Conza; II, 7 (744): Benevento; II, 6 (745): Benevento; II, 10 (751):Benevento; VI, [33] (752-755): Avellino; II, 15 (762): Caserta?; III, 29 (764): Cassano al-lo Jonio = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), nn. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17,18, 21, 23, 24, 34, 41, 45, 48; Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), I, n. 32 (754): Bene-vento e Frigento; I, n. 67 = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), nn. 40, 46(quest’ultimo con datazione corretta al 763).
14. Beni fiscali testimoniati in territorio pugliese nei diplomi di Arechi principe:Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), p. 279 (774): Lucera; I, 2 (774): Ascoli Satriano; I,5 (774): Siponto; I, 6 (774): Ascoli Satriano; I, 7 (774): Ascoli Satriano; I, 8 (774): Ta-ranto; I, 9 (774): Lucera-Montevergine; I, 11 (774): Salpi; I, 15 (774): Siponto; I, 18(774): Trani; I, 20 (774): Ascoli Satriano; I, 1, [3] (774): fra Ascoli Satriano e Candela; I,1, [6] (774): presso il Fortore; I, 1, [9] (774): presso Ostuni (?); I, 1, [11] (774): pressoMatera; I, 1, [22] e [69] (774); I, 1, [34] (774): presso il Fortore (?); I, 1, [36] (774): Can-ne. Beni fiscali testimoniati in territorio molisano prossimo alla Puglia: ibid., I, 1, [5](774): presso il Saccione; I, 1, [46] (774): Larino. Beni fiscali in altre aree del principatooltre alla Puglia: ibid., p. 283 (774): Liburia; I, 3 (774): Alife; I, 10 (774): Camposarcone(CB); I, 12 (774): Sessa; I, 16 e 19 (774): Conza; I, 1, [7] e [26] (774): presso il fiumeBiferno; I, 1, [25] (774): Rota (Mercato S. Severino); I, 1, [50] (774): Lucania; I, 1, [54](774): Salerno; I, 1, [64] (774): Benevento; I, 1, [65] (774): Maddaloni; I, 1, [66] (774):Prata Sannita (?); I, 1, [68] (774): Sessa.
VITO LORÉ254
trati su sedi urbane o castrali: Siponto 15 e Lucera 16. Figure di ga-staldi di livello sociale differente dovevano corrispondere a spazifra loro disomogenei per ampiezza, anche se non necessariamenteper densità di popolamento, come ha notato nella sua relazioneGiuliano Volpe 17. In particolare mi pare probabile che gli actusminori fossero spesso amministrati, oltre che da gastaldi, da agentidi più basso rango, come l’Annuni attionario che nel 724 sollecitòla conferma di quattro coloni da parte del duca Romualdo II diBenevento alla chiesa di S. Pietro « ad Aqua S. Potiti » 18; o comeil condoctor Virisano Giovanni, al cui figlio Trasulfo nel 789 19 ilprincipe Grimoaldo III confermava tutti i beni paterni. In un al-tro diploma dell’835 Virisano era definito insolitamente “territo-rio” e posto genericamente « in finibus Apulee »: una partizionedel fisco ducale minore e perciò più difficile da definire e da loca-lizzare, al contrario dell’actus di Lucera, al quale appartenevano glialtri beni concessi in quella stessa occasione a S. Sofia 20.
Tuttavia nei diplomi ducali la gran parte delle menzioni di ga-staldi e di altri ufficiali viene da riferimenti a una partizione del fi-sco ducale, detta subactio. Nel 724 i coloni confermati da Romual-do a S. Pietro « ad Aqua S. Potiti » risiedevano in località Gratianoe appartenevano alla subactio del già citato Annuni, che aveva an-che sollecitato il diploma ducale. Nel 740 il duca Godescalco con-cesse al suo tesoriere Anfrid lo schiavo Orso, con moglie e figli,« qui fuerunt de acto sipontino, de subactione Warnefrid gastaldeinostro » 21. Nel 749 il duca Gisulfo II concesse al tesoriere Orso un
15. Prima attestazione ibid., III, 9 (740) = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota1), n 15; cfr. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), p. 228.
16. Prima attestazione ibid., I, 9 (774); cfr. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), ibid..17. Cfr. G. VOLPE, Per una geografia insediativa ed economica della Puglia tardo antica, in
questo stesso volume.18. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 31 = I diplomi dei duchi di Benevento
cit. (nota 1), n. 13.19. Ibid., III, 2720. Ibid., I, 28. Si noti che in III, 34 (839) è definito conductor un servo del palazzo
principesco, concesso a un fedele di Radelchi I insieme con altri quattordici servi. An-che a Spoleto i conductores erano a volte di condizione non libera; gli actionarii erano in-vece ufficiali di livello superiore ai conductores e a volte protagonisti di carriere importan-ti. Cfr. COLLAVINI, Duchi e società locali cit. (nota 12), pp. 146-148.
21. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 9.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 255
condoma abitante in località Selece, « de subactione Cursuni scaurii », elo schiavo Fiorenzo, « qui fuet de subactione Trasari gastaldi et vesta-rario nostro » 22. Nel 774 il principe Arechi II offrì a S. Sofia una pe-schiera del Palazzo a Siponto, la chiesa di S. Eufemia e tre condome(cioè tre famiglie di dipendenti, con moglie e figli), specializzate nellaraccolta del sale e nella pesca, « qui fuerunt de subactione Hermerissigastaldio nostro » 23. In quello stesso anno, sempre a S. Sofia, Arechiconcesse una corte con dodici condome, « qui fuerunt de subactioneUrsi gastaldio nostro » nel territorio di Conza 24, esterno, ma prossi-mo all’area che ci interessa; si noti per inciso l’eccezionale uso di finesper designare il distretto, anziché i più consueti actus e iudiciaria: se neparlerà più avanti. Nello stesso 774 Arechi offrì un terreno in ungaio, un’estensione di terra incolta in via di dissodamento 25, « inCampo Senarcunis » (Camposarcone, presso S. Giovanni in Galdo,provincia di Campobasso), « qui fuit de subactionem Faroaldi mare-pais » 26. Ometto altre occorrenze di subactio in ambito apulo non so-lo per brevità, ma anche perché sono tratte dal primo documento delChronicon Sanctae Sophiae, riassunto di una settantina di concessioniarechiane, in forma molto breve e con qualche anacronismo. Il con-tenuto del diploma è storicamente attendibile, ma bisogna usarlo concautela come fonte per la terminologia istituzionale 27.
Che cos’è, dunque, la subactio e in che misura debba essere di-stinta dall’actus non è, a mio parere, ancora abbastanza chiaro. Ab-biamo già detto della prevalente sfumatura fondiaria nella termi-nologia amministrativa dei diplomi ducali. Io mi spingerei un pas-so più in là: riguardo al termine subactio, solo un occhio rivolto al-l’amministrazione fondiaria del patrimonio pubblico può dare
22. Ibid., III, 26.23. Ibid., I, 5. Sul significato di condoma nell’Italia meridionale longobarda vedi
MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), pp. 206-209 e L. FELLER, L’économie des territoires de Spo-lète et de Bénévent du VIe au Xe siècle, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento cit.(nota 12), in particolare le pp. 228-229.
24. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), I, 19.25. Cfr. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), pp. 194-199 su gualdum e gaium; FELLER,
L’économie des territoires de Spolète et de Bénévent cit. (nota 23), pp. 224 sgg..26. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), I, 10.27. Cfr. COLLAVINI, Duchi e società locali cit. (nota 12), nota 50, dove si osserva come
in età ducale il termine “gastaldato” compaia solo nella falsificazione che apre il Chroni-con e si attribuisce l’anomalia a un anacronismo del compilatore.
VITO LORÉ256
conto di evidenze documentarie altrimenti difficilmente interpre-tabili.
Subactio sembra avere un senso tecnico, piuttosto ristretto. Com-prende, salvo un caso, solo condome o schiavi, in ogni caso famigliecontadine considerate come unità di prelievo, sotto il controllo del-l’ufficiale. Non sembra coincidere con una circoscrizione, come giànotato da Simone Collavini 28: mentre l’actus può essere, ed è, solita-mente, definito in relazione a un capoluogo, un centro urbano o ca-strale (actus canosinus, actus sipontinus ecc.), e in ogni caso ha normal-mente una determinazione topografica, la subactio non ha una deter-minazione topografica ed è sempre definita soltanto in relazione al-l’ufficiale che ne è titolare. Certo, frequentemente è indicata la loca-lità di residenza delle famiglie contadine che la compongono, ma èaltra cosa: la specificazione di luogo riguarda propriamente quelle fa-miglie, non la subactio nel suo insieme. È quindi probabile, a mio av-viso, che la subactio non avesse di norma un assetto territorialmente,forse neanche spazialmente definito: di solito non ne facevano partegli altri oggetti che pure spesso compaiono a comporre il fisco ducalee principesco, i gai/gualdi e le chiese, individuate da Laurent Fellercome centri di popolamento di quelle terre in parte boschive e in-colte 29. Inoltre, se in alcuni casi la subactio era distinta dall’actus, in al-tri vi era invece compresa: la prima situazione era tipica della Pugliasettentrionale, la seconda della Puglia centromeridionale, dove l’actuscentrato su Canosa era particolarmente esteso. La probabile mancanzadi una configurazione territoriale, la composizione “puntuale”, la de-terminazione rispetto alle persone degli ufficiali fanno pensare non aspazi di governo, ma a rendite legate a un ufficio, tanto più che tito-lari di subactiones erano non solo gastaldi e actionarii, ma anche ufficialidi corte, come marpahis e tesorieri, dei quali è difficile ipotizzare unimpegno diretto nel governo del territorio 30. D’altronde queste figu-
28. Ibid., pp. 144-145, anche per l’interpretazione delle subactiones come « complessifiscali », da non intendersi « in senso rigidamente territoriale » (la citazione a p. 144).
29. FELLER, L’économie des territoires de Spolète et de Bénévent cit. (nota 23), pp. 224-225. Per una visione molto sfumata della contrapposizione fra aree coltivate e incolte fratardo antico e alto medioevo vedi in questo stesso volume il contributo cit. (nota 17) diG. VOLPE, con bibliografia.
30. Sugli ufficiali della corte beneventana vedi S. GASPARRI, Il ducato e il principato diBenevento, in Storia del Mezzogiorno, dir. G. GALASSO e R. ROMEO, II, Il Medioevo, 1, Na-
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 257
re di ufficiali di corte sono citate nell’VIII secolo in relazione con su-bactiones, non con actus 31. Da questo punto di vista la Puglia longo-barda è parte di un organismo più ampio, ma si tratta di una parteessenziale. Esiste, cioè, una specializzazione subregionale che fa dellaPuglia settentrionale l’area a maggiore densità di patrimoni fiscali, maanche di rendite destinate agli ufficiali. Condome o schiavi sotto il di-retto controllo del fisco ducale sono oggetto di più rade concessionianche in altre parti della Puglia, presso Barletta, per esempio, a Bi-tonto, o a Canne, ma spesso in quei casi i dipendenti non eranocompresi in una subactio 32.
Nel IX secolo il sistema sembra subire una profonda riorganizza-zione. L’asse del fisco ducale, forse meno ricco che nel passato recen-te (oppure meno numerose sono le concessioni principesche ai mo-nasteri), continua a includere il Nord della Puglia, ma sembra spo-starsi sul Molise e su spazi più vicini a Benevento e a Salerno 33. Iltermine subactio scompare dopo il 774 ed è sostituito da iudiciaria e ac-
poli, 1988, p. 106; COLLAVINI, Duchi e società locali cit. (nota 12), pp. 150-153, dove si no-ta la speciale relazione fra ufficiali palaziali e subactiones; MARTIN, La Longobardia meridio-nale cit. (nota 7), pp. 338-339, 344-345. La condivisione nel godimento delle risorse fi-scali darebbe anche conto della poca importanza, fra VIII e IX secolo, delle concessioniducali e principesche di beni fiscali in favore di alti ufficiali: cfr. J.-M. MARTIN, Élémentspréféodaux dans les principautés de Bénévent et de Capoue (fin du VIIIe siècle-début du XIe siè-cle): modalités de la privatisation du pouvoir, in Structures féodales et féodalisme dans l’Occidentméditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches. Colloque international(Rome, 10-13 octobre 1978), Roma, 1980 (Collection de l’École Française de Rome,XLIV), pp. 568-570.
31. Oltre ai casi già citati, vedi per esempio Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1),III, 1 (720): subactio del vestarario Orso; II, 11 (744): subactio del gastaldo e vestarario Se-condo; III, 26 (749): subactio del gastaldo e vestarario Trasari = I diplomi dei duchi di Bene-vento cit. (nota 1), nn. 7, 22, 33.
32. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), I, 8 (774); Chronicon Vulturnense cit. (nota3), I, n. 32 (754) = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), n. 40.
33. Proprietà del fisco in Puglia: Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 32 (833);I, 29 (834): Siponto; I, 28 (835): Lucera; I, 34 (841): Siponto; III, 24 (889): Siponto.Proprietà del fisco in Molise: ibid., III, 35 (839): presso il torrente Saccione; III, 36(840): Larino; I, 36 (878): Campobasso e Biferno. Proprietà del fisco in area beneventa-na: ibid., II, 21 (817): Benevento; III, 7 (826), 13 (833 o 836), 12 e 15 (838), 16 (845),17 (850): Foglianise; III, 14 (832): Forchia; VI, [32] (833): presso S. Giorgio del Sannio;II, 16 (840): presso Avellino; III, 18 (842): Benevento; I, 35 (858): Benevento; III, 21(867): Benevento; II, 22 (876): Ceppaloni; I, 30 (881): Venticano; II, 18 (881): Fogliani-se; I, 33 (881): Benevento; III, 20 (881): Benevento; II, 17 (882): Benevento; III, 19
VITO LORÉ258
tus con significato analogo, anche se non del tutto coincidente, per-ché la rendita legata all’ufficio è espressa ora in terre e non più in uo-mini. Così nell’821 Sicone concedeva venti moggi di terre forse dallaiudiciaria del mari pahis Douferio 34; nell’832 Sicardo concedeva quin-dici moggi a Forchia, dalla iudiciaria del gastaldo Pietro 35; nell’835 va-ri beni del palatium concessi dallo stesso Sicardo nella Puglia setten-trionale erano tratti dalla iudiciaria del gastaldo Azzo e da quella deltesoriere Radelchi 36. Sono attestazioni rare, fossili di un sistema dicondivisione e circolazione dei beni fiscali in profonda trasformazio-ne. Proprio gli esiti ultimi di quel sistema, ormai cristallizzato, sem-brano confermare a posteriori l’ipotesi complessiva formulata sulla si-tuazione di VIII secolo. Nel gennaio 838, con due diplomi, redattiuno a Benevento e l’altro ad Avellino 37, il principe Sicardo disposedi alcune famiglie contadine. Nel primo caso si trattava di parte delmari pansato di Roffrid, cioè di una dotazione legata all’ufficio di mar-pahis; nel secondo, forse meno esplicitamente ma con lo stesso senso,gli uomini erano definiti « de actu Attionis mari pahis nostri »; in en-trambi i casi gli uomini risiedevano a Foglianise. È impossibile dire se
(882): Vitulano. Altrove: ibid., I, 27 (834): Liburia; III, 34 (839): Cimitile; III, 33 (841):Maddaloni.
Vedi inoltre Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), I, n. 22 (778): Capua; I, n. 31 (810):Venafro; III, p. 93 (788-817): Liburia (cfr. MARTIN et alii, Regesti cit. (nota 4), n. 576); I,n. 58 (833): Venafro; I, n. 59 (836): Venafro; Chronica Monasterii Casinensis cit. (nota 4),I, 22 (828-832): Lesina (cfr. MARTIN et alii, Regesti cit. (nota 4), n. 619); T. LECCISOTTI,Antiche prepositure cassinesi nei pressi del Fortore e del Saccione, in Benedictina, I (1947), n. 4(837): presso il Fortore; Codex Diplomaticus Cavensis, I, curantibus M. MORCALDI, M.SCHIANI, S. DI STEFANO, Neapoli, 1873, inserto dell’832-839 nel n. 148 (928): Cava de’Tirreni (cfr. MARTIN et alii, Regesti cit. (nota 4), n. 659); Codex Diplomaticus Cavensis, II,curantibus M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DI STEFANO, Mediolani-Pisae-Neapoli, 1875,inserto dell’832-838 nel n. 23 (973): Fonti (cfr. MARTIN et alii, Regesti cit. (nota 4), n.667); inserto dell’839-849 in CUOZZO e MARTIN, Documents inédits ou peu connus cit. (nota4), n. 26. Escludo i diplomi di Siconolfo su cui MARTIN et alii, Regesti cit. (nota 4), ainn. 702 (845) e 727 (839-849, ma probabilmente verso l’850), perché all’epoca Salernoera (già) separata da Benevento, che è il centro politico di riferimento della nostraindagine.
34. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 8: il dettato del documento non èchiaro e della iudiciaria potrebbero far parte invece i servi palatini da cui alcuni liberiavevano acquistato le terre in questione.
35. Ibid., III, 14.36. Ibid., I, 29.37. Ibid., III, 12 e III, 15.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 259
la stessa dotazione sia passata da Roffrid ad Attione o viceversa, o sesi tratti di due dotazioni distinte e quindi insistenti contemporanea-mente sulla medesima località, come io tenderei a credere; in ognicaso, a distanza di pochi anni, nell’845 la principessa Garetruda, mo-glie di Radelchi I di Benevento, disponeva di un mari parsato com-prendente terre anch’esse a Foglianise. È con ogni probabilità unarendita in origine legata a un ufficio ed espressa in famiglie contadi-ne, poi convertita in forma di terre e passata alla regina, per la qualemi pare veramente difficile ipotizzare qui un ruolo di ufficialeterritoriale 38.
Se questa proposta di lettura è corretta, nel ducato longobardodi Benevento le modalità e l’ampiezza dell’accesso alle risorse fi-scali da parte degli ufficiali, attraverso una redistribuzione così seg-mentata e in parte centralizzata, costituiscono un elemento diprofonda originalità rispetto a quanto sappiamo per il ducato spo-letino 39 e per il regno, dove « la dimensione locale dello sfrutta-mento del fisco ... doveva essere largamente prevalente » e le te-stimonianze di risorse fiscali e introiti pubblici destinati agli uffi-ciali palaziali sono quasi assenti 40. Nello stesso tempo le presenzeeffettive di ufficiali sullo spazio beneventano divengono meno nu-merose e più evanescenti. È probabile che in molti casi l’ufficialetitolare di una subactio non fosse fisicamente presente sul territorio,ma integrasse nelle sue disponibilità dirette terre anche molto lon-tane dal centro del potere principesco e dalla sua residenza.
3. La documentazione privata che viene dai monasteri di S.Vincenzo al Volturno e di Montecassino, oltre a qualche preziosopezzo da archivi locali, ci consente di delineare almeno a grandilinee il contesto sociale degli ufficiali, in aree della Puglia diverserispetto a quelle più coperte dai diplomi di S. Sofia. Continuanoinvece a sfuggirci le modalità di governo del territorio. L’unica
38. Ibid., III, 16. Un altro mari passato, comprendente terre fra il Molise e la Pugliasettentrionale, in LECCISOTTI, Antiche prepositure cit. (nota 3), n. 4 (837).
39. Cfr. COLLAVINI, Duchi e società locali cit. (nota 12), soprattutto le pp. 159-163; a p.145 il caso, presentato come eccezionale, di un complesso fiscale retto da un marepahis.
40. GASPARRI, Il regno longobardo in Italia cit. (nota 12), pp. 26, 30 per le eccezionalitestimonianze dell’afferenza diretta di redditi pubblici al palatium di Pavia o a ufficialipalaziali; la citazione a p. 31.
VITO LORÉ260
traccia in proposito viene da un documento dell’archivio cavense,riferito dal suo ultimo editore a Sant’Agata di Puglia 41: nell’845 ilgastaldo Isenbardo tutela un soggetto debole, una vedova, assisten-dola nella vendita di un casale e di una casa a Benevento, parte delpatrimonio del marito.
Restano in maggiore evidenza le attività private degli ufficiali,grazie a un pugno soltanto di documenti, che collocati nel quadrocomplessivo del ducato ci mostrano però tratti di originalità deigastaldi pugliesi e più in generale delle élite della regione. Abbia-mo testimonianze dirette sugli ufficiali di due città, Trani e Ta-ranto, nei primi decenni del IX secolo; entrambe erano probabil-mente solo da poco divenute sedi gastaldali nell’ambito del grandedistretto canosino. Per Taranto possiamo attingere il profilo diuna dinastia funzionariale all’inizio del IX secolo, a partire da do-cumentazione cassinese.
Nell’807 42 lo sculdais Forti, figlio dello sculdais Roderissi, resi-dente a Taranto, offrì a Montecassino vari beni, fra cui la casa delgastaldo Paldo, varie vigne, orti, terre arborate (alcune forse aTrevico, presso Avellino) e un casale nel territorio di Conza. Conun altro documento tarantino, databile al 795 o all’810 43, il gastal-do Rodegari di Roderissi, probabilmente un fratello dello sculdaisForti attivo nell’807, offrì a Montecassino tutti i suoi beni nel ter-ritorio di Conza; fra essi il territorio di Albola, ad eccezione deiservi, e i beni nel territorio di Canosa, pervenuti al gastaldo dallamoglie Eusebia. La donazione prevedeva la riserva di usufrutto. Ildiacono tarantino Benedetto di Roderissi, presumibilmente fratellodello sculdais e del gastaldo, nell’822 44 donò metà del suo patrimo-nio a Montecassino e l’altra metà alla chiesa di S. Valentino, fondatadai genitori nei pressi di Taranto. Il quadro è quello di un gruppo fa-miliare fortemente radicato in città, ma con una proiezione patrimo-
41. Codex Diplomaticus Cavensis, I cit. (nota 33), n. 26 (845) = Chartae Latinae Anti-quiores. Facsimile-Edition of the Latin Charters, 2nd Series, Ninth Century, a cura di G. CA-VALLO e G. NICOLAJ, L (Italy XXII, Cava dei Tirreni), a cura di M. GALANTE, Dietikon-Zürich, 1997, n. 20.
42. CUOZZO e MARTIN, Documents inédits ou peu connus cit. (nota 4), n. 14. Su ciò chesegue vedi MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), pp. 179-181.
43. Ibid., n. 15.44. GATTOLA, Accessiones, I cit. (nota 4), p. 31.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 261
niale piuttosto ampia, anche grazie a legami matrimoniali con perso-naggi non del luogo: il riferimento all’ampio territorio di Conza esoprattutto i beni presso Trevico proiettano fino alle porte della capi-tale del principato il raggio di estensione del patrimonio familiare, delquale per altro non conosciamo la consistenza complessiva. L’oriz-zonte non solo locale della famiglia sarebbe confermato anche da unadonazione a Montecassino (826) da parte del chierico Daniele, figliodi Forti, che si trovava gravemente malato ad Aquino 45. La sua pre-senza lì non era occasionale, perché la donazione comprendeva benisia a Taranto che ad Aquino. Come ha notato Jean-Marie Martin 46,non è da escludere un legame della famiglia con il Roderissi titolarenel 774 di una subactio comprendente cinque famiglie contadine aPacciano, presso Trani, nella iudiciaria canosina 47.
La fondazione della chiesa di S. Valentino lega questa famigliatarantina a un’altra di rango gastaldale, residente a Trani. Nel-l’834 48 il gastaldo della città di Trani (« de civitate Trane »), Ra-deprando, figlio del fu gastaldo Sicoprando, offrì alla cattedrale diS. Maria una chiesa edificata dal padre, in un fondo suburbano disua proprietà, con il consenso dell’allora vescovo Leopardo. Lafondazione privata di una chiesa non ha in sé nulla di eccezionale.Nel contesto del ducato beneventano sono invece singolari lemodalità di gestione della chiesa sull’arco di due generazioni. ABenevento e in aree geograficamente centrali del ducato, le chiesedi fondazione privata (i fondatori ne erano spesso anche i primiabati) cadevano normalmente sotto la giurisdizione del Palatiumallo scoccare della seconda generazione 49; più raramente eranocedute a un grande monastero 50. I casi di S. Valentino a Tarantoe di S. Magno a Trani sembrano invece mostrare reti di relazioni
45. Ibid., p. 28.46. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), nota 424 a p. 229.47. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), I, 18.48. Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani (dal
IX secolo fino al 1266), a cura di A. PROLOGO, Barletta, 1877, n. 1.49. Esempi chiari in Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), II, 13 (743); III, 10 (751-
754); III, 23 (769) = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), nn. 20, 42 (con datazio-ne 752-756), 49. Sui rapporti fra nobiltà, chiese e monasteri nel IX secolo meridionalevedi V. LORÉ, La chiesa del principe. S. Massimo di Salerno nel quadro del Mezzogiorno lon-gobardo, in corso di stampa.
50. Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento, a cura di H. ZIELINSKI, Roma, 1986
VITO LORÉ262
più locali e un ruolo importante dell’episcopato 51. L’impressioneche questi gastaldi venissero dalle società locali, più che dall’élitedi governo beneventana, sembra confermata per Taranto dallapresenza nello stesso gruppo familiare di gastaldi e di sculdais: nelterritorio di Nocera, lo spazio meglio documentato del Mezzo-giorno longobardo di fine VIII-IX secolo, gli sculdais erano figuredi prestigio locale, con ogni probabilità originarie dell’ambito ru-rale in cui esercitavano la loro autorità, e rimanevano in carica an-che per periodi molto brevi, affiancandosi o avvicendandosi nellestesse località 52; e del resto, a riprova del carattere non vitaliziodella carica, proprio a Taranto nell’809 è testimoniato un « Aliper-tu f. Aliperti qui fuit sculdais » 53.
4. Il legame organico dei gastaldi nella Puglia centro-meridio-nale con le società che governavano e il loro reclutamento proba-bilmente locale non significa che essi non conoscessero relazioni eforme di integrazione con il centro del potere al di là del livelloistituzionale, sul piano delle parentele e delle proprietà. La Puglianel suo insieme era ben rappresentata nei patrimoni della nobiltàbeneventana 54. Nell’ultimo quarto dell’VIII secolo i circa trentafra casalia e curtes del gastaldo beneventano Guacco erano diffusi su
(Fonti per la Storia d’Italia, LXVI), n. 16. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), I, 21(781?); Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), n. 40 (796).
51. Cfr. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), pp. 238-240.52. Riferimenti a vicecomites e sculdhais che si avvicendano spesso rapidamente in ambien-
te nocerino in Codex Diplomaticus Cavensis, I cit. (nota 41), nn. 12 (822), 24 (844), 28 (848),31 (848), 32 (848), 37 (853) = Chartae Latinae Antiquiores... 2nd Series cit. (nota 41), L cit.(nota 41), nn. 11, 19, 22, 25, 26, 31 e Codex Diplomaticus Cavensis, I cit. (nota 41), insertosenza data nel n. 54 (858) = Chartae Latinae Antiquiores... 2nd Series cit. (nota 41), LI (ItalyXXIII, Cava dei Tirreni), a cura di F. MAGISTRALE, Dietikon-Zürich, 1998, n. 15.
53. Edizione in A. GALLO, Il più antico documento originale dell’archivio di Montecassino, inBullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, XLV (1969), pp. 163-164 = Chartae LatinaeAntiquiores..., 2nd Series cit. (nota 41), LIII (Italy XXV, Montecassino, Trani, Barletta, Beneven-to), a cura di F. MAGISTRALE, P. CORDASCO e C. GATTAGRISI, Dietikon-Zürich, 1999, n. 1.
54. Dei patrimoni della nobiltà beneventana in Puglia parla MARTIN, La Pouille cit.(nota 7), pp. 177-179. Sul livello di ricchezza dei duchi e dei principi beneventani in unquadro europeo vedi C. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Medi-terranean, 400-800, Oxford, 2005, pp. 217-218; tr. it. Le società dell’alto medioevo. Europa eMediterraneo, secoli V-VIII, a cura di A. FIORE e L. PROVERO, Roma, 2009, pp. 245-246.Wickham sottolinea come le disponibilità dei duchi e dei principi fossero di livello mol-
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 263
tutto il principato beneventano 55. Diversi sono localizzabili inambito apulo: Trani, Bisceglie, Terlizzi, Bari 56. Nel secondoquarto del IX secolo, nella cinquantina di aziende del beneventa-no Potone 57, alcune erano nel territorio di Canosa. Inoltre sap-piamo che il principe beneventano Sicone (in comune propriocon Potone) e la moglie del principe Sicardo possedevano beninel territorio di Canosa 58. Patrimoni consistenti come quelli diPotone e Guacco non erano probabilmente la norma, ma fra l’ul-timo quarto dell’VIII secolo e il primo trentennio del IX nonerano rare ricchezze fondiarie estese su spazi molto grandi, grossomodo coincidenti con l’intero principato. La genericità delle for-mule di donazione non sempre consente di quantificare l’entità dialtri patrimoni, come quelli, di certo molto consistenti, che Yme-dano di Teupo offrì a Montecassino e a S. Vincenzo al Voltur-no 59, o Radeprando di Radeprando a S. Vincenzo al Volturno 60,entrambi nell’801. L’articolazione di diverse altre proprietà nobiliarisu spazi molto ampi fa però pensare che Potone e Guacco non fosse-
to alto, con pochi paralleli a livello europeo, mentre esprime una valutazione più pru-dente sulla ricchezza fondiaria della nobiltà beneventana nel suo insieme.
55. Chronica Monasterii Casinensis cit. (nota 4), I 14; GATTOLA, Accessiones..., I cit. (no-ta 4), pp. 19-20 (797), donazioni di Guacco a Montecassino e alla chiesa beneventana diS. Benedetto, di proprietà dello stesso Guacco. Per il significato di curtis e casale nelladocumentazione meridionale dell’epoca vedi MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), pp. 204-206; ID., Città e campagna, in Storia del Mezzogiorno cit. (nota 30), III, Alto Medioevo, Na-poli, 1990, pp. 271-273.
56. Per la datazione e la proposta di localizzazione delle proprietà cfr. MARTIN et alii,Regesti cit. (nota 4), nn. 505, 506 (il n. 507 è un’altra, falsa donazione di Guacco a S.Benedetto di Benevento).
57. L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, II-2, Mediolani, 1723, rist. an. Bolo-gna, 1983, cc. 283-284; cfr. MARTIN et alii, Regesti cit. (nota 4), n. 734, che datano l’e-lenco dei patrimoni di Potone all’830-850 circa. Nuova edizione in appendice a W.POHL, Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die Gestaltung der langobardischen Vergan-genheit, Wien-München, 2001 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschicht-sforschung, Ergänzungsband XXXIX), pp. 197-199.
58. Per la comproprietà fra Sicone e Potone vale il riferimento alla nota precedente.Per Adelchisa, moglie di Sicardo, vedi Le più antiche carte dell’abbazia di S. Modesto in Be-nevento (secoli VIII-XIII), a cura di F. BARTOLONI, Roma, 1950 (Regesta Chartarum Italiae,XXXIII), n. 3 (852).
59. Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), I, n. 38 e CUOZZO e MARTIN, Documents inéditsou peu connus cit. (nota 4), n. 8.
60. Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), I, n. 34.
VITO LORÉ264
ro casi del tutto eccezionali in ambito beneventano e, per quanto ge-nerici, i riferimenti alla Puglia in altre donazioni ci dicono con chia-rezza che almeno nello strato sociale più elevato i patrimoni privatibeneventani coprivano anche la nostra regione 61.
Altra cosa è considerare dalla periferia il rapporto con Benevento.Dal punto di vista patrimoniale lo scarto tra le élite locali pugliesi e ilvertice sociale beneventano è evidente e in parte scontato. Si confer-ma la centralità del principe e l’importanza della residenza nella capi-tale, come manifestazione di prestigio e accesso privilegiato alle risor-se 62. Le élite apule erano poste su un livello decisamente più bassorispetto ai Beneventani: disponevano infatti di patrimoni solitamentecompresi in ambiti subregionali, estesi su uno o due fines al massimo,il che non deve comunque far pensare a un’élite provinciale povera:nella seconda metà del IX secolo la nobiltà di Salerno disponeva dipatrimoni in ambito quasi esclusivamente locale e di consistenza edestensione modeste 63. A confermare quanto fosse importante la vici-nanza personale al principe anche per chi viveva lontano da Bene-vento, dal quadro pugliese si distaccano proprio due famiglie di pro-filo gastaldale. Del patrimonio ad ampio raggio del gastaldo tarantinoRodegari abbiamo già detto. Nell’803 64 Giovanni del fu Pandone, re-sidente a Bari, grazie ai matrimoni di Giovanni stesso e dei suoi fra-telli, disponeva di beni nei territori di Canosa, Oria e Taranto, quin-di in tutta la Puglia centromeridionale longobarda. È probabile cheGiovanni fosse un ascendente, forse il padre 65, del Pandone gastaldodi Bari al momento della presa araba della città (sul quale torneremopiù avanti).
Le donazioni ai grandi monasteri meridionali testimoniano es-se stesse l’integrazione delle élite pugliesi in un circuito ampio ein senso lato beneventano. Ma ci sono anche alcuni indizi di rap-porti diretti di queste élite regionali con il principe e di integra-zione anche parentale con la nobiltà beneventana. Nel 724 il ducaRomualdo II, lo abbiamo già visto in apertura, aveva confermato
61. Ibid., I, nn. 47 (802); 42 (812); 43 (817); 64 (845).62. Vedi su questo punto GASPARRI, Il ducato e il principato di Benevento cit. (nota 30),
pp. 105-107, 113-115 e COLLAVINI, Duchi e società locali cit. (nota 12), soprattutto p. 152.63. Indicazioni in proposito in LORÉ, La chiesa del principe cit. (nota 49).64. Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), I, n. 41.65. Il legame è ipotizzato in MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), p. 179.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 265
alla chiesa di S. Pietro « ad Aqua S. Potiti » quattro coloni appar-tenenti alla subactio di Annuni attionario, su sollecitazione di Annunistesso. Egli era probabilmente un personaggio locale, per origine oresidenza, e di livello sociale non elevatissimo, a giudicare dal suotitolo, ma capace di perorare direttamente presso il duca, in quelmomento in provincia, la causa di una chiesa locale: S. Pietro erasituata presso Ascoli Satriano, nella Puglia settentrionale, dove delresto si trovava la località di Borfaniana, in cui il documento fu re-datto 66. Del resto l’abate di S. Pietro, Theoderaci, è forse da iden-tificare con l’omonimo abate di S. Pietro presso le mura di Bene-vento, testimoniato una ventina d’anni dopo 67. Trasulfo, il figliodel condoctor Virisano Giovanni, un altro personaggio di probabileambiente rurale pugliese, nel 789 aveva come intercessore l’arci-vescovo beneventano David 68. In una data imprecisata, Audoaledi Canosa cedette tutti i suoi beni ad Arechi II 69. Ma soprattuttoil citato, ricchissimo Potone, che aveva beni in comune con il do-minus Sicone nel territorio canosino, possedeva a Bari eredità dalsuo bisnonno Mitolinus 70. Per ascendenza maschile o femminile, ilnotabilato apulo era dunque arrivato a integrarsi alla più alta, ericca, nobiltà beneventana. Inoltre, secondo una fondata ipotesi diJean-Marie Martin, il padre del principe beneventano GrimoaldoIV è da identificare con l’Hermerissus gastaldo di Siponto nel 774.Non è detto che il gastaldo sipontino fosse di origine locale, madi certo Grimoaldo era cognatus del vescovo canosino Pietro, luisì, con ogni probabilità, espressione diretta dell’élite regionale 71.
66. Chronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 31 = I diplomi dei duchi di Beneventocit. (nota 1), n. 13; qui e altrove si rimanda al commento degli editori per l’identifica-zione dei luoghi.
67. La proposta di identificazione ibid., pp. 46-47, con bibliografia.68. Ibid., III, 27.69. Notizia ibid., I, 1, [27] (774).70. Cfr. le edizioni citate alla nota 57.71. Cfr. su tutta la questione J.-M. MARTIN, Note sur la Vie de saint Sabin de Canosa
et le prince de Bénévent Grimoald IV, in Vetera Christianorum, XXIV (1987), pp. 399-405,poi in Puglia paleocristiana e altomedievale, VI, Bari, 1991, pp. 171-177, con indicazionedelle fonti e della bibliografia precedente. Dopo la distruzione di Canosa, il vescovoPietro fuggì a Salerno e divenne vescovo di quella città: Chronicon Salernitanum cit. (nota6), 97.
VITO LORÉ266
5. Il terzo blocco di testimonianze viene dalle fonti narrative e ri-guarda essenzialmente il coinvolgimento degli ufficiali territoriali nel-le lotte interne alla nobiltà beneventana, nella prima metà del IX se-colo. All’interno di questo conflitto un ruolo di grande importanzaebbero i conti e gastaldi di Conza e di Acerenza, quest’ultimo centroai limiti della nostra regione. Acerenza e Conza, entrambe di origineantica 72, erano città importanti per la loro posizione di cerniera fra ilversante tirrenico del principato e le valli fluviali che direttamenteconducevano verso i territori pugliesi. L’esule spoletino Sicone, ac-colto presso la sua corte dal principe Grimoaldo IV, fu designato ga-staldo di Acerenza e divenne egli stesso principe di Benevento nel-l’817, con l’appoggio determinante del conte di Conza, Radechi 73,divenendo il punto di equilibrio per una composizione al termine diuna guerra civile che coinvolse diversi partiti della nobiltà beneventa-na, nessuno in grado di prevalere sugli altri 74. L’importanza determi-nante dei due centri nelle dinamiche politiche beneventane non eraperò contingente. Di nuovo il gastaldo di Acerenza e quello di Con-za ebbero un ruolo decisivo nello scontro fra Siconolfo e il principebeneventano Radelchi, indirizzato dall’intervento esterno dell’impe-ratore franco Ludovico II verso la divisione in due principati nel-l’848-849 75. Anche in questo secondo caso il Chronicon Salernitanum,la nostra fonte principale su queste vicende, ci dice con chiarezza l’o-rigine non locale dei gastaldi, membri anzi della nobiltà beneventanae cognati del principe salernitano Siconolfo, per averne sposato duesorelle 76: Acerenza rimanda a un circuito sociale differente, rispettoai casi di Taranto e Trani.
Senza volere qui richiamare tutta la vicenda narrata dal Chroni-
72. Su Conza vedi di recente G. PESCATORI, Città e centri demici dell’Hirpinia: Abelli-num, Aeclanum, Aequum Tuticum, Compsa, in Le città campane fra tarda antichità e alto Me-dioevo, a cura di G. VITOLO, Salerno, 2005 (Centro interuniversitario per la storia dellecittà campane nel Medioevo. Quaderni, II), pp. 292-298.
73. Questa è la grafia proposta dal cronista salernitano, non il più diffuso Radelchi.74. Cfr. sull’equilibrio delle forze in campo Chronicon Salernitanum cit. (nota 6), 48 e
53.75. Nuova edizione dell’accordo di divisione (Praeceptum concessionis sive capitulare,
848-849) in J.-M. MARTIN, Guerre, accords et frontières en Italie méridionale pendant le hautMoyen Âge. Pacta de Liburia, Divisio Principatus Beneventani et autres actes, Roma, 2005(Sources et documents d’histoire du Moyen Âge, VII), n. 4, pp. 201-217.
76. Chronicon Salernitanum cit. (nota 6), 55 e 80a.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 267
con, già analizzata in relazione al contesto politico più generale 77,vale però la pena prendere in considerazione alcuni elementi piùspecifici, relativi al ruolo gastaldale.
Il potere del gastaldo si centrava sulla città e da lì si irraggiavasu un ampio territorio circostante. Dal trattato di divisione fraRadelchi e Siconolfo emerge il rilievo del gastaldato di Acerenzae di quello di Conza, le cui confinazioni sono indicate, caso uni-co, a parte 78; lo stesso cronista salernitano sottolinea l’ampiezzadel territorio sottomesso alla giurisdizione di Sicone 79.
Anche se non originario del luogo, il gastaldo (o conte) era le-gato da una spontanea solidarietà con il corpo politico locale, chelo eleggeva a suo referente, in una negoziazione continua fra po-polazione, gastaldo e principe. Proprio gli Acerentini, nella narra-zione del Chronicon, convinsero Sicone a desistere dall’esilio a Bi-sanzio, che a lui sembrava l’unica via per salvare sé e i suoi dalleire del principe e di una parte della nobiltà beneventana: Siconeavrebbe invece unito il suo destino a quello degli Acerentini, cheavrebbe guidato per resistere al principe ed evitare la loro rovina,oltre che la sua 80.
Il gastaldo era il capo dei liberi in armi della sua sede e aveva unrapporto preferenziale con gli abitanti della città, dove sono ambien-tati gli episodi di contatto fra lui e la popolazione locale, mentre i ru-stici non sembrano direttamente coinvolti nel gioco politico. Tale
77. GASPARRI, Il ducato e il principato di Benevento cit. (nota 30), pp. 115-118, passim;P. DELOGU, Il principato longobardo di Salerno. La prima dinastia, in Storia del Mezzogiorno,II, Il Medioevo, 1 cit. (nota 30), pp. 240-244.
78. MARTIN, Guerre cit. (nota 75), pp. 205-206.79. Chronicon Salernitanum cit. (nota 6), 43: « [Grimoaldo IV] Aggerenciam ei [a Si-
cone] ad optinendum tribuit, que est nimirum spaciosa terra et ad venatum omnimodisapta, pro eo quod ipse Sico suosque proles talia diligere cognovit ».
80. Ibid, 44: « ”Si Beneventum nempe adeo [è Sicone che parla], Radechisi planeconsanguinei vivere me non sinebunt!” Et cum suis consilium inhiit, quatenus quippenavium emere, ut possint Constantinopolim properare. Hoc consilium sine Aggerentinisperactum est; set dum in patulo nempe exiit, Aggerentinis in hunc modum responsumSiconi promserunt: “Constantinopolim quare sic cicius tendere cupis? [...]”. Hec quippedicentibus, mox tellurem prostrati eumque vehementer obsecrabant, quatenus silicet mi-nime eos esse relicturus, adnectentes: “Clarum est plane, quia si tu nos deseris, omni-modis ad nichilum perveniemus. Tantum si dignitati vestre comparet, nos minime lin-quere; si morieris, nos pariter tecum moriemus; extimploque nos exinde iniamus fedus,quatenus quippe terra nostra inlesa optineamus” »
VITO LORÉ268
rapporto si manteneva anche in battaglia: sembra infatti che durantel’assedio di Acerenza gli uomini sotto il comando di Radechi diConza obbedissero direttamente a lui, il loro conte, anche se inqua-drati nella compagine ampia dell’esercito principesco 81.
Che cosa in particolare temevano gli Acerentini? Il rapportofra loro e Sicone potrebbe far pensare a uno spazio di manovra,che consentiva al gastaldo di godere delle risorse nel territorio dalui amministrato e insieme di avvantaggiare, o deprimere, gli inte-ressi locali. Da un cenno del cronista sembrerebbe infatti che Si-cone avesse una qualche disponibilità sui beni fiscali nel suo di-stretto, che furono distribuiti su indicazione del principe Grimoal-do IV alla popolazione locale dai figli di Sicone, in quel momentotrattenuto a corte 82. Questo episodio non è un unicum: il nessofra beni del fisco e amministrazione territoriale ritorna nella narra-zione del cronista salernitano riguardo a contesti territoriali diversida quello apulo 83. Allo stesso modo i vari casi di ribellione gastal-dale sembrano confermare il carattere diffuso delle prerogativemilitari dei gastaldi e il loro ruolo attivo nella competizione poli-tica che scosse il principato 84, in un contesto generalmente carat-
81. Ibid., 44: « Coniungens vero Beneventanorum princeps Grimoalt, sequipes eciameius et antefatus Radechis usque ad portam civitatis Aggerencie utrique venerunt; queobsedentes aliquantos dies, viriliter eam Beneventanorum exercitus constrinxerunt. AtSico hecontra deintus fortiter resistebat; sed ipse princeps simulans se molestia corporidetineri, ut exercitus a predatione cessarent, et procul ab ipsa civitate tentoria nimirumfigere iussit ». Qui è il verbo « cessarent », al plurale, che fa pensare a due corpi in qual-che misura distinti. Nel paragrafo 45, invece, il comando di Radechi sui suoi, insiemeeventualmente con altri armati, è esplicito: « Una dinique die Radechis cum magnaquippe audacia Cumsinis qui ipse nutrierat tollens, aderet sibi aliquam partem exercitui,cum ingenti virtute usque ad portam ipsius civitatis [Acerenza] pervenit ». Indicazionigenerali sugli eserciti del Mezzogiorno longobardo e sul potere di conscriptio esercitatodai principi in MARTIN, Guerre cit. (nota 75), pp. 68-72.
82. Chronicon Salernitanum cit. (nota 6), 47: « Sed ipse Sico, comeato accepto, hono-rifice eos Beneventum <ascire> fecit, atque Siconi idem princeps precipiens, ut minimeAggerenciam ipse silicet pergeret, sed quicquid fiscalia ibidem fuissent reperta, proles il-lius ipse inde acciperet, ac populus terre illius suaviter iudicaretur ».
83. Vedi per esempio la concessione di beni fiscali e di distretti territoriali operata daGisulfo I di Salerno a favore di suoi congiunti capuani ibid., 176, e anche la concessioneprincipesca di un castello come premio per l’astuzia di un suo suddito ibid., 85.
84. Vedi il caso del gastaldo di Avellino ibid., 147*, o quello del gastaldo di S. Aga-ta, Marino, in ERCHEMPERTUS, Historia cit. (nota 5), 66 e 71.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 269
terizzato dall’assenza o comunque dalla scarsissima rappresentativitàdi legami di tipo vassallatico 85 e dal carattere fluido e aperto deiseguiti aristocratici 86. Difficile però dire quale fosse in quel conte-sto il posto dei gastaldi pugliesi. Probabilmente la piena integra-zione di Acerenza nelle dinamiche politiche del principato è unfatto relativamente eccezionale per un centro apulo, frutto dellaposizione strategica acerentina a cavallo dei due versanti dell’Ap-pennino e dell’importanza particolare di quel territorio: il cronistasalernitano lo definisce terra, un termine in seguito usato per desi-gnare uno spazio politico con un’autonomia e un prestigio parti-colari, come i distretti maggiori del principato capuano nel Xsecolo 87.
Gli altri gastaldi che vediamo nell’esercizio delle loro prerogativemilitari sembrano infatti tutti da riferire all’area campana, compreso ilMarino gastaldo di Sant’Agata, ribellatosi ad Aione di Benevento nel-la seconda metà del IX secolo. La sede di Marino va a mio parereidentificata con Sant’Agata de’ Goti, presso Benevento, e non conl’omonimo castrum pugliese, a giudicare dalla sua posizione negli iti-nerari dello stratego Teofilatto e del principe Aione nel racconto diErchemperto 88. Gli unici gastaldi pugliesi menzionati dalle fonti nar-
85. Fondamentale su questo punto MARTIN, Éléments préféodaux cit. (nota 30).86. H. TAVIANI-CAROZZI, La principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe siècle). Pouvoir et
société en Italie lombarde méridionale, I-II, Roma, 1991 (Collection de l’École Française deRome, CLII), pp. 685 e seguenti, con qualche eccesso interpretativo.
87. Per la definizione di Acerenza come terra vedi sopra, i passi del Chronicon Salerni-tanum citati alle note 79 e 80; per un confronto più tardo nella documentazione d’archi-vio capuana vedi GATTOLA, Accessiones..., I cit. (nota 4), p. 124 (1035): « declaro antepresentia Aidulfi iudici Capuane cibitatis et de aliis terris... », dov’è evidente come Ca-pua sia una terra fra le altre che compongono il principato.
88. Secondo ERCHEMPERTUS, Historia cit. (nota 5), 66 e 71, lo stratego Teofilatto passaa Sant’Agata andando da Teano a Napoli (« His quoque diebus Theophilactus stratigo aBari Teanum hostiliter advenit hyemis tempore, Saracenos temptans impugnare; nihil-que proficiens, infructuosus abscessit; abiensque Neapolim, Marinum gastaldeum castriSanctae Agathae Aioni rebellem percepit, et Apuliam rediens, nonnullas munitiones eiu-sdem Aionis vi apprehendit ») e Aione venendo da Capua, per poi tornare a Benevento.(« indeque [da Capua Vetere] habiens, super castrum Sanctae Agathae insedit, atque Ma-rinum gastaldeum sibi rebellem in fide ad se remeantem suscipiens, abscessit, aliquandiuBenevento commorans, per Sepontum Varim reversus est »). Cfr. altri elementi, nessunodei quali a mio parere decisivo, a favore dell’identificazione di questa località con l’unoo l’altro dei due centri in MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), nota 416 a p. 228.
VITO LORÉ270
rative rimarrebbero allora quelli di Bari. Secondo Erchemperto 89, an-cora lui, nell’847 il barese Pandone chiamò presso la sua città i Sara-ceni, per ordine di Radelchi di Benevento; essi sarebbero poi riuscitia entrare in città e avrebbero ucciso Pandone, definito « proditoremgentis et patriae ». Qualche decennio dopo, per difendersi dalle scor-rerie saracene, i Baresi chiamarono in città i Bizantini, in quel mo-mento di stanza a Otranto; secondo i patti, dopo aver preso la città,l’anonimo gastaldo e i maggiorenti baresi furono inviati a Costantino-poli 90. Per quanto minimi, i due episodi sembrano mostrare una cer-ta evanescenza militare dei gastaldi baresi e, in certo senso di conse-guenza, una loro attitudine del tutto subalterna ai principi beneventa-ni prima, all’impero bizantino poi. Il secondo episodio, in modo nondel tutto slegato, pare anche mostrare uno scollamento fra la popola-zione cittadina e i maggiorenti, se il loro invio a Costantinopoli, giàconcordato prima che essi rendessero la città, dev’essere interpretatocome una forma di protezione nei loro confronti: un rapporto dell’é-lite con la popolazione locale di tipo probabilmente diverso rispetto aciò che abbiamo visto per Acerenza.
6. Analizzati i principali gruppi di testimonianze, resta da ve-dere come combinarle fra loro, tenendo conto soprattutto dell’a-simmetria, in parte cronologica in parte geografica, che le separale une dalle altre. A mio parere le fonti narrative, insieme con iltrattato di divisione dell’848-849, sono il sintomo e l’espressionedi un mutamento ancora in corso, ma già avviato ai primi del IXsecolo, quando nella documentazione d’archivio termini più anti-chi come actus e iudiciaria sono – finalmente, verrebbe da dire –affiancati e poi soppiantati da altri, come fines, con senso più pro-priamente territoriale 91. Con una cronologia molto sfasata rispetto
89. ERCHEMPERTUS, Historia cit. (nota 5), 16.90. Ibid., 38: « Hoc audientes qui Varim residebant, Gregorium, baiulum imperiale
Graecorum, qui tunc in Odronto degebat cum multis exercitibus, asciverunt, et Barimintroduxerunt ob Saracenorum metum. Qui statim apprehensum gastaldeum illiusqueprimores Constantinopolim misit, ut quibus iureiurandum fidem dederat » (ho operatoun piccolo cambiamento di punteggiatura rispetto all’edizione).
91. Vedi per esempio Chronicon Vulturnense cit. (nota 3), I, n. 34 (801): « finibus Lisine »,« finibus Siponto », « finibus Lucere », « finibus Canosine », « finibus Telesie » ecc.; ibid., I, n.41 (803): « finibus Tarantinis », « finibus Orietanis » e « finibus Canosinis »; ibid., I, n. 57(833): « finibus Acerentinis »; ibid., I, n. 62: « Lucerinis finibus »; CUOZZO e MARTIN, Docu-
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 271
al regno di Pavia e all’Italia centrosettentrionale, nel corso del IXsecolo si definirono progressivamente in senso territoriale quadriamministrativi nei quali fino a quel momento, come si è detto,dominava l’aspetto fondiario del potere ducale e che proprio per-ciò non portavano a una scansione uniforme dello spazio: sovrap-posizione e affiancamento fra subactiones e actus; actus definiti inbase all’elemento fondiario oppure personale, accanto ad altri piùclassicamente centrati su un capoluogo. Anche nel valutare la ter-ritorialità di questi ultimi casi, tuttavia, è necessario essere moltocauti, per evitare di cadere in anacronismo. Nell’840 tutto l’actusdi Larino era compreso nel gastaldatus di Quintus Decimus, pressoMirabella Eclano, vicino a Benevento: fra Larino e la sede del ga-staldatus c’è una distanza amplissima 92. Ancora più eclatante il casodel diploma (774) con cui il principe Arechi concesse a S. Sofia unacorte in Montevergine, confinante con il territorio di Nola e con uncorso d’acqua che lambiva un colle sotto Pietrastornina: se non lacorte, il colle era pertinente all’actus di Lucera, per il quale mi pareimpossibile qui ipotizzare una continuità territoriale dal capoluogo finoltre Benevento 93.
Nella serrata competizione per il potere principesco fra gruppi no-biliari emersero in primo piano le funzioni militari e di governo degliufficiali, in una radicale semplificazione di quadri amministrativi fin lìmolto complessi, espressa anche dalla rarefazione e poi dalla scomparsadelle rendite riservate agli ufficiali nella forma della subactio. Cambiò
ments inédits ou peu connus cit. (nota 4), n. 15 (795 o 810): « iuxta fines Canusie »; GATTOLA,Accessiones, I cit. (nota 4), pp. 27-28 (823): « de finibus Consina ». Più tarde le attestazioni dalChronicon Sanctae Sophiae cit. (nota 1), III, 36 (840): « finibus Larinensis »; III, 17 (850): « fini-bus Folianensis »; I, 36 (878), una delle primissime concessioni di immunità da dationes, pen-siones, angaria, laboratio e hostis, dovute in questo caso dai servi di Santa Sofia « ex finibusCampu Bassi et ex finibus Bifernense » agli ufficiali principeschi.
92. Ibid., III, 36.93. Ibid., I, 9. C’è anche da segnalare il caso di una subactio che potrebbe aver ab-
bracciato uomini fra loro distantissimi: quella del gastaldo Ferdolfus/Ferdulfus comprende-rebbe nel 751-754 (o 752-755) una donna e le sue due figlie, residenti presso Venticano,Avellino (ibid., VI, [33] = I diplomi dei duchi di Benevento cit. (nota 1), n. 41), e nel 774l’abate di una chiesa situata in un gaio con ogni probabilità presso Matera (ibid., I, 1[69]). Naturalmente, anche ammesso che Ferdolfus e Ferdulfus siano la stessa persona, nonabbiamo nessuna certezza che le tre donne e l’abate gli siano stati soggetti contempora-neamente, visto lo scarto cronologico dei documenti che li riguardano.
VITO LORÉ272
così radicalmente la figura del gastaldo, sospesa nel periodo precedentefra due livelli: l’ufficio di corte, importante espressione del prestigionobiliare e via di accesso privilegiata alle risorse fiscali, e l’amministra-zione territoriale, comprendente una serie di profili di agenti probabil-mente molto disomogenei, sia per competenze che per estrazione so-ciale. Nella nuova temperie del IX secolo il ruolo gastaldale trovò uni-formità e definizione molto maggiori dal punto di vista territoriale, dicui sono espressione precipua i comportamenti e il rilievo politico deigastaldi e conti di Conza e di Acerenza nelle vicende dei principati.Ma ciò ancora non implica una corrispondenza perfetta fra gastaldo,sede cittadina e distretto, come sembra mostrare proprio il caso dellaPuglia centrale.
Nel corso del IX secolo il numero dei gastaldi all’interno dellagrande circoscrizione canosina aumentò: abbiamo già detto dellacomparsa di gastaldi a Trani e a Bari. Eppure di fines tranenses o fi-nes barenses non c’è traccia, né nella documentazione di epocalongobarda, né in quella più abbondante di età bizantina, dove in-vece la locuzione fines canosina sopravvive a lungo, impiegata perlocalizzare toponimi e insediamenti rurali lungo tutta la Terra diBari, fin quasi a Conversano 94. Insomma è a mio parere possibileche i gastaldi di Trani e di Bari agissero all’interno del medesimo,grande ambito territoriale, centrato su Canosa, senza che attornoalle loro sedi si strutturasse un distretto, che andasse al di là dellacittà e del suo immediato entroterra. Del resto non a ogni distret-to doveva necessariamente corrispondere un gastaldo: non è affat-to detto che Barletta fosse sede gastaldale, anche se fines Baroletanisono testimoniati nell’845; e non tanto per la distanza molto ri-dotta fra Trani e Barletta 95, quanto perché i fines non sono di persé sinonimo di gastaldato, come mostra con evidenza il confrontocon la meglio documentata area salernitana 96. Nonostante l’evolu-zione in senso territoriale di figure e spazi originariamente conno-
94. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), nota 440 a p. 231.95. Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani cit.
(nota 48), n. 3 = Chartae Latinae Antiquiores..., 2nd Series cit. (nota 41), LIII cit. (nota53), n. 14. Cfr. MARTIN, La Pouille cit. (nota 7), p. 227.
96. Lo nota in modo sintetico, ma puntuale, V. RAMSEYER, The Transformation of aReligious Landscape. Medieval Southern Italy, 850-1150, Ithaca and London, 2006, pp.24-25.
I GASTALDI NELLA PUGLIA LONGOBARDA 273
tati in senso spiccatamente fondiario, il rapporto fra ambiti di go-verno e ufficiali pare al contempo più articolato e più fluido diquanto normalmente non si creda, ancora molto lontano dall’as-setto regolare e rigido del principato capuano-beneventano nellaseconda metà del X secolo 97.
Il reclutamento probabilmente locale dei gastaldi nella Pugliacentro-meridionale, il livello più basso (ma non in assoluto modesto)della loro ricchezza fondiaria in rapporto all’élite beneventana, i lega-mi organici con le società locali danno conto di un gruppo con unamorfologia sociale distinta e con un profilo militare meno accentuatorispetto a quello residente nella capitale, al di là dei legami diretti, an-che di parentela. Con un paradosso solo apparente potremmo direche proprio l’estraneità di quest’area alle serrate contese per il potereprincipesco appare come la premessa più chiara della sua uscita dallasfera politica longobarda, alla fine del IX secolo*.
97. In particolare sul rapporto fra ufficiali e beni fiscali nel principato capuano del Xsecolo vedi V. LORÉ, Beni principeschi e forme di potere nel Mezzogiorno longobardo, in Italia,888-962: una svolta?. Atti del IV seminario internazionale del Centro Interuniversitarioper la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo (Cassero di Poggio Imperiale, Poggi-bonsi (SI), 4-6 dicembre 2009), a cura di M. VALENTI e C. WICKHAM, in corso di stampa.
* Questo lavoro è dedicato a Emanuela, mia moglie, fra una casa e l’altra.