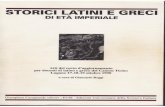Cenni storici, in C. EBANISTA-F. FUSARO, Cimitile. Guida al complesso basilicale e alla città....
Transcript of Cenni storici, in C. EBANISTA-F. FUSARO, Cimitile. Guida al complesso basilicale e alla città....
CIMITILEguida al complesso basilicale e alla città
nuova edizione ampliata e aggiornata
CARLO EBANISTAFILOMENA FUSARO
COMUNE DI CIMITILE
© 2005 - Proprietà riservataPrima edizione 2001
Comune di Cimitile, piazza Filo della Torre, 1, tel. 0815125404 -0815125406 - fax 0815122061e-mail: [email protected] - [email protected]
Progetto grafico di R. C. La FataIn copertina: Cartografia del territorio di Nola e Cimitile (G.A. Rizzi Zannoni, 1793). Complesso basilicale e Campanile di S. Maria degli Angeli (C. Ebanista).
PRESENTAZIONE (di Nunzio Provvisiero) p. 7
PREMESSA (di Carlo Ebanista e Filomena Fusaro) p. 9
CENNI STORICI (di Carlo Ebanista) p. 11
IL COMPLESSO BASILICALE (di Carlo Ebanista) p. 19Origini, sviluppo e storia degli scavi p. 19Basilica di S. Tommaso p. 29Cappella dei Ss. Martiri p. 35Basilica di S. Felice p. 47Cappella di S. Calionio p. 85Cappella di S. Maria degli Angeli p. 87Basilica nova, poi S. Giovanni p. 89Basilica di S. Stefano p. 101Arco santo p. 105
EDIFICI DI CULTO E DIMORE STORICHE (di Filomena Fusaro) p. 107Chiesa di S. Maria degli Angeli p. 107Palazzo Albertini p. 107Cappella di S. Luigi p. 108Parrocchiale di S. Felice p. 108Chiesa dei Morti p. 114Palazzo Filo della Torre, già Albertini p. 116Chiesa di Maria SS. del Carmelo p. 117Villa Lenzi, già chiesa e convento di S. Francesco di Paola p. 118Palazzo de Lerma, già Caracciolo p. 119Cappella di S. Raffaele p. 120
TRADIZIONI E CULTO (di Filomena Fusaro) p. 123
GLOSSARIO p. 127
BIBLIOGRAFIA p. 131
SUMMARY p. 139
ZUSAMMENFASSUNG p. 141
NOTIZIE UTILI p. 143
indice
A nord di Nola, nella fertile pia-nura protetta dai contrafforti preap-peninnici e dominata dal Somma-Vesuvio, sorge la cittadina di Cimitile(6877 abitanti), distante circa 25 kmda Napoli. Il suo territorio risulta fre-quentato sin dal IV secolo a.C.,quando vi fu costruito un luogo diculto delimitato da una strada e daun porticato in blocchi di tufo.Distrutto nel I secolo a.C., il com-plesso cultuale è stato individuatodalla Soprintendenza Archeologicadi Napoli in via Trivice d'Ossa neipressi della Scuola Media (fig. 5 n.4), durante gli scavi per la costruzio-ne dell'asilo nido. Nel corso delleindagini è stata rinvenuta una sta-tuetta di Ercole combattente (fig. 1)che, pur riprendendo uno schemaosco-sabellico di tipo arcaico, risen-te degli influssi della plastica greca.
Nella seconda metà del I secoloa.C. l'imperatore Augusto, per distri-buire le terre ai suoi veterani, fecesuddividere l'agro a nord della cittàdi Nola (attraversato molto probabil-mente dalla via che da Capua con-duceva a Reggio Calabria) in appez-zamenti regolari, delimitati da untracciato viario a maglia ortogonale(cardini e decumani). L'operazione
interessò anche il territorio dell'attua-le Cimitile (fig. 5): il corso Umberto I(con orientamento est-ovest) segue,infatti, il percorso di uno dei decu-mani della centuriazione.
Nella prima età imperiale inquest'area sorsero alcune ville rusti-che. In via Manzoni, durante i lavoridi sbancamento per la costruzione diun fabbricato, sono stati scoperti iresti di un impianto per la lavorazio-ne del vino, risalente nella sua primafase al I secolo d.C. Un'altra villarustica, ubicata a circa 450 m a norddella precedente, è venuta alla lucein via Morelli: l'indagine ha eviden-ziato parte del porticato di una resi-denza sorta nella prima età imperia-le; del porticato, pavimentato inmarmo, sono venuti alla luce duepilastri in opera listata separati dauna soglia e allineati ad una colon-na marmorea d'età flavia. In vicoNutrice, a circa 70 m a sud del por-ticato trovato in via Morelli, durantescavi eseguiti in occasione di lavoriedilizi, furono rinvenuti tre grossicontenitori ceramici (dolia) pertinentiforse ad una cella vinaria; la circo-stanza che il decumano (cui sisovrappone corso Umberto I) sepa-rava la zona residenziale della villa
11
Carlo Ebanista
cenni storici
(via Morelli) dal settore rurale (vicoNutrice) lascia, tuttavia, perplessi sul-l'effettiva appartenenza dei duenuclei allo stesso complesso, ancheperché resti di altre probabili villerustiche sono riemersi a circa 200metri a sud-est in via S. Elena e sullato nord di Corso Umberto al di sot-to del palazzo Filo della Torre.
Tra II e III secolo d.C., in un'areaubicata a circa 1,5 km dalla cittàromana di Nola e non molto lontana
dalle ville rustiche, si sviluppò unanecropoli costituita da mausolei alli-neati lungo l'asse nord-sud (fig. 2);oltre a tombe in laterizi, gli edificifunerari accolsero sarcofagi (fig. 48)e urne cinerarie in marmo (fig. 47).Non va escluso che il sepolcreto sor-se proprio in relazione alla popola-zione residente nelle adiacenti ville.
Alla fine del III secolo nellanecropoli fu seppellito il sacerdoteFelice, morto il 14 gennaio di unanno a noi sconosciuto. Prestigiosoesponente della comunità cristianadi Nola, Felice aveva amministrato lachiesa locale durante l'assenza forza-ta del vescovo Massimo, rinunciandoperò a succedergli nella carica.
Dalla prima metà del IV secolo,intorno alla venerata tomba di Felice(fig. 3), si sviluppò il famoso santua-rio (fig. 5 n. 1), celebre in tutto l'Oc-cidente, come ricorda S. Agostino.Presso il complesso monumentale,collegato a Nola da una stradalastricata, sorse un villaggio che S.Paolino (fig. 4), futuro vescovo dellacittà (409-431), ricorda per la primavolta nel 399-400. Dall'originariadestinazione sepolcrale, il santuarioe l'abitato derivarono la denomina-zione di Cimiterium che nell'altome-
12
Fig. 1Statuetta di Ercole combattente
dioevo si affiancò a quella ben piùantica di Nola. Attestato per la primavolta nell'839, il toponimo Cimite-rium si trasformò nel corso dei seco-li in Cimitino e quindi in Cimitile.
Sebbene danneggiato da unadisastrosa alluvione agli inizi del VIsecolo, il villaggio fu ininterrottamen-te abitato, grazie alla presenza delcelebre santuario che continuò adessere meta di pellegrinaggi e per uncerto periodo ospitò il vescovo diNola. Tra VI e VII secolo Cimiteriumevidenzia una stagione particolar-mente fiorente di pellegrinaggi e lapresenza di un vivace insediamentoche gravitava attorno al santuario, inanalogia con i più importanti centrimartiriali dell'epoca. Vecchi scavioccasionali e recenti indaginiarcheologiche sembrano attestareche, sino al VII secolo, il nucleo abi-tato si estese nella zona a sud-est delsantuario (ossia in direzione di Nola)dove fu reinsediata l'area di una villarustica d'età imperiale, mentre tra VIIIe XI secolo si sviluppò verso nord-est.Situato in un territorio a lungo conte-so tra i principi longobardi di Bene-vento e Salerno e i duchi di Napoli,Cimiterium, tra IX e X secolo, subì lescorrerie di Saraceni e Ungari.
Intanto al decumano della cen-turiazione romana (attuale corsoUmberto I) si era sovrapposta la 'stra-da regia' per le Puglie. La felice posi-zione lungo questo importante asseviario risultava ben evidente nel XIIsecolo, allorché il geografo araboAl-Edrisi, nel descrivere la rete stra-dale tra Benevento, Avellino e Saler-no, non mancava di ricordare g.bîti-rah (cioè Cimiterium). Fu proprio lun-go quest'importante asse viario e non
13
Fig. 2Mausoleo della necropoli
a ridosso del santuario che, tra isecoli terminali del medioevo e laprima età moderna, si concentròl'abitato di Cimitile e furono costruitinuovi edifici di culto, di pertinenzalaicale o conventuale. Il santuariorisultò ai margini del contesto urba-no cimitilese e decentrato rispettoalla 'strada regia'. In particolare ilnucleo centrale dell'insediamentosembra costituito dall'incrocio traquesto percorso stradale e l'asse via-
rio Nola-Camposano (ossia via S.Giacomo-via Forno), dove sorgeràla residenza degli Albertini, una del-le più prestigiose casate dell'aristo-crazia nolana. Legata all'amministra-zione imperiale e di tradizioni filo-spagnole, la famiglia Albertini pertutto il Cinquecento riuscì ad occu-pare con suoi esponenti alcune cari-che fondamentali per la vita econo-mica e amministrativa dello stato,arrivando a coprire nel territorionolano lo spazio lasciato libero dallacrisi della tradizionale potenza degliOrsini.
Alla fine del Cinquecento il baro-ne di Castel Cicala, Annibale Loffre-do, edificò ad est dell'abitato diCimitile il convento e la chiesa di S.Francesco di Paola (fig. 5 n. 7). Nel-l'arco di un secolo gli Albertini acqui-starono a Cimitile una masseria, unataverna e alcuni terreni confinanti,situati lungo la 'strada regia'. Agli ini-zi del XVII secolo il campo adiacentela taverna venne adibito al carico eallo scarico delle merci nonché allasosta di quanti percorrevano l'impor-tante asse viario. Nel 1631 l'abitato,che nel 1594 e 1600 era stato dan-neggiato da disastrose inondazioni,risentì le conseguenze dell'eruzione
14
Fig. 3Altare sulla tomba di S. Felice
del Vesuvio che fu accompagnata daun'intensa attività sismica durata sinoal febbraio dell'anno successivo.Consolidata la posizione patrimonia-le, nel 1640 Girolamo I Albertiniacquistò dal re di Polonia il feudo diCimitile, dietro pagamento di 6400ducati.
Intorno alla metà del Seicento, inlocalità Galluccio, venne eretto ilpalazzo Caracciolo (fig. 5 n. 8), pas-sato successivamente ai de Lerma,
duchi di Castelmezzano. Nellaseconda metà del secolo Cimitile fuinteressata da un grave decadimentosociale e morale che sfociò nelleefferate imprese dei banditi Cesare eFelice Antonio Riccardi; la circostan-za comportò il distaccamento aCimitile di truppe spagnole. Se sieccettuavano poche famiglie, la stra-grande maggioranza della popola-zione era costituita da contadini. Nel1688 Girolamo II Albertini, principe
15
Fig. 4Madonna orante tra i santi Felice ePaolino
di Cimitile, concesse agli eletti del-l'Università (ossia l'amministrazionecittadina) di tenere nella propriataverna le riunioni che fino a quelmomento si erano svolte nella chiesadei Morti (fig. 88 n. 7). Danni all'abi-tato furono causati dal violento terre-moto del 1694.
Agli inizi del XVIII secolo Girola-mo II trasformò taverna e masseria inun'elegante dimora con annessacappella gentilizia e due giardini; nel1726 quello più piccolo, abbattuti ilmuro di cinta e gli alberi, fu unitoallo spiazzo antistante la taverna,insieme al quale venne a costituirel'attuale piazza di Cimitile (fig. 5 n.2). Nel 1747 è attestata la presenzaoccasionale di mercanti di stoffe,sete, argenti e ori, che vi formavanoun piccolo mercato.
Nel 1799, dopo l'iniziale adesio-ne alle idee rivoluzionarie, l'Universi-tà di Cimitile si schierò con i Borbo-ni, sostenendone fattivamente letruppe. Il 15 giugno, a soli due gior-ni dall'arrivo a Napoli del cardinaleRuffo, l'amministrazione cimitilesefece costruire una croce in piazza,nel luogo ove i rivoluzionari avevanopiantato l'albero della libertà. Oltreai saccheggi perpetrati dai francesi,
a Cimitile tra gennaio e ottobre1799 si registrarono ben otto omici-di. In quel periodo i cimitilesi, oltre acoltivare grano, mais, legumi, vite,ortaggi, canapa e gelsi, allevavanoanche i bachi da seta.
Nel 1805 l'abitato fu danneggia-to da un forte terremoto. L'anno suc-cessivo, a seguito della legge del 2agosto 1806, il principe GaetanoAlbertini perse ogni diritto feudale suCimitile che divenne Comune, men-tre nel 1809 venne soppresso il con-vento di S. Francesco di Paola. Nel1859 il re Ferdinando II autorizzò ilComune di Cimitile a tenere la fieraannuale dal primo al 3 maggio (inconcomitanza con la festività dellaCroce) e il mercato settimanale ilvenerdí.
In occasione del plebiscito del21 ottobre 1861, i cimitilesi siespressero all'unanimità per l'annes-sione al Regno d'Italia. Nel 1884 fuinaugurata la linea ferroviaria Napo-li-Nola-Baiano (passata nel 1934alla Circumvesuviana) che ebbe unastazione a Cimitile (fig. 5 n. 6).
Interessata da un terremoto nel1903, Cimitile, come molti altri cen-tri della zona, fu ricoperta dalleceneri eruttate dal Vesuvio nel 1906.
16
Nel 1927 il Comune di Cimitile fuaggregato alla provincia di Napoli, aseguito dell'abolizione di quellacasertana. Tra il 1928 e il 1929 ven-ne costruita la Scuola Elementare"Fratelli Mercogliano" (fig. 5 n. 5).Negli anni Trenta, al centro dellapiazza (dedicata al conte Nicola Filodella Torre che, divenuto proprietariodi palazzo Albertini, aveva donatol'area antistante alla cittadinanza)venne eretto il monumento ai Cadu-ti, opera dello scultore Pellegrino;alla cerimonia di inaugurazione fupresente Gina Toti, sorella dell'eroeEnrico.
Dal 1931 con l'inizio degli scavi
nel complesso basilicale, Cimitilevenne a trovarsi al centro dell'atten-zione degli studiosi. Le ricerchearcheologiche e i restuari ebberoluogo negli anni 1931-36 sotto ladirezione prima del soprintendenteGino Chierici e quindi dell’arch.Benedetto Civiletti.
Danneggiata dai bombarda-menti durante il secondo conflittomondiale, subì l'occupazione delletruppe anglo-americane. Il comandoalleato venne allestito nel palazzoAlbertini.
Nel dopoguerra la prevalenteeconomia rurale è stata gradual-mente integrata da attività artigiana-
17
Fig. 5Planimetria del centro cittadino
1- complesso basilicale2- piazza Filo della Torre3- chiesa di Maria SS. del Carmelo4- Scuola Media5- Scuola Elementare
6- Stazione Circumvesuviana7- villa Lenzi8- palazzo de Lerma9- cappella di S. Raffaele
li, industriali e terziarie. Negli anniSettanta venne demolito e ricostruitoil Municipio che aveva una caratteri-stica torretta con orologio.
A seguito del terremoto del 23novembre 1980, il tessuto urbano el'edilizia tipica sono stati profonda-mente denaturati, mentre un nuovorione di case popolari (IACP) è statorealizzato nell'area nord del territoriocomunale (2,82 km2), al confine conCamposano.
18