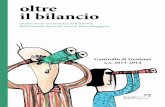La «crisi del Trecento». Bilancio e prospettive di ricerca, «Studi storici», Xv (1974), 3,...
Transcript of La «crisi del Trecento». Bilancio e prospettive di ricerca, «Studi storici», Xv (1974), 3,...
Fondazione Istituto Gramsci
La "Crisi del trecento". Bilancio e prospettive di ricercaAuthor(s): Giovanni CherubiniSource: Studi Storici, Anno 15, No. 3 (Jul. - Sep., 1974), pp. 660-670Published by: Fondazione Istituto GramsciStable URL: http://www.jstor.org/stable/20564172 .Accessed: 25/01/2011 10:05
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unlessyou have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and youmay use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at .http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=fig. .
Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printedpage of such transmission.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
Fondazione Istituto Gramsci is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to StudiStorici.
http://www.jstor.org
Note critiche
LA << CRISI DEL TRECENTO ,,. BILANCIO E PROSPETTIVE DI RICERCA
Sulle pagine di questa stessa rivista si e, di recente, fornito un ampio esame critico del primo volume della Storia d'Italia edita da Einaudi e delle componenti id,eologiche e culturali che, almeno programmaticamente (non sempre, tuttavia, nei risultati, o meglio, in tutti i risultati) ne stanno alla base '. Nelle pagine che seguono vorrei, molto piiu modestamente, soffermarmi soltanto, ora che sono apparsi anche i due tomi relativi ai Documenti, su un tema specifico che ritorna a piju riprese in molti dei contributi particolari, la cosi detta ? crisi del secolo XIV >>. Anche se un discorso piiu completo sarebbe possibile soltanto dopo la comparsa del II volume dell'opera (nel quale il Trecento 'e cronologicamente compreso), si puo fin da ora sottoliineare che a questo proposito la Storia einaudiana ha compiuto un'utile opera di <? adeguamento ? (sul piano, naturalmente, della piju larga divulgazione di buon livello) della storiografia italiana alla storiografia francese, inglese, americana, -tede sca, nelle quali il problema della << crisi del Trecento >> e ormai dibattuto da alcuni decenni.
Nel primo volume dell'opera Emilio Sereni, nel suo lungo saggio :dedicato ad Agricoltura e mondo rurale, riserva un paragrafo all'<< arresto ? e alla ? crisi >> del XIV secolo. Ben informate sulla tematica ? europea >> della crisi, queste pagine ne passano in rassegna, alla luce di una interpretazione marxista che utilizza i risul tati raggiunti per la maggior parte da storiografie di tutt'altro orientamento, i fe nomeni piCu salienti: rallentamento, dalla prima meta del Trecento, del moto dei grandi dissodamenti e della fondazione di nuovi insediamenti; comparsa, nello stesso periodo, di gravi carestie generali, i cui guasti culminarono nella gravissima pestilenza del 1348 e in quelle dei decenni successivi. Indipendentemente dai fat tori particolari - vicende climatiche, livello igienico ecc. - che possono aver favorito, di volta in volta, questi eventi, ? non si sfugge all'impressione che motivi di fondo operino nel condizionare un andamento congiunturale, che si protrae seppure con qualche attenuazione - dagli inizi del XIV a tutto il secolo XV ed
1 G. Turi, I caratteri originali della storia d'Italia, ? Studi storici ?, a.
XIV (1973), pp. 267-91. Fra le moite discussioni susc?tate dalla Storia si veda
anche, per la sua importanza, ? Caratteri originali ? e prospettive di analisi:
ancora sulla ? Storia ? d'Italia Einaudi (risultato di una ? tavola rotonda ? svol
tasi presso FUniversit? di Padova il 21 novembre 1973, con la partecipazione di A. Caracciolo, G. Giarrizzo, R. Manselli, E. Ragionieri, R. Romano, R. Villari, C. Vivanti, e con interventi di A. Macchioro, S. Lanaro, M. Reberschak), ? Qua derni storici ?, n. 26 (maggio^agosto 1974), pp. 523-58.
La < crisi del Trecento >>. Bilancio e prospettive di ricerca 661
oltre ?. In quest'andamento negativo della congiuntura, che interessa tutta l'Europa occidentale e centrale, si manifesta, a parere del Sereni, la prima crisi della << formazione feudale ?. Dopo la sua costituzione e la sua massima fioritura, essa entrerebbe ora nella < sua prima crisi, nel corso della quale i limiti che i rapporti di produzione feudale cominciano ormai ad opporre allo sviluppo delle forze produttive sociali, appaiono con particolare evidenza #. ? Si tratta in primo luogo, intanto, proprio della gia accennata battuta d'arresto nel gran moto espansivo dei dissodamenti. Nei secoli tra l'XI ed il XIII, invero, la rapidissima estensione delle superfici a cultura aveva portato al dissodamento di ampie fasce di terre marginali, che - in ragione della loro dislocazione e della loro costituzione stessa - una volta esaurita la loro fertilita, accumulata nel corso di lunghi secoli di riposo, dove vano ben presto rivelarsi come insufficientemente produttive e redditizie, e venire pertanto abbandonate. Nelle condizioni di un livello delle tecniche agricole pratica mente stazionario, cio significa che ne l'estensione, ne l'intensificazione delle col ture possono ormai far fronte all'accrescimento della popolazione; di qui il ripe tersi sempre piiu frequente e generale di carestie, che colpiscono soprattutto gli strati piiu poveri della popolazione, e che sono sempre piu spesso seguite da gravi epidemie, come queUe, appunto, del 1347-48 e dei decenni successivi. Ad uno sfruttamento delle masse lavoratrici rurali ed urbane, aggravato dall'accen tuarsi del gusto per il lusso da parte delle classi dominanti e dallo sviluppo mer cantile e monetario di tutta l'economia, fa ora d'altronde riscontro la mancanza di controparte in una accresciuta produttivit'a del lavoro: onde il progressivo e generale aggravarsi delle lotte di classe che, nelle citta come nelle campagne, in tutto l'occi dente europeo punteggiano, con le loro violente esplosioni, la storia di questa eta >>. Nel Piemonte, nel Friuli, nel Trentino o in altri settori, << come quello laziale, meridionale o siciliano, nei quali la solidita del potere dei grandi feudatari era restata meno gravemente scossa dall'impeto del moto comunale, le lotte e gli scoppi dell'ira contadina assumono in questo periodo il loro massimo rilievo e tutta la loro portata. Altrove, quelli che assumono il rilievo piiu evidente, improntando di se tutta la vita sociale, sono piuttosto i contrasti e le lotte di classe tra i ceti urbani, che nascono dagli sviluppi stessi del moto comunale, e che esplodono in tutta una serie di insurrezioni popolari, anch'esse concluse, generalmente, con una selvag gia repressione da parte delle classi dominanti # (Storia, I, pp. 189-192).
La lunga citazione e giustificata dal fatto che queste pagine del Sereni offrono una interpretazione generale che, pur comprendendolo, va di la dello stesso oggetto del suo saggio. Degli aspetti stessi della crisi egli non manca di segnalare, d'altra parte, quelle che a suo giudizio sono le peculiarita italiane. Nella penisola, al moto di arresto dei dissodamenti e dei disboscamenti di pianura si sarebbe accompagnata una migliore sistemazione delle zone collinari con opere di scasso e piantagioni arboree e arbustive, almeno relativamente all'Italia << comunale ?>, mentre nelle zone a coltura estensiva, come nella Maremma, nella Campagna romana e in larghi settori del Mezzogiorno e della Sardegna, << la riduzione della coltura granaria si traduce in una drastica riduzione delle superfici a coltura nel loro complesso, ed in una nuova estensione delle superfici destinate al pascolo delle greggi. Qui, come in altre parti dell'Europa occidentale (in Spagna, in primo luogo, ed in forme diverse, in Inghilterra), i bassi prezzi del grano, e I'aumento del costo della mano d'opera, conseguenti alla depressione demografica, combinando i loro effetti con quelli dell'accresciuta domanda e degli alti prezzi della lana, e degli altri prodotti dell'allevemento, specie ovino (carne, pelli, ecc.), provocano un profondo turba mento dell'equilibrio agricolo-pastorale, spostandolo decisamente nel senso di uno
662 Giovanni Cherubini
sviluppo e di una riorganizzazione sistematica della pastorizia transumante?
(p. 199). Alla interpretazione della ? crisi ? offerta dal Sereni, meglio, alle sue compo
nenti, vengono aggiunti alcuni supporti nel V volume della Storia. Christiane Klapisch-Zuber, che si 'e gia occupata di questo tema 2, porta, nel saggio Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne, un contributo notevole all'impostazione del problema degli abbandoni del Tre-Quattrocento. Anche questa studiosa sottolinea la diversita degli esiti fra il Mezzogiorno e l'Italia <<comunale ?, per la quale vengono giustamente messi in rilievo il peso che sull'habitat ebbe la diffusione della mezzadria e delle case isolate sui campi e con osservazioni particolari che non sempre ci trovano d'accordo, ma che non "e possibile discutere dettagliata mente in queste brevi pagine 3. Athos Bellettini, in alcune pagine del suo saggio su La popolazione italiana idall'inizio dell'era volgare ai giorni nostri, passa brevemente ma chiaramente in rassegna i caratteri, la profondita e le cause della crisi demo grafica del XIV secolo.
Dicevamo piiu indietro di << adeguamento >> della storiografia italiana ad una problematica nata fuori del nostro paese. Aggiungiamo ora che si tratta spesso di materiali di riporto - nel senso migliore del termine - e che la stessa interpreta zione generale del Sereni ben poco deve a ricerche italiane e assai di piiu ad una attenta lettura di ricerche non italiane. Si puo anzi aggiungere che, in piiu di un caso, cio che relativamente ella <<crisi >> si sa dell'Italia e dovuto a ricerche di studiosi stranieri. Se si escludono infatti le precoci prese di posizione di uno studioso largamente aperto alle problematiche e alla acquisizione della storiografia internazionale come Carlo M. Cipolla, gia presente nel dibattito fin dal 1949 4, bisogna giungere al 1966 per trovare, ad opera di Ruggiero Romano - significati vamente, uno dei coordinatori della Storia Einaudi e per anni docente all'Tcole pratiques des Hautes IRtudes - un intervento generale relativo all'Italia 5. Non
2 Cfr. Gh. Klapisch Zuber J. Day, Villages d?sert?s en Italic Esquisse, nel vol. collettivo Villages d?sert?s et histoire ?conomique, XI-XVIII si?cles, Pans 1965, pp. 419-59. La Klapisch ha continu?t? ad occuparsi anche negli anni successivi di demograf?a storica italiana. (Ofr. Fiscalit? et d?mographie en
Toscane (1427-1430), ?Annales?, XXIV (1969), -pp. 1313-1337). 3 Le opinioni dello scrivente sono state esposte in G. Cherubim, R. Fran
covich, Forme e vicende degli insediamenti ndla campagna toscana dei secoli
XIII-XV, ? Quaderni storici ?, n. 24 (settembre^dicembre 1973), pp. 877-904, al
quale per brevit? rimandiamo. 4 C. M. Cipolla, The Trends in Italian Economie History in the Late
Middle Ages, ? The Economic History Review ?, 1949. Successivamente l'autore
? ritornato a pi? riprese sull'argomento, ma per brevit? rinvio al suo recente e
stimolante volume Storia econ?mica dell'Europa preindustriale, (Bologna 1974),
dove, oltre che un elenco di molti suoi scritti, ? possibile vedere come egli inse
risca l'Italia nella ? crisi ? del Trecento. 5 R. Romano, LTtalia nella crisi del XIV sec?lo, ? Nuova rivista storica ?,
L (1966), pp. 580-95, ora in Tra due crisi: Vitalia del Rinascimento, Torino
1971, pp. 13-35 (nel volume sono pubblicati altri saggi, di data precedente o
successiva a quello citato, che ruotano intorno al problema della crisi). Le
opinioni dell'autore al riguardo sono esposte anche in opere di carattere pi?
gen?rale e divulgativo come il vol. 12? della Storia Universale Feltrinelli, steso in
collaborazione con Alberto Te?en ti, AUe origini del mondo moderno (1350-1550), Milano 1967, pp. 9-48.
La < crisi del Trecento >> bilancio e prospettive di ricerca 663
che, nel frattempo, il problema non sia stato risollevato - magari soltanto in rela zione a qualche regione italiana6, o da studiosi a contatto con la scuola delle <? Annales >> '- o che non sia stato almeno presente in alcuni studiosi italiani piiu avvertiti (basti ricordare, a tale proposito, il tentativo di nuova periodizzazione del Rinascimento portato innanzi da Armando Sapori, tentativo che sottintende appunto la presenza di una crisi nel corso del Trecento', e la vivace polemica Sapori-Melis relativa al Datini, che si iscrive sempre, da parte del Sapori, in questa prospettiva) 9. Ma la problematica della crisi 'e presente anche in qualche lavoro particolare 10, dagli anni piu recenti e penetrata anche in qualche manuale
6 La tem?tica relativa alla crisi era ad esempio presente pi? di died anni
fa, soprattutto per quel che riguarda i problemi agricoli e demografici, nel
bel volume di S. Tramontana, Mich?le da Piazza e il potere b atonde in Sicilia, (Messina-Firenze 1963). Intorno a quegli anni apparve anche una breve nota
di G. Miani, L'?conomie lombarde aux XIV et XV si?cles: une exception ? la
r?gle}, ?Annales?, XIX (1964), pp. 569-79. Si trattava, in quest'ultimo caso, di una studiosa a contatto con la francese ?cole Pratique des Hautes ?tudes.
7 Ricorder? che a questa tem?tica si rif?, in qualche modo, il noto e bel
volume di A. Tenenti, Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento
(Francia e Italia), Torino 1957 (cfr. soprattutto p. 14: ?Se nel sec?lo che va
dal 1250 al 1348, o addirittura dall'XI in poi, si possono trovare sintomi inte
ressanti del fen?meno spkituale che considero aperto appunto nel 1348 ed esaurientesi nella seconda meta del Cinquecento, tali sintomi resta?o delle rare
o sommesse anticipazioni, delle manifestazioni assai esili o claustrali. ? fuori
dubbio che Fascetismo mon?stico dei sec?la X-XIII costituisce un capitolo im
portante del senso della morte nel Medioevo: ?, pero, un capitolo che si deve inserir? in una fase anteriore a quella che s'inizia intorno al 1348. Per quanto
Faffermazione possa apparire azzardata, e purch? la si consideri senza cavilli, insisto nel sottolineare tale data ?. La forza di cesura nella sensibilit? rappresen tata dalla Peste ?era non potrebbe apparire pi? chiara. Com'? noto, un'opera fondamentale e largamente diseussa che pone in grande rilievo l'influenza del Fecatombe dell'ep?demia sulle manifestazioni artistiche ?
largamente esaminate
anche nel libro del Tenenti ? ? il volume di M. Meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death, (Princeton University Press, 1951). Ma sul grande a?fresco del Camposanto di Pisa cfr. il recente volume di L. Bellosi, Buffalmacco e il trionfo della morte, (Torino 1794), che tende a collocarlo cronol?gicamente una ventina di anni avanti al '48, e a dargli quindi un'ispirazione diversa da
quella ? pestista ?. 8 I vari interventi del Sapori hanno assunto la forma pi? org?nica
e ampia nel saggio Medioevo e Rinascimento: proposta di una nuova periodiz zazione, edito nel 1964 e ora ristampato nei suoi Studi di storia econ?mica, vol. III, Firenze 1967, pp. 423-56.
9 Per gli elementi fondamentali di questa pol?mica ofr. F. Melis, A pro
posito di un nuovo volume. ? Il mercante di Prato ?, ? Economia e storia ?, VI
((1959), pp. 737-63; A. Sapori, Un nuovo tipo di mercante e Cambiamento di men
talit? del grande operatore econ?mico tra la seconda meta del Trecento e i
primi del Quattrocento, in Studi, cit., vol. Ill, pp. 223-221, 457-85; e gli interventi dello stesso Sapori, di V. Rutenburg, e del Melis in ?Nuova rivista
storica?, L (1966), pp. 665-719. 10
Ricordo, per la loro importanza, i lavori di R. Comba, La din?mica del
l'insediamento umano nel cun?ese (secoli X-XIII), ?Bollettino storico-biblio
graficc^subalpino ?, LXXI (1973), pp. 51(l-602, e Testimonianze sull'uso dell'incol
to, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte m?ridionale (XIII-XIV
sec?lo), ibid., LXVIII (1970), pp. 415-53; il recente volume di C. Rotelli,
664 Giovanni Cherubini
scolastico ii Cio che e tuttavia mancato e stato, da parte della storiografia italiana, un vero contributo di studi e di ricerche volti ad identificare preliminarmente l'esistenza o meno della crisi per il nostro paese o alcune delle sue regioni e, successivamente, i caratteri e le dimensioni di questa crisi, la sua durata e le sun risultanze. II problema non 'e di poco momento se si pensa che esso coinvolge tutti i caratteri della societa italiana del periodo tre-quattrocentesco, dalle sue basi econo
miche ai rapporti tra le classi, all'organizzarsi del potere politico, allo stesso orientamento della cultura.
Non e possibile, in questa sede, riassumere neppure molto brevemente i poli della discussione svoltasi quasi esclusivamente fuori d'Italia 2, le cui linee e le cui conclusioni pur fornirebbero alla ricerca italiana alcuni parametri su cui misu rarsi e su cui condurre avanti la ricerca. Diro soltanto, con l'unico scopo di for nire qualche riferimento bibliografico di partenza e sottolineare insieme quale varieta di contributi abbia registrato la discussione, che la <? crisi >> ha avuto in alcuni spunti di Pirenne e di Bloch - il primo anche influenzato da un bellis simo e notissimo saggio del Lucas sulla carestia del 1315-1713 - quelli che
Una campagna medioevale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450, (Torino 1973), che ? il primo tentativo di storia agraria regionale basato su lunghe serie quantitative, ?nica strada per dare risposte convincenti ai
problemi della ? crisi ? del Trecento. In quest'ordine di problemi si muovono anche gli studi relativi alie carestie, fra i quali mi limito a ricordare quello
molto informato e ricco di osservazioni importanti di G. Pinto, Firenze e la carest?a del 1346-47. Aspetti e problemi delle crisi annonarie alia meta del
'300, ? Archivio storico italiano ?, CXXX ( 1792), pp. 3-84, dal quale possono trarsi le indispensabili indicazioni bibliografiche. L'autore ha in corso di stampa l'edizione del noto volume conosciuto come il Biadaiolo, importantissimo per studiare i temi relativi all'alimentazione e all'approwigionamento di una grande citt? m?di?vale ? nel caso specifico, Firenze ?, edizione che verra accompagnata da utili serie di prezzi dei cereali. Ricordo che della crisi e della sua incidenza in una piccola zona di montagna ho parlato nel mio Una comunit? rurale dell'Ap
pennino dal XIII al XV sec?lo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del
Trivio al dominio di Firenze, Firenze 1973. 11 Ad esempio in quelli di Rosario Villari (editore Laterza), di Giuliano
Procacci e Bernardino Farolfi (editore La Nuova Italia), di Giorgio Spini (editore Cremonese).
12 Non mancano tuttavia utili strumenti iniziali di informazione come
J. Heers, L'Occident aux XIV et XV si?cles. Aspects ?conomiques et sociaux, Paris 1963, o corne il pi? recente volume di J. Glenisson, J. Day, Textes et
documents d'histoire du Moyen Age XIV-XV si?cles, I, Perspectives d'ensemble.
Les ? crises et leur cadre ?, Paris 1790. Non ho potuto, invece, prendere visione
del lavoro di F. Graus, Das Sp?tmittelalter als Krisenzeit. Ein Literaturbericht
als Zwischenbilanz, ?Mediaevalia Boh?mica?, I (1969), 1. 13 H. S. Lucas. The great European Famine of 1315, 1316 and 1317,
? Speculum ?, 1930. II lavoro del Lucas fu citato dal Pirenne in testa al VII
capitolo de Le mouvement ?conomique et social, che faceva rparte dell'VIII volu me (La civilisation occidentale au Moyen Age du XI au milieu du XV si?cle) d?lTHistoire du Moyen Age, T sezione dtWHistoire g?n?rale diretta da Gustave
Glotz, edito a Parigi nel 1933. Fra le ristampe di questo lavoro di Pirenne, la
pi? importante ? quella in volume separato a cura di H. Van Werveke, col
titolo Histoire ?conomique et sociale du Moyen Age, Paris 1963, di cui ? stata
fat ta una traduzione italiana di id?ntico titolo, (Milano 1967).
La < crisi del Trecento >> bilancio e prospettive di ricerca 665
potremmo chiamare degli illustri << protosostenitori > 14. Successivamente si e arric chita e ampliata e sempre meglio precisata attraverso la spiegazione << neo-malthu siana >> del Postan 15, e dei suoi seguaci, le indagini di demografia storica del Russel 16, la spiegazione <<pampestista>> del Renouard 7, le spiegazioni ? moneta
14 Per Pirenne cfr. la nota precedente; ma gi? nella sua Storia d'Europa dalle invasioni al XVI sec?lo (trad, it., Firenze 1956, pp. 275 sgg.), stesa, com'?
noto, in prigionia, nel corso della prima guerra mondiale, lo storico belga avan
zava alcuni spunti per una interpretazione di ? crisi ? del periodo che ci int? ressa. Per Bloch cfr., in particolare, Seigneurie fran?aise et manoir anglais, Paris
1967, che costitui, materia di un corso di storia econ?mica alla Sorbona nel
1936, (la ? crisi ?, anzi ? le crisi ? dei secoli XIV e XV e le loro conseguenze vi sono trattate aile pp. 101 sgg.). In primo piano Bloch pone le cause ?monetarie?, in secondo piano le distruzioni della guerra dei cent'anni, mentre non si parla ancora della peste e del crollo demogr?fico, terni cosi cari alla successiva sto
riografia sulla ? crisi ?. 15 II primo, fondamentale articolo del Postan, citatissimo dagli autori
successivi, ? The fifteenth Century, ? The Economic History Review ?, 1939, poi seguito da studi particolari (fra i quali, particolarmente importante, Some social
Consequences of the Hundred Years War, ? The Economic History Review ?,
1942), e, died anni pi? tardi, da un articolo d'impostazione molto gen?rale in cui Fipotesi malthusiana trovava chiara formulazione (Some agrarian Evidence
of declining Population in the Later Middle Ages, ? The economic History Review ?, 1950. Questi ed altri articoli del Postan, importanti per una completa informazione delle sue posizioni sulla ? crisi ? son? ora riediti in M. M. Postan,
Essays on Medieval Agricolture and General Problems of the Medieval Economy, Cambridge 1973, volume che, per maggiore completezza, ? opportuno accompa gnare con la lettura dell'altra raccolta di studi Medieval Trade and Finance,
Cambridge 1973. Le posizioni dell'autore son? anche esposte, in forma pi? gen?rale ed org?nica, nel lucido profilo The Medieval Economy and Society. An economic History of Britain, 1100-1500, London 1972.
16 Lo studio tenuto in particolare considerazione nell'intervento pi? gene rale del Postan sulla crisi, (cfr. nota precedente) ? appunto J. C. R?ssel,
British Medieval Population, Albuquerque 1948. R?ssel ha successivamente
ampliato le sue ricerche in Late Ancient and Medieval Population, Philadelphia 1958 (?Transactions of the American Philosophical Society?, n.s., vol. 48, 3). Gli studi e le posizioni del R?ssel sono andati a confluir? nel profilo di storia della popolazione europea tra il 500 e il 1500 stesa per il I volume
della Fontana Economic History, diretta da C. M. Cipolla, 1972, pp. 25-70 (ma in fascicolo separate, gi? edito nel 1969).
17 II primo intervento del Renouard, edito nel 1948, in occasione del sesto centenario della grande epidemia, richiamava l'attenzione sulla sua impor tanza e sul suo int?resse demogr?fico (Consequences et int?r?t d?mographique de
la Peste Noire de 1348); il secondo, pi? ampio ed edito due anni pi? tardi, battezzava senz'altro l'epidemia corne ? il pi? importante awenimento mondiale
del XIV sec?lo ? (La peste noire de 1348-50). L'analisi del Renouard ? comunque ricca di spunti interessanti, e fra gli effetti della grande epidemia cerca di
metiere in rilievo tutta una serie di fenomeni che avrebbero occupato il quadro
negli anni successivi: in primo luogo i vuoti demograf?a, ma anche le conse
guenze economiche e sociali, dalla contrazione della manodopera all'aumento
dei prezzi e dei salari, dalla crisi del sistema signorile alie difflcolt? economiche dei grandi proprietari terrieri, dall'acuirsi dell'odio di classe nel corso del non
eguaHtario comportamento de?'epidemia al presunto favore accordato dalla peste alia concentrazione delle ricchezze attraverso il gioco delle eredit? (i ricchi
soprawissuti ereditavano nuove ricchezze, i poveri continuavano ad ereditare
666 Giovanni Cherubini
rie >> 18, il concetto di << frontiera >> dell'americano Lewis 19, quello di << crisi morale ? del Delatouche 20, i contributi dei marxisti 21, una serie particolarmente nutrita di monografie dedicate all'andamento demografico, alle carestie ed alle epidemie, dei quali fece il punto, nel 1962, Elizabeth Carpentier in un articolo ormai notissimo 2, sottoponendo alla problematica che in quelle pagine veniva esaminata II caso concreto di una citta italiana 23, Negli anni immediatamente precedenti il dibattito era stato arricchito da contributi sulla climatologia storica 24, in quelli successivi, grazie
soltanto ? gli stracci dei loro geni tori ?). I due studi del Renouard sono stati riediti nei suoi ?tudes d'histoire m?di?vale, Paris 1968, vol. I, pp. 143-64.
Un buon strumento di informazione sulla Peste ?era, gli studi relativi, i vari
problemi ad essa connessi, ?, nonostante il suo programmatico tono divulga tivo, il volume di Ph. Ziegler, The Black Death, London 1969. II volumetto
The Black Death. A turning Point in History?, a cura di W. M. Bowsky, New York 1971, oltre ad una breve introduzione e ad una bibliograf?a, offre un'utile raccolta di pagine di studiosi sull'argomento.
18 A queste spiegazioni fornl materiale, tra il '50 e il '60, la comparsa di studi dedicati a salari, prezzi e moneta. Con esiti e con impostazioni spesso
molto divergenti, ricordiamo i nomi di F. Graus, E. Perroy, J. Schreiner, W. C. Robinson (da vedere, degli ultimi due, rispettivamente gli articoli Wages and Prices in England in the Later Middle Ages, e Money, Population and economic
Change in Late Medieval Europe, entrambi in ? The Economic History Review ?, 1954 e 1959). Per ulteriori indicazioni bibliografiche cfr. la bibliograf?a alla fine del volume I prezzi in Europa dal XIII sec?lo a oggi. Saggi di storia dei
prezzi raccolti e presentati da Ruggiero Romano, Torino 1967. 19 A. R. Lewis, The closing of Medieval Frontier, ? Speculum ?, 1958, pp.
475-83. 20 R. Delatouche, La crise du XIV si?cle en Europe occidentale, ? Les ?tudes
sociales ?, 1959, pp. 149. 21 Gi? nel 1946 Dobb, nei suoi Studies in the development of capitalism
(cfr. M. Dobb, Problemi di storia del capitalismo, Roma 1970, specialmente pp. 79 sgg.) spiegava la crisi del Trecento come una crisi dell'economia feudale e
perci? parte del pi? gen?rale problema del passaggio dalla forma di produzione feudale a quella capitalistica. Pochi anni dopo R. H. Hilton, Y-eut il une crise
g?n?rale de la f?odalit??, ? Annales ?, 1951, cercava, sulla scia del Dobb, di fornire uno schema gen?rale di spiegazione del meccanismo della ? crisi ? in
contrapposizione a quelli dei neo-^malthusiani e dei monetari. Negli stessi anni un vivace dibattito sul tema del passaggio dal feudalesimo al capitalismo si
sviluppo nella rivista americana ? Science and Society ? (cfr. ora Sweezy, Dobb, Takahashi, Hilton, Hill, Lefebvre, Procacci, La transizione dal feudalesimo al
capitalismo, a cura di Guido Bolaffi, Roma 1973). ? opportune ricordare anche, per il suo particolare rilievo nella pol?mica contro il Postan, la voce del russo E. A. Kosminsky, dei cui interventi ci limitiamo a ricordare, per la loro maggiore accessibilit?, The evolution of feudal rent in England from XI to XV centuries, ? Past and Present ?, 1955, n. 7, pp. 12-36, e Peut-on consid?rer le XIV et le XV si?cles comme l'?poque de la d?candence de l'?conomie europ?enne?, in Studi in onore di Armando Sapori, Milano 1957, vol. I, pp. 551-69.
22 E. Carpentier, Autor de la peste noire: famines et ?pid?mies dans l'histoire du XIV si?cle, ?Annales?, 1962, pp. 1062-1092.
23 E. Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la Peste Noire de
1348, Paris 1962. 24 L'articolo forse pi? letto e senza dubbio affascinante, per quanto non
sempre convincente, ? stato in questo campo quello di G. Utterstr?m, Climatic Fluctuation and Population Problems in early modern History, ? The Scandinavian Economic History Review ?, 1955, pp. 3-47. Su questi problemi rimandiamo, per
La <? crisi del Trecento >>. Bilancio e prospettive di ricerca 667
anche alla pubblicazione di un volume collettivo di particolare rilievo23, uno dei poli del dibattito sarebbe stato il problema dei <<villaggi abbandonati >> 26, tema sollevato con particolare vigore dal tedesco Abel 27, e dall'inglese Beresford 28,
Come si inserisce la vicenda italiana in questa ricca problematica e fino a che punto e in quali direzioni e stata chiarita la trama di fondo della storia della penisola nei secoli XIV e XV? Quali problemi dovrebbero essere affrontati dai medievisti per fare del tema della << crisi >> in Italia non una semplice sovrapposi zione di una vicenda comune, di caratteristiche specifiche?
Ho iniziato mettendo in fila alcuni interrogativi e altri interrogativi dovro aggiungere piiu avanti, non per il gusto abbastanza sterile di mettere in rilievo cio che non si sa, ma con l'intento, viceversa, di indicare verso quali strade dovrebbe avviarsi la ricerca. Si tratta non soltanto di indicazioni per altri, ma anche di orientamenti di massima per l'indagine che sto conducendo da alcuni anni su una citta italiana ed il suo territorio tra Trecento e Quattrocento. E' sottinteso che,
brevit?, a E. Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil, Paris 1967, limitandoci qui a ricordare il rilievo che il fattore clim?tico ? ma non quello sortante*, dovendosi, secondo gli autori, mettersi nel conto anche il progressivo impoverimento del suolo e l'estensione della cultura a terre marginali
? assume nell'andamento dei raccolti (e questi, a loro volta, sulFandamento della mortalit? fra i contadini) nella ricerca di M. Postan J. Titow, Heriots and prices on
Wincester Manors, ? The Economie History Review ?, 1959, ora in Postan, Essays on Medieval Agricol?ure, cit., pp. 150-185, tema poi ripreso, ampliato e meglio documentato in J. Titow, Evidence of Weather in the Account rolls of the Bishopric of Winchester, 1209-1350, ? The Economic History Review ?, 1960, pp. 360-407.
25 Villages d?sert?s et histoire ?conomique, XI-XVIH si?cles, Paris 1965.
26 Un buon orientamento bibliogr?fico iniziale su questo problema e sugli indirizzi dell'archeologia m?di?vale e dello studio del popolamento pu? vedersi in R. Francovich, M. S. Mazzi, Le campagne europee dopo il Mille, Firenze 1974, pp. 45-48. Cfr., per quel che riguarda lo stato della ricerca in Italia, il n. 24
(settembre-dicembre 1973), di ? Quaderni storici ?, interamente dedicato al 1'? Archeologia e geograf?a del popolamento ?.
27 Si cfr. W. Abel, Spopolamento dei villaggi e caduta dei prezzi in Europa nel Basso Medioevo (articolo del 1953), in I prezzi in Europa dal XIII sec?lo a oggi, cit., pp. 87-141. Dell'opera pi? importante dell'Abel, la cui prima edizione ? del 1935, ho presente la recente traduzione francese condotta sulla seconda edizione tedesca (1966), rivista e aumentata, Crises agraires en Europe (XIII-XX si?cle, Paris 1973). L'autore dichiara che ? quand la premi?re edition de ce livre
parut, il y a plus de trente ans, mon intention ?tait d'aborder un domaine jusque l? n?glig? par la recherche historique: les prix, les salaires, les rentes fonci?res, la production agricole, le mouvement d?mographique et le niveau de vie de
larges couches de la population ? afin de trouver une r?ponse ? cette question
pr?cise: dans quelle mesure (et non pas tellement: sous quelle forme), l'agriculture et l'?conomie vivri?re de l'Europe ont-elles r?ussi depuis le milieu
du Moyen Age ? satifaire les besoins des hommes? ?. Sono queste le stesse do mande del Postan, formulate qualche anno prima di lui, e sono le domande in
torno aile quali ruota ancora, in buona misura, la ricerca sulla ? crisi ?. 28 M. W. Beresford, The lost villages of England, London 1954. Ma cfr. il
pi? recente M. Beresford, S. G. Hurst, Deserted Medieval Villages, London 1971, che contiene abbondanti indicazioni bibliografiche relativamente allTnghilterra.
668 Giovanni Cherubini
come sempre avviene, alcuni di questi orientamenti di partenza potranno anche risul tare fallaci, o mal posti, o in parte erronei e approssimativi, man mano che il lavoro andra avanti. E' anche sottinteso che a molte curiosita la documentazione non sara forse in grado di fornire una risposta. Ma questo non impedisce, naturalmente, di porre i problemi.
Per uno dei problemi relativi alla <<crisi >> si intravede con sicurezza una soluzione per tutta la penisola: quello relativo all'andamento della popolazione.
Mettendo insieme le indicazioni dei vecchi studi, le notizie delle cronache e le indagini piiu recenti - particolarmente numerose e convincenti quelle relative alla Toscana - - ne risulta con chiarezza il quadro di un'Italia colpita altrettanto duramente che il resto del continente dalla contrazione demografica, anche se non e possibile, nel complesso, dare con sicurezza, in particolare per le campagne, una dimensione quantitativa a questa crisi. Risulta anche, dagli studi piiu recenti, che la crisi demografica non si fece sentire a partire dalla Peste Nera, ma, almeno in certi luoghi, gia prima, anche se in forme non cosi catastrofiche. Cio porterebbe a pensare che la spiegazione << malthusiana >>, il problema cioe del sovrappopolamento e del crescente squilibrio tra mezzi di sussistenza e ammontare della popolazione sovrappopolamento, naturalmente, ai livelli produttivi dell'agricoltura medievale. che, com'e noto, erano molto bassi - si facesse sentire anche nella penisola.
Ma per verificare l'ipotesi << malthusiana ? bisognerebbe indagare in tre dire zioni: studiare le vicende climatiche -e di recente e stata, ad esempio, fornita qualche indicazione per il Piemonte30 per vedere se tra fine Duecento e inizio Trecento queste abbiano determinato un peggioramento dei raccolti, verificare in casi concreti se questo peggioramento c'e stato, indagare se si e verificato un ,peggioramento della dieta alimentare nella cronica sottoalimentazione dei ceti
piZu umili, cosi come si e ipotizzato per l'Inghilterra. Corollario indispensabile per verificare l'ipotetica strozzatura << malthusiana >>
sarebbe l'esame, in casi concreti, di come si ripartissero le ricchezze e, piju in particolare, di quanta parte dei prodotti alimentari a disposizione della societa nel suo complesso andasse ai singoli gruppi e ai singoli ceti. Non tutti, infatti, erano esposti alla minaccia della fame. C'era anche chi guazzava nell'abbondanza e anzi traeva dalle difficolta dei piiu il mezzo per speculare e arricchirsi. Sarebbe in primo luogo da vedere se costoro riuscissero piiu degli altri a sfuggire alle stesse epidemie, perche meglio nutriti, perche meglio protetti daIl'igiene, perche pitu in grado di allontanarsi dai luoghi infetti. Le cronache e molti indizi particolari lasciano supporre che la risposta debba essere affermativa, ma si sente la necessita di qualche indagine concreta, con lunghe serie di dati quantitativi - gli unici, in questa sede, ad autorizzare una risposta. Cosl come e da studiare l'eventuale esplodere di un vero e proprio odio dei poveri contro i ricchi di fronte ad epidemic e carestie che colpivano in maniera cosl poco egualitaria.
Sulla ripartizione della ricchezza si sa molto poco. Anche per le citta e per le zone studiate le fonti si limitano spesso a darci cifre d'estimo relative ai singoli proprietari, ma non la composizione particolareggiata della loro proprieta
29 Particolarmente p?rtate avanti da Enrico Fiumi (San Gimignano e Prato) e David Herlihy (Pisa e Pistoia). Per indicazioni pi? precise e pi? ampie cfr. Che rubini-Fr ancovich, Forme e vie ende, cit.
30 Cfr. Rotelli, Una campagna m?di?vale, cit., pp. $7 sgg., 174 sgg. (noti zie precedenti i dati sui conti delle sing?le castellanie), 314 sgg.
La <? crisi del Trecento >>. Bilancio e prospettive di ricerca 669
e il reddito che essi ricavavano da questa e dalle loro attivita professionali, mentre sarebbe necessario conoscere nei piiu piccoli dettagli tutta una societa per sperare di verificare l'incidenza della crisi. Non e attualmente possibile stabilire invece, nonostante si sia fatto qualche tentativo ", se pesti o carestie spingessero verso una maggiore o una minore stratificazione sociale o, meglio ancora, in quale direzione agi la crisi nel suo complesso. Manca infatti, per il momento, qualsiasi indagine sulla composizione sociale - quale noi la intendiamo - di una citta italiana, tanto meno di una regione italiana, sia per la fine del 'Duecento, sia per tutto il Trecento e per la prima met'a del Quattrocento. Per conocere la composi zione sociale e necessaria una indagine basata su dati quantitativi, che indichi na turalmente, in primo luogo, la ripartizione della ricchezza, ma ci dica anche, con una certa approssimazione, quanti erano all'interno delle mura i salariati, quanti i mendicanti e i disoccupati, quanti gli artigiani indipendenti, i borghesi, i nobili, come, infine, si strutturasse la societa nel contado. E bisognerebbe sapere poi come si nutrisse il <<componente medio?> di ogni ceto e di ogni classe, e seguire l'evoluzione delle sue condizioni attraverso i decenni. Cio che e sicuramente pos sibile per certi gruppi di salariati, di cui e agevole stabilire, come mostrano ottime ricerche recenti, non soltanto il salario nominale, ma anche il salario reale.
Si deve anche aggiungere che una comprensione di tutta l'evoluzione della societa e soprattutto dei suoi momenti di maggiore ebollizione - si pensi, in primo luogo, alle rivolte degli operai della lana a Perugia, Siena, Firenze... - non puo essere compresa soltanto attraverso un meccanico accostamento tra la tendenza di lungo periodo, ipoteticamente recessiva, e gli stessi avvenimenti, ma dall'accorto accostamento tra tendenza di fondo e momenti congiunturali 32. Si dira che stu diare tutto questo e molto difficile. Molto difficile certamente, ma non impossibile, soprattutto -per certe regioni o certe citta dell'Italia centrale o settentrionale, che racchiudono nei loro arahivi tesori, ancora in larga parte inesplorati, di fonti, dalle deliberazioni dei consigli cittadini a fonti elaborabili statisticamente, come com pensi a salariati o prezzi di generi di prima necessita.
31 Si veda quanto dice D. Herlihy (Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento
1200-1430, Firenze 1972, pp. 168-70) sulla presunta influenza della crisi e della
depressione demogr?fica nella decisiva affermazione del sistema mezzadrile. 32 Si veda quanto potrebbe ricavarsi di utile da tabelle di ? salari reali ?
(in calorie) quali quelle costruite per ortolani, muratori, manovali fiorentini per il periodo 1326-1378 da Ch. M. De La Ronci?re, Pauvres et pauvret? a Florence au XIV si?cle, in Etudes sur l'histoire de la pauvret? (Moyen Age-XVI si?cle), sous la direction de M. Mollat, Paris 1974, vol. II, pp. 674, 679, 682. Nel miglio ramento dei salari nel corso del periodo 1350-1378 rispetto ai venticinque anni
precedenti, il decennio 1371-78 pare segnare un momento di crisi. Pu? ahitare
questa constatazione del cattivo momento congiunturale per gruppi diversi di
lavoratori a collocare un po' meglio la stessa rivolta dei Ciompi? L'ipotesi ? in teressante e, per quanto non sia possibile dare una risposta, i dati del De La Ron
ci?re mostrano quanto sarebbe affascinante studiare i problemi di fondo della societ? m?di?vale (nel caso specifico i rapporti di classe all'interno della produ zione laniera) con il corredo di una conoscenza della congiuntura. I momenti ec
cezionali rappresentati dalle ? rivolte ? popolari potrebbero essere collocati in
modo pi? esatto. Ricordiamo che alla migliore conoscenza di questi problemi per la societ? fiorentina del Trecento porteranno un contributo anche le ricerche di
R. A. Goldthwaite, che ci ha fatto gentilmente leggere, dattiloscritto, un suo arti colo di prossima pubblicazione su ? Quaderni storici ?, relativo al prezzo del grano a Firenze dal XIV al XVI sec?lo, ricco di lunghe serie e di grafici.
670 Giovanni Cherubini
Ma la stessa tendenza di lungo periodo 'e poi veramente chiarita? Per spie gare I'andamento recessivo dell'economia sul piano quantitativo si e di solito ancora costretti a citare i dati relativi alla produzione laniera fiorentina, a cibo aggiungendo qualcosa sulla finanza e il commercio delle citta marittime, e pochi altri dati ". Ma per poter dare risposte esaurienti bisognerebbe conoscere, almeno sommariamente, l'andamento complessivo della produzione, di quella agricola come di quella manifatturiera, oltre che le variazioni nel volume del grande commercio o, quanto meno, presumendo che le fonti ben di rado offrano simili risposte, almeno tutta una serie di parziali, ma convergenti indicazioni.
Lo stesso discorso puo farsi su quello che, talvolta, viene chiamato il carattere socialmente <? liberatorio >> della crisi. Allo stato attuale della ricerca questa affermazione e piu un postulato che una conclusione, perche quella man canza di conoscenze sulla struttura della societa italiana in momenti cronologica
mente diversi di cui abbiamo gia detto impedisce tuttora qualsiasi verifica.
Giovanni Cherubini
33 Cfr., a tal proposito, il gi? citato articolo di Romano, LTtalia nella crisi.
Si veda anche H. A. Miskimin, The Economy of Early Renaissance Europe, 1300
1460, Prentice-Hall 1969, pp. 98-99, 130, nel quale Fautore riassume tutto un
indirizzo di ricerca, suo e di altri (fra questi Roberto Sabatino Lopez).