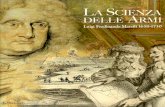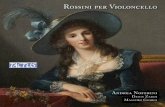Per il gran principe Ferdinando: tre opere del museo dell’Opificio delle Pietre Dure e alcuni...
-
Upload
innovazioniperlaterra -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Per il gran principe Ferdinando: tre opere del museo dell’Opificio delle Pietre Dure e alcuni...
R E S T A U R O 24 2012
Rivista dell’Opificio delle Pietre Duree Laboratori di Restauro di Firenze
Centro Di
OPD RestauroRivista dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze24 2012
SoprintendenteMarco Ciatti
DirezioneMarco Ciatti, Giancarlo Lanterna, Patrizia Riitano
Comitato di redazioneAlfredo Aldrovandi, Fabio Bertelli, Roberto Boddi, Giancarlo Buzzanca, Marco Ciatti, Cecilia Frosinini, Carlo Lalli, Annamaria Giusti, Francesca Graziati, Clarice Innocenti, Giancarlo Lanterna, Maria Donata Mazzoni, Anna Mieli, Letizia Montalbano, Simone Porcinai, Patrizia Riitano, Laura Speranza, Isetta Tosini, Maria Alberta Zuffanelli
RedazioneFabio Bertelli, Susanna Pozzi
Archivio restauriRebecca Giulietti, Giuliana Innocenti, Perla Roselli
Gabinetto fotograficoMarco Brancatelli, Giuseppe Zicarelli
Ufficio Promozione CulturaleDaria Del Duca, Giuliana Innocenti, Susanna Pozzi, Angela Verdiani
Direzione e Redazione Opificio delle Pietre Dure Via Alfani 78, 50121 Firenze Tel. 0552651347 Fax 055287123
www. opificiodellepietredure.itopd.promozioneculturale@beniculturali.it
Autorizzazione del Tribunale di Firenzen. 3914 del 16.12.1989Iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione n. 7257
Associato all’Unione StampaPeriodica Italiana
Hanno collaborato a questo numero
Opificio delle Pietre DureAlfredo Aldrovandi, Gianna Bacci, Fabrizio Bandini, Roberto Bellucci, Roberto Boddi, Andrea Cagnini, Chiara Cappuccini, Isidoro Castello, Francesca Ciani Passeri, Marco Ciatti, Gabriele Coccolini, Susanna Conti, Alberto Felici, Cecilia Frosinini, Monica Galeotti, Annamaria Giusti, Luisa Gusmeroli, Clarice Innocenti, Giuliana Innocenti, Francesca Kumar, Carlo Lalli, Maria Rosa Lanfranchi, Giancarlo Lanterna, Paola Ilaria Mariotti, Maria Donata Mazzoni, Letizia Montalbano, Simone Porcinai, Patrizia Riitano, Maria Rizzi, Perla Roselli, Chiara Rossi Scarzanella, Andrea Santacesaria, Oriana Sartiani, Isetta Tosini, Caterina Toso, Luigi Vigna
Collaboratori esterni
Comune di FirenzeMuseo di Palazzo VecchioSerena Pini, Curatore
Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoLuca Nassi
ICVBC – CNR, FirenzeBarbara Salvadori
IFAC – CNR, FirenzeBruno Radicati
Museo Archeologico “U. Formentini”, Castello di San Giorgio, La SpeziaDonatella Alessi, Conservatore
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di FirenzeGalleria degli UffiziAntonio Natali
Università degli Studi di FirenzeDipartimento di Ingegneria Civile e AmbientalePietro Capone, Tommaso Giusti
Rebecca Giulietti, archivista
Darya Andrash, Claudio Celi, Marco Erbetti, Federica Innocenti, Arcangelo Moles, diagnosti in Beni culturali
Restauratori privati
Rita Banci, Ilaria Barbetti, Paolo Belluzzo, Francesca Boniforti Piccolino, Ottaviano Caruso, Ciro Castelli, Marta Cimò, Lidia Cinelli, Svèta Gennai, Irene Giovacchini, Sara Guarducci, Federica Favaloro, Martina Fontana, Chiara Fornari, Serena Martucci di Scarfizzi,
Direttore responsabileGinevra Marchi
Copyright 1989 Centro Didella Edifimi srl, FirenzeOpificio delle Pietre Dure, Firenze
Stampa Alpi Lito, Firenze marzo 2013
Pubblicazione annualeISSN 1120-2513
Prezzo di copertina e 110,00
Abbonamentie 80,00 (Italia) e 100,00 (estero)
Distribuzione e abbonamentiCentro DiLungarno Serristori 35, 50125 Firenzetel. 055 2342666 / fax 055 [email protected]
Antonio Mignemi, Cristina Nencioni, Luigi Orata, Martina Panuccio, Alice Papi, Elisa Pucci, Giancarlo Raddi Delle Ruote, Filippo Tattini, Elisa Todisco, Chiara Valcepina, Andrea Vigna
Carlotta Brovadan, Marco Betti, Mario Marcenaro, storici dell’arte
Editoriale
Contributi
Note di restauro
7
13
33
45
57
71
90
99
110
117
124
139
149
L’Opificio tra presente e futuroMarco Ciatti
La Banderuola di Palazzo Vecchio: vicende conservative, restauro, storiaAndrea Cagnini, Svèta Gennai, Maria Donata Mazzoni, Antonio Mignemi, Serena Pini, Simone Porcinai, Elisa Pucci, Chiara Valcepina
Gli antichi codici di San Giacomo della Marca del Museo Civico di Monteprandone. Un intervento di conservazione programmata e di didattica decennale (2002-2012)Roberto Boddi, Gabriele Coccolini, Letizia Montalbano, Isetta Tosini
Un nuovo avvicinamento sistematico al restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci Roberto Bellucci, Ciro Castelli, Marco Ciatti, Cecilia Frosinini, Antonio Natali, Patrizia Riitano, Andrea Santacesaria
Applicazioni della spettroscopia infrarossa portatile nella diagnostica e monitoraggio dei Beni Culturali: vantaggi e limitiAlfredo Aldrovandi, Andrea Cagnini, Claudio Celi, Marco Erbetti, Monica Galeotti, Carlo Lalli, Giancarlo Lanterna, Simone Porcinai, Maria Rizzi, Barbara Salvadori, Isetta Tosini
La Cappella Maggiore della Basilica di Santa Croce a Firenze:la fine di un restauro, l’inizio di una curaDarya Andrash, Andrea Cagnini, Monica Galeotti, Carlo Lalli, Federica Innocenti, Maria Rosa Lanfranchi, Giancarlo Lanterna, Arcangelo Moles, Maria Rizzi, Isetta Tosini
Ottimizzazione della gestione della prevenzione incendi per gli edifici monumentali. Il caso-studio della sede della Fortezza da Basso dell’OPDPietro Capone, Tommaso Giusti, Luca Nassi
Un cratere a figure nere nella raccolta “Mauro Manfredi” al Museo del Castello della Spezia: aspetti morfologici, problematiche d’intervento ed una prima proposta di protocolli d’indagineDonatella Alessi, Andrea Cagnini, Monica Galeotti, Simone Porcinai, Luigi Vigna
Materiali di deposito negli arazzi: i meccanismi di sedimentazione e l’interazione con l’intreccioGianna Bacci, Rita Banci, Isetta Tosini
Gli aggregati impiegati negli intonaci dipintiAlfredo Aldrovandi, Ottaviano Caruso, Paola Ilaria Mariotti, Maria Rizzi
Strati preparatori originali e problematiche di stuccatura durante il restauro della Croce di San MarcoMarco Ciatti, Luisa Gusmeroli, Elisa Todisco
Il recupero della tavola dipinta distrutta dal terremoto dell’Aquila. L’intervento sul supporto ligneo della Deposizione di Anonimo abruzzese proveniente dal Museo Nazionale dell’AquilaFrancesca Ciani Passeri, Luigi Orata, Chiara Rossi Scarzanella, Andrea Santacesaria
Progetto di approfondimento del metodo integrativo riguardo al restauro delle lacune negli arazzi: valutazioni sulla densità (seconda parte)Marta Cimò, Federica Favaloro, Martina Panuccio, Alice Papi
Schede di restauro
Archivio storico
Attività dell’Opificio 2011-2012
Notiziario
159
175
185
193
203
215
229
241
249
257
263
273
279
284
299
301
302
Due preziose reliquie di San Giovanni Battista. Un restauro innovativo e alcuni suggerimenti espositiviMarco Ciatti, Susanna Conti, Cristina Nencioni
Sintesi di esperienze di restauro nell’intervento sulla Croce settecentesca in argento del Museo Diocesano di BovinoPaolo Belluzzo, Martina Fontana, Clarice Innocenti
Il calco della Mendicante di Quinto Martini: verifica degli elastomeri siliconici e messa a punto del metodo di pulitura e consolidamentoFilippo Tattini, Isetta Tosini
Il Bronzino inedito del Musée des Beaux-Arts di Nizza. Creatività, rigore e conservazioneMarco Ciatti, Oriana Sartiani, Caterina Toso
L’intervento dell’Opificio delle Pietre Dure al Battistero di Albenga nell’arco di un secoloSara Guarducci, Mario Marcenaro, Giancarlo Raddi delle Ruote
Il restauro delle pitture murali trecentesche dell’ex convento di San Jacopo a Ripoli di Firenze oggi Caserma SimoniDarya Andrash, Fabrizio Bandini, Ilaria Barbetti, Lidia Cinelli, Alberto Felici, Federica Innocenti, Carlo Lalli, Serena Martucci di Scarfizzi
Osservazioni durante il restauro di sei rilievi arnolfiani dall’antica facciata del duomo fiorentino: la Madonna della Natività, il frammento dell’Annuncio ai Pastori, due Angeli su frammento di arcata, due Angeli reggicortinaIsidoro Castello, Francesca Piccolino Boniforti
Ricerca di nuovi materiali da integrazione per la terracotta. Il restauro della Madonna con Bambino di Nanni di Bartolo detto il Rosso (noto 1419-1451)Chiara Fornari, Monica Galeotti, Francesca Kumar
L’Assalto finale a Gerusalemme del Museo Nazionale del Bargello.Il restauro di un grande frammento di arazzo medievaleMarta Cimò
Il Tabernacolo della Badia di San Salvatore a VaianoIrene Giovacchini
Per il Gran Principe Ferdinando: tre opere del museo dell’Opificio delle Pietre Dure e alcuni cenni sul suo gusto per le “arti minori”Marco Betti, Carlotta Brovadan
L’archivio di Vincenzo Canuti, restauratore di manufatti ligneiChiara Cappuccini
Un piano in pietre dure documentato e ora ritrovatoAnnamaria Giusti
Restauri eseguiti dal II semestre 2011 al I semestre 2012a cura di Rebecca Giulietti, Giuliana Innocenti, Perla Roselli
Lo stato di avanzamento dei lavori nel restauro dei dipinti murali del lato orientale del Chiostro Verde di Santa Maria Novella a FirenzeFabrizio Bandini, Alberto Felici, Cecilia Frosinini, Andrea Vigna
La conclusione del restauro della Porta del ParadisoAnnamaria Giusti
L’Europa incontra l’Opificio con archlabMonica Galeotti
Archivio storico
263
Per il Gran Principe Ferdinando: tre opere del museo dell’Opificio delle Pietre Dure e alcuni cenni sul suo gusto per le “arti minori”
Marco Betti, Carlotta Brovadan
“Martire di Venere, discepolo delle Grazie”.1 Con queste poche parole, nel suo vivace ritratto degli ul-timi Medici, Harold Acton acutamente compendiava la vicenda biografica del primogenito di Cosimo III. Appassionato mecenate e dilettante di molte arti, il Gran Principe ha goduto fin dall’epoca lorenese di una fortuna critica assai positiva, soprattutto se confronta-ta con quelle del padre Cosimo e del fratello minore Gian Gastone,2 ed è stato oggetto nel nostro secolo di un’attenzione particolare, che ha restituito un profilo completo e approfondito dei suoi interessi per le arti figurative, per la musica e per il teatro.3 Nel museo dell’Opificio delle Pietre Dure Karla Langedijk4 ha riconosciuto il piccolo Ferdinando in un ritrattino su rame (fig. 1), in virtù dell’evidente somiglianza con i lineamenti delicati e paffuti che contraddistingueva-no il principino in dipinti di poco posteriori, licenzia-ti dal fidato ritrattista di corte Justus Suttermans.5 La preziosa effige, provvista dell’originale cornice lignea con intarsi eburnei, accostata da Annamaria Giusti all’ebanista Leonard Van der Vinne,6 documentato a Firenze a partire dal 1659 e più volte scelto dal Gran Principe per lavori di intaglio,7 presenta Ferdinando all’età di circa cinque anni, poco prima che egli co-minciasse a mostrare la sua inclinazione per le arti.8 Il museo conserva anche una tela dalla forma parti-colare (fig. 2) che raffigura a trompe l’oeil un armadio con le ante aperte a rivelarne l’eterogeneo contenuto, composto da quadretti, medaglie, avori, strumenti scientifici e da quant’altro possa rientrare nel gusto enciclopedico della Wunderkammer.9 Il dipinto, du-bitativamente attribuito al fiammingo Domenico Remps10 sulla scorta di Pellegrino Antonio Orlandi e Francesco Maria Niccolò Gabburri che lo ricordano per numerose opere simili lasciate a Firenze,11 fu pro-babilmente eseguito per il marchese Francesco di Co-simo Riccardi, personaggio di spicco tra i cortigiani di Cosimo III e destinatario della lettera che compare
al centro del quadro.12 Solo successivamente, in data imprecisata, esso entrò nella ricca collezione del Gran Principe, com’è testimoniato dall’inventario dei beni redatto all’indomani della prematura morte del delfi-no mediceo.13 Lo scarabattolo dell’Opificio ben rappresenta il gusto innovatore e spregiudicato di Ferdinando, che lo por-tò a prediligere le novità della contemporanea pittura di tocco dell’Italia settentrionale, delle scene di genere e della natura morta.14 L’inventario appena citato, in-sieme a quello steso nel 1698,15 si è rivelato strumento imprescindibile per la ricostruzione delle inclinazioni e della collezione dello sfortunato erede di Cosimo III ed è stato attentamente vagliato da Marco Chiarini per i dipinti,16 da Maddalena de Luca Savelli per le sculture17 e da Francesco Morena per gli oggetti prove-
1. Scuola fiorentina, Ritratto del Gran Principe Ferdinando de’ Medici, olio su rame, 14x15 cm, Firenze, Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, inv. 704.
264
Archivio storico
nienti dalla Cina e dal Giappone.18 Nell’approssimarsi del terzo centenario della morte del Gran Principe, il documento può offrire lo spunto per una breve ri-flessione sull’interesse di Ferdinando per le cosiddette “arti minori”, meno ricorrenti nella sua raccolta, ma comunque da segnalarsi per l’alta qualità delle opere per lui create.
Arredi e oggetti in marmo e pietre dure
Si deve a Enrico Colle il merito di aver collegato a una voce dell’inventario del 1713 lo stipo oggi espo-sto nel museo dell’Opificio (fig. 3), individuandone la provenienza originaria dalla raccolta di Ferdinan-do di Cosimo III.19 Il mobile, realizzato tra il Sei e il Settecento in noce d’India e arricchito da dician-nove formelle in commesso di pietre dure con tral-ci vegetali abitati da uccelli, raggiunse la sua sede attuale nel 1857 dalla Guardaroba di Palazzo Vec-chio e in quell’occasione, date le precarie condizio-ni in cui versava e la necessità di proporlo a even-tuali acquirenti, fu sottoposto a estese integrazioni che interessarono principalmente la parte lignea.20 La lavorazione delle pietre dure, affidata a quel-le Botteghe granducali che, con la dinastia lorene-se, assunsero il nome di Opificio delle Pietre Dure e vennero trasferite nella sede attuale dell’istituto, raggiunse nella Firenze medicea esiti altissimi21 e
si distinse per la magnificenza degli oggetti crea-ti in epoca tardo-barocca sotto la guida di Gio-vanni Battista Foggini e di Giovacchino Fortini.22 Negli elenchi dei beni appartenenti al Gran Principe redatti nel 1698 e nel 1713 vengono ricordati nume-rosi arredi in materiali pregiati: oltre a tavoli dai piani lignei riccamente intarsiati,23 sono documentati an-che esemplari in marmo e pietre dure,24 molti dei qua-li non riconosciuti. Alla restituzione almeno parziale del fasto degli appartamenti di Ferdinando possono contribuire, insieme ai disegni di Diacinto Maria Marmi,25 fondamentali per ricostruire la facies degli ambienti medicei, due tavoli ancora oggi esposti a pa-lazzo Pitti. Il primo (fig. 4) si trova nella sala di Marte, dove fu trasferito in epoca lorenese, e si compone di una lastra di diaspro di Barga e di un esuberante pie-de in legno dorato, che lascia intravedere, nelle ampie volute che accolgono due leoni e un putto, l’influsso dei più importanti scultori attivi all’epoca per la corte granducale, Giovan Battista Foggini e Massimiliano Soldani Benzi.26 Per l’arredo, ricordato nell’inventario del 1698 nella sala dell’Udienza del Gran Principe,27 Marco Chiarini ha rintracciato pagamenti del 1697 all’intagliatore Paolo Monaccorb e dell’anno successi-vo al doratore Giuseppe Picchi.28 Le uscite della Guar-daroba medicea a favore di quest’ultimo, risalenti al 1693, hanno permesso di riferire alla collezione di Ferdinando anche un tavolo con piano in alabastro
2. Domenico Remps (attr.), Natura morta a inganno, olio su tela, 99x137 cm. Firenze, Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, inv. 780.
265
Archivio storico
cotognino retto da due sirene in legno dorato, attual-mente esposto nel Museo degli Argenti (fig. 5).29 Di un terzo tavolo in alabastro di Montauto, menzionato tra i beni inventariati nel 1698 e nel 1713,30 restano oggi solo i quattro sostegni, che furono trasformati in candelabri tra il 1802 e il 1829 e che spiccano per la bellissima invenzione dei tritoni impegnati a soste-nere lo stemma mediceo, immaginato, in ossequio al tema marino, come una conchiglia dischiusa.31 I disegni di Diacinto Maria Marmi restituiscono il gusto mediceo per stanze elegantemente rivestite di quadri e arredate con tavoli sormontati da pre-ziosi oggetti come “oriuoli”, bronzetti e vasi in pie-
tra dura, che non mancavano tra le suppellettili del principe32 e talvolta spiccavano per le fogge bizzarre, come il vaso in cristallo di rocca “in forma di pescie” (fig. 6), identificato da Kirsten Aschengreen Piacen-ti e da lei riferito a un intagliatore di area tedesca.33 Nella collezione di Ferdinando dovevano occupare un posto di rilievo le quattro magnifiche urne in pietra di paragone, oggi esposte nella sala dell’Iliade della Gal-leria Palatina (fig. 7), non solo per la qualità dell’in-taglio, ma anche per il virtuosistico ornamento con putti e cigni in bronzo argentato e dorato, realizzato dal Soldani Benzi tra il 1689 e il 1693.34 La Aschen-green Piacenti35 assegnava correttamente al medesimo
3. Botteghe granducali, Stipo con fiori e uccelli, legno impiallacciato di palissandro, bronzo dorato e pietre dure, 112x165x48 cm. Firenze, Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, inv. 577.
4. Botteghe granducali, Tavolo, piano in diaspro di Barga, base in legno dorato, 100x238x124 cm. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. Mobili di palazzo Pitti 1911 n. 19562.
266
Archivio storico
artista anche la montatura con serpi bronzee eseguita per due vasi in serpentino verde, attualmente ubica-ti all’ingresso del Museo degli Argenti (fig. 8): non registrati nell’inventario del 1713 perché consegnati alla Guardaroba granducale solo nel 1728, essi furono decorati dallo scultore, per volere del Gran Principe, tra il 1694 e il 1698.36 Le sei urne, tra gli esiti mi-gliori delle “arti minori” all’epoca degli ultimi Medici, ben testimoniano quel felice connubio tra il corpo del vaso e la montatura che la Aschengreen Piacen-ti riteneva caratteristica peculiare della manifattura fiorentina, a partire da grandi esempi cinquecen-teschi come la fiasca in lapislazzuli del Museo degli Argenti eseguita su disegno di Bernardo Buontalenti. Nell’elenco del 1713 vengono ricordati anche vasi in pietra dura montati in filigrana d’argento:37 seb-bene nessuno di essi sopravviva, ce ne restituiscono un’idea alcuni progetti del Marmi per opere simi-li38 e un curioso recipiente di produzione messicana (fig. 9), per il quale fu realizzata una montatura di questo tipo in occasione del suo ingresso nella col-lezione del Gran Principe.39 Esso testimonia inoltre l’interesse, poco diffuso altrove ma radicato nella fa-miglia Medici,40 per oggetti provenienti dalle Ame-riche e dalle regioni esotiche in genere, gusto che trovava spazio nella raccolta di Ferdinando grazie a suppellettili come i “quattro bicchierini di cocco dell’Indie con piedi torniti e coperchi simili” e la “noce d’India, intagliatovi di bassorilievo favole d’A-teone et altro”, di cui rimane traccia nei documenti.41 [Carlotta Brovadan]
Oggetti in avorio e in ambra
Ferdinando fu in contatto costante con l’arte,42 fin da bambino studiò, collezionò e trattò personalmente con gli artisti. Perfino le penne più spietate, a volte più morbosamente interessate alle miserie umane, come quella di Gaetano Pieraccini,43 unanimemente gli riconoscono un ruolo di primo piano nel pano-rama storico-artistico toscano tra Sei e Settecento. Come già anticipato, la passione di Ferdinando per le cosiddette arti maggiori è stata ampiamente inda-gata. Anche nel campo della pittura va però notato come il Gran Principe, parallelamente ai noti e quasi rapaci interessi per le opere “in grande” (si veda il caso esemplare della pala Dei del Rosso Fiorentino), si sia dedicato al collezionismo di opere in piccolo, costi-tuendo il suo Gabinetto nella villa Medicea di Poggio a Caiano,44 quasi un novello studiolo, dove Ferdinan-do, analogamente a quanto faceva il granduca France-sco I, amava rifugiarsi e dedicarsi alla contemplazione e allo studio di preziosi capolavori lontano dal pressante controllo del padre.Un collezionismo privato, dunque, destinato al proprio godimento o esteso a una ristretta cerchia di amatori, è quello del principe per le arti mino-ri; ma non solo di collezionismo si trattò: infatti un anonimo diarista di primo Settecento riporta che Ferdinando “possedé l’architettura e il disegno, torniava ed acquerellava”, oltre a ricordarci che “si dilettò assaissimo della musica, suonava vari stru-menti a perfezione, ma il cembalo da gran profes-sore”.45 Quindi non solo collezionista e conoscito-
5. Manifattura fiorentina, Tavolo, piano in alabastro cotognino, base in legno e bronzo dorati, 83x115x180 cm. Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli Argenti, inv. Mobili Artistici n. 150.
Archivio storico
267
re, ma prima di tutto artista, architetto46 e musico. Seguendo le orme del prozio Mattias,47 il principe Ferdinando nutrì una passione particolare per i ma-nufatti in avorio. Materiale assai pregiato, fin dall’an-tichità l’avorio fu accostato all’oro per la realizzazione di sculture di grande importanza. È da sottolineare come quello ricavato dalle zanne degli elefanti fosse l’unico tipo di avorio richiesto, in quanto, nonostan-te tutt’oggi si tendano a considerare d’avorio anche i corni di rinoceronte o i denti di ippopotamo, sap-piamo che essi sono in realtà organi costituiti di un materiale diverso e quindi da sempre non considerati preziosi.
Oltre alla collezione di vasi eburnei torniti del princi-pe Mattias, nella Firenze degli ultimi Medici soltanto la famiglia Riccardi possedeva una grande raccolta di avori, ma si trattava di pezzi esclusivamente di età an-tica, perlopiù di epoca bizantina:48 gli avori medicei quindi, oltre che per la grande abilità dei tornitori, sono notevoli in quanto oggetti scolpiti in età mo-derna. Come ha notato Kirsten Aschengreen Piacenti,49 dal Seicento, per gli oggetti in avorio, fu il nord Euro-pa, e soprattutto la Germania con le città di Mo-naco, Norimberga ed Augusta, il grande centro propulsore da cui poi prese spunto il resto del Vec-
6. Manifattura tedesca (?), Vaso a forma di pesce, cristallo di rocca e argento, h. 42 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1917 (III) n. 25.
7. Massimiliano Soldani Benzi e Botteghe granducali, Urna con putti e cigni, pietra di paragone e bronzo argentato e dorato, h. 81 cm. Firenze, Galleria Palatina, inv. Oggetti d’Arte 1911 n. 1534.
8. Massimiliano Soldani Benzi e Botteghe granducali, Urna con serpenti, marmo serpentino e bronzo dorato, h. 73 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1879 n. 194.
9. Arte messicana e manifattura fiorentina, Vaso montato in filigrana d’argento, h. 20 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1917 (II) n. 24.
268
Archivio storico
chio Continente; non è quindi un caso che i due grandi tornitori (attivi anche come scultori, archi-tetti e scenografi) presenti nel capoluogo mediceo al tempo di Ferdinando fossero Balthasar Permo-ser e Filippo Sengher, entrambi di origini bavaresi. Il Sengher, figura ancora da definire, fu chiamato in Toscana dal granduca Cosimo III, ma fu, durante la sua permanenza a Firenze, al servizio del Gran Prin-cipe Ferdinando; oltre ad essere l’artefice della ristrut-turazione del teatro della Pergola (edificio trasformato e ingrandito in occasione delle nozze di Ferdinando con Violante Beatrice di Baviera),50 fu un fecondo e raffinato scultore, apprezzato per gli straordinari ri-sultati ottenuti con un sapiente uso del tornio e del pantografo, tanto che le sue opere venivano celebra-te soprattutto per le notevoli difficoltà tecniche che presentavano: è noto come l’avorio sia un materiale di grande elasticità, dunque facilmente modellabile, ma per questo anche molto fragile, e quindi richiede un’attenta lavorazione. Stupisce ancora oggi, infatti, l’abilità con la quale Filippo Sengher eseguì il doppio medaglione (13,3x12,7 cm), conservato nel Museo degli Argenti a Firenze, da un unico blocco di avorio: i due ovali, uno raffigurante il profilo di Cosimo III
con lo stemma mediceo e l’altro il monogramma del granduca, sono uniti da una catena che, non aven-do giunture, faceva originariamente parte dell’unico blocco.I segreti dei virtuosismi del Sengher furono da lui stes-so tramandati al Gran Principe, il quale, a soli quindi-ci anni (nel 1678) ricavò da un grosso pezzo di avorio un vasetto da spezieria (fig. 10), datato e firmato all’in-terno del coperchio (PRINCEPS F MDCLXXVIII); le pareti del vaso sono molto sottili, ma la parte no-tevole è senza dubbio il globo all’apice, caratterizzato da una particolare decorazione a intrecci, che tradisce gli insegnamenti del maestro bavarese. Pare che sia Fi-lippo Sengher e non il Gran Principe, come invece sostiene la Aschengreen Piacenti,51 l’autore del bel-lissimo vaso in avorio sostenuto da un putto, attual-mente conservato al Victoria and Albert Museum di Londra e datato 1681. Per quanto abile nell’arte del tornio, Ferdinando non riuscì mai a raggiungere ri-sultati eguagliabili a quelli altissimi del Sengher che, a mio avviso, sono riscontrabili in questo vaso, mentre di opere in avorio di Gian Gastone, fratello minore di Ferdinando e ultimo granduca Medici, non abbia-mo traccia, nonostante che siano citate delle fonti.52 Come già detto, per il suo grande valore – soprattut-to economico e di prestigio – l’avorio fu collezionato quasi esclusivamente da sovrani e principi e spesso le opere eburnee erano oggetto di scambio tra le corti; caso eclatante è la scatola, con all’interno una bus-sola, scolpita da Pietro I Romanov e da lui regalata al granduca Cosimo III come ringraziamento per il grande “dono” che il sovrano mediceo gli aveva invia-to: Cosimo aveva infatti accordato a Filippo Sengher, nel 1712 (quando suo figlio Ferdinando, stando alla diagnosi del Pieraccini, era affetto da una sifilide ce-rebrale che lo teneva infermo allettato da due anni) il permesso di recarsi a San Pietroburgo, dove, analoga-mente a quanto fatto con il Gran Principe, divenne artista di corte, maestro e persona di fiducia dello zar. Di Filippo Sengher a Firenze si conservano ancora, forse commissionati proprio da Ferdinando, due vasi eburnei ornamentali ma, come detto sopra, non fu il Sengher l’unico scultore esperto nella lavorazione di avorio al servizio del Gran Principe: dal 1685 tro-viamo a Firenze, infatti, anche Balthasar Permoser. Formatosi a Roma e poi a Firenze con Giovan Battista Foggini, il Permoser53 fu particolarmente apprezzato
10. Ferdinando di Cosimo III de’ Medici, Vaso in avorio, h. 13,5 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1879 n. 45.
11. Balthasar Permoser, Eva, manico di coltello in avorio su plinto in ebano e avorio, h. 10,3 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1879 nn. 89.
Archivio storico
269
da Ferdinando, che gli commissionò oggetti di uso quotidiano, destinati, per la loro eccezionale qualità esecutiva, ad elevarsi a rango di opere d’arte, come fu il caso dei quattro manici di coltello, eseguiti nel 1688, raffiguranti due coppie di putti e, i più inte-ressanti, Adamo ed Eva (fig. 11); sappiamo per cer-to che queste statuette, tutte e quattro alte circa 10 centimetri, non furono mai utilizzate come manici – nonostante siano forate alla base per l’inserimento delle lame – giacché nell’inventario dei beni di Ferdi-nando, redatto nel 1713 all’indomani della morte del Gran Principe, figuravano come si presentano oggi, vale a dire montate su plinti in ebano e avorio: scultu-re che, poste su un piedistallo, potevano affiancare o, addirittura, sostituire i bronzetti (questi ultimi amati soprattutto dalla sorella di Ferdinando, Anna Maria Luisa), fino a quel momento e già dal Quattrocento considerati quasi l’emblema del collezionista privato, del dotto principe umanista. Ma non solo piccoli e quasi scherzosi manufatti furono le commissioni del Gran Principe al Permoser: è certamente da ricordare il Crocifisso in avorio montato su una croce di ebano, acquistato nel 1682, oppure il bellissimo ritratto della Gran Principessa Violante (fig. 12), scolpito per Fer-dinando in ovale con rilievo sottile nel 1689; questo ritratto, come del resto anche quello del Gran Princi-pe Ferdinando stesso (fig. 13), attribuito a un igno-to tornitore francese, o quello di Cosimo III, sopra citato, eseguito dal Sengher nel doppio medaglione, hanno la caratteristica evidente di presentare il ritrat-tato di profilo, ricollegandosi direttamente alla me-daglistica quattrocentesca e, ancor prima, ai cammei, alle monete e agli intagli di età romana.La passione di Ferdinando per l’avorio resta un caso isolato all’interno della corte di Cosimo III e, dopo la morte del Gran Principe, rimase insuperata an-che presso quella di Gian Gastone: piccoli pezzi di avorio sono parte costituente di alcuni dei magnifi-ci gioielli appartenuti ad Anna Maria Luisa – vale a dire il Mulattiere, l’Arrotino, il Venditore e la Vendi-trice di frutta e i Pellegrini – ma si tratta appunto di un utilizzo marginale dell’avorio, che oltretutto pas-sa in secondo piano essendo in questi casi affiancato da oro e pietre preziose. Si sa che un’affinità di gusti esisteva tra Ferdinando e il cognato, l’elettore palati-no Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, ma al mo-mento sono noti soltanto, per quanto riguarda ope-
re di piccolo formato, scambi di sculture in bronzo. Ancor più che l’avorio, la passione di Ferdinando per un altro materiale prezioso e singolare, vale a dire l’ambra, lo distinse dal resto della famiglia. Da sempre accomunata all’avorio, anche per l’identico processo lavorativo cui veniva sottoposta per esse-re utilizzata, l’ambra è una resina fossile particolar-mente fragile: proprio a causa di questa sua grande delicatezza, che aumenta con il passar del tempo, pochissimi esemplari di opere d’arte in questo ma-teriale sono giunti fino ai giorni nostri; anche in questo caso i maggiori centri di produzione di ma-nufatti in ambra sono la Germania e la costa del Baltico, dove i maestri tornitori, probabilmente gli stessi esperti nella lavorazione dell’avorio, scolpiva-no oggetti e statuette in ambra già dal Quattrocento. È interessante notare come nella collezione del Gran Principe – se si eccettua l’altarino a forma di ostenso-rio e croce (fig. 14), descritto nel già citato inventario del 1713 – tutti i numerosi manufatti in ambra da lui posseduti fossero oggetti di uso comune: trovia-mo infatti tazze, boccali, coppe, fiaschette, bicchieri e scatoline; questo si deve probabilmente a una prefe-renza di Ferdinando per l’avorio, che evidentemente considerava materiale più prezioso e quindi degno di essere utilizzato per la creazione di opere d’arte de-stinate solo alla contemplazione: nelle collezioni me-dicee esistevano, infatti, sculture in ambra (diverse raffiguranti la Madonna col Bambino54 o la Vergine e San Giovanni, attualmente conservate nel Museo de-
12. Balthasar Permoser, Ritratto della Gran Principessa Violante Beatrice di Baviera, rilievo in avorio, 10,5x7,8 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1879 n. 80.
13. Arte francese, Ritratto del Gran Principe Ferdinando de’ Medici, rilievo in avorio, 7x6 cm. Firenze, Museo degli Argenti, inv. Bargello 1879 n. 182.
270
Archivio storico
gli Argenti) acquistate nella prima metà del Seicento, ma, come abbiamo già detto, Ferdinando per questo materiale preferì concentrarsi sul collezionismo di oggetti funzionali. In ogni caso va precisato che non si tratta di meri utensili, ma di raffinatissimi manu-fatti, quasi certamente mai utilizzati nella loro desti-nazione d’uso: si veda ad esempio la sontuosa coppa di fattura tedesca, composta da una nicchia e, come piede, da un Ercole con il leone di Nemea (inv. Bar-gello 1917 (I) n. 66). Un caso a parte, come abbiamo accennato, lo costituisce l’altarino, un superbo ogget-to in ambra con rilievi che attorniano una raffigura-zione eburnea della Natività; l’utilizzo combinato di ambra e avorio è piuttosto frequente, soprattutto in epoca tardo-barocca: un altarino in ambra e avorio di scuola tedesca della fine del Seicento si trova at-tualmente al Victoria and Albert Museum di Londra, mentre a Firenze troviamo un Crocifisso su taberna-colo con rilievo eburneo raffigurante l’Annunciazione e un Crocifisso su altare con intagli a traforo di avo-rio (appartenuto a papa Innocenzo XI Odescalchi).55 L’accomunare questi due materiali fragili, rari e pre-
ziosissimi e, più in generale, il collezionismo privato del Gran Principe Ferdinando de’ Medici, caratteriz-zato da oggetti elaborati e non comuni, è indicativo di una cultura raffinata, quasi simbolo dell’elegante fragilità e della gloria medicea ormai giunta al tra-monto: con l’avvento dei Lorena e del loro governo il-luminato le bianchezze delle porcellane e degli stucchi presero il posto di questi materiali, a volte quasi um-bratili, ma che per secoli avevano popolato le collezio-ni e le Wunderkammer dei principi di tutta Europa. [Marco Betti]
RingraziamentiGli autori desiderano ringraziare Silvia Benassai, Lapo Cinotti, Clarice Innocenti, Anna Mieli, Simone Morandi e Mara Visonà. Le immagini nn. 4-14 sono state gentilmente fornite dal Gabi-netto Fotografico della Soprintendenza S.P.S.A.E. e per il Polo Museale della città di Firenze.
1) H. Acton, The last Medici, London 1932; ed. it. Gli ultimi Medici, Torino 1962, p. 262.2) R. Spinelli, Profilo di un principe-mecenate: Ferdinando di Co-simo III de’ Medici, in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena. Volume III. L’età di Cosimo III de’ Medici e la fine della dinastia (1670-1743), a cura di M. Gregori, Firenze 2007, pp. 179-194, p. 179.3) Tra i contributi più significativi ricordiamo F. Haskell, Patrons and painters. A study in the relations between Italian art and so-ciety in the age of the baroque, London 1963; ed. it. Mecenati e pittori. studio sui rapporti tra arte e società italiana nell’età barocca, Firenze 1966, pp. 354-373; M. L. Strocchi, Il gabinetto d’“Opere in piccolo” del Gran Principe Ferdinando a Poggio a Cajano, ‘Pa-ragone’, XXVI, 1975, 309, pp. 115-126 e XXVII, 1976, 311, pp. 83-116; E. Epe, Die Gemäldesammlungen des Ferdinando de’ Medici, Erbprinz von Toskana (1663-1713), Marburg 1990. Si rimanda a R. Spinelli, Profilo di un principe-mecenate cit., per una più estesa ricognizione della letteratura artistica. 4) K. Langedijk, The portraits of the Medici. 15th-18th centuries, Firenze 1981-1987, 3 voll., II, 1983, p. 833 n. 33.5) Si veda in particolare il Ritratto del gran principe Ferdinando con la sorella Anna Maria Luisa e la governante, in K. Langedijk, The portraits cit., II, 1983, p. 826 n. 21. Sul Suttermans cfr. Un Granduca e il suo ritrattista. Cosimo III de’ Medici e la “stanza de’ quadri” di Giusto Suttermans, catalogo della mostra (Firenze), a cura di Lisa Goldenberg Stoppato, Livorno 2006.6) A. Giusti in A. Giusti, P. Mazzoni, A. Pampaloni Martelli, Il museo dell’Opificio delle Pietre Dure a Firenze, Milano 1978, p. 335 n. 579. Sul Van der Vinne si veda A. González-Palacios, Limi-ti e contesto di Leonardo van der Vinne, ‘Paragone’, XXVIII, 1977, 333, pp. 37-68.7) K. Aschengreen Piacenti, A. González-Palacios in Gli ultimi
14. Manifattura di Danzica, Altarino, scultura in ambra e avorio, Firenze, Museo degli Argenti, Inv. Bargello 1917 n. 91.
Archivio storico
271
Medici. Il tardo barocco a Firenze, 1670-1743, catalogo della mo-stra (Detroit-Firenze), Firenze 1974, pp. 328, 386.8) Un vasetto in avorio firmato e datato “PRINCEPS F. MDCLXXVIII” (fig. 10), oggi conservato al Museo degli Argen-ti, testimonia come Ferdinando, già a quindici anni, fosse giunto a padroneggiare, sotto la guida di Filippo Sengher, la tecnica di lavorazione al tornio del prezioso materiale.9) J. Muylle, Lo scarabattolo attribuito a Domenico Remps, in In-ganni ad arte. Meraviglie del “trompe-l’oeil” dall’antichità al con-temperaneo, catalogo della mostra, a cura di Annamaria Giusti, Firenze 2009, pp. 75-80.10) A. Giusti in A. Giusti, P. Mazzoni, A. Pampaloni Martelli, Il museo cit., pp. 335-336 n. 580.11) P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, seconda edizione corretta e accresciuta, Bologna 1719, p. 136 e F. M. N. Gabburri, Vite di Pittori, 1730 c.-1742 c., Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ms. Pal. E.B.9.5, 4 voll., II, c. 685.12) A. Giusti in A. Giusti, P. Mazzoni, A. Pampaloni Martelli, Il museo cit., pp. 335-336 n. 580.13) Archivio di Stato di Firenze (ASF), Guardaroba Medicea 1222, c. 38v, cfr. M. Chiarini, I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana. II, ‘Paragone’, XXVI, 1975, 303, pp. 75-108, p. 88.14) R. Spinelli, Profilo di un principe-mecenate cit., pp. 189-194.15) ASF, Guardaroba Medicea 1067.16) M. Chiarini, I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana, ‘Paragone’, XXVI, 1975, 301, pp. 57-98, XXVI, 1975, 303, pp. 75-108, XXVI, 1975, 305, pp. 53-83; Id., Aggiunte a “I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana”, ‘Para-gone’, XLIII, 1992, 505/507, pp. 92-100. Si veda anche F. Navar-ro, Due “opere in piccolo” del Gran Principe Ferdinando ritrovate, in Arte collezionismo conservazione. Scritti in onore di Marco Chiarini, a cura di M. Chappell, M. Di Giampaolo, S. Padovani, Firenze 2004, pp. 84-87.17) M. De Luca Savelli, Bronzetti e marmi del Gran Principe Fer-dinando nell’Inventario del 1713, in M. Chappell, M. Di Giampa-olo, S. Padovani (a cura di), Arte collezionismo conservazione cit., pp. 71-78. 18) F. Morena, Oggetti di Cina e Giappone nell’Inventario del Gran Principe Ferdinando. Brevi spunti per una ricostruzione, in Arte col-lezionismo conservazione cit., pp. 79-83.19) ASF, Guardaroba Medicea 1222, c. 85v; cfr. E. Colle in I mo-bili di Palazzo Pitti. Il periodo dei Medici, 1537-1737, a cura di E. Colle, Firenze 1997, pp. 215-216 n. 66.20) A. Pampaloni Martelli in A. Giusti, P. Mazzoni, A. Pampaloni Martelli, Il museo cit., p. 313 n. 436.21) Si vedano A. González-Palacios, Il tempio del gusto. Le arti decorative in Italia fra classicismi e barocco. Il granducato di Tosca-na e gli stati settentrionali, Milano 1986, 2 voll., I, pp. 13-200 e Splendori di pietre dure. L’arte di corte nella Firenze dei Granduchi, catalogo della mostra, a cura di Annamaria Giusti, Firenze 1988. 22) Sui due scultori cfr. R. Spinelli, Giovan Battista Foggini “ar-chitetto primario della casa serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze 2003 e S. Bellesi, M. Visonà, Giovacchino Fortini. Scultura architettura decorazione e committenza a Firenze al tempo degli ul-
timi Medici, Firenze 2008, 2 voll.23) E. Colle in I mobili cit., pp. 150-153 n. 35.24) ASF, Guardaroba Medicea 1222, cc. 16, 50, 51, 52, 63, 101v, 102.25) A. González-Palacios in Gli ultimi Medici cit., pp. 395-399 nn. 230-234. Sull’argomento si veda anche P. Barocchi, G. Gaeta Bertelà, Arredi principeschi del Seicento fiorentino. Disegni di Dia-cinto Maria Marmi, Torino 1990.26) K. Aschengreen Piacenti, Collectors and princes, ‘Apollo’, 1977, 187, pp. 202-207, p. 204 ed E. Colle in I mobili cit., pp. 158-159 n. 38. Per il Soldani Benzi si rimanda alla biografia stesa da S. Blasio in Repertorio della scultura fiorentina del Seicento e Settecento, a cura di G. Pratesi, Torino 1993, 3 voll., I, pp. 59-60.27) ASF, Guardaroba Medicea 1067, c. 3v.28) ASF, Guardaroba Medicea 1073bis, cc. 88, 1198, cfr. E. Colle in I mobili cit., pp. 158-159 n. 38. Il Monaccorb è documenta-to anche tra gli artisti attivi nella cappella Feroni alla Santissima Annunziata (cfr. M. Visonà, Cappella Feroni nella Santissima An-nunziata, in Cappelle barocche a Firenze, a cura di M. Gregori, Milano 1990, pp. 221-248, p. 245) e nell’alcova del Gran Prin-cipe Ferdinando al primo piano di palazzo Pitti (cfr. R. Spinelli, L’appartamento di Ferdinando al piano nobile, in Fasto di corte cit., pp. 194-201, p. 196).29) ASF, Guardaroba Medicea 1073bis, c. 1169, cfr. E. Colle in I mobili cit., p. 156 n. 37.30) ASF, Guardaroba Medicea 1067, c. 8; ASF, Guardaroba Me-dicea 1222, c. 16.31) K. Aschengreen Piacenti, Collectors cit., pp. 204-205 e E. Col-le in I mobili cit., p. 160 n. 39.32) ASF, Guardaroba Medicea 1222, cc. 54, 67, 73v, 74, 74v. Su-gli orologi di Ferdinando si veda A. González-Palacios, Gli orologi del Gran Principe di Toscana, in A. González-Palacios, Il tempio del gusto cit., I, pp. 35-37.33) ASF, Guardaroba Medicea 1222, c. 73v, cfr. K. Aschengreen Piacenti, Collectors cit., p. 205.34) ASF, Guardaroba Medicea 1073bis, c. 1742, cfr. S. Bellesi, Precisazioni su alcune opere eseguite da Massimiliano Soldani Benzi per il Gran Principe Ferdinando de’ Medici, ‘Paragone’, XLII, 1991, 497, pp. 80-85, pp. 82, 84. Le due coppie di urne sono ricordate sia nell’inventario del 1698 (ASF, Guardaroba Medicea 1067, c. 4v) che in quello del 1713(ASF, Guardaroba Medicea 1222, c. 14).35) K. Aschengreen Piacenti, Collectors cit., p. 205.36) ASF, Guardaroba Medicea 1073bis, cc. 1742, 1744, cfr. S. Bellesi, Precisazioni cit., pp. 82, 85.37) ASF, Guardaroba Medicea 1222, cc. 74, 74v.38) A. González-Palacios, in Gli ultimi Medici, cit., pp. 396-397 n. 229.39) M. Mosco, I Medici e il fascino dell’esotico, in M. Mosco, O. Casazza, Il Museo degli Argenti. Collezioni e collezionisti, Firenze 2004, pp. 168-183, p. 173.40) Sull’argomento si vedano D. Heikamp, Mexico and the Medi-ci, Firenze 1972 e M. Mosco, I Medici e il fascino dell’esotico cit., pp. 168-183. 41) ASF, Guardaroba Medicea 1222, cc. 75, 85v.42) Si è scelto di citare una frase riferita da Stefano Casciu (S.
272
Archivio storico
Casciu, “Principessa di gran saviezza” dal fasto barocco delle corti al “Patto di famiglia”, in La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elettrice Palatina, catalogo della mostra [Firenze]), a cura di Stefano Casciu, Livorno 2006, pp. 30-57, p. 30) alla sorella di Ferdinando, Anna Maria Luisa, poiché, seppur con le dovute differenze, questa presenta molti punti di tangenza con il Nostro e il suoi gusti artistici.43) G. Pieraccini, La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo. Saggio di ricer-che sulla trasmissione ereditaria dei caratteri biologici, Firenze 1924-1925, 3 voll.; ed. cons. Firenze 1986, 3 voll., II, pp. 717-735.44) M. L. Strocchi, Il gabinetto d’“Opere in piccolo” cit.45) ASF, Miscellanea Medicea 781, c. 12.46) Pare che sia di Ferdinando il progetto architettonico e sculto-reo della cappella Feroni alla Santissima Annunziata (cfr. M. Vi-sonà, in S. Bellesi, M. Visonà, Giovacchino Fortini, cit., I, p. 67). 47) È ormai divenuto celebre l’episodio che vede protagonisti alcuni splendidi vasi in avorio, attualmente conservati presso il Museo degli Argenti di Firenze: nel 1632, durante la guerra dei Trent’anni, la città di Coburgo fu messa sotto assedio; il palazzo ducale di Ehrenburg, all’epoca abitato dal duca Johann Casimir di Sassonia, fu saccheggiato dall’armata imperiale e al principe Mat-tias de’ Medici, che combatteva per l’imperatore in quanto suo parente per parte di madre, fu consegnato un particolare bottino: una collezione di trenta vasi torniti in avorio, opere di Marcus Heiden e del suo allievo Johann Eisenberg. Il principe fiorentino, conscio del grande valore della raccolta, si adoperò per far portare i vasi a Firenze, promettendo al sergente maggiore Johann Keller, autore del furto ai danni del duca di Sassonia, un prezioso dono in cambio. Probabilmente Mattias non mantenne la promessa di ricompensa, poiché nel 1659 il Keller scrisse a Firenze, lamentan-dosi del fatto che, nonostante i vasi eburnei fossero esposti già da anni nella galleria degli Uffizi, non aveva ancora ricevuto nessun dono (cfr. K. Aschengreen Piacenti, La collezione medicea di avori torniti, ‘Antichità Viva’, II, 1963, 1, pp. 15-25, pp. 15-16).48) Sugli avori riccardiani si veda G. De Juliis, Le vicende degli antichi avori della collezione Riccardi, ‘Commentari’, XXIX, 1978, 1/4, pp. 144-156.49) K. Aschengreen Piacenti, Ambra e avorio, in K. Aschengre-en Piacenti, H. Honour, R. W. Lightbown, J. G. Pollard, G. M. Mori, Ambre, avori, lacche, cere, medaglie e monete, Milano 1981, pp. 23-49.50) Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici e Anton Domenico Gab-biani. Mecenatismo e committenza artistica ad un pittore fiorentino della fine del Seicento, catalogo della mostra (Poggio a Caiano), a cura di R. Spinelli, Prato 2003, p. 20.51) K. Aschengreen Piacenti, La collezione medicea cit., p. 22.52) Ibidem.53) M. Visonà, La scultura a Firenze alla fine del secolo, in Sto-ria delle arti in Toscana. Il Seicento, a cura di M. Gregori, Firenze 2001, pp. 201-217, pp. 214-215.54) K. Aschengreen Piacenti, Ambra e avorio cit., p. 24.55) Ivi, pp. 28-29.