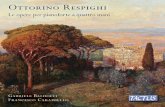ROSSINI PER VIOLONCELLO - IDAGIO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ROSSINI PER VIOLONCELLO - IDAGIO
℗ 2020Tactus s.a.s. di Gian Enzo Rossi & C.
www.tactus.it
In copertina / Cover:ÉLISABETH LOUISE VIGÉE LE BRUN (1755–1842)
Portrait of Antoinette-Elisabeth-Marie d'Aguesseau, comtesse de Ségur (1756-1828), 1785.
Sound engineer: Giuseppe MonariEnglish translation: Marta Innocenti
L’editore è a disposizione degli aventi diritto
Un sentito ringraziamento /Many thanks
Al Liceo Musicale «Angelo Masini» di Forlì per aver messo gentilmente a disposizione la sala«Sangiorgi» utilizzata per questa registrazione. Al grande e caro amico Beppe Monari,
tecnico e ingegnere del suono unico e inarrivabile con il quale lavorareinsieme diventa ogni volta un vero divertimento.
TACTUS
k
k
Termine latino con il quale, in epoca rinascimentale, si indicava quella che oggi è detta «battuta».The Renaissance Latin term for what is now called a measure.
1
Quando il Guillaume Tell venne rappresentato all’Opéra di Parigi il 3 Agosto 1829 GioacchinoRossini (1792-1868) aveva trentasette anni: con questo lavoro il compositore italiano chiudevadefinitivamente e deliberatamente la propria attività operistica, e già con qualche anno di ritardose si vuole credere all’asserzione del suo biografo Stendhal, secondo la quale il musicista avrebbevoluto smettere di lavorare già a trent’anni, appena raggiunta cioè una posizione economica chegli permettesse di vivere lussuosamente di rendita.Il ‘silenzio’musicale che ne conseguì, salvo sporadiche uscite non degne di nota, risulta uno dei
più misteriosi di tutta la storia musicale, solo in minima parte causato dalla malattia nervosa checolpì Rossini a partire dal 1839: una sorta di «nevrastenia accidiosa e ansiosa» derivataprobabilmente dall’intensità della sua attività musicale unita ad una vita fin troppo esuberante esfrenata.Rossini nelle sue lettere scriveva: «[…] le mie biografie, niuna eccettuata, sono piene di assurdità e
d’invenzioni più o meno nauseanti» così che in un’altra sua lettera ebbe a dire «[…] scrivevo Operequando le melodie venivano a cercarmi e a sedurmi; quando capii che toccava a me andarle a cercare,nella mia qualità di scansafatiche, rinunciai al viaggio e non volli più scrivere».Egli, riguardo a come avesse tratto ispirazione per la composizione delle sinfonie per le sue
opere, scrisse in una lettera tra il serio e il faceto:
[…] la Sinfonia dell ’Otello la composi in una piccola camera del Palazzo Barbaja [a Napoli] dove ilpiù selvaggio degli impresari mi teneva prigioniero, con una sola scodella di maccheroni e sotto laminaccia di non farmi uscire prima che avessi scritto l ’ultima nota. La Sinfonia de La gazza ladra lacomposi il giorno stesso della prima rappresentazione dell ’opera, in una soffitta della Scala, dovel ’impresario mi aveva rinchiuso, guardato a vista da quattro macchinisti che avevano l ’ordine dipassare i fogli ai copisti: infatti li gettavano via via dalla finestra a quelli che aspettavano lì sotto. Peril Barbiere la cosa fu più semplice, non composi la Sinfonia e la presi dall ’opera semi-seria Elisabetta:il pubblico ne fu contentissimo. La Sinfonia de Le Comte Ory la composi alla pesca, coi piedi nell ’acquae in compagnia del signor Aguado che mi teneva frattanto una conferenza sulla situazione finanziariadella Spagna. La Sinfonia del Guillaume Tell venne scritta quasi nelle medesime circostanze, per ciòche concerne il Moïse debbo dire che non scrissi nessuna Sinfonia».
2
Certamente dal 1842 al 1857 Rossini cadde in una sorta di violento esaurimento nervoso chelui stesso descrive in una lettera del 1855: «[…] martirizzato come io sono da tredici mesi di crisinervosa che mi ha tolto sonno, palato, alterato l ’udito e la vista e gettato in prostrazione di forze che nonposso né vestirmi né spogliarmi senza aiuto. I medici non possono aiutarmi […]». Sebbene in talunimomenti arrivasse persino a invocare la morte Rossini fu sempre attaccato alla vita: «[…] cercotutti i viottoli possibili per prolungare la vita, che mi è carissima […] contro questo tempo vigliacco easino […]».Durante l’ultimo decennio della sua esistenza, vissuto in un clima più sereno e disteso, Rossini
poté fugare certe ossessioni e fobìe riguardo la propria opera di compositore, riuscendo anche adescriversi umoristicamente nel 1864, in risposta all’operista italiano Giovanni Pacini che glichiedeva una piccola composizione per la Società del Quartetto di Firenze: «[…] io abbandonaila mia carriera musicale nel 1829; il lungo silenzio mi ha fatto perdere la potenza del comporre e laconoscenza degl ’istrumenti. Ora sono un umile pianista di quarta classe […] e vivo quindi, qualpianista, sotto il pubblico flagello» (citando la famosa aria di Don Basilio nel suo Barbiere diSiviglia).Pur nella difficoltà di adattarsi al nuovo spirito della musica romantica che stava prendendo il
sopravvento Rossini non si esime dall’ironia stilistica della sua musica, che ben si scorge neidodici pezzi vocali Soirées musicales (1835) ove «il chiassoso buonumore dell ’antico fabbricante diopere buffe si tramuta in ironia, in una sorta di malizia sottile che assume un tono sorprendentementeintellettualistico» (Luigi Rognoni Rossini, Ed. Guanda 1956, Parma).Per capriccio a tempo perso, si potrebbe dire, Rossini fu successivamente anche autore di
musiche da camera.Egli titolò Péchés de vieillesse (Peccati di vecchiaia) i pezzi per canto, pianofortee altri strumenti (dedicati ai pianisti «de la quatriéme classe», come lui stesso si classificava) chefurono composti per essere eseguiti fra il 1855 e il 1868, per divertimento suo e di quanti amavaospitare, nei famosi trattenimenti settimanali nella sua villa di Passy. Suddivisi in quattordicivolumi i centocinquanta Péchés de vieillesse mostrano un Rossini arguto ed estroso; questeminiature, da lui stesso definite «inezie» e «musica insignificante per fanciulli scaltri» rappresentanoal meglio l’ultimo periodo della sua creatività: in esse egli riversa la sua sottilissima ironiaunitamente alla malinconia contrapposta alla gioia di vivere, valicando i confini tra il suo
3
linguaggio ‘classico’ e il nuovo clima musicale a lui contemporaneo. Questa produzionecameristica sembra riproporre, sia pure su scala diversa, l’antitesi che caratterizza il Rossinioperista e che ne costituisce, in ultima analisi, la sigla: un perenne moto tra poli opposti, uncontinuo andirivieni fra le nostalgie settecentesche e i nuovi impulsi romantici.Il presente CD contiene tutti i brani cameristici per violoncello scritti dal compositore pesarese,
più alcune particolarità di grande interesse quali le trascrizioni del Ballet dal Moïse e de Lapromenade en gondole realizzate da Eugenio Albini (1881-1966) [violoncellista, importanterevisore e autore di vari testi musicologici: Beethoven e le sue cinque Sonate per Violoncello,La Violada gamba in Italia, Domenico Gabrielli, il Corelli del Violoncello e Gli strumenti musicali moderni]oltre a due rivisitazioni della musica rossiniana composte intorno alla metà del Novecento:Variations on a Theme of Rossini di Martinu e Figaro, a Concert Transcription di Castelnuovo-Tedesco. In ultimo due brani che richiamano il grande pubblico a due generi diversi: la LeggendaValacca di Braga, amico e grande estimatore di Rossini e la Czardas di Monti con quello spaccatostrumental-popolare che il tempo portò con sé in seguito all’avvenuta rivoluzione musicale postrossiniana.1-3. GIOACCHINO ROSSINI: Duetto per Violoncello e Contrabbasso, scritto nel 1824 durante un
viaggio a Londra fatto insieme alla prima moglie, Isabella Colbran, è costruito in forma di Sonataclassica in tre tempi e fu dedicato «al suo amico Salomons», primo sindaco ebreo di Londra efondatore della Westminster Bank, ma forse fu scritto più precisamente per il cugino diquest’ultimo, Philip Joseph, contrabbassista dilettante e allievo di Domenico Dragonetti, grandevirtuoso veneziano di contrabbasso che viveva a Londra. Non si sa con esattezza ove ebbe luogola prima esecuzione di questo Duetto ma probabilmente in un salotto della capitale inglese,plausibilmente a casa di Sir David Salomons stessa, e dal momento che il Dragonetti si esibivaspesso anche suonando il violoncello si potrebbe ipotizzare che la parte del contrabbasso venneeseguita da Philip Joseph Solomons mentre Dragonetti suonava la parte del violoncello;4. GIOACCHINO ROSSINI: Une Larme, Thème et Variations, dal nono volume dei Péchés de
Vieillesse e probabilmente scritto per Gaetano Braga, deve il suo nome al fatto che il Temainiziale, dopo un’introduzione orchestrale, è costruito su un Tema ‘lacrimoso’ che però lascia ilposto nelle Variazioni a una vivacità e a un capriccio che abbandonano l’iniziale atmosfera triste
4
e malinconica. Tra il Tema e tra le prime due Variazioni si presentano specularmente due brevitransizioni pure «orchestrali» che richiamano gli staccati e le figurazioni ritmiche già adottatenella Sinfonia del Guillaume Tell. Dopo la seconda Variazione si apre una parte che si prefiguracome un Recitativo per arrivare solo in seguito alla ripresa vera e propria del Tema iniziale,proposto a mò di Aria, e che viene in ogni caso poi interrotta da una cadenza del Violoncello chesimula una ipotetica cabaletta dell’aria stessa. Chiude il pezzo una Variazione molto brillante conuna coda e una stretta finale conclusiva con, anche qui, chiarissimi richiami operistici;5. GIOACCHINO ROSSINI: La promenade en gondole, (La gita in gondola), trascrizione edita nel
1930 per violoncello e pianoforte da Eugenio Albini dall’originale per soprano e pianoforte sutesto originale del conte Carlo Pepoli (1796-1881). È un brano ove si cerca di far ‘ondeggiare’ ilsuono del violoncello al pari di quello della voce nell’aria per far trasparire i delicati andamentidei flutti delle acque e delle dolcezze dell’essere umano innamorato come si evince dal testo dellalirica:
Voli l ’agile barchettaVoga, voga marinarOr ch’Elvira mia dilettaA me in braccio sfida il mar.Brilla in calma la lagunaUna vela non apparPalli detta e in ciel la lunaTutto in vita a sospirar.Voga, voga marinar...
Se ad bacio amor t’invitaNon temer mio bel tesorTu saprai che sia la vitaSol nel bacio del amor.Ma già un zefiro serenoDolce ondeggia il mar...Vieni Elvira a questo sen’Vieni e apprendi a palpitar!Voga, voga marinar...
6. GIOACCHINO ROSSINI: Tarantella (La danza), dalle Soirées Musicales (n. 8), scrittaoriginariamente per pianoforte, ricalca la tipica scrittura in 6/8 della tarantella napoletana, lacosiddetta Tammuriata o, tradizionalmente, ballu 'ncopp o tamburo, danza frenetica e senza sostadalla grande vivacità e allegria;7. GIOACCHINO ROSSINI: Pour Album, un brano scritto da Rossini per una delle sue raccolte,
caratterizzato da una grande liricità.
5
8. GIOACCHINO ROSSINI: Ballet, dal Moïse, trascrizione edita nel 1930 per violoncello epianoforte da Eugenio Albini, riprende uno degli estratti più brillanti e funambolici dal ballettodell’opera;9. GIOACCHINO ROSSINI: Un mot à Paganini, che reca Elegia come sottotitolo scritto, è
originale per violino e pianoforte. È considerata la più importante attestazione di stima diRossini nei confronti del più grande violinista di ogni tempo che era, a sua volta, suo devotoammiratore (prova ne sia l’uso da parte di Paganini di temi d’opera del Rossini per propriecomposizioni quali le celeberrime Variazioni su una corda sola sul «Dal tuo stellato Soglio» dalMoïse). Il brano è tratto dal nono volume dei Péchés de Vieillesse e sono in esso evidenti i richiamial Concerto n. 1 di Paganini per violino e orchestra, soprattutto per il colpo d’arco, «gettato» o«ricochet», utilizzato in tutta la coda;10. GIOACCHINO ROSSINI: Allegro agitato, brano originale per violoncello e pianoforte, ha
come parte centrale, una riproposizione praticamente identica della prima variazione de UneLarme,Thème et Variations. Caratteristica del brano è l’utilizzo quasi costante di una figurazioneritmica puntata per simulare un continuo stato di agitazione ritmica, quasi, fisicamente, unapulsazione cardiaca;11. BOHUSLAV MARTINU (1890-1959): Variations on a Theme of Rossini (dal Moïse), edito nel
1949 e dedicato al grande violoncellista Gregor Piatigorsky. In queste Variazioni, Martinu,utilizza tutte le quattro corde del violoncello e cercando un virtuosismo più nascosto chepirotecnico fatto prevalentemente di ritmi, colpi d’arco, accenti e difficili incastri d’insieme colpianoforte. Solo nell’ultima variazione l’agilità prende il sopravvento per portare leggerezza ebrio prima della pomposa ripresa del tema iniziale;12. MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895-1968): Figaro, a Concert Transcription from “The
Barber of Seville of Rossini” edito nel 1945 e, pure, brano dedicato a Gregor Piatigorsky. Dall’ariaprobabilmente più famosa mai scritta da Rossini, Castelnuovo-Tedesco estrapola unatrascrizione da concerto davvero efficace ripercorrendo col violoncello tutta l’aria di Figaro, daivirtuosismi orchestrali alla breve cadenza centrale e a tutti i gorgheggi vocali.13. GAETANO BRAGA (1829-1907): una menzione a parte merita la famosa Leggenda Valacca
che fa parte di una raccolta di sette melodie scritte da Braga per l’allieva cantante Adelaide
6
Borghi-Mamo. La Leggenda Valacca, nota con questo titolo invece dell’originale Serenata degliAngeli, adotta i versi diMarcoMarcellianoMarcello (1818-1865).Tali versi costruiscono il dialogotra una madre e la figlia morente, che ascolta un suono sovrannaturale chiamarla a sé. Braga, dabuon violoncellista, affidò al violoncello la realizzazione di questo suono, indicandosuggestivamente che venisse suonato «in una stanza vicina se possibile». Questo brano venneesplicitamente citato dallo scrittore russo Anton Čechov (1860-1904), del quale Braga era amicoal pari di Rossini, nel racconto Il Monaco nero (1894) in due momenti dell’opera letteraria ove sipone l’accento sull’aspetto allucinatorio della melodia («una fanciulla dall ’immaginazione malataudiva di notte nel giardino certi suoni misteriosi, belli e strani a tal punto da dover riconoscere in essiuna sacra armonia che per noi mortali è incomprensibile e perciò se ne vola dietro i cieli»):
- La figlia: Oh quali mi risvegliano dolcissimi concenti!Non li odi, o mamma, giunger con l ’alitar de’ venti?
Fatti al veron, ten supplico, e dimmi donde parte questo suon?- La madre: Io nulla veggio, calmati, non odo voce alcuna
Fuor che il fuggente zeffiro, il raggio della luna.D’una canzon, o povera ammalata, chi vuoi che t’erga il suon?
- La figlia: No!Non è mortal la musica che ascolto o madre mia:
ella mi sembra d’angeli festosa melodia,ov’elli son mi chiamano. O mamma, buonanotte!
Io seguo il suon, io seguo il suon.
14. VITTORIO MONTI (1868-1922): Czardas, scritta nel 1904 originariamente per violino, è unbrano basato su temi del folklore gitano ungherese. La Czardas è una forma musicale strutturatain sette cellule non necessariamente correlate tra loro per tonalità e tempo il quale, a sua volta èlasciato al libero arbitrio dell’esecutore. Ebbe un tale successo che ne furono realizzate diversetrascrizioni per vari strumenti e anche per orchestra dall’autore stesso.
ANDREA NOFERINI
7
When Guillaume Tell was staged at the Opéra of Paris on 3 August 1829, Gioacchino Rossini(1792-1868) was 37 years old: with this work he was closing his activity as a composer of operas,deliberately, for good, and actually several years late, if we are to believe his biographer Stendhal,who reported that he had wished to stop at the age of 30, as soon as he had reached a financialposition that would enable him to live luxuriously on a private income.The musical “silence” that ensued, except for a few sporadic, unremarkable bouts of activity, was
one of the most mysterious ones in the history of music, and was due only in a negligible measureto a nervous complaint that affected Rossini from 1839 onwards: a sort of “slothful, anxious neur-asthenia” probably resulting from the intensity of his musical activity combined with his all tooexuberant, immoderate lifestyle.In one of his letters, Rossini wrote: “[…] my biographies, none excluded, are full of absurdities and
more or less revolting inventions”; in another letter he wrote: “[…] I used to compose operas when thetunes sought me and seduced me; when I realised that it was up to me to seek them, since I am a shirker,I gave the whole thing up and stopped composing music”.On the subject of how he had drawn inspiration for the compositions of the symphonies of his
operas, he wrote in a half serious, half facetious letter:
[…] the symphony of Otello was composed by me in a small bedroom in Palazzo Barbaja [Naples],where the most savage of impresarios was holding me prisoner, with only a dish of macaroni, and un-der the threat of not allowing me to get out until I had completed the piece up to the last note. Thesymphony of La gazza ladra was composed by me on the very day of the premiere, in an attic of LaScala, where the impresario had imprisoned me under the close watch of four stagehands, who had beenordered to pass the sheets of music to the copyists: as soon as I had completed a page, they threw it downfrom the window to those who were waiting under. For the Barbiere, the matter was simpler: I didn’tcompose the symphony, but drew it from the semi-serious opera Elisabetta: the audience was quitepleased with it.The symphony of Le Comte Ory was composed by me while I was fishing, with my feetin the water, and in the company of Signor Aguado, who in the meantime was lecturing me on thefinancial situation of Spain. The symphony of Guillaume Tell was composed in very similar circum-stances, and as regards Moïse I must say that I didn’t compose a symphony at all.
8
What is certain is that from 1842 to 1857 Rossini fell into a sort of violent nervous prostration,described by him as follows in a letter from 1855: “[…]martyrised as I have been for thirteen months,and still am, by a nervous crisis that has deprived me of sleep and taste, has altered my hearing and sight,and has thrown me into such a state of exhaustion and loss of strength that I cannot dress or undresswithout assistance. Physicians are unable to help me […]”. Although in certain moments he went sofar as to call for death, he was always attached to life: “[…] I always seek all possible paths for pro-longing life, which is extremely dear to me […] against time, this despicable blockhead […]”.During the last decade of his existence, in which Rossini lived in a more serene, relaxed atmo-
sphere, he was able to get rid of certain obsessions and phobias of his about his work as a com-poser, and actually managed to describe himself wittily in 1864, replying as follows to the Italianopera composer Giovanni Pacini, who had asked him for a small composition for the Società delQuartetto of Florence: “[…] I gave up my musical career in 1829; this long silence has made me losemy power to compose and my knowledge of instruments. Now I am a humble, fourth-rate pianist […] soI live, as a pianist, under the public scourge” (quoting the famous aria of Don Basilio in Barbiere diSiviglia).Although it was not easy for Rossini to adapt to the new spirit of romantic music that was
beginning to prevail, he did not relinquish the stylistic irony of his music: it is quite visible in histwelve vocal pieces, Soirées musicales (1835), where “the boisterous high spirits of the former manufac-turer of opere buffe have turned into irony, into a sort of subtle slyness that takes on a surprisingly intel-lectualistic tone” (Luigi Rognoni,Rossini, Ed. Guanda, 1956, Parma).As an idle whim, so to speak, Rossini later also composed some chamber music. He gave the
title Péchés de vieillesse (Sins of old age) to his pieces for voice, piano and other instruments (dedic-ated ai pianisti "de la quatriéme classe", as he styled himself ), which he composed and were per-formed between 1855 and 1868, for his own amusement and for that of the guests he enjoyedentertaining in his famous weekly receptions in his villa at Passy.The 150 Péchés de vieillesse,whichare collected in fourteen volumes, show a humorous, imaginative Rossini.These miniatures, thathe described as “trifles” and “insignificant music for cunning children”, are the best possible represent-ation of the last period of his creativeness: he pours into them his remarkably subtle irony, togetherwith the melancholy that contrasts his joie de vivre, overstepping the boundaries between his
9
“classical” language and the new contemporary musical climate.This chamber-music productionseems to revive, though on a different scale, the anthitesis that characterised Rossini as a composerof operas and is, ultimately, his hallmark: an unceasing motion between opposite poles, a constantcoming and going between nostalgia of the eighteenth century and the new romantic drive.This CD contains all the chamber-music pieces for cello composed by Rossini, plus some highly
interesting pieces such as the transcription of the Ballet from Moïse and that of La promenade engondole drawn up by Eugenio Albini (1881-1966) [cellist, important revisor, and author of severalmusicological texts: Beethoven e le sue cinque Sonate per Violoncello, La Viola da gamba in Italia,Domenico Gabrielli, il Corelli del Violoncello and Gli strumenti musicali moderni].There are also tworeassessments of Rossini’s music that have been composed around the middle of the twentiethcentury: Variations on a Theme of Rossini, by Martinu, and Figaro, a Concert Transcription, byCastelnuovo-Tedesco. Lastly, the CD contains two pieces that address the large public to twodifferent genres: Leggenda Valacca, by Braga, a friend and great admirer of Rossini’s, and Czardas,by Monti, with the instrumental/popular cross-section that time had brought on as a result of thecompletion of the post-Rossini musical revolution.1-3. GIOACCHINO ROSSINI: Duetto per Violoncello e Contrabbasso, composed in 1824 during a
visit to London together with his first wife, Isabella Colbran, has the structure of a Sonata classicawith three movements. It was dedicated to “my friend Salomons”, the first Jewish mayor of Londonand founder of the Westminster Bank; but perhaps it had been actually composed for the latter’scousin, Philip Joseph, who was an amateur double-bass player and a pupil of Domenico Dragon-etti, a great double-bass virtuoso who lived in London.We do not know exactly where this piecewas performed for the first time, but it seems likely that its premiere took place in a drawing-roomin London, presumably in the house of Sir David Salomons; and since Dragonetti often per-formed also on the cello, it is possible to surmise that the double-bass part was performed byPhilip Joseph Solomons, while Dragonetti played the cello part.4. GIOACCHINO ROSSINI: Une Larme, Thème et Variations, from the ninth volume of Péchés de
Vieillesse, a piece that was probably composed for Gaetano Braga, was given this title because itsinitial theme, after an orchestral introduction, is based on a “lachrymose” theme, whose pensive,melancholy atmosphere is replaced, in the variations, by whimsical liveliness. Between the theme
10
and the first two variations there are two symmetrical, short transitions for orchestra that recallthe staccatos and rhythmic figurations previously adopted in the symphony of Guillaume Tell.Thesecond variation is followed by a part that at first sounds like a recitativo, but later turns into anactual reprise of the initial theme, which is presented “as an aria” and subsequently interrupted bya cadenza of the cello, which imitates a hypothetical cabaletta of that aria.The piece ends with avery brilliant variation, followed by a coda and a “stretta finale” that also contains evident refer-ences to the operatic style.5. GIOACCHINO ROSSINI: La promenade en gondole, transcription for cello and piano published
in 1930 by Eugenio Albini, from the original for soprano and piano, based on an original text byCount Carlo Pepoli (1796-1881). In this piece an attempt is made to cause the sound of the celloand that of the voice to “undulate” in the air in order to express the delicate movements of thewaves in the water and of the tenderness of the enamoured human being, as revealed by the textof the poem:
Voli l ’agile barchettaVoga, voga marinarOr ch’Elvira mia dilettaA me in braccio sfida il mar.Brilla in calma la lagunaUna vela non apparPalli detta e in ciel la lunaTutto in vita a sospirar.Voga, voga marinar...
Se ad bacio amor t’invitaNon temer mio bel tesorTu saprai che sia la vitaSol nel bacio del amor.Ma già un zefiro serenoDolce ondeggia il mar...Vieni Elvira a questo sen’Vieni e apprendi a palpitar!Voga, voga marinar...
6. GIOACCHINO ROSSINI: Tarantella, from the Soirées Musicales (no. 8), originally composed forpiano, follows the typical 6/8 structure of the Neapolitan tarantella, the so-called Tammuriata or,traditionally, ballu 'ncopp o tamburo, dance to the drum: a lively,merry dance with an unremittinglyfrenzied rhythm.7. GIOACCHINO ROSSINI: Pour Album, a highly lyrical piece composed by Rossini for one of his
collections.
11
8. GIOACCHINO ROSSINI: Ballet, dalMoïse, transcription for cello and piano published in 1930by Eugenio Albini: it revives one of the most brilliant, acrobatic passages of the opera’s ballet.9. GIOACCHINO ROSSINI: Un mot à Paganini, whose written subtitle is Elegia, is an original
piece for violin and piano. It is regarded as Rossini’s most important tribute to the greatest violin-ist of all times, who, in turn, was a devoted admirer of his (as demonstrated by the fact that Pa-ganini used themes from Rossini’s operas for his own compositions, such as the celebratedVariazioni su una corda sola sul “Dal tuo stellato Soglio”, from Moïse).This piece is drawn from theninth volume of Péchés de Vieillesse and contains evident allusions to Paganini’s Concerto no. 1 forviolin and orchestra, above all for the “gettato” or “ricochet” bowing in the entire coda.10. GIOACCHINO ROSSINI: Allegro agitato, original piece for cello and piano, whose central part
is a practically identical revival of the first variation of Une Larme, Thème et Variations.The maincharacteristic of this piece is the almost constant use of a dotted-rhythm figuration that simulatesa constant state of rhythmic agitation, or physically, as it were, heart palpitations.11. BOHUSLAV MARTINU (1890-1959): Variations on a Theme of Rossini (dal Moïse), published
in 1949 and dedicated to the great cellist Gregor Piatigorsky. In these variations,Martinu uses allfour of the cello strings, achieving a hidden rather than spectacular virtuosity, based chiefly on therhythms, bowing, accents and complex interactions with the piano.Only in the last variation doesagility get the upper hand, in order to bring lightness and sparkle before the solemn reprise of theinitial theme.12. MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895-1968): Figaro, a Concert Transcription from “The
Barber of Seville of Rossini”, published in 1945 and also dedicated to Gregor Piatigorsky. FromRossini’s aria, probably the most famous composed by him, Castelnuovo-Tedesco draws a concerttranscription that is really impressive, in which the cello reproduces the entire aria of Figaro, fromthe virtuoso passages of the orchestra to the short central cadenza, including all the vocal roulades.13. GAETANO BRAGA (1829-1907): a separate mention is deserved by the famous Leggenda
Valacca, which belongs to a collection of seven tunes composed by Braga for his pupil, the singerAdelaide Borghi-Mamo.Leggenda Valacca, known with this title instead of the original one Seren-ata degli Angeli, uses the lines by Marco Marcelliano Marcello (1818-1865).These lines relate adialogue between a mother and her dying daughter, who is listening to a supernatural sound that
12
allures her. Braga, as a good cellist, entrusted this sound to the cello, with the fascinating directionthat it be played “in a nearby room if possible”. This piece was explicitly mentioned by the Russianwriter Anton Čechov (1860-1904), who was a friend both of Braga’s and of Rossini’s, in his shortstoryThe Black Monk (1894), where, in two passages, the hallucinatory quality of this tune is high-lighted (“a maiden with a diseased imagination used to hear, during the night, certain mysterious soundsin her garden: they were so strange and beautiful that it was inevitable to acknowledge them as a sacredharmony, which for us mortals is incomprehensible, so it flies behind the skies”).
- La figlia: Oh quali mi risvegliano dolcissimi concenti!Non li odi, o mamma, giunger con l ’alitar de’ venti?
Fatti al veron, ten supplico, e dimmi donde parte questo suon?- La madre: Io nulla veggio, calmati, non odo voce alcuna
Fuor che il fuggente zeffiro, il raggio della luna.D’una canzon, o povera ammalata, chi vuoi che t’erga il suon?
- La figlia: No!Non è mortal la musica che ascolto o madre mia:
ella mi sembra d’angeli festosa melodia,ov’elli son mi chiamano. O mamma, buonanotte!
Io seguo il suon, io seguo il suon.
14. VITTORIO MONTI (1868-1922):Czardas, composed in 1904 originally for the violin, is a piecebased on themes of Hungarian gipsy folklore.The Czardas is a musical form consisting of sevencells that are not necessarily coordinated in their key and time; and the performer is allowed tochoose the time at will.This piece was so successful that the composer transcribed it several timesfor different instruments and also for orchestra.
ANDREA NOFERINI