Luigi Einaudi: teoria economica e legislazione sociale nel testo delle Lezioni (text in italian
MEMORIE LUIGI FERDINANDO MARSILI
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of MEMORIE LUIGI FERDINANDO MARSILI
1 0 GEN.
R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ ISTITUTO
DI B O LO G N A
MEMORIEINTORNO A
LUIGI FERDINANDO MARSILI
PUBBLICATE NEL SECONDO CENTENARIO DALLA MORTE
PER CURA DEL COMITATO MARSILI ANO
BOLOGNA
N IC O L A Z A N IC H E L L I
1930 - IX
R. ACCAD EM IA D E LLE SCIENZE D E L L ’ IS T ITU TO
DI BO LO G NA
MEMORIEISTORMi A
LUIGI FERDINANDO MARSILIPC SBUCATE KEL *IDC*«DO < KVTKNARlo DALLA M**KTK
PEB Ct-EA DEL CXiMrTATO MAKSIUAV»
BOLOOVA
N IC O L A Z A N IC H E L L I
Fino dal 1.92H, itrita aoirnnr adunanza pubblica tirila fttiiir Armdemta tiriir Scienze tirii ' istituto di Btdogna. ii Smatorr Luigi Nata, allora / residente, ricontata che fra pochi anni ti aarebbe compiuto it arcando acculo dalia morir di Luigi Ferdinando Morsili rd accrnnaca alt'obbligo, per l'Arcadrmta, di drgnamrntr atm memorare l'inMignr l'amo di azione e di atudio. chr, con aita comprendone scientifica e con larga munificenza, ideava r fondata un htituio in cui r Accademia veni eri a prendere fruito e chr ben prr*to veniva additato ad esempio e a modello dagli mdrnziati di tutta Rttropa. Acvicinandtm la data del tVntrnario, l'nttualr Presidenza riprendeva r faceva propria la iniziatica della Commemorazione, rd incaricata una ristretta (hmmisaione, scelta nel proprio •rno. di atudiare il migliore modo per l'Accademia di onorare la memoria del arcando tuo fondatore, di Quegli cui cmaa dece di potere eaarrr annoverata fra le più imagni. Venne proposto, e fu appr*/rato dall'Accademia nrila tua seduta plenaria dei 2t> maggio 192S, chr, fra altro, a» prnmuar a preparare pubblioaztom
m aM O t k r. M4MILI
che non arenami il carattere di banali scritti di orca- mone, ma che, per l ' ultrintero e sottanziale calore, rm u irro una tettimonmma duratura deir omaggio dell Accademia ; fra (pirite pnbbhrazioni. d»rette trovare patto un raggutirtleoole volume, cottituitn da una collana di Memorie rivolte ad illustrare le mttltrpHn farete della ¡Htlinlrica atti ritti del Mortili, e redatiìe dai più competenti eil autorevoli conemitori delle rane forme di questa attività. A questi ti indirizzò la Com- missione delegata dall'Arrademia, e tutti gli interpellati, o quoti, rispetterò volonterosi all' ap/tello, inviando la loro tnlda adesione e ponendoti tenia indugio al lavoro. K di questo la retro il presente volume offre il notrrole frutto: nonostante la ristrettezza del tempo, ben 16’ Memorie di egregi Autori prospettano, sotto i più cari punti di ritta, i molteplici aspetti delta figura del Mamh. Infatti, le prime quattrit Memorie lo ricorda net come soldato, sia nel rampo delle operazioni militari, sia in una detlorosa ben nota vicenda, sia come ulea- tare della difesa della sua regione natale e delle sponde adhatiehe. Altri lavttri pongontt im evidenza la tua conotrenza ilei mondo islamico, specie dal lato militare9 navale; altri mettono in rilievo le tue profonde cognizioni geografiche tanto speciali quanto generali; in altre Kgh apporr reme botanico, come archeologo ; uno studio esauriente fa conoscere le vicende che hanno accompagnato la creazione dell htttuto * la riforma dello studio ; dà motivo ad un brillante articolo I analisi di un opuscolo del Morsili mi Cafè; ad un altro
r a i r u K i « ! vti
lo istituzione di una tiam ¡tenti da Lui creata e che n è rena poi famumì. ( 'htutle questo ricco materiale una a entrata biblùigrafia.
I. Accademia, certa che il premente ridurne riceverà dii min ristretti circoli culturali una favorevole, sim- patini accoglienza, esprime la tua ricommcenza al l'apo del (tovemo, che ha concesso alla celebrazione l'alta tua adesione ed il ma patronato; agli Enti che hanno generomimente contribuito alle speme della pubblicazione e ctoè al Ministero della Educazione Nazionale, alla /'torinna di Bologna, al Comune di Bologna. al Consiglio hnocinciale dell * Economia. alla R. Università, alla H. Snuda d'Ingegneria, atta Cassa di Risparmio ; rende le più rive grazie agli egregi Autori che, non risparmiando fatica e cure, hanno data con tanto amore l ’ opera loro; »ente infine U dovere di encomiare nel modo più esplicito il lavoro indefesse» del ch.mo professor Albano Sorbelli che, in mezzo alle molteplici sue oceupazifjni. e con rara abnegazione, ha tanto efficacemente curato tutto ciò che si riferiva alla vasta e assulua corrispondenza cogli Autori e alla non facile preparazione materiale della pubblicazione.
f i P w f a l t» 4clU R Ae*»4»muk «U!t» S r « * i »
V i » Pnwt4c*«* d»i Comitato M m vIum
8. P t x m u L «
I.ilici IVrdlnfttido Marnili
H a * 41 goerra
r u v i H i
11 MufUI. 1« riri* della mi rariulf e frniil» atthltA.
raogionta rolla rapida prtmlow 41 acni umano aaprre r. an
rara fornito 41 una «pedale * prodigiosa larllnasiooe al km*
•tirre delle arai, aoa tardò. appena mirala al arrrlxlo 4 egll
Imperiali a «indiare od a reoderai ««allo eoo lo 41 quanto ai
era propoato «4 «Hfalla dai migliori in|ifnrrl e architetti
militari più la roga, del «oo tempo. la materia 41 forliflraxione,
on*le quadrar brne la ma tornir «olir maniere roal di dlfen
4rre. mar 41 aaaedlare plaur forti. In rapporto alle armi
41 offraa v 41 («Mi (11 altri mrati relativi all'lm piego tattico
d**lle truppe
( 1 4 do ♦ beo* notar «abito, gli é rbe il Maralll. in tolti i
«ooi ato4 i »olir ap«n> militari consultate. ramr chiaramente ri
aolta dalla pratica. non a'irrtgldlarr, come altri f«wo, «ugll
laaegnaowoti «ralaatiri, presentati aollo forma 41 m etodi, per
fortiftrarr ooa piarra e aarbr per al (aerarla, romr l'uv> 41
quel trmpo consiglia« a, ma traww ««Itanto «la qorata «perir 41
fortiAraaiooe teorica, alcool prlocipll imtoanrnil. appi Iran
4 oll parò raao per raao alle condirlo ni dei luoghi rollo «rapo,
beo intera. 41 «fruttarne le qoalità Inlrloaerbe. onde rendere
più «|»4 iti ed «Acori tanto I latori 41 dlfeaa. quanto 1 larari
41 u*edlo
A tal ftoe 11 M an lll r l t o lo la «oa attrnrlooe «opra quanto al era affermalo arile coaidette «coole oaxtonali 41 forllflca- rione derivate. come é noto. dall'arte Italiana Intorno alla qoale
2 MEMORIE INTORNO A L. V. MARSII.I
•l raggru|»parono i vari metodi e sistemi propugnati dagli ita (Uni, dai tedeschi, dagli olandesi e dai francesi.
('orni dalla scuola italiana, i cui maestri della Rinascenza affermarono le nuove forme difensive, apprese le caratteri ■tirile dei primitivi fronti bastionati, l'impiego dei rivellini e delle strade coperte con p iane d’armi di saliente e di rientrante, «Indiandone I particolari e ritmandone anche i plani di maggiore rilievo; egualmente dalla acuoia tedesca, che nacque dopo I* italiana, verso cioè 11 ’’ 500 „ ed ebbe più delle altre ra pillo sviluppo, a ragione delle guerre intestine sorte fra le famiglie regnanti e per opporsi alle invasioni turche, constatò l'adozione dei fronti tenagliati e delle cinte multiple; dalla scuola olandese, sorta con caratteri dipendenti dalle condizioni topografiche locali, rilevò il largo impiego di fossi acquei, i m eni per sottrarre te murature alla vista dell’ assediarne e ancora l ’ impirgo di linee di difesa successive per facilitare le comunicai ioni.
Finalmente dalla «cuoia francese, che si può considerare come la roatlnaaaione di quella italiana, poiché furono l nostri ingegneri che e re» seri» le fortificazioni la Francia, trasse par tifo delle nuove disposizioni d’ impiego dei bastioni, dell* intro- duaione dei roprtfacela. «Ielle tenaglie, delle traverse, delle opere addizionali e dei cosi detti metodi del Vauban, che ebbe campo di studiar* e di valutarne l ’ importanza pratica mente co » vedute, però meno scolastiche
Nella prevenzione che il fratto dei suoi »ind i, polirne srr vire mane norma d’ insegnamento alla girne«tò. «pectalmente appartenente alla c la w del nobili chiamati al arrvlxio della patria, il Marnili fere una Interessante raccolta di numerai piani di fo rin a r progettate e costruite dai p i« eminenti inge gneri militari di la tte le nazioni. facUitaadoae lo attuilo anche con modelli, eseguiti alla perftaioae
• • •
Venendo ora al sistemi di a «ned la re le piazar fortiicate, il Marsili. par convenendo eoa altri noaalal del ano tempo che, nella pluralità dei cari una piazza bene organizzata a difesa.
l m ju m x h x j • t- r . H t u t u c o m o ut a rm u u >
potrà capitolare «ola quaado «I cinga d 'M m ll» » «1 proceda para» a p u w , t r o n d o I metodi generalmente adottali, ta llarla quando forar poraiblle agire la »o d o più «pn llla rarrendoal drl bomba M ancato, a n y l lw la la plauui 41 aorpreaa, o anrhr atterrandola 41 rlra fona, è tempre II «lutrma prrfrrlb il* prr guadagnar tmipo » risparmiar* nomini r aialeriall.
Il Metodo di attaccare aaa p i**** fortr «Ufrmatlramentr fa concretato dal generale f r a ix w Vaahan. t e r » la w l t drl X V II raro lo, mrtodo. rW per quanto dtarurao pro* r roo tro, tena* generalmente adottato da tatti gli rrarritl ruropri Uno, al può dlrr. al trai pi noatrl a p i i p n r ia n m ir firn» all’ «d o lio a r drllr artiglieri* rigate. la quali Impanerò. di ronargurnia. uaorl a m i 41 dlfraa a quindi nuoto procedere prr g li arardl d rllr p iane forti,
Quando II Vautaaa peo pora II tuo m etodo, tuttr Ir pianu* fo t tigrate. la gmere, rrano protrU tr degli clementi di m i è erano aallr «ruote di fortlfiraxloal •urrimrdale, dorr II Mandil affinar largamente prr la m a prodigiosa erudizione.
KfTetti» aa*ente i prore« li menti dell'ataedio ai »tema tiro. rlral gono ad ua'rpora araal anteriore a quella drl Vauban; ed in fatti arila raron<la metà drl X V I arroto, «I rlntmgono trarre e»p iiH le circa II modo di arririnand alla piana al rnprrto mediante trincee, condotte ■rcondo un piano d lrrftlto che, *r non raggiunge ari particolari la rorritpondrnta drllr d itrm r parti rbe teppe Impr imerg li (I Vauban, nr cootirnr prr* Ir Ilare rd I concetti fondaaim iall C'omunqor il rinomato Inge gnere franrera potè, m i n o metodo d'atta ero. ronraguirr rifluitati brillanti «d inattesi arila e*pugaatione drllr pia*** olan dr*i negli aitim i drrm ni drl X V II «renio.
Il Mandli nei «noi procedlmmll d'attacco non drroga. in maraima, dairappllcarione drl metodo drl Vauban, e d ifa lli fa ««aneare Ir truppe ara«liIriri al coperto, mediante approcci a l ig la g . co» tra lare col Irga araali prr riunire g li approcci r prr poetare Ir a rtig lirrir »o lir direttrici del tiro crrno il f ron Ir p n w di mira, rompim d o nad tuttr Ir oprr*«ioni Uno allo «pa lio per poi procedere alla di a t ai « r i fotao e quindi a ll’ aaaalfo
« MEMORI C INTORNO A L . V. MARttll.t
deil'opera per breccie, aperte in antecedenza nei muri di ■carpa.
DI natura però insofferente agli intingi e<l alle lungaggini, dovute specialmente ad un convenzionalismo troppi esagerato, U Marnili pensò, studiando le propoate del Coéborn olandese contemporaneo e emulo del Vauban, che 1* impiego dei mortai unitamente a quello dei cannoni, postati convenientemente in batterie protette ed a distanza di tiro efficace, non poteTa non «lare buoni riunitati quando, bene inteso, l'azione del fuoco ai funse condotta con la massima efficienza e aenza interruzione. Con tale convinzione Egli era « iruro che il metodo di Vauban ai aarebbe di molto semplificato e reao più speditivo quando, •peclalmenle i lavori di copertura, ai foaaero eseguiti con rapidità su tracciati razionali, rispetto ai fronti delle opere cinte di asaedlo.
In altri termini il Marcili riteneva, e con giusto criterio, cbe allorquando le artiglierie foaaero átate in grado di colpire coi fuoco Intenso quelle deU'avveraario. rendendole inservibili e di rovinar«* I parapetti del fronti attaccati, le ulteriori operazioni sarebbero certamente avvantaggiate e l'assedio sarebbe risaltato di minor durata.
• * •
Dallo atadlo delle proposte «arte nelle «arie scuole della fartiftraaioae, il Mar-sili ae traaae g li elementi, cbe secondo i aaoi criteri, potevano servire agevolmente per la difesa di una piana, la am oa ia roo I meni di offro» allora in oro. Kg li eri deotemente non si «costà dall appliraziooc dei frooti, a tracciato bastionato im agi tato, coni raccomandalo da tatti i mar atri di fortlftcazioae, fra cal il bolognese Francesco De Marchi; per tatti g li a ltri particolari, perà, non fa portato a seguir* i metodi del Vaaban. compreso || J*. ritenolo il più importante, e preferendo a qaeato. quello del CaMmro * di cal ebbe a va
* |v» «S | * W « U m m ». rtn N ta a * c*e u m » 0 V tth U i ^ w a l* n « t a n i «m misen, a la » ««ita . *art a x * « la a t» jv » t o iiH n it ««a j*s«Mk. «aaata pM sttaonsrta. caa aawiB» n f r iu * .
u H i i n i t u • u r. M untu fo n o ni a t 'n iu &
Irmi, coatitnlto coM’era da una cinta haatkinal* roti tenaglia, rivellino r r o a in fu id l f . U r ia l* a ll« a principale ira poi arparata dalla rlala ha—a. o «avoadaria, per a n m di un ampio foMo aariallo difeao da (a llr r lr di roveacio « da ranamaltr ponte Drtrll orrcrbioai dri baatlonl. i m i Ila orbi rrano ru n l Ila r i; la tenaglia era la terra. U riveMao orgaaiaaato nane i baiti ioni, li tomo. cbe circonda«* la claU principale, era largo* anioni Hi a « fa b r a l im i drl Metudo «tri trdeac« Kimpler, ebr prupow nn fron lf con bastione centrale, ove la cortina * apra**la a M a g lia prr farla concorrere, con i fianchi. al llan ebeggi* a ra lo dri bastioni
Osa ta k I r a prram m io, la ( o r l i l c u k w a«*nn*r*a nn cara! Irrr pia avvolgente
In « g a l lo alla raasallaaioal fa ll# dri vari aeriltorl di far tifiraiionr. il Maraill pmaA di concretare ancbeaao nn tra tta i« in matrri*. ebr a ir r U r Intitolalo « principi fondamrntali di fo rtiicacioar » a * dU craiia lam m tr orila «uà raccolta di do Munenti, non b* laarialo arritto ebr una prima partr, nrlla quale fa aaa dracrtaioar particolareggiata dri m m i di offraa. allora la a » , rilevandone la B an cb n o ln w prr trarr«’ da ra*r Ir n»rmr prr aa m igliorr impiego negli attardi r di ennargurnuI meati adeguati prr opporr« una valida d ife M .1
I piani di piaaar forti diargnati a penna r a colori, rarrolli la appunti volami dal llara ili «ano, come già ai diaae, nume roai rd intr n i— nti prr l 'm ttea ta dri particolari nei riguardi d r l I r fortiScaaioai raao prr caao adottate Notevole è poi il fatto cbe Egli arile avariate application! di metodi e di alatemi fortificatori, non ai lim itò «o llaa lo a »Indiare le opere da edi tra rr n trrra ferma, m* anrbe aopra laolotli. aperte nella valle danubiana d ie permear. rilevando allentamente la natura di gran parte dei corti di ari)a* comperai fra la Herbi* inferiore a l ‘Anatri* aaprrior* ia taluni dei quali, come ai veilrà in ap p m a ». ebbe occaaionr di gettar ponti di ogni genere, ora con Materiali d 'equ ipaggi« ««I ora. fretlolo»*menle, eoa materiali d i rirroatant*.
• • •
Fra 1« piante di piasse forti appartenenti alla raccolta del M an li! ricorderemo, fra le altre a) la pianta di una fortessa •al !*o 1 fatta erigere in ('anale Monferrato dal Duca VIncenso di Mantova, secondo 11 progetto del l'ingegnere e architetto mi litare Germanico Havorgnano, Aglio di Marcantonio, 1 cui lavori condotti dal medesimo, ai protrassero dal 1589 al 15i>5 nel l'intervallo cioè fra la guerra di Fiandra e quella d'Ungheria. Quel piano contiene l'indlcaslone dei lavori d’assedio compiuti nel 1595 »otto la città e la cittadella di Camle da un esercito composto di truppe delle tre poterne Austria, Spagna e Piemonte.
Il 28 giugno 11595 gli austriaci e I piemontesi aprirono la trincea contro la cittadella e il 30, l'aprirono gli spagnoli contro la città ; mentre però rolla prima fa spinto l’assedio Ano alla tersa parallela, colla seconda trincea, invece, non si ottennero che scarsi risaltati, tuttavia le batterie furono armate ed anche aperto 11 fuoco, ma 1 lavori d’approccio avvolgevano rosi poco la fronte d'attacco, da non nascondere l'infingimento dnlle operai lo ni. dovute ad una ronvenslone segreta stipulata fra l.a lgi X IV e V Amedeo II .
Con questa, veniva stabilito la capitolatione della pLassa, la dem olitone delle opere attorno alla città e l’abbattimento totale della cittadella.
Dopo qoeU'epoca, scomparse dal terreno le tracci» di quella opera grandiosa. Il piano dell'asaedio tuttavia raffigurato nella pianta di n i si tratta, acquistò tale importanza storica da im pnraaionare qualunque studioso di fortificasiooe. »perle II Mar
H » bea fece a presentarlo nella sna raccolta; hi II piano, pare a colori, nella valle di Magonsa * è costituito da una linea, a base poligonale di tre lati colle estremità appoggiate al Reno, Pr r modo che la riva destra del Dame ne forma il fronte di gola, o rga n im i», a sna volta, con una semplice Hata morale.
* MEMORIE INTORNO A L . F. M AKH ll.l
MEMORIE INTORNO A L. V. MAM1I.1
Ha r lu n D lato Orila linea di baite poi, ai trova una «erte di fronti bastionati che, nel lato a mezzanotte, presentano »pie rata tendenza alla forma tenagiiata, mentre nel lato opposto, si rileva ao’opera a corno ed un ridotto che mediante un ba stione, s'innerisre nella cinta bastionata esterna. I l profilo del rampar«, oltre ad essere costituito da nn alto maro di scarpa presenta, alla sua sommità un parapetto pare in muratura che serviva a proteggere U cammino di ronda, ricavato fra 11 piede della *rar|Mi del soprastante ramparo in terra e il cordone del maro di acarpa; e) il plano altresì di un forte su terreno leg germente collinoso ' eretto *u pianta poligonale migliorato, in •«gallo, coll’aggiunta di un'opera a corno ani fronte a sud; d» il piano ancora di altro forte »opra un iaolotto del Dana b io* che riproduciamo nello «chizxo 1 per la »aa originalità. L ’opera è »{»ternata in an sensibile restringimento del fiume rd è messa in romonicaaione colle rive, mediante due passaggi, difesi da robuste leate di ponte. Come scorge«! la fortificazione principale è roatitnita da dae parti separate fra loro per mexzo di on fom»o acqueo; la parte rivolta verso valle è formata daoo froote bastionato con rivellino a fianchi rettilinei e con fronte di gola, muoilo di nn bastione tenagliato e di no rivellino in moralura. con feritoie nella parte a monte; il fronte, nella cartina rinforzata, a sna volta, con rivellino e contro guardie, è pare bastionato con doppio ordine di fuochi; r i è la strada coperta. Io »paltò con foM », che lambe il »no piede e che nella fortificaalone costituisce an fatto caratteristico e singolare; e) la pianta infine delle fortificazioni di Ferrara * coati tolta da ana cinta bastionata che racchiude la città e da una cittadella pvntagooa la qoalr venne a sostituirsi al rastello R a tea » del Bertolioo; la cinta venne tniaiata tn dal 1513 da Alfonso 1 e I lavori delle altre opere: baloardi. cioè cittadella » il talm ente della cinta «tessa, furono dirette dal celebre (iio . Batta Aleotti di Argenta, Ingegnere civile e militare «otto il
• r. M . T L X t » r M. Tot y X. »T. » r. m r. <*. it. »
L. MABIMM1-1 • L r. M iM IIJ UOMO DI Cil'HUU 9
regno di Alfonso I I . L*intrnto di tali fortificazioni ora preci m flirtiti* quello di esercitare predominio nulla città. come arrenar di fatto, dopo tre ureo li di r im i le politichi* nel 1KIK per opera del preti ilio austriaco.
• • •
Oltre a moltissimi altri piani di fortezze, la raccolta del Marnili contiene pare numeremitsime piante di rlltà nostre e di inori fra cui quella di Rrmcia, l^-gnsgo, Crema. Terracina. Faenza. Koma e «In via «enea contare le mappe di territori, talune riferente»! a intere provinole e anche a nazioni rame quella d 'Italia che ai estende <|al Tiralo fino alla mtrrtnllà della Calabria, dote il Marnili ha annotato le marcia* che potevano marre eseguite dalle armi di Cesare dal Anmr l'anaro. che divide lo stato di Modena da quello della Chiesa, Ano al A urne Tronto
Meraviglioso è altrm i il patrimonio che ha lasciato questo illustre bolognese, intorno alle ricognizioni ed oatervazionl fatte imi »variati corsi d'acqua nella valle Danubiana, «ut Aume Reno e su altre moltimime località a »rapo militare nelle cui
| relazioni ai rileva, oltre alla competente capacità di giudizi'» nel precisare i ponti adatti per determinati scopi, anche la ocu la len a sulle in formazioni intorno alle ritorse locali per le eventuali operazioni di guerra.
G li studi compiali al riguardo valsero al Marnili, in mod» veramente sorprendente, per la costruzione dei ponti pare nu mera»i»tim i che ebbe ommione di gettare cosi sai grandi rami d’acqua, rame sui piccoli in tutte le campagne alle quali prese parte attivissima rame ingegnere militare, rame condottiero e ancora rame abile consigliere nei consigli di guerra fra i gene rali e Io steaao capo delle truppe Imperiali.
Per I ponti grandi e piccoli che il Marnili ra»lrui. »perla i> mente sul Danubio e sui tuoi aMoenti. si servi tanto di mate ria li d'eqnipnggio * cioè barche, cavalletti, travi e tavole, tra
• r. t. «a. a. m
IO MIMIMI« isnuwo A L. P. MARMILI
•(«urtali dall« truppe operanti, quanto di materiali di circo- •U hm e cioè barche, «attere, fosti, travi e tavole, il tatto requisiti» «ai luoghi. Hi avvali* inoltre, anche degli ¡«»lotti mi
p A H U B ' Q ■A
A?' ° A O!
«tra ti «perir «a l llaaabio e «a altri g r «* »i •■orni« per farli •rrrtrv coaw corpi di « « le g n o lateral i. oode evitar» lunghe tra tir eoa m tv g a i d'equipaggi« aoltaato. che aoa m apre po Ina a m » a ma dUf»*takMM>. Vn m a ip io degno di aota di ponto Mi Daaabio apprettando di bolo ni «arirtno » . *)» fa
s c in rc ro A F a
• r. M.. V i . ) « L
u h u ix b x i • l . r. u s u il i uomo ni crnuu II
progettato dal lland ll per stabilire la comunicazione fra la TranailTanla e la Herbia prr i o Kam. I lavori riir erano già lai siati vennero aoapeai prr ordine del Principe Luigi di lladen, U quale volle poi che il passaggio ai effettuasse invece a Oiaa nlna. U collegamento del vari inolotti fra loro è ottenuto, rome acorgmi dallo achlzzo, per n etto di ponti formati con corpi di noategno galleggianti.
In parecchie coatlngrnze di guerra, dovette aervirai del ro|iera dei gunatatori dal Marnili «tesso allenati per aprire pa» •aggi trnnaitabili in terreni coperti e anche boschivi in rirco- •tante, talvolta diffirillnalme e tali, da dover ricorrere alle mine ch'Kgll egualmente praticava, con »pedale competenza.
Negli affortamenti apedltivi e, «perle nelle operazioni d'attacco di piazze forti, fece granile ano di coperture, formate ma gabbioni, faaelne, zolle di terra e «archi di terra, creando in tal modo parapetti per diaporvi dietro le artiglierie e anche per avanzare nei trinceramenti di approccio usando i gabbioni, •perle duranti- I lavori di zappa aemplire e doppia, come ai fa cera io tutti gli a Medi di quel tempo; fece egualmente largo impiego di dlfene ac reano rie come abbattute di fanti e di alberi palizzate, palancate, burbe da lupo ecc. rosi per ostacolare o ritardare l’avanzata degli avversari nelle località orga aizzate a difesa, come per chiudere gli accenni «a determinate ione di terreno in campo aperto, durante le operazioni di guerra
Xoa am a alacre ed appassionato fu lo ntudio del Marnili nulle armi in genere ed in Uperle »o lle artiglierie per le qaali non tra lanciò alcuna ornatone per mettersi al corrente dei progrenai che andavano seguendo, onde utilizzarne gli effetti e proponendo Kg 11 sterno modifiche e varianti aotto tatti gli napetti « Hoè sai calibri. Mila lunghezza dell'anima. Mila ma aegevolecta. «al traino. Mila fusione «ve.
Dove il Marnili ebbe rampo di approfondire le soe rogai zioai tecniche nei riguardi delle bocche da fooco, fa a ll’A me naie di Vienna, la via tori a d I6M per prmirdenr alla fabbri razione di tali armi, le quali dovevano servire, secondo tipi de-
12 MSMoait ISTOWO 1 L r. MAMILI
terminali dal consiglio di guerra imperiale, tanto |ier l'arma mento delle piasse forti, quanto per gli «w n ll.
Calè al trovò a contatto del celebre ingegnere Antonio Oon- sale*, di origine spagnola, il qnale al era inibito per fondere cannoni e mortai capaci di una lunghlaaima gittata e ancora per fabbrirare «variati tipi di bombe e fuochi artificiali II Mar «ili ebbe eoa! campo di aaaiatere e di praticare Kgll » In a » molti rape ri menti, dai quali trame rilevanti considerazioni eoa! nei riguardi delle artiglierie, specie di quelle ebe armai ano la piaaaa di Buda, come in quelli della polvere da cannone per la •uà accenaione nell'aria e per i aiioi effetti.
• • •
Tome tempra adamantina di aoldato, il Marnili ne dette numerose prove, durante tutta la «uà carriera al servizio degli Imperlali, la Incondizionata disciplina. la tenaria nel propositi. Il coraggio, l'audacia, la nonrnransa di aè »temo, furono le »ne doti preclari che tennero alto il faatigio del ano nome, ctMri nei momenti di gloria, come nei momenti di »conforto • di dolore ebe oon furono pochi g u n le doti rifnlaero anche nelle operazioni ani campi di battaglia, dove 11 Marmili, come condottiero, ai rivelò reperto e geniale neU'impiego tattico di tatti i messi d'azione del ano tempo.
Kgli curata altre«! l'Ulrnslone. l'allenamento ai disagi e alle fatiche de" »noi dipendenti, in terra.»* ndosi. in modo «pe ciale deU’uniformc e ancora della ronoacenza e impiego del l’arma portatile, per il buon uso che dovevano farne a mo mento opportuno.
Avvedalo e conciente, fere valere l’opera «un in tntti gli anuMmli e nelle operazioni di ricognizione e di esplorazione, la atta arditezza ed abilità nel cavalcare, g li procurarono inoltre l’unorr di raarr» scelto, » pe»se volte, qnale comandante di reparti di cavalleria per assolver» incarichi delicati e avventa- roal; ferito piò volte non ebbe momenti di debole*** e conti nnò ««inpre con lena nel forzato ripoao. i ano! »indi, le cne ri cerche accumulando memorie e relazioni 111 a » ira le con mappe e disegni in matita, a penna e a colori-
L M U 1 X IU 1 • U r . M A M I 1 1 UOMO DI O l'O U U 18
• • •
Nel fondo Marslllano. che tratta dell‘arte osaidlonalr. abbiamo arri lo e rimesso In luce. con (‘ausilio «li grafici. aironi •tndi r progetti Intorno ad operr di fortlficailone prette «lai Marnili in varie p iane e ancora intorno a lavori eseguiti tanto per cingere d'ancdlo, quanto per difendere p iane fortificate.
Cominciando dalia ricognizione e difesa del dumo Kaab ab bla ino ricordato: «| le opera »bini relative airassedlo di Itada: 6) la difesa delle p iane «li Htrigonla. Vlcegrado e l attacco di Npukanaael; e| le operaiioni di assedio e difesa di Belgrado; d i la difesa di Hemendria. Nlaaa. Oraova e attacco di V idlno; e ) il piano di dlfraa di Peter Varadino; /t l'assedio della piana di Landaa
Rlroffniilonr • difesa del fiume Kaab.
Nell’anno IO C il Dnca Carlo di Imorena, venato nella deter minatione di provvedere alla difesa del flume ftaab, rollo acopo di opporsi ad una eventuale avanzata dei Torchi, verno Vienna, ordinò ni Marnili di procedere ad ana preliminare ricognizione di quel ramo d acqua e di formulare poacla proposto concrete per la necessaria difesa lui prima operazione eseguila. cbe «l est««e dalle origini del Some nella Mtiria, fino al suo aborra nei Danubio a monte di Konam n presan Dia varino, dopo cioè nn percorso di d ir a 300 Km., venne segnalata dal Marslll al detto I>ura per me*in di ana monografia militare geografica redatta in guisa da potersi ritenere rame nn vero modello di rb la rena e di precisione R n r conto. In pari tempo, delle prò poste relative al lavori da eseguire per la difesa, in virlfi dei quali venivano migliorate le caratteristiche proprie del Dame ne» riguardi delle operazioni m ilitari concernenti, cioè, la fan ■ione di ostacolo, oppure di elemento di manovra. Tali proposte approvate dal Dura darlo consistevano. tananai lutto, nella «oppressione di diversi ponti mantenuti dalle popolazioni al nolo «rapo di transitarvi le beatie per recarsi al pascolo: nel
M Mancata ijrrnnjio a l . r n i u i i i
mantenimento ili altri a scopo difensivo. fra cui quelli di A r pa* e ili H. Iiottarilo, a lti a funaionare «la elementi ili manovra. A custodia ili essi era prevlato un presidio ili 500 Domini accasermati in appoaito forti-, eretto ralla «ponda amica con corpo di guardia * cavalli-ria; ralla «ponila opposta, Invece, erano propoali dei Irinivramenti a wnipllcc profilo, ma pwò capaci di tenere «oggetti gli accettai con tiri d'infilata.
iV r i guadi, in corrUpondentn di «ponde basse, veniva provveduto pure con trinceramenti, per battere d 'in filata e in cor riapondenia di «ponile ripide con patinati* di sbarramento; le rampe d'arce—w dovevano essere distrutte e la linea di guado sottoposta al tiro d'infllala esercitato da apposite trincee con venientemente «{«ternate.
Kra inoltre «tabilito un perfetto «Ulema di vigilania a metto di pattuglie di cavalleria «peclalmente e, prescritto infine ebe In ogni luogo presidiato, fonar tenuto un cannone per dare l'a llarme. Il Marnili a tale riguardo acrive: « A l «entire qu oti « «barri ognuno che «a r i rapare di portare armi, «otto pena « della vita, sarà obbligato a correre a quelli tali pò*ti li «a « ranno to rn ii nella ripartlalone... » *.
Tatto adunque era pre»li»po*to nel modo indicato per im pedlre a ll'w n ilo ottomano, forte di 30 mila armati, il foraa mento del Raab. «e nonché nel momento ebe « i «volgevano le ostilità, vennero a mancare le truppe di «occono e. peggio aa cor* g li Caguri, ebe erano dislocati nei vari presidi. abbaa donarono I loro posti e d'accordo con i Tartari avversari «i diedero a correre la campagna mettendo a ferro e fuoco tutto il paese
I l Marnili. abbandonato * # stesso, fu raggiunto da una «quadra d i rotarti ribelli e arrestato come an volgare malfattore.
t*a quanto «opra si è detto e dal rimanente carteggio I* «ciato dal Marnili, appare evidente rbe la disastrosa fine «Iella mai bene idrata impresa del R**b, ai debba ascrivere, non «olo alla «iefrtione degli t'ngarl. m* anrbe al tradhnealo di quell» popolazioni Indigene, ben conoariute dal Marnili stmao rune infide e ancora, e fame, con ptà funeste conseguente dal mai-
• r m v a a i m «
L. M A «i*«ttt • u r. m * * »n i « omo ni g i n ju 16
calo appoggio «Irli- « a toriU di Vimna, cbe purr r n ■ cono- M tn u dell« »ituatlone roti poro r*««iru ran tr e jier I* quali» o r r o rm » provi edere innanai irmpo, m u incedette * w n u Indugi.
Opernioni attorno a ll’ A « * 4 lo 41 Rada.
Il Marnili ridar parte olirrmodo Importantr nrlle o|>rraalonl di amrdlo di Rad*, au la «aa «siane prr«on«lr. pur mal p m i»M . anche la qarile ci reo» tante per la ronoarrau rbr a m a drll* l l a u i , del modo di cumbattrrr «Irl t r a in i r prr i ■aggi rr ilrr i che a t n U r applicalo nello n o lg lam tn «Irgli al tacchi. fa «p i o tra «carata o deviata aia dalle direttive di V im n a, m a r dal parere «Irj comandanti I «ari raggruppatueall di a m a li che rootituhano II l'orpo d ’aawdlo.
I l Mandi! rbbr a compilare, eoa lettera direna al Dura di Lorena, una monografia della placa* di Rad*, valendoci dei ricordi che «m arn ava drl periodo in m i fn prigioniero del T o rchi trascorrendo colà parecchi meni In «tato di arbiavllA. A dire il vero da qnevt* monografia *1 «arebbe indotti a formularelo a t r o » giodicio eh« poi ar trawarro grim prriati nel 16K1 «a llo «la to cioè di « a r a eArraa* della piatta, chr ai «opponeva cir evadala da »empiici mara di poca grt»*»e*ta m i a oprrr m ie riori. a ll'in foori di rondelle p lt o meno vaatr e perciò di facile conquista £ da ritener* però chr U Marnili «in daU'lnitio delle operarlo«i drl primo «M edio di Buda, c o n » (alato, fra l ’altro, che la notevole re*l» len i* drl Ir mura, era determinata dalla roccia del amate, coatro U quair «I trovavano In gran parte addowatr. a m U » adottalo prò* tedi menti adeguali »la per l ’impiego drl le artiglierie, come prr rappm lam rn lo delle mlnr di breccia, dà chr però eoo risolta abbia attuato II corpo d 'a» urdlo di allora taatochè. Ir oprraxloai di attacco continua aien te paraliuate da ll» «orti Ir dei Turchi, dovettero e»«rre in ter rotte e. a ir ia iiio drll'Invrm o, rendendo»! «rmpre p ii difficiliI rifornimenti, l’aMedlo veaar addirittura levato.
In una lettera diretta al Principe Gastone di Toscana (18 Norembre IfiSt) il Marnili rileva, in modo particolareggiato, le canne che determinarono rinxucceMo del primo assedio di Buda e già 1*1* occasione accenna Ri criteri fondamentali che, iterando Lui, ni dorrebbero seguire per l ’attacco di una fortezza e che in seguito, espose in forma concreta compilando il progetto d'assedio di quella piazza (schizzo X. 3).
Per meglio intendere le osservazioni e proposte del Marnili, occorre ricordare che Buda, in quei tempi, si trorara riunita «ulla sommità di un colle isolato alla destra del Danubio a falde, in massima, notevolmente ripide con terrazzo superiore paragonato ad un triangolo isoacele; la base piuttosto ristretta di questo, era dalla parte di tramontana, dorè trorarasi pure, sulla falda del colle, la città bassa « I il terreno circostante si srolgera poi in discreta pianura, il rertice invece era dalla parte a sud ed Rrera di contro un terreno collinoso costituente le peudici del monte San Geranio; a lerante, inrece, la falda del colle lasciata breve spazio libero sulla sponda del Danubio e a ponente, inAne, dopo brere ralle, seguire una catena continua di colli e monti.
1*> opere di difesa ronsisterano essenzialmente in una cinta murata a cortine e mezze torri o rondelle; a sud. coll’aggiunta d i un'ampia rondella, si era costituito il ridotto o castello ( l ’an tiro Palazzo di Re Mattia) e, mediante un’ appendice, lungo la falda terso il Danubio, il rosi detto ('«s te llo Basso Rtente la funxione più speciale di assicurare il rifornimento d’acqua dal Danubio medesimo, perché i posai della Città fornivano solo acqua guasta da minerali e pressoché imbetibile.
Io» praticabilità delle falde delimitanti il colle di Bada, era difficile a lerante e a ponente, più facile inrece dalla parte di mezzogiorno e d i tramontana.
Il Corpo d'aasrdio si dispose intorno alla Piazza in due nucle i: l’uno, contro la città bassa, l’altro, di contro al castello addossandosi dote possibile, alle rolline fuori del tiro del cannone e coprendosi, contro eventuali sorprese da parte di una armata di soccorso alla Piana.
16 M KMORIE INTORNO A !.. V M ARSII.I
18 MEMORIE INTORNO A L . F . M A R S II.I
11 nucleo di tramontana occupò, combattendo, la città bassa ma ni arrestò di contro alla cinta murata attivamente difesa dai Turchi; il nucleo di mezzogiorno stabili invece due attacchi distinti: l ’uno, contro la grande rondella, l ’altro contro quelle del castello basso; sulle alture alle pendici del monte 8. Geranio vennero appostate le batterie di breccia, ma «tante l'eccessiva lontananza del bersaglio, la resistenza delle murature, e ancora l'insufficienza del detriti di queste, ottenuti dal tiro, con i quali detriti ni dovevano formare le rampe d'accenno alle breccie, occorse quindi affidare alle mine il compito di com piotare l'apertura del varco nella cinta. Ogni attacco sviluppò 1 relativi approcci che per quanto continuamente ostacolati ed arrestati dalle vivaci sortite dei Turchi, giunsero fin presso il piede della cinta murata in località scelta su di un fianco della ron della grande tanto nel castello alto, come nel basso.
A questo punto id svolse la guerra di mina e contromina, senza però riaultato decisivo per l'attaccante; e poiché i Turchi riuscirono ad impadronirai e a distruggere poi la nuova linea di approcci degli Imperiali luogo la sponda del Danubio, che avevalo scopo d'impedire i rifornimenti d’acqua nella piazza, questi risolsero di levare l'assedio, tanto più che avanzava la cattiva stagione ed aumentavano le difficoltà logistiche.
Nella sua lettera al Principe (Iasione di Toscana, il Marnili rileva, a proposito delle su accennate operazioni di assedio, che venne a mancare una vera ed opportuna linea di circonvallazione. sempre necessaria per meglio tranquillizzare il Corpo d'assedio e facilitargli una eventuale reazione contro armate di soccorsa alla piazza : mancò pure una organica linm di cuntrova Dazione, tanto importante, secondo rileva il Marsili stesso, per opporsi alle aortite e limitare i danni che l'assediato può arrecare ai lavori deU*attaccantc.
U tardiva costruzione di una linea di approcci, che doveva poi funzionare anche lungo la sponda del Danubio da controval- lazione. non permise il completo isolamento della piazza, la quale potè cosi comunicare attraverso detto fiume con IV«terno.
L ’andamento degli approcci non venoe curato in modo da evitare i tiri d’ infilata ed anche nella struttura degli approcci
U V t l lM I I.I - U r. M AMI I I UOMO DI OI.TBUU 1»
ni commiarro errori notevoli, tra i qaiili. la ln»ufflciente la reti rara e profondità dello aravo, per modo rhe il movimento delle guardie e delle troppe d'anaalto, riunciva lento e con araraa protestane : non ai rM troim nu neppure tumrhine per i moarbettieri e quindi venne a mancare ii tursao più efficace per opponi alle aortite degli anneritati, in viata delle quali veniva npeano provocato l ’incendio delie numerone falcine, che gl'lm prriaii avevano impiegalo prr procedere plé nolleeitamenle alia roatroaione dei parapetti.
Le artiglierie impiegale ai dimnatrarono Inefficaci ed ii Marnili ne rileva le cau«e ed acrenna ai provvedimenti adatti per rimediarti in arguito; anche la guerra di mina procurò •can i vantaggi aH'attacco, nonoatante i notevoli aacrillri di per nona Ir e materiali, in quanto InUiandoni le gallerie a dintania troppo grande dalia divisata brerria. la difesa riusciva ad individuane e a procedere quindi ad efficaci lavori di contromine. U gallerie venivano costruite a aratone troppo riatrelta con tracciato tortuoso, determinando, in tal modo, difficoltà notevoli di arieggiamento rhe « i otteneva a m n in di mantici; l'In- ta*ammto delle cariche di polvere fu spenno inaufficienle e all’atto dell' eaploaione ai verificarono prole* ioni di materiale anche verno l'attacco con invasone di gaa anflanlantl nelle gallerie.
I l Maraili. nella nteaaa lettera al Principe Cantone di To ■rana, dopo avere capraio numerose altre acute onaervazioni Intorno alTimpirgo delle batterie d'attacco, al modo di praticare Ir hreccie colle mine, d i atabilire p iane d'armi, palixxate a sostegno degli approcci, con funzione analoga delle parallele, che troviamo poi nel elamico •¡•tema di amedio del Vauban. enuncia anche un aaaioma militare, ila arguire nell'attacco di una pianta aaaediata e r W « di opporsi all'inimico con fronte maggiore di lui * ciò che ottiene «viIuppan<lo i lavori d'attacco in dirvcione degli angoli e contro le rondelle; inoltre la direttrice dell'attacco dovrebbe volger»! aecondo la mnraria e non ani fianchi, come fecero gl'im periali in qu oto primo assedio. rapo nemioni cori a costanti tiri di infilata e di fianco da parte della difeaa.
Nel marco «lei 1865 il Marnili compilò una Propo»ta di attacco di Muda che, farinai i disegni, è in gran parte riportata nel carteggio lasciato dall'autore In essa proposta si rilevano le disposizioni di carattere generale o particolare che dovrebbero regolare l’andamento del l'assedio, dettate, non solo «lai la esperienza che il Marsili fece durante il primo assedio di Buda, ma anche dalla perspicacia dimostrata nella sua multiforme attività, per modo che gli riuscì di operare notevoli progressi tanto nelle scienze, come nell’arte m ilitare in genere.
Sommariamente I» l'rojmuta di attacco di Buda comprende: una linea di circonvallazione, per opporsi alle eventuali armate di «occorso ed una linea di controvallazione, per isolare la l ’ iazza ; contrastare od impedire le sortite: costituire la base, per lo sviluppo degli approcci diretti nelle zone di minore resistenza della difesa e verso le breccie che verranno poi aperte da cannoni o dalle mine e assaltate infine dalla fanteria in accordo con un bombardamento generale. In questa fase il Mar sili fa Intervenire le batterie di mortai adatte per provocare incendi nelle case, che in Buda erano per lo più coperte di paglia, e determinare. In pari trmpo, disordini nel presidio.
Speciale interesse presenta poi il proposto sistema di piazze d’anni consistenti in spianati rinchiusi da parapetto a prova dt cannone per proteggere l ’accampamento del Corpo d’assedio; per installarvi le batterie di cannoni di vario calibro, che devono incrociare 1 fuochi nelle zone adatte alla controffensiva della piazza e ancora per ammassarvi le truppe destinate a ll’a»- salto delle breccie. Il collegamento stabilito, poi, fra le dette piazze d'armi e fra queste e gli approcci io progressivo sviluppo verso le brecce, accenna già al criterio di avanzare nell’assedio conquistando passo a passo il terreno esterno, come appunto pre arri ve il Marnili che cioè anche le breccie, non devono esaere d'ordinario prese di viva forza, ma ben») sviluppandovi nuovi approcci sino a sboccare in località dove l'attaccante posaa avere una fronte non troppo ristretta.
SO mkmokik intorno a l . r. u armili
* r. m.. v. a.
Lp d irttlogl, «ru n ilu coi d o m i procedere l'itt ircu , <<raun trr conformi in mancini* a quelle »eguitc nel primo assedio; però ori I6 M , iT fndo l'K lettorr di llarlrra preteso di r lw f v ir r per Ir »ue truppe un attacco apparato, quello cioè contro il castrilo, nr venne che gli a ltri dur attacchi, «I «Tolsero aul fronte noni della p i*u a per opera delle truppe Brandeburghesi e del Dura di Lorena.
La Proposi* di attacco di Buda, compilata dal Marslli, rum prende infine un elenco particolareggiato dei lavori ds eseguire, fra i quali: una linea di cirronvallaalonc, lunga circa metri 10.000; una di controvallaaionr lunga circa tn. .'1.000; gli ap procri per I tre attarchU lunghi complessltamenle rirm me tri 5.000; e ancora le truppe di presidio delle bocche da fuoco, per l'armamento delle batterie; Il numero dei guastatori e le altre maeatranse, con i relativi strumenti da lavoro afieciftrati per numero e genere, nonché I materiali per costnuione di rivesti ■tenti, pallaaate, paino!! per le artiglierie ecc.
Il Corpo d'assedio avrebbe dovuto costituirsi con 21.000 uomini di fanteria. 4.000 di cavalleria. 104 cannoni di vario ca- libro e 18 mortai.
Nel mese di giugno «lei I6H6 le truppe deU'Kserrito Cesareo sospewrro l'assedio a Buda e. dopo vari conaigli tenuti*! fra I generali intorno agli attacchi da sviluppare, venne deciso di attenersi alle proposte del Mandi! rolla variante, di cui sopra, nei riguardi detrattam i riservato all'K lettore di Baviera. Dopo tre notti consecutive di lavoro, contro il fronte della città bassa fu possibile impostare una polente batteria : nella notte seguente poi, II Marnili riuscì a portare le trincee fino al piede del muro della cinta: sventuratamente però, nel compiere Kgli •tesso una ricognizione del terreno, dittanti alla batteria, collo scopo di stabilire la preciaa direcione deirasaalto, fu colpito da una palla di moschetto nemir», riportando la frattura del braccio destro. Venne rosi a mancare l'intervento attivo e perso naie di un generale di tanta rompetenu.
Furono lanciati tre vigore»! assalti, ma siccome i Turchi non cedettero terreno, il Marsili suggerì allora di procedere ad un attacco generale, coordinando opportunamente gli sforai ri-
u m aiim k u u - l . r. m4m i i .i como oi ci'muu 21
22 MEMORIE INTORNO A L . V. MAKM1I.I
ro ltl nelle note direzioni; e poiché dopo qualche incertezza il suggerimento venne accolto, le resistenze della piazza furono superate, U presidio passato a HI di spada e la città data alle fiamme.
• • •
Nominato Ispettore generale degli Assedi (1688) il Marnili ai affrettò a segnalare a Vienna la necessità del restauro della Piazza di Buda non essendo improbabile un disperato ritorno offensivo da parte dei Turchi.
Nella chiara e particolareggiata relazione ' relativa al suaccennato restauro, il Marsili procede separatamente nell'esame dei lavori occorrenti in corrispondenza del fronte d’attacco tenuto nell'ultimo assedio dagli Imperiali e di quello tenuto dai Bavaresi.
L ’ostinata difesa dei Turchi fu causa di notevoli distruzioni da parte degli assedianti, per opera dei quali la cinta murata risultò abbattuta per una estensione di circa 500 metri, sul fronte degli Imperiali e di 140 metri sul fronte dei Bavaresi; il Marsili nel proporre la ricostruzione, limita la «uà altezza a •oli 8, e ciò, non tanto per considerazioni di economia o di sollecitudine di esecuzione, ma per fornire alla difesa, in quei tratti di cinta, la possibilità di eseguire tiri piuttoso radenti.
In corrispondenza al fronte d'attacco degli Imperiali, propone di radere al suolo tutta la parte della città bassa, che in passato aveva ostacolato l'attività della difesa: di costruire sul davanti ed a rinforzo della cinta una strada coperta con palizzate. preceduta da rivellini e 11 tutto regolato in modo da supplire all'aagustla «Ielle rondelle e quindi alla deflcrnza di fuochi frontali e Aancheggianti, che si era manifestata anche nell'ul* timo assedio.
Davanti alla breccia del fronte dei Bavaresi, propone pure una strada coperta palizzata con andamento tale, da evitare I tiri d’infilata provenienti dalle posizioni deU'attacco. stabilitosi sulle alture di 8. «»cranio.
• r . M , V. 53. |«s. «OT
Il Marnili »i preoccupò poi nnn solo «li aumentare la rati- mi-ma «leseli orfan i prioripali della cinta al tiro del cannone, proponendo, a tale scopo, la costruitone di un parapetto di terra intorno alle rondelle, ma esige il ma*«in>o «viluppo dell'anione di fuoco da parte della difesa e perciò propone rinatallaalone di cannoni nelle rondelle »tc**e e la costruzione di appositi fianchi in ogni località adatta della cinta, per renderne più sicuro ed efficace il fiancheggiamento.
Per facilitare g li ereatuali spostamenti di cannoni della d ifesa e delle truppe addetteti, il Marmili propone la demolizione di numerosi caargglati della città posti nelle immediate vici- nanie della d a ta ; infine per assicurare le comunicazioni con II Danubio, dal quale la piatta può attendere soccorsi e trarre l'acqua per le esigente della popolazione e del presidio, il Marcili propone miglioramenti ed ampliamenti al Oantello basso in guisa da coprire anche l'arresao del ponte di collegamento con Pest.
L'importanza della Piazza ili Buda, In relazione al domi nlo da essa esercitato sul Ihinuhlo e sui paesi circostanti di frontiera, non sfuggi al Marsill che pertanto, non si lim itò a proporne il restauro, ma compilò anche un progetto nominarlo di riedificazione della piazza stessa allo scopo di renderla addirittura inespugnabile Malauguratamente però mancando nel carteggio lasciato dal Marsili, le tavole di dlnegno, che accom pugnavano ('anzidetto progetto, questo non può nutere not-i che nelle sue caratteristiche principali.
Nel riferire a Vienna Intorno al progetto medesimo. Il Mar- «IH premette alcune considerazioni sulle particolarità topografiche dei luogo, rilevandone I pregi e I d ifetti alfine di piegire poi l'arte e la «cienza ad accrescere, o almeno, a garantire l'utilità degli uni e ad attenuare o sopprimere gli altri. (Tosi la vantaggiosa situazione della piazza di Buda sul terrazzo, in wm mila di un colle, viene migliorata con la proposta di costruir« una strada coperta palizzata ai margini del terrazzo »lesso, in modo da sottrarre airattacrante ogni più piccolo spazio piano
I_ MABIXBUJ • L r. MAMIU UOMO 01 GCHUU 23
• r m v*t » . * «s r
ai pip»li delia cinta. Inoltre il favorevole andamento della «ponila destra del Danubio nelle immettiate vicinanze di Buda, permette U rifornimento dell'arqua, le comunicazioni coH'e«terno e l'arrivo di «occorsi; ma per assicurare tutto ciò il Marnili giudica necessario l'ampliamento del Castello basso e la costruzione di un’opera bastionata come copertura di probabili sbarchi e «Iella navigazione; la diversa p«>ndenza poi e la variata asperità delle falde, che delimitano il colle, concorrono a prestabilire i fronti «li più probabile attacco; ora il Marnili in considerazione appunto che sul lato di p«>nente della piazza si possono escludere operazioni di attacco con grandi forze, limita, «la questo lato, le difese esterne alla strada coperta con palizzate e piazze d 'armi, queste ultime, con compito sopratutto «li fiancheggiare la ripida ed aspra falda del colle e sopprimerne rosi gli angoli morti.
In corrispondenza della falda a sud del colle, le coalizioni «lei terreno favoriscono la minaccia di un atta«rco, che è resa piò grave dalla esUteuza di alture, ai piedi del monte 8. Gerardo, «a lle quali le batterie del nemico risaltavano, come le definisce il Mar-sili, orizzontali ossia con angolo «li «ito nullo, rispetto al bersagli^ costituito dalla cinta murata: In altri termini risultavano, in quel tnopo, nelle migliori condizioni per eseguire il tiro efficace di breccia. Anche «ni fronte a tramontana, la minaccia di un attacco in forae. favorita dal terreno pianeggiante e privo di ostacoli, e quindi «favorevole alla di- frsa, suggerisce al Mandli di applicare la massima, «la lui definita imfmllibUr. di mettere cioè la piazza in stato che possa avere fronti di fuoco più rstrsi di quelli del nemico. Propone per tanto di costruire rosi sul fronte nord, come sn quello «ud bastioni aU'esterno della cinta e, dove il terreno lo permetta, di intercalare fra essi dei rivellini colla funzione anche di rapo niere per I forni del bastioni e di fiancheggiamen to pel terreno circostante. 8ul dinanzi di queste opere esterne, il Marmili propone altre«! di «viluppare una strada coperta con piasse d'armi, palizzate e spalto. In collegamento col tratti contigui, proposti per g li a ltri fronti, onde costituir* cosi un secondo completo recinto difensivo intorno alla piazza.
24 M RM ORIK INTORNO A L. F. M ARM ILI
I. MARtKKLl.1 - L. r . t l iU lU UOMO DI GUERRA .»fi
La natura del terreno nelle immediate vicinante del eolie di Huda «i presentava favorevole ai lavori di mina ; in comdde ratinile di riò il Marsili pro|K>ne rimpianto di un «interna organico di contromine, costituito. o da una galleria posta »otto e p rm u il piede della muraglia, dove non ai aveva eccessiva angustia di «patio, oppure da appositi potti nel rimanenti tratti del recinto: inoltre «otto lo «(Mito della ulrada coperta ed in corriapondenta dei salienti, propone altre gallerie con predisposti imbocchi per i rami d'attacco da coatruire durante10 sviluppo della gnerra sotterranea, o anche per illstruKgere eventuali lavori deU’assedianle.
A lla fonatone di ridotto della difesa, attribuita al ('astello,11 Maraili aggiunge a questo anche la facoltà di tenere in sog gettone g li abitanti della piatxa, e pertanto propone di «epa rare il ('aatello stesso dall'abitato, costruendo, da quella parte, apposito fosso o tagliata preceduta da una spianata di forma ed estensione tale, da permettere al cannone fattone di indiare le strade maestre della città.
I l Marnili accenna pure al provvedimento, ap|Mrentiinente semplice e ritenuto da taluni di grande efficacia, per garantire nna prolungata difesa di Buda, consistente nella deviatione delle acque del l>anubio da tramontana ed intorno al rolle, in modo da ridurre questo ad isola nel (lume stesso. Pur non escludendo la possibilità di un tale provvedimento, il Marsili si riserva di eseguire apposite livellationi del terreno per de terminare l'entità «lei lavori di scavo da reg«dar*i con criteri molteplici e «lei quali sarà necessario tenerne «trotto conto per evitare che nel futuro l'axione corrosiva «Iella corrente del
nuovo canale, possa provocare la frana di parte delle faide del colle, di coi ai tratta, e quindi compromettere la stabilità del terraxjui sa cui sorge la piatta.
Per assicurare le comunicazioni di essa colla spomla opposta del Danobto, il Marsili propone di spostare il ponte di barche esistente fra Bada e Pe*t dislocandolo in corrlspon denta dell’opera bastionata, di cui è ceono innanti, per avere la possibilità di tenere l'abitato di Pesi sotto la minaccia del
cannone dell’opera bastionata e quindi impedire al nemico di trovare ricovero e riparo nell’abitato suddetto.
Il Marnili nel chiudere il suo progetto di riedificazione della piazza di Buda, dopo aver designato le località convenienti per sistemare le caserme, i laboratori, le armerie, le polveriere e altri magazzini, aggiunge talune considerazioni dirette a convincere l’autorità superiore d i Vienna che la fortezza di Buda, coni notevolmente ampliata colla attuazione delie proponte in esame richiederà, in conseguenza della maggiore efficacia dovuta ai nuovi mezzi di difesa, un presidio numerica- mente inferiore a quello occorso in passato, pur offrendo sicura garanzia di tenace resistenza contro qualunque assedio.
26 M EMORIE INTORNO A L . T . M A R S IL I
L ’opera del Marsili, in tutte le vicende, che riguardano la piazza di Buda, è semplicemente m eravig lio «. Le pagine che precedono, dimostrano, a ll’evidenza come Kgli, ispirato ai più a lti concetti, senza vincoli di scuole dell'arte o«aidlonale appli cala con I mezzi di offesa e di difesa del suo tempo, fu veramente II precursore di quelle m axim e basate sul largo impiego di fuochi, massime, che del resto, potevano assicurare la vittoria, cosi nei procedimenti dell'attacco come in quelli della
difesa.D ifatti nella compilaaloue dei progetti è degna di nota la
precisione nel definire, non solo gli elementi «Ielle singole opere, ma ancbe il calcolo del l’arma mento, del presidio, delle mae stranie, dei materiali, della spesa e del tempo occorrenti nella pratica delle operazioni: ••mcrgr altresi l'oculatezza e la spedi- len a del Marsili neU'atlrstlmento e nello Impiego dei mezzi 1 più acconci alle circostanze di luogo e di tempo, tanto nella guerra rampale, quanto In quella omidionale. Per la riedificazione della fortezza, infine si preoccupa, con giusta ragione, del fatto eromunico nei riguardi della forza presidiarla e ne d imostra la possibilità di raggiungere lo scopo eoU'adozione dei nuovi elementi difensivi in rapporto a quelli offensivi in via di progresso.
U M A R IN E LL I • U r . M A R N IL I UOMO DI GUERRA 27
Difena de lle piati«* di S trlgon ia *• d i V leegrado e aaaodlo
de lla p ian a di Neahauaael.
Nell'anno Ifitó dalla primavera aH’autunno, II Marnili fu impegnato nei lavori di difena prr naivaguardare le placa«* «li Oran o tttrigonia e di Vkegrado, amlteduc nulla «lenirà del Danubio a noni di Buda 1 e ancora nelle operacioni di attacco l»«*r mecco «li anaedio, contro la città di Xeubaunnel, ponta nul Xitra, affluente dello « I (m o Danubio.
In quellanno I Turchi vagheggiando l'idea di riconquintare le prime due p iane atale tolte loro dagli Imperiali n«*l 151)5, urgeva metterle in atato di di/ena e i lavori |>er la biitogna, furono affiliati al Marnili, il quale recato*! nul luogo e «lopo aver pmxi vlaione dello «tato «Iella placca, ne rifcriiw-e at Duca d i I ai rena, aggiungendo nella relacione informativa anche le prò ponte d i ’ Kgll ritiene attuare |»t ridonare alla placca il pri- «tino nuo atato.
I l brano di tale relacione che riguardn lenito della vlnitn fatta dal Marnili è coni concepita2: «...g iu n to a Oran con «qu e lli requiniti che dalla carica di V. H. I. mi furono Mommi « nintrati, ntudiai m i ! luogo, ma a causa della Magione e per «m o lte altre ragioni trovo in atato poco buono, di maniera Ito «creduto meglio fare le nejjuenti dÌ*po*icioni e domani venire « alla esecucione di tutto che lancio nelle mani di quento ner « gente maggiore aotto il quale pongo due intraprenaorl o pie « culi ingegneri acciò «lenirò il me«r di maggio «da enrguiio « quanto ho diaponto ».
Premettiamo che la placca di Htrigonia è contituita «la una parte alta e da una parte ba**a, naturalmente protetta dal Danubio, aperte verno ponente, in virtù della «pedale mia ubi- caaione. Ix* f or tifi cacumi che raiatevano In quel tempo, ridotte ■«rondo il Marnili in cattive condicioni di connervaclone, erano formale da una cinta murale munita di rondelle attorno alla
• H«rt«MUa * poma la n 'a M colla roncatili. mutila («oaoarlata. ri Tot la a rad. q«nnl alla m rta n u a «M F l o w Orna. Vlerarado * [**1* a rad 41 Ktrlanaia w tk 'tHunn- 41 Roda,
i r m T o l « * . r « C 7
città R i t a t da una Hccomla cinta, attorno alla città Inuma organizzata con fronti bastionati prorviati di opere addizionali.di fosso •• di altri particolari inerenti al »¡«tema difensivo adottato.
Nella itua relazione informativa, adunque, il Marnili rife rliu-e che la rovina di quelle vecchie fortificazioni ai è iiiagKior- mcnte accentuala nel muri di »ost«*gtio delle «carpe, nelle strade co|«erte. nelle palizzate e*l in genere nelle M-arpc in terra, nel materiali di rividi intento ecc., fa poi seguire renumeraiione dei lavori per le riparazioni occorrenti, unendovi un profilo, munito di leggenda, con la quale ni richiamano, ad uno ad uno gli elementi della fortificazione, indicati: con linee «egnate in roMw>. gli esistenti e con linee Degnate in nero I nuovi ag giunti e quelli rime**! in pristino »tato.
Siccome nel carteggio consultato. un «im ile profilo è «egnato in matita, c’è <la ritenere che quello disegnato con linee a colori diversi, sia »tato Invialo al Duca di I<orrna inaiente colla anzidetta relazione.
l ’omnnqne. «tal profilo in matita ai è potuto egualmente r ilevare la c«inee*lonc dlfenaiva «Iella piasza in «*»amc. mrondoI criteri «lei Marnili, tapiniti alla necessità «il proposte da po tersi attuare con tutta sollerltudine. K*»e consiaiono princi- talmente: « i nel riattamento delle mora piantate mi! monte, che recingono la città a lla ; nell’agginnta di un cammino ili ron«la al ptale «Iella scarpata «tei monte, protetto da un maro di wwtegno. che *1 prolunga Ano al fosso; cl nel ripristino del fosao colla aggiunta di caponiere per la sua dfesa diretta e ancora «lei muro «Il rivestimento della rontro acarpa in luogo «Iella palizzata; <f) nella »internazione del rampar» «im prendente: il parapetto, la *ua scarpa interna, la banchina per II
ralorl. il pendio «lei parapetto e la scarpa esterna del rampato : e) nella »traila coperta e nello spalto con particolare per fucileria.
Tale profilo rispomle pienamente alle vigenze di quel tempo nei riguardi della difesa, in quanto la fortificazione, cosi concepita |>ern>elteva l'impiego di due distinte linee di fuoco, di cui: l'una. sulla banchina del rampato che poteva organizzanti
t& MEMORIE INTORNO A L. f . MARMILI
U MABISEIXI - I . r. M ABBILI COMO DI CI'KBBA 29
tanto per artiglieria, quanto per furiieria e l'a ltra per fucileria, eacl usi va mente, «alla strada roperta dietro la acarpa Interna dello «paltò.
Per Virejcrado, il Marnili giusta la «uà relacione, informa di aver dato disposiiioni preclsr al l'omandaute di quella piazza intorno ai lavori «la eseguire. con ordine tassativo «Il attendervi direttamente Uno al loro rompimento.
Circa alla quantità e la qualità delle bocche «la fuoco per il fabbisogno delle due piane, informa altre»! che nono aulii cienti quelle che vi ai trovano; ma però richiedono prr>ntl ri«ar cimenti per ottenere da esse il ma »«im o rendimento.
Nei riguardi degli «frumenti da minatore e guastatore, oc «Torrenti II Marnili «crive: « «ni punto di partire da Vienna tro- « vai uno Hmit che «i esibì a trovare per la fabbrica e man « lenimento de li instromenti per le fortificazioni e massima « abbi a compiere la rocca e trovandolo di qualche abilità, gli « assegnai 12 talleri al m ne come ne avviso II commissariato « e a Kaab g li c<«nprai ogni n<>cewaari<> ordigno per qualalasi < travaglio di ferro di mo«!o che a Vicngrado (intanto che il « travaglio durerà, r i farà l'officina di fabbro che poi «i farà « trasportare a llran ricevendo per l ’uso di questa, buona quan- « tità di carbone » .
• • •
Per le operazioni d ’assedio contro la p ia « « di Neuhaus- sel 1 la difficoltà maggiore che al presentò agli a«ae«liati dopo eseguiti I preliminari dell'investimento, fu il forte ostacolo «lei fosso che impedi loro, in nn primo tempo, la discesa nei me desini» onde iniziare I lavori delle gallerie per l’ulteriore procedimento. Hi cercò, innanzi tatto, di far passare una barca carica di minatori col favore «Iella notte in maniera che questi potessero, al coperto, porsi al lavoro avanzando col loro fornelli, ma l ’espediente non riuaci. poiché la barra con II presidio fu respinta «lai colpi di pietra provenienti dalla «ommità del maro; il fatto però rbe la caduta del pietrame nel fosso ne
■ r. m Voi sai e *47« a
HO MEMORIE INTORNO A L. F. M ABB ILI
agevolava il riempimento, co«) fu stabilito di concorrervi ancora col gettamento di fascine e di «acchi d'arena in gui»a da |M>tcr stabilire il fondamento «olido per l'esecuzione delle due gallerie, »«aia pa«saggi coperti e protetti, progettati insieme con l'impianto di una batteria per cinque gro««i cannoni, onde hat tere in breccia le facce delle opere Investite.
Per* que*to lavoro che « ’ incominciò felicemente, fu disturbato dai difensori che cercarono di appiccare il fuoco alle gallerie medesime, già iniziate, servendosi a ll’uopo di materie cotn bu«tlbili che accendevano col lancio di frecce intinte nel hi lume. A tale inconveniente «i pose rimedio coprendo le gallerie con terra e ponendovi a guardia alcuni uomini con ordine di dare avviso tempestivo di ogni altro principio d’incendio a ffine di concorrere, per tempo, all'eatinxione per m eno di acqua con«ervata in apposite botti convenientemente dislocate.
Frattanto che le cotte procedevano in tal aenso. i Turchi operarono una sortila per la porta detta di Vienna che non fu difesa dalle fanterie di Hvevia, le quali ne avevano avuto l'incarico, scusando la loro condotta colle condizioni delle trincee, le quali eaaendo troppo profonde, non avevano loro permesso di far fuoco contro il nemico U quale riuscì a penetrarvi e a passare a RI di «pada quelli che non ebbero il tempo di fuggire.
CIÒ nonostante il Duca di Lorena decise di assicurare quel punto con maggior forza, onde impedire ulteriori aortite in modo a molato e. in pari tempo, per ostare a qualsiasi colpo di mano da parte del Turchi medesimi. Po perciò risoluto di trar partito dal rilievo del terreno per erigervi un forte capace di mille uomini con armamento di cannoni: il tatto per operare una valida difesa sia contro la piazza, «ia attraverso alla campagna adiacente.
I l Marsili che ebbe l’ incarico di eseguire tale ordine, cosi si esprime nella sua relazione : „ * K per questo l’ho fatto della « necessaria grandezza e cinto di forte palizzata. Contro que « «to lavoro il nemico fece uno a fono col moschetto e col can « none, ma dopo due giorni d’azione riconobbe l’imporaibilità « di aver ragione di quel presidio e ritirò l'artiglieria che r i « era stata impegnata. Hi trovò necessario per abbreviare le
L l l t l lM U I • U r. M U IIU POMO DI OPUUU 81
« operazioni d'attacco di tentare l'incendio del ponte 1 II che « « I f«*ce col favore dell* noli«* mediante fuochi d'artiflzlo con « paglia po«ta sul ponte, per il cbè. Il nemico rinuniiò alle « aortite barricando la porta steasa... » . *
K en ila n o frattanto i lavori delle gallerie, «ebbene re«i difficili dal fuoco del dlfenaori, finché aperte le (treccie dalla artiglieria nei muri di acarpa, fu punibile al generale Hilvio Enea Oaprara di dare l'as«alto alla fortezza e conquistarla.
Il Mandi! che prese parte pur es*o alla vivissima lo lla alla teata del granatieri, fu colpito da una pietra «ulta faccia con tale tri»leni* da doventi ritirare nella «un tenda, appena tra ilo dal fosso, ov'er* precipitato.
L'ertto vittorioso di tale assedio e ancora della liberatone di Htrigoula «I deve in gran parte al Marwill, il quale con la roosueta «uà a t t iv ili e periti*, rituel, come *i è visto, in un tempo relativamente breve a mettere gl'im periali in condizioni di aver ragione «ni Turchi in ambedue le operazioni di guerra svolte«! rispettivamente nelle piarne, di cut trattasi.
Anche neU'adempimento degli incarichi a lui affidali nelle auaccennate circostanze, il Marnili pose speciale cura non solo nel concretare i provvedimenti di carattere generale, ma pn* ciaò altresì I più minuti particolari relativi ai lavori oasidio nali ed a ll’apprestamrnto delle artiglierie, elementi questi che ebbero senza dubbio la loro valida influenza cosi nella spedi teua. come nel buon «sito di ogni adone di guerra.
Operazioni 41 assedio e di d ifesa di Belgrado.
Fin dal 168# il Marnili, approfittando dell'udienza che gli venne accordata dal Pontefice Innocenzo X I. dal quale si era recato in missione per chiedere sussidi, onde proseguire la guerra da parte delle armi cristiane, ebbe l'opportunità di presentargli un piano dimostrativo intorno all'assedio di Bel grado che Egli aveva preparato in tutti i suol particolari, fa-
• IH IWMMK?.. aUa pana sa ricontala «v it * di v irus** r . M . reta*, TaL M. e a »
M EMORIE INTORNO A L. V. M ARM ILI
crollagli rilevare, in pari tempo con evidente convinzione, il buon esito dell'impresa qualora questa veni «ne realizzata.
Ottenuto il cospicuo sussidio di centomila Hcudi, fu determinato iient’altro di porre in atto l'ardito progetto coll’inviare colà renereito Cesareo agli ortiini del Duca di Baviera il quale, dopo le Hollecite operazioni preliminari del catto fu in grado di attaccare la piazza di viva forza e di penetrarvi passando a HI di *pada la guarnigione ivi rinchiuda.
• • •
In seguito, premendo a Cesare di conservare Belgrado in condizioni di difetta tali, da poter far fronte a qualsiasi ritorno offensivo da parte del Turchi, fu dato Incarico al Marnili di restaurar«* e rafforzare le opere Ivi esistenti e aggiungerne delle altre col One «tl rendere quella piazza capace di resistere ad un lungo assedio e contro armate p«xlerose.
La fortezza di Belgrado (schizzo n. 4)* situata su di una collina compresa, fra la sponda destra del Danubio e quella pure destra della Ha va nel tratto In «mi questa sfocia in quello, era costituita, nel I6SV, di un castello a tracciato rettangolare allungato con ridotto Interno e di una cinta murata di protezione nella città bassa, la quale, essendo posta alla gola del castello e presso la sponda «lei fiume, che In quel tratto accerchia per t ir lati la rolltna. costringeva l’attaccante a svolgere 1 suoi lavori d’assedio contro il quarto lato, dove appunto detta cinta era protetta, a sua volta, «la un profondo fosso asciutto. Ter un migliore apprestamento a difesa di Belgrado, Il Marnili compilò tre distinte proposte disegnando per ciascuna di esse una precisa e chiara planimetria «Iella proget tata forteaxa.
DI tali proposte: due, considerano l’abbandono e quindi la
demolizione delle opere rimaste: la terza Invece, ispirata a criteri «•ssenzlalmeote economici e di piò sollecita attuazione, ne comprende la conservazione con l’aggiunta di elementi per un
• P Voi ft. a l
congruo rafforzamento insieme coll’ ampliamento di alcune torri e la sistemazione di opere aderenti disposte, per la maggior parte, «ni previsto fronte principale d’attacco.
Più particolarmente il Marsili propose d’inserire nella cinta murata sulla città bassa (schizzo 5>1 tre torri piatte T a tracciato pentagonale; di trasformare in mezzi bastioni B le due torri d'angolo del fronte principale del castello A, che diventa cosi bastionato a lunga cortina; di costruirvi in capitale un rivellino C, coperto sul dinanzi da una vasta opera a corno D, con rivellino E ; di aggiungere sui fianchi della fortezza le controguardie e ancora più indietro due rivellini K Intagliati nelle falde della collina; i fossi, inoltre, di queste opere sono proposti asciutti con strade coperte spalto e relative piazze d 'arm i; in fine ai piedi dello spalto dell'opera a corno, pone tre fortini a dente H con fosso asciutto.
Delle altre due proposte, quella che II Marsili chiama c prima maniera di fortificare realmente B elgrado» comprende: un forte o cittadella in luogo del castello a pianta pressoché quadrata con fronte bastionato su ciascun lato munito, a sua volta, di rivellino, fosso asciutto, strada coperta e spalto, soltanto però in corrispondenza al fronte rivolto al supposto at- tacro principale; un'opera a corona con quattro fronti di cui: uno. in capitale della cittadella, un altro sulla destra di questo, verso la Ss va e g li altri due sulla sinistra, ripiegati verso il Danubio. Detta opera si svolge ai piedi del suindicato spalto e si appoggia : da un lato, al meno bastione del fronte estremo di destra, alla sponda della «a v a ; e dall'altra, si collega, sulla sponda del Danubio, alla cinta della città bassa.
Qnesta cinta di semplici mura, a tracciato poligonale con cortine a ripiegamenti in forma di torri piatte, segue l ’andamento della sponda del fiume e si collega, dalla parte della Sava, al m eno bastione del fronte esterno destro dell'opera a corona. A ll ’esterno di essa poi e sulla capitale della cittadella e cioè, sul terreno di più probabile attacco, il Marsili propone due opere a corno, con rivellino, l'una davanti a ll’altra, in modo
84 MEM ORIE INTORNO i L F . M A R S IL I
* r. M . Voi H. B 5,
«la presentare i rispettivi fianchi In direaione parallela alla capitalo della piazza munendole, altresì, di fossi asciutti alla •tettila guisa di quelli appartenenti al fronte bastionato dell 'a t t ic a opera a corona.
Tutti g li altri fossi della fortezza sono invece, acquei, compreso un controfosso progettato al piede dello spalto che circonda per intero la fortezza medesima; completano il sistema difensivo tre fortini a dente con fosso asciutto, proposti ai piedi dello spalto dell’opera a corno.
Per il mantenimento delle comunicazioni fra la piazza e le località circostanti, il Marsili propone passaggi cosi sul Danubio, come sulla Sava e fra gli isolotti, mediante ponti su barche con relative teste di ponte organizzate con opere a corno.
Intlne per il servizio del presidio di difesa era stato previsto: un magazzino a polvere, una fonderia per cannoni, un arsenale, nonché quartieri per cavalleria e caserme per fanteria.
• * *
U seconda proposta relativa alla fortezza di Belgrado, com prende: la cittadella con rivellino, come nella prima maniera, contraila egualmente sui fronti posti lungo i fianchi della collina, dne coprifacda del bastioni del fronte principale e la sistemazione di opere a dente circondate e collegato con fosso acqueo, preceduto dalla strada coperta dallo spalto e dal con trofomo acque«. Per la difesa sulla cresta della collina concorrono, oltre il fronte principale della cittadella, anche «peciali roprifacce del rivellino, un'opera a corona con due fronti e relativi rivellini e il bastione centrale dell'opera risultante sulla capitale della fortezaa. C o m p le ta n o f| sistema difensivo, i funsi, la strada coperta, lo spalto e tre fortin i a dente con fonato, ai piedi dello spalto dell'opera a corona.
Ita quanto si è e«posto intorno alle tre maniere di fortificare Belgrado, risulta evidente che il Marsili si conserva fedele al fronte bastionato italiano, in quanto Egli propone tale elemento con i Banchi perpendicolari alla cortina e protetti dai relativi orecchioni.
36 MRMoRIE INTORNO A L. P. MARSILI
L MAIIKKU.I • L. r. MJUMIU l umi RI OUHUU 87
Hi preoccupa inoltre di ballere il tirreno d 'itU rra con fuochi incrociali e a u l uopo propone, con giunta ronslderatlone, tracciati di opere a corno ed a corona.
• • •
Belgrado. r im rtu in pristine condizioni fu nel 1 fiS*0 a »»e diata dai Torchi, ma con poca speranca di conquistarla, in vlrtò delle fortlficamionl di m i era ninnila e ancora del nnm< roso presidio che ri era alato dinlocato per la relativa difesa Ad on dato momento però, non + detto In che modo, manife alatosi l'Incendio nella torre del castello. Incendio che a inano n mani» andò propagando»! a lutti I msgaulnl, compreso quello della polvere, dette Modo ai Torchi di approfittarne per pene trarr nella p iana e Infondere noovo terrore agli assediami, alenai dei qoali. •oltanto. poterono scampare dal pericolo ira ghettando, per om« < i di barche ralla sponda opposta de) Da nnbio
In segnilo a tale sria (rara, pensando che i Turchi, rinforzati da noove troppe, potessero tentare l’invasione della Transil vania. fn incaricato il Marnili di riconoscere il luogo ove essi si erano accampati per vedere se vi era la pnaalbilitA di aitar carli con la cavalleria e costringerli ad allontanarsi.
Il Marnili presi g li appunti necessari, con la consueta sua avveduteti« e, ahbouato «u caria il piano della situazione <11 quelle troppe, corse immediatamente dal «uo Principe per riferir gli intorno alla posniblliiA. am i alla convenlenu di procedere ad on'axlooe offensiva pronta ed energica, sen i« correre alcon rischio.
Accettata la proposta, il Principe affidò al Marnili medesimo l'incarico di porre in alto l ’impresa, dandogli per la bisogna il romando di on numeroso riparto di scelta cavalleria : i Torchi però subodorato la monna degli avversari, sloggiarono ironie dlatamente dal campo, pannarono II fiume Alauta seni« distruggere Il ponte dopo, e a marrie fo n a le si misero in nalvo lanciando lungo la strada i contnuwrgni evidenti della fuga.
Il Marnili prooegnendo lottarla l'innegulmenlo potè raggiungere pienamente lo scopo propostosi e liberare, in lai guisa, la
MEMORIE INTORNO A L. K. MAHHIl.I
Transil vania «la una minaccia d'invasione che poteva mettere g li Imperiali in gravi imbarazzi.
Una Mimile vittoria però, non poteva dare serie garanzie per l ’avvenire, in quutito i Turchi non avrebbero rinunciato a mettere in atto i ritorni offensivi, non appena fosse stato possi- bile, approfittando delle condizioni del terreno a loro favorevoli e anche del momento in cui g li avv«*r*ari non fossero stati in forze sufficienti per evitarli. Kra quindi necessario provvedere colla ricognizione, innanzi tutto, delle località che avrebbero potuto favorire le truppe ottomane per ritentare la non facile impresa e poi concretare il da farsi per porre g li ostacoli del caso sulle probabili direttrici di marcia, che sarebbero state scelte per procedere alla manovra controffensiva.
I l Maritili, al quale non era sfuggita la possibilità di tale manovra, dopo un'accurata ricognizione dei luoghi, fu in grado di rinvenire fra le ¡daghe di «juel ternano, transiti che potevano essere utilizzati senza alcun pericolo di sorprese. Immediatamente il Marsili propose di proce«]ere a lavori speditivi, ma nello stesso tempo efficaci, consistenti essenzialmente in tagliate, «Mtsia profonde e larghe interruzioni in tutti i transiti bene individuati, inasprite anche con difese accessorie abbai tnte, buche da lupo ecc.
Simile espediente, di carattere essenzialmente provvisorio, non poteva però impedire, in modo definitivo, ni Torchi la ri- presa della loro offensiva; dette tottavia tempo agli imperiali di ritardare l'avanzata, con notevole perdita di tempo, a cagione specialmente degli ostacoli menni io opera dal Marnili stesso, sui transiti di obbligato passaggio.
Supraggionto l'inverno, furono troncate le ostilità e intavolate a Vienna le trattative di pare fra le doe potenze belligeranti.
D ifesa 41 Sem eadrla d i Siasa e assedio 41 Vidino.
Nella primavera del I6$9 il Principe di Baden. desideroso di porre in istato di assedio la piazza di Semendria 1 abbando nata dai Torchi ancor prima dell'assedio di Belgrado, ordinava
• Salta im a t a • • o m ir del iHiaobio 145 Ka> da Brljcrsdo).
U MARlXBI.l-1 - U r. MASIIILI UOMO l>l (ir EH IH 39
•I Marnili «li preparar* il relativo progetto comprendente, non aolo, i lavori attorno alla pianta, ma anche gli «U ri Inerrati alla «istrauuione «li no transito nella aelva «Iella Morava, posta a «od di Relgrad«), nonché di un ponte «a questo Utraao II urne.
I l progetto allestito dal Mandi! e presentato al Principe Luigi, fu «la queato pienamente approvato eoa ordine, in pari tempo, «Il por mano ai lavori proponi!1 Mirrarne urgeva l'aa aetto definitivo della plana, il Marnili informò 1« «uè propoafe alla raatrnxiooe di opere a carattere speditivo, per lo più in terra, curando di rafforlare quelle esistenti rollo »rapo di ottenere la « ira rena degli aborrili t la totale protexlone «Ielle arti glierie installate ani rampar! t angli «patti.
Contemporaneamente all'earroilonc di detti lavori, il Mar- aili attrae a ltre«! al diaboaramento della selva per una estensione di rirra 10 Km. in modo da ricavare un transito «ufficiente, anrbe per il ra ireggio e alla sistematone di ponti roal sulla Morava, rame so altri corsi d'acqua verso Jagodina *.
Mirabile fu il lavoro del Marsili io questa impresa per le gravi difficoltà che dovette sormontare, dovute, più specialmente, alla ricerca di materiali di cirraatanu sul quali, aoltanto potè fare assegnamento per la bisogna.
D ifatti clopo aver requisito su quei luoghi paludosi delle piccole barche e delle zattere, riuscì a mettrre inaiptne con queste, corpi di sostegno suffirientemente robusti i quali, collegati iniseme con fusti e travi, ricuperati dal taglio della selva, forn irono ottim i passaggi per il transito di cannoni e di materiali, coal attraverso alla Morava, come so altri corsi d'acqua minori.
Dato la grande importanza del passaggio principale, il Mar aili non trascurò di munirlo di teste di ponte, con tracciato a semicerchio e a profilo per aola fucileria.
• r M , Val. .Vi. r. «m (M te rs lo data 34 laallo Mao>. la <|w«ta M irra U l ’ rmc.j«' U ig l «n tla t. ira «lu u , al MarsIU « di riaiab re qaatrbe «torno a Knaaadrla per an-odtr» tanto uva lio al lavort * aorta« per rlw a a w w oaa looallU «warvaicat* «olla Morara per fecu rv l tu> p o « t r . ».
* Rltaaia a K Km da «M araM a mita rtva stabrtra M ía Morara.
40 MEMORIE INTORNO A L. V. MARMILI
Il Principe Luigi di Haden, apprezzando tutti i lavori di fortificazione in corso a Semendria e altrove, se ne compiacque col Marnili e lo lodò per mezzo di una sua lettera 1 »criItagli da Hemendria medesima, in data li luglio 1G89.
Premendo allo Menno Princijie di spingersi verno le alture di Km o! onde fronteggiare i Turchi, che avanzavano da quella parte, varcò il flume con le nue truppe attraverso 11 ponte I (schizzo 0) 3 sulla Morava, ma a cagione delle piogge soprag giunte renosi difficile il tras|K>rto dei viveri e, |>eggio ancora, manifentatasi la diserzione nel campo, furono contretti i Cenare! a soprassedere, però in condizioni comI «vantaggiose da poter ensere attaccati, con ogni probabilità, di fronte e anche alle spalle.
Tale pericolo era reso ancora più evidente dal fatto, che i Turchi, attraversando la Morava sopra il ponte, che rapidamente costruirono presso Jagodina, si trovarono, in un dato momento, di fronte alle truppe Cenaree.
In tale frangente non c'era che un mezzo solo di salvezza, raggiungere cioè la piazza di Semendria. Occorreva per questo11 gittamento di un nuovo ponte ( I I I ) «o lla Morava stenna che il Marnili allenti prontamente con materiale d'equipaggio munendone l ' imbocco con una robusta tenta di ponte a profilo per artiglieria.
La fanteria trinceratasi dietro tale fortificazione renpinse in un primo tempo, i Tartari che assalirono le troppe di retroguardia. e in un secondo tempo, entrata in azione anche la cavalleria. che ebbe il destro di coadiuvare i fanti nell'inaegol
mento, le troppe ottomane furono prese di fiaoco e obbligate a ritirarsi precipitosamente, lanciando nella foga ricchissimo
bottino.• • •
• r. M„ V. W. e. 411* Mrukiris tataro« «I pracrttu dell* Unen dei m i * Emo. F. U ,
VoL M. C. 502.* I r » — « 1 «w n lil ralla Morava e sai ItsaaMo s a » ladira il scilo
««-fatato roa ooaterl rimami dall' 1 si IV.
42 MEMORIE INTORNO lRAILI
In seguito alla vittoria riportata a Jagodina, venne di nuovo in rampo l'occupazione di Monte Kmo e per tanto fu dato l'incarico al Maritili di esplorare il campo turco che ai era dislocato preso*« Ni ssa1 in una posizione molto favorevole, in quanto le condizioni del terreno circoHtante ne salvaguardavano la fronte e i fianchi; hì trattava quindi di riconoscere se g li elementi di copertura ne assicuravano anche le s|uille; il M im ili dopo un'accurata esplorazione, molto contrastata, riuscì a verificare, con la consueta sua abilità, che le spalle degli avversari erano scoperte e anche esposte in una vasta pianura.
Senza (torre tempo in mezzo, gli Imperiali si posero in marcia verso quella località, ove giunti, poterono, con abile manovra, piombare improvvisamente sul rampo del nemico e ivi attaccarlo alle spalle come era stato previsto. Tale successo, per la verità, si deve in gran parto al Marxili che vi contribuì in modo speciale, sia conte ardito ed audace esploratore, sia come comandante d i truppe nello svolgimento dell’azione.
Il Pricipe Luigi assicuratosi cosi la linea del monte Emo e posta a difesa la piazza di Xissa, mosse colle sue truppe su V id io o 1 ove i Turchi si erano ritirati e trincerati presso l'a ttiguo rampo santo, dietro la cinta esterna trasformata in copertura difensiva. Investiti però improvvisamente dalla cavalleria tedesca sulla sinistra e caricati sulla destra dalla fanteria, g l’ imperiali riuscirono a penetrare nel campo e a porre in fuga gli assediati.
Occorreva in seguito a questo nuovo successo, occupare Vi- dino e per raggiungere l'intento era necessario cingerla d'assedio: il Mandli che ne ebbe l'incarico, pose subito mano ai lavori di trincea, che in breve tempo condusse tino al fosso delle opere avanzate, ma non disponendo poi di grossi cannoni per l'apertura delle brecce nei muri di scarpa e, mancando anche 1 minatori per praticare i passaggi sotterranei, ri fu un momento di trepidanza che preoccupò lo stesso Tesare; volle però fortuna che i Turchi,
> Hitoata a n r i « i d « t di Se— «tris s 1 « Kb 41 dwanas »olla M «m i la. aBoeotr della Morava.
* Itinerario di marcia F M . V o i 36. a. »
U M AKI.N Zl.I.I - L. r. M A M IL I DOMO DI Ct'KIMU 43
fonie non in grailo «li »ostenere quel nuovo assetilo, capitolarono ■enea colpo ferire.
Occupala la fortezza il Marnili ai po«e «ubilo all'opera per rimetterla nel ano pieno assetto difensivo l .
Frattanto nei primi tarai del I6U0 | Turchi ripresero l'o ffensiva e dopo aver» «confitto a NUaa un distaccamento di cin«|ue reggimenti Ceaarri. a'iacaniminarono verao r t ’ nghoria e la Trans ita n t i, coll'intento di ritogliere a «'eaare le piazae occupate dalle «uè fon *.
Mirrarne in quel tempo. queste fonte avevano «ubilo una sensibile diminuzione. eoa) il Principe di fladen, in seguito al Consiglio di guerra, «lerlae di abbandonare le piazze «Iella Tran silvania e restringere tutte le difese in Belgrado. Quando però fu ordinato al deaerale Veterani, che presidiava NI «sa di abbandonarla. qoeati «i avvalae del Mandli perché a Vienna r«po ne«uM> le ragioni che militavano a mantenere, anzi che cedere tale piata«.
Il Mandli con i piani della località alla mano, correttati delle fortificazioni alatevi erette e dimostrando quindi la necessità di non abbandonarla, rinarl nel suo intento e X i«*a fu eonnerrata; recatosi poacia colà pose termine a tutti i lavori di difesa in antecedenza concretati, facilitando altresì gli accessi alla piazza col sistemare passaggi sulla Morava e col riattare alcune strade per la viabilità dei pedoni e del carreggio. Tutto quindi era disposto per resistere convenientemente all'assedio posto dalle truppe Ottomane, senonché al momento in cui bisognava disporre di rinforsi e di mezzi pecuniari, in quantoi Turchi incalzavano verso Stasa e la Tranailvanla correva serio pericolo, tutto ciò indusse il Con«iglio di guerra a pren dere nuove misure consistenti nel portare tutte le forte in quella Provincia e accrescere la guarnigione di Belgra«lo. Il Marnili che era al corrente degli avvenimenti, cosi poco rassicuranti di quel tempo, ai portò immeditatamente a Hemen dria per verificare le condizioni di sicurezza di quella piazza, onde poter fare assegnamento sopra una base di protezione
* r. il . Voi 87 t SIS
44 MEMORIE INTORNO A L. Y. MARMILI
e ili rJforninu*nto e, In pari tcnijMj, per gettare un nuovo ponte sul Danubio ( IV ) (schizzo 6) onde facilitare il passaggio di tutto il preiddio col carreggio al line d i occupare, in seguito,il forte di Carlo nell’ isola omonima poco a sud di Orsova. ripristinato a difetta per contraltare l'avanzata dei Turchi nella Tranidlvania Ungarica.
Il sistema difensivo concretato dal Mandli consiste nel miglioramento delle fortificazioni nei due isolotti A e B (schizzo 7 )* coll' aggiunta di batterie d 'artig lieria per incrociare i fuochi sul naviglio nemico, con probabile provenienza da levante; nella sistemazione di una batteria C sulla sponda sinistra del Danubio per proteggere il ponte P, che mette in comunicazione l ' isolotto grande a valle, con questa stessa sponda e ancora, per coadiuvar«' le artiglierie «legli isolotti per lo stesso scopo; concorrono infine, per completare il sistema. due rivellini K e K, situati uno di fronte a ll’altro sulle «lue rive verso monte; alcuni trinceramenti T provvisti di r idotti, a nord «Iella sponda sinistra del fiume e due ridotte 8 8, poste pure di fronte l ’una a ll’ altra e piè a monte dei rivellini citati. Fra l’ isolotto a valle B e il rivellino R è sistemato infine un porto scorrevole O che il Marnili ha indicato separatamiMite in altra tavola di disegno *.
Attraverso adunque il Danubio, l'armata imperiale si dis- l«x'd, in un primo tempo, presso l’ isolotto maggiore «lei forte Carlo, per proseguire poi verso su«l. onde affrontare le forze turche, marciami in direzione opposta, la sola che poteva servire allo scopo, in quanto la mossa aggirante da noni-est sarebbe stata oatarolata dalla difesa, «txd bene organizzata a sud di O ri»va .
Mentre perù g l’ imperiali avanzavano, i torchi invece retro ardevano accelerando il passo, sebbene in terreno piottoato coperto. Horto il dnbbio che simile tattica ten<W«e a qual che mutamento nella manovra iniziale, suggerito fonie dalle condizioni del terreno, il principe Luigi, avutone sospetto.
* P . M . V o L &
t r . M v«J. a. a. *
inviò il Muntili sul luogo ove erasi ridotta l'arm ata turca per riconoscere se era o meno possibile eh’ p*** potesse ope- rare copertamente un aggiramento onde sorprendere alle «palle le truppe di Cenare. Il Marnili, sempre coerente a aè stesso in ogni piò difficile missione, riconobbe difatti la probabilità di una tale manovra, qualora il nemico avesse approfittato di due strade che Kgli segnalò con tutta precisione le quali, in virtù della loro ubicazione rispetto al terreno circostante, avrebbero permesso al nemico la mossa supposta, senza poterla ostacolare.
Immediatamente furono prese le opportune misure di sicurezza sbarrando cioè una d i enne strade con profonde abbattute di fusti e travi e sorvegliando l ’ altra con la cavalleria pronta, con la sua mobilità a respingere qualunque tentativo di forzamento.
Nonostante peni le cautele adottate cosi nella preparazione e nei dispositivi di marcia di quest' ultima impresa, come in tutte le altre operazioni di difesa e di attacco durante l ’ intera campagna nella quale l ’ opera del Marnili, come si è visto, rifulse sotto ogni aspetto, la fortuna non arrise alle armi di Cesare: il quale oltre ad abbandonare ogni ulteriore procedimento offensivo sulle forze ottomane, dovette cedere a patti N’ issa e Vidino e per imposizione, dovuta a forzamento, anche la piazza di Beiuendria.
Plano d i difesa della Piazza di Peter Yaradino.
Nell'anno 1 '»'>4 LI Marnili, dopo avere sistemato il passaggio sul fiume Tibisco, affiliente di sinistra del Danubio 1 per assicurare la via di Titul, località minacciata dai Turchi perchè ritenuta necessaria agli Imperiali, onde mantenere le romu nicazioni colla piazza di Beghedino e per tu a colla Transil- vania. ebbe l'incarico di rimettere io pristino stato, colla ma»
4« MEMORIE INTORNO * L. Y. MARMILI
• FMMXKto nwgnito ta rondlsfooi d lf lr ilM a f a razione del terrenola (Tao parte paltxkwo per eoi fu aeensssrio l'tmpWo di aiaterlatldi rtrnataua. nane fttMi. travi, tavole, far ine. sarchi di «abbia • aitr-ara e»!k-rrt»ntl
I_ MABI*tLLI • U r. M AMILI UOMO t>l IM UIV 47
■ini« aollecitudine, le forti llcationl «Irli» p lana di l'eter Vara dlno nulla quale puntava l'Armata Turca avanzando da lb*l gradu, dopo catere alala aconAtta durante l'azione per II forta nini tu di quel p u u n i » . Inum netilp difeso dagli loiperlali ■•deai i l .di quel paw atgi», tenarrmentr dlfeao dagli Imperlali medeaiml.
Lo arhixxo a. H, ' rapprendala II piano elaboralo dal Mar aiIi della piana di l*eler Varadino co ll« atte fortificazioni, nonché la situazione delie forte belligeranti contrapponi e con la Indicazione delie opere e dei metti di di ima, da parte delle truppe O aaree e. di attacco, da parie delle truppe ottonane.
Le forttAcazloni di Peter Varadino, piatta eoatltulta da ana parte alta A » da una parie baaaa 11, poate «mlwilue nulla deatra del Danabio ia una marcata inneuatura ritolta »erto ovMt, tennero rafforzate coll* aggiunta di una aeconda linea ratrrna a carattere baa fio nato con ampi rivellini e eoa troguardie, fortemente appoggiata alle alt. verno la aponda del ftume. l ’ n nolo paaaaggio venne laaciato nella gola della cinta baaaa per le comunicazioni rim pel lo ai due ponti C e I prò tetti, a loro volta, da una fortiArazione a ponente, da alcuni vaacelll K a mettano!te e da alcune piccole navi da guardia H a mezzogiorno, queate ultime per impedire ai Turchi la pò» ni bili tà di avvicinami al ponti C e 1 collo acopo di farli tal- tare, mediante macchine o anche enplonivl.
L 'armala turca, agli ordini del Oran Vialr A ly Hannà nel net tembre di detto anno, accampava le #ue truppe a mettogiorno di Peter Varadlao ia località ponta al nlcuro dalle offene di- tette della piatta.
Immediatamente furono inixiati i lavori di inventìmento con «intenti. principalmente, in due linee di dlfeaa X e V di cui la X» era organizzata in modo da utilizzare le pieghe del terreno che ia quella zona offriva una copertura auflieiente agli aaaaiitori, acnza intralciar loro Pu ione di fuoco; la ne ronda linea invece era costituita da trinceramenti fortemente protetti alle ali e provvisti di numero«! pa**aggi pure prò
■ r M . V o i &. N «
U HUIM IXI • U r. M «U I1.I l'OMU DI O ft tU 49
tetti, per facilitare le comunicaatoni fra quest« linea e l’altra più avanzata. Dietro e a fianco «Il ambedue erano istallate numero*«- batterie di cannoni per agire con fuochi incrociati ani trinceramenti avversari.
Completata l'invertimento, altra artiglieria posta pure in apeciali batterle dialocate In N e in L per battere rispettivamente : la piaaaa di rovescio, e I [muti C e l e ancora la testa di ponte Z.
L'armata Imperlale agli ordini dei Maresciallo Hllvio Enea Caprara. concordemente col Marnili, a cui era stato affidato l ’ incarico di provvedere per il lavori di difesa, al accinse, per la bisogna, alle varie operaaioni per salvaguardare la piaua da tutte le parti e specialmente da meuoglorno, dove si era già pronunciato l'a ttacco principale del nemico. Da quella parte, adunque, il Marslli fece costruire egualmente due linee di trinceramenti F « O ; la prima coatituita da due lati uno dei quali, appoggiato alla plana (parte alta A ) e l ’altro al Danubio, In modo da servire : il primo, come trinceramento d'approccio ed il secondo, come trincea di protettone in caso di ritirata delle truppe dalla seconda linea. Questa, quasi concentrica coila prima, collegatavi per mnttu di approcci, aveva lo scopo di rin touare qualunque Tentativo di avanuta del* l'aw er*ario per procedere poi all'attacco della piaua di viva fona. L ’organinaiione di questa linea avansata, era munita d i tutti g li elementi difensivi atti a proteggere le truppe cosi di fronte, come di fianco e nello stesso tempo a facilitare le aortite mediante appositi approcci e anche la ritirala al coperto.
Completata infine il sistema difensivo: l'appostamento delle batterie. O, per coni roba tlerie l'artiglieria nemica L ; P e P , per battere il naviglio K, ancorato su una diramazione del Danubio e finalmente Q e 8 per controbattere le artiglierie avversarie poste alle ali dei trinceramenti X e V.
Questa era la situaxiooe delie due armate contrapposte nel settembre dell'anno più volte ricordato. Parecchi furono gli •contri sulle prime linee, ma sensa risultati tangibili, a ragione deH’avversa stagione, che impedi al Maresciallo Caprara di
operar* un aggiramento sul campo ottomano con il concomo di riuforzi, che dovevano giungere dalle alture circostanti per sorprendere il nemico alle spalle O li ottomani, vista l ’ impossibilità di proseguire l'assedio, levarono le tende e di conseguenza anche gl'im peria li si ritirarono nei quartieri di inverno. I l Marsili in uno degli scontri fu ferito alla spalla destra, perù non gravemente*.
Assedio d e ll« Piazza di Landau.
L'Imperatore di Germania nell'anno 1702 assicuratosi l'appoggio dell'Inghilterra e dell’Olanda. dichiarò guerra ai Francesi per impadronirsi del Reno effettuando, come prima operazione, l ’asaedio della piazza fortificata di Landau attraversata dal fiume Qneicb affidandone l’ incarico al Principe Luigi di Raden.
La fortificazione eretta in quella città (schizzo 9 )* una delle pià importanti della Confederazione Germanica, furono erette dal Generale Vanban applicando il suo secondo metodo e cioè recingendo la piazza (città, e cittadella) mediante una cinta poligonale a fronti bastionati con torri casamattate ai vertici e con haluardi staccati, in modo da formare, con le interposte cortine, un recinto esterno.
Verso la metà di aprile di detto annu, il Principe di Raden intraprese I lavori d'anedlo. investendo la piazza da mezzogiorno e da mezzanotte, applicando per le operazioni d’assedio Il metodo di Vauban 2*.
Itala perà la lentezza dell’avaniata veno gli obbiettivi su cui era diretto l’aitacco, forse per ragioni di poca esperienza «la parie degli ingegneri m ilitari addetti, o anche per non affari care wverrhlamente le truppe assalltrlrl. sia li fatto che dopo 60 giorni «lall’inlzlo delle operazioni, nessun risultalo degno di noia si era ottenuto, in quanto le artiglierie erano ancora lungi «lagll spalli del fronti presi di mira.
SO MEMORIE INTORNO A L. P. MARSII.!
* I «ta fan i. « «M a il «lai Osale T slsta al. ztssarrr «la HMu dove U MsnOli aveva (e lis io so poalt «a l l> a n M a
* La ttrrs «e rn ia al fratello la data » oste*«* F . M . V a l 4. X . 11.* r . M . Voi. S. X. 7.
»tuoe 0 w * l . i
I Omtom • ivo*v) p io * m ****11 e
- f l Y C T N V T
O N V K 1
s = ar-■— r j ^ f *>•**>
• m or/iHsi
v a w a o o n
b i MEMORIE INTORNO A L. F. MAR8I1.1
Qiunto sul posto il Morsili insieme coirArciduca Giuseppe, visitò attentamente i trinceramenti eseguiti e rilevando »abito che Tentennone dei medesimi, non era proporzionata alla forza impiegata, opinò che bisognava concentrare, senza ulteriori indugi, tutti gli sforzi verno la trincea, nulla quale dovevano installarsi le batterie per l’appertura «Ielle brecce sui fronti dell’opera investita. V inte tutte le resistenze incontrate per la sua ardita proposta e ottenuti rinforzi, potè, insieme col Colonnello Kekler, comandante dell’artiglieria, far costruire numerose batterie per quarantadue cannoni di grosso calibro e ventilile mortai nei trinceramenti ben protetti, dai quali gli fu consentito di aprire un fuoco insistente ed efficacemente d ireno sui fronti più vulnerabili della fortezza la quale, dopo quattro giorni, fu costretta ad arrendersi.
• • •
Ter questa nuova impresa del Marnili, nella quale risulta chiaramente la potenza delta sua Intuizione, cosi sul giudizio dell’operii del Va uba n, come degli inadeguati mezzi impiegati dal Principe di Haden per attaccarla, troviamo opportuno ricordare quanto il Marslli stesso opinava circa l ’es«*nza della fortezza e dei mezzi per farla cadere, senza soverchie pentite
A l Big. L I). C. 11. D. Qnincy 1 che g li aveva chiesto cosa ne pensasse sui metodi di fortificare le piazze suggeriti dal Vau- ban. metodi che in Germania si ritenevano non originali, ma copiati dallo Srheiter. il Marnili rispondeva « che Egli non era partitante del geoerale francese, specialmente nei riguardi del suo li* metodo, del quale esiste nn'applicazione nella fortezza di Laudan e aggiungeva che essa non era di grande resistenza. quando fosse stata attaccata come occorreva... » .
la una lettera del Marsili diretta al canonico Trioni et li, dopo la presa di I-andau rosi Egli si esprime « la nuova fortificazione di Vauhan. famoso ingegnere francese, non è gran coaa e questo lo dica pure al Dott. Randelli maestro di forti-
■ M tm ottr* sur la vie del Mr le Coarte 4» MsrriJI 41 L t> C IL «V Vuixwy. u t |»rtie. fmg. 127 a».
t. MABIXKLL1 • U r . M AM ILI COMO PI 01‘ KHIH
Orazioni in Bolnpii. He poi d irru r rhe l'assedio hu tiara lo tre meni, risponda che rotti orlò soltanto con MOO fanti e a poro a poco renne qualche scaglione di truppe Uno che ai 2 di agosto arrivarono i due vecchi reggimenti Imperiali Molai e Marnili e eoa! con questo soccomo, Il nostro Kc rominriò il vero assedio pigliando per assalto tutti i ponti avanuti e con Bine e lavori di tappa, *i potè prender posto «albi «Inula t*operla ; dica altresì che l ’ impietri modrrno del fuoco del cannone non trova renistenza abbastanza e rhe conviene appi gitami ad a ltri principi e ma»»ime. alle quali, rredo murre arri vato in gran parte, col fondamento del l'esperienza di tanti m «o l i che ho fatti. Asairuri tempre il Ke dei Kotnani rhe quando fonae aiata terminata la noatra gran batteria di 42 granai peui di cannone suH*orlo del fon«o e 22 mortai, rhe la p ia iu , in termine di 10 giorni, avrebbe dovuto redere, quando anrhr 11 nemico ai foane ostinato all'ultima difeaa ».
« Ebbi la sorte di farla terminare questa batteria la notte del 0; la mattina del 7 venne H. M anli! negli approrrt. dove cominciò questo gran fuoco rhe per 2 giorni e 2 notti mai non riponò ed il 9 sul m ezzog iorn o apparve la bandiera bianra rolla domanda di rapitolaxione da parte del nemiro. Tutti coni trovarono rhe il prescritto termine di 10 giorni, era il più lungo, rhe potevano gl'inim ici sostenersi. Intliie ra*wdio vero ha durato dal 3 agosto al 9 settembre... ».
« A I Rondelii dira ancora che i p ro fili delle fortitteaziooi nono il tutto e che questi si conoscono solamente dal gene rate Cotfcorn in Olanda t che io »pero anche di migliorarli a riguan lo delle nuove massime che esso insegna e dalla fon a del ranno ne per l'espugnazione di piazze... » *.
In questo asnedio chiaro emerge come il »urresao ottenuto «t debba quasi esclusivamente al Marnili. D ifatti il sito inter
1 lettera. 41 Mai M M t lap irtisu . portante la dal» <M» mitrmtbrw imo. * riportata «al Feniani nelle sor ramili* «M anni ■enti Intorno alla vita M eraeral* co Laici Ferdinand» Marnili : .«rrft roriginate aon .1 tre»» neil « Kmdltomai epistola ad Mi.'iDaai a. V. 1. !• *•. carne U Fsstaul «tasso srrtre. Ma brasi nel Ondk* 1072. Voi VI >Mt. «l
vento niiì larori d'approccio, che ni »tarano eseguendo, ralse in un primo tempo, a far delimitare l'estensione dei trinceramenti, che riconobbe, nou compatibili colla forza impegnata; la conoscenza perfetta che avera delle fortificazioni su cni era diretto l ’ attacco, lo misero in condizioni di potere intuire il grado di resistenza delle medesime e stabilire, di conseguenza, la maniera più acconcia e più efficace onde poter procedere airassalto nel più brere tempo possibile; la persuasione, al treni, del Marnili che l'azione rlsolutira si sarebbe potuta otte nere non altrimenti che con una preponderanza di fuoco da lanciarsi a portata utile di tiro, adoperò tutto il suo interessamento perchè i lavori di zappa progredissero alacremente facilitandone l ’esecuzione coH’aumento di forze e degli strumenti occorrenti; l ’ installazione, infine, delle batterie di numero«! cannoni e mortai nella parallela scarata per batterie in breccia, servi magnificamente per aprire il fuoco intenso e continuo, mediante il quale fa possibile al Marnili di raggiungere pienamente lo scopo propostosi.
• • •
Nel chiudere questo cenno monografico sull’ attività del Marnili nel rampo delie operazioni militari, per la parte che abbiamo arato occasione di esaminare, siamo pervenuti nella coorinzione rhe II Marsill, pur arendo dato laminose prore di possedere una mente rasta, analitica e risolntira. non ebbe, lattarla, »è occasione, nè tempo di rivelarsi eminente nel l ’arte nwsidinnale. non ostante abbia diretto e preparati aa- sedi e rafforzato, con opere rere e proprie di fortificazione, numerose piazze, talune delle quali, come «I è trizio, di grande importanza. Forse perchè troppo impegnato la molteplici fan aloni d’ indole tecnico militare, non lasciò neppure trarrle di trattazioni teoriche di tale arte, da potergli attribuire una sua maniera particolare, cosi di fortificare, come di assediate unapìlfflH
L'opera del Marnili fu sp esso paralizzata dalle esigenze po litiche di quell’epoca, essendo noto come l’Autorità centrale di Vienna a’ imponesse per regolare ogni rotta, a suo talento.
M MEMORIE mono A L. r. MAK41M
L. NillXCUJ • l_ r. MAttlLI COMO I»I UCEMA 5 6
qualsia»! operazione o prattn lliM B lo affidalo anche ai propri funzionari di Odaci«. I l fa llo adunque rhe il Marsili non alitila potalo, che rarr volte, applicate integralmente le ho«* proposte, «rbben«* at od la le, quasi «empre frettolosamente. aensa controllo « con dannosi ritardi, «piega come «la mancalo nel uno vatto repertorio l'affermazione di an metodo personale, tale •la richiamare l'autendone degli studiosi di arie militare di epoca moderna. Q è non toglie però che, ae qualcuno di ratti •1 fo**e applicalo qoalcbe tempo alla ricerca di dticumenti ori ginali nel voluminosissimo patrimonio tlegli «ludi e delle appli cationi mnltiformi lascialo dal Marnili, avrebbe trovalo nei riguardi dell'arte oaaidionale ae non an metodo vero e proprio d! fortificare • a n ch e di aaardiare piane, cerio una «erie di !ntere»«anti propoate »oggeriie non nolo da norme allora in vigore, ma anche, e piò •pecialmente, ispirate alle condiaioni !• >|>ograflche «lei luoghi per an migliore adallamento, oltre che per una maggiore economia di «pena e di tempo.
Noi, per altro, che abbiamo avaio occasione di consultare relazioni, memorie, progetti e grafici di opere di fortificazione, una parie delle qaali ri tu e» «a in luce nella presente mimo grafia, possiamo affermare, per quanto modestamente, che il Marsill. fu nel tuo tempo nn ingegnere militare di non dubbio valore e qaindi degno di appartenere alla eletta «cbiera di molti a ltri nottri ingegneri che lasciarono traccie indelebili delle loro opere in Italia e fuori.
Cien. Lonovirn Marimcli.i
La ri«l»ilitMZÌoii«* militari'.
Le opere « | giorni 41 Luigi Ferdinando Marnili ebbero an'omhra. ebe petò «a gran parte della tua r ifa : a quarantarln- qne anni g li occo rre. militando nell'eaercito auttriaro rum» gene rale. un fatto dlagnalatiaaimo, ebe travolte i’onor ano di aoldalo; e tale demerito purtroppo egli non potè vita naturai durante compiutamente cancellare, e per e«ao molto «offerte.
Nel commemorare quest’anno l'uomo, che fu eccellente in ogni pid diverto campo deirattlvltà umana, tento doverono e gradito il compito di tentare, rou la »corta di elementi documentarli, la riabilitaxione di lui come uomo d'arme.
l/a».unto è quanto mai arduo; ma l'bo accettato con delibe razione ferma percb*. ancor ebe tardi, giustizia aia reaa a Luigi Ferdinando M attili, e, coincidenza autpirale, proprio nel tempo In cui Bologna e l'Ita lia ai apprestano ad onorarne, nel secondo centenario della morte, la memoria iiluatre.
• • •
Correva l'anno 1703, terzo della guerra per la aucresaione di ftpagna. il quale fu a »«a i duro per l'im pero: guerra afavorevole all'eaterno. «r it i gravi mima all'interno, ribellione aperta del I T ngberia
A llo aplendido Inizio di tal guerra, nel 1701, per opera del Principe Eugenio di Mavoia al aervixio dell'impero e alle felici imprese del 1702. «accedevano a favore della Francia le »venture imperiali del 1703. In coletto anno fortunoso le armi degli
a
MEMORIE INTORNO A L. F. MARMILI
Absbtirgo e d«>i loro allpati mì incrociarono *ui campi di (»attaglia di ben sei distinti teatri di guerra: in Ita lia , nel Tirolo, ani Reno, in Franconia, nella Baviera e in l ’ ngheria.
Comandava, nella calda estate del 17(Vl, l'armata imperiale del Reno il luogotenente generale 1 principe Luigi margravio di Haden; che aveva di fronte l'armata francete del duca di Borgogna; la quale, tranne che per la superiorità «lei numero, era in condisioni forte peggiori di quella.
Disegno dei francesi, già da qualche mete maturato, era di cingere d'assedio la piazza forte di A lt Rreitacb, la cui caduta avrebbe agevolato lo «volgimento delle operazioni successive.
Molta im|K>rtanza era attribuita in quel tempo a tale fortezza, che alla pace di Muntter era pa»«ata alla Francia e che in quella di Rvtvrik ( Itili" i veniva rettituita all'impero.
A lt Hreitarh, capitale della Hritgovia, copriva un importante patto del Reno ed in essa ti riunivano due ttrade, conducenti Cuna a Kehl e l'altra per Friburgo alla Selva Nera. (Uà note voi mente rafforzata dal celebre maresciallo francete Vauban J, munita di cinta battionata, che racchiudeva la città alta indipendentemente fortificata, era con ragione denominata « l'origliere principale del u cro romano impero >. e, più incisiva mente. « la chiave «Iella tiermania ». A pochi chilometri da que Ma fortezza «urgeva l’altra, francete, di Xeu.Rreisach, costruita secondo il tistema del Vauban. la quale sbarrava la strada della riva sinistra del Reno e serviva all'esercito francete come piazza di deposito e di adunata.
Comandava la fortezza di A lt Rreitacb il luogotenente maresciallo conte Filippo A rco : che. come spiegano gli «forici austriaci delle Campagne del Primoipr Kitgmio éi Samia, era
* Geaeral-Ueateaaat. militar« M r ia fx « . .»j»rtor* di l i* (n d l al UnM mat | M n l fn sw w o « d'altra, rte equivaleva al reidMartrfcall-U*«tt»aal UtprrtaW.
* Lepr*tr* de Yaofcaa. grac-V la» »za»tv militare del »et- reato: diritti SS amwdl: pnw parte a 140 fra KtttazUe e eoa tatuatati ; <-o*trai 33 fattene «ecoado aa tao ptrtlrcìarr itaea». e a* a litivrt ritea ano.
R. BC0GIA3I • LA Rt«ail.tT AZIONE MILITARI
membro di quella famiglia eh« allora er « in rapporti «trotti eoa l'elettore di Baviera e della quale un altro membro, il conte Carlo, alla fine di luglio 1703. quando II maresciallo VendAme in va ae il Trentino, aveva «velalo «entimemi oatili a ll’Austria inae gnando al franreai le vie del Monte Baldo ...
Nella «te*»a fori esca vi era pure il conte Luigi Ferdinando Marnili 1 (in tatti i documenti dell'epoca «I legge M ar«iglii mag giore generale addetto all# fortificazioni e comandante di un reggimento di fanteria per gran parte «tanalalo nella forletxa medesima La data precisa in cui II Marnili fa comandalo in tale forieaza l'apprendiamo ila lai stesso:
« Slavo io guardami» il posto di Kltac nella Melva Nera, quando mi pervenne lettera del Hereni««imo Principe Luigi di Baden. leoente generai di 8. M. O sa rea. aerina «otto il 10 I)ecembrr dell'anno 1703— Le commesaioni furono di portarmi nella piazza di Hreisach™ Kntrato io in eaaa la notte delti 13 par di Derembrr.. » . ■ Non riattila che egli ai allontanasse anche per brevissimo tempo dalla forteua. nella quale pertanto egli ri ma «e ininterrottamente Ano alia radala di essa, che avvenne li giorno H settembre 1703.
Hotto quale titolo e per quale ragione fosse Inviato il Maraili a Bri «acro è chiaramente contenuto nella lettera del principe di Baden su ricordata e che mette qui conto di riportare inte Kralmente per la decisiva im porianu che essa ha ai (ini della responsabilità del Marsili nella resa della fortetxa all'armata del darà di Borgogna.
« Quanto importi la Piazza di Brisacco è assai nolo al signor generale di battag lia* (a l M arsili). e siccome è noto che il ne mico in queste congiuntore abbia disegni, ho trovalo necessario di mandare in Brisacro anche nn generale. E comechè il signor
1 Osa {« le a le Imperlale M 3 » Mirato IttR gli era «tato eoo ferii o 11 SO* r i« « ! l im ilo di materia e U ( » 4 « di cutaaaelk» l « « » * * *
' < I « /»o » m i h > 41 Latgl Wrdlaaado M«nSU «opra q usalo all * acca- dato aeil afftr» della m a di Brtasoro» - ( m a indicazione akoaai psg 1
* Oeaeral WartUneMer. corri »pós t rale a cenerate. aitrlawatidetto «rsersie di bsuaalls. prima grado nella eatagorla <M generali nelr«ssrrlio anatrine» dal U f i
60 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
marescial tenente conte d 'Arco potrebbe o per malattia o per altro accidente non essere in lutato da eaercitare l'ufficio di comandante, e dall’ altra parte etwendomi abbondantemente nota la «|ierienza militare, la vigilanza ed il aedo del »¡gnor «tene rale di battaglia e principalmente nota per la conservazione e per la difetta di una Piazza, perciò bo volato mandargli quest’or- «line di andare «ubito in Brisacco ed ivi in questo inverno al Marescial tenente comandante conte d 'Arco »tare subordinato nel di lui ufficio, osservando il servizio del nostro clementissimo Signore e della causa pubblica e promuoverlo. D i più ancora il Signor generale di battaglia, ben pratico nelle fortificazioni, volentieri «'impiegherà in esse, come gli raccomando. Aspetto la relazione in che «tato sia la Piazza e di quello che vi è necessario per la riparazione, e resto... ecc.
a Rastatt, 10 dicembre 1702 ».
I lo tratto questa lettera dalla citata < In form azione» dello stesso Marnili, nella quale * stampata in lingua tedesca e nella traduzione italiana. Da tale lettera appare che il Marsili fa mandato a Hrisacco in qualità di sostituto comandante per il caso che il titolare non fosse più in grado di esercitare le soe funzioni e non già come con comandante o vice comandante; il che militarmente ha ben altro significato e valore.
A questo proposito mi tornano a mente le parole scritte dallo stesso Marnili in altra sua pubblicazione \ là dove parla del modo come fu istruito e condotto li processo per la resa di Brisacco:
« Il tentarmi più volte con cavillose maniere per indarmi a dire, comtro Im rrritè, che io fossi c<m.comandante o vice-co mandante nella piazza perduta» Ipag. 211
A l Marmili erano, in particolare, affidate la conservazione e la messa in efficenza delle fortificazioni di Brisacco.
* < ra tin i* ritpswrff* alla sw gmsie natragU ia srrtitwa 41 astore tK s ts o di o r t ote) Frrdisasd» Mar*Ut - « t t s ( « l t Casa» ITV« » . (st*as a lm a sltrs Itdh titari.
K. I U U U M • LA KIAHII.ITAXlo.NK M ILITA R E 61
Nella ricordata *ua « In form atone » a pag. 3 è detto che « la custodia della Piatta era beo«) appoggiata al conte d 'A rro ; ma il ripar» dell«* fortificazioni rra aurora alla mia vigilatila raccontaodalo ». Dunque comandante vero era il conte d 'Arco e notamente questi.
D generale Marnili atte*«- a rispondere alla riportata lettera del principe di Badea alquanti giorni e solo in data IH dicembre indiritaavagli una breve relatiooe, nella quale fra l'altro era detto ebe « dopo il mio arrivo bo cominciato a procurare perché la P iatta ai fortifichi dalla parte del fiume, in modo tale che almeno eia fuor di pericolo da una sortire«« » ; che « la fonia della città, la quale era lina volta «limata delle migliori, è pre aentemente in pessimo «tato per essere affatto secca, in tal maniera che si può andare a piedi », e « che la chiusa grande ba la bocca cosi rovinata e piena di fango che non si può aprire n* chiudere ».
In data 13 gennaio 1703 il Marsili dirigeva sempre allo stesso principe di Baden un progrtto particolareggiato dei la vori più importanti e più urgenti da compiersi per mettere in eonditioni di buona difesa la P iana di Hrisacco. Tale progetto, come appare a pag. 33 della « In form atone », fu dal Marsili esposto anche « in lutto a bocca al comandante d'Arco, che mos so dal telo al buon servizio di Hua Maestà ^’esarca ardii anche consigliare che preferisce questi lavori tanto necessari in Uri •acro agli a ltri che si andavano avantando in Muntingen e In diversi luoghi circonvicini; i quali a paragone della Piatta medesima di Brisacro « i facevano conoscere poco o nulla considerabili e capaci di difesa ».
« Perciò, senta più differire, mi diedi al meglio che per me si potesse col promuovere qualche lavoro, impiegando in esso in man canta di guastatori la guarnigione, accresciuta allora di £04 uomini del mio reggimento, introdotti in Brisacco per ordine del Kignor Principe Lnigi ; ancorché fosse la guarnigione medesima in ¡»tato miserabile e non soddisfatta delle paghe.
« A llora il conte d 'A rco: o fonar che si lasciasse piegare dalle Istante dei cittadini e Borgomastri, mal sofferenti le spr*r che per tali lavori occorreva»« ; o fosse che per non creder vicino
6 2 MKMOKIK INTORNO A L. F. MARMILI
1’ annedio «Iella I'Iaxta apprenderne come intempentivo il mio telo e come eccedente l'autorità che io mi prendevo in promuovere tali operazioni, cominci«') a «linnentire da me e » ’irritò fino al M>gno di farm i porre in arrento e mi ci tenne dal giorno 18 di marzo 17o:t Ano al giorno 3 di maggio ». ( « Informa zione » pag 4).
Tutto <|ue«to contituince un panno importante, perchè dimo- «tra la effettiva nubordinazione «lei Marnili all'autorità del conte d'Arco, vero comandante della Piazza; la divergenza di vedute fra i due nel pre«linporre a difena la fortezza; la non lieta nitua- zione delle truppe entro di «*nna. A quent' ultimo riguardo ni legge nello Menno documento marnilian» a pag. 4 e 5:
« Scorrendo poncia alruni altri mesi, incominciava a i u m u
rare gagliardamente la guarnigione non noddinfatta delle nue {taglie: ed lo, che almeno volevo tenere in «lovere il mio reggi mento, npedli uno dei miei capitani, il Kainer, alla Keggenta di Hrincovia in Friburgo il «11 30 dì luglio ad oggetto «11 aver un imprestilo di 10.000 Fiorini, non nolo nulla mia parola, ma nul rapitale del mio reggimento e nul patrimonio di O sa re : mn d ò pure tentai invano, on«ie fui costretto a far battere n o nota di piombo.
« In questo mentre più chiaro ni palesò eoa l'arrivo del duca di Borgogna nel Forte Mortier II pericolo dell'ansedio. ed r» •rmdo amebe la piazza tprorrrdml» comr prima, fu da me scritto a Friburgo al medesimo capitano Kainrr che pronegulsne il suo viaggio alla corte di Vienna, provvedendolo di più lettere, di («trazioni e di carte bianche, per ransrgnare il mio retori « mento ed uscirmene da Hrinacco ».
• * •
A questo punto conviene dire alcune delle operazioni belliche che condussero alla raduta di A lt llretnarh Come ai è detto in principio, l'ansedio di questa piazza forte, iniziatosi alla metà di agosto, era nlato qualche mene prima »Indiato «lai francesi, che però furono per alcun tempo perplessi se assediare A lt Rreisach ovvero Landau, asnai meglio presidiata dalle truppe imperiali
rispetto alla prima. Dlacusaionl arraiirn irbr ebbero luogo alla «ede del quartirr generale fr a t irw fra il «luca di Borgogna, Il maresciallo Tallard e re Luigi X IV circa l'operazione più con- »m ie lite : l'assedio <11 Landau o quello di Breiaacb. ovvero di en tran ti, dando la prem lenta a quello di I*andau. Narrano gli •«orici a (Mt ria ri delle Campagne drt primc-ip* Kugmia di Sa'»¡a d ie ai offriva la poMibiiltà di impoaae«aar«i di Lati dau con un colpo di mano mercè l'accordo segreto con alcuni abitanti della città. Secondo cronache di quel tem|io, lo steaao borgomastro Clom, rbe era pure capomastro delle fortifica- ■ioni, il ronaigliere I .a pia ce fin caaa del quale furono trovati na«coati mille acocketti) e lo acrivano municipale Uoaarr ai sarebbero Intesi con gli agenti del duca di Borgogna circa il modo di aorprendere la forteua e toglierla ai tedeacbL. Ho non che, «coperta la trama, i franerai ai appigliarono all'altro
partito di aaaediar» A lt-Brriiach, poiché per Landau non ai credevano forti abbaatanza. Del reato militava per i ’aaaedlo a ltrelaach anche la ragione di a «»irti raro con la prem di quella forteua la rom un ira i ione dell' armata del mareaciallo V illani
col territorio francete, la qnale era allora molto incerta e mi narciata. Deciaa l'operazione tutto fu prediapoato per iniziarla in agoato. non appena cioè foaaero giunte le truppe destinate a coatituire il t ’orpo d 'a—cdk>. I^uealn risultò compoato di SO battaglioni e SO «quadroni pari a 24.000 uomini; Il parco d'aa- «M io di 120 cannoni e .12 mortai. A Xeu BreUach, sulla frontiera francese, e preoso il forte Mortier, vicinissimo alla for-
tetta di A lt Breiaacb da assediare, dovevano raccoglierai diecimila paeaani deU'Alsaxia per 1 lavori di terra.
Da parte degli imperiali ben poco ai fece in quel torno di tempo per attraversare I disegni, non piò «egreti, dei franerai e. «e non proprio per impedire, rendere più dlfflcile il porre l'assedio alla forteua di A lt Breiaacb. I l Feld Maresciallo Tbftn- gen, che comandava l*ala destra delle truppe mobili imperiali «u ll'a lto Reno, non disponeva alla metà di agoato che di 17.000 uomini, appena «oScienti per la custodia delle linee di Htoll- bofen sulle quali si erano schierate le predette truppe dell’ar
E. aBDUUMt ■ Ut aiABII-ITAlloSIt XII.ITAMI: 6A
6 * MEMORIE INTORNO A L . » ' . MARMILI
mala del principe di Baden, che avera il proprio quartier generale a llaunshelm.
Il presidio di A lt Breinarh era aiutai «tig lio : da documenti dell’Archivio di guerra di Vienna (1703, X I I I , 7. 8. 13 e 75 a.) •i desume la vegliente composizione di es*o:
del reggimento imp. Margravio di Baden . 1183 uomini » > » » * Bayrvuth 808 »» > » M a r it ig li ........................1313 »» > » K r f l t z .............................152 *
Totale 3458 >
In merito alla entità di tale presidio è doverono soffermarci un poco, perchè è di capitale importansa conoscere la vera o la piti appronalmatlva rifra ai Ani della maggiore o minore resistenza che poteva cime re offerta a ll’assedlante. le col forte — come ai è vinto — ammontavano a ben 24.000 uomini.
11 Marmili nuU'argomento parla In pià punti. Cosi nella nota « In form azione* a pag. 2 *1 legge:
« Entrato io in c**a [nella fortexza di Brisacro | la notte dell! 13 par di deeembre ed osservatone diligentemente nei giorni appretuio lo alato, la trovai mal fornita di artiglieria, che ap
pena arrivava a 40 pezzi mancanti di enne, di mote e d’altro. La trovai priva in tutto di minatori, cannonieri ed ingegneri Trovai la guarnigione consistente nel solo numero di 1744 sol dati, la quale poi dopo qualche tempo ai accrebbe con 804 Uomini del mio reggimento, tenta che fra questi fo**e alcuno ancorché piccai numero d i cavalleria, tanto Deceduta ria per le aortite ».
K plà oltre a pag. 13 della stessa «uà « In form azione»:« Imperocché, ae intero vi foMv »tato U numero rompo*lo
di 1744 nomini trovati in Brlaacro al mio ingrewao e degli 804 aggiunti del mio reggimento, non «arrbbe asceso lutto il pre aidio a più che dne mila cinquecento quarantotto soldati; ma per che nel decorno del tempo erano mancati alcuni, si ridata«
B. BKXÌIA.M • LA BlAaiLITAKIOKE M t l . m i l 65
la goamigiotir a 2417 uomini Tanti furono trovati il ili 23 ago sto, arrotili» giorno ilrl reale attacco tirila piasaa, tirila rassegna generale. rbe «1 frrr alla prtwBM r per romando ilrl conte d 'A rro ; r tanti (orano appunto ila mr ripartiti nrlla dispo. aizionr «u la breccia. rrr. ».
Nelle Paatillr ritptomtire mila mrriHmrm 4i auturr amnmimo (g ià rlrorilatr la nota preredcutcì 11 Marnili aggiungr r rbla riarr »o li' affarr della quantità di grntr d' armr contenuta in Briaarro :
« l'n 'a ltra prova ritolta dal r a m p a r t im r n to rbr alla vinta d'ognuno ai faceva delle Ooardie e d o r ò <|on>ta c o in c id e n te d i
a*o«lru ion r dal primi giorni d i febbraio Ano ai 13 d'agnato. La Ooardia giornali- Importata 712 n o m in i, e a llo rc h é la m at
lina veaiva la veerbla a rilevar la nuova ae ne vedevano in armi 1424; ma ai vedeva aurora non meno e v id e n te m e n te rbe nelle raae d'armi non restavano 712 uomini di vacanza.... Beco dnnqnr rbe malamrnte arrivava tutto i l n u m ero adoperabile per Ooardie a 2136 D om in i, e questo numero era r o m p o « !o dalle tre partite di Ooardie giornalr d i 712 Cuna, ed II rima
nente. per andare alla wmma d i 2500 rlrra. era composto d i
oiBriali maggiori e gente d e l lo «tato Colonnello che oon mon tarano Ooardia » (pag. 32 e 33».
OH atorirl austriaci delle CatmfMtptir drl priaiHpr Eagmin di Sm tuia ripetono il numero di 3438 uomini dato dall'Arrbivio di guerra di Vienna e chiariscono rbe per il «ervlxlo delle » r tiglierie non vi erano rbr un artigliere e 12 cannonieri Bottoil ramando del recrfcio capitano Heinite. He non che quegli »U»
rici «i contraddicono da poi cbe aa*eri«cono cbe P 8 «ettrmbrr 1703 aiPatto della capitolazione. le truppe u«centi da llriaarro erano in numero di 1268 uomini e 5 artiglieri, e cbe nella far- len a rimanevano 130 feriti e malati non trasportabili, oltrei 70 morti cadati dorante l'asardio. Ora aggiungendo alla fona uscita di 3273 | 130 riausti e i 70 morti l'entità del presidio aale a 3473 nomini, nomero ««p erio rr a quello dagli »tr«*o «to- rici fornito come fon a del preaidio al momento delPInialato
n a n llo L .
•
E giacché parliamo di storici austriaci dei fatto in esame riuscirà per io meno strano se non pur ridicolo riportare questo testuale passo a riguardo del nostro M a rs ili:1
« V i era pnre (nella fortezza di Alt-Breisach] un secondo generale, il maggiore generale conte Luigi M arsigli: un vecchio e dotto signore tormentato dalla gotta, che non andava molto d'accordo con l ’Arco ».
Nel 1703, agosto, il conte Marsili aveva da poco compiuti i 4.% anni di età, essendo nato il 10 luglio 1H58! (guanto poi alla gotta, questa sopraggiunse quando divenne veramente rccvhio....
Sempre a riguardo della efficienza del presidio di Breisacba) momento in cui i francesi si apprestarono a cingerla d'assedio, è notevole il disaccordo fra i dati contenuti nei documenti offerti dagli storici suddetti e quelli assunti da altre fonti non meno apprezzabili e attendibili.
Comunque dobbiamo premiere atto dei seguente passo, assai importante, che il generale Marsili pubblicò senza che venisse minimamente smentito o contraddetto:
« fc vero — dice egli — che appresso i mal intenzionati potea far grande »trepito il trovarsi in quella piazza il nome, se non la sostanza, di quattro reggimenti, cioè: Baden, Bay. reuth. Marsigli e Gràtz oltre 200 svizzeri del reggimento Nide- r is i; ma è necessario sapere due particolarità. La prima si è che qneoti reggimenti in sè stessi non erano compinti, mancando ognuno delle debite recinte dell’anno 1703... e il reggimento di Gràtz, venuto da Catalogna, appena poteva chiamarsi nna compagnia contandosi in esso solamente 92 uomini fra gregari e ufficiali. La seconda è che dei medesimi reggi menti cosi diuiinniti erano Impiegati altrove 1700 nomini, come si giustifica nella seguente lista... s.
Tale Usta, minutamente compilata e riscontrata veritiera, contrmpla « la gente comandata dal tenente generale margravio «li Baden fuori di Brisacro in altre Piazze e Posti » come a Landau, a Fillingen. a Laufenhurg. in Hohenzoller. a Mnnzin
66 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
• 4*4 prlmctp* £mfrm4c 44 M ttM ■ Velame V. ; « ( 3SM.
B- BBOCIAXI • LA BUSIUTAXIO*! MILITAMI! «7
gen ecc. OM «testi «forici «Ielle Cmmpagne èri principe Eugenio ammettono ad esempio eh* la Landau *1 trovava un battaglione del reggimento Marcigli, mentre la rimanente parte era in BriMcra (voi. V. pag. S IS l
• • •
Per quanto riguarda le operaiioni ostid tonali basterà, al fini di questo *rritto, rirordarr rbe da parte francese I lavori di circonvallaiiose principiarono II 15 sgotto «otto la direttone perdonale del maresciallo Vaaban. che conosceva aMiai bene sei »noi minuti particolari Popera della piatta per essere questa «tata dalla pace di Mflnater (l»U9i a quella di Rjrnwik ( IO ? ) In mano dei francesi e dallo «tes«o Vauban in piò parti fortiSrata w aoro. I l 18 l'investimento era compiuto.
O li a*aedianti erano cosi distribuiti e schierati:
12 battaglioni e 15 squadroni, a monte della forteaaa, al Pala «inlatra;
22 battaglioni e 24 «quadroni, presto il villaggio di UOnd- llngen. al centro;
I l battaglioni e 18 squadroni, a valle della fortrata, al Pala destra;
4 battaglioni alla custodia dei ponti «o lle due rive e nelle Itole interposte:
1 battaglione nei forte Mortier;2 «quadroni in Neu BrUach.
I cannoni della fortesu rWposero con molta efficacia e con tale precisione ebe fu dallo stesso maresciallo Vauban ammirata e proposta ad esempio alla sua artiglieria.
Nella notte dal 24 al 27 agosto gli assediali tentarono una sortila in due colonne. O li «testi storici austriaci dicano che la colonna maggiore, forte di o lire mille uomini agli ordini del colonnello Tanner mise io grande «coro pigi io I lavoratori francesi, cosi che i battaglioni loro furono respinti con perdita notevole di morti e feriti. La «lessa relazione francese con fe««a rbe fu grande la confusione nel campo e che solo allorché
venturo al soccorso quattro battaglioni del reggimento du Roi g li imperiali furono costretti a fermar*! e quindi a ritirar«! in buon ordine perchè non più inseguiti. L 'a ltra colonna di qualche centinaio di uomini fece soltanto una Anta in altra direzione.
(jueatta sortita molte cose dimo«tra, ne non altro la non ignavia del presidio e l ’ intenzione del comandante di e««o a non cedere »e non a prezzo di «acritici e d i «angue!
I l 28 agosto l'aHMediante batteva la fortezza con 38 cannoni e 2t> mortai, che facevano fuoco continuo. Il 5 settembre di mattina (narrano i più volte riconiati storici! erano g i i in tuitteria 80 pezzi, il cui violento fuoco di«tru*»c fra le altre co ne la cateratta principili** d’ immi»«ione, rendendo co«) ini p o s s ib i le al difensore il governo delle acque. In quel giorno i ’Arco fece costruire una traversa dietro la fronte d'attacco; ciò che dimostra che egli nulla lasciava di intentato per resistere e per offendere.... Net pomeriggio di quel giorno »tesso la batteria dell'ultima parallela aveva aperta una breccia e giù gli assediami lavoravano a preparare il passaggio del fosso. Fu allora che parve al comandante d 'Arco che la difesa, non uatante tutto, non potesse più oltre protrarsi con vantaggio. Nel mattino seguente, che fu il 6 settembre, egli adunò gran parte degli unciali del presidio per un consiglio di guerra che decidesse il da fa r«i: capitolare o resistere ancora. Tutti votarono, motivandone le ragioni per iscritto, per la capitolazione. Kra la catastrofe per il D 'Arro e U Marnili !
Vediamo come si »valse questo consiglio di guerra in Bri- sacro » come « i addivenne alla resa: indi raccoglieremo tutte le Ale e sulla «corta di documenti, non ancora resi di pub blira ragione e a me comunicati daU'Archivio di guerra di Vienna, considereremo l'opera del M arilll e la non g iu s te «« della «offerta condanna marziale.
Secondo i documenti ufficiali (Arch ivio di guerra. 1703. X I I I , 32) accennati anche nel V volume a pag. 304 delle Cam jMsgnc del Principe ¿’ «{reato, il conte d’Arco. «olo e unico co mandante della fortezza, adunò il mattino del 6 settembre tutti g li «flirta li del presidio e dichiarò che « non potendosi sperare
« 8 MKMORIK INTORNO A L. P. M ARSILI
B. H W U X I ■ LA RUaiLITAZloXR MILITAR* 6»
torcono, era Kinoio il mommlo «li ragionar della rapitola lio n e ». C itò una Irtirra del Margravio in data 30 giugno 1703, in cui questi, rispondendo a rk k lw l» fa ltr dall' A rra di varie «perir di materiali e di denaro, dichiarata non poter mandare aU’Arra nulla e rimanere prrriò In facoltà di qurati di prov vedere ai mai anni e regolarai rane lo rirhirdeaaero le rir-
ràatanie e l'Intrreaae «lei arrvUio. Il ronlr d’A rro ritenne tale lettera rame nna dladetia «Irgli ordini mollo perentori avuti dallo ateaan Margravio la dala 18 febbraio e in parte reiterali la data 8 maggio e chirae agli ufficiali II parere aerino clrm la possibilità di roatlanare la difeaa. Con quaai unanimità il reaponao rieH'uffirlalità eoavenula al ranaiglio fn prr la rea«, purché al prealdlo fo*«r ranrraaa la libera uarlla con tu lli g li onori di gnerra.
Erra I trainali ordini emanati in preeedensa dal prlnripe Luigi di Itadrn al traente marearlallo d’Arro.
1*1 in «lata 1« febbraio 1703:
« I battaglioni coati deatlnati (a Ilrelaarh) li ho spediti al aignor L. M. (luogotenente maresciallo d 'A rra ) affinché nel raao foaae attarrato dal nemira piuM tanto meglio difenderai,lo dubito invero che 11 nemira In viata drl proaaimo «norair* voglia presentami dinanzi ad nna tale forlnua; ma intanto lutto biangna aapettarai. Affinché però II aignor L. M . nel raoo che il nemico awaaliw il posto affidatogli, non abbia da rom perai il rapo a pensarvi. gli dA con quealo I' ordrc potiti* di difenjlersi Ano all'ultima immaginabilr estremità, e non prendere veron altro contili*m a rcaolutkm : imperciocché lo non ■are! contento di Ini ae il nemico entra««* nella forteua affi datagli altrimenti che eoo la «paria in pugno e per la B rcn ckc,
e gliene rhirderri •tret!i**imo conio. Tale ordine il aignor L. M. lo farà leggvrr pobbliramrnte a m ila la gnmUon ; af finché ae 1'Altiaaimo dispone»*«* di queati o di quegli, ognuno dal primo airu llim o della fmrmitom aappia aerando la luburdinatiom regolarai come qui è detto ». (Archivio di guerra, 1703. X I I I , IU|.
70 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARSILI
2*) in data 8 maggio 1703:
«.... del resto ripeto l'antecedente mio ordrr, cioè che se il nemico intraprendesse alcunché contro Breisacb, Il signor L. M. e tutta la ijominon, secondo il contenuto del primo mio ordrv, dorranno difendersi ad oltranza e fino all'ultimo uomo ». (Archivio di guerra, 1703, X I I I , 25).
3*) in data 30 giugno 1703:
« Dalla relazione in data 21 del cadente mese a me scritta vedo non solo in che stato ora sia tanto la milizia esistente In Breisarh quanto la penuria delle cose necessarie. Per verità non posso fan* altro che aprire confidenzialmente al signor L. M. che, non ostante tutte le mie moltiplicate ed efficaci rimostranze, mi trovo fino ad ora abbandonato dalla Corte e senza verun aiuto e rhe a pena mi è possibile alle volte di supplire alle quotidiane necessità. K molto meno appresso di me sono le forse da soccorrervi con denari e con altri requisiti.
« Per questo con la sua condotta Industria e zelo, per il «er- vlzlo dell*Angustissimo Padrone sarà da agirsi in qual forma il negosio si debba dirigere ». (Archivio di guerra. 1703, X I I I , 71 l
4*1 in data 16 agosto 1703:
« .„. ripeto l'ordine di difendere e conservare l'importante fo rtru a Uno all'ultima estremità, adoperandovi corpo ed anima, testa e m ano». (Archivio di guerra. 1703. X I I I . 28u
Qiova subito dire rhe il quarto ordine in data 16 agosto (come g li stessi storici austriaci riconoscono r «emhra apparire dagli A tti del gtudliio cui diede motivo l'assedio di Brei- «ari») non potè essere recapitato al conte d’A rro ; perché il corriere, pur ammettendo partito dui quartier generale del Margravio che era in Ilaunsheim lo stesso giorno 16. doveva impiegare almeno tre giorni per giungere ad A lt Brrlsach. allorché questa piazza era già da alcuni giorni cinta da regolare assedio. Giova altresì ricordare rhe rimase ignota lino
ft. aSOtilAXt ■ Uà aiAIIIUTAXIONB MILITARE 71
a ll' atto del protri—». al conte U ir t ill, la lettera del Margravio in data g maggio che confermava l'ordine del 16 febbraio, e che dei pari rimaae ignota al M an ili Ano al momento in cui fu letta dal conte d 'Arco al nolo consiglio di guerra in Brei- aacb II <1 aettembre. l'ultima parte della lettera del Margravio in data 30 giugno che concede in un certo modo arbitrio al d ’Arco « di agire in qual forma il negocio ai debba dirigere ».
<*lò ponto vediamo il contegno del Maraill In queata con. tingt-nia Kgli dice che «rammemorando alla guarnigione il tenore di una lettera del Derrnimimo di Baden del 16 febbraio IpiA aopra riportata! In cui veniva ordinalo di non perdere la piana ae non con la «pada alla mano «ulta breccia. ed etten- 4omi io determinalo m morire la d ife t della medetima, riduaal la gente in ordinanaa per ribattere l'aaaalto sulla breccia già aperta dagli inimici, «rcondo la diapoaltione che »1 vede chia ramente descritta nei foglio K. ' Mtandoai però in tal procinto, la mattina del giorno 6 di «ettetnbre aoprawenne una chiamata del conte d 'Arco comandante, con la quale ordinava il ridun i a consiglio a me e ad altri 30 ufficiali della guarnigione ». (/ »/ornano««', pag. A}. K nelle Pottille rbptintice già piò volte citate aggiunge a pag. 30:
« Uni io per la mio porle pronto a »ottenerlo (l'a«aalto| e a tal effetto aveva <li«po«to «a lla breccia quel poco numero di genie che coatitaiva il p m id io . quando (ter ordine del conte d 'Arco fui chiamalo a consiglio ». K altrove nella »t«-*»a pub blicaxione (a pag. 231 «crive: « Io dunque non ho mai |ieu«ato a proporre qne«to conaiglio: ma «olo mi «ono applicalo a far ogni afono poaaibile per la difesa esortando, come io feci lo •ero dei j , » tolda t i o morire occnrrm*lo tulio breccia ».
E di una coai bella aoldateaca condotta del M an ili diede atto la «tema Commissione incaricata del proce««o. Qui la Agura morale del M an ili è tu lt’altro che modesta, o. |*ggfo. proiettala di ombra. Kgli che pur oon aveva le funmionl di comandante, ma che in particolare presieder* aU’efficrnM delle
' q i i aoa * rlpMUU.
72 MEMORIE IXTOR.NO A L. P. M ARSILI
fortificazioni e al modo come meglio metterle in assetto di diie*a, nel fatto assume il volto e l ’anima del capitano combattente che prepara nè, i gregari e g li ufficiali dipendenti al sacrificio pii! alto pur di resistere al facile e già imbaldanzito assalto del nemico! Non dimentichiamo questo fatto e questo atto.
A l consiglio di guerra, adunato per ordine del conte d'Arco, parteciparono precisamente 31 ufficiali oltre il comandante e il Marsili: non quindi tutti gli ufficiali del presidio.
Dopo quanto ebbe a spiegare il d 'Arco sulla scorta deir ultima lettera ricevuta dal Margravio di Raden in data 30 giugno tutti convennero sulla impossibilità di continuare la difesa. Scrive a questo proposito il Marsili nella sua I * formazione a pagi na 8: « Io che fui il penultimo a votare, dopo avere intesi 1 sentimenti di altri 30 ufficiali e che per altro non aveva in quel tempo alcun ordine a parte (dipendendo da quelli comunicatimi dal conte d’Arcol avendo esaminato l’obbligo della mia coscienza e della mia fede, non potei non concorrere nel comune voto se non quanto aggiunsi: che non potendosi ottenere capitolazione onorevole si doveva piuttosto morire » .
Siccome molti hanno contestato una simile aggiunta o ne hanno travisato la sostanza non che la forma, mi piace riportare qni sotto la deposizione originale fatta dal Marnili in quel Consiglio, la quale ho potuto avere dall’Archivio di guerra di Vienna che la registra cosi 17U.I. X I I I . 33. La parte in discussione * ora qui fedelmente tradotta:
« Ma qualora questa capitolazione non sta ritenuta giusta, noi tutti siamo disposti a difendere con 1« vita l’onore delle armi imperiali » .
Fra le varie deposizioni scritte dagli officiali adunati in consiglio, qnesta del Marsili è particolarmente significativa, anteponendovi*!. pur nella iattura contingente, l'onore delle armi a qualsiasi capitolazione affrettata o ritenuta meu che degna per II presidio che fino allora ai era comportato tanto onorevolmente. effettuando — come «I è piò «opra descr itto — nna audace e improvvisa sortita, duramente scontata daU'asuediante.
In seguito al risultato del Consiglio di guerra, alle ore 13
ft. MKXSIA*! • LA BIABILITAXItiKK MII.ITAKK 73
dello «trmui giorno A •rllrn b rr il Oont* d’Arco few ¡««are la bandiera bianca noi rastello della piana. Aperte «libilo le im itative ron I francesi, queste ai chiù «ero la aera del giorno mede•imo a condiiioni veramente onorevoli, polcb* la guarnigione «arebbe uscita 11* «ettembre alle ore 6 « a tamburo battente e bandiere «piegale, ron armi e bagaglio, palla in borra e ron la tti gli onori militari, pattando per la brerria ».
Nel documento di eapilolaxlnne em altre»! « la b ili!» che la guarnigione doveva condurre aero 4 cannoni, 2 mortai ron rispettivi attacchi, IUI colpi per ogni forile da fanteria e fi carri coperti, e viveri per aolo quattro giorni; località di concentra- mento em Rheinfeld. dove la guarnigione «arebbe giunta per tappe pa*«ando per Munxingen e Mulheim. l'er ultimo era «labi- ilio che foaae « proibito alle reali trup|>e (france«i| di molestare i noldati del presidio aH'o«eita di questo, e di «frapparne alcuno dalle Ale, o prendere al loro «ervlxlo I diaertori, «e anche qnesil vi ai dimo«tra«sero disposti *. (Archivio di guerra, 1703, X I I I , SI e «4 1.
Le perdite dei francesi durante le o|ieraxioni dell'aaaedio furono di otto ufficiali e 827 ««ridati tra morti e feriti, «li mollo «uperiori di quelle indille, nell'eguale periodo, alla guarnigione imperiale.
La partenza di qoeat'ulfima e la consegna della forteua avvennero in e«atla conformità d e ll'a lto di rapltolaxione. Oli •torlrl anatriaci ai compiacciono di aggiungere a questo punto che il • L. M conte Arco «e ne andò «olo in vettura a Rheinfeld, e che il M O. Marnigli, invece, visitò il 7 settembre il ritira di Borgogna In «Wdllngrn, pranzò, dormi e fere rolatione la mattina seguente ron Ini, poi segui con la «ua carrozza le frappe partenti » .
K allegano a conforto di tale versione II documento 71 del- l ’archivio di guerra h i i m m alla pratica «egnata 1703, X I I I da me più volte citata in questo ««-ritto.
La raduta «a d Inaspettata e cosi sollecita della capitale del la Brisgovia fece gran «en«o lo Germania. Lo «degno popolare — riferiscono gli «forici delle Cmmpagmr 4rl /V. — ai voi-«e contro 0 conte Arra, quasi apertamente accanandolo di tra
74 MEMORIE INTORNO A L. K. MARMILI
dimenio. « L'Imperatore acconsenti perciò alla proposta drl l ’irato tuo luoffotrnrnte genrratr, di sottoporre il fatto ad una inchiesta giudiziaria militare * (voi. V, pag. 306>. E qui cominciano i guai.
• • •
I>a poco più di due mesi, in data cioè 3 luglio, l'imperatore Leopoldo I aveva conferito la presidenza del Consiglio aulico di guerra al Principe Eugenio di Savoia in luogo del conte Mann- afeld principe di Fondi, creato gran Ciambellano della corte imperiale. In una lettera del principe Eugenio datata da Vienna li) settembre 1708, e diretta al conte Guido Htarhemlierg comandante l'armata im|ieriale in Italia, è scritto testualmente:
« Breisach ni è arrena al nemico e la parnisoH {»are »ia »tata condotta a Reinfeld; al quale proponilo io non ho invero comprendere come trattando*! di una fortezza tanto importante la c o m i «ia accaduta e successa poi co«) subitamente. Perciò nino a che non ai abbiano più precisi particolari non è irragionevole l'avere molta prnetumption in contrario. Bensi da parecchio tempo ho rimostrato ed adrrrtirt convenientemente Kua Maestà Imperiale a proposito del conte d'Arco colà comandante, ma per nessun vento fu possibile indurla ad una revolution ». (Archivio di guerra « Italia » 1703, IX , 4K A che cotta vole»*e alludere il principe Eugenio con la frase per ultima riportala non è dato ancora di sapere con qualche sicuro fondamento. Hta il fatto che egli deve aver proposto all'imperatore, e forse più di una tolta, quello che oggi usa dire il « siluramento » del generale d'Arco quale comandante della fortezza di A lt Breisach.
In altre tre lettere sempre del principe Eugenio, nella sua qualità di presidente del Consiglio aulico di guerra, dirette al P. M. barone di Thflngen sono evidenti segni di disistima per il conte d'Arco. Non mio. ma dato che 11 Thàngen fu incaricato di istituire il processo per la resa di Brrisacfc. l'effetto delle tre lettere, che più sotto riporto nella loro parte integrale, dovette essere per U Thùngen più che nn invito un ordine esplicito di essere severo, e forse eccessivo, nei riguardi dell'affare di Brei-
B. REGGIANI • LA RIABILITAZIONE MILITARE 7&
»•ac h. E noi sappiamo quali effetti possano fare in un inferiore certe frani acritte officiosamente «la |iersona che sia altolocata....
In data 24 ottobre 1703 il principe Eugenio «crivera:« Per risposta alla gradita lettera di V. E. in data 12 hujUu
mi riferisco alla rTprditio* già mandatale di poi, con la quale i «tata affiliala a V. E. la Committio » circa la frettolosa r tu di Breisach, e quindi L'avverto ancora officiosamente che in quella •a^uùrstio» Ella voglia procedere con tutto rigore senza il mi nimo reyard; perocché «e dovesse risultare che nella mentovata defrnur, e perciò anche nella aollecita rena, le cose non fossero procedute regolarmente, in tale caao è assolutamente necessario che «ia »tatu ilo un ettmpeL « e però risultasse che tanto il comandante quanto tutto il reato della guarnigione avessero fatto il loro dovere e che per avventura non e n tra le nel fatto una segreta incomcmiem, allora è giunto che ad e**i rimanga intatto l ’onore». (Archivio di guerra « Kom. Imp. e Paesi Ha« ai > 170.3. X. 42».
In data 5 dicembre 1703 il principe ancora scriveva al barone di ThOngen:
< Le dirò che purtroppo è da deplorare il rove*cio toccato al noatro » «c o ir » avviato a Landau e che in «eguito a ciò quella fortezza siasi perduta e abbia poi dovuto arrendersi al nemico.... I l comandante di della Landau, per quanto «i può giudicare dalla drfemaion. ha fatto il dover suo e ha mostralo ciò che avrebbe dovalo easere fatto a Breisacb. Quindi è sommamente necessario che si proceda alla imqmUitiom di questo caao e nella iatilOBione del relativo processo. V. E. senta qualsiasi rrgord proceda con tatto rigore conforme alle leggi di guerra, attesoché deve una buona volta essere «tatu ilo un errmprt; affinchè nelle armate imperiali non abbiaoo piò oltre a prevalere la negligrm e pusillanimità, pur tacendo dell’altro sospetto ancora che in quella resa di Breisacb le ro tr non siano procedale lealmente, di che ai dubita assai » . (Archivio di guerra, < Roma Imp.. e Paesi Bassi >. 1703, X II. 4L
Infine nella terza lettera spedila da Presburgo il 27 dicembre 1703, U principe Eugenio ancora insiate nel «enso sopra detto e aggiunge:
76 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARSILI
« Le raccomando inoltre di sollecitare il giudizio di guerra per Breisach, avvertendoLn che ho dato all'imperatore un re- frrot del tenore che la futura sentenza possa essere tosto eseguita senza chiedere altro. Spero altresì di potere annunciare a V. E. l'approvazione in proposito, prima ancora che sia condotto a termine quel giudizio di guerra. Ma con la presente ripeto ancora una volta che in tale bisogna Ella senza verun rrgard procella con giusto vit/or secondo gli articoli di guerra ». (A r chivio di guerra « Rum. lmp. e Paesi Bassi » 17<M X II , 20).
Occorrono forse commenti a cosi chiarissime espressioni e a cosi non meno chiari intendimenti? Perchè tanto infierire sul disgraziato caso di Breisach? V i era stata legittima suspicione di tradimento? Diremo subito che a detta degli stessi storici delle Campagne drl Pr. Eugenia « uè di tradimento nè di corruzione a carico di Arco o Marnigli o di altro qualsiasi ufficiale superiore o inferiore si ebbe alcuna prova. Nulla vi era su cui si potessero fondare tali sospetti ». (voi. V, pag. 306).
Sgombrato cosi il campo di tanto sospetto, vediamo in che consistettero le accuse formulate contro il Marnili nel verdetto della fam o»« sentenza reso pubblico il 4 febbraio 1704 in Hre genz.
Premesso il motivo del convocato giudizio marziale e cioè: « a ragione della troppo sollecita resa dell' importantissima fortezza di A lt Breisach al duca di Borgogna, avvenuta per mccnrd il tredicesimo giorno dopo l'apertura della breccia, senza provato difetto e mancanza dei necessari requisiti, senza attendere un assalto», fu legalmente giudicato e sentenziato:
1*) che il conte Filippo Arco, perchè comandante della mentovata fortezza ha agito non solo immediate in opposizione alla ricevuta regolare Imatruetion e al prestato giuramento e agli articoli di guerra universalmente noti, ma altresì perchè ha agito singolarmente contro g li iterati ordini positivi di H. A. il principe luogotenente generale in data 16 febbraio e 8 maggio dell'anno scorso, in fona ilei quali egli doveva difenderai v ir ilmente e fino all'ultima goccia di sangue: omesso le necessarie misure per nna resistenza e difesa vigorosa: abbandonato mal è prof»., troppo presto le opere esterne e la coa/reaowpe. a te»
R. REGGIANI * LA RIABILITAZIONE MILITARE 77
nore dell’articolo 43 dell* imperiale legge marciale, »la mandato da vita a morte con la »pada e i suoi beni alano presi riall'im periate Ateo, meno un quarto riaerbato a coprire le «|M*«e prò
ceasaali.3*1 II conte Marnili poi. benché «landò al rigore e alla
aeverità delle leggi m ilitari e alla loro oaservanta. aia del pari incorao nella pena di morte e meriti di essere giustiziato me dianle la apada, perché come primo comandante »ottoniine, arendo piena cooosceota ili quell'ordine tanto positivo dette il ano roto e ru u ra w alla capitolaaione. cb'egli doveva impedir* f » o r w modo, e per l'eccelso m t i i i o di 8. M. I. e prò bona p « Miro dorerà roufurme agli ordini difendersi con la guarnigione Ano all'ultimo uomo, aia decadato da tutti g li onori e uffici. gli aia «pettata la spada e rendalo il auo tywipage per coprire I# apeae processuali » . lA r r t . di guerra 1704 * Barn Imp. e Paesi Baaai », X I I I . « i .
Ora. a* noi potrem o dimoatrare eoo documenti acbietti ebe la fortetta di Alt-Brriaarb non poteva resistere ad un aerio e regolare aa«*dio (24.000 franerai in confronto di circa 2500 imp* r ia li! ) e ebe tale esplicito e preciso g iu d iz io era condivi«*» formulato e comunicato a chi di ragion* dagli ste»»i comandanti di piA alto grado dopo quello che era a caatodia di A lt Breisach, noi avremo raggiamo le prore della vanità e inanità del reslatere in m a dopa an certo tempo, e con«egu*ntemente della erroneità della «ectenia, scolpando eoa) ae non propro in tutto il generale Arra, completamente II generale M arsili; le coi attribationi. come «i * viato in questo arrltto, erano considerevolmente minori e la cui re*pon«abilità del tatto indiretta e secondarla.
E cominciamo dagli storici austriaci più volte ricordati, i quali nel volarne V, pag. 94 delle Campagne del principe Eugenio eaplicitamente dicono: « le riserve di artiglierie e di munixiooi tanto per l'armata attiva quanto nelle fo rte ti* di Landau, F r i burg e Rreiaacb abbisognavano di considerevoli racconciamenti e completamenti ».
I l margravio Luigi di Baden. che abbiamo redato arriverà sotto la data del 10 febbraio al conte d'Arco quell’ordine tanto positivo e perentorio, cosi rappreaentara all'imperatore lo stato
78 MEMORIE INTORNO A L. K. M ARSILI
«Iella una Armata con lettera datata «la Rastatt il 29 m ano 1703:
€ Sebbene io avessi creduto di aver scritto a Vostra Maestà imperiale tutto quanto concerne il cattivo stato in coi stanno qui le cose, pure mi accorgo ogni giorno più di qualche nuovo rovinoso difetto di truppe e di tante altre necessità; perchè non ho truppe sufficienti per guernire bastantemente l’nna o l ’altra fortezza, nè per mettere insieme un'armata e neanche il bisognevole per munire le fortezze «lei puro necessario.
Mancano dappertutto polvere, piombo, fucili di riserva nelle piazze e cento altri requisiti indispensabili » . (('ancelleria del Min. della guerra per l'impero, aprile 1703, n. 178).
Lo stesso margravio all'imperatore ancora scriveva in data9 aprile 1703 :
« Sono costretto ad affidare Friburgo e Breisach a Dio e alla loro boona resistenza.... perchè io non sono in grado con questa poca gente, senza artiglieria, treno di provianda e ogni altro materiale di accorrere in tempo In loro aiuto.
« Quelle duo fortezze sono si molto buone e forti e non sarebbe da pensare che un nemico le assalisse senza una grossa armar», se esse fossero fornite aaltrm secondo il bisogno di sufficiente presidio e delle altre cose ncessarle; ma cosi r i è tutto da temere, perchè al nemico è facile assalirle » . (Cancelleria Min. Guerra per l'impero, aprile 1703, n. 316).
Sempre all'imperatore, ma questa volta dallo stesso principe Eugenio in data 11 agosto, vigilia dell'aaaedio di Breisach sono rivolte queste singolari e significative frasi in una « Memoria intorno alle condizioni delle armate imperiali al momento «Iella mia assunzione alla presidenza del Consiglio antico di guerra » :
« Ho giudicato di informarmi prima particolareggiatamente di ogni cosa, per potere poi con tanto maggiore sicurezza dare rapporto di tutto a V. M. I. I l luogotenente generale di Baden si è spesso lagnato che la sua fanteria sia tanto scemata che non basta neanche per i posti di Breisach e di Friborgo. Intanto fu rimedialo a poco, e sebbene il reggimento Salm e quello Mandigli non siano ancora caduti in penuria tanto grave, anche per essi
R. U u , U M IJt RIABILITAZIONE MILITARE
è imminente la miseri* non lieve eoendo Ano mi oggi rimasti •eDia i denari dalle competente
« Ite furto non una «Ielle piatte m i Reno * provvista di ba stanti truppe, provianda c maniaioni; In esse per giunta crolla la fortiflraaione e non ai provvede alrnn fondo per la ripara- tlotir Mlrcbè anche l'Armata di Vostra Maestà Imperiale che •ta nell'impero * aenaa recinte, senta rimonta, senta arredo, mate armata e p e n i» pagata, con le forteaae mal m unite». (1)1- bl lo teca di Corte. IV , 133. « Imp. Leopoldo » n. 16».
Le rondltionl erano gravissime, tali appaiono nel molti documenti dei tempo di «aria fonte rbe bo potuto consultare.
Non farà sorridere, e ridere addirittura, quindi il seguente pusao di lettera aU'Imperatore diretta «Ulto steaso principe di Baden. rbe eoi suoi inferiori si mostrava di ben altra tempra « carattere; è piavevotmente. ,. terribile il quadro:
« __* ae dalla Corte nnlla si manda, di rbe debbono ramparee dove stare te truppe? Perchè è impossibile — s'Immaginl pur» quel rbe si vuole — di trovare una is r rs lw s per mettere gli nomini e i cavalli altrimenti rbe sulla terra e mantenerli vivi con altro che non sia li mangiare e il bere... » {Campagne Pr. Eugenio, V, pag. Vii.
Dopo quanto sopra riportato è facile riscontrare nel verdetto della sententa una severità veramente ecresaiva e una parzialità rbe addolora pur oggi, a distanta di oltre due secoli e un quarto!
Questo per entrambi I generali d 'Arro e Marnili, ma sopra- tatto per quest'ultimo, rbe non era il comandante titolare e neanche il vice-comandante delia piatta di BrUaeco...
Ora. sta di fatto rbe la I>ieta di Ratisbona aveva deliberato rbe la Brisacro < si dovessero porre di stabile presidio 8000 uomini «d un numero di ottantaquattro petti di cannon grosso e otto mortari con tutte le loro attinente di munitloni, di ufll. riali. di artefici e d'altro ». Anti il principe di Baden « con auc- ecaaiva e più distinta ordinazione, ben*) riconoMie necessario per lo tempo di guerra il numero di presidio statuito dalla Dieta pià tonto maggiore, anzi specificò do vere ig li porre ancora mag f io r numero di artiglieri, cioè almeno 120 o 130 petti di cannone e dodici o quindici mortai e maggior quantità rispetti-
80 MEMÒRIE INTORNO A L. f . MARSH.I
vamcnte di ufficiali e munizioni; ma in tempo di pace giudicò sufficienti 5(MH) uomini di ordinaria guarnigione. Ambedue tali decreti ai leggono stampati nel libro che ha per titolo KuropeUce Htat» Cantzley a cari. 444 e cart. 445 ». Coni il Marnili nella mia Informazione a pag. 3 ; il quale nuli'oggetto tanto importante non ebbe »mentita alcuna, neanche da parte dell’anonimo autore che tanto l’attaccò vilmente con un di lui libello, che causò le lien note Posi il le ritponitire del Mar»ill.
Sul contegno di queat* ultimo abbiamo altrove detto; ag giungeremo (nulla »corta ili doc umenti comunicatici poco tempo fa dall’ Archivio di Stato di Vienna) che in un rapporto del maresciallo barone di ThQngen al principe Eugenio di Savoia datato da Fre.venthal il 7 »ettembre 1703 (cioè proprio v er»» la line deU'a»»edlo, atteso il tempo occorso per conoscere la notizia) è detto che c il Marnigli si tiene molto bene a Brei* *ach ». E pensare che sarà lo * tesso ThQngen a presiedere il prore*»©, che fu tanto criticato poi da tu tti! Ad annullare la sentenza del qual processo o ad attenuarne assai il valore giudicante valgano princi|mlmente le -tegnenti circostanze:
• I il non esservi da sperar soccorso;6) il pericolo manifesto della guarnigione: r ) il non essere sufficientemente presidiato di gente la
p ian a ;d i Tesser già formata dal nemico la breccia e non aver
•voto gente a difenderla;e) la mancanza della quantità necessaria degli ¡strumenti
m ilitari di ogni specie.Circostanze tutte rodeste, che emergono dai documenti sopra
addotti e che costituiscono altrettante limitazioni, legalmente previste, delle leggi marziali del tempo, all* articolo 43 dello Statato leopoldino. che cosi si esprime:
€ Quel comandante che anzitempo ceda una fortezza sarà punito di morte, e i soldati se complici saranno decimati, e i superai ti dichiarati infami ».
In relazione alle suddette circostanze o limitazioni, le quali sono a ll' evidenza occorsi nell' affare di Breisacè. siano tenute quindi presenti le chiose ufficialmente impresse nei fogli 63 e *»*
ft. u o a u m • LA HUSILtTAXKtMC M IL ITA I* 81
delle Leopoldine ■ rum «li gloriati d d l'impero tfra m i ai trovalo u h m Maldonnrr. luogotenente uditore generai«» net ptwraao di Bregenz a carico dcU'Arro. Marnili rtc.| le quali suonano coni:
1*1 Mi può rendere una piana quando vi manchino i viveri e che non vi aia piò donde prenderli ;
2*1 Hi pnó rendere una piana quando non vi »la da operare aorrorao;
3*i Quando ai vede«»* rke la piazza iu«len»e con la guarnì gione iinw# in pericolo;
4*) Quando la p iana non foaae «u (Udentemente guarnita di gente, o ewrudo faaae la gente ammalata o ferita o non p ii ia alato da poter «errire ; e rke il comandante non puteaae al tendere aorrorao ;
5*i Quando il «upremo romando non avesae «ufficienti- mente fornita la p iana di gente, di requlaiti e di tutte le co*e nrreaaarie K d ie II comandante della P ian a p»te*ae dlmoatrare di averlo per tempo avvertito per non eaaerne reo; altrimenti non potendo dimostrare egli ne aarebbe ré*jion»abilc;
9*1 Quando il comandante abbia fatto il auo dovere e non poaaa ««Mere incolpalo d i qualche errore;
7*) Quando le breccie fomero formate ed il comandante non avwme gente per difenderle e per reaiatere al nemico;
i**i Quando le munizioni e atrumenti m ilitari foaaero manrati.
He confrontiamo le ora «ielle limitazioni, ufficialmente ata- tuite. eoa le circo*lam e piò aopra elencate e documentale, facilmente «e ne vedrà la correlazione intima e la non giuntma della «eutenza emea*a. E tutto dò , ripetiamo ancora una volta, nd riguardi del comandante della fortezza che era II conte d 'A rco; perche per il Marnili non v è pur biaogno di riferirai ad alcune di tali leggi marziali o a loro regolari limitazioni.
• • #
Due documenti, non anche reai pubblici e a me comunicati in queatj giorni dall'Arrhivio di guerra di Vienna, provano ebe l ’innocenza dei Marcili fa riconosci a la, «ebbene in forma a ««a i
i
MEMORIE INTORNO A L. F. MARMILI
ristrettiva, dallo stesso imperatore Leopoldo I, che *u proposta del ron»iglio aulico di guerra aveva decretato l’ intituiione del prore«*«) fatuo*«.
Il primo, iofatti, di tali documenti, registrato nella /mitica Keld.Akten (róm. Heich.» 1703, X I I I , 53 a., riporta copia di una lettera scritta da 8. M. I. Leopoldo I al suo luogotenente principe Luigi margravio di itaden (nella cui giurisditione erano1 giudicatil datata da Vienna 24 febbraio 1703, in cui ni min tiona la parte della sentenza riguardante il conte d 'Arco e per il Marnili viene mitigata la condanna tino a dichiararla < priva dì infamia», pur »empre obbligando il giudicato alle sj»e*e prore «« nati__
L ’altro documento, anrhe più importante e ai tini di que«to •«•ritto veramente decisivo, contras«egnato negli archivi alla pratica Feld Akten (r««m Keichl 1704, I I I , 1, contiene l’originale dello «critto mandato dal pre*ideote interinale del Consiglio aulirò di guerra. L M. principe Enrico di Mann«frld, datato da Vienna 3 marao 17tM diretto al tenente mareariallo barone Thtìn- gen. nel quale »critto viene deplorato che già « i sia dato corso a ll’eaecutione «letta «entrata riguardante II Marnili e rbe perciò non «I po*«a più mettere in effetto l’ atto relativo di grasia e di dementa imperiale.
S tralicila ed ironia del protocollo di allora, per cui non era in potere del Monarra di annullare nna arti tenia iniqua, resti- tuemlo ufficialmente all'imputato la riconosciuta innorenu!
8. E. Il generale Margutti, rbe tanto « i è interessato della questione Marnili. ba voluto trasmettermi «rritta di «no pugno copta di tale importantissimo documento, il cui valore è per me dee lui ito per la riabilltaaione morale «lei generate Luigi Ferdinando Marsill.
Parlano abhastanta di«te«amente del disgraziato fatto occorso al Marniti a Rrrisacli «Ine noatri scrittori: Adolfo Alber- ta u i in Yaoc« Amtolngi* (fascicolo del luglio 19011 e Wiu- seppe Brucio nel »uo libro Luigi F. MmrtOi (Zanichelli, Bologna. 1921); ma tanto l'A lbe r ia tt i che II Brutto non allegano d o cumrnti probatori! circa l’ innorenta del Marnili Sembra a me che per tali » i debbano considerare I due documenti ufficiali
sopra r ila li ila mr, specialmente il secondo, che lmplicÌtauion«i* riconosce x 'U U reticenze l'inum-enia ilei Marnili.
• • •
Ciò cbe più onora il Marnili in «ulta la disgradata faccenda di Hrelsach è l'aver «v ii dlfrao non (là sé aol». ma prima <* »opra* latto il »no comandante conte d 'A rco , »ebbene f«w*e notorio a lutti e in ba*an e in alto (Uno all'imperatore! il dissidio con tinuo fra loro due *ui modi di predisporre a difesa la piuma.
Tarn’* vero che in data - settembre 17CKJ, t rop|M> tanfi per giungere prima deH'irreparahile, partivano da Vienna due lettere dirette: Cuna dal Consiglio aulico di « »e r ra al Marnili, l'altra «la H. M l*lmi>eralare al d’Arco, in col rispettivamente era In tono grave «criIto :
(a l Marnili t « H. M. desidera e aeriamente comanda che nei presenti tempi geloni, a riguardo degli « fo n i del nemico, il ai- gnor conte i Marnili i viva in bnona intelligenia col conte d’Arco, come all'incontro comanda al detto conte di far lo atenao con lui, e pacificamente convenire aero in ogni ocranione cbe appartenga al «erri*io di H. M. Ce*aira, ed in conneguenjta ni col conaiglio come con le opere d'accordo con Ini procuri che abbia effetto tutto d ò cbe appartiene alla difetta di Hreiaacb ».
(a l d 'Arcoi « Finalmente comandiamo e«l assolutamente vogliamo che nella p m ro le occasione. scordandosi ogni privato odio. disgusto et dispiacere col noatro Marnili, v'intendiate on ninamente con Ini. comunichiate fedelmente ogni disegno et “ gni opera cbe riguardi la difesa *.
Ma nella lettera arritta al Marnili vi era qualche coaa di più e per me di ben grave momento, perrbè fa ivi capolino il aonpetto ingiustissimo di tradimento mal velato alla Corte nei riguardi del d’A rro ; motivo non ultimo della di lui infelice fine. I>iceva la lettera tentnalmente :
• Che ne ella ( Marnili i con sicuro e reai fondamento scoprirà qualche cosa contraria al servido di 8. M i'e*area, con questa lettera «e Le d i facoltà di porre io opera ogni rimedio aAneb* i pericoli e I danni cbe ne potrebbero «ognire siano riparati e prevenati *.
B. KBUULUC! ■ I-* RIABII.ITAJttoNK M IL IT A R I H3
Ki* non che, vivaddio, di tradimento o di fellonia non si potè nulla provare ndl'istruttoria capziosa del procedo di Bregvnz a carico <11 nessun ufficiale e tanto meno poi del d 'A rco!
Que*ti fu vittima di tutto l'aml>iente militare e più politico del momento; onde pur oggi non ni può non fremere rileggendo< l'orazione ultima da lui pronunciata sai luogo del supplicio verno I’ bora di meun giorno a’ di 18 febbraio 17(M ».
Ureo le parole estreme del comandante:« Qui è l'imagine del vero Dio. giudice del Cielo e della terra
Kgli sa se io abbia o non meritato la morte. In verità qtian tunque sia raduto su di me un giudicio cosi rigoroso, lo accetterò per amor di Dio ron allegrezza e giubilo, perchè in me venga adempiuta la sua divina volontà, e nella stessa guisa che per dono di tatto bnon cuore ad ognuno di quelli che potessero aver avnto parti* nella mia morte, cosi prego l'A rb itro di tutte le cose, Iddio, (U quale spero di volere oggi in Cielo» che anche Esso
ad ognuno di essi perdoni; e nello stesso modo prego ciascuno che voglia pregare Iddio per me dopo la mia morte. Del reato ognuno impari a spese di un tanto generale e nato di stirpe nobile che ha »pe»« piò di 30 anni in render* fedeli servizi a 8. M Cesarea, qual finalmente è ridotto a troncare I suol giorni; impari diro che in questo mondo ogni cosa è vanità fuorché il
servire a INo. cornerh* Iddio solo rimunera infallibilmente e fedelmente I meriti di ciaacono.
« Ma principalmente ed in primo luogo desidero alla He renim i ma Cn*a Austriaca ogni buona sorte in terre e benedi alone dal C ielo
Inoltre mero mando alla clemenza del nostro imperatore la mia a instimi ma consorte e i miei orfani Agitoli ; e ciò con tutta sommissione ».
Colpevole un uomo che cosi parta?
• • •
lai sentenza di Rregenz suscitò sdegno ed orrore in tutta Europa. essendo universale la rinomanza di eccellenti generali
84 MKMoRtK INTORNO A L. T. MARMILI
K. K K ttlA X I LA RIAHILITAXIOXK M ILITAKK «5
dei due italiani conte Filippo Arco provenienti- dall'arm a di cavalleria e conte Luigi Ferdinando Marnili da quella del genio. MoltUalme furono le attentatemi di «tima e di «impatta per i due d lagra ta ii ufficiali. Co«l ai «piega come in m oltiatm c pub. bliraxioni »loriche ricorrano fra«i che accennano all'innocenza loro e «opraiatto «lei Marvili; del reato anche la critica «lorica piò recente tende ormai a riconoacere la non reità nel fatto |«t il Maraili, oltre che per il d’Arco.
N d l'o ttim » « pigiommrio biografi™ », compilato da una «o- cietà di letterati nel 1791, fra l'altro ai legge: « A motivo della «ucce«aione di Kpagna e«aendoai accesa nel 1701 una guerra che poae ad inceadio qua»i tutta l'Kuropa, l'importante p iaua di Breiaach ai arreae per accordo, aotlo cond iton i per altro onorevoli, al duca di Borgogna, dopo 13 giorni di trincea a {»erta, m i di 6 «ettembre 170CI.
Kra comandante il conte d 'Arco e «otto di lui Maraigli, (iene- nulo allora a) grado di generale di battaglia. Kimaato «orpreso
l'imperatore «la una «I pronta capitolatone nominò <|<-l giudici, i
quali condannarono il conte d’Arco ad enaere decapitalo e Mar »¡gli ad eaaere depoato ila tu lli g li onori ed impieghi col venirglirotta la «pada «ul domo__Hi pen«ò molto generalmente, e conragione, che questo giudizio non fo « «e che un e ffe tto di quella raggiratrice astu ta che «noi chiamar»! politica, perchè la corte imperiale, a coa lo di aacrillcare gli innocenti, votante «altare l'onore ilei principe di Haden comandante in capo.... Luigi X IV remlette più giustixia al conte Marnigli: avendolo veduto alla di lui Corte aenxa «pada. gli donò la «na propria, a««iciirandoio della aua buona g ra z ia » (voi. 17*, pag. 213l
Nel l>ictiommmirr mmirrrtri d'hisloirr, ecc. del Bouillet, edito d a in i achei t- io Parigi nel IS76 a pagina 1199 ai legge a ri guardo del Maraili: « fu per merco di una aenlenxa di una «e- verità estrema condannato alla degradatone ».
Nel \cmrrmn l/Orom+*t Tome S. pag. 965 ai legge : « Ingiunta mente condannato nel 1700, dopo aver difeao per dodici giorni Bri«acco contro i francesi, alla degradatone ».
<!ià Cesare Balbo nei ttommmrUi drlla i/wm d'Italia (ed IMSft. pag. 353i era «ia to esplicito: « fu indegnamente condan
MBMORIB INTORNO A L. P. MARSH.I
nato da un Consiglio (li guerra per la perdita di Brisacco, ove militava » .
Taluni dei documenti, che in questo scritto sono citati e in jiarte ritrascritti, mi furono comunicati da 8. E. il generale barone Alberto Margutti (ex aiutante di campo dell’imperatore Francesco Oiuseppe prima e Carlo poi) che personalmente molto nì interessò della questione in esame, e del quale mi piace qui riportare nel testo originale italiano la flne di una lettera a me diretta sull'argomento:
« Da ciò che io lessi in questi giorni snU’evento di Alt-Brd- sach nel 1703 lo mi formai la seguente opinione. Il Marsili, che era famoso ingegnere, voleva già mezzo anno prima che la fortezza fosse assediata ila! francesi metterla in perfetto stato di difesa e bensì approvvigionarla per sostenere anche un assedio abbastanza lungo. Contrariamente a ciò 11 comandante della fortezza ten. Maresciallo conte d’Arco, non accettò nessuna delle ben ginste proposte del Marsili e non fece prendere alcun provvedimento. Perciò avvennero parecchi alterchi fra I due comandanti: ma il Marnigli non ebbe ragione e non fa in caso di vince re la letargia e l'opposizione del conte d’Areo. Quando però la fortezza venne assediata dai francesi ed in pochi giorni accerchiata completamente, 11 conte d 'A rro pretendeva che il Marnigli facesse tatto ciò che questi aveva già da gran tempo proponi». Ci**a allora assolutamente divenuta impossibile perché non si poteva introdurre piò nella fortezza né materiale di fortificazione né viveri oltre le linee dei francesi 81 capisce bene che il Marsigli. tremendamente disgustato da questa situazione da lai chiaramente preveduta, si esprimesse pure, in momento di aro ragliamento, per la rosa della fortezza ai francesi. Ed in ciò costituisce secondo II Consiglio di guerra la colpa del Marsigti; il quale veramente era innocente. Ciò fu anche piò lardi riconosciuto dall'imperatore Leopoldo I, il qua)«» d ifa iti mitigò la condanna a semplice congedo: ma le pratiche di «Cassazione » erano già state effettuate e non si potè, secondo le idee cavalle reache allora vigenti, piò renderle nulle. I l Marsigli dovette adunque portare tutte le conseguenze delta « rateazione » ed i loro effetti sociali ».
R. RBOGIAMI - LA RIABILITAZIONE M ILITARE 87
Da copia <!i documenti favoritim i dallo «tesso generale Mar gutti, ho potuto trarre una parte. seppure indirettamente impor- tante al Ani di quatto acritto. dello «tato di servlcio militari* del conte Marnili e precisamente quella che va dal conferimento a lui del 5!r reggimento fanteria al giudiiio marciale di Bregenc. Eccone i punti «alienti:
Con patente del S febbraio 1 t t t gli è conferito il 5tt* regg. fanteria imperiale. dopo il di lui ritorno dalla prigionia nella guerra contro i turchi.
I l 3 maggio 1*593 egli «i presenta al reggimento a Rima Hcombatb e insieme con m u partecipa alla campagna di guerra di qaeU'anoo.
Verso la 6ne del 1«#3 * promosso provvisoriamente a DiretIo re del Corpo degli ingegneri al poato del generale ingegnere, caduto.
Dal marco l*a»3 ritorna a comandare il suo reggimento.Durante la campagna 1*»7 ai trova al quartier generale del
principe Kugeuio quale Capo del Corpo degli ingegneri militari.Il 31 maggio l«;!*s. nuovamente torna al mio reggimento,
e nel DUMI è mandalo come Commissario per la conclusione della pace, indi come commissario per la delimitacione del confini dell'impero.
I l 18 settembre l'Xrt*. dopo aver assolto tale incarico, fa ritorno a Vienna.
In data 24 gennaio 1700 è pr«»m»«»<> maggior generale (o generale di battaglia» e diviene preaddente dell' ancidetla com missione dei confini. In tale qualità egli ha l ’incarico di proce dere alla demolicione dei vari posti quali risultavano di«egnati nel trattato di pace.
Nel settembre del 1701 torna al comando del reggimento, e il 14 maggio 1702 da Scegedin si trasferisce all'armata del margravio di Itaden.
Nell'agosto del 1702 è comandante di una brigata di prima schiera del F. M. conte Herh»tein.
A lla fine ilei 1702 si porta col suo reggimento a rinforco del presidio di A lt Breisach. di csi è comandante il tra. maresciallo conte Arco.
8® MEMORIE INTORNO A !.. F. MARMILI
Da questa (lata il documento reca interessanti notizie che qui trascrivo in traduzione fedele, quasi letterale. Dice il documento che fra il Marnili e il comandante della fortezza vi erano frequenti divergenze, poiché il primo voleva veder meglio curatoIo stato di occupazione della fortezza.
« Dopo l ’inceatimento di Alt-Breiaach, iniziatoti ii 16 agitato U Horaigli fu l'anima della difeao. Il 6 settembre ebbe luogo al completo un consiglio ili guerra, nel quale anche il Marnigli ni pronunziò per la capitolazione: questa segui 1*8 settembre.
Marnigli fu tratto in arresto insieme all'Arco, e con altri uRiciali condotto a Hregenz dinanzi ad un giudizio marziale.
Il 4 febbraio 1704 fu condannato alla degradazione mediante rottura sul dorso della »|>aila fatto dal Itola, e al rimborso delle spene processuali.
I l 36 febbraio la sua condanna fu confermata dall'impera- tore, però irnzn infamai. 11 giudizio essendo già stato eseguito, non potè aver lungo, come l'imperatore voleva, l'annullamento della sentenza.
Il giudizio marziale tenne le sue sedute nell'osteria del Leone in Hregenz, presieduto dal F. M. barone fa r lo Th angeli.
Le deposizioni dei membri erano in generale favorevoli al Marnili, ma fu causa della sua condanna l'aver egli «•»presso per iacritto il suo consenso per la capitolatone nel consiglio di guerra di Rreisacb *.
• • •
Abbiamo pià sopra riportato varie lettere del principe Eugenio dirette al barone Thttngen. tutte innistenti nel volere una condanna che restituisse esempio nell'esercito. Come interpre ta»*»e U senso di quelle missive il Thfingen, incaricato di preaie dere il pro cesso, è facile immaginare appena si leggano queste poche righe che dipingono l ’uomo e il soldato, ncritte dagli sto rlci delle t'mmpngne del principe Km genio :
« Nel Thùngen ni riscontravano le caratteristiche del soldato di quel tempo. Di mente acuta, saper lati vomente valoroso, proo to ad ogni audacia e ad ogni rischio, con ferreo rigore voleva
R. REO.IAM • LA BUBILtTAZIONE MILITARE 8»
mantenuta l'obbedienza assoluta in aervizio, coni « Ih- il muo ab i
tuale « Quant'è vero ohe mi cklaoKi ThQngen ! » Im itava a fa r ette gu ire i »uoi ord in i in ogni caso » . (Il voi. pag. UU.li.
K la condanna < impunibile ». pubblicala a Hregenz, contimi l'esempio deRiderato!
L ’effetto di tale giudizio nei riguardi del Marnigli fu non nolo militarmente disastr«»o, ma anche deleterio negli a ltri rampi de ll' attività »uà. nei quali più aveva brillala 1* opera del dolio e dello scienziato in aervizio dell'impero. K non meravigli c iò !
Il paaao che aegue, fedelmente ritorta lo dal voi I. pag. 16? delle Campagne di guerra del Pr. Eugenio, ne fnrniace la mira bolanle misura, veramente auRlriara, anzi aulica, per la menta lilà del tempo a cui ai riferisce :
« Nel IfiOH il conte Luigi Ferdinando Maritigli poRto, come plenipotenziario imperiale, a capo della <’ommi»Rlone regolatrice dei Confini, fece tu lio il possibile per raccogliere materiali per coRtruire una caria più enalta dei paeRi dTngberia ; al quale Rcopo gli fu dato un numeroRo Reguito di ufficiali ingegneri e di matematici. In fatti con numerose miRurazioni e ricognizioni riuRci al Maraigli di raccogliere copiosa materia; di cui però,
per mala »u rte , non fu fa tto uro estendo i l M arn ig li m u ta to dai
ru o li in teg u ito a lla re ta d i Itre ita rh » . (Rich !(.
Questo lo Rpirilo dei tempi di allora, onde veramente al co spetto del mondo il Marnili dovette eaaere considerato come un indegno !
Oggi, sulla «corta dì documenti ufficiali, che qui in gran copia bo riportato integralmente o riassunti, si «limosini in tut
ta la Rua iniquità la non giuRtezza della condanna Ria per il rapo conte Arco sia per g li a ltri ufficiali in aottordine, primo fra tatti II conte generale Mandli.
A dare un’ idea detta infondatezza ed empietà di tale sentenza
e lio II fatto . R inlom alico in té e non mai per l’addietro avvenuto
uè dopo nell'esercito imperiale, che gli ufficiali aggiudicati ai r ifiutarono di rico noncere il giudizio espresso a loro carico nel
verdetto di Bergenz. La coaa fu risaputa dall'imperatore me de*imo che ne parla gravemente nello » c r i i lo da me ricordalo
9 0 MEMORIE INTORNO A L. V. MARMILI
più «opra in data 24 febbraio 1704 diretto al margravio di Kaden (F'eld Akten ròm. Reich. 1708, X I I I . .Vi a.):
« Ilo appresto inoltre ohe, come V. A. mi »crive, quasi tutti g li uffleiali della guarnigione ricusano di rispettarla (la *en- tenta] e che ciò ol trapaniti ogni limite cannando l'indebolimento della dinclplina dell'Armata ».
G li è che il modo, onde era ntato condotto e istruito il prò cetmo a Hregens, lese apertamente le più elementari ed umane norme del regolare giudicare^ Luigi Ferdinando Marnili ne fu come schiacciato »otto l'onta nenia nome. A l suo generoso e forte animo e più alla mia condensa che lo rassicurava sotto l'usbergo del Mentimi pura, ai deve ne egli non commise atti e genti gravi, l quali in ogni caso sarebbero ntati giustificabili« itimi, avvento all'antorità militare e alla Maestà stessa dell'Im peratore una volta che egli ne era ntato allontanato, anci « ca» nato » nenia pietà.
Abbiamo fatto parlare in queste rapide note più i documenti ufficiali v «idricamente «Icari (con attenta pa*ieuia compulsati* raccolti) che non la no«tra appa»«ionata anima italica, acerba mente ferita «locome ammiratori del grande bolognese.
Saremo |x*r avventura rluncitl tediosi e pedanti. Che impor ta? Abbiamo perà una buona volta e definitivamente « provata » (questa è la parolai la piena incolpabilità Bell'affare di Hreiaach tlel generale Marnili; rrdimendo con lui l'altro eccellente gene m ie Italiano, infeliclMtim», conte Filippo Arco.
Per noi d’ora in avanti l'ombra, che avvolse 11 generale Mar « ili. lui virente, per coni lungo ordine di anni, è dissipata per sempre.
I documenti, dei quali taluno non fa nemmeno prufferto a Ini dopo la condanna, restano monumento inconfondibile e perenne a testimoniare per tutti g li italiani e per tatti i g ra t i
luomini e m ilitari di ogni tempo e di ogni paese la bella ed invitta innocenia. unita alla più generosa nmanità di citta, dino p di soldato, di Luigi Ferdinand« Slamili.
lMc«na. 13 «(«••«o 1900 «Vitti.
Tea. Col. R o m K k »,u s i
Il Generale Marcili e la <lif«**a dello Stato ]H »n tifi< * io
nel 1708 - 9.
r ia * (fello «lutilo . Fatatiti del conflitto tra Impero e papato . tKTTj parino» di Comacvhio ■ Mire e | iM n r acuirla eh» «iiH 'Iu lla : ln*vrt»**a W l i •ItoatlnDP militare In Italia nel 170*. • Arrivo 4*1 Martin, «tw prlm- dlapoalrionl t> andata a Roma • Febbrile o|*ra di orgnnluarione con piata a Roma : condizioni deH’eaerrlto. • Ritorno In Romagna, attriti eoa 11 begato * il Reggimento: dlaa*troaa «Ituariooe dell'esercito * <lfl lavori : suol propositi e doloro«» prrrWIoal. - l/avanaata au«triaca e la ritirata per pro le«**** la atrada di Roma : trattative: la pare del 15 granalo 1700. e le preteae Imperlali. ■ M icaela dell'opera del Maritili• Aplteodirr
La carriera militare di L. F. Mandi! percorsa per più di rent’ anni in serriilo «feir imperatore, con pericolone avventure e rapidi avanzamenti, ma (ragl carneo te troncata a Rri«acb. do rea chiuderai al «errigio del papa, in ufficio meno brillante, ma almeno dedicato alla difewa del «no aorrano e della «uà terra natale, fc noto che quando le truppe cenaree, occupando Co- macchio i maggi" ITW i parvero minacciare l'inraalone dello Htato pontificio, in parte effettuala pochi me*! dopo, il papa ( 'le mente X I (*l. F. Albani di Pe*aro, 1700 7211 incaricò il Mainili di organUgxare la difena con l'ufllrio di Hergente (fenerale, che egli tenne dal giugno 1708 al m ano 1701*. Nel 1715 poi. arendo il papa dichiaralo di voler aiutare Venetia nella lotta contro il Turco, al Mandi! fu aOdata la difesa delle «piagge adrlaticbe contro possibili incursioni turebeaebe.
Il carteggio del Mandli di questi anni. con«errato con cura melicoloM. le numero«* piante di forteue. le mappe di tetri
92 MEMORIE INTORNO A L. F. MARMI I I
torii, i memoriali e progetti di regolamenti militari, di rafforzamenti di piacce ecc., che rimangono fra le carte del Maritili, oltre i carteggi del Menato e delle Astanterie Bologne«!, del Cardinal Legato e del Segretario di Stato card, Paolucci. offrono un vasto materiale per arguire l'opera ana e conoscere le condizioni di abbandono in cni era In Btato «otto l ’anpetto m ilitar«, e le difficoltà incontrate dal Marnili per improvvisare con quel materiale, qnei soldati e specie quei collaboratori, una difesa modesta contro truppe agguerrite e baldansose per la vittoria. Ma pii! che analizzare la cam|>agna del Marnili, eoa) poco brillante aenza ana colpa, o inaiatere ani particolari m ilitari, è mio proposito mettere in rilievo la serietà dell'opera ana, le canae generali e locali che influirono aul ano rianltato, ed etta minare ae, malgrado tatto, m m « rinac) di qualche utilità nei rapporti fra il Papa e I* Imperatore.
* • •
La condotta di papa Clemente, che ai gettava in un conflitto con l'im pero, proprio quando la Francia appariva battuta e ridotta anlla difensiva, l ’ Ita lia era abbandonata agli Austriaci e la aorte della guerra sembrava già decisa, può apparire leggera, e poco avveduto anche il generale Marnili *, che lanciava gli osi studio«! di Francia per assumere il romando di un’ impresa già destinata a fallire, moaso forar più che altro
• IT qnrrto » telarti»!» rbe ha dato 11 primo Mocrafo del Mandil. U f à W i i t Ita Urawrif è ri la rito è ri On. V tru fli Rotocs*. 1770. p 239) e c l » * sfato senile l«>l da Utili Rii altri : « Lo sa i » » l'iavllo : vi Arre qua fa-h* riàessiim». ma aoa tanta qoaats poteva 0 tao lotrwdlmeatn. » corse taaoHMÌialaa>rnt* a Uosa* rialo dal dosete di «addilo, dai Mane di n tn » . r dalla «wa |aw kar ; » f firm i R i « ( u rxmfrmmrr. rW questo aoa * il poaio plà lamlaooo della «ila drl IV r MaoKtl Capo di oa >«T rito «mta dtsrlpUaa. H «* ih I* Io d armi, e ra t in a i. (U * pia M- « 10 « di p n d w a che di rorawto: OarW ani U Gvaaala ire* * n i la pare fra li IVateflre e llm ien iliw : e II r « » da cao <k» f i » » 1) Mante li da qariia rarira. fa la w n w lH di d ow ri rissarlarv- jwr --arralraia. « «a le rfce il Geaefale I*aua led w » «triacera n a ««a i maaiera di «m- aeaylo » di mina ori» il puaieàee. iwfrfc* lo tirvaria««r dal «ao «rrrltia.
U SIM BOM I.A DIFKMA t>CU» »TATO POKTiriC IO 1708!« 93
dal muo rancore contro gli antichi compagni <l' arme, che l 'a v e
vano coni ingiustamente trattato. £ innegabile che questa è la impressione che si riceve da un nauti' sommario dei fatti specie
avendo predente i risaltati ottenati. Ma questa impressione — come «|iia*i sempre i giudici affrettali e semplicisti — è Ine natta pii ingiusta, perchè dovala a una conoscenza poco precisa e dell’origine del conflitto e dei suoi risultali, come della situa aione politica e militare di quell’anno, che noi ricostruiamo sulla hase degli eventi posteriori, mentre, per spiegarci i giudizi e le decisioni prese allora, dobbiamo cercare di vederla quale ai presentava nelle sue possibilità nella primavera del 170H
Tre sono i rilievi su cui è bene insistere per comprendere
e valutare con equità la condotta del Papa :1*) I l conflitto con l'im pero era inevitabile per il papato
che si era compromesso verso la Hpagna già a ll’atto della successione di Filippo V.
2*) La questione per il papato era diversa e più grave che per gli a ltri principi, non trattandosi *olo di vessatlonl, esazioni,
occupazioni di terre, ma di un grave spostamento delle sne relazioni politiche per il nuovo insediarsi dell' Impero in Italia.
.T*> La mossa papaie fu giudicata non ridicola e leggera ma grave e pericolosa sopratatto dagli Austriaci e dagli A lleati, che bea conoscevano la debolezza della loro situazione generai», specialmente in Ita lia
Clemente XI saliva al trono, il 23 novembre 1700, quando
da pochi giorni, con la morie e il testamento di Carlo II , ai era aperta la crisi delia successione spagnuola, e già in Curia appariva prevalente il favore per la successione borbonica. Inno
anelilo taM Irvw at* 4a f « M > sflfcrr. ts m i t'scrrs posto, come «I * M in «a trssporto 41 ««a lo per Itam i— »
Asdbe 0 parttroter* dal U n a m a c t i » Imposto dal O tta ooa » «san o; U » lU U fto di Mala. Osrd. Psolood ts ssdodera la t e a m al Martin •tei m an » ITO» i Vm. MrnniU. LX X T» , fu lai s rfcM sr* Il ooogsdo plft lardi
94 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSII.!
renio X II 1 avea confortato Carlo I I nel pensiero «li mantenere l ’integritA della monarchia e a»Megnarla al duca d 'Angiò: di più Clemente XI «la Cardinale era stato parte importante della Commissione Catti (milizia che uvea consigliato il Papa in questo senso : e non era uomo «l'animo debole e «li scarsa esperienza d iplomatica, come vorrehb«1 il Kanke. sì «la essere più a«latto a seguire un impulso giù «lato che a sostitu itene uno suo (terso- naie che foM»e in contrasti! con i »entinienti dominanti in Curia. Inoltre, anche se i) papato non si fosse già compromesso con i consigli a Carlo I I , era difficile che fosse proprio lui ad impugnare il testamento del re, i|Uando le potenze europee parevano, al primo momento, «lisposte a subirlo. Clemente riconobbe quindi Filippo V conte re cattolico «li Spagna, ma non di Napoli e Sicilia, come fecero del resto in un primo tempo Olanda e Inghilterra : e, quando Analmente scoppiò la guerra, cercò invano di essere paciere, ma non poteva ritirarsi dalla posizione presa, specie vedendo l'arciduca Carlo, pretendente al trono, sostenuto •opratutto dagli 8tati acattolici di Inghilterra ed Olanda, oltre che dai principi p ro fe tan ti dell'impero, come la Prussia che si era Innalzata a regno nel 1701 malgrado le proteste papali. Di più nel primi tre anni pareva sirara la vittoria francospa- gnoola. la quale pareva allontanare daU’ Italia II flagello della guerra.
Ma quando ctiminciarono 1 rovesci francesi in Fiandra e Baviera e, dopo la vittoria di Torino, si ebbe lo sgombro dell’ Ita lia nel 170?. cominciarono le vessazioni imperlali: attraverso il territorio pontificio si dovettero lasciar passare le troppe d irette a Napoli, con i danni soliti, ed un vero conflitto scoppi/, per Parma, avendo U papa. U -7 loglio 1707, dichiarata nulla
* Risa* ; IN r rnmùràrm t la 4rn 1*1 U n i rive fttàràmmérrtrm. II131. Lipsia II Raake rilava a x s lifsa «Mia h u agenasttaa» lairWaiMHM «M l'anb. > m < « Marcata! del 1107: U O m in i la fffa4M n i ¿ «a ltera la 4i Cirmtrmlr X I 4« Arvfclvto «M ia R Sorte«* R o a a w 41 Otaria Patria ». I*<*. XX I. p M ) ha d lacn trsi» r o m a n i » la « m . Qaert'operapnferole i (badala «a aao sp««tlo copkws M <i ’«a ia ll d lp loaa lk i vatkaaL Riguardo al Marvin vi * p*»A ItnaSirm
U MIMCOXI LA ttir rn A t>KUx> «TATO PUNTINCIO 1 TOH il 1)5
una conventlone » i r r t i i il 11 dicembre 170« Ira il Ma re beat* di l*rtè, <'»m mi Mar i<> imperiai«* in Italia, e il I>uca «li Parma peri quartieri d'interno delle truppe imperiali in cui era previata anche una rontrlbutlone degli cccleaiaatici per 21.2AO piatole. Ka arrido qu«nti rlcond al papa, «'»me alto Mlgnore del Durato, quarti la dichiarò nulla minacciando la acomunlra agli invaaori *.
La rlapoata ufBrlalr deH'Imperatnre, rhe negata «igni fondamento alla pr»ite*ta, rivendicando I tocchi d iritti im|ieriali au Parma e Placenta e infirmando || valore «Ielle renaure ateaar, «I fece appettar«* quaai no anno * (giugno 1 “OHt, ma non già i »egnl di malcontento, come I divieti di Inviare denaro a Roma ; il pi«1 grave di cani fu l’ocrti pallone improvvida di ('anurrh io che pa
reva voler far risorgere a profitto degli E»tenni la questione non mai aopita di Ferrara. Il duca Rinaldo d’Rate, che aveva avutolo atato occupato dai Franerai, viatoal trattato da m i come ao* petto, ai era rifugiato a Ikdogna, dove rima a«- dal 1702 al 17»7; rientrato a Modena, rioccupata II 20 novemlire 170« dagli Imperlali. ■'•ime avea ottenuto la facoltà <11 acquistare a ca ri» almo pretto Mirandola e Concordia, mnflacate al Pico, coal certamente ricordò all'lmperator* la queatione «Il ( ’«»macchio, eh« come feudo imperlale non doveva eaaer conducalo inaiente a Ferrara nel 159* * Ma in realtà Comacehio fu per l ’ impero aolo un
* [ « U a a n n i l *m mir t i pomr •rrrir a r kutoirr da X V I I I » M e . Ala 1TTT. V . e BmlUrimmi Clraaealia XI. Roma». MDCCXXM. p. «7.
* f i MaaUaato laqwrlale la Da I-im bkstt. op. cU „ V, M . Il leato latteo la n g tatui« M em ori*. l .XXI . BM (BibL tn lr«Ta llaria di Ho- U «aa»
* E" laii r w m if ricordar» rbe Rinaldo era «tato *IA cardinale a atta ael l « 6 rtaaDctalo alla porpora per aamdrrr al nipote Praoceacoll ■aorte ael l<W «rata prole.
l u carica* rnmaegneara di «weaio Mutano dorale a Bologna al col* !*tta allopwra del Ma c i 11 che. nei •»< Matura I70H. veniva lalerrotptto dal pmfcfeute del Monte di l’VtA di BoUpa per aaprre <*r oaa al don* a far» d»Q*anprai»r1a del Data di Modena, l a v a t i « p tr 40 000 aradU, ea- »anda «cadalo U lavmlae. Il Marnili rtapoa» « t » al r»od«aiae (lettera al Orni Paolanrii e ixad por* ordinò 0 Paola«*. sta al può credere
9 « MEMORIE INTORNO A L. P. MARMILI
mezzo per minacciare il papa e guadagnarsi con vane promesse gli aiuti |>ecuiiiari degli Estensi '.
A i primi di maggio del 170» arrivarono da Napoli due reggi menti di cavalleria che parevano dover andare in Piemonte e invece ni fermarono a N'onantola. « M olti furono i Lunarii, dico il Muratori, dei curiosi Po litic i e non minori i sospetti degli Ecclesiastici in Ferrara che ¡wrciò si diedero a preparare magaz zini ed armi *.* E non a torto, perchè il 30 maggio queste truppe unitesi al Finale con altre venute da Mirandola sotto 11 romando del m. generale co. Bonneval, entrarono nel Ferrarese, dicendo di voler foraggiare e, invece passando nei pressi della città, ai portarono a Tona dove il Bonneral ricevette l ’ordine dal gene m ie Visconti, comandante della Lombardia, di aspettare a prò cedere neH’occupazione; ma. ad invaaione già avvenuta, il Bonneval giudicò imprudente arrestarsi. Kgli divine le sue truppe In due colonne: il tenente colonnello Valmarode con 400 cava lleri seguendo il Po di Argenta al portò a Lungaatrino il 22, requisì barche e 11 24 sbarrava nella penisola dei Cappuccini a Cornacchie ; il giorno dopo 23. vi arrivava pure U Bonneval, rbe avea segnilo il Po di Volano, ron 3 » barche. Il presidio ni ritirò, e il 3 giugno «1 arrendeva anche la Torre di Magnavacea che era vera« il mare. Il Bonneval impose ai cittadini un giuramento di fedeltà all* imperatore, collocò sulla torre un’ iacrizione coni
eh» eoa la minaccia di on'larnsioaa ■ a»triaca, rfc* reaira da Modeaa. m d ai sarà osato trattar* arroado 1 ri »ori de*li Statati dei Monte U daonle debllore. <«M. VarWM. t.XXIt. Blhl fa i* , di RolofM).
* P «o;«rrfluo ricordare la t o Ii i b ì m m polo atra i ni prenatali tra Xodraa e Rosta per •taWllrr a» f a n retilo rra frodo Imperiale « papa Ir. arila qoalr Ir raffice! M I' Imper» e di <’a«a d'Estr Mimo « s t r aatr dal Muratori
t JaJiHbfM ealraai. II. » » Nella r « a H r « M rrtmrtp* K m+ rmim, X. I * è detta rfce I dor rectfatenti erano M ntatf • Vefciea eoe IW b nllir m del n « t di cavalleria Battali * Racnrlo*» e t « fanti M reo. Wartrcabrrt : I Im t««w ori Feminwe <arM » arr*««to 0 10 maggia, maII Marateri rbe dà le akm* dora» per tk n o pceeta» H » il r « Boa aerai era uà colonnello ftaarvw diserte**. cfce pi« tardi. «aantaUnri n i Itine Rilavalo. pnm& in «erri*!« dei Tor> h: H»>iadnM aamtfmaao : mori come tate nei 1747,
L «IM B O X 1 l a o i r é « « t * i . u > » t a t o p o v r i r i e i o 170K-1» 97
memorativa deirimprraa. rimando la ravallerla. tr«it<-nri<* la fan terla e mi«.- io «ta lo <11 dlfcoa la plana.
Immediata o vivare fu la proteata del |iapa r i volt a non aolo aH'imperatore. ma a<l altri aorranl o peraonagKi 1 e neH'abbor ramento arremato ira U marrbeae Prioro (P r ié l* r II cardinal* <*aM)tii Irgato <11 Ferrara, il 4 Itigllo a i ’arrlumaro. queat'ullimo, richieae la renlituiiono <11 l'omarrhlo rom«- ron<IUIonr «tac t/na M a per tra lla re.
Vlato rattrgg iaarn io riaolmo <lel |>«pa. II itnvrrno Importa Ir rkorrc a añoro « <*a*jul«nl: II rardinale iSrimanl. vlr*>N> a Na poli, prolbiaro le aped ilion I a Roma delle rrndllr <loi boneflci <loi cardinal!: a ana ro lla II 7 luglio II papa ordina al vearotl ñapo Iota ni di aromnnirarr g il u ftciall cbr eargulaaero I arqueatr!: r io * || goreruo Impértalo ai moatnava doclao a rlcorrere a nuore formo di prwrioa# per r lu m r la reaiatenia |<«pale. o fra qiaeate la plA orvla potora nombrar* locrupailono di ouorl lerritorii an m i ora farílo pwraw noi rirordl deH'impcr<> medierale dril* nuore p re ln », mentre lo eatoroioni o requlaizloni arrebbero aol lévalo l'eaauato ora rio I tapónale
• • •
Quando llotuonio XI reaglra coal riaoluiamcnte ron tro i mal traltamonti imperial!. ora giuatamonto preoceupato non aolo di qur«lo vo«»aiioni. ma bou pin dolía grave diminuciono di po torna e di libertA política che volea dire per il papato il rllorno dell’ impero in Italia. Veuiva roal a reamare quel aero lo <• n in io di pare di rui II papato a vea goduto per la política In fondo
• BmUtrtmm r t l , p 470 t «rtct U l l r r r nwaioJII furooo loríale alio N w n ir t r t . t i é H i e rwnaaio. al < '« f »a M ir Imperlale II acanita p. la- iW Uwtto R IvdS . ai rr 41 Pwrtagalla o Potaula. al d o n <11 Marola, alia RafmMMIra V iaH a, a nn ltaa lt e reatorl 41 <imnanU. al « r a o Mai-^ru 4rlf<m llao O nnw l l a t M a X. aarfce r u a e n u X I : E p u io ltr n flnrim
*o«. Hasta 173«. r«IL 4.* Em ole Tarta*«!*. a iK tM a r 41 Prlero. («o to a lIX to ro col notao 41
P rt í i ara p l— a a l»n 41 Chiart l U d ipto auliro aabaudo paaaalo al «ar- * W o hatarla lr. Ha lal G . r u a m i «a lia Urftkmr a Kom* M / T W / | *ri U*t 6 . M o a . < U io ro a lr U i c a i r n » . IM 7 , t IX .
» 8 MEMORIE INTORNO A !.. F. MARNILI
ileferente della Ca*a di Spagna, che l'avea protetto contro le minacce esterne e specie contro le prepotenze ili Francia. Ora questa condizione era tlnita per wmpre, perchè la vittoria franco- spagnuola voleva dir«* cadere nella *oggezione della Francia, mentre la vittoria austriaca »igniflcava aver addotuio l'impero con le vecchie prelese risorte, e una dinastia, che, |*er (pianto cattolica, era troppo in rapporti con »ta ti e principi protestanti, alleati o «udditi. per non e*«ere pronta a lanciare ogni riguardo verso un papa poco r«*mi«*ivo. I l ricordo del 1527 era predente tanto a Vienna che a Koma.1
Non biaogna credere poi che l’ intervento austriaco in Italia fosse in servigio del candidato aimtriaco al trono »pagnuolo, l’arciduca O »r lo : 2 per quanto sia poco noto, è pur vero che l ’ impero intendeva richiamare a *è tutti i dominii «pagnuoli d’ Ita lia : quella spartizione di casi che fa fatta poi a Utrecht per la morie di Oiusrppe I, era già prospettata a Vienna (In dall'inizio della guerra, sia pure a danno del re astiargliene ( '« r io I I . L ’ Italia dovea in ogni caso diventare austriaca, e a Barcellona. nella corte dell’Arcidnca, si guardava con «ospetto l ’intervento austriaco a Napoli e ai intrigava per impedire l'rae cuaione di questi piani ben noti, donde un conflitto tra le auto, rilà m ilitari che facevano capo a Vienna e il rappresentante di Carlo U card. Ortmani. Le sconfitte francesi, l'abbandono dell ’ Italia avevano fatto risorgere idee e pretese come ai tempi di Carlo V : g li eserciti imperiali intendevano di vivere a «pe*«* dei Principi italiani * non per un diritto di guerra, ma per do vate prestazioni fendali: g li »forici austriaci delle campagne
1 Alla I4 k i p r a i s N ni crolla • BatUfcnaa ad «toga» ITO*. Ila - prralor* 0 « « voi»»» un decreto la cal si dichiarava abvdto In ai» Brio 41 Napoli al Papa et» m i dipende» a da Ivi. 41 «oter rientrare ari diritti dell'Impeto, riprender» I feodl tm tiail. raa laa t» la ra*4lak«t di quelli alleasti, far n rhae alte tatuante del dar* di JI«W*a «<t
» r+mpmia» 4 ri pnmripr Ctfnte. X.• 4H Prim rifr Emfrmi». X. St * m stsILA date aa Idra del •eathaentl rbe <| m a » a Vltnaa per rifalla e II
(al palo pnft w ftlr* D 1V»t*»*ealo palifica di «* m tm ittn érW iatftrrafaee. «pera del dar« di Moie« «t* aatsirlaiMt «fwcawda a VWaaa di Carlo II poi ramalo affli Amdrlari. tr un proynaaa del Medi da adoperare per
L m u c o s i - l a t u r c a * d i l u ì » t a t o p o K T t r t n o I 7«»m :» W
del principe Kugrnio ronfeimano «ruta reticenw* rh<* il piano imperiale m di entorcrre dagli Stati italiani tutti* ir ape«* ttrm uarir jwr IVaerclto: e eoo fredda brutalità «I mirava infatti ad ottener* qneoto intento. I principi italiani ai lanciano taglieggiar» «rn u protrate; nniro ai Ir* a il papa in difena dei •noi privilegi * d iritti ecrieniaaticl. (anche *e a noi poro gra diti, ma allora riconosciuti t « di fronte alla brutale aera pastosa di Coaarrkio, e, («oirbe U cattolica imperatore «I ride delle «co muniebe minacciate o . » e un proteatante. cerca di armami prr non eaner* «cannato p ro p r io come nn agnello. In fondo quento papa, che * detto ingrnoo « poco »aperto di politica, a Tra aell’a nim<> più flervtM che non i Fam i*!, i Medici, gli Katenai e gli
rtaMHr* la C «x> (* te >> > a w l» n a r U n • per prò»orar» li papa a r » «| * r r n * l'imperator». m a r Infatti (Tre n o » Erro, ria m a l u. Il braa« riguardante U Papa:
iu k M la O n usta r Imperatore aaallatto ri r «odimi» I diritti !mi*riali la Italia taato pM ekt gli Alemanni *ono aWwtaau • tolti por acrocrrr» la p p i»« ) alla diatnufaae drlt Italia. Qnnta <-be oaarpA le aae libertà la leaipo 41 » b ul in a M l'la p ttu . * ora ppr la divistone e la «aa --rimiti tarile ad opprimer» Qanta gran arena »1 derr aprir» ma una rottura piena col l*apn. la rei «t dev» dl*1 incorre rV «u ipator» dal Vira rio di Ohta, mostrando di badai* |H6 al diritti r.oortftrl ( i r a quelli aliti, ottenendo mal l'affetto degli Eretici tedeorfai. ». rHttando U torto «u A tal. oonaertaada qnello M Caltallrl. R lx cu rolplre »n a ilon » Il Papa
la i * * t » <** **11 paaa riunir» mauro l'impero all altri .‘‘ ta li Ita- Uaal: diape*»» Il paator* la tari a n i* la n*-cgla « Non barre«» |<ma (ToMdlgar» 0 l*apa m a « m i Immiti ad Imbrogliar«! ma Voi et a ve- alme a qaalrbe dichiarati***. a da qaaata dicbUratioae ne rerr* Il roatro taatagglo la fleraaaa M ia Corte Romana » facile ad irritar«!: I Ventri (¿•aerali la Italia, et I rostri Aaabaeriatori a Roma fioreranno renio or- •»«ioni d| morti Arar io. a dl«caa«arlo Egli t Impoaalbile rbe rjnalrhana acm aa prodara l'effetto rbe aitwittas». a rbe aoa ataarbl la paiim*» del Papa», lavare di dlspeas» per la ma arata roroaatianr, l'imperatore* ora la grado di andarla a r t M m ma una potente armata, e mal «ti «fatetele I vostri dritti col Papa a fArmi «oatre r f faranao ragioneqaaado la glnatlaU aaa forno iM aitaua forte per »ttMwria », ( t a - aaaxL I-X X I. S R 4M. I l Mote« m aapotetaao. dlr»nne mlnhotro dei ¡A rrldur* a Barmltoaa e mori a Nat«-!! ari 17«: era «tato proposto dall Imperatore poi rardlaalato? V. « u n U n to «: M *m M n*. rd. Boiti»ie. x i . aa
100 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
st&ssi Veneziani; e lui solo, che era il meno armato, tentò una resistenza che prolungò sino all’estremo, e, come vedremo, non fu del tutto inefficace.1
D’altra parte a torto si vede la condotta bellicosa di Clemente XI e l’opera del Marsili in una luce quasi di ridicolo e la si giudica con quel senso di compatimento con cui, a tortoo a ragione, è stato sempre considerato l’ esercito papalino, quasi che l’impresa del Marsili preluda a quella, ben più disastrosa, del Colli nel 1797, così messa in ridicolo, anche troppo, dal Leopardi.
Quando il papa decideva nel giugno di armarsi e incaricava del comando il Marsili, la sua condotta non era affatto così leggera e temeraria come può parere a noi, e tale non la considerarono punto gli alleati: anzi gli storici militari austriaci mostrano con ricchezza di particolari (pianto debole fosse la loro situazione militare in Italia e come se lo sforzo papale fosse stato veramente assecondato da Francia e Spagna, come avevano promesso, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime : ed anche senza questi aiuti esso non fu senza qualche effetto sulla situazione papale e sullo svolgimento generale della guerra.
Napoli era in una condizione pericolosa : pochi soldati, mal pagati, diminuiti dalle numerose diserzioni : il Viceré Grimani e il comandante spagnuolo in disaccordo col comandante austriaco, il clero e le nobiltà ostili, e incombente la minaccia di un attacco dalla Sicilia. Nell’alta Italia le forze erano appena sufficienti per le operazioni in Piemonte. Se veramente la Francia, con un semplice attacco diversivo sulle Alpi, avesse impegnate le truppe del Piemonte e la Spagna avesse coordinato un attacco su Napoli con un’avanzata di truppe papali, dopo assicurata la linea difensiva nel Bolognese e Ferrarese, Napoli poteva esser rioccupata.2
1 Campagne del Principe Eugenio, X, 23. « Sino a che 11 Papa non si fosse piegato davanti alle Insegne di Casa d’Austria. Giuseppe I non sarebbe Stato pienamente Signore in Ita lia ».
2 Campagne del Principe Eugenio, X, 143, 148, 192.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 101
Queste azioni ardite ed offensive non erano però nei disegni del papa, e in ogni caso furono frustrate dalla condotta della Francia, die avea abbandonato troppo precipitosamente l’Italia, e, giustamente, si preoccupava dei suoi confini minacciati, ma seguiva sempre la vecchia manovra egoistica di servirsi degli Stati italiani per creare una diversione utile ai suoi fini, pronta poi ad abbandonai^ ai loro destini; 1 era il vecchio metodo di Francesco I, Richelieu, Mazarino e Luigi XIV. E il provocare un conflitto tra papa ed impero e magari l’uso delle armi spirituali era in quel momento assai utile alla Francia che preparava la riscossa con un esercito affidato al Vendóme, e con una fede così sicura nella vittoria da indurre Luigi XIV a voler partecipe della gloria sperata il nipote Duca di Borgogna a cui fu affidato il comando nominale. È noto che fu appunto questa disgraziata risoluzione a guastare la campagna brillantemente iniziata, e a trasformare la battaglia di Oudenarde (11 luglio 1708), che poteva essere solo un insuccesso, in una vera sconfitta, per la ritirata imposta dal Borgogna sfiduciato al Vendóme.
* * *
Questa era la situazione generale quando Clemente XI risolveva di armarsi, cioè essa appariva così poco nettamente decisa da poter essere rovesciata da un evento improvviso, a cui anche il modesto contributo papale poteva giovare. Quando il Marsili assumeva il comando, avea diritto di contare sulla collaborazione francese (ed egli stesso cercò personalmente di promuo
1 In Francia si pensava di nuovo nella primavera del 1708 a una Lega dei Principi italiani che avrebbero dovuto fornire determinati contingenti armati come l ’avea tentata nel 1701 i l card. d’Estrées ; ma solo dopo Oudenarde, nel settembre, fu mandato alle varie corti il Tessè che trovò accoglienze freddissime. La Francia avrebbe fornito J0.000 uomini. Questa ideea della Lega italiana antiimperiale, sotto la protezione di Francia tornava fuori sistematicamente nei momenti di pericolo. I l Marsili si contentava di assai meno, che trattenessero il Daun per qualche mese in Piemonte. A torto il C o s e ( Storia della Casa d’Austria, IV , 380) ed altri attribuiscono al Papa il tentativo della Lega, che era invece Francese.
102 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
verla scrivendo, come vedremo, al de Torcy ed al de I’ontchar- train) e di ritenere che il Daun sarebbe stato trattenuto da piccole azioni francesi in Piemonte, da cui infatti partì contro la volontà del duca Vittorio Amedeo e lasciandovi solo 1500 uomini. Così egli avrebbe avuto il tempo di organizzare le difese e ordinare meglio il suo esercito improvvisato.
Ma, per ottenere dei buoni risultati militari, non bastano le condizioni generali, ci vogliono anche le armi e i mezzi locali, e per chi conosceva le forze militari pontifìcie, come il Marsili, non poteva esser dubbio che al momento non c’era che una spada di legno e uno scudo di cartone.
£: il caso di chiedersi come mai il Marsili accettò un incarico, 1 che, se non disperato, era certo assai difficile e in ogni caso poco brillante. Le lettere di lui al papa e al Segretario di Stato riboccano di proteste di devozione Ano all’ ultimo sangue: non è il caso di prender troppo sul serio queste frasi doverose in un secolo così cerimonioso. Non mi par dubbio che due moventi spinsero il Marsili all’impresa : il rancore verso l’imperatore e il sentimento ambizioso di tornare in patria con un’autorità eccezionale che metteva lui e la sua famiglia in una posizione particolare fra la nobiltà bolognese. La speranza di poter veramente fare qualche cosa di utile, sostenuta da una ferma fede nella sua capacità ed esperienza militare, come nelle
1 II Lambebty, op. cit. V lascia credere che il Papa si rivolgesse al Marsili, dopo aver chiesto invano un generale a Luigi X IV che, osserva, di buoni non ne avea neppure per sè. Credo sia poco esatta la notizia, come quella del Saint Simon (Mémoires, ed. Boiiisle, X V I, 406) che dice che aveva chiesto il Feuquière: dovea trattarsi di progetti e voci di Versailles in rapporto alla sperata Lega italiana, mentre la decisione papale fu determinata dall’occupazione di Comacchio che è del 25 maggio, e ai primi di Giugno il M arsili era già nominato capo dell'esercito : sarebbe quindi mancato il tempo per altre pratiche. Inoltre prendere un generale francese sarebbe stato pericoloso per il Papa, perchè cosi sarebbe apparso in rotta con tutta la coalizione, e non con il solo imperatore per cause particolari, e di più non avrebbe avuto libertà di concludere la pace quando g li fosse parso opportuno. Marsili era e si comportò da suddito, un generale francese sarebbe stato un padrone.
L. SIMEONI - LA DIPESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 103
sue relazioni politiche, dovea stimolare la sua natura orgogliosa ed ambiziosa più che la carità del natio loco e la lealtà e l’affetto verso il proprio sovrano, non certo sviluppatisi servendo l’ imperatore.
Ma, ammessi anche questi moventi, è innegabile la serietà con cui il Marsili assunse il suo compito, cercando ben prima di arrivare a Ferrara di provvedere a quelle deficienze che conosceva in anticipo, prima di constatarle personalmente anche peggiori del previsto. Dal suo contegno si capisce che sapeva di venire non tanto a prendere il comando di un esercito, quanto a creare un organismo militare in un paese di ecclesiastici, dove avrebbe dovuto fare e dirigere tutto. L ’invito papale lo aveva raggiunto a Cassis sulle coste della Provenza 1 dove si occcupava di studi marini, e partì quasi subito, ma facendo, per causa della flotta olandese ed inglese, un lungo giro per la Svizzera e il territorio veneto, indugio che egli cercò di rendere utile ai suoi nuovi doveri.
Ad Avignone si abboccò col Vicelegato per promuovere leve, che gli Intendenti della Provenza, della Linguadoca e del Delft-
1 La nomina del M arsili è del 1° giugno : rimane fra i suoi Mss. XL, 31, il diploma di nomina a colonnello di un futuro Reggimento dei Granatieri ; esso può riuscire interessante per il suo stile.
Co b n e l io B e n t iv o g l io d ’ A bag o n a , chierico della Reverenda Camera e Commissario generale delVArmì. Havendo la Santità di N. Sig. Papa Clemente X I appoggiato al valore a ll’ isperieuza, alla Condotta di lei Sig. C o n t e L u i g i M a b s i i .i i il comando delle sue Armi, nel grado specioso di Sargente Generale di Battaglia ; Quindi è chè per distinguerla, e per rimostrare il concetto e l ’estimatione, che ne tiene, si è perciò benignamente degnato d’unire al primo, anche il secondo carattere di Colonnello d’un Reggimento de Granatieri, da levarsi in servigio del suo Armamento; Ed in vigore della Presente hà ordinato, se ne facci dichia- ratione con tutti g li onori, Pesi, Facoltà, P riv ileg ij, Prerogative ed emolumenti stabiliti nella Congregatone Militare. Si comanda però, che Ella, come tale sia riconosciuta, e trattata da chiunque si deve sotto pena della disgratia di Sua Santità, e di altre ad arbitrio. In fede etc. Dato in Roma questo di primo Giugno M D C C V III.
C. B e n t iv o g l io Comm. Gen.le. Q u in t i l i a n o V a l e n t i Reg. 1. Gio. B a t t a C o s s a Segr.
(S ig illo del Bentivoglio).
104 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
nato avean promesso di aiutare consegnando i disertori: queste truppe dovevano fare aneh’esse il giro del Vallese e ottener poi il passo da Venezia ; solo in questo caso potevano in otto settimane essere a Ferrara, altrimenti dovevano attender l’ inverno e il ritiro delle flotte nemiche per venire per mare. A Lucerna trovò che il papa avea già chiesto di poter arruolare 3000 uomini e comperare cavalli. Ma in realtà nulla potè venire: ebbe buone parole, altri accordi fece col co. Salis in Valtellina perchè mandasse a Ferrara alla spicciolata un centinaio di uomini. A Brescia col card. Badoèr, vescovo della città, affrontò il tema dei cattivi rapporti che vi erano in quel momento tra il papa e la Serenissima per una questione di etichetta pretesa dal Nunzio, e, poiché essi gli stavano molto a cuore, passò da Venezia, dove stando chiuso in un’osteria, potè vedere segreta- mente il co. Francesco Morosini, uno dei Savi Grandi che gli fece promessa di favorire l’acquisto di barche ed effetti militari, e di ordinare che la squadra del Golfo vigilasse contro possibili colpi di mano sulla fiera di Sinigaglia che si temeva l’Austria meditasse fare, o lasciar fare ai Signani, gli Uscocchi di 90 anni prima. Questo provvedimento rientrava nella polizia del Golfo, mentre era poco probabile che Venezia, col territorio attraversato continuamente da colonne imperiali, favorisse la raccolta d’ uomini ed armi contro l’ impero.
A Ferrara iniziò le sue funzioni effettive conferendo col Legato card. Casoni, che affermò di essere in settimana pronto con 4000 uomini e in grado di resistere a 30.000. Vanteria di cuii mille gridi d’aiuto posteriori dovevano mostrare la fatuità. Ma il Marsili ci presenta il Casoni in luce simpatica e, anche più tardi, pur lagnandosi indirettamente di sue decisioni imprudenti, come di fortificare Bondeno, ne affermò lo zelo e l’attività in confronto alla mala volontà e all’ostruzionismo del Legato di Bologna, card. Grimani.1.
1 Relazione del Marsili al Segret. di Stato, da Ferrara, primi di luglio 1708. Mss. M arsili, LX X II.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 105
Quando il generale giungeva il 10 luglio nella sua città, la situazione aveva continuato il suo sviluppo: bande di cavalleria si erano viste il 16 giugno a foraggiare nel Ferrarese, il Cardinal Grimani aveva, in una lettera da Fondi del 29 giugno, offerto a nome dell’imperatore che questi era pronto a ritirare la cavalleria dal Ferrarese, purché gli si cedesse Comaccliio e si desse garanzia di non attaccarlo : questa proposta ripetè il marchese Priè il 4 luglio al Casoni, ma, come ho detto, fu nettamente rifiutata, esigendosi lo sgombro di Comacchio.
Alla mellifluità del cardinale Grimani fa curioso riscontro la insolenza del manifesto imperiale del 20 giugno, che veniva comunicato con lettera del 27 ai Cardinali, in cui si respingeva vivacemente la minaccia di scomunica. La polemica continuò, perchè il papa ribadì la minaccia, il 16 luglio, di trattarlo come un figlio ribelle con le scomuniche e anche con le armi, affermando di nulla temere «anche se venissero degli eserciti contro di noi ». 1 In realtà il papa poco incoraggiato dalle risposte ricevute dai varii sovrani, non osò arrivare alla scomunica che poteva implicare nel conflitto e danneggiare anche la sua autorità spirituale. A pace avvenuta, quando il papa fece sapere all’imperatore che dovea chieder l’assoluzione delle censure in cui era incorso, gli fu risposto insolentemente che non si ammetteva affatto la validità di queste censure. I Cardinali alla lor volta risposero alla lettera imperiale offrendo un accomodamento. 2 Ma erano schermaglie senza scopo, perchè a Roma in quel momento si pensava sul serio ad armarsi, e la lettera servì solo di pretesto agli Austriaci all’Aja per dire che il papa, armando e attaccando Comacchio, aveva rotto la tacita tregua che la lettera presupponeva, per cui il marchese di Prié inviato per trattare si era arrestato a Milano.
Ma più interessanti erano le misure di guerra : fin dal 2 giugno il papa avea chiesto con breve ai Cantoni Cattolici svizzeri di poter levare 3000 uomini : 3 si era intimato ai sudditi che ser
1 L a m b eb ty : Mémoires c it., V, 87. G h is e i . l i , LX X I e LX X II.2 L a m b eb ty , op. cit., V, 89.3 Lam b eb ty , op. cit., V, 90.
106 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
vivano sotto principi stranieri di accorrere, il che dovè fruttare ben poco o niente: si era formato l’elenco di tutti i feu- datarii dello Stato che dovevano militare: si era cercato di presidiare Cento, di rafforzare Forte Urbano con miliziotti o milizie paesane, di arruolare soldati ordinarii facendo batter la cassa dagli ingaggiatori. A tutto il 27 giugno a Bologna si erano arruolati 200 uomini, sicché si ricorse a una specie di leva ordinando che le Comunità formassero gli elenchi della popolazione: per ogni 100 anime dovevano fornire un uomo. Inoltre con Editto era promessa la sospensione delle pene ai banditi e contumaci che si arruolassero 1.
Questo era presso a poco quello che trovò il Marsili arrivando a Bologna, dove tenne un contegno riservato: visitò il Legato, che finse di non sapere del suo incarico, e gli parlò di alcuni pettegolezzi di famiglie, ed anche con i suoi concittadini, non essendo la sua nomina pubblicata, si condusse da semplice privato cavaliere. Ma certo troviamo assai curioso che egli, sul punto di partire per Koma, dove lo attendevano con ansia, offrisse la sera del 12 luglio una cena lautissima in casa sua a nove dame, servite da cavalieri, una delle quali, la marchesa Tanari Campeggi, a nome di tutte, in segno di gradimento, gli donava un ricchissimo nastro.
E proprio quel giorno passava da Bologna e vi alloggiava la moglie del maresciallo Daun, già viceré di Napoli, con 100 persone di seguito e 50 muli carichi di ricchezze raccolte a Napoli, dove pochi mesi prima, dice il Ghiselli, si erano visti recarsi con poche miserabili valigie! Del resto continuavano i passaggi di truppe austriache alla spicciolata, e peggio: ad es. il 17 luglio si presentavano alla Porta Maggiore 50 cavalleggeri imperiali con un ufficiale, reclamando la consegna di un tedesco arrestato per un coltello superiore alla misura, a cui si era data la corda. Sotto la minaccia di saccheggio il Legato, dopo aver mandato invano il suo segretario a trattare, fini col consegnarlo,
1 Questi dati sono ricavati dalle M emorie del G h is e l l i , voli. LXX I, L X X II e dai carteggi del Legato col Segretario di Stato e dalle lettere di questi che sono nell’A r c h iv io V a t ic a n o , Bologna, 89 e 238.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 107
prendendosela poi non con gli Austriaci che violavano il territorio, ma con l’Assunteria di Milizia, che chiaramente accusava di aver provocata la mossa nemica. E in città, sia perchè il Legato era mal visto, sia perchè si temeva di provocare la violenza del nemico che era numeroso sul Modenese, si dava torto al Legato.1
Due giorni prima, il 15 luglio, Marsili era partito alla volta di Roma,2 ma visitando in fretta le fortezze che erano sul suo cammino, dando ordini provvisorii per la loro riparazione e custodia. Così al col. Rasponi, governatore delle armi di Romagna, lasciava ordini preeisi perchè Faenza — che egli intendeva fare piazza d’armi, ossia base di operazione per fronteggiare sia la minaccia dal Modenese e Mantovano che da Comacchio — fosse assicurata da sorprese: scavare e riempire d’acqua i fossati; costrurre palizzate davanti alle porte, abbattere gli alberi che vi erano sui terrapieni, riparare e costruire baluardi, sorvegliare i forestieri, e far battere i dintorni ogni notte da pattuglie di 24 cavalieri. Si sente subito il soldato che conosce veramente la guerra. Visitò così pure Imola, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Rimini, Pesaro, Fano: ad Urbino col Card. Legato Ta- nara si accordò per misure di protezione della Fiera di Sini- gaglia, che non allarmassero le popolazioni e i mercanti. Curioso stato di guerra!
Arrivando a Roma il Marsili trovò un da fare immenso, perchè aspettando lui si erano solo presi dei provvedimenti isolati, spesso contradditorii : ora si trattava di formulare un piano organico e completo. Ogni giorno in quella fine di luglio si tenevano Congregazioni col Segretario di Stato ed altri capi dei vari dicasteri per approvare più che altro i progetti che il Marsili preparava rapidamente sullo Stato milita/re ossia l’organizzazione dell’esercito, sui provvedimenti per questa o quella fortezza, per i quadri dei Reggimenti, per la fabbrica delle muni
1 Gh is e l u , L X X II, 166 : altre volte venivano ufficiali tedeschi a reclamare i disertori o 12 doppie per ciascuno !
2 Le notizie seguenti sono prese dalle lettere e dai memoriali del Marsili di questi giorni contenuti nel voi. L X X II dei suoi Mss.
108 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
zioni. E fa piacere il constatare, non tanto l’approvazione che incontrava il Marsili nella sua opera 1 (l’unica notizia che l’ambasciatore bolognese trasmetteva al Senato), quanto l’ardore con cui il papa e il card. Paolucci insistevano coraggiosamente nella via intrapresa: forse erano gli unici in tutto lo Stato ecclesiastico col Marsili a credere a una efficace resistenza!
Non solo da Boma piovono ai Legati e alle città istruzioni preparate dal Sergente Generale, ma il tono delle lettere del Segretario è più secco e risoluto: il 1° agosto il Paolucci rimprovera il Legato di Bologna di aver accettato di trattare col commissario imperiale Paehner, che avea chiesto il passaggio per delle truppe, poiché Grimaldi, con la sua prudenza, poteva capire che cosa esigeva il fatto che lo Stato era invaso e maltrattato. E gli mandava la minuta defila lettera con cui dovea comunicare al Paehner che il Papa negava il passo : « E se poi, non ostante questa tanto ragionevole ripulsa, si volesse effettuare dagli Alemanni il passaggio, è mente di N. S. che V. E. si opponga colla
forza e colle armi', al quale effetto dovrà V. E. render avvisati cotesti Signori Assunti di Milizia di tener pronta la loro gente per accorrere ove il bisogno richiederà dando armi ai paesani e alla commissione, anzi coll’ ordine espresso di difendersi, facendo dar le campane a martello ad ogni comparsa di truppe straniere che vengano per tentare il passaggio ». *
1 A rc h . S ta t o B o lo g n a . Lettere al Senato 1708-9. Lettera dell’amb. Filippo Aldrovandi, 25 luglio 1708 : « Ed egli non solo per ciò che r iguarda il militare, ma ancora il politico, si mostra non meno atto a comandare che a consigliare, e però in questa S. Congregazione mista di M ilitare, di Economico e di Politico ei fa una figura maggiore di ogni aspettazione, benché l’aspettazione fosse grande ».
2 A rc h . V a tic a n o , Bologna, voi. 238. Nelle istruzioni per la difesa del Bolognese (preparate dal M arsili) trasmesse dal Segretario di Stato, oltre all’ordine di organizzare i contadini e di reagire energicamente, tagliando la strada ai foraggiatori, è detto espressamente di impiccare le loro guide al primo albero. Mas. M ors ili L X X II, 102. Della seria volontà del Papa di difendersi è prova la grave deliberazione presa nel Concistoro di levare dal tesoro di Castel S. Angelo raccolto da Sisto V, 500.000
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 109
Si sente in questo ordine coraggioso lo spirito del Marsili,il quale però giustamente non nascondeva al Papa le gravissime deficienze e l’urgenza di rimediarvi. Una che veramente lo preoccupava, era la sicurezza della città di Roma che poteva essere esposta a un colpo di mano di qualche banda di cavalleria che arditamente venisse da Napoli. La notte del 26 luglio presi con sè 40 dragoni si recò d'improvviso a ispezionare le Porte della città e i Corpi di guardia sparsi per la città. Il quadro che egli fa al Papa è, per noi, abbastanza divertente! Le porte custodite da un semplice portinaio a cui due uomini avrebbero potuto prender le chiavi; inoltre alcune di esse, tra cui Porta Pia che conduceva direttamente al Quirinale dove era il Papa, restava aperta quasi tutta notte per i somari e i muli che portavano derrate. E peggio i Corpi di Guardia erano senza ufficiali, e senza ordini, con la sola intesa di andare a chiamarli in caso di bisogno. Peggio era accaduto in uno di essi dove non c’era neppure la sentinella e per farsi aprire si dovè battere a lungo, perchè tutti dormivano in camicia, come se fossero a casa loro ! 1
scudi d’ oro sui 3.000.000 che vi erano. Di questi, 300.000 alla fine di ottobre erano giunti a Faenza e il M arsili potè fa r li portare in salvo. (Comunicazione del Paolucci al Legato del 26 settembre. A r c h . V a t ic a n o
voi. 238 e Mss. M arsili, L X X II I , 31 ottobre al Paolucci).1 Relazione dello stato in cui si sono trova ti l i Posti tu tt i che riguar
dare dovrebbero la sicurezza del nostro Beatissimo Padre e poi di tutta la città di Roma (presentata alla Congregazione il dì 27 luglio) :
« Ho ritrovato, Beatissimo Padre, di mio sommo debito il riconoscere le disposizioni m ilitari, che sono in Roma affine di non essere inscio delle medesime, e con prineipii sicuri proporre 11 rimedii sicuri, ove ne fosse di bisogno.
Nella notte caduta delli 26, venendo il giorno d'oggi 27, ordinai con somma segretezza quaranta Dragoni del reggimento Albani con due Uf- fiziali e due Aiutanti, commettendo loro di trovarsi ad un'ora di notte fuori dalla Porta del Popolo, per far credere che fossero ordinati più tosto per servizi di fuori che dentro della città. Ad un’ora e mezza mi trovai in persona al prescritto luogo, rientrai in Roma, e visitai per prima lo stato della medesima Porta ; volli vedere come si chiudeva, e come conservavano le chiavi. Queste, come in tutte le altre Porte da me riconosciute attorno di Roma, si custodiscono da un semplice portinaio abitante in una piccola casetta senz’alcuna guardia, dove arrivando solo
110 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
L’esercito poi funzionava così male perchè, osservava il Mar- sili, non esisteva affatto; bisognava crearlo del tutto, in quanto vi erano solo compagnie isolate nelle guarnigioni, e non ordinate in Reggimenti che dessero ordine e uniformità a tutto l’organismo. Ogni capitano ordinava la sua compagnia secondo il suo capriccio, o spesso la sua ignoranza, sicché esse erano divenute « un ammasso di borghesi nelle fortezze». Mancava un Regolamento generale che fissasse esattamente i doveri dei soldati e
due uomini, che fossero d’intelligenza con gente di fuori, pigliarebbero le chiavi dalla stanza e aprirebbero le Porte a chi fosse di fuori.
Porta Pia è quella la quale conduce immediatamente a Monte Cavallo, ho trovato che s’apre alle due della notte, introducendo somaretti, muli e gente dimodoché è sempre un continuo corso con sommo mio scandalo, mentre un tale abuso non sarebbe malagevole a gente cattiva d’introdursi in Roma, giacché quel custode non difficulta a chiunque vuole l’ ingresso.
Ho visitato Porta Angelica, dietro il Vaticano, che non stava niente meglio, come sento sia lo stesso di tutte l ’altre, inconveniente che merita riflessione, altrimenti nelle presenti congiunture si potrebbero temere sconcerti non creduti.
La vigilanza ne’ Corpi di Guardia, distribuiti per Roma dovrebbe esser pronta a queste negligenze, ma mi conviene d i rappresentare a V. S. che che il cattivo uso de tempi andati ha fatto che ogni buona regola siasi dimenticata, non avendo trovato in alcuno de medesimi, eziandio in quello che sta avanti Monte Cavallo alcuni uffizziali, cioè a dire nè Capitano, nè Alfiere, e nè meno lasciati gli ordini necessarii a quel miserabile Sergente di quello debba fare, a riserva di quello che quando venisse qualche disordine dovesse mandarli ad avvisare o nella lor Casa, o in qualche Conversazione.
I l Corpo di Guardia delle Corazze a Terni non avea nè meno una sentinella e bisognò battere alla porta un lungo tempo, come si farebbe alla casa d’un artigiano per aver prima risposta : e poi tuti erano spogliati, in camisa, e dormivano come se fossero stati nelle lor case».
Bisogna rimediare mettendo guardie nelle porte e un ufficiale che soi-raintende, e controliando l'ingresso dei foras tie ri: egli si scioglie di ogni responsabilità, avendo denunciato i l disordine. Loda la disciplina dei Dragoni e aggiunge che la città era interamente quieta: a tre ore di notte tu tt i i caffè e pubblici r itro v i erano chiusi e si trovavano solo « sterzi con donne e cavalieri che si divertivano al fresco. A ll ’alba discese da Monte Cavallo alla sua casa in Piazza dei S.S. Apostoli ». Mss. M ors ili, L X X II.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 111
degli ufficiali, che ne precisasse la disciplina, e su questo puntoil Marsili insisterà sempre senza frutto, perchè anche quando accadevano dei fatti gravi, non vi era una norma per giudicarli e punirli.
Uno dei primi progetti da lui presentati il 24 luglio fu appunto per creare questo Stato militare, in cui era trattato anche del pane delle truppe (che secondo il Marsili era scarso in confronto agli altri eserciti) del vestiario, delle armi, del carreggioo treno per mobilitare la truppa ecc. In quest’occasione egli dovè pure presentare i preventivi per la spesa dei reggimenti di Fanteria e Cavalleria, secondo i quadri da lui proposti.
In questo Stato Militare 1 del Marsili ci interessa special- mente l’ultima parte in cui egli prospetta provvisoriamente al Papa quale piano di difesa era possibile preparare e attuare. Dato che per l’occupazione di Comacchio era minacciata anche la bassa Romagna, non c’era che da tenersi sulla difensiva, munendo saldamente Ferrara e Forte Urbano e distribuendo altra truppa nelle rocche della via Emilia per impedire che il nemico le occupasse. Un grave pensiero gli dava Bologna, difficile a difendersi, preda ambita per le sue ricchezze, mentre non era il caso di abbatterne le mura per sottrarla ad attacchi. Il Marsili chiedeva una seduta speciale per trattarne, e, dal contegno che egli poi tenne a Bologna, pare che si decidesse di organizzare una qualche difesa, non tanto contro un assedio, ma contro le scorrerie o i colpi di mano.
Un pericolo grave secondo il Marsili era l’essere il Lazio e la Campagna Romana aperte ad un’invasione, che poteva essere sostenuta da un attacco da Orbetello, da poco occupato dagli Austriaci: e questo confermò dopo una visita minuta alla frontiera meridionale in una relazione presentata il 20 agosto in cui proponeva di concentrare circa 12000 uomini a Ferentino, portandovi quei 3500 che erano a Roma oziosi. La misura avrebbe avuto il risultato di aggravare la situazione a Napoli, dove, se
1 Vedi il documento in Appendice.
112 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
il Papa riusciva a negare il passaggio dei rinforzi, gli Austriaci non potevano sostenersi.
A questo pensiero del Marsili di combinare Fazione pur difensiva de*l Papa, con un’azione aggressiva franco-spagnuola, si riferiscono due sue lettere a due ministri di Luigi XIV, che egli conosceva personalmente, il Co. de Torcy segretario di Stato eil Co. Pontchartrain ministro della Marina, colle quaii chiaramente desidera far sottoporre al re i suoi progetti.1 Non già che il Marsili, esperto gentiluomo, si permettesse di dare così arditamente dei consigli al re; tutt’altro anzi, l’abilità per dissimulare l'intento è così esagerata, da riuscire un pochino ridicola, quando lo vediamo, il 20 agosto, con quel da fare che aveva, chiedere al Pontchartrain (che aveva pur lui ben altro
1 Al de Torcy 25 settembre 1708 : « .... 11 Signor Card. Grlmanì vorrebbe farsi credere più potente che non è mancandogli soldati, denari e grano per alimentar un cosi numeroso popolo sino alla nuova raccolta. Questa notizia potrà V. E. umigliare a S. M. come verità sincera e come un fondamento indubitabile di molte agitazioni in quel regno e particolarmente s’ ella sollecita un forte soccorso al regno di Sicilia, che i Veneziani non siano indulgenti a lasciar a’ tedeschi il passo del Golfo e che da qui si possa essere in istato di resolutamente opporsi al passaggio loro per le Provincie Ecclesiastiche, il che riuscirà loro difficile per non dir impossibile se saranno in poco numero, com'è credibile, tanto più che nè dal Sig. Duca di Savoia, nè dagli alleati sì consentirà mai che le forze alemane tutte esistenti in Ita lia vengano a tentar tal passaggio per non privarsene contro la FrancTa, vedendo bene V. E. col sommo suo discernimento, che se volessero ciò eseguire, difficilmente tal gente ritornarebbe più nel Piemonte, mentre una gran parte s’impiegarebbe a guarnire il regno, e l'altra fra il fuoco, miserie, stenti e cattiva influenza dell’aria, si eonsumtnarebbe tutta lasciando un bel campo al Marescial di V illars di rientrar nell’ Italia. Queste mie riverenti evidentissime rimostranze, che m’immagino prevedute per lungo tempo dalla gran mente di S. M. potranno promuovere l ’intento di trovar una volta la quiete universale ». Mas. M arsili, L X X II, 98.
Nel voi. L X X V II vi è la lettera di risposta del de Pontchartrain chelo assicura che il re approva le sue vedute e si son mandati rinforzi a Messina e si è parlato seriamente ai Veneziani perchè custodiscano il G olfo : manderà anche la famosa Venda (ott. 1708) di cui è detto più avanti.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 113
per il capo !) di fargli avere « una lunga benda di tela egiziana tutta piena di geroglifici per copiarla e inserirla nelle sue dissertazioni, non avendo fra tante serie occupazioni mai tralasciato gli studi e massime sull’ erudizione degli Egizi ! ». Via, non era il momento di fare lo Champollion, quando gli costava tanta fatica fare il generale sul serio!
Le considerazioni che svolge il Marsili sono che se si mandano aiuti agli Spagnuoli in Sicilia, e il Papa riesce e negare il passaggio, e i Veneziani mantengono chiuso il Golfo, ossia l’Adriatico, il Regno di Napoli sarebbe insorto non avendo grano per arrivare sino al nuovo raccolto. Certo il Marsili si lusingava troppo quando già prevedeva la possibilità che il Villars potesse rientrare in Italia, perchè dimenticava che a tagliare i soccorsi alla Sicilia si opponeva la flotta inglese ed olandese che dominava il Tirreno, ma ho già mostrato come anche il Principe Eugenio fosse angustiato per la situazione di Napoli, sicché le sue non erano tutte fantasie. Per il momento bisognava realizzare la parte più vitale del suo programma: avere il modo di opporsi a una invasione austriaca dalla Lombardia.
E certo egli non si risparmiava per riuscirvi: il lavoro suo di cui ci è rimasta la prova sicura nelle relazioni o proposte da lui presentate alla Congregazione od al Papa è ingente e non poteva essere improvvisato, perchè ora si trattava di visitare l’armeria pontificia, ora tutta la frontiera meridionale, chelo occupò quasi 20 giorni, ora di dettare minute istruzioni per le riparazioni e il rafforzamento di Forte Urbano e della Cittadella di Ferrara e per la difesa del Bolognese, ora di compilare l’elenco di tutte le artiglierie disponibili, con le proposte per le mancanti, che erano quelle da campagna e i mortari, ora di determinare un Regolamento sulle paghe degli ufficiali mettendovi l’uniformità che non c’era, suggerire l'ordine migliore per gli appalti dei viveri e forniture, fare il piano di un reggimento di granatieri raccogliendo quelli sparsi nei varii corpi etc. 1
1 Tra i vari Regolamenti che il Marsili dovè improvvisare ve ne è uno che si spiega bene trattandosi di un esercito pontificio, cioè per il servizio religioso, intitolato « Ricord i del Sig. Oen. M ors ili a tu tti
114 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Come se questo non bastasse bisognava, essendo in uno stato assoluto, fare la corte al Papa e di più forse ai suoi nipoti. Così egli aveva fatto nominare colonnello dell’unico reggimento di Dragoni un po’ a posto, D. Alessandro Albani,1 e prima di andare alla visita della frontiera meridionale, gli lasciava un minuto memoriale dei preparativi per una rivista del reggimento che dovea esser passata dal Papa, al suo ritorno, il 19 ago* sto, cosicché il nipote non sfigurasse. Questa nomina, suggerita dalla opportunità cortigiana, lo obbligò poi a non impegnare mai l’intero reggimento nei punti più pericolosi, perchè il colonnello non venisse catturato. Il Marsili serviva con devozione piena, ardore e fede, ma non mancava di fierezza sì da dimenticare, non dirò il suo interesse, ma la sua dignità e il suo
i Reggim enti dell’Armata Pontifìcia ■». II cappellano del Reggimento avea con sè una cassetta per la messa e gli oli santi custodita presso la bandiera. Alla messa dovevano assistere i soldati con g li ufficiali tutte le feste e anche i giorni feria li se disoccupati. A lla sera, alle 22, il cappellano radunava col suono del tamburo i soldati alla preghiera, in una piazza in città, e presso la bandiera in campo, e iacea recitar le litanie. A ll’inizio di una marcia i soldati, a un segno di tamburo, s’inginoechiavano e recitavano un pater e ave, e così alla fine della marcia, come si iacea nelle truppe cesaree, ùngare e polacche, dice il Marsili. I capipellani denunciavano al colonnello i concubinarii, i bestemmiatori : le meretrici colte nei quartieri o nei campi erano frustate dal carnefice (L X X II, 128). Anche il solo elenco delle relazioni, carte e mappe che rappresentano l’attività del Marsili in questi pochi mesi susciterebbe stupore: ma per la necessaria brevità ometto tutti i particolari superflui.
1 G h is e l l i , L X X II, 137. La nomina avvenne in questa curiosa maniera : I l Marsili stava passando in rivista a Castel S. Angelo i Dragoni. Sentendo che il papa era andato alla vicina chiesa di S. Celso v i porta il Reggimento, glie lo fa benedire e g li chiede di nominare il colonnello. I l papa «soddisfatto del suo generale, come pronto e capace di fa r fronte a ogni pii! brigosa riso lu tone» g li affida la scelta: Marsili nomina senz'altro il nipote del papa e lo presenta al Reggimento, mentre il pontefice è commosso sino alle lacrime e il popolo grida : Viva il nostro liberatore etc. Del Marsili lontano e in auge a Bologna erano fieri, vicino lo trovavano molesto.
L. SIME0NI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 115
decoro, e ce lo provano le lagnanze, discrete, per lo scanso stipendio, che non gli permetteva di tenere la casa e l’equipaggio che egli credeva necessarii al suo ufficio.1
* * *
Verso i primi di settembre, questo lavoro di organizzazione a Roma poteva dirsi completo, ed egli si preparava ad accorrere alla frontiera minacciata, per affrettare i lavori ordinati : il 1° settembre scriveva al Senato bolognese avvertendo del suo prossimo arrivo perchè sollecitassero i lavori e gli mandassero a Faenza un ufficiale con l’elenco delle opere già fatte e una pianta della città, affinchè potesse dare gli ordini per le opere di rafforzamento. 2 Partì infatti il 5 settembre da Roma, ma per volontà del Papa dovette visitare la frontiera del Tronto e le città adriatiche, poiché anche affidando, per necessità, questa linea ad altri, si voleva il parere di un uomo come lui veramente esperto di guerra e di fortezze. Il 9 settembre era ad
1 La paga assegnatagli di 200 scudi mensili più le 6-10 piazze morte che la portavano a 240 unita pure a quella di colonnello del Reggimento dei Granatieri è insufficiente. Chiede che g li sia assegnato un Commissario che faccia le spese del suo equipaggio, quale egli lo propone in misura che non gli pare eccessiva, rimettendosi per la mercede delle sue fatiche alla paterna benevolenza e giustizia di S. S. R ingrazia dei 1000 scudi assegnatigli dal papa per il suo equipaggio.
« Nota dell’equipaggio espresso nel detto memoriale :
SegretarioMaestro di casaMaestro di stallaCameriereCredenziereCuocoSottocuocoStafferi : quattroCavalli da mano n. seiMuli da soma n. otto.
T iro a sei cavalli per un carrozzino Servitori da stalla, n. undici Cavalli per i servitori n. quindici L ivree per li lacchè e serv. di stalla Salarii a tutti.Vestiti modesti pr la mia persona Forniture de cavalli BiancherieQuotidiana spesa di una tavola per gli uffiziali e fam iglia ».
24 ag. 1708, Mss. Marsili, L X X II, 93.
2 A b c h . St a t o B o lo g n a , Lettere al Senato, 1708-9.
116 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Ascoli; poi a Fermo, Ancona, Pesaro, e il 17 a Faenza, lasciando ovunque istruzioni minute di lavori da fare e precauzioni da prendere, ai comandanti le piazze, ai Priori delle città, di tutto dando lunghe relazioni al Segretario di Stato, e contemporaneamente scrivendo ai vari Legati1 ciò che dovevano fare nelle singole legazioni. Dall’esame di tutta questa numerosa, e talora prolissa corrispondenza, appare una natura precisa e meticolosa, ma insieme pronta alla decisione, e una forte coscienza del proprio valore e della dignità dell'ufficio che, pur sotto le forme cerimoniose, non intende per nulla lasciarsi menomare nei propri diritti e fin nei riguardi.
Arrivando in Romagna cominciava per il Marsili la parte più dura: a Roma aveva lavorato come un martire, ma, apprezzato, accarezzato dal Papa e dal Segretario di Stato, avea il compenso delle sue fatiche nel piacere stesso di pensare e creare un organismo nuovo, con la speranza, o l ’illusione, di dargli vita. Ma ora cominciava la serie degli attriti e delle delusioni. Ben poco di quanto egli avea ordinato era fatto, molto neppure cominciato e dappertutto urtava contro gelosie, diffidenze, resistenze di Legati, di magistrati, sì che per vincerle egli doveva ricorrere alla superiore autorità di Roma. Di lì nuovi ritardi, mentre nell’esercito che si raccoglie non c’è disciplina, mancano i vestiti, le armi, gli ufficiali, e i pochi che ci sono si occupano di stipendi, di assegni, di foraggi gratis, lasciando la truppa nel più vergognoso abbandono.
Il primo incidente l’ebbe col Legato Grimaldi per una sciocchezza di cerimoniale. Portatosi a visitarlo, il Legato gli fece dire di attenderlo: ma il Marsili, poiché lo si lasciava nell’anticamera fra gente di grado inferiore, rispose che il Papa non gli aveva ordinato di far anticamera, se ne andò, non consegnando neppure le lettere. Chiaramente egli avea in cuore l’ umiliazione dell’ altro ricevimento del luglio e se ne vendicava : il Legato poi al momento di riceverlo si era preoccupato unica
1 Mss. M arsili, voi. L X X II. Lettere del settembre.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708 !) 117
mente di sapere come doveano essere disposte le sedie nella sala, secondo i precedenti per un visitatore di quel grado.
Ci furono proteste del Marsili che volea tornare a Roma, del Cardinale, lettere del Segretario che dà in fondo ragione al Marsili, ma lo invita a una minor rigidezza, e opera conciliativa del Marchese Pier Jacopo Martelli (il futuro tragico, allora segretario presso l’ambasciatore bolognese a Roma) venuto da Roma che riesci a combinare una nuova visita senza ritardi offensivi.1 Si capisce con quale zelo il Legato e i suoi ufficiali assecondassero gli ordini del Marsili per l’acceleramento dei lavori!
Ma anche col Reggimento, ossia con la Magistratura cittadina le cose non furono tutte liscie: qui entravano in azione ¡due elementi: qualche antipatia o gelosia personale verso il Marsili, ma ben più il costante sospetto del Reggimento verso l’azione del Governo pontificio, che a poco a poco avea usurpato il potere effettivo, riducendo a una vana pompa l’autonomia cittadina garantita da Nicolò V.
La pretesa quindi del Marsili di ordinare lavori, prendere disposizioni militari in città e nel Bolognese urtava contro i diritti delle Assunterie che consideravano la cosa di loro spettanza, e potevano ricevere dei consigli, non già degli ordini. E questo dispetto faceva ricordare ai Bolognesi che la Respu- Mica Bononiensis, come stato autonomo avea diritto di disinteressarsi dei pasticci politici in cui si trovava avvolto il papato, concetti e affermazioni che hanno per noi un suono curioso, ma che vanno spiegati con questi tenaci sentimenti di gelosia e rancore
1 Su questo sciocco incidente nel voi. L X X II dei Mss. M ars ili vi sono tutte le numerose lettere del Marsili al Paolucci e agli a ltri Legati; nel voi. L X X II I le risposte al M arsili del Segretario: le lettere del Legato e le risposte del Paolucci sono in A r c h . V a t ic a n o , Bologna, voli. 89 e 238. Anche nel G h is e l l i , LX X II, 423 vi è una lunga narrazione, poco benevola al Marsili. E ’ graziosa l ’affermazione del Le gato « se io non ero un ucello meno non poteva aspetare.... ma il vero si è che ci vole suditi » .
118 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
verso il papato, con questa illusione di non far veramente parte dello Stato ecclesiastico.1
Il contrasto tra il Marsili e il Reggimento ci è narrato dal Ghiselli con evidente compiacenza per la fierezza delle Assuntene, e il suo racconto2 ci dà un quadro evidente di questi curiosi sentimenti,
« Adì 19 Settembre giunse in Bologna il generale Co. Luigi Marsili di ritorno da Roma, dichiarato dal Papa Sargente Generale dell* Esercito Papalino in queste parti, essendovene altri due simili che devono comandare in Roma e nell’ Ab- bruzzo. Giunto questi in Bologna si vantò di bavere autorità suprema in ordine al Militare, ciò però non ostante li convenne conferire con il Pubblico, e particolarmente con l’As- sunteria di Milit.ia di Camera : fece egli sulle prime il giro delle mura da se medesimo, osservando le positure, il sito, e la qualità delle medesime, poscia accompagnato da gli As- sonti di Milizia lo replicò. Doppo bavere osservato molte cose disse che bisognava buttare a terra la Truna (tribuna) eh’ immediatamente fuori di Saragozza principia il portico di S. Luca, atterrare i Molini, Hosteria e Beccaria fuori di Galliera, buttar giù un pezzo di portico fuori di Strada Maggiore sino dirimpetto la Palazzina, che sarebbe stato necessario spianare il Palazzo di Mirabello del Conte Francesco Ranuzzi. Ma qui è da osservare che si trovò presente esso Conte, e sentendo una tale proposizione disse : 0 questo mi spiacerebbe, perchè sarei poi forzato partirmi da Bologna: tuttavia vorrei essere j>re- sente all'opera, e lo disse in modo che fece ben conoscere la forza di questo discorso, essendo Cavaliere da intraprendere
1 Questa illusione era coltivata dagli im periali: quando il 15 ottobre il plenipotenziario austriaco M.se P rie passò da Bologna, ai Senatori" che lo visitarono assicurò che l’imperatore voleva conservare tutta la libertà di una così degna e gloriosa Repubblica. Parole, osserva il Ghiselli (L X X II , 570), che avean più del sedizioso che del veridico.
* G h is e l l i , L X X II, 394.
L. SIMEONI LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 119
qual [si] voglia gran risolutione. Proseguì poi il Generale a dire che bisognava fare una Spianata attorno alla città per un miglio di giro, cosa che sarebbe stata di grandissimo danno per gli Orti, e campagne circonvicine e per le Chiese, e per le Case di Citadini, eh’ in gran numero si trovano in questo contorno. Ch’ era necessario fare due recinti di fosse, uno per l ’aqqua', l ’altro per riparo. I Senatori non risposero mai cosa alcuna, ma radunatasi poi l’Assonteria et andatovi il detto Generale, replicò l’istesse cose, parlando sempre in termini dispositivi. Vi erano ancora le altre Assonterie di Camera, di Governo e di Magistrato. Finalmente il Senatore Co. Gio. Gaspero Grassi prese la parola e disse: Chi ha da spendere, Signore
Generalef et egli rispose: Il Publico. Soggiunse il Grassi: Noi siamo amici de’ Tedeschi, de* Francesi, de’ Spagnuoli e siamo
sudditi fedeli di Santa Chiesa, non l’ habbiamo con nissuno, nè abbiamo occasione di armarci, se ella ha questo genio, e se
il Santo Pontefice vuole abbracciare queste spese, a loro tocca
il farle, noi dobbiamo essere difesi dalla Santa Sede conforme
gli accordati, senza sentire alcuna gravezza. Circa poi alle ope- rationi speriamo che Sua Santità prenderà quelle rissolutioni che sono proprie della sua inarrivabile prudenza e somma clemenza verso questa città, che non ha verun sentimento che
[non] sia tutto devotione verso la Santità Sua e verso la Santa
Sede, e qui lini il discorso, ma sopra tali propositioni si spedì a Roma.
Questo Signore Generale non era molto gradito, o forse per naturale inclinatione del Paese, che malamente soffre ch’un Cittadino pretenda comandargli, o perchè veramente egli si rendesse poco amabile col suo modo imperioso e superbo, che fu appunto quello che lo rovinò in Germania, come vedessimo altrove ».
Chiaramente a Bologna non solo il Legato, ma anche il Marsili non godeva troppe simpatie, specie nella veste di esecutore di ordini papali a danno dell’autonomia cittadina e lo si desume dal vedere come spesso gli ricordavano con parole oblique la
120 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
sua disgrazia in Germania.1 Ma è curioso osservare come il Marsili, malgrado queste punzecchiature, si sentisse abbastanza bolognese da non lagnarsi mai del Senato,* anzi farne gli elogi al Paolucci nelle sue lettere, rovesciando, come i suoi concittadini, tutto il torto sopra il Legato.
Il Ghiselli prosegue il suo racconto rilevando come il Marsili si prodigasse per riparare all'inerzia altrui e allo stato disastroso dell’esercito facendo tutti i mestieri, riuscendo così, senza volerlo, a farne un altissimo elogio.
« Del resto egli faceva una figura che a longo andare non poteva durare, le conveniva non solo sostenere il posto di Sar- gente Generale, ma di Brigadiere, Proveditore, da Capitano, e sino degli ultimi Uffìtii della Guerra, con una fattica immensa essendo sempre a cavallo, o a Forte Urbano, o a Ferrara, o a Faenza, o in altro luogo secondo che la necessità lo portava,
1 In un ricevimento in Braveria avendo il Marsili, scherzando, detto al Sen. Fr. Davia : Siete rimasto pazzo come eravate, si senti rispondere : Ci siamo conservati pazzi entrambi, ma io però mi sono conservato cavaliere onorato : il Marsili finse di non sentire. (G h is e l l i , L X X I I ,
f>32). Caratteristico ricordo di questi attriti è il titolo apposto dal Marsili al volume 144 dei suoi Mss. che riunisce le lettere dell’Assunteria dal 1708 al 1711: Lettere del Regimentó, ed Assonteria del medesimo scritte a Lu ig i M arsilli, e che punto non corrispondono poi al predicato, che esso Regimentó ha fa tto della di lui Persona, cioè che non s ij uno Buon C itta dino e queste saranno Testimonio ai Posteri, se meritasse una tal im postura.
2 Nel D iario del Senato (X I, 1706, 14) vi sono i verbali della visita fatta al Marsili il 19 settembre e della restituzione di visita avvenuta il 4 ottobre, con ogni precisione di particolari specie dell’ aver il generale in casa sua dato ai Senatori la mano destra e le sedie di primo posto. Ecco la relazione che dà una idea di questi curiosi documenti che mirano solo a precisare dettagli di etichetta, come norma per l'avvenire.
T. Gen. M orsig li visitatoAdì 19 settembre 1708.
Trovandosi in Bologna il T. Generale Marsigli Cavaliere di questa patria e promosso dalla Santità di N. Sig. al grado di Generale con autorità nelle tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna, l ’Ill.mo
L. SIMEONI LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 121
sovrastando poi a un esercito non ancora compito, e spogliato di tutto il bisognevole, senza armi, senza viveri, senza muni- tioni da guerra, senz’habiti, senza letti, insomma destituito d’ogni provisione: gente poi indisciplinata affatto e ch’ad ogni piccolo incontro era capace di ritirarsi, ond’era da credere eh’ egli potesse havere puoca speranca d’ acquistar fama nella condotta di gente così imperita nel mestiere delFarmi, guidata da Capitani et Ufficiali inespertissimi, e quasi tutti giovinetti che mai havevano veduto a suoi giorni principio alcuno di quelli insegnamenti, che sono necessarii a buoni soldati, e questo era un mal generale nello Stato Ecclesiastico ove i preti amano d’haver gente inesperta di tal mestiere ».
Le parole, sia pur appassionate, del canonico Ghiselli, rappresentavano con troppa esattezza la situazione trovata dal Marsili in Romagna. Dopo nove settimane, non trovò a Faenza quasi niente di fatto per magazzini e polveri, tanto che il cardinale Gualtieri legato di Ravenna gli suggerì di portare la piazza d’armi a Bologna, cioè nel territorio di un altro Legato 1. Era
S. Confaloniere destinò li SS.ri Senatori Ghirlandi e P av ia a fa r li v isita in nome pubblico et in feragliolo secondo il costume di somiglianti Personaggi.
Si partirono essi dunque da Palazzo nella Carrozza del Sig. Senatore Ghirlandi nella quale hebbe luogo il S.r Segretario Maggiore, et alcuni altri della Cancelleria andarno nell’altra Carrozza del S.r Davia serviti in oltre detti Signori da alcuni Mazzieri e Cavallari senza però Pubblica Livrea.
Giunti a Casa Marsigli furono incontrati alla Porta da alcuni Ministri del T. Generale, et ascendendo le Scale trovarono al principio delle Scale Superiori il med. S. Generale, che si fece loro incontro e li accolse, dando loro la mano destra, e passando per la sala grande alle stanze del suo appartamento li introdusse nella seconda, dov'erano preparate le sedie, tenendo il primo luogo quelle de SS.ri Senatori, l ’ultimo quella del S. Generale.
Dopo un’ esteso complimento nel quali li SS.ri Senatori trattarono d’Eccellenza il S. Generale, esso d’ Ill.m i li SS.ri Senatori, si licenziarono e furono favoriti da S. Eccellenza sino alla Carrozza, havendoli esso voluto vedere partire.
1 AI ss. M arsili, L X X II, 20 sette. 1708 al Paoluci.
impaziente di vedere quello che avevano fatto a Bologna e specie a Forte Urbano, ma quando lo vide così abbandonato di materiali e palizzate gli crepò il cuore. Invece dei 30.000 scudi assegnati ai lavori, il Vicelegato ne avea mandati 1000, disanimando il castellano e gli operaix. A giustificare l’inerzia si erano affrettati a dire che i lavori ordinati richiedevano non 40.000 scudi come diceva il Marsili, ma 75.000, intanto non facevano niente. € ’era una tale incertezza che a Bologna, i mura tori incaricati di riattare le mura, non lavoravano temendo di non essere poi pagati.2 11 Marsili di fronte a questa situazione esclamava:
« Mi figurava che la pratica del mondo mi avesse insegnato di conoscere un poco gli affari, ma mi dichiaro che nella simetria di Governo di Bologna, non intendo nulla, e per questo anche è desiderabile di esserne lontano » . 3
A Ferrara, dove il Casoni era pieno di buona volontà, trova che nella Cittadella di Ferrara avevano costruita una contro- scarpa troppo alta e bisognava demolirla.
Se disastroso era lo stato dei lavori; quello dei soldati era pessimo. Xe erano arrivati circa 6000, bella gente, ima erano quasi nudi, in calzoni di tela, senza uniforme, ed armati solo di moschetti troppo pesanti a cui non erano abituati. Chiedeva da Roma ordini di fuoco, di .somma violenza ai mercanti di panno, per concentrare a Bologna, nel salone di re Enzo, tutti i sarti e farli lavorare giorno e notte ai vestiti prima che sopraggiungesse il freddo. Gli ufficiali superiori non si erano mossi da Roma dove intrigavano per avere miglioramenti economici.
« Supplico V. E. di non tardar a far che la Santità di N. 8. ordini precisamente che tutti gli ufficiali cioè colonnelli, tenenti colonnelli, sergenti maggiori etc. si rendano al comando di queste truppe; altrimenti non è possibile diriggerle, tanto per l ’economico che militare governo. Spero che in quattro o cinque
122 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
1 Mss. M orsili, L X X II, 6 ottobre 1708 al Paolucci.2 G h is e l l i , L X X II.3 Mss. M orsili, L X X II, 22 settembre 1708 al Paolucci.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 123
giorni arriveranno li soldati vecchi da Roma per disporli come caporali. Sono già tre mesi che si fanno truppe e sin a quest’ora non vi è alcuna bandiera fatta da dare a una compagnia, dovendo queste marchiarne senza » . 1
La disciplina naturalmente era nulla : se i soldati disertavano, non c’era modo di punirli, e gli ufficiali inferiori non facevano fare gli esercizi, ed erano talmente inesperti che, durante le marce, perdevano i loro soldati che marciavano come volevano.
« Non sarà possibile a lunga durata di governare un ammasso di gente militare senza che vi sia il fondamento del gastigo contro li rei. Qui ogniuno fa ciò che vuole : ogniuno si fida nelle raccomandazioni e protezioni. Le diserzioni sono così familiari che un soldato fugge da un reggimento e va nell’altro, o pur che se ne ritorna alla propria patria senza che vi sia gastigo dovuto a desertori. Gli uffiziali nulla temono, e solamente parlano di paghe, foraggi, pane, utensili, e niente di pigliar guardia alla gente e di fare gli esercizi, come se nel servizio di N. S. si dovesse essere trattato superfluamente, e senza debito di guadagnar tali trattamenti. Il S. Card. Casoni in Gabinetto meco conoscendo tutti questi abusi si era fatto furioso più di me. Lo consigliai col dovuto rispetto, a dar un breve tempo carrican- domi io di rappresentar tutto a N. S. per lo mezzo di V. E., affinchè ne interceda un pronto rimedio, altrimenti li tesori della S. Sede non saranno che tutti gettati. Devo portare un esempio alla E. V. che nella marchia di ieri al Forte Urbano si presentarono avanti di me un Capitano, Tenente ed Insegna di una compagnia, ed uffiziali che mai avevano servito e mi dissero che trenta uomini della loro Compagnia, quali avevano bona gamba, si erano tanto avvanzati, che non sapevano dove fossero. Può V. E. immaginarsi se fosse stato in altro servizio che quello di N. S. cosa avrei fatto. Li gastigai con una fiera riprensione, ma questa si soffre volontieri purché li scudi 50 al mese corrano. Non vi é più tempo da perdere a stabilire un sodo rimedio a
1 Mss. M um ili, L X X II, 226, 22 sett.
124 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
questi disordini, perchè N. S. non veda gettata la gran somma di denaro che impiega » . 1
E ancora ai 9 di ottobre rinnovava le sue sollecitazioni, perchè questa gente fosse vestita ed armata, perchè venissero gli ufficiali superiori, perchè si stabilisse una disciplina e un ordine nel soldo delle truppe giacché, osservava, il fondamento di una organizzazione militare è il castigo e la mercede puntuale. Mancando un elenco esatto dei soldati, il soldo era affidato agli ufficiali che vi lucravano sopra, e quanto ai metodi paterni, sarebbero piacuti anche a lui, ma senza castighi severi non poteva esserci disciplina. 2
Gli ufficiali di fanteria non si erano provvisti il cavallo, sicché non si poteva far marciare la gente: e i Governatori e Legati per non molestare i privati requisendone i cavalli, prendevano quelli delle poste disorganizzando il servizio, sicché per spedire un corriere si doveva farlo passare da Firenze. Il Mar-
1 Mss. Marnili, L X X II, 169.
1 Rinnovo le mie più riverenti e premurose instanze perchè la Gente sia montata ed armata, perchè se questo procede, non siamo più in istato di intrapprendere marchie ne’ tempi piovosi che già cominciano ad essere freddi non che fangosi. Non vi sono colonnelli, e pochi t. colonnelli e quasi verun sergente maggiore che sia alle loro carriche e per questo mai stabiliremo ne’ corpi la necessaria disciplina. L ’anema dello Stato m ilitare per servigio del Prencipe è il gastigo e la mercede puntuale che sin ad ora non sono nel loro essere. Disertano, non vi è castigo : le mercedi si fidano agli uffiziali sotto nome di qualche denaro a buon conto : non si fanno mostre E per questo non seguono li necessari conti a sollievo del gregario soldato e dell’Erario di N. S., e poter vedere a che somma ascendono le diserzioni et individuare di quale Comunità sono li desertori, per dar effetto al decreto di N. S. consigliatogli dalla Congregazione acciocché le medesime Comunità r ispondessero dei fuggiaschi.... Vorrei fosse fruttuosa la dolcezza o lisemplici complimenti, e servirmene per poter metter la disciplina e la puntualità al servizio di N. S., e mi lusingo lo saprei fare, e che sarebbe più del mio genio che d’esser obbligato a parlar a loro aspramente, non per il mio interesse et inclinazione, ma per debito verso N. S. (Mss., L X X II, 9 ott.).
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 125
sili con i suoi rimproveri contro questa gente si faceva odiare, tanto più che a Roma i generali si vantavano di aver ottenuto dei vantaggi agli ufficiali a dispetto di lui : egli si diceva stanco di difendere l’erario contro l’avidità di quella gente che si era assicurata delle paghe superiori a quelle degli ufficiali inglesi è olandesi. Poiché tutti rubavano era deciso a profittar anche lui della cuccagna, ma a Roma si sarebbero accorti che cosa voleva dire cedere a quella gente che avuto il foraggio voleva avere anche le selle, le coperte ecc. I meno ladri di questi ufficiali erano quelli presi dalle famiglie nobili, ma anehe per questi vi erano stati pettegolezzi per la mancata nomina dell’uno o dell’altro attribuita a gelosie o rancori del Marsili. Inoltre se dei nobili avevano levate delle compagnie a loro spese, verso la conferma di certi privilegi, si trattava di una così povera cosa che nelle rassegne « apparvero, dice il Ghiselli, così inesperti e mal montati che non si poteva veder peggio » . 1
L ’esercito era composto, o di gente arruolata per riscuotere la doppia che era promessa, — e questi erano per lo più gente violenta, pregiudicata, banditi graziati, che poi commettevano violenze, (anche nei conventi) peggio dei turchi diceva il Legato Grimaldi —, ovvero era gente di leva, contadini presi per forza alle Comunità, che non sapevano far nulla, sempre pronti a disertare. Accadevano anzi degli strani incidenti, come quando i Pe poli trovando lesivo dei loro privilegi l’editto di leva, andarono fino a Ravenna a riprendere i loro contadini arruolati, facendo violenza alle sentinelle del quartiere, senza essere poi molestati seriamente. 2
Questi soldati, farabutti o disgraziati, erano esasperati anche dalle condizioni di abbandono e quasi nudità, e dalle complicazioni del soldo. Proprio in quei giorni il papa avea alterato la moneta, stabilendo una nuova tariffa per le monete, cioè modificando il rapporto fra lo scudo, i giulii e i baiocchi. Il
1 G h is e l l i , L X X II, 391.2 G h is e l l i , L X X II, 432. A rendere difficili g li arruolamenti contri
buiva la voce sparsa da emissarii imperiali, che i soldati sarebbero mandati a Malta.
126 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
giulio che prima valeva 10 baiocchi, ora invece equivaleva a10 baiocchi e 4 quattrini e così il resto in proporzione. Ma i bottegai non volevano ricevere uno scudo per questo valore sicché la moneta piccola spariva perchè la tenevano nascosta, sperando nel ritiro della tariffa. I disgraziati soldati quando mangiavano nelle osterie baruffavano con gli osti per il valore delle monete, in modo che vi era un forte malcontento e degli esercenti e dei soldati.
Il contado molestato dalle scorrerie e ruberie dei tedeschi sentiva di più il pericolo ed era anche disposto a menar le mani, a dar la caccia ai foraggiatori e ad ammazzarli, applicando l’ordine papale; la città invece considerava la minacciata invasione come una molestia procuratale dal papa, e, fidando nelle voci degli emissarii, si lusingava che Bologna venisse rispettata, perchè gli imperiali miravano tutt’al più a Ferrara. Quindi i preparativi militari da un lato suscitavano il disprezzo, dall’altra preoccupazione (come in D. Abbondio l’azione dell’innominato contro i Lanzichenecchi) per timore che provocassero qualche seria azione degli imperiali, mentre le misure che faceva adottare il Marsili, murare alcune porte, o magari tenerle chiuse tutte da un pomeriggio all’altro, per impedire che la notizia di qualche spedizione arrivasse al nemico, destavano vivaci lamenti di chi era rimasto chiuso fuori o dentro la città, proprio in un’epoca di grande traffico come erano quelle settimane della vendemmia. Si era data acqua alle fosse della città che da anni erano in secco, e molte cantine, che si vede aveano finestre abusive, erano rimaste allagate, molestie piccole e grandi che sembravano insopportabili a chi non si sentiva affatto in stato di guerra.1
Che questo fosse lo stato d’animo della popolazione lo si vede da quello che si faceva o proponeva per allontanare il pericolo. Mentre il Senato, stimolato dal papa e dal Marsili pren
1 A d es. l 'o rd in e d i ra c co g lie re g l i a rch ib u g i p e r a rm a re i s o ld a ti
a v e v a d es ta to i l sospetto ch e si vo lesse in vece d is a rm a re la p op o la
z ion e . A k c h . V a t ic a n o , Lettere del Legato, 10 o ttob re .
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 127
deva delle misure militari1 la massa della popolazione si preoccupava molto meno. Lasciamo pure quell’originale che proponeva, come rimedio contro l’incombente sciagura, di guadagnarsi il favore del cielo coprendo le scandalose nudità del Gigante (e il Ghiselli ha creduto opportuno conservare la supplica!); si può dire ¿he le precauzioni maggiori prese in città furono le processioni straordinarie fatte col corpo di <S. Anna e con la Madonna di S. Luca, che diedero poi occasione a numerose beghe fra Canonici, frati e Confraternite per i posti nei cortei, obbligando ad intervenire il Confaloniere per accomodarle, senza risolverle, vertenze, che probabilmente gli devono aver date più noie dei Tedeschi stessi.
In mezzo a tutta questa inerzia, il Marsili faceva l’impossibile per affrettare i lavori e l’armamento sentendo prossima l’invasione: quando c’era qualche cosa di rischioso o diffìcile lo eseguiva personalmente, portando ad es. un corpo di truppe a Cento, con 15 ore di marcia, in mezzo alle domestiche spie degli
1 I I Marsili non avea mancato di eccitare il Reggimento di Bologna a una seria resistenza : con una lettera assai seria e severa del 3 ottobre da Faenza ricordava al Senato che il Papa avea dato ordine positivo che non si desse il minimo aiuto agli Alemanni e si impedisse con ogni risolutezza le loro rapine. Bologna era minacciata quanto Ferrara malgrado le voci sparse: ad essa toccava organizzare il cordone dei confini da Bazzano a Orevalcore, e difendere il recinto della città affidato a ll ’unione e valore di tanta nobiltà e cittadini. La risposta del Senato (5 ottobre 1708) è ricca di proteste di fedeltà « ad ogni rischio di sostanze e di vite, per In perpetuità del presente Governo, per la gloria del nostro Sommo Pontefice » ( cioè l ’autonomia cittadina anzitutto !) malgrado si preveda che « senza li tante volte implorati soccorsi di truppe regolarii l nostro Territorio sia per soccombere ad una irreparabile devastazione e le nostre m ilizie e paesani ad una deplorabile strage » : e chiude affermando che « ancorché lo scorgerci sproveduti del bisognevole e quasi affatto abbandonati possa in gran parte debilitare il vigore delle nostre difese » imiteranno il suo esempio di energia e coraggio. I l lamento era rivolto non al M arsili ma al Legato, al quale lo stesso generale li avea eccitati a presentarsi per ottenere che trasformasse « i consigli verbali in risolute operazioni ■». A r c h . St a t o d i B o lo g n a , Lettere al Senato 1708-9 e Lettere del Senato 1708.
128 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Alemanni « con quella soldatesca, nuova, mal calzata e peggio vestita nel fango sino alla cinta ».
Il suo proposito sarebbe stato di guernire seriamente la Cittadella di Ferrara e Forte Urbano, e di collocarvi nel mezzo un campo mobile per arrestare o frenare le invasioni, mentre Ponte- lagoscuro fortemente munito con barche armate, arrestando i convogli diretti a Comacchio, avrebbe tolto ogni possibilità offensiva a questa posizione minacciosa.
« Io non posso, diceva, far quel che tocca ai Legati : solo indicarlo: le mie occupazioni devono essere quelle di menare le mani a suo tempo » , 1 ma in realtà aveva dovuto adattarsi a fare tutte le parti, e a vedere guastati i suoi progetti dalle intempestive disposizioni dei Legati che avrebbero voluto salvare tutto, mentre diceva « io sono chirurgo che non avrò riguardo a tagliare qualche parte per conservare il sodo delle piazze e dar tempo al tempo». Il card. Casoni aveva fortificato il Bondeno contro il parere del Marsili, immobilizzandovi 2000 uomini, mentre il posto era troppo vasto per difenderlo e sarebbe subito caduto. Uguali preoccupazioni egli nutriva per Pon- telagoscuro, punto importante, ma troppo poco fortificato. E le sue previsioni dovevano verificarsi completamente, salvo che egli riuscì a tempo a salvare gli uomini di Pontelagoscuro come di Cento.
* * *
Mentre così il Marsili si affannava e doleva con poco frutto e molte dolorose previsioni, gli imperiali stavano per arrivare, appunto per impedirgli di rendere solide le sue difese. L ’imperatore con l’occupazione brutale di Comacchio si era tirato addosso un vespaio, ed ora, poiché, contro i suoi calcoli, il Papa, invece di cedere, si armava, bisognava soffocare questa ostilità prima che si facesse veramente pericolosa e potesse divenire il nucleo della Lega italiana progettata dalla Francia, approfittando dei vantaggi ottenuti nelle Fiandre, che escludevano per il momento
1 Ai ss. M arsili, L X X II, Lettere al Paolueei dell’ottobre.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 129
un soccorso francese al Papa. Di più gli alleati all’Aia avevano fatto il viso dell’arari a questa mossa imperiale che minacciava di distogliere truppe imperiali dallo scacchiere per loro più delicato delle Fiandre, per mettere a posto i pappagalli. 1
L’ordine imperiale al Daun di lasciare il Piemonte per portarsi nel Ferrarese, è del 29 agosto, e l’ordine venne rinnovato al Daun il 26 settembre in forma assoluta. Bisognava marciare su Roma, mettere alla raison la Corte Romana, far vivere le truppe sul paese, punire esemplarmente i malintenzionati ecc.2
Come si vede non furono, come molti credevano, gli atti di ostilità avvenuti nel Ferrarese a provocare l’invasione, perchè la marcia era già decisa, essi offrirono solo un comodo pretesto.
I principali di questi atti di cui le due parti si palleggiavano la responsabilità e le atrocità erano questi: ai primi di settembre quattro corazzieri e una cornetta che accompagnavano dei foraggiatori erano stati uccisi dai contadini a Longastrino e il card Casoni avea, a ragione, rifiutato di dar soddisfazione: c’era l’ordine del Papa di resistere con le armi! Il card. Gualtieri avea organizzato una spedizione su Argenta il 16 settembre, e 30 uomini e un capitano erano stati uccisi; tanto che il Konigsegg si era ritirato con la cavalleria sul Finalese. Ma per rappresaglia il 26 settembre una banda di 300 tedeschi a S. Agostino presso Castelfranco che voleva del foraggio, aperse il fuoco improvvisamente sui pontificii ammazzandone o ferendone circa cinquanta. 3 A sua volta il Bonneval, ricevuti rinforzi dal mare con tolleranza di Venezia, (perchè a Ponte Lagoscuro due barche armate di artiglieria avevano catturato quattro barche cariche di munizioni per Comacchio) si era vendicato piombando su Longastrino, dove avea fucilato parecchi villani ar
1 Cosi, secondo il L a m b e r t i (V , 89), si chiamavano a ll’A ia i soldati del Papa, amico di Francia.
2 Campagne del Principe Eugenio, X, 196. 197.3 l i Legato riferisce (lett. del 26 sett.) che i soldati erano fuggiti
come lepri. A sua volta il Segretario Card. Paolucci dice che il Papa si stupisce (6 ott.) sentendo che i soldati avevano ordine di non sparare, i l che è contro la sua mente di difendersi. A r c h V a t ic a n o Bologna, voli. cit.
io
130 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
mati, poi su Ostellato, fugando il presidio, che vi avea perduto 200 uomini, dando fuoco al paese, ed impiccando, fra gli altri, un prete perchè diceva che questi eccitavano i villani e davano, come era l’ordine del Papa, nelle campane appena gli imperiali erano segnalati: il Marsili ilice che vide ad Ostellato orrori e profanazioni peggiori che in Turchia. 1
Ma queste non erano che forme crudeli di rappresaglia, la vera invasione si ebbe il 26 ottobre quando il Konigsegg attaccò il Bondeno, e il Daun avanzò dalla via Emilia. Accadde rapidamente ciò che il Marsili avea temuto e sconsigliato : Bondeno cadde il secondo giorno con 2000 prigionieri: Pontelagoseuro fu sgombrato, ritirandosi i 1000 uomini di guarnigione a Ferrara, Forte Urbano e la cittadella di Ferrara furono bloccate e a Bologna si presentava il colonnello Pallavicino intimando di preparare quartieri per le truppe. Non vi era nulla da fare che sottomettersi. Ma, a dir il vero, lo si fece forse con troppa grazia, poiché al Daun come al Konigsegg, quando passarono per la città, il Senato si affrettò a far una visita di omaggio, tenendo nota precisa del Diario dell’etichetta seguita. Marsili e Daun di fronte ai segreti del cerimoniale non differivano punto, anzi quando, fatta la pace, il Daun ripassò l’8 febbraio per Bologna e volle egli stesso restituire la visita, il Con- faloniere commosso ne fece una particolare relazione al Senato, rilevando che Daun teneva in pugno il bastone di comando che il Senato gli avea regalato. Era proprio vero che Bologna non faceva parte dello Stato ecclesiastico con cui il Daun era stato in guerra ! Al povero Marsili non toccò punto tanto onore al suo ritorno nell’aprile, benché avesse adempito sino all’ultimo il suo dovere verso il Papa.
1 II Marsili descrive lungamente il suo accorrere in soccorso di Lon- gastrino e Ostellato, avvenuto troppo tardi perchè la sua jjartenza stabilita per il 15 sera, data la cattiva esecuzione degli ordini avvenne solo il 16 sera. Mss. M arsili, I.X X II. Per imparzialità si deve ricordare che nelle Campagne del Principe Eugenio, X, si accusano i pontifici di aver ad Argenta sventrato una donna incinta, moglie di un ufficiale austriaco.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 131
Quando l’invasione temuta si delineò sicura il Marsili si affrettò a far ritirar le truppe da Cento, proteggendone la ritirata con pochi cavalieri, mandò il Reggimento Albani ad Imola ed accorse con 80 cavalli a Forte Urbano per vederne lo stato e lasciare gli ordini. La visita inaspettata sollevò il morale di quella povera gente e il Marsili nel lamentare col Paolucci le deficienze (dovute sempre al Legato!) della fortificazione, del vestiario e del vettovagliamento, si compiace del buon contegno dei soldati e del comandante col. Bussi.
Nel tornare a Bologna dovè sfuggire gli agguati tesigli dal nemico : lasciò la via Emilia, si tenne alle colline, e camminando tutta notte, carne un tartaro, arrivò al mattino a Porta S. Ma- molo mentre tutti a Bologna lo credevano già prigioniero, voci sparse, dice il Marsili, da quelli stessi che avevano fatta la spia al nemico della sua corsa. In compenso gli imperiali catturavano un convoglio di vestiti al Samoggia che, solo adesso, il Vicelegato mandava a Forte Urbano.
A Bologna intanto arrivava un trombetta che precedeva il col. March. Pallavicino con le intimazioni del Daun alla città e al Legato.1 Marsili, che si trovava presso quest’ultimo per confortarlo, dovendo restare con i tedeschi in una città che non lo amava, si prestò a combinare i termini dell’abboccamento, poi, uscendo dalla città verso la pianura, mentre le pattuglie nemiche lo attendevano verso i monti, arrivò il 6 ad Imola, e di lì passò a Faenza, cercando di raccogliere la gente dispersa, mantenere un po’ la disciplina, salvare le artiglierie e i depositi, dar fuoco ai foraggi abbandonati. Nella marcia a Faenza corse rischio di essere ucciso perchè capitato fra dei fanti in ribellione del Reggimento Malvezzi, uno di questi lo prese di mira col fucile. Il colpevole e un altro furono fucilati davanti
1 I I Pallavicin i arrivò con 40 cavalieri il 4 novembre : oltre i quartieri pretese degli ostaggi bolognesi per il passaggio sicuro delle truppe e la garanzia che la popolazione non prendesse, sino alla pace, le armi. A r c h .
V a t ic a n o , Lettere del Legato, 4 novembre. Le altre notizie sono desunte dalla corrispondenza del Marsili, Mss. L X X II I .
132 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
alle truppe, anzi si fece l’estrazione a sorte di un soldato ogni venti per la decimazione: ma a questi finì col conceder grazia.
Colla perdita di Bologna e l’avanzata delle truppe cesaree nelle Romagne, l’opera del Marsili non perdette affatto delle sue attività e importanza. Bisognava aiutare a resistere le due fortezze bloccate di Forte Urbano e Ferrara spedendo loro denaro, in quanto servivano a immobilizzare truppe, salvare le poche forze disponibili e le fortezze che potevano arrestare o rallentare l’avanzata su Roma.
Il Papa gli avea ordinato di non ritirarsi per ultimo, col pericolo di essere tagliato fuori dal nemico: giustamente lo voleva presso di sè per il caso di un avvicinarsi degli Austriaci. Ma il Marsili, fidando negli scarsi mezzi del nemico,1 non gli obbedì che a metà : provvide perchè le poche truppe buone si portassero nell’ Umbria e si concentrarono a Narni,2 luogo ove confluivano le due strade dell’Appennino, egli invece si appostò verso Candiana per chiudere la via più breve che avrebbe portato verso Città di Castello. In pratica, dato che vi erano più vie possibili, non era facile, con i pochi mezzi alla mano, occuparle tutte sicuramente. Quando l’invasione parve fermarsi a Ravenna e Forlì verso il 21 novembre, sia per la speranza di pronti risultati delle trattative, sia per l’inverno rigido, il Marsili si fermò ad Ancona dove avea fatto portare tutte le artiglierie delle fortezze che si dovevauo abbandonare per salvarle. E ad Ancona rimase lavorando 3 fino alla pace, a riassettare la fortezza dove tutti gli affusti dei cannoni erano putrefatti, e non vi erano alloggi neppure per 200 uomini, sì che avea dovuto attendare le truppe dentro il recinto ! 4
1 Erano in tutto 5000 fanti e 4000 cavalieri. Campagne del Prìncipe Eugenio, X, 201.
2 Lettera a l Paoluoci, 21 novembre 1708. Mss., L X X III.3 II P o m e t t i, erroneamente dice (op. cit., 398) « I l Marsigli giunto a
Fano e ritenuta inutile ogni opposizione, disciolse i suoi e se ne tornò a R o n m ».
* Lettera al Paoluccl, 9 dicembre 1708. Mss., L X X III,
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 133
A Roma intanto le trattative andavano in lungo, perchè il Papa e il Paolueci, per quanto spaventati dalla minacciata invasione, opponevano al Marchese Prié una tattica dilatoria contraria all’urgenza imperiale di finire subito la spedizione. Già si era cominciato con il rifiuto di riceverlo come plenipotenzario: il Papa lo ricevette in piedi, come un visitatore qualunque, e neppure in abito di cerimonia, ma di campagna : Paolucci poi, quando si venne a trattare, si limitò a offrire il disarmo verso10 sgombero dello Stato e garanzie contro attacchi del Duca di Modena e della flotta inglese. Carlo I I I sarebbe stato riconosciuto re, ma senza indicazione di regno. In realtà il Papa si mosse ben poco da questa linea, benché il Daun accusando il Prié di debolezza, gli inviasse un consigliere militare, il barone di Zumiungen e il 12 dicembre da Vienna venisse formulato un ultimatum da accettarsi entro il 15 gennaio, nel quale si esigeva anche l’ammissione della sovranità imperiale su Parma, Piacenza e Comacchio, lo scioglimento delle alleanze ostili all’impero, e11 riconoscimento di Carlo re di Spagna : 1 del rifiuto dell’omaggio per Napoli non si parlava quindi già più.
La occupazione austriaca durante queste lungaggini si estendeva verso Sud, arrivando sino a Pesaro e Jesi, ma puramente per necessità di viveri, e il Daun era così preoccupato dei danni che subivano le truppe senza quartieri d’inverno, mal alloggiate e nutrite, che diceva che bisognava o marciare su Roma o tornare indietro,2 perchè altrimenti queste forze non sarebbero più state in grado di marciare con l’aprirsi della nuova campagna. Nè in miglior stato era l’attacco dal Sud, che il Principe di Assia Darmstadt avea iniziato per ordine di Vienna le cui poche truppe erano quasi senza viveri e diradate dalle diserzioni provocate dai premi offerti dal Papa. 3
A decidere il Papa a cedere la sera del 15 gennaio, oltre l’invasione, molesta ai popoli, ma poco pericolosa per Roma, dovè contribuire il riapparire nel Tirreno della flotta inglese
1 Campagne del Principe Eugenio, X, 204.2 Campagne del Principe Eugenio, X, 211, 6 gennaio 1709.3 Campagne del Principe Eugenio, X, 208.
134 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
che già aveva minacciato di bombardare Civitavecchia. Così il trattato fu firmato, ma in realtà anche l’impero aveva ceduto rinunciando alle pretese di sovranità su Parma, Piacenza e Co- inacchio nonché sul Regno di Napoli e al riconoscimento immediato di Carlo come re di Spagna, e accontentandosi del disarmo, già offerto dal Papa in novembre. L ’imperatore ritirava le sue truppe, man mano che l’esercito pontificio si riduceva al piede di pace, ed offriva anche garanzie per le ostilità di Modena, come per quelle inglesi che non erano pattuite, ma assicurate lo stesso. Per Parma, Piacenza e Comacchio si trovò l’eufe- nismo che una Commissione di Cardinuli col Prié esaminerebbe la questione « ma non in veruna forma di giudizio, bensì per un appagamento comune tra S. Santità e l’imperatore ■».1
Era una rinuncia così chiara che il Duca di Modena protestò vivacemente contro questo articolo che mandava a vuoto ogni sua speranza. E in Italia, malgrado il mantenimento di un piccolo presidio a Comacchio (piccola concessione all’amor proprio imperiale) tutti assicuravano che l’incidente era chiuso, come infatti fu in realtà. Malgrado tutti i fieri propositi di ridurre la corte romana alla raison, l’impero non era in grado, data la situazione generale e locale, di compiere sul serio la minacciata marcia su Roma e per le forti pressioni alleate si
1 L a m b e b ty : Mémoires, V, p. 245. Testo del Trattato in italiano e francese. Anche le clausole segrete riguardanti Carlo I I I , non erano cosi disastrose (vedile in P o m e t t i , op. cit., 407, in una lettera del Paolucei a Mons. Piazza a Vienna) perchè per avere un riconoscimento generico regio, Carlo si impegnava a ritirare prima tutti i decreti di Milano e Napoli che proibivano di inviar denari a Roma, ristabilire in Parma e Piacenza la potestà spirituale, reintegrando lo Stato ecclesiastico dei danni sofferti pel soggiorno degli Alemanni. I l Papa per la Spagna riconosceva lo stato di fatto, cioè due re, contemporaneamente, senza stabilire quale fosse il legittimo.
E ’ vero che dalle lettere del Paolucci al Piazza ( P o m e t t i, op. cit., 408) appare l'angustia in cui si trovavano a Roma, ma questo non toglie il fa tto che si cedesse solo dopo due mesi e mezzo, e che le lettere del Daun e del Principe Eugenio mostrino che l'invasione non era cosi minacciosa come si potrebbe credere.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 135
doveva rassegnare a liquidare il dissenso, rinunziando alle sue pretese come gli avea scritto il Principe Eugenio nel dicembre :
« Riguardo poi alla marcia su Roma, V. M. mi permetterà di rappresentarle con umilissimo respect, che bisogna conside riren S. Santità non solo coirne Principe terrestre ma anche come Capo della Chiesa Cattolica, e per questa ragione crederei doversi ben ponderiren la cosa ed essere molto meglio, che nella speranza suespressa e nelle presenti favorablen conjuncturen le truppe di V. M. I. non abbiano da avanciren proprio sino a Roma, tranne il caso che non vi fosse altro mezzo e le circostanze volessero così » . 1
E pochi giorni dopo esponeva con più vivacità le insistenze alleate e l’urgenza di finire il conflitto.2
Ora è assai curioso il fatto che le fonti austriache più serie giudicassero il trattato favorevole al Papa, come era in realtà, mentre nell’ambiente francese (rappresentatoci dal Saint Simòn e dalle Gazzette) si presentasse il Prié come un insolente trion
1 Campagne del Principe Eugenio, X, 355, 2 dicembre 1708.2 Tanto il Mylord (H arlborough) quanto i Deputati dell’ Olanda mi
hanno parlato in termini molto energici degli affari papali, avendo essi ricevuta dalla Francia e da altri luoghi la notizia che quel litig io abbia la probabilità di assumere vaste proporzioni ed hanno detto, che se stando cosi le cose le forze di Vostra Maestà Imperiale avessero da essere im pegnirt colà, essi soli non potrebbero fare qui ogni cosa, e perciò tanto l'uno quanto g li a ltri vorrebbero scriverle, affinchè da quella questione non derivino intoppi alla imminente campagne, delia quale invece si avrebbe tanta ragione di sperare, che abbia da riuscire la migliore, tenuto conto che da parte degli A lleati si vorrebbe fare un effort, e quindi non sarebbe equo, che le armi di V. M. I. fossero adoperate ed usate altrove per una cosa che non è di speciale conseguenza.
Per conto mio ho contrapposto tutti i motivi immaginabili, sia per mantenerli nei loro buoni propositi sia per assicurarli, che da parte di V. M. I. si vorrà fare ed appliciren ogni cosa per risolvere quella faccenda durante questo inverno. Ciononostante essi mi hanno pregato d i volere a nome loro interessare con tutta sommessione V. M. I. a questo proposito, il che faccio subordinatamente con questa mia e non devo tralasciare di dirle umilissimamente, che siamo vicini al mese di gennaio e quindi non rimane più tempo per lasciarsi ulteriormente
136 MEMORIE INTORNO A L. P. RIARSILI
fatore, e il Papa così terrorizzato da pensare a ritirarsi ad Avignone, cosa ridicola essendovi la flotta anglo-olandese nel Tirreno! Era invece anche questa una proposta francese, e chiaramente il rappresentare il Papa come gravemente maltrattato era un piccolo compenso al dispetto di veder svanire la speranza di cagionare all’imperatore un serio imbarazzo coll’acuirsi del con. flitto col Papa. 1
D’altra parte, anche astraendo dai dati precisi del trattato, se si riflette che il Daun non avea che 9000 uomini, di cui una discreta parte era immobilizzata nel blocco di Forte Urbano e Ferrara, e gli si opponevano truppe molto più numerose, anche se scadenti, passi difficili, la campagna ostile, appare subito che quei 5000 Austriaci, che erano ancora di là d’Appennino, poco aiutati dalle scarse e malconcie truppe di Napoli, non potevano rappresentare affatto Annibaie alle porte di Roma! 2 Non vi fu
pascere di vane speranze e menare per le lunghe. Sicché da quanto si è detto sopra V. M. I. con l ’augusta Sua saviezza giudicherà Ella stessa che non vi è pi(l da perdere un momento, per aggiustare senza indugio mediante una tractat la questione papale, ovvero per sbrigare la cosa e indurre alla raison colla forza delle armi. Campagne del P rjn cipe Eugenio, X, 388, 27 dicembre. A ltr i ricordi di questa pressione alleata si trovano in quasi tutte le lettere del Principe di questi mesi, come nel L a m b e r t y , op. cit., V.
1 L ’opera di aiuto della Francia si era ridotta alle chiacchiere del Tessè sulla Lega italiana, che logicamente compromettevano il Papa agli occhi dell’imperatore. I l Tessè cercò di opporsi alla pace con pressioni e lettere insolenti al Papa (riprodotte in L a m b e k t y , op. cit., V, 245) e ricordate con ammirazione dal Saint Simon. Ad es. il 14 dicembre osserva al Papa che se la forza decide in materia di religione (? ! ) sarebbe lecito divenir Turchi, quando questa potenza entrasse vittoriosa in Ita lia : e, i l 12 gennaio, afferma che la Chiesa cattolica non è più a Roma « tant que Rome est dans l’Esclavage: le Souverain Pontife n’ y peut plus ètre pour nous » . Lo stesso Tessè si diede l ’aria di dare consigli al M arsili sull’arresto dell’avanzata nemica in lettere del 10 novembre e 22 dicembre. Mss. M orsili, L X X II, 200, 294.
2 «M a poiché tutte insieme le truppe imperiali entrate nello Stato della Chiesa non superavano i 5000 f. e 4000 cav., ne veniva di conseguenza a motivo del blocco di Ferrara e Forte Urbano, che ì>en poca forza rimaneva per l’avanzata». Campagne cit., X, 201.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 137
quindi un vero trionfo imperiale, e neppure in certo senso una grande umiliazione papale, quale amavano figurarsela a Versailles e si è tramandata volontieri nella tradizione antipapale anche fra noi, quasi non si trattasse di una prepotenza straniera su terre italiane, su un Principe italiano, e in nome di antiche pretese che, realizzate, avrebbero profondamente aggravato la vita politica italiana.
* * *
L’opera militare del Marsili ebbe qualche efficacia sulle trattative e contribuì alla remissività imperiale? Credo che si possa rispondere, senza esitazione, affermativamente, non in quanto l’esercito improvvisato dal Marsili rappresentasse un ostacolo veramente serio per le truppe del Daun, se avessero voluto risolutamente avanzare, ma perchè esso col ritardarne la marcia, col costringerlo a distaccare forze per bloccare le fortezze che resistevano, col concentrarsi nei passaggi obbligati, rendeva la impresa ben più lunga e grave di quello che gli alleati potessero tollerare. Non era all’animo del pio imperatore d’Asburgo che ripugnava il far violenza al Papa e l’arrivare all’estremità di una marcia su Roma che ricordasse i fasti di Carlo V, ma bensì ai calcoli dei suoi alleati e finanziatori protestanti, che non volevano sentir parlare di una nuova guerra in Italia, di ostacoli alla pronta conclusione della guerra e perciò di violenze al Papa che, seguite magari da scomuniche, creassero nei paesi cattolici una ripresa di simpatie per la Francia.
Ora chi impedì la rapida e facile avanzata su Roma — che se breve non sarebbe spiaciuta ai due Stati protestanti — fu appunto l’opera del Marsili che non sognò mai di dare battaglie, ma mirò senza fanfaronate e spavalderie, a creare un’azione militare di difesa, che acquistasse valore dal suo rapporto con la situazione generale. Non doveva essere possibile la incursione di poche migliaia di cavalieri sino alle porte di Roma, come nell’eroicomica guerra di Castro; e perciò con una pronta ritirata, che poteva apparire anche ridicola, bisognava salvare al Papa le poche truppe buone per occupare i passi degli Appennini, ostacolare la marcia, e concentrarsi davanti a Roma. Questo il Marsili
138 MEMORIE INTORNO À L. F. MARSILI
fece seriamente e l’opera sua raggiunse, malgrado gli scarsi mezzi e il poco tempo avuto, un risultato buono, perchè impedì che il Papa si trovasse a subire senza riserve la prepotenza nemica : opera certo poco brillante, ma utile, perchè l’azione militare di un generale va giudicata in rapporto ai mezzi e agli scopi che gli sono prefissi, e non già dai successi clamorosi, in quanto la guerra, malgrado la retorica che spesso la travisa, è solo un mezzo per raggiungere, con l’offesa e la difesa, dei determinati obbiettivi politici.
Il Ranke 1 afferma che col trattato del 15 gennaio 1709 non solo fu diminuita al papato l’autorità arbitrale, ma gli fu tolta anche la sua stessa libertà politica e il diritto di libera decisione. Ora 1’ affermazione del grande storico pecca d’ inesattezza. Anzitutto il trattato non fu per nulla così umiliante; inoltre l’autorità arbitrale del papato avea ricevuto il primo grave colpo sessant’ anni prima nella pace di Westfalia, e se fu certo profondamente abbassata a Utrecht nel 1713, dove si dispose di terre papali come Napoli e la Sicilia senza interrogarlo, questo avvenne non già perchè il Papa avea subito il trattato del 1709, ma bensì perchè si era mutata la situazione europea, e predominavano due stati protestanti: Olanda e Inghilterra. Ma questo era stato deciso nelle grandi battaglie di Baviera e Fiandra e non poteva essere impedito lottando nel Ferrarese o nel Bolognese; anche se Clemente XI o il Marsili avessero avuto truppe migliori, ben poco potevano opporsi al trasformarsi della situazione politica europea.
La difesa dello Stato pontifico affidata da Clemente XI al Marsili nel 1708, non fu per nulla una impresa comica e ridicola, ma per la abnegazione con cui il generale adempì il suo ufficio permise al Papa di negoziare con l’imperatore in condizioni favorevoli e di ottenere, malgrado le apparenze, ciò che egli
1 D ie römischen Päpste cit., I l i , 123 : I l Ranke afferma sulla fede del L a m b e r t i che il Papa riconobbe, segretamente, Carlo I I I come re cattolico, mentre invece non è vero. Anche il breve cenno del Co x e ( Storia della Casa d'Austria, Milano, 1833, IV , 380) esagera la umiliazione papale.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 139
voleva, lo sgombro del territorio, la restituzione di Comaccbio, e la rinuncia alle nuove pretese imperiali.
* * *
Avvenuta la pace il Marsili rimase fino a tutto il Marzo ad Ancona provvedendo alla riduzione dell'esercito e anche a frenare le prepotenze delle truppe austriache, che col licenziamento dei soldati papali, aumentavano le loro incursioni. Egli non fu affatto licenziato dal papa, come vuole il Fantuzzi per le pressioni austriache, ma chiese il congedo, per cattive condizioni di salute, rifiutando il Governo delle truppe delle Marche e di Ancona che gli era stato offerto dal Paolucci. Anzi tornato a Bologna fu incaricato di sorvegliare i lavori che si facevano a Forte Urbano per riparare i bastioni cadenti. E nel giugno accompagnava a Venezia i nipoti del Papa, ed ebbe in quell’occasione un segreto abboccamento col Savio grande il Morosini che sollecitava il Papa ad armarsi dati i pericoli, che la pace, che si credeva prossima, riservava agli Stati italiani abbandonati alla prepotenza dell’imperatore che si proponeva di venire in Italia col pretesto dell’incoronazione, per rinfrescare i vecchi diritti e sopratutto esigere le tasse di investitura che avrebbero fornito una grande somma.1
Nel settembre il Marsili era ricevuto dal Papa che gli dimostrava il suo gradimento per l’opera prestata e l'incaricava di redigere uno Statuto per la sua guardia personale: e quanta fiducia avesse nella sua capacità e fedeltà gli mostrò nel 1715, affidandogli la difesa delle coste adriatiche.
1 Mss. M arsili, L X X II I . Lett. al Paolucci del 9 giugno 1709 da Venezia. E’ importante per le notizie dei sentimenti di angustia che vi erano a Venezia : si temeva persino che i nobili di Terraferm a sperassero dal ritorno dell’imperatore la restaurazione dei loro d iritti feudali perduti. I l Marsili poi aggiunge che Venezia sperava di poter corrompere i ministri imperiali, poiché questo era il segreto con cui si era Ano allora salvata dalle pii» gravi vessazioni.
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI 140
A P P E N D IC ERegole per la Institutione (li uno Stato militare presentate
alla Congregazione li 24 lnglio 1708.1
Il pontefice si trova a « dover formare di pianta uno stato militare tutto nuovo, che è quello suol accadere a’ Principi quali per una lunga serie di anni fra l’assopimento della pace ne hanno dimenticato il dispendioso peso ». Tutto questo è aggravato dall’angustia del tempo che resta libero per prepararsi « a resistere ad aggressori formati da una ordinata disciplina militare e lungo esercizio di guerra viva ».
La memoria è divisa in sette punti.
1° Punto - Della soldatesca.
Essa è distinta in regolare e milizia paesana che ne è solo il complemento. La prima se non è ben organizzata nei suoi quadri di ufficiali alti e bassi, non si conserva e non può far buona prova. « La mancanza di simil ordinata distribuzione è stata la causa che anche li predecessori di V. S. mai habbiano possuto havere una soldatesca ben regolata, e con un effetto proporzionale alle rilevanti spese che ne fecero ».
È allegato il « Proietto per la formazione di un Reggimento ».
2° Punto - Détta fornitura delle armi.
Le condizioni d’armamento sono deplorabili ed esigono « una violenta risoluzione di formare un Direttore de magazzeni di Guerra, Cannoni e Armi, « che si metta subito all’opera perchè non si può esagerare abbastanza lo stato deplorevole delle armi ». Bisognava raccogliere fucili e pistole, fabbricare mortai
1 ,1/s.s. M orsili, L X X II, 25. La lunga memoria è qui in gran parte riassunta.
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 141
e sopratutto preparare bombe e granate che mancavano del tutto, e assicurarsi che le palle di cannone che erano tutte mescolate nelle piazze servissero veramente per quei pezzi.
3° Punto - Dello sostentamento della soldatesca.
Osserva l’irregolare misura delle paghe dei soldati, sì che essi fuggono dai posti ove sono meno pagati a quelli ove la paga è più alta. Converrebbe ridurre le paghe e migliorare il vitto. Il pane è troppo poco, 18 once scarse contro 24 in uso negli altri eserciti. Già a Ferrara i soldati reclamarono con lui. Si dovrebbe favorire l’uso che i soldati si preparassero da sè il rai*- cio, fornendo gli arnesi, come si fa negli altri eserciti, per evitare che sciupino il soldo nelle osterie. Quanto alla montura negli altri eserciti si è dimostrato utile fornire al soldato oltre il giustacore tutto il sottabito, che protegge meglio il soldato, e può durare due anni. Sarà bene lasciarne l’incarico ai colonnelli per l’emulazione fra loro e creare nello stato manifatture di panni, saie per fodere, tele, calze, scarpe perchè il denaro rimanga in casa. E allo scopo della durata suggerisce per i panni il color grigio naturale della lana, distinguendo i reggimenti col risvolto delle maniche.
4° Punto - Quali siano le cause di diverse irregolarità che sononelle truppe di N. Signore.
« Gli Antecessori di V. Santità che nel godimento di una somma pace furono esenti dal rilevante peso di mettere un’armata in piedi, trascurarono anche di prescrivere le necessarie leggi et ordini alle poche truppe che ebbero o in guarnigione o in guardia del proprio Corpo, premettendole inesperti delle puntuali che osserva la soldatesca per vivere con parsimonia, subordi- natione militare ed esattezza in tutto che esigge la profusione.
Questa maniera di vivere fra le truppe di V. Santità è passata in uso per non dir in una legge, la quale se dovesse haver durata renderebbe inutili le spese di millioni e di millioni, perchè mai si verrebbe a termine di havere assieme un’armata regolare, ma solamente un ammasso tumultuario di gente inutile al servigio della Santità V.
142 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Fu causa fondamentale d’ogni male che le truppe pontificie non furono poste nell’ordinato sistema dei Reggimenti, ma solo lasciate in Compagnie separate che erano divenute più tosto un ammasso di borghesi nelle fortezze, disordine che, conosciuto dall’imperatore morto, l’obbligò di cavarle tutte et incorporare la gente in Reggimenti col fare che questi con distaccamenti guarnissero le medesime piazze, mutandosi d’anno in anno, e sicome la Santità V. sin ad ora non ha havuto che ruppe disposte in tal maniera di compagnie sciolte, non è da maravigliare, se siasi veduto un effetto poco buono sotto li di Lei predecessori; e con questo esempio sia stato obbligato a reggimentarle.
Un’altra causa è quella di vedere che non sia stato stabilito da predecessori di V. S. un regolamento universale tanto per il debito dell’infimo soldato che del subalterno minore e maggiore ufficiale, come nè meno delle leggi che devono osservare per la disciplina militare, per l’economia, per fino tutto quello che può riguardare a tenere una sì gran communità dentro gli ordinati statuti, la mancanza de quali cagiona, che li nuovi soldati non si ammaestrino con regolati precetti, e che li vecchi continuino ne loro antichi errori. Mi prendo perciò ossequiosamente la libertà di consigliare riverentemente V. S. che non si perda tempo a formare un sol regolamento che sul principio non sia tanto rigoroso come negli altri servigi, per non spaventar questa gente nuova, e poi con progresso di un poco di tempo astringerla al più rigoroso ordine militare. Ne tempi andati ogni Capitano nella propria compagnia, ogni Castellano nelle fortezze praticavano differenti metodi inventati o dal capriccio o. dall’inesperienza. Onde se non si previene con questo nuovo modo quanto seguiva nelle Compagnie sciolte, seguirà ne Reggimenti e sarà una confusione che impedirà a’ subalterni di bene ubidire, come a Generali di potersi egualmente far ubidire per il servizio della S. V. ».
5° Punto - Dello stato delle piazze e fortificazioni di più luoghiesistenti in quella parte dello stato ecclesiastico che hoavuto occasione di vedere.
Unici luoghi guarniti al presente sono Forte Urbano, Ferrara, Sinigaglia ed Ancona « già che tutti gli altri non sono che
L. SIMEONI - LA DIFESA DELLO STATO PONTIFICIO 1708-9 143
corpi aperti alla discrezione di chi se ne volesse impadronire, mancando non solo le guarnigioni, ma le porte, ponti levatoi e tutti quasi abbandonati, ma non già che l’inimico non se ne possa servire... ». Seguono proposte minute per rafforzare la cittadella di Ferrara.
6° Punto - Delle provvisioni necessarie per render mobile un Corpo d’Armata.
Occorrono magazzini distribuiti opportunamente, carri per ^i cassoni « a due rote tirati da due cavalli attaccati uno doppo l'altro » : tende per .3 o 4 uomini ciascuna : dovrebbero essercene circa 1500 nelle piazze d’armi per un contingente intanto di 5-6.000 uomini; un treno di artiglieria da campagna di 12 pezzi da 3 libbre e 6 pezzi da otto con i carri da munizioni.
7° Punto - Proposizione della difesa dello Stato ecclesiastico contro gli attentati che si volessero fare per gli Alemanni, o per sottometterlo o per vessarlo coll’esazione di quartieri d’inverno.
Per determinare la difesa, è opportuno determinare quale sia la probabile offesa che può venire dal regno di Napoli o dal Ducato di Modena, ed è meno probabile nell’Adriatico.
Contro l’invasione dal Modenese si è coperti dalle piazze di Ferrara e Forte Urbano, ma la proditoria occupazione di Co- macchio apre al nemico la bassa Romagna (che è indifesa, perchè si riteneva coperta da Po) e minaccia la difesa stessa delle due piazze. Una invasione dal Regno non troverebbe alcun ostacolo nel Lazio e nella Campagna di Roma, e potrebbe essere assecondata da una avanzata da Orbetello, nuovamente occupata dagli Alemanni.
Contro questi pericoli non si può pensare a tener la campagna, ma sarà prudente ritirarsi ne’ luoghi forti mettendo 4000 nomini in Ferrara e 3000 in Forte Urbano : un altro migliaio dovrà essere distribuito nelle rocche della Via Romana (Emilia) per impedire che il nemico se ne impadronisca. Grave problema è quello di Bologna che per la sua importanza e ricchezza può
144 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
attrarre gli Alemanni, mentre non è il caso di abbatterne le mura: bisognerebbe trattarne particolarmente in Congregazione. Non conosce abbastanza la frontiera meridionale per fare proposte.
Quanto alle campagne si potrebbe organizzare la difesa dei paesani, che con segnali avviserebbero delle incursioni per venir soccorsi dalla soldatesca. Allega alcune mappe per indicare la probabile marcia del nemico, le rocche da custodire etc.
L u ig i S im e o n i
L'opera militare e scientifica di Luigi Ferdinando Marsili nella difesa della costa pontificia
dell’Adriatico
L'Adriatico era aperto, nei primi anni del secolo decimo ottavo, pili che ogni altro mare, alle scorrerie dei pirati, sia perchè la sua configurazione a bacino lungo e ristretto, a levante ricco d’isole e di anfratti, poteva offrire facili e comodi rifugi ai velieri, sia perchè agli Stati costieri, o appena usciti da guerre estenuanti — Venezia stessa era un corpo rifinito dalle lotte coi musulmani — o ancora impegnati in conflitti d’ordine politico ed economico, mancava la possibilità d’inseguire e di combattere sempre con successo i predoni del mare. Ond’è che turchi e barbareschi pirateggiavano con baldanza inaudita e spesso assalivano, oltre i luoghi littoranei, anche contrade e villaggi interni, particolarmente del dominio pontificio.
Da tutte le relazioni del tempo riguardanti comunque gli affari della Chiesa è messa in rilievo la grande preoccupazione, che per ciò affliggeva il Papa, le cui ricerche di aiuto presso altri principi non erano sempre esaudite, mentre le disponibilità finanziarie della Santa Sede tendevano a scarseggiare. Le frequenti, pur necessarie compartecipazioni delle forze pontificie in tante campagne e la stessa ultima infelice guerra del Papa contro gli austriaci (1708-1709) — un simulacro, sia pure, di guerra, come fu detto, ma che tuttavia pesò in misura rovinosa sul bilancio — aggravarono notevolmente le condizioni economiche dello Stato, tanto più che, come molti altri paesi d’Italia, anche quelli del papa soffrivano per le raccolte agrarie ripetutamente cattive o del tutto insufficienti. Nè valevano
11
146 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
gli «forzi della Santa Sede per sopperire a tanto disagio, poiché erano per lo più resi vani dalla mala amministrazione di una moltitudine di impiegati mal consigliati e spesso infedeli. E pertanto tutti gli ordinamenti risentivano l’influenza di un tale stato di cose, e in particolar modo la milizia. L’armamento difettava sempre più in tutto il dominio della Chiesa, a Roma stessa, a Bologna ed a Ferrara, e le città costiere, se togli Ancona e Civitavecchia, non erano sufficientemente fortificate per resistere ad incursioni nemiche; e talune di esse, come Fano, non avevano alcun presidio. Dovunque poi, nella milizia presidiarla — non diciamo esercito nè marina, perchè erano queste per la Chiesa istituzioni temporanee organizzate soltanto quando si trattava di affrontare e di combattere il nemico — regnavano indisciplina e disordine, poiché molto spesso i presidi, come le truppe in tempo di guerra, erano costituiti di gente raccogliticcia, di oziosi e banditi perdonati, male istrutti e peggio provvisti d’armi.
Gli è appunto nel volgere di tali vicende non liete che Clemente XI, mentre inviava il Perretti con una flottiglia verso il Levante, affidò al conte Luigi Ferdinando Marsili la difesa della costa adriatica del proprio dominio, dal Tronto al Po, contro i pirati e contro i turchi, che proprio di que’ giorni tentavano la riconquista della Morea e nello istesso tempo minacciavano seriamente i paesi costieri dello Stato del papa. Questi al Marsili espose le gravi condizioni del momento e commise una spedizione lungo il littorale con lo scopo preciso di fortificare i luoghi di più probabile assalto da parte del nemico e di presidiarli in misura adeguata alla loro importanza. E scelta migliore il papa non poteva fare, poiché il Marsili dava tutto l’affidamento di saper assolvere la missione, a cui era chiamato. Il Conte infatti aveva lunghi anni di esperienza, acquistata sui campi di battaglia, e conosceva per ciò, nonché per gli studi compiuti, l’arte del fortificare non meno che la strategia del condottiero: basta per convincersene la lettura di quelle «Notizie per un trattato di una nuova maniera di fortificare» ch’egli lasciò manoscritte e che con le annesse tavole potrebbero ancora oggidì servire di fondamento per uno studio
G. BRUZZ0 - l ’ o p e r a .MILITARE E SCIENTIFICA 147
dettagliato sull’arte delle fortificazioni. Ed inoltre il Mainili poteva, meglio di qualunque altro, aver presenti i bisogni delle città littoranee dell’Adriatico, che più volte aveva visitate durante il comando delle truppe pontificie nella guerra contro gl’imperiali. E ne sono una conferma cospicua le piante ed i profili di città, quali Rimini, Pesaro, Senigallia, Ancona ed altre, che furono da lui disegnati appunto dal 1708 al 1709 e che si trovano ora nella grande raccolta dei suoi manoscritti..
Dal canto suo il Marsili, uomo nel quale era profondo il senso di devozione al Capo della Chiesa, capì il proprio dovere e non tardò anche questa volta a rispondere all’appello, tanto più che egli sentiva di portare, difendendo la lunga costa adria- tica dello Stato pontificio dalle incursioni piratiche, un reale giovamento agli interessi del traffico marittimo, ch’era alloray come fu sempre — così egli pensava e scriveva nelle mie relazioni — tanta parte delle risorse economiche dell’Italia e quindi anche un coefficiente poderoso della futura sua restaurazione politica. E qui è dover nostro porre in rilievo che il Marsili nelle sue azioni militari, come nei suoi studi, non dimenticava mai di essere innanzi tutto un figlio d’Italia, egli che fra quanti italiani « nella guerra di successione di Spagna — scrisse Adolfo Albertazzi — dimostrarono il valore antico, fu forse solo che ringraziasse Dio del sottrailo ai danni della patria ».
I l Marsili, con l’ordine di partenza immediata, andò ad Ancona e da qui, lungo le coste, a sud sino al Tronto e a nord sino alle foci del Po, dopo di avere avuto da « fedelissimo servitore e vassallo una lunga conferenza con Mons. Molara, commissario dell’Armi, intorno all’esame del littorale del mare Adriatico.... per assicurarlo non solo dall’invasione dei pirati ma anche e specialmente dai turchi ». Era infatti grande il suo travaglio in que’ giorni — nel gennaio del 1715 — quando appunto i musulmani minacciavano i possedimenti della Sere>- nissima sull’Adriatico e, di riverbero, anche quelli della Chiesa. E le condizioni militari delle coste non erano certamente tali da non preoccuparlo: ond’ egli non indugia a segnalare alla Santa Sede « le miserie, i pericoli e le ruine che avverranno agli Stati Veneti ed Ecclesiastici, quando non si presti loro un sol
148 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
lecito e risoluto riparo » e non si prestino aiuti finanziari a Venezia, per renderle possibile « di porre in sicuro amendue i lidi dell’Adriatico dalle barbare ostilità degli ottomani », eventualmente soccorrendo anche le piazze di Sebenico, Zara, Trau e Spalato « che essendo nelle mani de’ Veneziani servono di avanguardia a stati del papa », in forza della loro posizione « rispettivamente allo stato d’Urbino, alla Marca e alla Romagna ». E spedì a Roma, in vari tempi, relazioni e mappe col proposito di metter sempre più in luce la topografia delle coste e le loro necessità dal punto di vista della difesa militare o di informare — per quel sentimento di singolare liberalità chelo dominava anche come uomo di scienza — circa le « osservazioni di varie cose appartenenti alla storia naturale del mare fatte sulla spiaggia pontificia dell’Adriatico ».
Al primo scopo mirano i suoi rapporti al cardinale Pao- lucci segretario di stato e quelli al pontefice: tutti scritti in forma di lettera, com’era allora costume di fare, fitti di notizie che riguardano le condizioni topografiche e militari delle coste e che rivelano nel Marsili una abilità di osservatore non comu ne.
« La spiaggia di mare fra Ancona e conflusso in esso del fiume Tronto — egli scriveva in data 17 inaggio 1715 al cardinale Paolucci — ha un’ estensione di dieci miglia sotto li quattro governi d’Ancona Macerata Fermo et Ascoli di diversa disposizione de terreni eh’ è quella che la varia maggiore o minor attività alla difesa d’ un così popolato continente contro le moderne incursioni de pirati ».
« Dal molo d'Ancona fino al principio della valle detta d’Aspi ha le ripe scoscese e di poco accesso perchè sono formate dalie precipitose falde dell’alto monte detto d’Ancona che fra diversi seni formano nascondigli alle fuste de turchi con pericolo sommo di Ancona particolarmente. Dal principio della valle d’Aspi fino ad un miglio più basso del porto d’Ascoli la spiaggia già è tutta piana, parte con scagni d’arena, che impediscono il sicuro abbordo anche di leggieri legni in terra. L ’altra, che è quella che immediatamente riguarda alla S. Casa, manca affatto di tali scagni, essendovi appresso della ripa da
G. BRUZZO - l ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 149
per tutto una profondità non solo per le galere da metter scalo in terra, ma anche vascelli da alto bordo e che in somma è capace... a nemici sbarchi e pericolosa al pretioso nostro capitale della S. Casa ».
« Un miglio più basso dal porto di Fermo sino al tiume Tronto vi è un’angusta strada carriabile fra esso mare e monti che al luogo di S. Benedetto si slarga lasciando una paludosa pianura. In alcuni pochi luoghi vi sono siti per l’abbordo di galeotte, ma non di bastimenti grossi ».
Dunque di costa montuosa è il primo tratto, il quale non richiede ancora gran che di lavoro per considerarsi sicuro contro le invasioni nemiche. « La parte della spiaggia che è compresa nella faida del monte di Ancona non ha bisogno di altra manifattura che quella di rompere alcuni sentieri capaci d’ un solo huomo introdottosi da tagliatori de boschi e di collocare sopra di certe punte casotti di paglia da ricovrare tre sentinelle in ogn’ uno di essi che riguardino dall’alto dentro certi seni dove si sogliono nascondere le fuste de turchi e particolarmente si dovrà chiudere l’ampia grotta detta de’ schiavi dove il mare se gl’ è introdotto a profondità tale da ricovrare molte fuste, nido che si distruggerà affondandogli nella bocca una barca vecchia da riempire di pietre formando ivi una trincera che impedisca in avvenire l’ingresso ».
Invece la parte più debole del littorale e quindi maggiormente esposta ai pericoli è quella « che cinge il territorio di Loreto, incominciando dal fiume Aspi infino alla Torre nuova » dove le fortificazioni nei due porti di Recanati e Monte Santo non sono più « considerabili come in altri tempi.... L ’artiglieria sta rinchiusa dentro di certi buchi ed in pessimo stato che è meglio a non farne il dettaglio ». D’altra parte si sa che nello Stato pontificio di corpi regolarmente organizzati di artiglieria, perchè tali non potevano chiamarsi quelli dei bombardieri, si hanno i primi veri esempi soltanto nel 1792.
E prosegue il' Marsili in una descrizione poco edificante: « Dal porto di Monte Santo sino all’ ingresso del territorio di Fermo vi sono due porti, cioè Cittanova e Sant’ Elpidio. Il primo ch’è nel feudo della Casa del Duca Cesarini non ha forte,
150 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARS ILI
non ha un cannone, è tutto in intiero precipitio, benché sia tutto di muro con bastioncini correndo a peso del medesimo Feudatario che per risparmio della spesa lia lasciato andare tutto in precipitio e che è in stato che li turchi ne possano entrare quando volessero. Sant’ Elpidio è meglio conservato, ma però ha bisogno di risarcimenti e d’artiglieria. Passato il fiume Chienti s’ incontra una piccola torre chiamata il Casino... che per la sua piccolezza merita poca riflessione. S’ incontra il Porto d’Ascoli che di giorno in giorno per le ricchezze di nove fabbriche cresce ad un segno che costì diffìcilmente crederanno e che quando li banchi d’arena non lo difendessero dalla parte del mare potrebbe temere un caso simile al seguito in Recanati.... Tutto il resto della spiaggia sino al Tronto, essendo provvista dei castelli di Torre di Palma, Pedaso, Marano, le Grotte S. Benedetto situati sopra di rupi e cinti di muri, non hanno nulla da temere; e quelle poche case che sono al piede d’essa su la ripa del mare e fuori de recinti de muri ordinai che le spogliassero de mobili come due chiese de loro apparati e portarle dentro de castelli come le donne fanciulli ■eh’ è quell’istesso crederei si dovesse fare con le capanne attorno al porto di Recanati. Il porto d’Ascoli eh’ è 1’ ultimo porto è una fabbrica che costò molto denaro e che è stata negletta per la conservatione ma che per la spaggia renosa e senza sesto •e le paludi che vi sono non merita riflessione... » ; e continua il Marsili, rilevando manchevolezze ed errori.
Come si vede, il quadro che Egli fa di questo lungo tratto di costa, non è certo tale da portare tranquillità alla Santa Sede: quasi dappertutto si nota una grande incuria da parte dei preposti alla difesa dello Stato e povertà di presidi. Non per nulla sin dall’aprile del 1715 il Marsili, dopo aver impartito ordini e disposizioni, coraggiosamente scriveva al Sacro Ufficio che tutto era disposto « nel suo perfetto ordine e che veruno potrà scusarsi d’ ignoranza, ma a chi mancherà se gli dovrà dare un esemplare castigo come reo di negligenza, e se in questa parte N.° Se non dà ordini ai Legati, ai governatori, ogni spesa, ogni fatica sarà buttata ; i poveri sudditi sacrificati e la gloria del Principe esposta ». Troveremo nella sua relazione al
papa i rimedi che egli propone ; ed' intanto seguiamolo nell’esame che fa del littorale a nord di Ancona, in una lettera allo stesso card. Paolucci, in data 9 giugno dell’ anno predetto, da Rimini. « Questa spiaggia della Legazione di Romagna ha una estensione di 55 miglia, infraposta alle due legazioni di Urbino e Ferrara. Dalla prima resta divisa per il piccolo fiume Tavullo (presso Cattolica), e dalla seconda per il Po d’Argenta o di Primaro. Non ha di montuoso che un piccolo spazio che è un’appendice dei Monti di Pesaro, dove la Cattolica è collocata. Tutto il rimanente è pianura asciutta, coltivata fino quasi a Cervia e per il rimanente vi sono selve di pini mescolate d’altri alberi ed interrotte da paludi e disabitate.... Il mio viaggio è sempre stato colli piedi del cavallo bagnati dentro del mare per pigliare esatta informazione delle diverse profondità di esso, o a comodo o ad impedimento dello sbarco de’ pirati; ma nell’ universale della medesima ho trovate Tacque sottili a segno tale che in gran distanza dalla terra dovrebbero le fuste sbarcare li pirati dentro dell’ acqua, giacché non è possibile di metter la prora in terra, e questo nostro vantaggio si fa sempre maggiore quanto più andiamo verso le bocche del Po grande. Nell’appendice del Monte di Pesaro al sito della Cattolica vi è qualche interrupimento a causa di piccoli spazi d’ acque profonde, come all’ imboccatura d’ alcuni fiumi confluenti in questo tratto di mare, e massime nel tempo della solita crescenza del flusso e riflusso che sempre maggiore si fa ascendendo all’ estremità del golfo ».
« Tutta la spiaggia è ripiena di popolo sino a Cervia perchè li terreni sono ameni e capaci d’ una regolata cultura, che non è, come ho detto, dalla medesima Cervia sino al confluente del Po di Primaro. Gli antichi predecessori di V. S. pretesero di assicurare questa parte della loro spiaggia, come in tutte le altre, col mezzo delle torri, la maggior parte collocate all’imboccatura de fiumi variabili per la loro stessa natura di condurre tanta arena, molte si trovano fuor di misura a sodisfare a quell’ intento, con il quale furono collocate. Queste torri non contando Rimini sono al numero di nove e tutte ho visitate fuori di quella di Primaro, alla quale non mi appros-
G. BRUZZO - L ' OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 151
152 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
«mai che in lontananza di mezzo miglio per esservi dentro la guarnigione tedesca rilevata a Comacchio... ». Questa precauzione del Marsili di tenersi piuttosto al largo da Primaro, ancora presidiata dagli imperiali, non ci stupisce. Egli ben ricordava tutto ciò che gli era accaduto e quanto gli era stato imposto nel 1704 a Bregenz dopo la resa di Brisacco, nonché i patti che il maresciallo Dauu aveva posti nella pace del 1709 e fra i quali era appunto la sua rinuncia da comandante le truppe del papa! Nè poteva dimenticare il barbaro trattamento dei sudditi pontifìci da parte dei tedeschi durante l’ultima guerra.
Di maggiori proporzioni ed esauriente è la relazione, che il Marsili mandò a Clemente XL il 13 luglio del 1715 ed in cui egli « restrigne tutto lo stato della spiaggia adriatica, incominciando da uno degli estremi e successivamente ragionando di essa infino all’ altro » e mediante una carta topografica farà al papa « scorgere il corso del mare e sua disposizione fra- diversi giri del lido or piani ed ora montuosi, come ancora li fiumi, i luoghi abitati e le difese pensate ».
Come abbiamo in precedenza notato, il Marsili già in un altro rapporto, pure sotto forma di lettera, aveva richiamato direttamente l’attenzione del pontefice circa il formidabile pericolo che incombeva sulla Cristianità per la nuova guerra fra la Repubblica di Venezia, oramai debole e decadente, e il Turco ancora saldo e forte, e quindi sulla necessità di premunirsi da una parte e dall’altra dell’Adriatico; ma in questa nuova relazione egli, in conformità all’ incarico ricevuto, è più preciso, e per ciò rivolge il suo esame alle condizioni topografiche della costa orientale dello Stato della Chiesa e ne rileva i bisogni in ordine alle fortificazioni. Ond’è che anche la carta topografica, con cui si accompagna la relazione, acquista una particolare importanza. Essa è disegnata a mano, a penna ed a colori: giallo il littorale, bleu con sfumature di verde chiaroi corsi d’acqua ed il mare, con tratti di piccole linee orizzontali e verticali le coste alte e rocciose; "ha dimensioni di metri 2 per 0,50 e, posta nel senso secondo cui sono scritti i nomi dei porti, orientazione col Nord a destra. Dalla scala grafica di
ti. BKUZZO - l ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 153
millimetri 200 per miglia (pontificie) 10 si deduce il rapporto di 1 a 74.500 circa.
La carta non porta il nome deH'autore, ma è opera certamente ideata dal Marsili e costruita sotto la sua direzione, e, come si palesa anche dal titolo « Descrizione topografica delle spiaggie pontificie dalla bocca del Tronto ne’ confini del Regno di Napoli fino alla Cattolica intitolata: Giornale delle ricognizioni della spiaggia pontificia », ha lo scopo di dimostrare le condizioni morfologiche e idrografiche del littorale ed insieme la distribuzione dei luoghi abitati costieri.
Il Marsili, dopo avere descritto lo stato della costa — poco invero aggiungendo a quanto aveva prima messo iu evidenza al card. Paolucci e allo stesso pontefice — espone francamente a Clemente XI i bisogni delle fortificazioni adriatiche e suggerisce i mezzi per sopperirvi: da esecutore coscienzioso e fedele, non temendo di provocare il risentimento delle persone preposte ai luoghi di presidio e solamente curandosi degli interessi dello Stato, con una padronanza vera della materia, con una sicurezza sorprendente, senza seguire alcuna scuola nè alcun sistema convenzionale, ma con una visione precisa e chiara di ciò che manca ed occorre. E sentiamolo. «... Una spiaggia tanto ragguardevole per cagione della ruina dell’impero greco, sopra di cui ha fondata la sua grandezza l’ottomano, è divenuta frontiera a questo comune nimico che in alcuni luoghi per la strettezza del golfo Adriatico non è più lungi di miglia 80. Per la qual cosa li savissimi predecessori di V. Santità avanti le ultime vittorie nella passata guerra terminata con la pace di Carlovitz, furono obbligati a fortificare le città, a fabbricare forti e torri e stabilire ordinanze diverse per custodire così lunga spiaggia non solo da’ pirati, ma eziandio da qualsiasi considerabile forza marittima ottomana. Da quelli già la V. S. viene infestata; a questi è esposta ogni qual volta (che Dio non voglia) l’armata navale veneta fusse perdente, come le significai riverentemente nella mia scrittura del 12 gennaio. Nella Marca fino ad Ancona tutte le castella presso la spiaggia furono fortificate come oggidì si trovano per cagione delle guerre civili; ed ora sono oltre modo
154 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
giovevoli nelle presenti congiunture. Li sommi pontefici predecessori di Y. S. ne’ luoghi dove queste non giugnevano per assicurare le rimboccature de’ fiumi e tener ben guardata in proporzionata distanza la spiaggia fecero le torri Casino, Nova, d’Aspi, d’Omana e li ridotti di S. Elpidio, Cittanuova, Monte Santo, Porto di Recanati. Fortificarono eziandio la città d’Ancona, fecero una cittadella che doveva difendere un ampio recinto quasi compiuto da Gregorio X III per ricoverare il popolo della vicina campagna dalle invasioni de turchi. La bella torre poi di Fiumicino fatta ne tempi delle civili guerre è stata posta in uso per la difesa contro li medesimi turchi, per cagione de quali i duchi d’Crbino ridussero nello stato in cui si trova presentemente la fortezza e città di Sinigaglia e la fortezza della Bastida sul fiume Cesano. E lo stesso fu fatto a Fano, a Pesaro, nè recinti della città e cittadella e in diverse altre castella intìno alla Cattolica dove evvi alla foce del fiume Taulo (Tavollo) una torre, come eziandio un’altra dentro il borgo della stessa Cattolica, e poscia vi sono l’altre tre infino a Iiimino chiamate di Conca, Fontanelle e Trinità.... La città di Rimino e molto più la fortezza per essersi ritirato il mare sono divenute fuor di portata per far difesa contro li pirati. Da quivi infino al Po grande li predecessori di V. S. hanno fabbricate le torri appellate Petrera, Bell'Aria, Cesenatico, Cervia, Can- diano, Primaro, Bell’ Occhio, Magnavacca, Volano, Panfiglia, Casa delPAmmiraglio ».
« Fu stabilito per massima giovevole l’ edificarsi le nuove torri una distante dall’altra cinque miglia e dove queste non fossero state bastevoli, si fosse supplito con li porti descritti antichi. Una tale disposizione di luoghi ebbe per primario oggetto, che servissero per le sentinelle, le quali scoprissero il mare, difendessero le imboccature de fiumi e de porti e scambievolmente potessero vedere i segnali de vicini, ed oltracciò dessero ricovero a certo numero di cavalleria, che in tempo di notte batta da una torre all’altra la spiaggia. Li segnali si fanno sulle cime delle torri. Il giorno col fumo, la notte col fuoco, e in ammendue i tempi, se fia d’uopo, co’ sbari di cannone e mor/ taletti. Li battitori sogliono fare ogni notte due o tre battute
G. BKUZZO - l ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 155
da una torre all’altra, o da un porto all’altro, attentamente osservando se vi sia barca nimica, affine di darne sollecitamente avviso alle torri vicine, che co fuochi e sbari avvisano i bastimenti in mare affinchè non indugino a scampare il vicino periglio, e che dai luoghi vicini corrano le milizie nel modo divisato nelle antiche ordinanze ».
« Nella mia visita ho esaminato questo antico metodo la- lasciando che quello che vi è di buono si eseguisca, e ciò che mi è paruto difettuoso ho sul fatto per quanto mi è stato possibile rimediato, e fattane incontanente la proposizione da porre a piedi di V. S. per mezzo delle mie riverentissime lettere indirizzate alla Segreteria di Stato, alle quali mi raporto ponendo intanto sotto gli occhi di V. B. la presente mappa per mezzo di cui potrà ad un tratto comprendere il tutto ». È appunto la mappa, che fa parte della relazione stessa e della quale di sopra abbiamo dato cenno. « Le ordinanze poi militari stampate per tutti li governi di questa spiaggia lette in un gabinetto promettono un gran servizio e una ferma sicurezza allo Stato; ma nella pratica della mia visita, fra continui allarmi ho conosciuto che non sono d’ alcun utile nelle presenti congiunture dove i pirati sono quelli che ci molestano, volli dire gente sollecita nel predare, la quale appena giunta alla spiaggia incontanente si parte nè dà tempo di mandare il necessario soccorso per impedire i loro ladronecci, il che per fare sarebbe mestieri di quattro o cinque ore. Per la qual cosa stimai necessarissimo di porre a piedi di V. S. il ricordo di stabilire ne posti accennati nelle mie lettere un gran numero di cavalleria pronta ad ogni attentato, e rendere fruttuosa la vigilanza de Battitori delle spiaggie che scovrendo barche vicine ànno subito rinforzo di gente, resistendo con forza e valore allo sbarco de nemici li quali se sbarcati fossero, potranno agevolmente impedirli il rimbarco, e liberare chi avessero fatti schiavi, quando per lo contrario non vi fusse detta cavalleria in riserva ne verrebbero que pregiudizi che V. S. dolorosamente ha intesi. Questa spesa stabile a prima vista pare maggiore dell’accidentale, ma non è così, a mio avviso, perciocché di gran lunga è maggiore l’accidentale nello spedire che debbono le comunità
156 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
al mare la gente come V. S. avrà inteso dagli Eminentissimi Legati e Governatori; oltreché è assai più presta e opportuna la soldatesca che non è la gente non avvezza all’armi, e non disciplinata, di cui secondo lo stile antico della ordinanza si servivano ».
« L ’ infanteria non può rendere servigio utile, per la indispensabile sua tardanza nel muoversi eziandio da un posto all’altro, bastando solamente per ogni torre tre o quattro fanti per fare la sentinella, i fuochi, il fumo, per lo sbarco de cannoni e mortaletti ».
« Quando nel mare vi fossero legni di linea che con effettivo reale sbarco volessero tentare alcuna cosa contro la spiaggia di V. S., in tal caso le ordinanze antiche ottime sarebbero; perciocché non mancherebbe in tal caso il tempo proprio per radunare le forze stabilite dalle medesime ordinanze: non potendo mai un’armata fare le sue disposizioni (massime in una spiaggia così bassa o aperta) per lo sbarco, che col fermarsi alcun tempo a vista di quel sito, dove volessero fare lo sbarco. E per questo bisogno non ho mancato di fare le dovute riflessioni, le quali qui lascio di raccontare, poiché porto fermissima speranza che l’armata veneta con l’aiuto dell’onnipotente Iddio sia per toglierci ogni occasione di dovere a ciò pensare ».
« Li segnali secondo l’uso antico li trovai difettuosi in più siti, o per esser troppo lontano l’uno dall’altro o fatti in luoghi non veduti e con poca uguaglianza. Oltracciò ne veniva un altro inconveniente, e questo è che una fusta nemica, che per cagion d’esempio trova vasi presso il Tronto era cagione che si ponevano all’armi infìno le genti del ducato di Urbino con sommo aggravio de Popoli, e senz’aleun bisogno per la soverchia lontananza degli aggressori. Per la qual cosa ho stimato ben fatto prevalermi a questo effetto di castelli, di torri, di chiese e di case alte per porvi sopra le guardie a piedi co segnali di fuochi e fumi in minore distanza e distinti, e frequenti particolarità di farli dove è l’attacco, e sono disposti, come Y. S. vedrà nelle mappe delineate col fumo sopra dipintovi, il quale indica quegli essere un segnale. Oltracciò mi sono eziandio prevaluto dei monti e colli vicini alle spiaggie facendo sopra
G. BRUZZO - L ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 157
essi fabbricare alcune capanne per riparo delle guardie a piedi a somiglianza di quelle praticate nelli monti d’Ancona e Pesaro. Non ha dubbio alcuno che sarebbe stato necessario oltre ogni credere di fabbricare alcune torri, o pure piccioli ridotti; ma le presenti calamitose congiunture non mi hanno dato animo di suggerirlo a V. S. Mi applicai adunque di multiplicare non solo le guardie ne siti de seni, de monti di Ancona Pesaro e Cattolica; ma eziandio di rovinare li molti nascondigli alle fuste turchesehe, affondando in essi barche piene di pietre; ed altracciò risarcii li porti di Recanati, Monte Santo, Cittanova, Sant’Elpidio e fabbricai un fortino all’imboccatura del porto di Rimini armato di sei pezzi d’artiglieria, che copre il medesimo e li borghi che erano totalmente esposti ».
Il Marisli, evidentemente, comprendeva tutta la gravità del pericolo, che sovrastava allo Stato della Chiesa, e si affrettava ad opporvi un riparo. Egli, nelle contingenze in cui era, non s’ indugiò nella ricerca di nuove forme difensive ; ma piuttosto pose mente ad applicare sistemi già noti, anche se da altri ideati, purché adattabili alle condizioni ed alle necessità del momento, o addirittura a modificare od a rendere complete opere di difesa preesistenti.
« Non ho mancato — egli continua — di dare le dovute istruzioni agli ufficiali de Porti per quanto la mia debole ispe- rienza mi ha suggerito; e sopra il tutto ho ricordato agli Eminentissimi Legati e Monsignori Governatori che sarebbe ben fatto il far ritirare in luoghi sicuri tutti quelli che abitano in case separate in campagna vicino alla spiaggia e non lontano dalle imboccature de fiumi, mentre senza l’accrescimento della cavalleria non è possibil cosa in così lungo tratto di linea per la velocità de pirati aiutati da venti di tenerle lungamente libere dalle disavventure. Nella Marca tra il porto di Fano e il fiume Tronto da me stesso eseguii questo ripiego, che produsse utile e che è quello che si pratica nelle frontiere de vasti imperi, quando non vi sono bastevoli forze per difendere i sudditi che abitano fuori de recinti. Dove è stato bisogno di rinforzo di artiglieria, d’armi e munizioni non ho mancato di soccorrerne (per quanto è stato possibile) incontanente i forti; e
158 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
per ciò mi portai sollecitamente a Ferrara affine di quivi mandare il necessario di luoghi della Romagna, spedendo un convoglio da S. Alberto con farne fare la legale consegna al Governatore dell’armi cavaìier Raspolli, che avrà compartito il tutto secondo significai all’ Eminentissimo Gozzadini », che è il comandante del nuovo forte eretto all’ imboccatura del porto di Rimini ed al quale il Marsili invia particolari istruzioni su la distribuzione delle munizioni e l’azione da svolgere nei riguardi della difesa.
Ed a questo punto richiama l’attenzione del pontefice sui ragguagli, che egli potrà avere da un esame ponderato della mappa e fa osservare che « quando le acque (dei fiumi) crescono e conseguentemente s’alzano di superficie li Battitori non possono passarli » e che quindi per assicurare il paese sarebbe necessario « formare ponti sopra i fiumi ed aprire nuove strade vicine al mare, acciocché li Battitori obbligati non fossero a deviare non solo dalla vicina scoverta di esso; ma da poter scorrere liberamente da un luogo all’altro ». E chiude la relazione riconfermando i propri sentimenti di devozione al papa e dichiarandosi pronto come sempre ad ogni suo appello.
Ma il conte Marsili, nonché maestro nell’arte militare, era un uomo di scienza, e come tale non si lasciava sfuggire occasioni per raccogliere dati e notizie, che a lui valessero per approfondire i suoi studi o per completare i suoi lavori sopra questo o quell’argomento: studi e lavori che avrebbero dovuto convergere in un unico grande trattato sulla struttura del globo, che Egli si era posto in mente di comporre e di cui poi non ci lasciò che brevi memorie, di varia natura, quali appaiono nel volume dei suoi manoscritti dal titolo « Notizie varie raccolte per uso del Trattato della struttura del globo terreo ». Sono osservazioni sulla distribuzione delle acque, sulle parti componenti il globo, sui cristalli, sui sali, sullo stato termico ed altro, molte di esse incomplete, ma nel complesso sufficienti per indurci a pensare che anche il Marsili forse scorgeva nella Terra una specie di organismo, nel quale tutte le parti sono in reciproca dipendenza fra loro e si compenetrano in modo da dare origine a un corpo di armonica costituzione.
G. BRUZZO - L ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 1B9>
Era naturale che egli, anche durante questa nuova missione affidatagli dal pontefice, profittasse dei momenti liberi dalle incalzanti cure del suo ufficio per compiere come meglio poteva quelle « osservazioni di varie cose appartenenti alla storia naturale del mare fatte sulla spiaggia pontificia del- l’Adriatico » le quali, se non sono tutte nuove, poiché parecchie di esse corrispondono ad altre già rese note dai suoi studi precedenti, hanno però tutte molta importanza, in quanto sono il frutto della sua personale esperienza e di un metodo di lavoro sempre rigidamente coscienzioso, e confermano conclusioni in precedenza da lui enunciate. In lettera e data del 13 luglio dello stesso anno 1715 le indirizzò a Giovanni Maria Lancisi, che era allora archiatro pontificio e godeva fama di grande erudito e scienziato « per comune consentimento — come afferma il Marsili nella stessa lettera — il maggiore filosofante di Italia, la (/itale non ha dubbio è V emporio delle scienze ». Erasi iniziato in Italia quel grande movimento scientifico, con cui la Patria nostra, nel secolo decimottavo, si accingeva a prepararsi intellettualmente al conseguimento della indi- pendenza politica, ed il Marsili non lasciava occasione per esaltarne le conquiste e le glorie.
Premessi brevi cenni su la configurazione verticale del lit- torale anconitano, dove nell’aggetto di monte Cònero gli strati di natura gessosa si alternano con quelli di « terra cretacea » ricorda di avere osservato « in più siti della spiaggia arenosa fra Rimini e Cesenatico, in tempo di riflusso, molte picciolis- sime sorgenti d’acque dolci et isquisite, le quali scaturiscono continuamente sotto l’acqua del mare quando in detto luogo evvi il flusso. Questa osservazione mi persuade potervene essere delle uguali non solo, ma eziandio maggiori al pari de fiumi, come scovrii... fra Marsiglia e Cassis, dove i Romani sulla spiaggia pietrosa fecero uno scavamento perpendicolare al piano dell’orizzonte che ancor oggi si vede, affine di trarre, come da un pozzo dell’acqua dolce, prima che si mescolasse con quella del mare; la qual acqua dolce chiaramente dimostra esservi nello stesso mare molti fiumi confluenti e sotterranei, il che è cagione che in molti luoghi di esso mare si ritrovino
acque meno salse nel fondo che nella di lui superfìcie, quando secondo il metodo universale le acque superficiali debbono essere meno salse che le vicine al fondo, come tante isperienze appurato mi hanno ».
Egli constata un fatto, intorno al quale non si avevano prima che vaghe e mal sicure notizie e che soltanto nei nostri tempi, con lo sviluppo degli studi oceanologici in generale .e dei batimetrici in particolare, è divenuto argomento di seria considerazione : l’ esistenza dei fiumi sottomarini, i quali non solo, come osserva gustamente il Marsili, fanno sì che nelle zone, in cui essi si trovano, la salsedine e per ciò il peso specifico dell’acqua diminuiscano, contro la regola più comune, negli strati inferiori, ma concorrono altresì a modificare la configurazione del fondo marino.
Il Marsili prosegue poi parlando del lavoro di alluviona- mento delle correnti fluviali e dimostrandone gli effetti in ordine sia alla morfologia delle coste che alle condizioni bati metriche del mare. « Nelle foci di tutti i fiumi e torrenti che in tanto numero si veggono nella spiaggia nostra dell'Adriatico, o vi sono scanni di arena, se queste conducono, o di giara, se questa trasportano.... Tra le punte o scanni d’arena o giara evvi questa differenza, che l’acqua vicina a quella è bassa e a questa profonda. Le punte o scanni di arena crescono più per il lungo dentro del mare, e quelle di giara lo fanno più nell’alto che nella estensione orizzontale. E dove si veggono punte arenose acute così avanzate in mare lungo questa nostra spiaggia, è certissimo indizio essere quivi una foce o di fiumeo di torrente. Egli non ha dubbio alcuno essere verissima quella proporzione maggiore assegnata da V. S. nella sua dottissima dissertazione intorno al lido di Ostia nei tempi moderni che ne’ passati secoli intorno all’accrescimento delle spiaggie per la deposizione di arena e giara, che si fa da fiumi e torrenti, avendolo chiaramente dimostrato una pianta di Rimini stampata cent’anni sono — carta che è parte del volume 71 dei manoscritti, ben conservata, di m. 0,30 per 0,40, nel rapporto da 1 a 2200 circa — dalla quale si conosce che la spiaggia è riempita un mezzo miglio oggidì ». Appunto nella memoria,
160 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
G. BRUZZO - l ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 161
pregevolissima indubbiamente dal lato storico-geografico e intitolata « Physiologicae anima diversiones in Plinianain Villani nuper in Laurent ino detectam, in quibus tuia de novis aggestio- nibus circa Ostia Tiberis; tum de ibidem succrescentibus are- narum tumulis; tum deni-que de herbis et fruticibus in recens aggesto litore suborientibus disseritur », il Lancisi, pigliando occasione dalle alluvioni del Tevere, discorre a lungo dell’azione di trasporto dei fiumi e dei suoi effetti, e in particolare, nel capitolo tredicesimo, dei protendimene della spiaggia, maggiori oggidì che in passato.
« Che se nei precedenti secoli tanto accrescimento si fosse fatto di lido, certamente la linea dell’Appennino non avrebbe potuto essere dov’ è presentemente, rispetto a Rimini, o il mede simo dovrebbe essere decine e decine di miglia lungi dal mare; il che fermamente avverrà nei futuri secoli, tanto più se si continuerà a coltivare i monti, i quali si abbasseranno e si formeranno vaste pianure. Ciò a mio avviso, è succeduto nella bassa Germania e nella Ungaria, come nelle mie dimostrazioni intorno alla struttura della terra mi lusingo di persuadere; e per avventura l’ardita e non fallace proposizione, che sulla superficie della terra non vi fossero altre pianure che quelle delle valli fra monti. Tutto il piano contenuto tra i vari giri dell’Appennino e dell’Adriatico, il quale ora è il fertilissimo Paese di Lombardia, al tempo de’ Romani non fu mai praticabile dagli eserciti; perciocché egli era una palude chiamata Padusa, ora divenuta un continente sodo e fertile » — evidentemente qui il Nostro confonde la Lombardia con la Padusa, che fu una distesa mal definita di acque stagnanti nella regione del basso Po, come può leggersi nella dotta memoria, una fra le tante che trattano di tale argomento, di Eu. Manfredi dal titolo Notizie di fatto intorno al Reno, al Po, alla Padusa e all’ anti-ca cultura del territorio bolognese — « non tanto perchè Emilio Scauro unì l’acqua del Po in un solo alveo, quanto per la ragione accennata delle terre de monti coltivate e portate da fiumi, poscia con arte ricolte e distribuite da paesani per farne come fatto ànuo fertilissime campagne. La torre Panfilia, che fu da Innocenzo X edificata alla foce del Po
12
162 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
grande presso il mare, sessantacinque anni sono, presentemente per cagione degl’interrimenti fatti è lontana da esso mare due miglia e mezzo; la quale osservazione, da me fatta, sempre più conferma le ragioni che V. S. ha portate nella non mai baste- volmente commendata sua dissertazione ».
Il Marsili, corn’è chiaro, allude allo sfacelo dei monti sopra tutto italiani, cagionato in parte dal diboscamento e dallo estendersi delle culture, e alla conseguente formazione littoranea di ampie alluvioni. E da questo fatto, verificantesi in ispecial modo nella costa padana, egli poi, trasportato dalla sua fervida fantasia, arriva ad una conclusione, che certamente non armonizza con le verità più tardi conquistate dalla scienza, quando cioè afferma che « sulla superficie della terra non vi furono altre pianure che quelle delle valli fra i monti » e attribuisce la formazione delle vere pianure ora esistenti alle « terre de monti coltivate et portate dai fiumi », sia pure « poscia con arte ricolte e distribuite da paesani ». Non è adunque chi non veda quanto ciò contrasti con i risultati della scienza nel riguardo dell’origine dei bassopiani, i quali sotto tale rispetto distin- guonsi in tettonici e di riempimento, essendo gli uni zone di terre emerse, gli altri zone depresse ricolmate od in via di col- mataggio, sebbene in natura la loro diversa origine non sia quasi mai ben distinta, poiché le zone emerse soggiacquero, in seguito, all’azione di ripianamento per parte dei materiali detritici od anche vulcanici od eolici e per parte dello stesso lavoro umano, e le zone ricolmate od in via di colmataggio corrispondono spesso a fondi di mari emersi od in corso di emersione. Ad esempio il bassopiano germanico, compreso appunto fra quelli citati dal Marsili, è una delle pianure più recentemente emerse di tutto il mondo, le cui rocce originarie sono ricoperte da potenti strati orizzontali di ciottolame, argille, marne e sabbie, depositati durante il periodo glaciale.
Ma. non per questo viene diminuito il merito del Marsili di essere stato fra i primi — pur in mezzo a tante difficoltà di indagini e di studio create dalle stesse condizioni politiche del tempo — a ravvisare anche nell’azione demolitrice e ricostruttrice delle acque correnti, come del mare, quel duplice la
G. BRUZZO - L ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 163
voro di compensazione, su cui si basa l’equilibrio del globo, e di avere cominciato a considerare scientificamente, per quanto era allora possibile, nel suo insieme, il fenomeno delle trasformazioni subite dalla superficie terrestre.
Non meno importante è la parte, che noi diremo seconda, della relazione marsiliana a Mons. Lancisi, e che riguarda la profondità e quindi la conformazione del fondo dell’Adriatico, poiché essa ci fornisce notizie e dati i quali, se anche non sono sempre attendibili e corrispondenti a quelli della moderna batimetría, pure acquistano un valore per la loro originalità, che è stimolo ad ulteriori ricerche e studi.
« La conca o letto dell’Adriatico, nella parte alla Santa Sede soggetta, presso la ripa per lo più è di pochissima profondità: e questa è la cagione per cui dai marinai viene appellata spiaggia sottile. Lungi un miglio poi dal lido incomincia una ordinata proporzione d’altezza d’acque, infino a miglia dieci: crescendo sempre la detta altezza d’acque un passo per ogni miglio; talché la inclinazione del piano o letto del mare dal lido infino alla distanza di miglia dieci è dieci passi, come io diligentemente osservai in faccia a Rimini ed altri luoghi. Egli è ben vero però, che in certi siti questa ordinata proporzione dura solamente per la lunghezza di miglia cinque, o al più sei da terra ; crescendo poscia la profondità intìno a mezzo il golfo con varia regola, e in mezzo al golfo evvi per lungo tratto un piano che continua con la stessa profondità. Merita particolare riflessione un sito di questo letto del mare lungi di terra ferma venticinque o trenta miglia, il quale incomincia alla dirittura di Fiumicino posto fra Ancona e Sinigaglia, e grànge infino a Venezia. Egli da pescatori viene chiamato « sporchezzo » ; perciocché in esso non si trovano che grandissime quantità di sponghe, alcioni di vari colori, alcune strane piante ed altre cose simiglianti alle frutta della terra; la quale gran copia di cose mescolata col fango rompe de’ pescatori le reti; e perciò essi sfuggono di pescare in tal sito: il che io avrei certamente tentato di fare, se non fosse stato il timore de corsari, avendo inteso che fra le altre rarissime cose vi sieno degli alcioni che pescano mille libbre ».
164 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
« Evvi un altro sito di detto letto di mare chiamato « banco » alla dirittura di Fano, e lungi dal lido quattro miglia. Egli in tal luogo è profondo dodici passi e largo quattrocento, e si prolunga verso Maestro infino alla dirittura di Pesaro. Esso incomincia di nuovo a Rimini continuando sino a Cesenatico per lo stesso Maestro dove cessa, e ripiglia poscia dirimpetto a Primaro, terminando sopra Magnavacca. Tutti questi piani sono ripieni di ostriche quasi collocate una sopra l’altra a guisa delle pietre, che formano un muro».
« Il golfo ha un declivio da tramontana verso ostro, il che V. S. potrà agevolmente vedere né’ profili di alcune sezioni di esso da me fatti sulle relazioni di alcuni naviganti e di vari pescatori. Essi tutti mi hanno assicurato che dirimpetto a Ravenna la profondità del'l’acque nel mezzo del golfo è venti passi e in faccia al Tronto è settanta passi. Per le quaili osservazioni V. S. può vedere che in una linea di 160 miglia vi sarà probabilmente un declivio di cinquanta passi.... Le profondità della spiaggia opposta alla pontificia sono grandi, essendo essa alle radici d’alti monti di pietra e scarsi di fiumi: il che avviene ancora in altre simiglianti coste, come è quella di Provenza, a distinzione della nostra, e di quella ancora di Lingua docca dove la spiaggia fino ai confini della Spagna in faccia ai Pirenei è bassa, nè vi sono fondi o porti ».
«Ad istanza del nostro signor Lodovico Trionfetti ho fatto una ricolta di tutte le arene de fiumi e torrenti confluenti, e dello stesso mare, le quali a suo tempo passeranno sotto l’esame del microscopio per vederne le figure, essendovene alcune, che con l’occhio ignudo si conosce esser elleno minutissimi frag- menti di telina. Alla ripa della nostra spiaggia non vi sono altri 'fossili che alcune miniere di gesso alle radici dei monti di Ancona e della Cattolica. Presso Cittanova dalla parie di Monte Santo e lungi dal mare un mezzo miglio, allorché i bovi arano sul colle e che il terreno umido sia, si attacca ai peli dei loro piedi un certo bitume liquefatto; per la qual cosa quando in tale dirittura fanno venti siroccali, per la lunghezza di un miglio sulla superficie del mare si vede detto bitume simigliantissimo a quello di cui parlai in una delle mie lettere
G. BRUZZO - l ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 165
pubblicate per via delle stampe sopra il canale di Costantinopoli... e che nel mio saggio fisico del mare ho dimostrato con molte isperienze, essere quel sugo che cagiona il sapore amaro delle acque del mare che mai potei levare benché spogliate per mezzo ilei fuoco da quel salso ».
Dunque il Marsili, precorrendo le moderne ricerche, praticò* le prime misure e operazioni di scandaglio sull’Adriatico ed è ben degno di rivendicare a sè il merito di aver gettato le basi per lo studio scientifico di questo mare per eccellenza italiano, per primo raccogliendo, correggendo e ordinando sistematicamente notizie intorno ad esso, sopra tutto in quanto si. rapporta alla batimetria e alla morfologia del fondo. Egli misura qua e là, dove e come può, le profondità dell’Adriatico e ne riscontra a partire dalla costa dello Stato pontificio un andamento ritmico di pochissimo rilievo « presso la ripa », che si accentua, allontanandosene, « di un passo per ogni miglio », fino alla distanza di dieci miglia, non senza far eccezioni verso la parte mediana in cui « evvi per lungo tratto un piano che continua con la stessa profondità ». E ciò, se si prescinde dai dati batimetrici che nel Marsili sono quasi sempre al di sotto dei veri, trova pressoché una perfetta corrispondenza nelle moderne carte compilate sui lavori della nostra R. Marina.
Il fondo dell’Adriatico settentrionale, che il Marsili chiama col termine ben appropriato di « golfo », declina in generale da nord a sud, tanto che « dirimpetto a Ravenna la profondità dell’acqua nel mezzo del golfo è di venti passi (m. 26,300) e in faccia al Tronto è di settanta » (m. 92,350), dati come al solito inferiori ai reali, che giusta le più recenti misurazioni nei due punti su indicati sono rispettivamente di m. 58 e 243. E mentre alla sponda orientale, perchè dirupata e scarsa di fiumi, il letto del mare, estremamente frastagliato, si adima a notevoli profondità, a 80, 90 e più metri, alla opposta riva, nella zona sottomarina costiera estendentesi sino a circa l’isobata di — 30 m., dove i depositi recenti dei fiumi hanno cancellato ogni rilievo, la topografia subacquea dell’Adriatico presenta forme quasi regolari; laddove procedendo oltre a detta linea, verso il mezzo,, le accidentalità del fondo si fanno più frequenti e conseguen
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
temente anche più irregolare l’ andamento delle curve bati- metriche.
Non risultano invece dagli odierni documenti batimetrici i due banchi segnalati dal Nostro e protendentisi nella direzione di maestro: dall’ altezza di Fiumicino, a 25-30 miglia dalla costa, sino a Venezia l’uno, ricco di lotto « di sponghe, alcioni di vari colori, piante strane ed altre cose simiglianti alle frutta della terra » ; dall’altezaa di Fano, a quattro miglia dal litto- rale, fino a quella di Pesaro, per riprendere poi a Rimini e prolungarsi, interrottamente, sino di fronte a Magnavacca, l'altro. Evidentemente si tratta di un equivoco: il Marsili, nella rapidità forzata delle sue ricerche scientifiche, scambiò i comuni banchi sottomarini con quel fenomeno, in tutto differente, che nell’Adriatico si produce ad intervalli, talora con grave osta colo per la pesca, e che consiste nella formazione di ingombranti ammassi gleosi per effetto di una proliferazione enorme di piccolissimi organismi.
Tocca poi il Marsili della costituzione litologica delle sponde ed accenna ad una raccolta di « tutte le arene de fiumi e torrenti confluenti e dello stesso mare » fatta a comodo del canonico Lelio Trionfetti — bella figura di erudito, filosofo e naturalista, primo presidente dell’ Istituto delle Scienze, con cui il Marsili, che fu suo discepolo, si mantenne lungamente in amichevoli rapporti — : una raccolta ben modesta, ma che sin d’al- lora con la distinzione fra sabbie fluviali e sabbie marine preludeva alla moderna classificazione dei depositi marini nelle due grandi categorie di terrigeni e di pelagici, composti i primi dallo sfasciume delle terre apportato principalmente dai fiumi,i secondi dagli elementi minerali sia di origine tellurica che di provenienza cosmica o prevalentemente dalle spoglie di organismi, quale è, ad esempio, il fango di globigerina, che tappezza una notevole parte del letto oceanico, e sopra tutto dell’Atlau- tico. E passa ben tosto ai moti ed alla vita dell’Adriatico.
« Non ho potuto — Egli riferisce in quest’ ultimo capitolo della sua relazione — per mancanza d’ instromenti e di tempo impegnarmi alle osservazioni della natura dell' acqua e suoi moti. Dalle informazioni però avute da periti naviganti e da
G. BRUZZO - l ’ OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 167
alcuni vecchi pescatori ho inteso che non mancano in questo golfo strane correnti, e non meno superficiali che presso il fondo in certi periodi, come ho nel mio saggio fìsico del mare accennato di avere altrove osservato, ma senza potere stabilire nulla di metodico per qualche sistema, il quale da veruno privato mai si potrà tentare. Perchè fa mestieri ohe in più mari (come nell’ Eusino, Bosforo, Propontide, Egeo, Golfo Adriatico, Medi- terraneo infìno allo stretto) e nello stesso tempo e metodo si faccian le tavole delle osservazioni, altrimenti nulla di buono si farebbe. Certa cosa è che da queste correnti e dalle loro diligentissime osservazioni si potrebbe formare un sistema, il quale inteso bene servirebbe non solo per spiegar meglio il flusso e riflusso e ritrovare il periodo giusto della non impossibile circolazione della mole acquea ma a molte altre cose che per brevità tralascio ». Dei moti dell’Adriatico, invero, il Mar- sili afferma soltanto l’esistenza, ma nulla di particolare può dire « non essendosi potuto per mancanza di istromenti e di tempo impegnare in osservazioni speciali » ; ne rileva tuttavia l’importanza in rapporto con l’intera circolazone « della mole acquea » ed abbozza per così dire un piano di lavoro per le future campagne talassografiche, mostrando di avere un larga e chiara visione del fenomeno marino e quindi rivelando ancora una volta la vigoria del proprio intelletto.
Anche nelle indagini sulla vita vegetale ed animale dell’Adriatico non impiegò gran tempo nè studio profondo, perchè ben altro era lo scopo della sua visita alla regione adriatica pontifìcia; e quindi la trattazione che ne fa è incompleta. Ed infatti « l’obbligo che mi correva — Egli soggiunge — di scorrere per servizio del principe la spiaggia non mi permise di potere come avrei desiderato tentare con diligente pescagione o altro mezzo più acconcio e più proprio ise vi siano entro questo mare delle piante come mi avvenne di trovarne nelle spiaggie della Provenza. Nondimeno nello scorrere più volte eh’ io feci tutti li seni e scogli del monte di Ancona con alcune navicelle ebbi grandissima cagione sospicare che in alcuni siti sassosi che quivi sono, vi sieno litofìti, pseudocoralli, e per avventura eziandio de coralli veri. E ch’io dica di questo il vero, me ne
1B8 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
diede una ferinissima testimonianza una fiera tempesta succeduta negli ultimi di maggio, la quale, a mio credere, strappò dal detto fondo le accennate cose fuorché de perfetti coralli: perciocché il dì seguente alcuni pescatori avendo gettate le loro reti in tal sito presso il Monte, raccolsero molti litofiti e pseudocoralli che in Ancona mi recarono. Si veggono pur quivi altre piante moli di varie specie, quando è calma, sopra sassi, tufi e cretoni, le quali... possono agevolmente pigliarsi. Dentroli calici de pseudocoralli trovai la solita sostanza glutinosa che ha il colore di paglia che per il loro aumento equivale al latte di colore bianchissimo del corallo rosso fino; sostanza nel vero che opera all’ingrandimento di tali piante pietrose, come V. S. con una esatta notomia della struttura di queste e dislocamento di tali succhi glutinosi riconoscerà nel secondo tomo del mio saggio fisico. A piedi della punta de gessi tanto del monte di Ancona quanto di quello della Cattolica nella profondità di un piede o poco più mi furono mostrate le dette pietre le quali in se stesse contengono li testacei tallari. Questa osservazione mi risvegliò alla memoria l’antica mia questione nella quale lungamente mi trattenni pensando, nell’ incominciare il terzo tomo, in cui tratto della generazione de viventi entro il mare, e particolarmente ragiono de testacei affatto rinchiusi dentro l ’arena, creta, pietra durissima ; in parte fitti nell’arena o pure legati con alcuni filamenti a pietre o a legni; o pure che insie- memente conglutinati sono fra essi loro, formando di se stessi un muro o uno scoglio ed in guisa che la unione di amendueli sessi tra loro non è possibile o sia per effettivo coito, come è manifesto seguire ne viviperi marini o, per lo spargimento dello sperma mascolino sopra le uova gettate dalla femmina sull’arena, pietre, legni o altra simigliante cosa. Io certamente confesso che sono all’oscuro come seguire possa questa generazione delle specie... ». Egli, invero, non dice cose importanti e limita le sue considerazioni, brevi, pressoché al corallo ed ai testacei: al corallo, che per lui non é più la pianta misteriosa della metamorfosi, alla quale si adattano i versi di Ovidio Sic et coralium, quo primum contigit aura* — Tempore durescit: mallis fuit li erba sub undis ; ma una vera pianta «dalla corteccia
G. BRUZZO - L* OPERA MILITARE E SCIENTIFICA 169
glandolosa, grossa e dai fiori di color bianco » ; e come tale essa si continua a concepire fino a quando il Cestoni prima (1717) e il Peysonel poi (1723) non ne dimostrano la natura animale. Dei testacei pure assai poco discorre ed in modo confuso, talché termina chiedendo lumi allo stesso Lancisi e dichiarando che, rassicurato dal suo parere, ne tratterà nel terzo tomo dell’opera intorno al mare: dichiarazione questa che ridonda a onore dell’Uomo, franco ed onesto come nei privati negozi così nelle pubbliche mansioni e negli studi.
E la missione, che la fiducia della Santa Sede aveva a lui affidata, Egli seppe compiere con abilità e fine accorgimento, raggiungendo il duplice scopo di corrispondere interamente alle aspettative del papa nei riguardi della difesa adriatica e di portare un nuovo contributo alla conoscenza scientifica del mare.
G iu s e p p e B r u z z o
La marineria Musulmana.
Nella sua opera, « lo Stato militare dell’impero ottomano », Luigi Ferdinando Marsili ha riportato le informazioni succinte, ma ordinate e preziose, sulla marineria ottomana, che egli aveva personalmente raccolte nella sua permanenza a Costantinopoli.
Nel rilevare quelle di tali notizie che si riferiscono alla tecnica e delle navi e del personale, non sarà inopportuno riassumere e prospettare in uno sguardo generale le vicende di tutta la marineria musulmana a partire dalle origini sino alla battaglia di Navarino, che chiude la vera attività militare marittima della Turchia.
Nella rapidissima, fulminea conquista compiuta contemporaneamente lungo il litorale nord africano e in Asia Minore contro l’impero bizantino, doveva quanto prima rendersi indispensabile agli Arabi anche una marineria. E questa effettivamente sorse poco dopo la morte di Maometto, ossia durante il governo dei primi quattro califfi, i così detti quattro califfi « ben diretti ». - Abù Bakr, Umar, Uthmàn e Ali.
Il vero campo della futura marina musulmana non poteva essere che il Mediterraneo; mettiamo quindi senz’altro fuor di questione il Mar Rosso, a proposito del quale pur nulla si sa di diretto e preciso quanto alle azioni navali dei primi Musulmani.
Prima dell’IsIàm si può dire che in quel mare dominava incontrastata una marineria etiopica, ma più che militare, mercantile;il traffico fra le due sponde era essenzialmente attuato da navio imbarcazioni abissine e i piloti abissini, molto abili, servivano anche sulle nav? che uscivano poi nel Golfo Persico e verso l’india, incrociandosi il loro servizio con quello dei piloti indiani.
172 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Naturalmente appena sorto lo Stato musulmano, questo, nella sua terribile ed improvvisa espansione centrifuga, non dimenticò la prospiciente Abissinia e provvide ad ottenere anche il dominio del mare Eritreo. Non si sa di preciso come andassero dettagliatamente le cose, solo risulta che quel dominio fu immediatamente ottenuto, il commercio marittimo etiopico venne distrutto e Adülis, l'odierna Zula (poco lungi da Assàb), il grande porto commerciale abissino, perdè di colpo ogni importanza ; anzi dalle rovine apparirebbe che fosse stato precipitosamente abbandonato da tutti gli abitanti, quasi in una sola notte, davanti all’impeto musulmano.
Si ha notizia di un disastro navale dell’IsIàm, un completo naufragio della prima flotta mandata alla conquista dell’opposta sponda dal secondo califfo Umar; disastro tuttavia che non impedì quella conquista, subito dopo egualmente avvenuta, tanto che risulta come al di là dello stretto Mare Eritreo si mandassero dall’Arabia a domicilio coatto i politicanti importuni.
Tuttava il dominio del Mar Rosso, se procurò al nuovo IsIàm la padronanza della gran via marittima verso le Indie e l’Oriente in genere, nulla gli giovò per la conquista e la conversione della cristiana Etiopia ; e nemmeno quando, pochi anni dopo, tutto l’Egitto era già divenuto musulmano, sicché anche dal Nord essa poteva esser invasa.
L ’Etiopia resistè come un masso inespugnabile alla pressione musulmana che la stringeva dal Nord e daH’Oriente, come resistè contemporaneamente a quella pagana dei popoli che dal centro deH’Africa proseguivano la fatale millenaria invasione verso il Nord, invasione che tuttora si continua coi Galla.
L ’Etiopia resistè per mille anni isolata completamente, come perduta e tagliata fuori della Cristianità, fuori della civiltà europea con la quale era prima stata in fecondo contatto. Resistè per opera del Cristianesimo, certo degenerato oltre che eretico e che ancor piti degenerò durante il periodo d'isolamento, ma che ebbe l'effetto di dar una coscienza nazionale all’amalgama non omogeneo della popolazione e a mantener in vita per nuovi destini l’antico regno di Axùm, trasformato in impero d’Etiopia,
B. DUCATI - LA MARINERIA M USULM ANA 173
runico Stato africano che, oltre l’Egitto, possegga una storia propria.
E resistè fino a quando essa fu nel 1490 per l’Europa nuovamente rivelata dal Padre Pedro do Covilham, il quale in quell’impero e in quel sovrano cristiano, da secoli dimenticato, credè aver trovato il leggendario Prete Gianni di cui ci parla Marco Polo. E fu egli il primo tramite per la richiesta e l’invio delle flotte portoghesi in sostegno della Cristianità contro l’IsIàm che ora anche dalla parte sud orientale, dalla Somalia, incalzava.
Passando al vero campo d’ azione della marineria musulmana, il Mediterraneo, troviamo che Umar, male impressionato dal disastro anzi rammentato della flotta mandata sul- l ’ opposta sponda del Mar Rosso, rifiutò a Muàwia, il suo governatore di Siria e futuro quinto califfo, il chiesto permesso di servirsi di navi per attaccar le isole cristiane del Levante. Muàwia, il vero fondatore della marineria musulmana, dovè pel momento rinunciare ai suoi progetti navali, ma potè darvi ampiamente corso sotto il successivo califfo Uthmàn, della stessa sua stirpe, il quale gli lasciò mano libera sia per la consolidazione della sua provincia di Siria in uno Stato quasi autonomo, fortissimo e fedelissimo, sia nelle sue azioni belliche contro l’ impero d’ Oriente.
Così con Uthmàn, a partire dal 649, si ebbe la vera istituzione di una marina da guerra araba, poiché fu concesso a Muàwia di costituirla, alla condizione tuttavia che fosse composta di soli volontari; marina la quale, appartenendo ad un popolo essenzialmente terriero, ebbe subito la caratteristica che poi conservò anche sotto i Turchi, popolo egualmente terriero, di esser cioè nella sua parte tecnica essenzialmente costituita da indigeni delle coste, quindi presi fra le popolazioni assoggettate, convertite o meno all’ IsIàm, e da rinnegati cristiani.
Cipro, Rudi, Creta vennero corse e saccheggiate nelle loro spiaggie. Il primo ammiraglio (amir al bahr, principe del mare) si può dire che fosse fra gli Arabi Abù Qàis e la sua abilità rifulse nell’attacco di Cipro.
Altro ammiraglio e più famoso fu Abd Allàh Ibn Abi Sarh,
174 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
che successe poi nel governo (l’Egitto ad Anar bin al Aas che l'aveva conquistato. Nel 652 egli sconfisse la flotta bizantina davanti Alessandria e due anni dopo, a Foinix sulle coste della Licia, riportava la prima grande vittoria navale sulla flotta greca comandata dallo stesso imperatore Costante II.
Nel (><>1 Muàwia, spodestando Ali, si fece califfo. Già come governatore della Siria nel (548 aveva effettuato la sua prima spedizione contro Cipro, nel 654 la seconda e Tanno prima aveva osato persino minacciare Costantinopoli. A partire dal suo califfato gli Arabi seguitarono a svolgere intense azioni sul mare; la loro marineria, ormai saldamente costituita, permetteva loro di compiere scorrerie per tutto il Mediterraneo orientale, prendendo saldamente piede nelle isole già prima più volte corseggiate. Nel 666 veniva effettuata la prima razzia in Sicilia. Ma Pobbiettivo ben definito di Muàwia era la metropoli nemica, Bisanzio, e ripetutamente la attaccò.
La assediò la prima volta nel 669 e per tre mesi, poi nuovamente, ma sempre senza ottener nulla, nel 674, nel quale anno occupò Cizico, che fu poi per trattato restituita nel 680, subito dopo la sua morte.
L ’assedio di Costantinopoli in maggior stile, ma sempre senza risultato, fu preparato da Walid I ed iniziato il 25 agosto 716 dal suo successore Sulaimàn in modo completo, anche dal lato di terra. Solo pochi mesi prima Leone Isaurico era salito sul soglio di Bisanzio e vigorosamente aveva subito preparato la resistenza.
L'assedio durò circa un anno e sul principio non apparve sfavorevole ai Musulmani, i quali fra l’altro avevano occupato Pergamo e Sardi, sicché i Greci si trovarono duramente premuti. Ma il rigido inverno si mise dalla loro e gli assedianti dovettero alla fine ritirarsi. Il loro condottiero Maslama ricondusse le sue forze di terra diminuite e stremate, in uno stato veramente pietoso, mentre che la flotta araba, nel suo ritorno, veniva in parte distrutta da una violenta tempesta.
I Musulmani considerarono il disastro come uno dei peggiori che abbiano colpito l’umanità e come quello che ritardò per secoli il progresso del mondo. L'altro gran disastro del
B. DUCATI - LA MARINERIA M USULM ANA 175
l ’IsIàm nel primo impeto della sua conquista fu poco dopo (732) la battaglia di Poitiers, con la quale esso venne definitivamente fermato in Occidente da Carlo Martello; disastro dipeso dal- l’aver le rivolte dei Berberi in Libia e Tunisia impedito il tempestivo giungere dei soccorsi arabi in Provenza.
Effettivamente se Maslama avesse occupato Costantinopoli,o se Carlo Martello fosse stato soccombente, la storia dell’IsIàm e quella dell’Europa sarebbero state ben diverse; non si sarebbero molto probabilmente avute le Crociate e i Musulmani in Europa li avremmo poi trovati, oltre che fra gli Asiatici invasori, non soltanto fra gli Albanesi e Bosniaci ed Erzegovini.
Con la successiva dinastia califfale, gli Abbàsidi, si ebbe una ripresa marinaresca dell’ IsIàm.
Nel 806 Humàid bin Maaiùf, ammiraglio del leggendario califfo Hàrùn ar Rascid, occupò Cipro sotto pretesto di mancanza ai trattati, e deportò come schiavi sedicimila dei suoi abitanti.
Poi le imprese marinaresche arabe contro la Cristianità avvennero non più ad opera del califfato, ma delle dinastie autonome stabilitesi sulla costa settentrionale dell’Africa.
Già nel 800 Hàrùn ar Rascid aveva messo, nella regione fra Tripoli e Algeri, come governatore Ibràhìm bin Al Aghlab, il quale ben presto si rese autonomo fondando la dinastia degli Aghlabìti. L ’impero califfale, giunto all’apice della sua potenza, della ricchezza e dello splendore, cominciava a non curarsi più tanto delle regioni più estreme e a disinteressarsene, come già aveva fatto per la Spagna e il Marocco.
Gli Aghlabìti furono, per le coste Nord mediterranee e specie le italiane, dei veri corsari; fra loro maggior fama ottenne il secondo successore di Ibràhim, ossia Ziàdat Allàh, e particolarmente per i suoi successi in Sicilia. Ma le incursioni piratesche vennero dirette anche sulle coste della Sardegna e della Corsica, a Nizza, Civitavecchia ed Ischia.
Dopo la battaglia di Mazara (827) la Sicilia fu anche occupata e in seguito completamente con la presa di Messina (842) e in fine a Siracusa (878). Dalla Sicilia gli Aghlabìti tentarono attaccare anche Gaeta e Roma, di cui vennero persin
saccheggiate le basiliche esterne; ma furono respinti, mentre che truppe bizantine liberavano Bari, inclusa nel piccolo regno che F ammiraglio aghlabìta al Mufarrigj si era costituito in Puglia e Calabria.
Nel 872 gli Aghlabìti toccarono una grave sconfìtta a Salerno, che pose termine ai loro tentativi di conquista sul continente italiano, sicché si ridussero alle semplici razzie.
Al principio del decimo secolo agli Aghlabìti nel Nord del- l’Africa successero gli eretici Fatimìti, fondati da Ubàid Allàh al Màhdì, il quale, dopo alcuni tentativi, riuscì a toglier nel 934 la Sicilia agli antichi governatori Aghlabìti ivi rimasti; di là le sue navi mossero a saccheggiare sin Genova (935), la Corsica e la Sardegna. Poi i Fatimìti conquistarono l’Egitto e là si stabilirono, il litorale centro africano sfuggì dalle loro mani e vi successero varie dinastie berbere.
La Sicilia restava pur sempre sotto i Fatimìti, sino a che nel 988 il loro governatore Giàafar si rese autonomo; ma con la sua crudeltà di governo scontentò prima i Berberi, che egli rimandò in Africa, poi gli Arabi, i quali lo deposero e lo scacciarono in Egitto, pur lasciandogli portarsi seco le sue « economie » in 670.000 monete d’oro.
Il malgoverno degli Arabi in Sicilia provocò l’intervento dei Bizantini, dei quali le truppe poi si ritirarono lasciando l’isola frazionata in molti piccoli governi musulmani in lotta fra loro, uno de quali chiamò in suo soccorso i Normanni. Il principe di questi, Roberto Guiscardo, fece iniziar la conquista dell’isola dal fratello Ruggero, poi egli stesso la completò, occupò Malta e il suo successore Ruggero I I si impadronì, ma per poco, anche del litorale africano da Susa a Tripoli (1148).
Siamo già nel periodo delle Crociate, durante le quali, e ancor per due secoli dopo, il Mediterraneo si trova in potere, si può dire, dei Cristiani; la pirateria non può più fiorire; mentre dal lato orientale del bacino l’ impero islamico, diventato di arabo turco, attende all’assestamento dopo l’invasione mongola di Tamerlano (1402-3) ed esplica il suo conflitto con l’Occidente cristiano essenzialmente posando il piede in Europa
176 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
B. DUCATI LA MARINERIA M USULM ANA 177
attraverso il Marinara e giungendo sino alla conquista di Costantinopoli (1458).
'Si può dir che a partire da quest'epoca la marineria dell'IsIàm agisca in due ambienti e con due indirizzi ben diversi. Risorge da un lato la pirateria nel Mediterraneo occidentale e centrale e per la colpevole inerzia, se non acquiescenza, dei Governi cristiani dura più di tre secoli. Ma ciò si può dir non riguardi affatto l’impero ottomano. Questo per mare ha le sue azioni essenzialmente guerresche e politiche, piratesche solo, negli effetti.
Considereremo quindi separatamente i due campi d’azione marittima dell’ IsIàm, cominciando da quello dei così detti Corsari barbareschi.
I Mori completamente vinti in Ispagna con la resa di Granata (1492), e ira loro specie gli Abencerragi espulsi, si vendicarono facendosi corsari e la pirateria in seguito si organizzò sotto tre capi famosi: Khàir ad Din ibn Bàbà Urftgj (Barbarossa), IJlùoj Ali (Ucciali) e Turgùt (Dragutte), che ottennero l’ investitura dal sultano di Costantinopoli al quale avevano conquistato e sottomesso rispettivamente l’Algeria (1517), la Libia (1574) e la Tunisia (1551).
Sino al 1587 le tre provincie furono governate dai beilerbèi nominati dal sultano, poi, sino al 1659, da pascià mandati triennalmente dalla Porta. Dopo di che le regioni si resero autonome, costituendo come delle repubbliche oligarchiche le quali si nominavano ciascuna il proprio reggente e vivevano essenzialmente di pirateria.
I beilerbèi erano stati dei veri ammiragli del sultano e, oltre che occuparsi della caccia agli schiavi, avevan anche condotto flotte potenti per veri scopi militari e politici; dovremo quindi occuparci nuovamente di loro anche nel trattare delle azioni militari navali dell’impero ottomano.
Dopo il 1587 la pirateria rimase l’unico scopo di questa marineria. I capitani delle navi (reis), molti dei quali erano cristiani rinnegati, costituivano una vera corporazione e tutto il traffico piratesco si trovava dettagliatamente regolamentato.
II principale porto della pirateria barbaresca fu dapprima
13
178 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
La Bougie (Begjàia, la romana Scaldae) presso Costantina, dal nome della quale si chiamarono in Francia le candele. Il suo hinterland poteva allora fornire in abbondanza il legname da costruzione.
Sino al XVII secolo i pirati si servirono solo di galere a remi con vela semplicemente ausiliaria; poi il rinnegato fiammingo Simone Danser insegnò loro l’arte del veleggiare. Uscirono quindi le navi dai vari porti corsari, di cui i principali erano divenuti Algeri, Tunisi, Tripoli e Salii nel Marocco, e mentre le galere, incapaci di tenere l'alto mare, servivano per il Mediterraneo e la navigazione costiera, i velieri portavano i corsari nell’Atlantico, alle Canarie e sino in Islanda. Nel 1631 Murad bei, un rinnegato fiammingo, saccheggiò Baltimora in Irlanda.
La prima metà del secolo XVII fu l’età più fiorita della pirateria barbaresca ; i più potenti Stati della Cristianità s’eran assuefatti a pagarle tributo e tollerarne le provocazioni e gli insulti.
La Francia incoraggiò questi pirati contro la Spagna sua rivale, poi furono la Gran Britannia e la Olanda ad aizzarli contro la Francia. Si giunse nel XVII secolo al punto che uomini politici inglesi non ebber vergogna di affermare come la pirateria nel Mediterraneo fosse un elemento indispensabile nelle competizioni commerciali fra le nazioni. Lord Exmouth istesso, nel partire per una spedizione punitiva contro i pirati, scriveva ‘thè la loro soppressione non avrebbe potuto riuscir gradita ai commercianti in genere.
Le reazioni armate della Cristianità contro quel danno e quella vergogna si trascinarono per quasi due secoli.
Nel 1655 l’ammiraglio britannico Bobert Brake inflisse ai Tunisini una severa lezione; seguirono altre spedizioni inglesi ed anglo olandesi. Nel 1682-3 i Francesi bombardarono Algeri e si ebbero ancora altre spedizioni da parte loro. Nel 1801-3 e 1815 furono effettuate le spedizioni degli Stati Uniti d’America.
Il saccheggio di Palma in Sardegna nel 1815 e il fatto dei nuovi interessi inglesi nel Mediterraneo dopo l’acquisto di Malta e delle isole ionie, fecero sì che al Congresso di Vienna venisse
B. DUCATI - LA MARINERIA M USULM ANA 179
decisa la soppressione della pirateria e se ne desse il mandato all’Inghilterra.
Fu quindi nel 181(5 inviato Lord Exmouth il quale dapprima trattò con Algeri e con Tunisi, poi, assieme all’ammiraglio olandese Yan de Capellen, bombardò Algeri ottenendo la liberazione di tremila schiavi cristiani.
Ma Algeri riprese subito le azioni piratesche sino a necessitare che nel congresso di Aix la Chapelle si decidessero le misure necessarie per farle cessare.
Nel 1824 l’ammiraglio inglese Harry Neal nuovamente bombardò Algeri. Pure la pirateria ebbe termine solo con la conquista francese dell’Algeria (iniziata nel 1830).
Passando ora dalla pirateria alla vera marina militare musulmana :
Maometto II, occupata Bisanzio, inviò una potente spedizione navale contro Rodi, sede dei Cavalieri di San Giovanni, ma essa fallì e si concluse un armistizio e un trattato di commercio col Gran Maestro Pierre d’Abusson (1479). Contemporaneamente Otranto era stata occupata e rimase per un certo tempo nelle mani dei Turchi.
Il 29 luglio 1499 il sultano Bajazed I I ottenne la prima grande vittoria navale sui Veneziani a Sapienza ed occupò Lepanto; seguì la conquista turca della Morea e del pili delle isole dell’Arcipelago.
Nel 1522 si ha la spedizione di Selim I contro Rodi, che viene espugnata dopo sei mesi d’assedio.
Le imprese navali di Khàir ad Din Barbarossa, che stanno fra le glorie dell’ impero turco, condussero nuovamente all’ ostilità contro Venezia. Il celebre ammiraglio corsaro, dopo aver tolto Algeri alla dinastia berbera dei Wattasìdi, attaccò anche Tunisi dominata dagli Hafsìdi e ne fu respinto con l’intervento degli Spagnuoli ; ma nel Mediterraneo mantenne una lotta molto vivace con Andrea Doria, ammiraglio di Carlo V. Venezia si alleò all’impero e per conseguenza i suoi possedimenti vennero attaccati dalla Turchia per terra e per mare e molte isole, fra le quali Syra e Tinos, caddero davanti agli assalti di Barbarossa. La pace fu poi conclusa alla condizione che alla Turchia
180 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
restassero le conquiste fatte e inoltre le venisse versata una forte indennità.
Nel 1541 si ebbe una gran spedizione di Carlo V contro Algeri, la quale completamente fallì per esser stata la flotta alteramente distrutta da un’improvvisa tempesta (Ottobre).
Nel 1542 la flotta turca fu messa a disposizione di Francesco I, il cristianissimo re di Francia, e nell’anuo seguente Barbarossa e il duca d’Enghien, assieme alleati, posero l'assedio a Nizza che Andra Doria giunse in tempo a liberare.
Nel periodo successivo il potere ottomano sul mare fu mantenuto specialmente mercè una serie di valenti ammiragli che successero al Barbarossa, a cominciare da suo figlio Ilasan: altri furono i seguenti:
Pialè, un ex cristiano croato che era giunto al grado di •capudan pascià; egli riportò sulle galere di Andrea Doria una serie di vittorie ed occupò nel 1560 Gerba, l’isoletta presso Tunisi, preludendo alla cacciata completa delle forze di Carlo V, che si trovavano insediate in quella città sin dal 1534, cacciata compiuta poi nel 1574 da Ucciali;
Dragutte, figlio di un Cristiano dell’Asia Minore e antico galeotto sulle navi genovesi, divenne il terrore del Mediterraneo. Occupò Mahdìa in Tunisia e ne fece il centro delle sue scorrerie. Bombardato ivi da una spedizione di Carlo V nel 1550, subito dopo (1551) occupò Tripoli scacciandone i Cavalieri di San Giovanni che la tenevano da quasi quaranta anni; prese anche Bastia in Corsica (1553) e morì nel suo infruttuoso attacco a Malta (1565);
Piri Reis, nipote di Kiàmil Reis il quale sotto Baiazed II aveva scorazzato per Egeo e Mediterraneo, compì le sue imprese nei golfi Arabico e Persico e nell’Oceano Indiano. Prese Mascate e assediò Ormuz, ma ne fu scacciato da una flotta portoghese;
Sali Reis fu un altro valente ammiraglio ex cristiano;Sìdi \lì, altro ammiraglio, pure battuto dai Portoghesi,
per gli scritti che lasciò porta il nome di Kàtib Rùmì. Sbarcato con cinquanta compagni sulle coste indiane, fece per terra un viaggio di tre anni nel Siud, Belucistàn, Khurasàn, Persia e Turchia sino a rendersi a Costantinopoli e lasciò la descrizione
B. DUCATI - LA MARINERIA M USULM ANA 181
del suo viaggio. Scrisse pure un lavoro matematco sull’ uso dell’ astrolabio e un libro, il « muhit » (Oceano), sulla navigazione nei mari indiani.
Nel 1571 Selim I I prese Famagosta di Cipro e fece uccidere in supplizio il governatore veneziano Marco Antonio Bragadino contrariamente ai patti della resa; nello stesso anno avvenne la battaglia di Lepanto. Infruttuosa come successo materiale (l’anno seguente usciva lina nuova flotta ottomana di 250 navi), ¿ssa ebbe un valore morale altissimo e costituì una grandiosa manifestazione di solidarietà del mondo cristiano.
Dopo una guerra di venticinque anni, Candia cade in mano ai Turchi (1(569). Nel 1715 la flotta turca occupa Tinos e Cerigo e i tre forti (Suda, Grabusa, Spinalunga) che in Candia ancora rimanevano ai Veneziani. L ’Austria interviene quando gli Ottomani accennano a voler occupare Corfù.
Nel 1770 la flotta ottomana è attaccata e distrutta al largo di Cheshme da quella russa, la quale minaccia di entrar pei Dardanelli.
Nel 1779 le flotte di Russia e Turchia, alleate, occupano le isole ionie, che pel trattato di Campoformio eran passate alla Francia, e alcune città ancor indipendenti dell’Albania.
Nel 1807, aiutata da un forte vento del Sud, la squadra inglese passa i Dardanelli, si ancora alle Sette Torri e manda un ultimatum al sultano. L ’ambasciatore francese Sebastiani persuade alla resistenza e in un sol giorno mille cannoni vengono piazzati sulle due sponde del Bosforo, sì che, dopo dieci giorni, gli Inglesi devono ritirarsi non senza subire gravi danni nel passare davanti ai forti.
Nel 1827, al 27 di Ottobre, avviene la battaglia di Navarino, l’evento decisivo che consentì la liberazione della Grecia..
Nella baia stava raccolta la flotta turco-egiziana sotto il comando di Tàhir pascià, quando la flotta anglo-franco-russa, agli ordini dell’ammiraglio Codrington, entrò e si mise all’ancora schierata entro il semicerchio formato dai Musulmani.
Le Potenze europee non erano in guerra con la Turchia, solo avevano allora ottenuto la dichiarazione della sospensione delle ostilità contro i Greci, promessa anche dal generale egiziano
182 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Ibràhira pascià figlio di Mohammed Ali; e invece della baia si scorgevano nell’interno sorgere le colonne di fumo dei villaggi incendiati.
Per un malinteso o forse per atto di fanatismo individuale, da una piccola nave turca fu sparato su una lancia inglese e allora la flotta musulmana venne immediatamente colata a picco.
Luigi Ferdinando Marsili si trovò giovanissimo a Costantinopoli alla fine del XYrII secolo, quindi ancora nel pieno fiorire della marineria ottomana, che egli tuttavia trova molto poco esercitata ed ordinata, e tenuta alla necessaria altezza tecnica principalmente ad opera di rinnegati.
Nelle sue sobrie e lucide note, egli si rifà all’inizio della marina turca, rammentando che Maometto II investì Costantinopoli e compì le successive imprese sul mare servendosi di navi comprate da Cristiani in Europa. Fra i suoi successori il grande Selirn I, per consiglio del vizir Pery pascià, feee fabbricare 500 navi con materiale fornito dall’impero turco e compì la costruzione degli arsenali.
Passa quindi l’autore a descrivere schematicamente il materiale e il personale.
Dell’arsenale accenna solo che si trova a Calata, con accanto il bagno (zentanè) degli schiavi.
La flotta comprende navi a remi e a vela e navi solo a vela, che sono o mantenute dall’erario sultaniale, o da governatori ed altri funzionari, ossia i beilerbèi, bèi, ecc. o dai principi tributari dell’ impero.
Le navi a remi con vela ausiliaria presentano i seguenti tipi :
fricata ( = fregata), con 10-12 banchi ; berghendò ( = brigantino), con 18-19 banchi ; galeotta ( — alle europee), con 19-24 banchi ; gikterè ( = galera), rotonda come un cocomero, per me
glio sostenere le tempeste del Mar Nero, e con 25 banchi; le galere si chiamano:
zachalè quando sono mantenute dall’ erario; beilery’ se mantenute dal loro ammiraglio;
B. DUCATI - LA MARINERIA M USULM ANA 183
maona (come una galeazza veneziana), con 26 banchi;orta bastarda, con 26-27 banchi;bastarda (come le veneziane), con 36 banchi.
Quanto alla vela ausiliaria. ad esempio la galera aveva quattro vele tutte triangolari:
il trinket (di 600 braccia) all’albero di prora; all’albero maestro le altre:
il kortaran (1400 braccia), poi passata in disuso perchè non maneggevole;
la mezzana (1200 braccia);il burdè (800 braccia), da sostituirsi in tempo cattivo.
Gli strumenti nautici prescritti per ogni nave erano: uno scandaglio; una carta nautica; una bussola; un cannocchiale.
L ’armamento di una galera consisteva in tre cannoni posti in corsia.
La. maona era più potentemente armata; aveva quattro cannoni in corsia, due sul castello di prora, due su quello di poppa, due sui fianchi, quattro falconetti sul castello di poppa e sei petriere fra i remi.
Venti galere beilery’ erano armate dai comandanti delle isole e luoghi marittimi, i quali, per mantenerle, percepivano sulle popolazioni la decima o ushùr.
Le galere zachalè, dovevano essere almeno quaranta in ordine, con sei maone.
Navi unicamente a vela erano i galeoni, forniti quasi tutti dalle provincie di Barberia (Libia, Tunisia, Algeria), le quali adoperavano le galere solo pel loro traffico piratesco e mettevamoi galeoni, dietro un certo compenso, a disposizione del sultano.
La costruzione di una galera importava la spesa di 1344 talleri.
Quanto al personale, è a distinguere quello che potremmo chiamare costiero da quello navigante.
Il primo comprendeva gli azzàp, in numero di 1364, fissato dal Kanùn Namè (Regolamento), e divisi in isquadre; erano
184 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
addetti al servizio di guardia, custodia del bagno, alle imbarcazioni e alla calafatura. Avevano per ausiliari dei fanciulli cristiani prelevati, come i gianizzeri, quale tributo dalle popolazioni cristiane dell’ impero. Gli azzàp dovevano essere istruiti anche nella navigazione.
Gli ufficiali per la disciplina erano: il reis o guardian bashy’, nello stesso tempo còmito della galera imperiale; aveva il dovere di compier ronde notturne e poteva anche assumere il titolo di capitano dell’arsenale (terzane); l’odà bashy o suo luogotenente; lo ashgjy’ bashy’ o capo cuoco.
Per la cura dell’arsenale gli ufficiali erano: il terzanè eminy’, che teneva anche il comando di una galera, il controllore del porto e il magazziniere.
Passando ai naviganti, essi erano distinti nelle seguenti categorie :
leventi, specie di fanteria di marina, fornita da certe pro- vincie marittime;
marinai costieri di rinforzo sulle navi; marinai fissi per la manovra; ciurma da remo (schiavi cristiani); artefici (falegnami, fabbri, calafati, cordai).
Gli ufficiali supremi dell’armata erano: il capudàn pascià, ammiraglio comandante su tutte le
spiaggie ed isole. La sua autorità diventava dispotica non appena fosse uscito dai Dardanelli. Risiedeva nominalmente a Rodi e vi teneva un rappresentante (sirdàr) con tre galere a carico dell'isola ; ma generalmente vi lasciava tre zachalè mantenute dall’ Erario, così che egli si rubava la somma relativa. Portava per insegna una canna d’india:
il terzanè kiany’, con diritto ad una contribuzione per ogni galera. Portava lui pure una canna d’ India ;
il terzanè agasy’, o luogotenente del capudàn pascià quando questi lasciava Costantinopoli; riceveva egli pure una contribuzione per ogni galera e portava una canna d’ India.
Su ogni galera si avevano i seguenti ufficiali: il begh o capitano;il guardian bashy’ o còmito, per la ciurma e la manovra ;
B. DUCATI - LA MARINERIA M USULM ANA 185
il rèis o timoniere (di solito il più anziano degli schiavi) per il pilotaggio (ufficiale di rotta).
L ’equipaggio di una galera zachalè comprendeva, oltre i tre ufficiali :
2 giami o trasmettitori ili comandi col fischietto;20 marinai compreso il loro oda bashy’ ;2 fabbricanti di remi;2 calafati;2 falegnami;
196 galeotti;100 leventi;
in tutto 327 uomini.Tutta la flotta prescritta dal Kanùn Namè, di 40 zachalè,
20 beilery’ e 6 maone, aveva un effettivo di 16.400 uomini, di cui 7.300 combattenti.
Tale era la flotta normale, potremmo dire: in tempo di pace, dell’impero ottomano; naturalmente poi essa aumentava le navi e gli effettivi quando passava sul piede di guerra.
Il Marsili, nella sua rapidissima esposizione, accenna come a lui sembrasse possibile il forzamento dello stretto dei Dardanelli per dei marinai arditi; e il suo pensiero doveva riferirsi a marinai italiani, poiché quel che osarono duecento quaranta anni dopo le nostre fragili torpediniere, non si sentì di farlo pochi anni appresso la numerosa e potentissima squadra inglese, fornita dei mezzi più ricchi e più moderni.
B r u n o D u c a t i
L. F. Marcili geografo.
Il titolo ha bisogno d’un chiarimento: non parlerò del Marsili geografo dando alla parola geografla il significato che oggi questa scienza ha assunto, ma attribuendo ad essa il valore che aveva nel secolo del Marsili, valore più vasto ad un tempo e più vago.
Quindi tutti i fenomeni localizzati sulla terra e da lui considerati, risolti o avviati ad una soluzione, in qualche modo trattati, prenderò in esame. Non seguirò un criterio cronologico, perchè il Marsili più volte ritorna sullo stesso argomento ed ogni volta che può cerca di vedere se quel che ha scoperto o concluso è confermato dalle sue nuove osservazioni, perchè da studioso di rara coscienza ha sempre dubbi sui risultati a cui è giunto e rifà più volte il cammino percorso e ritenta per altra via di pervenire alle stesse conclusioni, ma raggrupperò in vari capitoli la varia sua attività, procurando dall’esame un po’ rapido — troppe pagine sarebbero necessarie per esaminare ogni cosa ed esaminarla con ampiezza — di trarre un’immagine, vicina alla precisione, di lui come contributore alla migliore conoscenza del globo.
Ed un’altra osservazione mi preme aggiungere. Se qui io vo lessi, come qualcuno ha tentato di fare, passar in rassegna quel che è stato scoperto dal Marsili nel campo della geografia, non dovrei che porre tentativi nobilissimi, superati ben presto dai progressi fatti di poi. Forse non c’è problema che egli abbia risolto definitivamente, non c’è campo, nella grande varietà della scienza geografica, che egli abbia percorso in tale guisa da esonerare i posteri da ogni tentativo di ripercorrerlo; non c’è verità, rimasta di poi immutata, che egli sia riuscito a fissare con preci
188 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
sione e sicurezza. Però quel che egli non ha fatto nel campo positivo del sapere, quel che non è riuscito a fare — non per colpa sua, ma per le condizioni assai tristi in cui erauo le discipline geografiche, troppo inferiori all’altezza dei problemi da lui tentati ed assaliti — è largamente compensato dalle superbe sue affermazioni nel modo di trattare gli argomenti : egli è un maestro impareggiabile di metodo, e dentro i confini da lui fissati per ciascuno degli argomenti che ha trattati, e sotto il titolo da lui stosso posto in cima ad ogni capitolo, è possibile ancor oggi raccogliere tutta la fresca materia che la scienza ha saputo accumulare.
Nella storia del metodo, che è in fondo storia pur essa della scienza, il Marsili occupa un posto notevole assai; e questa sapienza di disposizione delle parti, questo anticipare e posporre, che non è affatto formalità ma è sostanza, questa gradazione di importanza di argomenti, il Marsili non ha tratta da modelli precedenti, ma ha inaugurata lui.
Tale aspetto dell’attività scientifica sua io cercherò di mettere in chiara evidenza, parendomi che egli non meriti minore ri- conoscenza da parte nostra dei reali contributi portati alla scienza.
Come si esamina un fenomeno geografico, ci insegna il Marsili, come lo si studii, come lo si tratta ; quali siano le parti che vanno considerate prima e quali quelle che devono seguire, quali proporzioni si devono osservare nella trattazione dei singoli capitoli, questo ci dice con i suoi modelli che appaiono ancor oggi esempi degni di imitazione. Ed altre cose ci insegna il Marsili che io porrò in luce, affinchè non appaia la risurrezione sua, in questo bicentenario, come un fatto puramente storico, ma sia sopra tutto la determinazione del suo valore come cultore di scienza e come studioso dei fenomeni naturali.
* * -»
Si può dire che il Marsili abbia prevalentemente esaminato una serie di fenomeni geografici — intesa sempre la parola geografia nel senso antico, non in quello d’oggi — quelli dove elemento predominante è l'acqua; difatti è considerato come uno
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 189
dei fondatori dell’oceanografìa, e noi aggiungiamo che gli si può assegnare il merito di aver fondato la potamologia e di aver dato il primo modello di monografìa limnologica, senza tener conto del suo trattato sulle valli bolognesi, senza fermar troppo l’attenzione sulle sue schede intorno ai pozzi ed alle fonti1, senza an- mettere importanza soverchia, chè sono osservazioni fatte e conservate, ma non destinate a servire all’autore come materiale da elaborare, ai bagni minerali e termali2. Nè mancano neppure i ghiacciai: al ms. 90 C, a carta 90 c’è un’annotazione sopra il glegier (gletscher) o monte di ghiaccio perenne nel cantone di Berna.
Quindi si può affermare che tutti gli aspetti della idrografìa, tutte le sue divisioni, sono state trattate o toccate dal Marsiii: l’acqua fluttuante dei mari, o scorrente o raccolta in bacini o serpeggiante sotterra è stata da lui considerata, sottoposta a diligente e fortunato esame, analizzata nella sua composizione, guardata anche da un punto di vista umano.
Quanti mari ha navigati e su quanti mari ha fatto le sue osservazioni ! Da Venezia ha viaggiato fino a Costantinopoli e s’è fermato sullo stretto di Costantinopoli; da Livorno, sempre per mare, è giunto fino alle foci del Tamigi e di qui all’Olanda; è stato a lungo e per più volte sulla spiaggia di Provenza, ed ha percorso le spiagge marchigiane, a scopo militare, il che non gli ha impedito di fare osservazioni e di aggiungere conferma a quel che sapeva ed a cui era giunto attraverso il più attento esame.
Pure non pochi furono i fiumi da lui studiati; dalla Raab, il primo individuo della potamologia sottoposto ad osservazione, al Danubio trattato, quasi per intero, dalle sorgenti alla foce, in sei grossi volumi, è tutto il camino da lui percorso per impossessarsi pienamente di tutto ciò che caratterizza un corso d’acqua,
1 V. Ms. 87, pp. 71-81 - Avvertim enti circa i laghi e fonti.Ms. 90, A. 6 - Detaglio dei pozzi di Barigella, Cò di Savena e Mi-
nerbio. - A. 13 - Diverse altezze dei monti e profondità dei pozzi.2 Ms. 51, pp. 88-90 - D ell’uso dei bagni turchi ; Ms. 87, pp. 68-70 -
Annotazioni circa i bagni ed acque di Carlsbad e sue stalictides.
190 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
per comprendere quasi l’essenza sua e la sua intera funzione. Ma non solo dal Danubio — il fiume che ha esplorato intero, — parla magistralmente, ma anche il Reno — altro bel fiume interessante ed importante — parve per un momento attirasse la sua passione di studioso. E difatti abbiamo una serie di mappe 1 ed anche l’affermazione che era suo desiderio di sottoporlo come il Danubio, ad un esame; ma, forse, Tessersi proprio sul Reno imbattuto in quella sfortuna che decise poi di tutta la sua vita, gli troncò ogni intenzione e gli fece cadere ogni proposito.
Ma il Po, il Reno bolognese, il Rodano ed altri minori membri dell’idrografìa fluviale ricorrono ne’ suoi manoscritti ed hanno avuto omaggio di osservazioni e di rappresentazioni.
Per i laghi si deve ripetere quel che si è detto per i fiumi : il lago di Garda è stato il più fortunato, perchè completo è statolo studio intorno ad esso. Ma di altri laghi s’è occupato il Mar- sili: ha poche pagine sui laghetti che sorgono sulle sommità delle A lp i2, ha una diecina di pagine su « avvenimenti » circa i laghi3, e poi ha carte del lago di Como 4, del lago Maggiore, dei laghi sulla sommità del S. Gottardo, di parecchi laghi della Svizzera (quelli di Lucerna, di Joux, di Costanza), dei laghi del bacino danubiano ecc.
Un’altra attività, sempre nel campo della geografia, che ha il Marsili coltivata con speciale amore e con abilità non comune, è quella delle rappresentazioni cartografiche, per cui infinite ter
1 Due carte del Reno sono nel Ms. 46 al n. 8 (Mappa del tratto del Reno dal lago di Costanza a 'Coblenz) e 20 (Mappa dell'origine del Reno e fiumi adiacenti nelli Grisoni). Una tavola ad acquarello delineata da J. J. Scheuchzer, dove sono le prime fonti del Reno, del Rodano, della Reuss e del Ticino, si trova nel Ms. 90. O.
A ltra tavola acquarellata, e dovuta allo stesso, del primo corso del Reno posteriore e della Mosa si trova più oltre nello stesso Ms.
A ltre due mappe — stampate — sono nel Ms. A M. C. I, 5, 11 e 21.Inoltre troviamo segni della sua intenzione dì studiarlo anche in
lettere.2 Si vyeda il Ms. 90, C, pp. 41-2.
3 Ms. 87, C, pp. 71-81.
* Ms. 53 C, 75 e 78.
M. LONGHENA - L. P. MARSILI GEOGRAFO 191
re, tutte quelle per cui è passato ed iu cui s’è fermato, ci sono state conservate con le loro immagini nei volumi manoscritti della Biblioteca Universitaria,
E queste due sono le principali caratteristiche della figura del Marsili come geografo, sì che esaminando ciò che ha scritto di idrografìa e passando in rassegna le sue carte, si dà un quadro completo della sua operosità. Però non bisogna passar sotto silenzio l’opera sua di viaggiatore, la quale essendo sempre stata seguita da relazioni di tali viaggi, è implicitamente compresa nell'attività sua di studioso dell’idrografia, ed il tentativo di dare della struttura della terra una spiegazione, il tentativo di ricavare da ciò che si vede della terra quello che non si vede.
Quindi si potrebbe ridurre a quattro paragrafi ciò che il Marsili ha fatto per la geografia — i viaggi, gli studi di idrografia, i suoi sforzi per conoscere l’intima struttura del globo e l’opera sua cartografica — paragrafi di differente lunghezza e di importanza diversa, ai quali sarà come conclusione una breve visione della bontà del metodo seguito con costante cura in tutte le trattazioni.
I viaggi.I primi viaggi, non determinati da alcuna ragione se non dal
desiderio di vedere cose nuove, rientrano nella categoria dei veri viaggi, chè quelli di poi, mossi dal bisogno o dovuti ai compiti che a lui imponeva la milizia, se anche accompagnati da osservazioni o seguiti da relazioni, non possono più considerarsi come tali e debbono collocarsi fra le attività dello studioso, che si muove per studiare un fenomeno, e non viaggia per osservare e notare la varietà dei fenomeni.
Poco più che diciottenne va a visitare le cose più interessanti, dal punto di vista della storia naturale, che sono intorno a Napoli: le zolfatare di Pozzuoli, il lago d’Agnano, la grotta del Cane furono da lui visitate, e poi salì sul Vesuvio fino alla cima, ne visitò il cratere con tanta attenzione che ne potè fare il modello. Ma quello che per noi ha maggiore importanza, in queste diverse gite fatte intorno a Napoli, è che egli ne fece una
192 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
relazione che presentò al suo maestro Geminiano Montanari. Sfortunatamente, mentre delle lettere dirette al Marsili quasi nessuna ci manca, chè è stato un conservatore preciso di tutto cò che lo riguardava, di quelle da lui mandate ad altri solo di tratto in tratto si ha copia.
Nelle sue memorie, che ci restano, egli fa cenno di questo suo viaggio e dice che fece osservazioni sulle «proprietà » della Grotta del Cane, e che raccolse minerali di zolfo, esaminati poi con cura nel suo albergo. NulPaltro sappiamo del suo soggiorno a Napoli o nei dintorni, ma negli scritti posteriori — posteriori di oltre 30 anni — ci sono parole le quali ci autorizzano a supporre che da questa prima gita di curiosità scientifica sia nato il desiderio, che avrà poi manifestazoni parecchie, di indagare quale sia il comportamento degli strati solfiferi in Italia. Di qui hanno origine ed i suoi esami delle miniere di zolfo delle Romagne,1 e le osservazioni fatte nella sua relazione della gita al Cimone: di qui forse deriva la sua scoperta sulFandamento di tali strati e sulla zona gessoso-solfifera dell’Emilia, della Romagna e delle Marche.
LT Italia — è questo il succo del suo ragionamento — ha dello zolfo in più d’un luogo, dalle Romagne alla Sicilia: è casuale e senz’ordine questa distribuzione di minerale, oppure no? Ammesso che abbia un ritmo lo zolfo nella sua larga dispersione per l’ Italia, quale esso è? E siccome lo zolfo e il gesso si trovano vicini, che rapporto c’ è fra l’uno e l’altro?
Nelle poche pagine che più tardi (1715) scrisse sulla gita al Cimone, 2 il Marsili tenta di fissare come lo zolfo si comporta co’ suoi strati nel versante tirrenico e nel versante adriatico, collega le miniere della valle del Savio e quelle di lontane parti d’ Italia, e, sebbene con un linguaggio ancora vago, chè l’esplo-
1 Tutto il AIs. 88, lettera E, è pieno di opuscoli riguardanti il gesso
e lo zolfo da Meldola a Sarsina.Si vedano le carte della lettera D dello stesso manoscritto, che
contengono la narrazione della gita al Cimone.2 M. L o n g h e n a - L. F. M arsili sull'Appennino modenese e sul Cimone.
« Archiginnasio » , 1929, fase. 1-3.
H . LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 193
razione geologica è ancora così scarsa da non permettere alcuna conclusione, cerca di stringere con uno sguardo e con alcune linee tutto il nostro paese. Tentativi, siamo d’accordo, e nul- l’altro che tentativi, ma così audaci che non possiamo 11011 segnalarli, a distanza di due secoli, all’ammirazione dei posteri.
Il secondo viaggio — tralasciamo i minori a Firenze ed a Livorno, dove pure qualcosa osserva, a Livorno, ad esempio, il movimento del commercio e della navigazione — è assai più lungo. Da Venezia a Costantinopoli accompagna il bailo Pietro Civrani, e torna a Venezia, seguendo un itinerario tutto terrestre.1 Questo è un viaggio, assai più importante che il precedente: c’ è, fra i due punti estremi, il mare di mezzo, e sul mare non poche città e non poche isole, che egli tocca o vede; poi c’è una grande città, capitale d’un grande stato, che dà frequenti ragioni di noie al mondo cristiano, e la città è su uno stretto di grande importanza. Quindi viaggio quasi fatto per suscitare osservazioni e per spingere il viaggiatore a indagini nuove. E per di più sulle rive del Bosforo vive un popolo che potrà essere temuto, odiato, trascurato, ma non può non destare curiosità in chi lo avvicina, il popolo turco, che tutti credono di conoscere e che ben pochi realmente conoscono. Ed ecco di qui nascere due motivi di attività scientifica: da una parte il Bosforo con le sue correnti, con i suoi problemi, primo atto di un dramma, in cui l’indagatore lotta con disperato accanimento per strappare i più fitti veli, e dall’altra il popolo turco, del quale cerca di indovinare l’anima, esaminandone i caratteri, le consuetudini, i costumi, gli usi di pace e di guerra. Ma come spesso accade, lungo la strada si mutano un po’ le circostanze, per cui il primitivo disegno non si conserva intatto, e il Bosforo si allarga fino a diventare tutti i mari del Mediterraneo ed anche ad estendersi fuori di esso, ed il popolo turco, come
1 L u d o v ic o F r a t i - I l viaggio da Venezia a Costantinopoli di L. F. UarsUi. Nuovo Archivio Veneto, N. S. V i l i , pp. 295-3X6 (Venezia, 1904).
Si veda il Ms. 51, pp. 15-38 per il viaggio d’anclata, ed il Ma. 52, pp. 300-358 che contiene il diario per il viaggio di ritorno.
14
194 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
quello ohe sopra tutto per le armi supera gli altri popoli, serve come (li argomento per trattarne lo stato militare. Forse sulle prime accarezzava l’idea di una monografìa di natura antropica : ed invece ne uscì un grosso volume, dove si parla di molti caratteri del Turco, ma dove sopra tutto se ne esaminano l’organizzazione militare e dove anche si cerca di penetrare l’intima costituzione di questo grandioso stato.
Dunque, anche qui, un viaggio per mare ad una città marittima fa sorgere in lui il desiderio di occuparsi del mare e crea quella consuetudine di studi che sarà la principale della sua vita, quella consuetudine che lo porrà fra i maggiori cultori della oceanografìa; e l’aver avvicinato un popolo politicamente potente gli è di incitamento a vedere come è questo popolo, che cosa ha fatto e che cosa fa, quali sono i caratteri che lo distinguono dagli altri e le ragioni che lo hanno reso tanto temibile.
S’è detto che il viaggio di ritorno il Marsili lo fa per terra e che attraversa la penisola balcanica dal Bosforo all’Adriatico. Ora in questa sua determinazione — ha appena 22 anni — c’è il bisogno di conoscere anche all’interno questo stato dei Turchi, di cui aveva visto la capitale, e di conoscere la terra che teneva soggetta. Non lo spaventa la asprezza dei luoghi nè lo distolgono i pericoli che un tale viaggio porta con sè, chè non ordinato è il vivere dei popoli soggetti ai Turchi. Adrianopoli, Sofìa, Belgrado — non accenniamo che ai luoghi principali — sono le città più notevoli che vede; ma il suo diario è assai minuto e ci dice di infiniti altri luoghi, chè la via seguita è quella che ancora si segue e die quasi percorre la ferrovia. Poi risale la Sava, il tranquillo affluente del Danubio e tagliando altri fiumi, tributari di questo, e superando monti giunge a Zara. Qui quasi ha fine la sua fatica, chè dopo costeggia l’Adriatico, sempre per terre obbedienti a Venezia.
Se nel viaggio di andata bisogna cercar le origini del suo amore per il mare, al viaggio di ritorno dobbiamo far risalire la sua passione potamologia e sopra tutto la sua passione per il gran fiume. Appena lo vede, e non lo vede maestosamente come lo vedrà poi svolgersi attraverso la gran pianura ungherese, ne è come rapito : ne intuisce la grande importanza e vede
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 195
tutta la bellezza di una descrizione che nulla dimenticasse e di ima rappresentazione che desse la sua bella immagine vera. Ecco quindi la prima radice di uno studio che condurrà poi con metodo e con fortuna.
Se dai diari di questi due viaggi per Costantinopoli e da Costantinopoli non è lecito trarre altro che visioni, quasi cinematografiche, di luoghi, in essi si devono porre le fondamenta di cospicue opere posteriori, quali le osservazioni intorno al Bosforo Tracio, la histaire physique de la mer con tutte le minori pubblicazioni che la completano, 1’ opus Danubiale, che è il lavoro maggiore per mole e più definitivo.
Tornato in patria, il Marsili che non può adattarsi alla vita queta e monotona, pensa a farsi soldato dell’imperatore, e poiché senza difficoltà l’ottiene, eccolo subito in movimento, per le terre dell’ impero d’Austria. Per primo è il fiume Eaab che ha le attente esplorazioni del Marsili: deve fortificarlo, chè fino ad esso giungono i confini fra Turchi ed impero, e perciò è necessario che lo risalga e lo conosca in tutta la sua vallata.1 Poi vengono le tristi giornate della sua prigionia e le dolorose ferite, le quali se dànno tormenti al corpo e umiliazioni all’animo, non però gli tolgono la forza di vedere e di osservare e di notare nella memoria tenace. In tale stato vede Buda-Pest e poi percorre le terre fino alla Bosnia. Nulla a lui sfugge, e noi troviamo cenni nelle sue memorie, nelle varie narrazioni della sua prigionia, ma sopra tutto tracce di questo periodo sono nell’Opus Danubiale, dove tutto ciò che il Marsili aveva via via visto, è come distribuito in un quadro immenso ed in esso ben disposto.
Chi potrebbe seguire il Marsili, liberato dalla prigionia e risanato dalle ferite, attraverso le terre dell’ impero ? di segnare tutto ciò che vede per la prima volta o rivede per meglio conoscerlo? Si può delimitare con i Carpazi, il Reno ed il Danubio
1 Si vedano le carte 109-129 del Ms. 53 « Mia spedizione per la difesa del fiume Rab (1683) » e le ipp. 145-204 dello stesso Ms. « Progetto originale per fortificare il fiume Bab ». Si veda anche la mappa n. 21 del Ms. 50 « Mappae cisdanubiales ».
196 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
la regione da lui percorsa a varie riprese e ripercorsa durante i quasi 20 anni in cui militò sotto le bandiere di Leopoldo I. Ora scopi militari, ora ragioni di pace, ora desiderio di sorprendere un fenomeno o fissarlo ne’ suoi caratteri conducono il Marsili un po’ da per tutto entro questo vasto trapezio.
Tornato in patria, dopo Brisacco, eccolo, per motivi suoi personali, nella Svizzera, dove era già stato altra volta, ma più di sfuggita. E forse da questo suo ritorno nella repubblica Elvetica hanno origine non poche cose che troviamo ancora manoscritte e la sterminata serie di appunti e di note su questoo quel fenomeno disseminata nei volumi da lui stesso con cura raccolti. Si sa che il Marsili, quasi mosso da un senso di riconoscenza verso la casa che lo teneva in alta considerazione, quando era ancora soldato, pensò di tracciarne la storia, dagli inizi sino al suo protettore1 e raccolse notizie, genealogie ed itinerari, cliè intendeva mostrare l ’espansione territoriale della dinastia asburgica.
Ma anche il popolo svizzero ed i suoi cantoni ed i suoi governi avevano determinato un po’ di simpatia nell’animo suo, sì che tutto un manoscritto - è ripieno di cose che riguardano la Svizzera: forse in lui era l’intenzione di comporre in bell’ordine tutto il materiale e di cavarne un lavoro come aveva fatto dei Turchi.
Senza tener conto dei minora itinera fatti nell’ Emilia o in altre parti d’ Italia — ad esempio nelle Marche costiere — dobbiamo notare la sua lunga permanenza a Cassis, un villaggio di pescatori nella Provenza, ed i suoi frequenti ritorni su questa solitaria spiaggia tutte le volte che qualche molestia lo turbava. Qui le sue ricerche sul mare ebbero finalmente compimento, qui ebbe gli ultimi ritocchi la sua storia fisica del mare. Altro
1 Si vedano i Mss. 26 « Notizie spettanti alla casa dei Conti d’Hab- sbourg etc. » e 90 C. i>p. 118-20 e 122. Inoltre si veda la carta 2 della Raccolta n. 39.
2 Ms. 96 C. Sono 35 fra schedae Mstoricae e mappe tutte relative a lla Svizzera.
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 197
luogo che da lui fu scelto come sua sede per qualche tempo e che gli piacque e da cui mosse per gite di esplorazione scientifica fu il lago di Garda : a Maderno si fermò parecchio, esplorò in tutti i sensi il lago e le terre alte che ad est lo chiudono (m. Baldo), misurò altezze, col barometro, e profondità con strumenti di sua fabbricazione, si spinse di qui anche assai oltre, fino alla Laguna Veneta e fino ai monti del vicentino ed anche del principato di Trento. La monografia sul Garda, una delle opere più armoniche e più complete che siano uscite dalla sua penna e che forse doveva attendere soltanto, per apparire onestamente fra la gente, la lima di qualcuno dei tanti correttori delle sue cose, fu composta durante la permanenza del Marsili a Maderno, nel 1725.
Ultimo viaggio di qualche lunghezza e durata si deve considerare quello da Livorno alle foci del Tamigi e di qui alle coste Olandesi, viaggio intrapreso quando il Marsili andava verso i 65 anni. Frutto di questa lunga navigazione che gli permette di fare osservazioni sulle correnti dello stretto di Gibilterra, che gli permette di studiare le dune olandesi, sono e la famosa lettera allo scienziato olandese Ermanno Boerhaave 1 e le molte osservazioni sopra le dighe contenute nel ms. 99 A. e raccolte in 7 quadernetti.
Ma quante altre parti d’ Italia e d’ Europa il Marsili ha visitate ! Ce ne accorgiamo scorrendo i lunghi volumi manoscritti,lo avvertiamo leggendo nelle sue opere pubblicate i frequenti accostamenti fra un fenomeno e l’altro. Schizzi numerosi, appunti brevi, osservazioni buttate là, alla buona, richiami numerosi ci reonducono nelle parti più remote, negli angoli meno noti d’ Europa, ed in essi fu realmente il Marsili e ciò che dice indubbiamente osservò, chè in lui è meticolosa scrupolosità di scienziato e rara coscienza di studioso.
1 Si veda il contenuto, da me pubblicato, di questa lettera nell’An- nuario del R. Istituto Scientifico A. Righi, Bologna, 1929-1930.
198 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
I suoi studi di idrografia.a) II mare.
I risultati degli studi del Marsili sul mare sono raccolti nel- Vhistovre physique de la mer e nella lettera al Boerhaave citata più sopra : l’histoire fu pubblicata nel 1725 ad Amsterdam, l’altra è stata scritta nello stesso anno ed è rimasta inedita fino al sunto ed al commento che io ne ho dato. Tutto ciò che è stato pubblicato prima, le osservazioni sul Bosforo Tracio (1681), le due lettere all’abbate Bignon, inserite nel Journal des S^avants, tradotte in italiano e stampale nel Brieve ristretto del saggio fisico intorno alla storia del mare (1711), è fuso nell’opera maggiore.
La prefazione, che è del Boerhaave, è la presentazione dell’autore e del suo lavoro, e le lodi sono così larghe e vengono da uno scienziato così serio che chi legge non può non ritenere l’opera degna. Ed al Boerhaave deve aver fatto questa favorevole impressione il lavoro marsiliano, così ampio di materiale, ben ordinato e ben elaborato, con distribuzione così saggia delle parti. Prima il bacino del mare, poi l’acqua in esso raccolta, indi i movimenti di queste acque e da ultimo i viventi — vegetali ed animali — dentro il mare: tale la distribuzione della materia, distribuzione che oggi non si saprebbe, neppur volendo, mutare. E chi ben consideri tale materia e pensi come si possa distribuire, non trova che ci sia altra via di quella seguita dal Marsili: oceanografìa statica, oceanografìa dinamica e biogeografìa del mare.
Naturalmente le sue tabelle delle analisi dell’acqua oggi hanno valore puramente storico, la chimica non era ancor nata, e gli esercizi da lui fatti di analisi erano esercizi che non potevano dare al lettore se non la sensazione dello sforzo e della diligenza del Marsili.
Ancora non possiamo annettere soverchia importanza alle misurazioni da lui fatte della profondità dell'acqua del mare e della temperatura alle varie profondità, perchè gli strumenti da lui adoperati erano primitivi e gli accorgimenti da lui trovati per rimediare al loro difetto, se accorciavano il male, non
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 199
lo eliminavano affatto. Quindi tutto ciò bisogna accoglierlo con molta indulgenza e con largo spirito di tolleranza: è necessario dare al tempo i suoi diritti e pensare che il Marsili cominciò a lavorare intorno al mare, nello stretto di Costantinopoli, proprio 250 anni fa. Ora si pensi a quel che l’ingegno umano aveva fatto in quel tempo e lo si confronti all’opera mar- siliana, e si vedrà l'enorme differenza, che giustitìca gli entusiasmi del Boerhaave.
Prima di tutto il Marsili non parte da alcun apriorismo, non ha idee preconcette, non ha una scienza già formata nella mente a cui cerchi di adattare ciò che via via va osservando : il suo sapere nasce dall’osservazione, e l’osservazione sua non è rapida, incauta, frettolosa, ma è ripetuta a distanza di tempo e di luogo, in circostanze che mutano. Poi le osservazioni ripetute e liberate da ciò che è contorno inutile sono raccolte insieme, sono confrontate, sono sottoposte ad un rigoroso vaglio; e solo quando da esse balzi fuori nitida la causa o la legge che su di esse vigila, solo allora il Marsili si dispone ad affermare: quando la sicurezza non lo assiste, nobilmente dichiara di non potere affermare o confessa di non sapere. È nobile questa sua consuetudine mentale e morale, e degna che ancor oggi la si proponga a chi così leggermente afferma e rapidamente conclude.
Il Marsili non pensa che fra le terre emerse e le sommerse ci sia come un solco divisore, ma è persuaso che le une e le altre siano collegate insieme: le coste hanno nel fondo del mare prolungati i loro caratteri e gli strati che mostrano le coste si ritrovano continuati sotto le acque; quindi dalle rive è lecito argomentare la natura del fondo. Le conclusioni che trae da questo esame delle coste, dopo numerose osservazioni, sono parecchie, e queste conclusioni oggi la scienza quasi tali e quali accoglie. Così il Marsili conclude che non è vero che certi mari siano senza fondo, così afferma che le profondità del mare uguagliano l’altezza delle montagne, e che alle rive più alte rispondono le profondità delle acque, a rive basse acque poco profonde.
Forse qualcosa oggi è da mutare, che non è questa la forma
200 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
pili propria e non può avere il pensiero la rigidezza datagli dal Marsili; ma si rifletta per un momento che davanti a sè il Mar- sili non aveva che il trattato di Bovle « de fundo maris », la cui principale affermazione era che il fondo del mare presentava delle ineguaglianze. E più oltre parlando delle varie parti della costa dice che ce n’è una parte emersa e<ì un’altra sommersa, e che questa si può conoscere esaminando quella. Egli quindi fa delle due parti della terra un tutto e concepisce integralmente la terra e non accoglie nessuna teorica che ammetta linee dividitrici. Ma numerose altre osservazioni accumula che lo conducono a conclusioni interessanti: qui le tralasciamo, perchè oltrepasseremmo i limiti di questa rapida rassegna.
Il Marsili, credo, è il primo a proporre e ad attuare misurazioni a varie profondità della temperatura delle acque marine, e nelle diverse stagioni; ed è il primo indubbiamente a concludere che senza alterazioni notevoli sia la temperatura del mare profondo e che perciò si debba considerare costante.
La seconda parte è tutta dedicata a stabilire i caratteri dell’acqua del mare, colore e gusto, a fissare il grado di salinità, maggiore al fondo e minore superficialmente, a dividerla in profonda ed alla superficie. A questa seconda parte segue il fitto elenco di cifre dimostranti il modo di comportarsi dell’acqua del mare rispetto ai corpi che il Marsili fa agire su di essa, ma di questo non ci occuperemo per le ragioni dette sopra.
I movimenti del mare sono esaminati nella terza parte, e sono esaminati con rapidità, in quanto che di essi ha tale esperienza da poter concludere senza soste. Le onde, le correnti e le maree — la stessa divisione dell’oceanografia moderna — le ha esaminate sul Bosforo, a Cassia e sull’Adriatico, quindi di «sse s’è impadronito in modo perfetto. Continue ed interrotte, superficiali e profonde: ecco come si possono supporre le correnti; ma infelice è negli esempi, perchè dà come correnti superficiali e continue le masse d’acqua, portate dai fiumi. Ma subito dopo si corregge e torna a parlare delle correnti, dando ad esse il significato che attribuiamo noi, e parla della corrente che dallo stretto di Gibilterra va verso l’Egitto e ritorna allo stretto di Gibilterra, parla delle correnti del Bosforo Tracio, da
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 201
Ini già osservate nel 1679 e nel 1691, e da ultimo dice delle correnti notate a Cassis, che par che non obbediscano alla legge generale, poiché vanno ora da est ad ovest ora da ovest ad est. Davanti all’ostacolo il Marsili non sa trovare una spiegazione sufficiente e piuttosto che arzigogolare ragioni, preferisce confessare di non sapere e di rinunciare a spiegare. Vero è che non alla sua insufficienza questo si deve imputare, ma alle condizioni di tenuissima conoscenza di queste correnti: i naviganti ne avevano segnalato alcune, egli altre ne nota, ma tutto questo è troppo poco di fronte all’immensità del mare, sì che a conclusioni sicure è diffìcile arrivare. Onde opportuno è quel che il Marsili stesso propone: tutti gli stati armino navi di istru- menti opportuni per osservare il mare: solo così sarà lecito, accumulando gli sforzi singoli, arrivare ad una sufficiente raccolta di materiale adatto.
Come si vede, egli fin da allora prevede le campagne talassografiche che l’ottocento appresterà per sommare in un tutto le scoperte particolari.
Certamente al Marsili non balza subito agli occhi la ragione delle correnti: egli la ignora e domanda se ai venti si debba assegnare, ma conclude negativamente, perchè pure in periodo di perfetta calma le correnti hanno compimento nè modificano il loro modo di comportarsi.
Sulle onde non ha dubbio di sorta: il vento le solleva, e quindi tale movimento è accidentale. Distingue poi nell’onda due condizioni, una naturale e l’altra determinata dall’ambiente, cioè quella è in rapporto diretto alla causa, cioè al vento che la provoca, questa è dipendente dal luogo dove avviene — coste rocciose, scogli a fior d’acqua ecc. —.
Il Marsili ha voluto anche fissare l’altezza dell’onda e dice che le misure da lui prese non oltrepassano i sette piedi, cifra che se può essere esatta per il mar di Provenza non ha alcun valore come punto estremo, chè assai maggiore è la cifra raggiunta in altri mari.
Pure delle maree s’è occupato il Marsili ed ha tentato di misurarle con un istrumento da lui fabbricato, ma non è facile tale misurazione — egli dice — chè al movimento del flusso e
202 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
riflusso si accompagna quello delle onde e s’uniscono ad aumentare il turbamento anche le correnti. Quel che ha potuto per altro constatare si è che sul lido di Cassis tenue è la marea e quasi inavvertibile.
L ’ultima parte — la biografia del mare — è la più larga ed in essa si sono meglio che nelle altre esercitate le capacità di analisi del Marsili. Egli è il primo a svelare la vasta ricchezza fitogeografica del mare: prima di lui l’uomo non aveva cacciato l’occhio indagatore nelle profondità delle acque marine, sì che s’ignorava questa flora e parecchi errori gravavano su di essa. Spiega perchè questa ha esemplari che mancano di radici e conclude che le acque non costituiscono un ambiente meno favorevole dell'ambiente terrestre per la propagazione dei vegetali: parla dei fiori, che trova somiglianti ai fiori delle piante terrestri, e scopre i loro semi nei frutti, sottoponendoli all’analisi microscopica ed alle esperienze della chimica.
Ma il paragrafo di maggiore importanza di tutta quest’ul- tima parte riguarda il corallo. Si sa che prima di lui il corallo era considerato come appartenente al regno minerale; col Marsili esso si muove dalla fissità sua e diventa essere vivente : non si giunge ancora a porlo nel mondo animale, ma un passo, un notevole passo l’ha fatto. Senza dubbio col Marsili si accresce il numero delle favole riflettenti il corallo e si varia, se non si aumenta, il cumulo degli errori; senza dubbio, rispetto alle spugne, non diminuiscono per opera sua le false credenze; ma quanta differenza fra il prima di lui e quello che egli ci ha lasciato! Nessuno può contestare al Marsili il merito di avere in quest’ultima parte della sua storia del mare — vera visione del mondo vegetale marino — in capitoli che non esitiamo a chiamare superbi per vastità di fenomeni descritti e per profonde intuizioni, raccolto tutto ciò che dopo osservazioni ed esperienze poteva dire. Basta a quei fiori bianchi che escono dalle piccole cavità dei rami cambiar nome, e si avrà una descrizione moderna del nostro corallo rosso e dei banchi e degli scogli corallini.
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 203
b) 1 fiumi.
S’ è detto pili sopra che la sua passione per i fiumi come individui geografici comincia il giorno in cui per ragioni militari deve risalire la Raab per conoscerla ed opportunamente fortificarla. Ma la Raab è fiume troppo modesto e la sua illustrazione, come la intende il Marsili e come poi l’attuerà per il Danubio, non potrebbe avere gli sviluppi che egli pensa : non è fiume direttamente sfociante al mare, non ha abbondanza notevole di acqua nè grandioso sviluppo di corso, e poi scende per terre linguisticamente uniformi e di non grande ricchezza mineraria. Invece il Danubio ha tutti i caratteri voluti ed è il solo fiume d’ Europa che percorra terre sì diverse, ampio e navigabile, via di commercio fra le prime, superbo della sua storia passata e della sua importanza presente.
La conoscenza del gran fiume procede rapida, perchè i suoi doveri di ufficiale gli impongono di essere ora qua ora là, lo obbligano a conoscere meglio degli altri i luoghi dov’è il nemico, dove bisogna costrurre un ponte o tracciare una strada. E l’argomento man mano si avanza, si allarga, si approfondisce e si fa più attraente: nel 1700 il lavoro era completo; e il prò drornus pubblicato allora dice come era diviso il soggetto trat tato, quante erano le parti ecc. Poi passano 26 anni ed in questo frattempo il frutto si matura. Il Marsili fa delle modificazioni e stampa un nuovo prodromus, più rispondente alla realtà dell’opera che si pubblicherà. Sei volumi in folio, carte geografiche e storiche, tabelle, illustrazioni : ecco da che cosa è composta l’opera. Il Danubio ben si prestava come soggetto ad una illustrazione sì fatta, la quale nulla trascura: ampio e solenne passante per varietà di paesi, con begli affluenti e chiuso entro terre che sono fra le più ricche di fenomeni. In quest’argomento al Marsili non era possibile far scoperte, come aveva fatto per il mare, non era consentito mettere avanti conclusioni nuove.Il gran fiume era conosciuto ab antiquo ed era assai navigato. Perciò tutti i meriti riguardano il metodo, seguito nella trattazione, ed il metodo è dei più saggi e dei più rigidi. Il Marsili, che limita il suo lavoro a parte del corso del Danubio, poiché
204 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
nè il suo corso germanico, nè il Danubio rumeno sono considerati se non nelle carte e di sfuggita, dice come ha potuto studiarlo e mostra quale parte ha avuto maggior numero di osservazioni, chè non ugualmente allora era libero, ed alcune parti soggette al turco non era facile esplorare, misurarle e quindi darne fedelmente l’ immagine.
« Inaequalis fuit fortunae condicio qua labor meus processit in hoc opere colligendo » ; così egli dice, e con queste parole egli indica le difficoltà incontrate, per causa dei Turchi, nel- l’esplorare l’ultima parte del Danubio. Perciò c’ è differenza e nelle carte e nel testo, rispetto allo svolgimento, fra le diverse parti: meno nomi e meno segni nelle carte, più rapide notizie nel testo.
Venti carte sono dedicate alla illustrazione di questo rilevante tratto del Danubio — due carte generali e 18 sectiones, e sono mappe fatte molto bene; anche oggi, a parte la maggior esattezza della rappresentazione, esse costituirebbero un non piccolo orgoglio e per il cartografo e per il tipografo. Il disegno è preciso, sicuro, curato, la rappresentazione fine, artistica. Le carte sezionali sono così ricche di particolari che non è necessaria una descrizione per comprendere le tortuosità ed i meandri del fiume: le isole o i tratti di terra rinchiusi fra due rami sono a scala sufficiente per modo che chi esamina la carta non deve fare alcuno sforzo di immaginazione per rappresentarsi il corso del fiume. Non solo i maggiori affluenti, ma anche i minori, non solo le città più popolose, ma anche le più modeste e le fortezze e la varia vegetazione e la varietà della sua frequenza sono rappresentate in queste carte che parlano un linguaggio di grande semplicità e di estrema chiarezza.
Il Marsili forse pensando che in qualcuno potesse nascere il sospetto che le tortuosità fossero disegnate « calamo sine lege errante » o « adscititii ornamenti causa » avverte che le varie « flexuras fluminis » le ha determinate tutte per mezzo della bussola, e che anche le cateratte, i vortici, il restringersi e l’allargarsi delle rive non sono segnate ad occhio e croce, ma dopo misurazioni e dopo aver fissato la loro direzione rispetto ai punti cardinali.
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 205
Alle carte segue il testo esplicativo di esse. Il lettore ha bisogno di conoscere un po’ la terra per la quale scorre il Danubio, e perciò sono dal Marsili fissati i confini ed esposte le principali caratteristiche di quella regioue. La storia qui si mescola alla geografia ed è necessaro: l’una dà lume all’altra. Naturalmente qui, accanto a cose esatte c’è qualche avanzo dei tempi e qualche offerta alle credenze d’allora : l’ etimologia del nome Danubio è quella corrente, e non so se oggi un glottologo la degnerebbe della sua attenzione. Ma le divisioni amministrative — allora assai più estese di oggi — i commenti storici e geografici intorno ai luoghi più notevoli segnati nelle mappe, ed i cenni, più brevi e rapidi, circa i «loca minus insignia », le notizie intorno agli abitanti che vivono in luoghi percorsi dal Danubio o dai suoi affluenti, e le isole più grandi in mezzo al fiume, sono ancor oggi di grande importanza e possono essere accolte quasi per intero, senza nulla modificare.
Nel primo volume, dopo le cose dette ora, c’ è un capitolo dedicato all’astronomia, o meglio alle determinazioni della latitudine di alcuni luoghi secondo le stelle: otto sono i luoghi di cui dà la distanza dal polo, e di due le determinazioni sono del tutto nuove.
Ed anche la declinazione magnetica di alcuni luoghi cerca di fissare il Marsili, il che non è di piccola importanza per stabilire la oscillazione del fenomeno attraverso il tempo.
Pure nel 1° volume è la parte che si può dire nuova, la pa/rn liydrographica. In essa, che abbraccia quasi 50 pagine a due colonne, il Marsili getta le basi — lo si può altamente proclamare — d’una scienza nuova, uscita fuor dal grembo prolifico della geografia, la potamologia, e dà l’esempio di una monografia potamologica che fa pendant alla sua histoire physique de la mer ed al lavoro sul lago di Garda. E poiché anche qualcosa osserva sui ghiacciai ed a lungo parla delle acque sotterranee, si può dire che tutte le parti dell’idrografia furono trat> tate da lui, e di alcune si deve considerare come il fondatore. Certo la potamologia ha avuto da lui basi sicure e trattazione rigorosa, e la scelta di un fiume, che quasi degli altri è re, pone la monografia marsiliana in una luce più bella.
206 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Colla mappa potamologica che precede, nella quale il Danubio è rappresentato dal Kahlenberg al mare, con tutti i suoi affluenti e subaffluenti, con i monti che lo dividono e lo determinano e con la cerchia dei monti che cingono tutto l’ampio bacino, il Marsili ha voluto ben fissare le idee di bacino principale e di bacino secondario, ha individuato l’idea di valle principale e di valle secondaria, ha determinato il concetto di alveo e posto con precisione tutte le questioni riguardanti un fiume.
I paragrafi che via via si succedono svolgono i vari argomenti che suggerisce la mappa potamologica: così dell’alveo il Marsili esamina la struttura e mostra qual’essa è per mezzo di molti profili, poi risolve il quesito di quali terreni sia fatto l’alveo ed accompagna la sua dimostrazione con non pochi profili e sezioni. La varietà delle rive — paludose e di pietra —, la loro variabile distanza — pur essa mostrata con parecchie sezioni trasversali, sezioni che troviamo anche per gli affluenti maggiori — le varie profondità del fiume, conosciute durante la costruzione di ponti, le numerose paludi — c’è un paragrafo di discreta lunghezza « de paludibus danubialibus » — e le comunicazioni sotterranee fra le acque delle paludi del fiume principale e quelle degli stagni che si stendono presso le rive del Tibisco, le magre e le piene del Danubio, la composizione delle acque sue e de’ suoi tributari costituiscono tanti paragrafi che sono trattati con maestria e con profondità.
Si può dire che la parte strettamente geografica termini col primo volume: dopo questa visione completa non c’è quasi pili nulla che venga aggiunto nei volumi che seguono. Ma se geograficamente si può far punto, non completo è il quadro: manca la parte archeologica, manca la parte che separatamente esamini i tre regni della natura, minerali, piante ed animali. E tutto questo il Marsili fa passare davanti agli occhi del lettore negli altri cinque grossi tomi che compongono l’opera. Dei quali il secondo è tutto un disseppellimento di monumenti e di ricordi del passato.
Poiché fino al Danubio s’era spinto il dominio romano, così fino ad esso era possibile trovare i segni suoi, e non era lecito
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO *207
che solo a quello che era visibile si limitassero le tracce del suo passaggio e delle sue soste.
Perciò il Marsili e passa in rassegna quello che era noto e disseppellisce quel che la terra vuole rapire agli uomini, ricoprendolo e facendolo invisibile.
Non ci fermeremo al lungo elenco ed alla minuziosa descrizione, solo aggiungeremo che in fondo al capitolo, che occupa con le illustrazioni il 2° volume, c’è un saggio che esce dall’archeologia, o meglio riguarda l'archeologia degli animali, tratta cioè di paleontologia, forse uno dei primi saggi su questo argomento e degno di essere studiato da chi di tale disciplina non è debole e scarso cultore.
Tutto il 3° tomo è un trattato di mineralogia regionale: il suolo, attraverso il quale il Danubio ed i suoi affluenti scorrono, è studiato nella sua composizione mineralogica, e tutti i suoi componenti sono, ad uno ad uno, esaminati, sezionati ed analizzati.
Naturalmente oggi non si può più accogliere la classificazione che egli ci dà dei minerali: è una suddivisione che sa troppo di esame superficiale: i caratteri organolettici sono i soli che determinino tale classifica. Ad ogni modo quanta varietà di corpi vediamo passarci davanti con i nomi che hanno da noi, nell’impero e nel mondo della scienza, con l’uso che se ne fa e con l’indicazione del modo con cui appaiono. Ma se la mineralogia non ha ragione di essere orgogliosa del capitolo marsiliano sui minerali, un’altra disciplina, nata assai più tardi, ma da lui battezzata come meritevole di star da sè, la stratigrafia, deve a lui riconoscenza, poiché egli, accennando agli strati, mostra di non credere che essi capricciosamente siano così, in questa o in quella postura, ed abbiano avuto questo o quel movimento, ma a ciascuna posizione debba rispondere una particolare causa. Saremmo troppo esigenti se ci aspettassimo da lui la ricerca di queste cause: egli solo formula il suo pensiero, che intuisce una verità; le condizioni del sapere del suo tempo — e specialmente della geologia e della strati- grafia non ancora nate — gli impedivano di andar oltre.
Di questo volume fa parte una carta che a me pare vera
2 0 8 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
mente nuova, una carta mineralogica — o mineralographica, come la chiama il Marsili —, dove appaiono le indicazioni di tutte le miniere. Evidentemente il Marsili ha superato la fase della cartografia che suppone le carte rappresentazione di pochi fenomeni fisici e di non moltissimi fenomeni umani: egli piega le carte a rappresentare qualsiasi fenomeno che sia distribuito sulla superficie terrestre o nel suolo poco lontano dalla superficie.
Chiude il volume terzo una teoria « de generatione metallo- rum» che sa troppo di alchimia perchè qui la si voglia riassumere. Ma tale teoria ci dà ragione di osservare cosa che può parere strana e che invece è assai naturale. Accanto a geniali osservazioni e ad acute indagini, accanto a trovate che non possono non sorprendere, il Marsili rimane attaccato, per certi rispetti, al passato in guisa da ripeterci le più ridicole teorie. La ragione la si cerchi in questo: finché obbedisce all’osservazione attenta de’ suoi occhi, non c’è pericolo che lo vediamo deviare, ma quando tenta di volar più alto e di dare, dei fenomeni superiori una spiegazione, allora, venendo a mancare il sussidio dell’osservazione, si afferra al vecchio od invoca interpretazioni quasi dogmatiche.
Due interi volumi riguardano gli animali i quali o vivono dentro le acque del Danubio e dei tributari o si muovono nelle terre o per le paludi intorno, i pesci e gli uccelli. Anche qui le classificazioni che egli ci offre sono vecchie, poiché tengono conto dei caratteri esterni e solo parzialmente di quelli interni; perciò non le considereremo.
Finalmente l’ultimo volume è una miscellanea, poiché in esso fu collocato tutto ciò che non poteva essere contenuto negli altri, benché vicino assai per i vari argomenti in esso trattati a quelli esposti negli altri cinque tomi. Accanto ad « observa- tones anatomicae » ci sono gli elenchi degli insetti più comuni della regione danubiana, accanto ad argomenti potamologici stanno argomenti d’ indole climatica ; e poi seguono cifre indicanti le varie velocità dei corsi d’acqua, osservazioni sulla grandine, misurazioni col termometro e col barometro, e finalmente
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 209
un catalogo di circa 500 piante che si incontrano lungo il Danubio o nel resto dell'Ungheria.
Certo in quest’opera c’è della sproporzione: alcune parti sono troppo ampie, altre sono più brevi di quel che dovrebbero essere: l’archeologia e la fauna hanno una posizione quasi di preminenza, ed i minerali sono pure troppo ampiamente trattati; invece il clima è relegato in un angolo del sesto volume e la geografia e la storia sono condensate nelle poche pagine del 1° volume.
Ha cercato di accumular troppo materiale, non ha distinto ciò che era essenziale da quello che si poteva abbandonare senza rimpianto, e, venendo meno ad un principio con costanza sempre seguito, ha riempito sei grossi volumi, mentre 4 erano bastanti, se si condensava tutto il materiale di illustrazione ed iconografico.
c) I laghi.
Ed eccoci alla monografia limnologica, la quale per essere stata scritta nel 1725 è quella che meglio delle altre sa rendere la maturità piena del pensiero marsiliano e darci un’idea del suo metodo portato quasi alla perfezione. E tale monografia è rimasta fino a qui inedita, e solo ora per le cure della commissione marsiliana vede la luce.
In due parti si divide « la dissertazione » ; la prima — ed in questo suo metodo il Marsili non ha nulla da invidiare ad un trattatista moderno — considera il lago come individuo geografico, indipendentemente dalla vita vegetale ed animale che sulle sue rive e dentro le sue acque si muove o verdeggia: la seconda parte esamina appunto questa vita multiforme vegetale ed animale.
Ogni parte è suddivisa in capitoli. Il primo cerca di dare a chi legge una sicura idea della posizione, della forma e delle proporzioni del lago; ed in questo suo tentativo è felice il Marsili, perchè sa bene incastonare questo verde smeraldo di acqua fra i monti grigi e verdi che precedono le grandi Alpi. Anche la figura ha saputo rendere : « a foggia di liuto con principio fra
15
210 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
greco e tramontana », e le dimensioni del pari ha misurato con sufficiente approssimazione, tanto che sentiamo di dovergli perdonare il più o il meno.
E quest’approssimazione ottiene servendosi d’una barchetta condotta da tre remiganti.
Le sponde — dice il Marsili — è necessario descriverle prima, perchè esse « debbono servire alla dimostrazione e conoscenza dell’alveo », e difatti egli ne fa una dimostrazione minuziosa. Nota le rive alte e le basse, le possibilità di approdo e le difficoltà, le isole che sono di contro e gli scogli, i centri principali e le attività che esercitano gli abitanti, onde alla fine del capitolo non c’è nulla che non sia chiaro, come se davanti a noi stesse una rappresentazione plastica del lago.
Poi in un altro capitolo entra nell’esame della parte meno visibile del lago, quella coperta dalle acque, ed in questa parte egli appare più profondamente geografo, pili accurato indagatore delle cause dei fenomeni superficiali.
Il lago — egli dice — è come una « cratera » che consta di due parti: lo si pensi per un momento tutto vuoto, il fondo apparirà stretto fra le sponde; lo si riempia d’acqua, delle sponde una parte emergerà dalle acque e l’altra parte sarà dalle acque sommersa.
Ma — continua il Marsili — mentre di ciò che sta fuori è possibile l’esame, le parti coperte dalle acque presentano non poche difficoltà ad essere studiate. È vero che dal visibile è lecito argomentare ciò che non si vede, è vero che il fondo si può conoscere dai frammenti che lo scandaglio trae con sè, ma se le difficoltà scemano, non possono essere del tutto annullate. Cauto in questo suo ragionamento appare il Marsili, che ha piena consapevolezza delle difficoltà del sapere, e provveduto di uno spirito fatto apposta per indagare e trepido davanti alla luce delle scoperte, e d’una perizia tutta moderna nell’analiz- zare i fenomeni.
Lo studio del mare gli aveva aperto le porte della limnologia, ed anche in essa, anzi più in essa che nelle altre parti dell’ idrografìa, fa passi degni, di essere segnalati.
Le rive hanno nella parte che è sommersa quella consistente
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 211
ossatura che forma la parte montuosa e visibile; e se talvolta essa non appare, segno è che su di essa si è distesa quella « cute » varia per spessore e talora assai alta per scorrimenti di materiale dai monti vicini.
Poi seguono nozioni — le chiameremo così — di stratigrafia: il Marsili tiene in conto non scarso gli strati, perchè, egli dice, devono essere corrispondenti, e se tale corrispondenza non si incontra, vuol dire che cause hanno determinato le alterazioni.
I numerosi scandagli presi — con strumenti che non potevano non essere fonte di errori, primitivi, poco sensibili — permettono al Marsili di tracciare 19 profili, dei quali 8 riguardano la parte dove il lago è più largo. Questi profili — ed in tale attività egli può essere considerato come un pioniere — gli permettono di fare questa affermazione, la cui bontà oggi non può essere messa in dubbio, « le profondità delle acque del lago sono regolate dall’altezza dei monti vicini ».
A questa prima affermazione ne segue un’altra, del pari fondata sull’esame dei profili : « il fondo del lago, dov’esso è più angusto, pende verso la riva veronese, cioè verso il Baldo presenta le maggiori profondità ».
Senza discutere quanta verità ci sia nelle misurazioni prese (lai Marsili — nel commento al testo da me pubblicato si rettificano le conclusioni a cui è giunto — è pur vero che egli è il primo a dar profili, a ricavar sezioni ed a ragionare su questi dati dell’osservazione e dell’esperienza.
II terzo capitolo parla delle acque che si versano nel Garda, che è come un gran nappo che il soverchio scarica nel Mincio.
Dei vari fiumi che si gettan nel Benaco tenta di determinare il tributo, per vedere se quel che esso riceve scarica immediatamente nell’emissario, determina la quantità di acqua che il sole fa evaporare, e poi conclude che le acque ricevute per immissari superficiali sono press’a poco uguali a quelle che si scaricano nel Mincio od evaporano : quindi la gran massa delle acque del lago è costituita dalle emissioni delle fonti subacquee, laterali o del fondo, quindi questa gran massa è come in una condizione di quasi immobilità: la natura ha voluto che le acque colmino queste depressioni e la natura per mezzo di queste
212 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
fonti fa sì che esse si mantengano nelle condizioni di volume primitive. Accanto a tentativi nuovi ecco il ripetersi d’un concetto che fa della natura un qualcosa di molto rigido e di punto variabile. E poi, come se questo suo tentativo di far servire le osservazioni e le esperienze a provare una dottrina vecchia non ci fosse stato, eccolo di nuovo misurare la temperatura delle acque del lago e stabilire confronti e far paragoni e tirar conclusioni in conformità piena ai dati raccolti e constatati.
I venti, che hanno come campo d’azione il lago di Garda, sono considerati nel quinto capitolo, ed una carta riassume benissimo tutta questa non facile materia, e mostra dove appaiono le varie correnti atmosferiche che prevalgono nei diversi luoghi, sulle rive e nel mezzo.
II Marsili logicamente prima di trattare dei movimenti delle acque, considera i venti, perchè questi influiscono e non poco su quelli, anzi alcuni movimenti sono determinati dai venti. Il giuoco delle varie correnti atmosferiche è ben descritto in questo capitolo, e ben poco forse è da aggiungere oggi a quel che ci riferisce il Marsili. Il buon libro del Malfer 1 ha servito ottimamente nel commento che io ho fatto alla monografìa marai- liana, e da esso ho tratto spiegazioni non poche di fenomeni accennati e descritti dal Marsili.
L ’ultimo capitolo contiene una trattazione dei moti diversi delle acque, ed è forse quello che più contiene osservazioni originali e che rende la monografìa del tutto nuova.
Quante distinzioni fa dei moti delle acque!Poiché il lago è una mole liquida che tende a spostarsi per
la più semplice delle cause, così non deve apparir strano che un elenco di tali effetti sia numeroso. Ed ai moti costanti fa seguire gli incostanti, generati dalla varietà dei venti, e qui mescola idee, per cui la scienza gli deve riconoscenza, a risurrezioni o continuazioni di credenze che non avevano che l'appoggio di qualche buon nome, ma che la esperienza non confermava affatto.
Interessanti sono le sue osservazioni circa gli effetti di certi movimenti: questi determinano dei contro moti che sono più ce-
1 F l o r e s t e M a l f e r - I l Benaco - Parte I e I I - Oro-idrografia ed ittio log ia . Verona, 1927.
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 213
Ieri, ma di dimensioni, in lunghezza ed in larghezza, minori; sì che, cessando le cause esterne, a poco a poco ritorna in perfetta calma anche l'interno. Questi contramoti sono stati verificati di poi e largamente ne parla il Malfer.1
Biogeogralìca è la seconda parte: piante ed animali l’occupano tutta con la loro varietà, con le loro costumanze. Pino al suo tempo scarsa attenzione gli uomini avevano dato alle piante che crescono dentro le acque, ed il Marsili è forse il primo ad occuparsene con cura e con serietà. Ciò che egli aveva fatto per il mare, ripete ora per i laghi: anzi propone che si fìssi quasi una nuova botanica, quella che vuole studiare le piante che nascono, si sviluppano e fruttificano dentro le acque: vera previsione anche questa, anticipatrice di decenni del futuro.
d) Le valli.
Altro argomento toccato dal Marsili è quello delle valli che sono numerose nel Bolognese e che costituiscono una caratteristica della parte bassa della provincia. L ’argomento aveva attirato l’attenzione di non pochi studiosi, specialmente degli studiosi d’ idraulica — e Bologna ne aveva avuti molti e valenti — sì che non poteva il Marsili non rivolgere ad esse la sua mente, e vi andò nel 1715 ed anche di poi non come privato, ma per invito del Senato, allo scopo di dar un giudizio sulle proposte avanzate da alcuni matematici circa il rimedio alle frequenti innondazioni.
Il Marsili non ha pubblicato quel che ha scritto intorno a questo fenomeno della bassa bolognese, ma la sua « Agri bono- niensis palustris historia » giace ancora manoscritta, in attesa che qualcuno la sollevi dall’obblio, almeno riassumendo le idee principali che essa contiene.
Stabilita la equazione fra valle e palude, fissate le varietà dell’acqua che stagna, il Marsili si chiede quale sia la ragione che determina queste formazioni, che sono un non senso, perchè
1 Op. cit., p. 69.
2 1 4 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
l’acqua è tale elemento che cerca, per sua natura, di correre verso la parte più bassa, cioè verso il mare. La ragione di questo fenomeno, strano solo in apparenza, è questa : « tutte le volte che le acque mancano di un corso regolato e continuo verso la loro meta, vanno a distendersi in certi spazi o scorrendo sulla superficie o penetrandovi attraverso i pori della terra ».
Ed aggiunge che « quando non vi siano impedimenti fatti dall’arte o lasciati sorgere dalla negligenza degli uomini o prodotti dall’irregolare accumularsi delle arene, delle erbe o deivirgulti, non nascono paludi... Se però l'acqua trova intoppi,retrocede verso siti con orizzonte più basso di quelli verso cui dovrebbe andare, onde si formano rigurgiti che inondano le più fertili campagne, trasformandole in paludi. E così è avvenuto del basso bolognese, in cui le parti inferiori, per essersi colmate di sabbia, e gli scoli maestri per essere stati negletti per tanti anni, invece di essere veicoli, hanno acquistato orizzonte più alto costringendo così le acque ad uscire dalla loro strada diretta ed a soffrire un movimento in apparenza innaturale, ed un ristagno innaturale che le corrompe. »
La visione delle cause del fenomeno è esatta, e chiara è la descrizione che ce ne offre. Ma anche ci dà notizie storiche, poiché ci ricorda la grave questione fra Bolognesi e Ferraresi a proposito della deviazione del Reno: l’interesse di Ferrara voleva che tale fiume continuasse a versare le sue acque nella palude della San Martino, perchè coi detriti riempiva tale palude: invece Bologna, che vedeva le sue terre innondate, le sue case ed i suoi palazzi distrutti, non poteva non avanzare solenni proteste: ed essa insistè, ricorse, sostenne con calore le sue ragioni, senza però distruggere ciò che di male era stato compiuto.
Non si creda però che il Marsili pensi a qualche progetto o accarezzi qualche idea che voglia distruggere il male che si chiama valle o palude; più che a redimere la pianura da questo fenomeno assai dannoso, il che lascia ai tecnici, egli mira a risolvere un altro problema : in che modo trarre da questo stato doloroso di cose il maggior vantaggio possibile.
Non è quindi un problema tecnico, idraulico che qui si di
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 215
senta, ma un problema agricolo, politico che si vuol risolvere. È l’utilizzazione, o meglio il tentativo di utilizzare tutto ciò che è utilizzabile, nel miglore dei modi e con più lieve sforzo.
Il Marsili ci appare perciò sotto una nuova luce; è quello che si preoccupa anche delle folle lontane che la sorte costringe a vivere in luoghi ingrati e quasi sterili, e pensa ad esse e vuole che pur qualcosa si faccia per strapparle alla miseria. Un altro scopo poi s’aggiunge a quelli indicati fino a qui, e tale scopo è pure esposto: dal Marsili si vuole con questa storia della palude iniziare una descrizione intera del Bolognese, piano, collinoso e montuoso, descrizione a cui ha posto mano e che se non riuscirà a compiere, spera che qualcuno dell’istituto voglia condurre a termine, poiché il distretto, ricco di molti prodotti naturali, merita di essere illustrato.
In un altro fascicoletto appartenente allo stesso manoscritto, ritorna su questi concetti su cui s’è fermato prima, ma più d’ogni altra cosa insiste sulla parte che in questi fenomeni ha avuto la negligenza o la mala volontà degli uomini, ai quali si devono far risalire le tristi condizioni di larghe plaghe di campagna.
La organica struttura della terraChi scorra le pagine stampate o i fogli manoscritti del Mar-
sigli, tratto tratto, mentre altro argomento viene esaminato e discusso, trova che egli ha nell’animo un altro problema assai più importante e grandioso, e che appunto per risolvere questo, tratta degli altri argomenti. Il problema è quello dell’ «organica struttura della terra ». Che cosa intende con queste parole? Qual’è il vero concetto che dobbiamo vedere sotto le parole un po’ vaghe?
Il Marsili ha delle concezioni geografiche e geologiche che si potrebbero qualificare come cartesiane: egli concepisce la terra come un tutto perfetto, come un qualche cosa che Dio ha voluto fosse armonico in tutte le sue parti, e che gli uomini hanno cercato in tutti i modi di disarmonizzare e di alterare, di modificare assai e di variare. Quindi, stando così le cose, nel Mar-
216 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
sili c’è il desiderio di determinare realmente, desumendolo da quel che gli occhi possono vedere, la struttura della terra, come organismo. È un nobilissimo tentativo di sintesi geologica, che non poteva al suo tempo, per le tristi condizioni della scienza, sperare di costrurre.
Vede negli strati una continuità indiscutibile, vede nella terra emersa un legame stretto con la terra coperta dalle acque, vede che le vecchie divisioni non hanno pivi valore. Oh se avesse saputo abbracciare con uno sguardo d’aquila tutte le terre, se avesse potuto vedere i legami fra le regioni più lontane e cancellare ciò che il tempo, intorbidando, aveva su di esse disteso, avrebbe forse avuto un’idea di questo pianeta e non avrebbe dovuto attraverso ad altri studi, tentare di affermare la sua struttura!
Il Marsili crede che le linee dei monti non siano casuali, o meglio non crede che i raggrinzamenti che chiamiamo monti ricorrano sulla superfìcie terrestre in modo strano e bisbetico, ma con un certo ritmo e simmetria; il Marsili pensa pure che le linee dei metalli non ricorrano saltuariamente, non si protendano a caso, ma quelle che contengono lo stesso minerale sono come ricorrenti ritmicamente nei luoghi che presentano gli stessi caratteri, ond’è possibile affermare che dove esse si muovono, ivi sono identici terreni, e viceversa che l’identità dei terreni racchiude lo svolgersi di linee metalliche identiche. E del pari gli altri fenomeni che offre la superfìcie terrestre non crede che il caso li abbia distribuiti: un attento esame mostra che essi sono collegati insieme e che ad essi rispondono cause vicine e che ovunque queste esistano, immancabilmente producono quelli. Onde al Marsili appare naturale il ravvicinamento di fenomeni che la distanza separa, e tali accostamenti tenterà tutte le volte che gli sarà lecito.
Ora se a taluno può sembrare che questa armonia di linee e di condizioni quasi preluda ad una concezione geometrica della nostra terra, come al suo tempo, prima e dopo di lui, qualcuno pensava, tanto che si cercava a quale corpo della geometria solida potesse essere avvicinata la terra, a me pare che in fondo tale concezione, liberata da tutte quelle incrostazioni che
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 217
i tempi necessariamente vi avevano disteso sopra, sia fondata su questo principio che non possiamo non accogliere: non c’è al mondo nulla di arbitrario, nulla di puramente casuale. Ogni cosa obbedisce ad una legge e questa legge, se ha eccezioni, alla loro volta queste sono ben fisse, perchè si verificano tutte le volte che determinate condizioni si ripetono. Quindi non concezione troppo rigida e senza movimento, ma concezione sorretta ed appoggiantesi a leggi che non vengono mai meno, che hanno eccezioni, ma queste sono confortate e giustificate da condizioni particolari.
A questo mi pare che il Marsili tenda con ogni suo sforzo, cercare di segnar su una carta la via di un fenomeno, raccostare i fenomeni della stessa specie per collegarli in un tutto, stringere insieme le distanze quando queste ci appaiono caratterizzate dagli stessi fenomeni: in una parola considerare la terra come un organismo che ha una struttura, cercare di svelare questa struttura e svelata fissarne il suo funzionamento.
Non è giunto il Marsili a toccare la sua meta, benché essa gli sia sempre presente alla mente, ed in tutte le sue costruzioni scientifiche non nasconda a sè che per tale meta costruisce e che ad essa vuol giungere; ma come poteva essere altrimenti? La scienza o meglio le scienze che egli coltiva erano al suo tempo proprio in sul nascere, e quindi era assolutamente impossibile che da esse sapesse trarre quella visione d’insieme che è propria dei tempi di maturità scientifica.
L'opera cartografica.Non piccola è stata l’attività cartografica del Marsili, anzi si
può dire che essa costituisca uno dei maggiori meriti suoi. Le carte che accompagnano le sue opere pubblicate, e specialmente l’Opus Danubiale, e sopra tutto le carte che troviamo ne’ suoi manoscritti, alcune delle quali a colori hanno servito per la stampa dell’ Opus Danubiale e delle altre opere, mostrano in lui la vera comprensione dell’importanza della carta, quale rappresentazione dei fenomeni superficiali della terra.
2 1 8 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Certo egli si è valso di disegnatori abili, che obbedendo alle sue indicazioni ed ai suoi schizzi hanno fatto bello quello troviamo malamente indicato ne’ suoi appunti. Ma questo non diminuisce affatto il merito suo, poiché ogni carta risulta di due parti: una parte artistica, fatta di linee ben tracciate, di simboli convenientemente resi, di colori non stridenti, e di una parte intima che si può riassumere in questo: piena rispondenza fra i segni e la realtà, si capisce, espressa simbolicamente, presupponente misurazioni precise, calcoli di distanze esatti, abile uso di strumenti, determinazioni astronomiche ecc.
Ma il Marsili ha piegato la cartografia a tutti gli scopi che egl si prefiggeva: non ci sono infatti fra le produzioni sue carte fisiche — inteso questo aggettivo nel significato suo più ristretto — e politiche, ma carte d’ogni varietà. Il marelo ha saputo rappresentare con tutte le particolarità che egli vi aveva notate, e se ancora non troviamo segnate linee isobate, già le carte si dispongono ad accogliere una vaga rappresentazione del fondo. Però le correnti, specialmente quelle del lago, hanno trovato modo di essere espresse, e siccome esse si fanno risalire in parte ai venti, così anche i venti appaiono nella loro varietà spiranti sul breve bacino del Garda. Ma che dire delle carte mineralogiche, delle carte che indicano la varia distribuzione delle miniere sulla terra o su parte di essa, che dire delle mappe potamologiche, che dire delle mappe topografiche, quasi iniziate dal Marsili e continuate da lui con sempre crescente rispetto alla realtà ed ai vari fenomeni di essa?
Anche la tecnica cartografica con lui e per opera sua acquista maggiore sapienza: i monti sono rappresentati da un tratteggio così fine, che le loro altezze si notano subito : le città vi appaiono non solitamente rappresentate di prospetto con la loro cinta di mura e la corona delle loro torri, ma con quella varietà che ce ne fa subito comprendere l’importanza: di più comparisce — ed è una delle prime comparse con pienezza di funzione — la rappresentazione della flora ed anche c’è l’intenzione di mostrarne il variare da luogo a luogo.
In una parola, poiché il Marsili mirando la terra e le sue parti non le vide monotone ed uniformi, ma assai varie, cercò
M. LONGHENA - L. F. MARSILI GEOGRAFO 219
che tutte queste varietà apparissero nell’immagine che egli tentava, e ci riuscì con più che discreta arte.
Non c’è volume de’ suoi manoscritti che non abbia qualche carta o qualche schizzo, tanto che chi vuole conoscere la terra — limitatamente a gran parte dell’Europa — come la conoscevano gli uomini del principio del ’700, non deve far altro che scorrere i manoscritti marsiliani ed apprenderà assai di più di quel che sapessero i contemporanei del Marsili. Variamente orientate queste mappe, ma per lo più nel senso nostro, a penna ed a lapis, bene spesso a colori, quasi sempre ben lavorate, con scale assai diverse e con misure diversissime, rispondenti ai paesi che tali carte rappresentano, meritano di essere fatte note — sia pure in un catalogo ragionato — affinchè agli studiosi della geografia e della storia non resti nascosta quest’abbondante e ricca miniera.
Altri potrà poi trasportare in pagine e commentare e discutere i dati offerti dai brevi fogli percorsi da linee e coperti da disegni; altri potrà quasi far vivere nella sua prosa le visioni del nobile bolognese che ha voluto lasciar traccia visiva della sua meravigliosa attività viaggiatrice e geografica.
Il metodo.Il titolo posto davanti a questa rapida rassegna è quasi
troppo pretenzioso : del Marsili geografo si possono scrivere infinite pagine senza per altro giungere a dir di lui tutto quello che si può dire, tant’ è vasto il campo in cui ha lavorato e tanto profonda traccia di sè ha segnata.
Ciò che ho scritto è come la linea principale di un lavoro intorno a questa predominante attività marsiliana, quasi l’indice degli argomenti eia trattare poi estesamente e compiuta- mente.
Tuttavia a me pare di aver dato modo di sufficientemente apprezzare l ’ importanza di questo scienziato, offrendo tutti gli specimina della varia sua capacità a trattare argomenti geografici. Nei quali il Marsili non si appaga di portare un po’ di contributo, ma tutti li percorre, li approfondisce, li sviscera ;
220 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
gli ostacoli non li sa tollerare, le difficoltà hanno la forza di renderlo più tenace e più fervoroso ricercatore, e solo quando la sua incapacità a trovare il vero ha evidenza cristallina, allora, percorse tutte le vie, si confessa impotente a raggiungere la verità, e piuttosto che seguire sentieri non onesti e non dignitosi, s’ inchina alla necessità e dichiara di ignorare.
Ma quando queste condizioni non si verifichino e può liberamente cimentarsi alla lotta per la scoperta di qualcosa che è il vero od un avvicinamento al vero, quanta meravigliosa e varia energia sa spiegare e quanto entusiasmo lo anima!
È ancor qui l’uomo d’arme che sa calcolare le forze sue e quelle del nemico e sa disporre delle sue forze con mirabile parsimonia e con prontezza e con prudenza.
È il metodo sapiente la sua arma che non si spezza nè si piega, che sa riportar le vittorie ed impedisce le sconfitte piene. Questo metodo egli non l’ha appreso da maestri, non l’ha tratto dai libri, ma se l’è fabbricato da sè con la riflessione, con lo studio; lentamente, ogni argomento sottoposto all’azione di tale metodo, tutto suo, si è diviso in parti — nelle parti che lo costituivano —, e ciascuna parte è stato più facile vincerla d’assalto e sottometterla.
Segno di questo suo saggio mezzo per vincere le difficoltà è il linguaggio semplice e piano, che par il più naturale ed è invece il prodotto di matura e lunga riflessione: questa semplicità è indice di ordine, di visione chiara, di intuizione sicura, e svela la mente forte e disposta a scoprire entro i fatti ed i fenomeni le leggi che li governano e la verità che li anima e li fa belli.
M a r io L o n g h e n a
Uno scritto di Luigi Ferdinando Marsili su la riforma della Geografia.
Durante il suo primo viaggio da Venezia a Costantinopoli al seguito del bailo Civrani nel 1679, il Marsili, come è noto, attese con amorevole studio alle cose dei Turchi, alla loro cultura, al loro stato civile e militare, ai loro costumi ed arti, venne a conoscenza di loro valenti eruditi e si potè procurare codici rari, mentre, assecondando il proprio spirito di osservazione e di ricerca, acquistò materiali preziosi e cognizioni svariatissime intorno ai luoghi ed alle condizioni di vita dei popoli, orientali. Si veniva sviluppando in lui la tipica natura del viaggiatore curioso, la tempra dell’esploratore e scienziato moderno.
Tra l’altro gli riuscì d’avere il celebre Canon Nome con tutte le notizie politiche e militari dell’impero Ottomano, e di prender contatto con Abubekir Effendi « che fu quello che fece l’in- ventione di tutte le mappe geografiche del Blaw, donate da un ambasciatore d’Olanda a quel Sultano » 1, e ne ebbe, oltre a segrete notizie di astrologia, schiarimenti per le mappe, che più tardi accompagnarono il suo trattato sulla milizia ottomana 2, e più precisamente copia di una « mappa dell’estensione maggiore dell’ Impero Ottomano che fu fatta dalla Reggenza del Sultano Mehemet IV coi nomi dei luoghi in lingua turca scritti in caratteri latini dallo stesso Abubekir Effendi l’anno 1678. » 3
1 R . B ib l io t e c a U n iv e r s i t a r ia d i B o lo g n a - M anoscritti MarsiUani : Autobiografia. I, c. 37.
2 M a r s i l i - Stato m ilita re dell' Im pero Ottomano. 1732. Gap. V II.3 Id. - Mnss., Voi. 46, n. 1, n. 6.
222 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Questo Abubekir, geografo del Sultano, fu in verità l’introduttore del Marsili nei segreti della geografia ottomana, la qual cosa, meglio che d’altra parte, ricaviamo da una lettera che il Marsili scrisse da Vienna il 14 maggio 1688 a Giovan Battista Donato bailo a Costantinopoli, sopra la letteratura dei Turchi. Oltre a fornire dotte notizie circa la Teologia, la Medicina, la Retorica, la Poesia, la Musica, l’Astronomia, l’Architettura, così il Marsili si esprime intorno alla Geografìa:
« La necessaria scienza della Geografìa fra Turchi nei tempi « antichi poco era praticata fuorché per quelle parti era neces- « saria alla navigatone dei loro mari, cognoscendo per autore « delle molte cognitioni che hanno in ora il Primo Wisir Kiu- « perii Uglu, che nel tempo della sua Regenza volse che gli « Atlanti fossero tradotti da più esperti interpreti, e la com- « positione delle Mappe la comise ad Abubekir Effendi di na- « tione arabba, e che nel amicitia del quale mi riuscì entrare col « mezzo dei donativi, che più di ogni altra cosa amolirono la di « lui rozezza, dimostrandomi li tanti errori erano nelle nostre « Mappe dell’Asia, tanto per la situatione che per la denomina- « tione de’ lochi, tanto che fui obligato con valide instanze di « pregarlo a colorarmi tutti i Beylerbati, i Sangiaccati che l’Im- « pero Ottomano tiene in quelle parti di mondo, e che si vedrà « nel mio esame della militia turca, già tottalmente terminato « col fondamento dei di lei instituti appresi col mio soggiorno « a Costantinopoli e degli esercitii per ogni atione possibile mil- « litare, veduti da me come soldato contro Turchi millitante e « come schiavo nella loro armata osservatore del metodo pra- « ticano in più parti, congiunture che tutte assieme spero mi « abbino datto un tal fondamento da pottere lasciare alla poste- « rità che cosa fosse la militia dell’impero Ottomano e la dila- « tione di pubblicarlo è causata dall’agitatione di così fervente « guerra.
« Questo vanto che mi fece Abubekir suddetto, toccante l’Asia « e la Mappa d’Ongaria in idioma turco trovata nel campo ne- « mico e che tengo presso di me, et la continuata agitatione de’ « miei viaggi mi obligarono a stabilire che la Geografìa per « causa delle denominationi de’ lochi ora quasi diven inutile a
G. NATALI - UNO SCRITTO SU LA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA 223
« quei che ne hanno rilevante bisogno, e per questo tre anni sono « risolsi di esortare li moderni geografi a men curare più super- « flui abilimenti e solo cercare le vere conosciute denominationi « de’ lochi, dando principio ad un Vocabulario di nomi geogra- « fici in quelle tante lingue ho avuto occasione e ne’ viaggi e « negli impieghi millitari di apprendere, e benché il fatto sinora « da me non sia che un saggio in risguardo di quello sarebbe bi- « sogno, ad ogni modo spero incontrerà la publica soddisfa- « tione, massime di quelli hanno bisogno dell’uso della Geogra- « fia non per superfitiale curiosità, ma per valersene et disporre « equalmente l’ationi <li pace che di guerra.
« Queste notitie dell’essere nel quale trovai la Geografia ap- « presso i Turchi, spero ad ogni modo non li saranno discare, « mentre sono le più solide potei investigare e vorrei che V.... « potesse veddere la Mappa tengo d’Ongaria fatta da medesimi « con assai competente agiustatezza. » 1
È dunque chiaro il divisamente del Marsili, già provetto nel- l’armi e rotto ad ogni avventura di viaggio per paesi inospitali e mezzo barbari, di farsi riformatore della Geografia e di dar fuori qualche opera sull’impero Ottomano, che gli permettesse di valersi del prezioso materiale raccolto e in parte già riordinato nel campo della geografia orientale. Era stata del resto sua norma costante di capitano, di viaggiatore, di studioso raccogliere via via nomi geografici in più lingue e mappe d’ogni genere, più spesso semplici schizzi a penna o a matita di monti0 fiumi, di città o villaggi ; certo a lui pareva di muoversi entro un mondo nuovo o mal noto, del quale era pur necessario farsi un’idea precisa e dare ai contemporanei una rappresentazione prossima al vero.
Ma quale più ampia e feconda messe di notizie geografiche e naturali non potè mietere e accumulare l’animoso Conte nel suo secondo viaggio a Costantinopoli nel 1691 e ’92 e in tutte le operazioni militari ed i negozi diplomatici che precedettero la pace di Carlovitz e la conseguente delimitazione dei confini tra1 due imperi d’Austria e di Turchia !
1 iJnss. Marsiliani. Voi. 81, Carte 83-90.
224 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Nella sua seconda dimora a Costantinopoli il Marsili, per ciò che riguarda la Geografia e l’Astronomia fece una scelta dei migliori autori delle tre lingue, araba, persiana e turca, e riuscì a carpire l’unico esemplare della traduzione di tutto il gran corpo dell’Atlante del Blaew, che il sultano Mehemed IV aveva fatto fare per uso del proprio governo. Il Marsili non badò a spese per procurarsi questo codice prezioso, perchè considerò che in quest’opera di gran pregio erano stati impiegati alcuni Turchi esperti nella Geografìa, « che nominano nelle « Mappe — come egli scrive — i nomi dell’Asia come sono al « presente, laddove nelle Mappe nostre non se ne trova pure « una che abbia minima sembianza con quelli d’oggi, nè pertanto « è da ponersi in dubbio, che in Europa non avremo mai Mappe « competenti dell’impero Turco e Persiano, Tartaro ed Arabo, « se non ricorreremo alla traduzione della Geografìa di questi « autori »A
Memorie, appunti, schizzi, mappe, note strategiche, osservazioni celesti e terrestri, codici e informazioni d’ogni specie, costituirono un cumulo ingente di materiali, donde il Marsili intendeva trar fuori qualche opera conclusiva che illustrasse i paesi e le civiltà dell’Oriente Europeo ; e dopo la dolorosa catastrofe di Breisac, col continuo alimento di nuove ricerche e con la meditata elaborazione impostagli da circostanze di opportunità e di esecuzione, ne uscirono infatti il Danubms Pannonico- Mysicus, YHistoire physique de la Mer e lo Stato Militare dell’impero Ottomano, che nel loro complesso condensarono e coordinarono il meglio dei materiali raccolti nelle campagne d’Oriente.
Ma quante altre opere scientifiche il Marsili venne meditando e abbozzando e quante trasformazioni subirono nel loro piano organico le opere stesse, cui è precipuamente legata la fama dell’operoso instancabile patrizio !
Tra le molte cose pensate o appena iniziate da lui è da porsi il progetto di un’opera geografica e cartografica, che valesse di
1 M a r s il i - Stato m ilitare dell’ Im pero Ottomano. Cap. V II , p. 39. Mnss. Mars. Autobiografia : I I , c. 54-55.
G. NATALI - UNO SCRITTO SU LA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA 225
correzione e di riordinamento della geografia dell’Europa orientale e delle parti extra-europee dell’ Impero Ottomano, nella quale potesse tutto essere versato e utilmente disposto il materiale accozzato in tante laboriose peregrinazioni.
Relativa a questo proposito è una prefazione, che si conserva in manoscritto autografo nella Raccolta Marsiliana presso la R. Biblioteca Universitaria di Bologna, che è di alto interesse nei riguardi della geografia in generale.
Il Marsili intitola il suo scritto « Introdutione alla mia riforma della Geografia ». Era dunque in lui la precisa coscienza di poter riformare, almeno in parte, la geografia dell’Europa, e per geografia egli intendeva precipuamente l’esatta descrizione dei luoghi.
Lo scritto è da assegnarsi, a mio avviso, ai primi anni del ’700, dopo la pace di Carlovitz, nel periodo più fervido dell’attività marsiliana e coincide assai probabilmente con la pubblicazione del Prodromo all’opera danubiale, la quale poi avrebbe assorbito le migliori energie del Marsigli ed i materiali più scelti e vagliati.
I viaggi e le operazioni militari lo avevano indotto agli studi geografici, alle scienze naturali, alla geologia, ma nella pratica strategica, diplomatica e odeporica gli si erano palesate tutte le manchevolezze e le lacune della geografia del suo tempo, tuttii problemi, dalla cui soluzione dipendeva l’avviamento di questa scienza verso fini di utilità politica ed economica.
Della riforma geografica gli apparivano opportune ed evidenti queste direttive:
1°) restaurare la rappresentazione cartografica della superficie terrestre, specie per i paesi barbari; a questo fine misurare distanze, fissare esatte latitudini e longitudini mediante osservazioni astronomiche, ritrarre dal vero la posizione e il rilievo dei luoghi ;
2°) esplorare paesi mal noti, osservare oggetti e fenomeni, senza troppo fidare in vecchie carte ed antichi scrittori.
Per la parte del rinnovamento cartografico, il Marsili entra nel gran circolo di scienza irradiato da Gian Domenico Cassini,
16
226 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
che infonde in lui il sano concetto di restaurare la geografia sul metodo delle osservazioni celesti.1
Anche Domenico Gnglielmini, a cui Lelio Trionfetti, interpellato in proposito, lo aveva rivolto per schiarimenti in materia di geografia -, lo esortò con opportuno consiglio a compiere osservazioni astronomiche per la esatta definizione della longitudine e latitudine dei luoghi danubiali 3, e il 18 giugno 1697 con bella franchezza di scienziato così gli scriveva : « Quando Ella « verrà a Bologna bisogna che porti seco un buon orologio e un « buon sestante da lasciar qui, che io poi me ne servirò da fare « osservazioni in corrispondenza di quelle che Ella farà e farà « fare in altre parti. La mia povertà non mi permette di far tali « spese, e senza stromenti non posso far cosa alcuna. Col mezzo « delle osservazioni si levano in oggi 40 gradj di longitudine al « continente dell’Asia, dell’Africa e tutte le altre parti propor- « atonalmente si restringono. Ciò prova ciò che Ella dice, che i « geografi fanno di belle pitture nelle stanze, ma non giuste per « diffetto di viaggi e di osservazioni. Questo è un errore che non « si può correggere che coll’erario dei Principi, che farebbero « molto meglio a spendere il loro danaro in persone dotte che « s’applicassero alle perfetioni dell’arti e delle scienze che in « musici che recitassero loro di quando in quando un’opera sen- « z’altro vantaggio che di un grattamento d’orecchi momenta- « neo che appena nato è svanito. Noi riformeremmo ben presto « il mondo se i Principi non volessero fare a modo loro, ma a « nostro ».
Anche Eustachio Manfredi, che il Marsili prescelse come direttore dell’erigendo Osservatorio Astronomico e Libreria in Bologna, si riprometteva dalle osservazioni astronomiche un van
1 AIii88. Mars. Voi. 79, n. 8 (Lettera di Dorn. Cassini a L. P. Marsili da Bologna, in data 20 maggio 1695. Gli dà istruzioni circa le osservazioni celesti e lo informa che quelle fatte dai matematici del Re Cristianissimo mandati alle coste orientali della Cina danno una longitudine di 25° minore di quelle delle carte e dei globi più recenti ed accurati stampati in Ita lia ). Cfr. altra lettera del Cassini al M arsili da Parigi in data2 giugno 1698.
2 M h88. M a ri. Voi. 79, n. 2 e 3.8 Mnss. Mars. Voi. 79, n. 6.
G. NATALI - UNO SCRITTO SU LA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA 227
taggio sicuro per la geografia e così scriveva al Marsili « Il frutto principale che si ricava dalle osservazioni astronomiche è la riforma della geografia. Quella dell’Italia ne ha gran bisogno, essendo le carte del Magmi tutte false nella graduazione e molto peggiori quelle che vanno tutto giorno pubblicando in Italia e massime in Roma » . 1
Sul cadere del 1699 il Marsili, che stava per dare alle stampeil Prodromo dell’opera danubiale, attendeva ad osservazioni celesti, fiducioso che ciò fosse di sicuro ausilio a un rinnovamento della geografia, e così ne informava il Trionfetti. « Felicemente osservai l’Ecclisse su fiume Corana, e l’osservazione la scriverò al Cassini, perchè con ogni diligenza è stata fatta, e riuscita utile per essere stata in paese, dove mai simil cosa si è fatta a beneficio delle longitudini, e mi creda, che senza una molteplicità di tali osservazioni, ed un lexicon in più lingue dei nomi della Geografia, che siamo tutti per questa bella scienza in un pelagà di confusioni, e d’inganni, e pochi ne hanno fatte le prove, come io, che ho scandagliati provincie e paesi tanti per fare la guerra, e la pace, che vale a dire ben considerato tutto con una mente assai attenta per tali operazioni ». 2
Questa coscienza di possedere la capacità e l’esperienza per farsi riformatore della Geografia ed avviarla a mete più precise, è il sentimento che dà valore al documento che pubblichiamo,il quale anche attesta come il Marsili, col proceder degli anni e delle studiose fatiche, venisse intendendo ad opere di vasto concetto e di ampia tessitura volgenti alla descrizione della terra.
Dopo breve introduzione il Marsili entra nel vivo della questione e nota le manchevolezze nella cartografia dei suoi tempi ed espone le cause della facile alterazione delle carte, che pur derivano in parte da itinerari romani, ed enumera tra esse la barbarie dei popoli, la difficoltà della trascrizione dei nomi dei luoghi da una lingua ad un’altra, l’incuria e l’incompetenza dei viaggiatori, la mancanza di esatte informazioni. Rivendica
1 B b u z z o G iu s e p p e - L. F. Marsili. N uovi studi sulla sua vita e sulle opere m inori edite ed inedite. Bologna, Zanichelli, 1921, pag. 89.
2 Mnss. Mars. Voi. 79. Lettera del Marsili al Can. Trionfetti del 14 novembre 1699.
228 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
la bontà delle misure romane, rispetto alle distanze rappresentate dai cartografi su informazioni vaghe e tendenziose.
La necessità delle marcie militari fu al Marsili occasione propizia ed impellente all’esatto rilievo delle distanze; le varie operazioni per la delimitazione dei confini tra l’impero Ottomano e 'l’impero Cesareo gli resero necessario il rilievo topografico, l’osservazione delle coordinate ed ogni altra indagine atta a conoscere le caratteristiche naturali e strategiche dei luoghi. Non avrebbe egli dovuto dar saggio dei suoi studi e riformare questa parte della Geografia, che si attardava su vecchi schemi ed errate rappresentazioni e denominazioni dei luoghi? Egli provava sdegno per quei geografi e cartografi di professione, che lavoravano a tavolino aggiustando arbitrariamente le carte, senza diretta conoscenza dei luoghi. Tale dunque è il suo proposito : riformare la Geografia dell’Europa Orientale. Per l’impero Ottomano si varrà dell’atlante del Blaew tradotto da Abubekir e delle informazioni da lui assunte a Costantinopoli intorno alle parti dell’impero situate in Asia ed in Africa; per i dominii di S. M. Cesarea potrà valersi dell’immenso materiale di sua pertinenza e di prima e sua propria mano raccolto ed eleborato, chè egli a buon diritto può vantarsi di aver percorso ogni paese dell’Ungheria, Transilvania, Valacchia, Serbia, Bulgaria, Albania, Schiavonia e Croazia, di aver fatte infinite misurazioni terrestri ed alcune celesti. Nè manca nei suoi progetti l’idea di un vocabolario di nomi geografici in più lingue, ad uso dei geografi e dei viaggiatori.
Il Marsili sente che una qualsiasi opera geografica, abbia essa carattere naturalistico od istorico-politico, non trova il suo giusto compimento se non si estrinseca in mappe, che quasi ne siano l’anima e la sintesi evidente ed efficace. Per lui la Geografia assume il suo vero significato etimologico di rappresentazione o disegno della superficie terrestre. Ma sull’ inizio del secolo X V III la Geografia, che si veniva arricchendo notevolmente di notizie su luoghi e popoli, era ancor deficiente nella rappresentazione cartografica. Alla riforma del Riccioli era mancata la pratica attuazione, ma già il Cassini aveva derivato dalla astro-
G. NATALI - UNO SCRITTO SU LA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA 229
norma metodi valevoli al rinnovamento cartografico, e il Marsili aggiungeva per conto suo la pratica esploratrice.
Se alle grandi opere di natura cartografica e geografica edite dal Marsili aggiungiamo i materiali rilevati e raccolti, le schede e gli abbozzi per uno studio su l’interna struttura del globo 1,il concorso dato alla fondazione dell’istituto delle Scienze in Bologna, ove, anche per suo influsso, fu aperta nel 1724 una Camera di Geografia e Nautica, 2 si può concludere non essere vanaglorioso il titolo che il Marsili diede allo scritto, che qui di lui si riporta, ove francamente si atteggia a riformatore della geografia.
(R . Biblioteca Universitaria di Bologna - M anoscritti M a rs ilia n i L X X X V I1 I . F . 1.)
Introdutione alla mia riforma della Geografia
Creossi la sfera del Mondo da D io con una sola parola, e da lui fu divisa in terra et aqua. La terra in continenti isole e anche in pianure, coli, monti, le alpi ; l ’acqua in fonti, rivoli, torrenti, fiumi di varie grandezze, laghi, stagni e mari. Ed entrambe queste parti destinate alla stanza dell’uomo furono non meno di piante che d’animali populate per il di lui uso e sostentamento. Non tosto cominciò a propagarsi l ’umana populatione che della medesima terra si venne alla divisione di parti in essa, che abitate con Città disposte sotto varii dominii, leggi et usi et populate da genti, che nella confusione delle lingue ciasched’uno s’accostumò, da loco a loco o da provincia a provincia, ad uno particolare. La necessità del comercio, o pacifico o m ilitare d’una Provincia con l ’altra obligò l ’ inteletto dell’ omo a trovar modo di comporre una universal guida a chiunque fosse bisognoso di viaggiare per esse, mostrando distanze, situationi de’ lochi et interpositioni de’ monti, mari, corsi dei fiumi, per il che Tomo potesse diriggere li di lui regolati motti.
1 Mnss. Mars. Voi. 90.2 C fr . N a t a l i G io v a n n i - La Camera di Geografia e Nautica presso
V lstitu to delle Scienze in Bologna. Stab. Poligrafici, Bologna, 1922.
2 3 0 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Questa guida non è che la Geografìa invento d i ..........da seco li...........che ridottasi ad un regolato sistema, si è reso degno del sudore di tanti ingenii per ridure in m igliore et ordinatto mettodo li di lei primi imbrioni, parte con la scorta del cielo, e parte con la dimostratone assomigliante alle parti della terra, da che ne venne il composto delle Ta vole e Mappe.
In moltissime di quelle parti diviso il Mondo si rende solo applau- sibile la predetta antica inventione di Geografia, ma non già estimabile la moderna esecutione, trovandosi tanto nella dispositione di terra che d ’ aqua, i lim iti e situationi e distantie e denominai ioni dei lochi to ta lmente in confusione, che il merito anche de l’antiguità soffrir deve, non meno che ristare ingannati quelli che da tali descriptioni si prendono legge, non meno per il confronto de le historie che del presente uso ne volessero havere.
Questa confusione bisogna gran parte attribuirla alle tante domina- tioni che hanno posseduto tali paesi (lo incendio delle famose biblioteche), che molte delle volte sono sfatte barbare e di diverse lingue, che non impedendo gli omini di studiata curiosità in viaggiarle, e l ’altra «ausando mutationi nelle denominationi hanno impedito di fare l'offitio di esato restauratore della Geografia.
L i Regni e Provincie d’Europa, dove lo studio, la curiosità hanno potuto aggire, restano tanto per stampe che disegnate Mappe per li Gabinetti de Principi assai bene illustrate; ma appena sortendo da tali lim iti entriamo subbito fra una caligine di oscurità e falli, che disposti in vaghe Mappe lusingano gli omini ad una falsa creddenza, che li conduce ad accingersi a viaggi o spedittioni m illitari, senza precautionarsi d i altre notitie, chè creddono in quella non men vaga per colori che taglio ed autorizzata dal bel titolo di nova et esata.
Da dove per lo più si cavano tali rinnovationi esattissime tanto m illantate? Per lo più da relationi di gente incapace di darle, o da viandanti che hanno portato il diario delle loro giornate privo d’ogni altra in form atone laterale della loro strada, e con il corompimento dei nomi, <.'ol non avere regolato la diretlone della bussola, con Tesser statto timido d i far ricerche, per impedire sospetti, e molte volte alcuni si può cred- dere variino qualche paese de l ’antiche Mappe per dar essere al creddito della novità. Infine ho riconosciuto che tutte le più moderne Mappe d i terre, che per l ’avanti erano dette barbare, sono più falaci de l ’antiche, per la sola ragione dell’avidità hanno avuto alcuni compositori d i queste d’ accreditarsi d'un usurpato nome di esato restauratore della Geografia, rubbando dagli omini denaro non meno che fama. L ’uno di codesti moderni restauratori comincia a slontanarsi da quel puro antico col inventarsi, o essere male informato di qualche variatione, un a ltro che segue copia o pure fa un aggiunta d’altre novità di relatione
G. NATALI - UNO SCRITTO SU LA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA 281
o inventione et oltre la corutione del trascrivere i nomi si fa sempre maggiore, et infine si rende il moderno restauratore, il distruttore della Geografia con tanto danno publico.
Qual demerito è quello d’un omo che vogli dar per sicuro la di lui geografica descritione d’un paese dove mai è stato e da dove neanche ha accreditate e giuditiose relationi? Stancansi questi soli a coreggere quelle provincie che possono con l ’ochio in terra et in cielo compassare, assicurando che troveranno da fare tanto per l'uttile pubblico che- loro privato, per il creddito e basta.
E lasciamo l ’antiche Mappe nella loro primaria purità, avengachfr quelle hebbero li loro primi natali dalle relationi d'uno Imperio Romano, che di tali provincie ne era dominante, pottendo asserire che in tante peregrinationi ho trovato molta piti corrispondentia fra le Provincie e situationi che l ’historia antica Romana, che con li raconti di viandanti, essendo che quella ha havuto le sue radici da omini che non scorrevano da viandanti le terre, ma le misuravano con il compasso degli eserciti, che è l ’ infalibile, mentre non è contento di solamente propor- tionare le parti dei Regni, ma le vole riconoscere per applicarle al usa di Principe in pace o in guerra.
E li tanti viaggi non meno che m illitari speditioni in Province che per la sugetione a barbaro Popolo, non pottevano per avanti essere riconosciute, mi hanno datto motivo di pottere osservare qualche cosa vergente alle medesime provincie, non voglio essere ingrato alla congiuntura ho havuto col trascurare la radunanza delle mie geografiche osservationi.
L i m iei mobilissimi viaggi per la Turchia in Europpa, di Vienna, di di Venezia a Costantinopoli, li miei impieghi m illitari in servitio di Cesare Leopoldo con quelli eserciti, che hanno depresso l ’ottomano orgoglio, scorrendo per ogni paese dell’Ungaria, Transilvania, Valachia, Servia, parte di Bulgaria, Albania, intera Schiavonia e Croatia, mi hanno fatto la base di questa mia Geografia, toccante tali parti, che ho misurate, suddivise per le marchie degli eserciti non solo, ma per incorporarle con difesa m illitare all’ impero di Cesare. Da Costantinopoli ho cercato notitie delle parti Asiatiche, A fricane et Europee settentrionali sotto l ’im perio Ottomano e non con l’havere ricercate relationi qui e là, ma con il non bavere risparmiato a spese et per havere le Mappe loro proprie Turche, tanto di terra che di mare e sopra il tutto il volume dell’Atlante che fu tradotto da Bubekir Effendi per ordine di Sultano Meemet e corettosi al dire dei Turchi degli errori sono ne’ stampati delle loro Provincie.
Ne’ viaggi e speditioni m illitari ho potuto io medesimo conoscere il corso di fiumi, pianure, monti, alpi, distantie dei lochi quanto alla terrestre mesuratione non havendo fra le m artiali agitationi pottuto havere l’aggio di servirmi del cielo.
232 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Le Mappe turchesche dell’ Imperio Ottomano saranno impresse con quella purità le hanno, non usurpandomi l’altrui merito nè incaricandomi neanche della verità. Si può ben creddere che le loro notitie siino più vere che le nostre, mentre quelli passegiano di continuo da dominanti le Provincie, et noi per accidente da tim idi viandanti. Le Tavole delle conquiste di Cesare le distendo con quell’ordine e proportione che la guerra mi ha prescritto.
Dalle raccolte Mappe dei Turchi pretendo di ritirare in gran parte il fondamento d’un Vocabolario in più lingue dei nomi geografici oggi tanto necessario per levare quelle confusioni trova un omo per la Geografia, quando è necessitato di servirsene non da otioso studiando al tavolino, ma o da viandante o da soldato. Dalla estensione dell’altre delle conquiste non solo pure trovo aiuto al Vocabolario suddetto, ma fondamento da dimostrare tante parti della eruditione antica Romana m illitare.
G io v a n n i N a t a l i
L. F. Marsigli e la Transilvania.
1. L ’ attività enciclopedica del M. - 2. I l M. e l ’ Ungheria. - 3. I manoscritti riguardanti la Transilvania. - 4. I l M. e la Transilvania. : 5. Conclusione.
1. L’ attività enciclopedica del Marsili.
Dell’attività scientifica di L. F. Marsili (1658-1730), durata ininterrottamente per oltre cinquant’anni, pur fra le cure, le occupazioni e le traversie della sua lunga e avventurosa carriera militare e delle sue missioni diplomatiche, sono testimonianza le opere a stampa pubblicate da lui medesimo o dopo la sua morte 1 e i numerosi manoscritti — ancora inediti i più — che si conservano nella Biblioteca Universitaria di Bologna 2.
Addestratosi alla scuola d’insigni maestri dello Studio bolognese e del padovano — quali il Malpighi, il Trionfetti, il Montanari e il Pighi, celebri cultori delle scienze naturali e matematiche — il suo spirito lucido e geniale, avido d’ogni sorta di sapere, si applicò alla indagine dei più svariati problemi e ad un’in
1 Ne dà l’elenco G io v a n n i F a n t u z z i , in appendice alle sue Memorie della v ita del Generale Conte Lu ig i Ferdinando Marsigli, stampate in Bologna per Lelio Dalla Volpe l'anno 1770 (v. a pag. 334-338).
s II Catalogo dei M anoscritti di L u ig i Ferdinando M ars ili conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna è stato pubblicato con d iligentissima cura da Lonovico F r a t i pei tipi dell’editore Leo S. Olschki di Firenze nel 1928. Esso è preceduto da brevi pagine introduttive, intorno alla vita del Marsili, e seguito da un copioso « Indice dei nomi di persone e luoghi e dei soggetti » . I l catalogo vero e proprio si estende per ben 134 pagine in 4o, iv i comprese anche alcune interessanti tavole illustrative, riproduzioni di manoscritti ecc.
17
234 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
faticabile e incessante raccolta, fatta un po’ dovunque, di libri, di manoscritti, di mappe, di minerali, di piante, di curiosità d’ogni genere, che costituirono poi il primo importantissimo nucleo della gloriosa Accademia delle Scienze, da lui stesso fondata a Bologna nel 1712.
L’operosità del Marsili, che si estese ai più disparati campi dello scibile, poiché nulla sfuggiva al suo acuto e insonne spirito d’osservazione e tutto lo interessava e di tutto teneva diligente nota, è, in verità, enciclopedica. E, sebbene le sue opere maggiori gli meritassero l’onore di essere aggregato ad insigni Accademie d’Europa, quali la Società Beale di Londra, l’Accademia Beale delle Scienze di Parigi e l’Accademia di Montpellier, e la sua attività scientifica abbia trovato diligenti illustratori nel Guare- schi1 e nel Bruzzo -, pure essa attende ancora chi la illustri degnamente nel suo insieme, con quella vasta e profonda competenza che si richiede per mettere in giusta luce così complessa personalità.
2. Il Marsili e l’ Ungheria.
Il Marsili, dopo un primo viaggio fatto a Costantinopoli nel 1679-80, al seguito del bailo veneto Pietro Civran, e da Costantinopoli in Serbia, in Bosnia ed in Dalmazia, chiesto ed ottenuto poco più tardi (1682) di entrare nell’esercito di S. M. Cesarea l’imperatore Leopoldo I, militò lunghi anni al suo servizio, raggiungendo da ultimo il grado di generale di battaglia.
In tale qualità, non solo per la parte di primo piano da lui avuta in importanti azioni militari, ma per gl’incarichi diplomatici, che fecero di lui un abilissimo negoziatore politico, percorse e ripercorse palmo a palmo il territorio ungherese e le regioni ad esso finitime, che studiò ed illustrò attentissimamente in tutti i loro aspetti oro-idrografici, topografici, etnografici, archeologici, storici, nella flora, nella fauna, nelle lingue, nei co
1 L. F. M on tili e la sua opera scientifica, nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, serie I I , voi. 65, 1916.
2 G i u s e p p e B r u z z o - L u ig i Ferdinado M orsili. Nuovi studi sulla sua vita e sulle opere m inori edite ed inedite. Bologna, Zanichelli, 1921, pag. VIII-154.
A. GIANOLA - L. F. MAUSIGLI E LA TRANSILVANIA 235
stumi. Lo attestano luminosamente l’ opera sua capitale intorno al Danubio x, altre opere minori2 e i numerosissimi manoscritti, che, trattando dei più svariati argomenti, costituiscono una ricca e in gran parte ancora inesplorata miniera di notizie intorno ai paesi balcanici in generale e all’Ungheria in particolar modo.
È perciò ben naturale che qualche studioso magiaro si sia interessato al Marsili, alla sua vita, alle sue pubblicazioni ed anche all’esame dei suoi manoscritti e che ne abbia pubblicati alcuni — o parte di essi — ad illustrazione di particolari eventi storici, massime della liberazione di Buda dall’occupazione dei Turchi. Ma in verità il numero di tali studiosi è ancora così scarso, che a contarli sono superflue le dita di una mano. 3 E ci voleva proprio la vigorosa ripresa delle relazioni culturali fra l’Ungheria e l’Italia determinata nel dopoguerra dalla politica fìlomagiara del Governo fascista e dalla politica italofìla di S. E. il Conte Klebelsberg, perchè, insieme con Andrea Veress — che già nel 1907 aveva pubblicato un catalogo dei manoscritti bolo
1 A l o y s i i F erd . Co. M a r s il i i Danubialis operis prodrotnus etc. a. 1700, Norimbergae, apud Jo. Andreae Endteri filios, e Danubius Pannonlco - My- sicus, observationibus geographicis etc. perlustratiti et in sex tomos di- gestus ab A l . F eed . Co. M a r s il io etc. Hagae Comitum ap. P. Gosse etc. 1726. F o l. atlantico.
2 Bevanda asiatica etc. da L. F. M a r s ig l i, che narra l’istoria medica del Cavè, o sia Caffè, Vienna, appresso Gio. Van Ghelen, 1685 in-12. — L. F. M a r s il i i - Dissertatìo de generation« fungorum etc. Romae, 1714 Ex off. typ. Francisci Gonzagae in via Lata, in fol. — Lettera intorno al ponte fa tto sul Danubio sotto l'im perio di Trajano etc. in data di Roma, 27 aprile 1715. — L ’état m ilita ire de VEmpire Ottonimi etc. par M . le Comte de M a r s ig l i etc. La Ha.ve - Amsterdam, 1732, in fol. (Un’altra edizione in lingua russa è stata stampata a Pietroburgo nel 1737). — Bibliotheca orientalis, sive Elenclius librorum etc. quos partivi in bello Turcico et partini in itinere Constantinopollm suscepto ipse (Co. F erd .
M a b s il i u s ) collegit, coemitque. Opera M ichaelit Talman. Ma questa stampa restò imperfetta.
3 G ià lo S z il à d y (1867), il B e l ic z a y ( M arsigli élete és munkdi, Budapest, 1881), 11 T h a l y (1892) e I 'A l d à s y (1893) avevano richiamato l ’attenzione degli studiosi ungheresi sopra l ’esistenza di tali manoscritti. Nel 1901 G u g l ie l m o F b a k n o i , fondatore e direttore della « R ivista storica ungherese», dette l ’ incarico ad Andrea Veress di recarsi a Bologna per lo studio dei manoscritti.
236 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
gnesi1, nonché una breve monografìa sul Marsigli, studiandone le relazioni e gli schizzi riguardanti Buda assediata dagl’imperiali dal 1684 al 1686 * — altri riprendessero gli studi marsi- liani, dai quali è lecito attendersi ottimi frutti.3
Ma in sostanza a tutt’oggi l’abbondante materiale di documenti e di ricerche d’ogni sorta lasciatoci dal Marsigli intorno all’Ungheria, « così importante — come scrisse il Thaly all’Ac- cademia storico-scientifica ungherese — che senza la conoscenza di esso non si potrebbe preparare una storia dettagliata special- mente di Buda al tempo della dominazione turca », è qui pochissimo noto e quasi del tutto inesplorato e inedito.
Sicché io, per mostrarne ancor meglio agli studiosi d’Ungheria la ricchezza e l’importanza, non potendo, per ragioni di tempo, nonché studiare, neppure elencare tutto quanto nelle raccolte marsiliane riguarda la loro patria, mi limiterò a segnalare nelle presenti note tutto quello che, in esse, ha attinenza alla sola Transilvania.
3. I manoscritti riguardanti la Transilvania.
Nella ricca collezione di manoscritti, ordinati e divisi in oltre 150 grossi volumi, interessano in tutto o in parte la Transilvania quelli segnati coi numeri: 15, 19, 24, 28, 46, 48, 54,
1 Catalogo ungherese dei mss. bolognesi del M arsigli (con ritratto), Budapest, Ateneo Letterario, 1907. Questo però non sembra al Bruzzo (op. eit. pag. 42 n.) « completo, poiché non v i troviamo elencato qualche manoscritto, che pur ha tanta importanza per la storia delle città danubiane. » .
* O róf M ors ig li Alajos Ferdinand jelentései és tt'rképei Buda v<ir 1684- 1686 - ik i etc., Budapest, Ranschbnrg, 1907, pag. 70, con tavole e illustrazioni. Gli schizzi e i piani topografici riprodotti in questo volume non sembrano al Bruzzo (op. eit. p. 42 n.) scelti fra i migliori.
s Cosi il dott. Béla B e v il a q u a -B orsody ha pubblicato un suo diligente studio sul Marsigli come astronomo, nella rivista Stella di Budapest (IV , 2, 1929); edito anche in estratto dalla stamperia Stephaneum, col t itolo : L. F. M arsigli di Bologna gróf tàbornok X V II , szózaévégi Magj/ar- orszògi esittagdszati megflgyelései, cioè Osservazioni astronomiche ungheresi del Conte Generale I.. F. M . di B . alla fine del sec. X V II (con 6 illustrazioni).
A. GIAN0LA - L. F. MABSIGLI E LA TRANSILVANIA 237
55, 57, 58, 6J,, 65, 66, 70, 81, 88, 100, 101, 103, 10.i, 117, A. M. C. I. 5, e i rotali 27, 29, 32.
Elenchiamoli, dunque, anzitutto in dettaglio.
Il voi. 4 (Miscellanea rerum naturalium) contiene al n. 5 un « Syllogos annotandorum circa physica naturaliave per Tran- sylvaniam reperiunda ».
I l voi. 15 s’intitola : « La popolazione di Transilvania composta di varie nationi di diverse lingue, religioni, usi e vestiti ». Esso consta di 41 carte in folio 46X30, con figure a colori incollate sulle pagine, alcune delle quali sono state lacerate.
Il voi. 19 è un Epitome historicum regni Hungariae, sire Prodromus et introductio ad acta executionis pacis Carlowi- censis, ad Clementem X I P. M. Di questo volume (in folio, 43X30 di 62 carte) troviamo il primo abbozzo, scritto in lingua italiana, nel voi. 117. Anche i mss. 28,1 e 70,10 si riferiscono in parte alla medesima materia.
Il voi. 2-i contiene una Raccolta di Mappe di osservazioni militari ed erudite fatte dal Generale Mar sili per i limiti dei due Imperi, che si stendono per la vera Ungarici e pei regni adiacenti.... Dei 138 schizzi e mappe delineati a penna e a colori di questa raccolta interessano in particolare la Transilvania quelli segnati coi numeri:
8. Mappa che mostra le più commode marchie tanto per l’Armata che proviande dal Danubio, Tliibisco e Marusio a Temisvar, e da questo per rimettersi di novo al Danubio in soccorso delle piazze della Schiavonia;
29. Entrata e sortita da Transilvania;79. Note di Transilvania;82. Entrata in Transilvania col prospetto de’ monti;97. Marchia de l’entrata in Transilvania;
120. Notizie della nascita del Maros et Luta et dei confini de’ Siculi1 ;
123. Nomi de’ monti che cingono la Transilvania.
1 II catalogo del Frati dà, per un evidente errore di stampa, l ’ indicazione : « Notizie della nascita, del lecto e dei confini de Siculi ».
238 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il voi. 28 è di Notitie geografiche e genealogiche dell’Ungaria raccolte dal Generale Co. Marsili. È di 03 carte in folio 52X39, con carte geografiche delineate a penna e stemmi araldici a colori, e consta di due parti : la prima contenente Memorie e introduzione all’istoria della ribellion d’Ungheria (cfr. voi. 19 e10,10), e la seconda comprendente le carte della Monarchia Ungarica in sua regna, principatus et ducatus divisa, nimirum : Hungariam veram, Bosnam, Serviam, Croatiam, Sclavoniam, Erzegovmam, Moldaviam, Valaohiam, Transylvaniam, Bana- tum Temisvariensem, Bulgariam.
Il voi J/G, che contiene Mappae chorographicae variarum re- gionum manufactae, ha :
sotto il n. 12 la Mappa potamographica, omnes fere qui in Monarchia IIungariae in Danubium sive mediate, sive immediate se exonerant fluvios, lacus item ac palude8 exhibens ;
sotto il n. 14 la Mappa potamographica plerorumque omnium in universa Hungaria fluviorum origines, decursus ae confluxus, etc. ;
e sotto il n. 27 una Mappa esattissima del Banato di Temi star.
Il voi. contiene Mappae geographicae variarum regionum Transdanubialium ni ss. prò linea liminum, e, fra le altre,
al n. 13 la Mappa per l’ostensione della necessità delti già fatti ponti tanto sul Tibisco, che Danubio, che Marusi fra essi, affine di potere nella guerra difensiva secondare la Transilva- nia e questa al Danubio;
al n. 1G la Mappa del paese intitolato « Partes Regni Unga ria e s>, che anni sono fu da me fatta con le relatiom d’esperte guide, e che poi servì alti proietti di pace dell’anno 1691;
al n. 24 il Proietto della possibile disposinone all’assedio di Tetnisvar secondo Videa datami dal Generale Aisler (Heisler);
al n. 29 una Mappa che dimostra li confini della Transil- vania et il dominio di Temisvar;1
1 Anche il vol. 49 contlene, sotto 11 n. 40, una Mappa geographica, Transylvaniain a Banatu Temisvariensi separantes lim ites exhibens. Da- tata dal 23 deeemb. 1700.
A. GIANOLA - L. F. MABBIGLI E LA TRANSILVANIA 239
al n. 34 una Transilvaniae rudis delineatio; al n. 36 una Mappa di Transilvania ; al n. 37 una Mappa della Transilvania con il proietto feci
Vanno 1690 delli lochi si havrebbero dovuti fortificare per sicurezza ;
ai nn. 43 e 44 due Mappe di quella parte di Transilvania visitai dopo l’espulsione del Tekli (Thokoly).
Il voi. 54 di Manoscritti diversi toccanti la seconda spedizione a Roma e monegio per D. Livio Odescalchi con scritture naturali e militari, contiene:
a carte 180-188 un Index civitatum, oppidorum, ardum XJngariae ;
a c. 343-345 una Conferma di tutto ciò che dissero al Co. Morsili sugli ambasciatori della Transilvania e Wallachia (20 maggio 1689);
a c. 519-521 Memorie d’alcune notizie avute dai Turchi intorno alle loro forze di quella campagna e all’andata del Tekly (Thokoly) a Vidino, ed altre particolarità;
a c. 526 una Piccola mappa, delineata a penna, che dimostra il sito dell’Ungheria e delle sue parti, della Transilvania, Wallachia, Polonia e Mar Nero;
a c. 535 un Ordine credenziale a tutta la Transilvania dato dal Principe di Baden al Morsili per chiuder i passi della medesima (29 ott. 1690);
a c. 537-644 numerose importanti Notificazioni ed istruzioni relative a_ detto ordine credenziale, attestazioni, lettere e ordini diversi, passi di Transilvania delineati a penna, Mappa della disposizione proposta dal Morsili a S. A. di Baden per rinchiudere Tekli (Thokoly), che si battesse o ritirasse dalla Transilvania, che fu accettata e dal Marsili fatta eseguire con l’effetto che il mondo sa, Esame di più ribelli fatti prigionieri, una Relazione militare della Transilvania con disegni a penna (c. 619-640), un’altra Tavola de’ passi ecc.;
a c. 669-686 una Raccolta della lingua che si praticava dalli Sciti abitanti della Siculiu ne* tempi antichi, scolpita in
2 4 0 MEMORIE INTORNO À L. F. MARSILI
un legno che esprimeva il calendario delle feste mobili per uso di quei primi convertiti alla fede cattolica, e da me dall’istesso legno raccolta e mandata al mio gabinetto in Italia, quando serravo li passi della Transilvania. 1
Il voi. 55, che contiene Manoscritti diversi fatti nel trattato della pace del 1691 sino al 1699 inclusive, ha a c. 292 una Mappa a colori della Moldavia, Transilvania, Servia, Bosnia, Sclavonia e Carabavialìlca.
Il voi. 57, che contiene Manoscritti diversi toccanti lo studio naturale di operazioni militari del 1693 sino al 1699, ha :
a c. 1-27 una Introduzione della linea geografica di commercio fra l’Asia ed Europa per l’Ongaria;
a c. 31-34 una Introduzione della pastura dell’Europa ed Asia e della Monarchia Austriaca in Germania ;
a c. 56-58 Memorie per il traffico ;a c. 65 Memoria della distanza de' paesi concorrenti al
commercio tra l’Europa e l’Asia;a c. 142-159 Probabile ac Morale Tertium Expediens ac
Moderameli Aulicum super stata Apaffy et Transylvania circa Apaffium ;
a c. 390-391 Memorie per l’attacco dell’assedio di Temesvar.
Il voi. 58, che contiene Diversi progetti di pace fra li due imperi Cesareo ed Ottomano et alleati cristiani ed il trattato di Carloioitz e varie lettere, ha
1 I caratteri di questo curioso monumento, dice il F r a t i (op. cit. pag. 52 n.), sono assai simili, ma non identici a quelli del Calendario in legno posseduto dal Museo Civico di Bologna, che fu illustrato da L u ig i F r a t i, D i un Calendario runico della Pontificia Università di Bologna, Bologna 1841, pag. VI-109 in-4 e V i l i tavole. Anche la forma materiale di questi due Calendari — l ’uno (quello del Museo) in otto tavolette rettangolari di bosso, scolpite in ambo i lati ; l'altro (quello descritto qui dal M arsili) in forma di bastone a quattro faccie — esclude qualsiasi identificazione. Comunque giova rilevare l'interesse non comune del monumento descritto dal Marsili, il quale di ogni faccia del Calendario diede la trascrizione, la traslitterazione e l ’ interpretazione dei nomi dei Santi e delle festività religiose, in latino. Sembra però che il Calendario visto dal Mai-sili non fosse, come l ’altro, figurato.
A. GIANOLA - L. F. MAKSIGLI E LA TRANSILVANIA 241
a c. 11-34 Descrizione geografica delie frontiere della sacra lega cantra l’imperio Ottomano e Progetto generale sopra i confini da stabilirsi alla medesima nella pace, con altro particolare su quei d’ambedue gVim perii ad uso de’ futuri trattati di pace;
a c. 35-58 Progetto del possibile commercio fra ambedue gl’imperi, diviso in tre parti ;
a c. 59-61 Scrittura per il traffico con VOttomano;
a c. 65-69 Pro eonstruenda vallationis linea in Syzemio et prò impositione confi ni uni inter H ungariatu et Transilvaniam ;
a c. 90-92 Pro pontibus struendis in terris limitaneis ;
a c. 94-95 Pro impositione confinium inter Ungariam et Transilvaniam animadversiones variae.
Il voi. 6/f, contenente Lettere del Consiglio di guerra ricevute nella divisione de’ confini di Transilvania, è di carte 691, e comprende:
1. Reacripta a Consilio Caesareo Aulae bellico (c. 1-25). Dal 14 sett. 1700 all’8 marzo 1701. Lettere originali n. 8 e una mappa delineata a penna;
2. Litterae a Generale Transylvaniae Commendante Comite Rabutin (c. 26-136). Dal 24 agosto 1700 al 27 marzo 1701. Lettere n. 411 ;
3. Epistolae a gubernio Transylvaniae (c. 137-150). Dal 12 sett. 1700 al 22 febbr. 1701. Lettere n. 6, datate da Alba Julia, e firmate Comes Georgius Banffi e Comes Nicola us Bethlen;
4. A Generalibus Leopoldo Schliek, Nehen et Glóckesberg (c. 151-224). Dal 21 ott. 1700 al 7 febbr. 1701, Lettere n. 32 2, un capitolo in terza rima e due sonetti;
5. A diversis magnatibus et nobilibus Transylvaniae (c. 225- 271). Dal 7 sett. 1700 all’l l febbr. 1701. Lettere n. 23, firmate: Stephanus Xalais, Nicolaus de Bethlen (2 lettere datate da Alba
1 A ltre lettere del Rabutin sono nel voi. 63 al n. 7 (carte 270-318) e si riferiscono alla divisione dei confini della Schiavonia e Croazia fatta precedentemente. V. anche sotto, voi 70, 1 e 2.
2 V. al voi. 70, 1 le risposte del Marsili.
18
242 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Julia l’8 ott. e il 20 die. 1700), Gabriel Josika, Johannes Sarofi ed altri;
6. A Commendantibus aliisque Officialibus germanicis (c. 272-524). Dal 30 ott. 1700 al 23 marzo 1701. Lettere n. 110, fìrm. : J. P. Costa, De Viard, Bernardo Visconti, Franz von Col- let, Ibraliim Bassà, De Tilff, Cari von Nirtenberg, Znoriza, J. Merauns, Rolber ed altri;
7. A variis statibus, senatibus et sedibus (c. 506-591). Dal 24 ag. 1700 al 15 genn. 1701. Lettere n. 7 fìrm. : Blasius Csulay, Edler von Jarbemerk ed altri;
8. .1 variis Commissariis aliisque Camerae officialibus (c. 522-574). Dal 24 ag. 1700 al 19 marzo 1701. Lettere n. 25, firm. : Gio. Benedetto Cavazzani1 ed altri ;
9. .4 diversis Commissionis confiniariae Officialibus (c. 575- 601). DalD 20 ott. 1700 al 13 genn. 1701. Lettere n. 12, firm. : Von Hollstein, Ehrmann, J. B. Kayser, Lucas Jagelsky, Niccolò Guicciardini ed altri ;
10. Epistolae a Camerae Praefecto Chilko (c. 602-653). Dal 22 ag. 1700 al 18 marzo 1701. Lettere n. 22;
11. Litterae Qermanicae ab Jbrahim Bassà, Jbrahim Effendi et interprete Osman Agà (c. 654-688). Dall’8 die. 1700 al 19 marzo 1701.
Il voi. 65, che contiene Lettere turche, con la traduzione, in Commissione de' confini, chiuse in otto fascicoli, ha anche
nel fase. I una Specificazione delli luoghi dove, a Dio piacendo, la primavera per la terminazione dei limiti fra Temesvar e la TransUvania si hanno da mettere li dieci cumuli',
e nei fase. V I e V II venti lettere originali di Ahmed Pascià, comandante di Temesvar, al Marsili, dal 19 maggio 1700 al 13 gennaio 1701.
Il voi. 66 contiene i Diaria geographica in itinere liinitaneo collecta.... in tres libros digesta: interessano la Transilvania i Diaria transdanubialia contenuti nel terzo libro (parte seconda).
1 Cfr. al voi. 70 n. 13.
A. GIAN0LA - L. F. MARSIGLI E LA TRANSILVANIA 243
Il volume 70 è una Miscellanea per la Commissione dei confini, e contiene 14 fascicoli di carte sciolte. Si riferiscono alla Transilvania i seguenti:
1. Minute di 16 lettere scritte a più comandanti ed anche ministri nel tempo della Commissione de’ confini di Transilvania, dall’agosto 1700 alla fine di febbraio 1701. Sono indirizzate al Generale Rabutin, al Generale Schlick, al Generale Glficke- sberg e al Comandante d’Arath ;
2. Atti transilvani, con varie lettere turche e loro traduzioni. Sono 19 documenti e 30 lettere, scritte dal 10 gennaio al 29 luglio 1700, firmate Rabutin, Ahmed Passà, Jusuf Pascià, Vi- cinus, Allì Passà, Huszain ;
3. Lettere 12 italiane, scritte daU'Ibrahim Effendi Capigi Bassà per mano del suo interprete Hassan Gelebì;
4. Protocollo di lettere del Sig. L. F. Morsili mentre agi la parte di Commissario plenipotenziario della Maestà dell’im peratore, deputato a separare i confini del di lui Imperio con
l’ottomano, in vigore della pace di Carloviz (4 apr. 1699-18 settembre 1700);
5. Lettere 11 scritte a diversi per l’affare della Commissione (26 luglio-1 nov. 1699). Sono dirette ad Ibrahim Effendi, a Tenterdar Effendi, al Co. Antonio Coronini e ad altri;
6. Contenuto delle scritture che stanno sotto il titolo di « Miscellanea » ;
7. Index conceptuum lineae tempore Transdanubialis (ago- sto-30 ott. 1700) ;
8. Index conceptuum lineae tempore Cisdanubialis (mar- zo-nov. 1700);
10. Epitome della ribellione dell’Ungheria con annesso il Prodromo del protocollo de’ moderni confini cesarei-ottomani. Da confrontare coi voi. n. 19; 28,1; 117;
11. Declaratio, demolitiones et evacuationes locorum limi- taneorum concernens. Actum in castris prope Costanizam 25 Julii 1700. In forma authentica;
244 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
13. Lettere 8 ricevute dal Co. L. F. Morsili in marzo 1701 e seguenti dalla Porta di Transilvania al Campo di Ferdinando
e sono scritte di Curansebes da Gio. Benedetto Gavazzi dalli 10 marzo alli 10 ag. 1701;
14. Lettere 9 del Co. L. F. Mar sili alli Bassa di Belgrado e
di Temesvar ed all’Ibrahim Effendi, dalli 2 sett. 1700 a’ 17 genn. 1701.
Il voi. 81, che è una Miscellanea, contiene: a c. 34-46 un Progetto per la campagna dell'anno 1697 a
S. E. il Co. di Staremberg;e a c. 97 una Tavola sinottica dello stato temporale ed ec
clesiastico del Regno d’Ungheria e delle sue dipendenze.
Il voi. 88, che è pure una Miscellanea rerum naturalium, nel fase. F al n. 4 contiene un Discorso sulla miniera del sale in
Transilvania e del fonte igneo in detta provincia, autografo del 1690.
11 voi. 100, di Observationes astronomicae, contiene nel primo fascicolo Observationes astronomicae Hungarioae, habitae a Comite L. F. Morsili in castri# H ungarici» anno 1696, circa
solem, lunam, planetas ac stellas fi,ras, cum figuris. Di c. 44 con molte tavole a matita.
Il voi. 101 è una Miscellanea antiquitatum variarum, e nel fascicolo A ( Antiquitates romanae circa Danubiani) sotto il n. 2 contiene Antiquitates in itinere limitáneo collectae, con 7 tavole a penna, 5 a colori, 15 a matita e molte antiche iscrizioni.
Il voi. 103, che contiene Documenta rerum croa tica rum et Transylvanicarum in Commissione limitáneo collecta, comprende opere manoscritte e a stampa, di autori e in lingue diverse. Fra gli altri:
a c. 323-387: Notitia Transylvaniae, di mani diverse;
a c. 389 : Ritratti e stemmi dei principi di Transilvania e
dei giudici della nazione Sassone, dall’anno 1522 al 1697. Fascicolo di 51. pag. con 66 tavole delineate a penna e acquerellate;
A. GIAN OLA - L. F. MARSIGLI E LA TRANSILVANIA 245
a c. 396-489: Davidis Rosnai, Constantinopoli interpreti», Res tragieae gestae in plagis orientalibus, occidentalibus, me- ridionalibus, septentrionalibus a diebus Ferdinandi I Imp. et Sultani Bajezid, usque ad Leopoldum I et Mehemed IV Impe- ratorem, anno 1674, in latinum versae anno 1701 Co. L. F. Mar- sili porrectae. Con script io districtuum, idest Divisio nonnul- lorum districtuum Transylvaniae, Servine, Bulgaria-e et Hun~ gariae.
Il voi. 104 consta di diversi Catalogi mineralium. Il catalogo n. 5 è delle varie sorti di Miniere osservate nell’inverno del 1695 nelli comitati Gemeriense maggiore e minore, Hundense e Sapusiense; e il n. 6 è un Catalogo generale di tutti i minerali mandati in più volte dal Co. L. F. Marsili (20 giugno 1698).
Il voi. 117 contiene il Primo abbozzo del Compendio storico dell’Ungheria, per servire d’ introduzione al trattato « Acta executionis pacis » fatto dal Generale Co. Marsili. È di 122 pag. in-4, 30X21. Si confrontino con esso i voi. 19, 28,1 e 70,10.
Con la segnatura A. M. C. I. 5 c’è anche, nella stessa Biblioteca dell’Università, una bella Raccolta marsiliana di Mappe geografiche di varii tempi ed autori. Fra esse notiamo i numeri
1. Mappa della Transilvania e Provincie contigue, nella quale si vedono li confini dell’Ongaria e li campamenti fatti dall’Armate Cesaree in quelle ultime guerre, dedicata all’A. R. Maestà di Gioseppe I Re de’ Romani e d’Ongaria da Gio. M orando Visconti, sup.mo Ingegniere per S. M. Cesarea in Transilvania. In Hermanstadt, an. 1699. - Stephanus Welzer de Corona fecit;
3. Pianta dell’Ungheria, colorita a mano, con cinque stemmi a colori;
13. Nova et accurata totius superioris inferiorisque maxi- mae partis Regni Hungariae descriptio. Anno 1682. Corneo fecit;
22. Novissima et accuratissima totius Regni Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Bosniae, Serviae, Transylvaniae cum adiacentibus Regnis et provmciis tabula, auctore ■fa- cobo Sandrart;
246 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARS ILI
23. Le Royaume de Hongrie et les Etats.... qui font presentemente la partie septentrionale de la Turquie en Europe.... Par le S.r Sanson, géogr. ord. du Roy.
Infine i rotuli n. 27, 29 e 32 contengono: Mappa geographha utriusque Impervi (Jaeswrei et Ottonumhi (3 carte delineate a pernia), Mappa limitropha Austriaci et Turchi 1 inperii, e Mappa geographico-Umitanea Imperii Austriaci et Ottomanici, an. 1099.
4. I l M ars l l I e la TransllYanla.
Dalla semplice elencazione di tutti questi documenti, a cui si debbono aggiungere particolari spiccioli sparsi qua e là un po’ dovunque negli altri volumi, risulta chiaro quale messe di notizie e di dati abbia raccolta lo stesso Marsili e quale ricchezza d’informazioni possano trarne gli studiosi per la conoscenza della topografia, delle risorse naturali, della storia civile e politica della Transilvania e regioni contermini1.
Dal 1687 al 1701 il nostro Conte fu in Transilvania più volte, e per lunghi periodi, vuoi come ufficiale comandato dall ’ imperatore Leopoldo o dai suoi Marescialli di campo a più o meno importanti imprese militari (assedi, ricognizioni, opere di fortificazione, lavori stradali, costruzioni di ponti e simili), vuoi come commissario delegato con pieni poteri dall’imperatore medesimo allo svolgimento delle trattative di pace coll’impero Ottomano e alla delimitazione dei confini fra i due Imperi, tanto nel 1691 quanto dopo la conchiusione della pace di Carlowitz (1699). I documenti stessi sono dunque essenziali per la storia di questo periodo. E poiché di tutte le vicende della sua vita, infaticabilmente dedita così alle opere della guerra come alle ricerche scientifiche, il Marsili stesso ci ha lasciato memorie particolareggiate fino all’anno 1711, così è evidente che
1 La dott. M. E. A m a ld i ue ha infatti ricavato ottimo partito, scrivendo un diligentissimo e minuzioso lavoro (in corso di pubblicazione nella R ivista « L'Europa Orientale » , voi. V I I , pag. 193 e seg.), che mi è stato segnalato, quando la presente nota era già stesa, dalla cortesia del prof. Carlo Tagliavin i di Bologna, titolare della cattedra di lingua e letteratura romena presso l ’Università di Budapest.
A. GIANOLA - L. F. MARSIGLI E LA TRANSILVANIA 247
anche la lettura di questo volume autobiografico tuttora inedito 1 deve essere fatta con particolare diligenza da chi voglia precisare i rapporti del Marsili con la Transilvania e inquadrare nei giusti termini cronologici e in un’esatta valutazione storica tutti i predetti documenti.
Fra i quali, dal punto di vista strettamente storico-militare, sono in particolare notevoli il Compendio della ribellione d 'Ungheria (voi./9, 117, 28,1 e 70,10) e la Relazione militare della Transilvania contenuta nel voi. 51f (c. 619-640). In tali scritti— di carattere ufficiale — quello che, per gli Ungheresi e particolarmente per i Transilvani, fu, sotto la guida del Conte Etne- rico Thòkòly (1657-1705), un tentativo di indipendenza e di riscossa dal dominio degli Absburgo appoggiandosi alla potenza e forza militare dei Turchi, non poteva evidentemente essere sentito e prospettato come tale da un nobile, suddito della Santa Sede e cattolico ferventissimo, che, servo fedele dell’imperatore e da lui insignito d’un alto grado militare, scriveva, in rapporti diretti a S. M. Imperiale, intorno a sudditi ribelli, alleati degli Ottomani, nemici dell’impero e della Cristianità. 2 Ciò non di meno, così nelle linee generali come nei particolari aneddotici, le scritture di questo attento ed esatto osservatore sono documenti storici di singolare importanza e valore.
A parte dunque il punto di vista necessariamente unilaterale sotto cui egli ha osservata, studiata e narrata la storia della ribellione transilvana, sta di fatto che il Marsili ha consi
1 E ’ il volume segnato col n. 145 : Autobiografia del Co. L. F. Marsili, dalla nascita a ll’anno 1111. Scritta da mani diverse, con correzioni, consta di due tomi, d i carte 179 e 123. D i queste sono autografe solo le carte 116-123 del secondo tomo, che comprendono g li anni 1710 e 1711. V i è pure unita una tavola incisa dei trinceramenti dell’armata imperiale sotto Petervaradino, comandata dal Maresciallo Co. Caprara, i l 2 ottóbre 1694-
2 Da analogo punto di vista e con eguali sentimenti giudicarono e narrarono i particolari d i questa « ribellione », uno storico veneto e un poeta toscano contemporanei. I l primo è il senatore P ie tk o G a r z o n i, autore di una Istoria della Repubblica di Venezia in tempo della sacra Lega contra Maometto IV e tre suoi successori, gran Sultani de’ Turchi (Venezia, Manfrè, 1707), e il secondo è F ederigo N o m i , autore del poema eroico Buda Liberata (Venezia, Albricei, 1702).
248 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
derata questa regione come una unità geografico-storica a sè, nei riguardi non pure dell’impero absburgico, ma della stessa Ungheria e del Banato di Temesvàr, con cui confinava ad occidente e a sud-ovest.1
Ora, a questa individualità geografica della Transilvania, delimitata da suoi confini ben distinti, corrispondeva anche una sua propria individualità etnica? Non possiamo in verità affermarlo, anche se in essa aveva il predominio, sulla varietà delle sue nazioni, la nazione ungherese. Di ciò è testimonianza nel voi. 15, dove il Marsili ad un elenco delle « sette » nazionalità conviventi nella regione — ungara, sassone, valacca o rumena, greca, armena, anabattista e zingara — fa seguire, per ciascuna di esse, un quadro che ne mostra sommariamente la distribuzione corografica, la lingua, la religione, gl’impieghi ed occupazioni manuali, e, per mezzo di figure finemente colorate, le fogge di vestire degli uomini e delle donne.
Secondo tale elencazione, la prima e pili importante delle sette nazionalità è Yungherese, distinta in ungara vera, che abita le parti inferiori e piane della Transilvania, ed ungara Sicilia, che abita la parte montuosa, detta Siculia (Székelyfòld). Entrambe di lingua ungherese, diversificandosi nell’accento ed in alcune parole scite conservatesi tuttavia fra i Siculi (Széke- lyek); entrambe di religione cattolica o calvinista o ariana; entrambe di impieghi militari, politici e giudiziarii, per effetto dei quali questa nazione governa e comanda a tutte le altre. Il Marsili, dunque, non solo riconosce qui esplicitamente la preminenza degli Ungheresi in Transilvania, ma fissa, fra Ungheresi veri e proprii e Siculi, le differenze, consistenti in diversità di sedi e di lingua, avendo quella de’ Siculi diverso accento, ossia pronunzia, e conservando nel proprio lessico alcune parole scite, che fra gli altri ungheresi, benché anch’essi discendenti dagli antichi Sciti, non si riscontrano. Al qual proposito non sarà inutile aggiungere che dalla derivazione dei Magiari tutti dagli Sciti— la quale, in conformità delle cognizioni scien
1 Si veda, per es. al voi. 28 n. 2, la carta separata della Transilvania.
A. GIANOLA - L. F. MARSIGLI E LA TRANSILVANIA 249
tifiche del suo tempo, è data per vera dal Marsili — questi faceva discendere non pure questi residui scitici nella lingua dei Siculi (cfr. voi. 54, pag. 669-686), ma altresì alcune delle caratteristiche della razza magiara, come la grandezza dell’animo, l’amore per l’indipendenza e per la gloria, lo spirito bellicoso, l’eccellenza nel cavalcare, l’individualismo e simili, di cui il nostro autore fa cenno in più luoghi, e specialmente in quel magnifico elogio della razza ungherese con cui si inizia YEpitome historicum. 1
Seconda, in ordine d’importanza, viene la nazione sassone, divisa in civile — perchè abita le più belle città della Transil- vania, non ammettendo che si stabilisca in esse altra nazione — e rusticana, perchè abita i villaggi d’alcuni distretti assegnati ad essa col nome di sede 2. Ambedue di lingua tedesca con ac
1 Epitome historicum etc. voi. 19 ( = Prim o abbozzo ecc. del voi. 117) : «.... Et quidem nulla in Europa N atio retinet adhuc reliquias vetusti Scytharum sanguì[n i]s praeter Hungaricam, genus nimirum eorum Hun- norum, qui Attila duce totam Europam late pervaserant, sobolemque de se in Pannoniis reliquerant. Quod quidem certi quidam ritus, quos numerare longum esset, maxime vero lingua ipsa hungarica testatur. Haec eadem itaque gens ad occupandas easdein, quas maiores sui olim tenue- ian t Pannonias rediere, se seque illis paucis iunxere, qui adhuc ex codem sanguine supererant, ac per summa Daciae montium cacumina vaga- bantur.... Cutn ig itu r Hungariae incolae a Scytharum stirpe profiscantur, minime mirum est, si ad hanc nostram memoriam ingentes spiritus gerani. Eorum siquidem genus gloriosum aeque ac facinora gloriosa fuisse constat, quippe quae victoriis illustrata sint. Ea demum valuit apud Hun- garos disciplina, ut Regis imperata facerent, legesque una cum Rege ve- luti Regni libera membra servarent. Libertatis amor exacuit hebetiora quoque ingenia, multo magis erectas ac per se claras indoles excitat, atque inflammat. Quippe Hungari suopte ingenio novarum rerum et glo- riae cupidi, libertatis tenaces, dignitatibus quae suffragiis deferuntur, atque adeo regiis fascibus velificari pulcherrimum arbitrabantur. Quibus certe moribus necesse fuit, ut flnitimis essent iniurii atque molesti, sibi vero etiam ad ampliores victorias tandem aliquando impedimento essent. Verum enimvero sicuti Nationis omnis natura atque ingenium et ex eiusdem sanguine constat et caelo regionum effingitur, et instituitur edu- catione, quam a parentibus quisque nostrum hausit et expressit, Ita piane difficile atque asperam factu est ipsam naturam mutare atque refingere.
2 Le « sedi » transilvane corrispondevano ai « Comitati » delle altre parti dell’Ungheria, come attesta lo stesso ila rs ili ne\V E pitome : « Postrema divisio inter sedes et comitatus esse dicitur, sed re eadem est, ac prior,
250 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
cento duro e più barbarismi; ambedue di religione luterana e, quanto agli impieghi, artefici, trafficanti, giudiziarii (per giudicare la propria nazione), rusticani, assidui nel lavoro, avidi nel guadagno, diligenti nella coltura. Anche per i Sassoni, dunque, il Marsili nota la differenza fra gli abitanti delle città e della campagna, quelli gelosi di non lasciar penetrare in niezzo ad essi nuclei, più che membri, d’altra nazionalità, e dediti alla mercatura e a mestieri manuali, e questi raccolti in propri villaggi e dediti all’agricoltura ; gli uni e gli altri assidui nel lavoro e parsimoniosi, tenaci nel conservare la propria lingua (tedesca), pur inquinata da neologismi stranieri, e la propria religione (luterana), e amministranti la giustizia con proprii giudici.
Terza è la nazione valacca, che non ha suddivisioni, ma è suddita anzi schiava, eppure gloriosa del nome tuttavia di romana (con la parola corrotta di Romegn), con lingua propria (valacca), da questa chiamata romagnesta, non essendo che un latino ed italiano corrotto ', con religione greco-scismatica, con impieghi « rusticali (particolarmente la pastorizia), assassine- schi2, abitando per lo più nell’Alpi che cingono la Transilva- nia, dove le selve servono non meno ai molti armenti che malvagità loro ».
Quarta è la nazione greca, che, senza alcuna divisione, nativa per lo più dell’Acaia e forestiera, abita nelle città dei Sassoni, di lingua greca illirica, di religione greca scismatica,
cuui respondeat tot territoriis, in quae distributum fuit Regnimi ad pu- blica iudiciarii regiminis commoda : nomen vero scdis in Transylvania tantummodo usuryatur ».
1 Oltre a particolari elenchi di nomi geografici in latino, ungherese e valacco (rumeno) che il Marsili compose o fece comporre per proprio uso, esiste anche fra i mss. marsiliani un Lexicon latin uni, vallachicum et H u ngaricvm ; opera incompiuta che forma il voi. 116. Di esso è stata fatta recentemente la pubblicazione integrale a cura del Prof. C ab lo T a
g l ia v in i , il quale in un ampio studio preliminare ne mette in rilievo l ’altissima importanza.
* Come è noto, assassino fu in origine il nome di una setta d'ismaelit i musulmani che s’inebriava di hascisc, sotto un capo detto il Vecchio della Montagna, e giurava di commettere qualunque omicidio ; onde poi
A. GIANOLA - L. F. MARSIGLI E LA TRANSILVANIA 251
esclusivamente dedita alle arti tessili, o, come dice il Marsili, alla « trevatura di pelanci, tappeti e tele di bambocc ». Essi hanno una particolare compagnia governata da loro che eleggono il giudice.
Quinta è la nazione armena ; ma di questa manca nel volume il prospetto relativo, e le pagine ad esso destinate sono bianche. Segno che su di essi il Marsili, amante della esattezza e delle notizie bene accertate, o era ancora malsicuro o non aveva ancora raccolto dati sufficienti a individuarli nella loro specifica etnicità. Sugli Armeni il nostro autore parla tuttavia in più luoghi del voi. 52.
Sesta è la nazione anabattista, che costituisce una piccola parte della popolazione della Transilvania, dove passò dalla Germania, per opera del Principe Ràkoczi, che ne fissò la sede a Yinz. Di lingua tedesca, meno corrotta di quella usata dai Sassoni, di religione anabattista « dolendosi questi che assai perda del suo rito della comune vita », dediti all’arte figulina (vasai) e all’arte cultraria (coltelli ecc.), con le quali vivono ed anche lavorano con molta pulizia.1 È curioso che il Marsili abbia
il nome passò atl indicare chiunque ammazza a tradimento, per odio o per vendetta o per scopo di rapina. Che fra i Romeni di Transilvania molti fossero dediti al malandrinaggio non può far meraviglia, se si pensi alle condizioni generali del tempo e a quelle particolari dei valacchi, ridotti un po’ in tutto il territorio transilvano, come rileva lo stesso Marsili, in istato di soggezione anzi di schiavitù politica ed economica. Del resto nella stessa pianura ungherese (A lfo ld ) c’è stato per lunghi secoli i l brigantaggio del szegény legények e dei betyàrak, di cui la eco è ancor così v iva nel canzoniere del Petofi e nella poesia popolare magiara.
1 S ig is m o n d o B A t k i , nei suo studio su le Condizioni etnografiche del- VVngheria (nel volume Ungheria, edito d&ll’Istit. per l ’Europa Orient. a Roma nel 1929, pag. 45-77), dice, a proposito delle stoviglie in uso fra i contadini magiari : « Fra questi si trovano ancora oggidì molti bellissimi pezzi originali di disegno finissimo con smaltatura di stagno; essi sono avanzi d i una piccola industria ormai decaduta, e vengono gelosamente custoditi dalle donne, specialmente nella Transilvania, dove questo genere di ceramica rimonta ai prim i anni del sec. X V II, quando cioè uno dei principi ungheresi della Transilvania accolse nel paese una parte degli anabattisti tedeschi espulsi dal T iro lo meridionale e ricoveratisi prima
252 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
fatto di questi tedeschi, passati in Transilvania assai tempo dopo i Sassoni, una nazione distinta. Ma in verità essi non potevano confondersi con questi, perchè non erano originarii della Sassonia, e perchè li distinguevano dai Sassoni la diversità della lingua (un tedesco meno imbastardito), della religione (quelli luterani e questi anabattisti), delle sedi e delle professioni, e il fatto che essi non potevano neppure considerarsi come un gruppo etnico avente una propria individualità sociale, se non politica, dal momento che non avevano, come i Sassoni ed i Greci, giudici proprii, ma erano soggetti agli ordinari giudici ungheresi della Transilvania.
Settima ed ultima è la nazione zingara, che abita in piccole casucce nei sobborghi delle città, di lingua valacca la più parte, ed alcuni di lingua sassone, di religione scismatica greca, dediti alla raccolta dell’oro nell’arena di alcuni fiumi e a «fare il foco » (cioè alla fusione dei metalli?). La raccolta dell’oro li fa ricchi, e per verità non vi è alcun luogo dove gli1 zingari siano pili puliti di qui. È evidente pertanto che essi, venuti dall’oriente e dal sud nella Transilvania, forse attratti dal miraggio dell’oro, alla cui ricerca nelle sabbie dei fiumi il Marsili li trova particolarmente occupati al tempo suo, pur conservando la religione greco-scismatica da loro abbracciata nella precedente dimora in altre regioni balcaniche, avevano anche una scarsa vitalità nazionale o, per lo meno, un grande spirito di adattabilità aH’ambiente, se parlavano la lingua valacca e, alcuni, persino la sassone : l’una e l’altra però non dovevano essere le uniche da essi parlate, ma quelle di cui si servivano nei loro rapporti con la popolazione dei paesi d’immigrazione, mentre fra loro dovettero continuare ad usare il loro caratteristico gergo, incomprensibile per gli estranei alla loro razza girovaga.
nell’alta Ungheria, fra i quali si trovavano molti esperti stovigliai. Considerando il loro paese d'origine, si può capire facilmente che i loro prodotti coloriti rivelino a prima vista l ’influsso italiano. La loro tecnica speciale, detta neo-cristiana, elevò poi in generale a un livello più alto l ’antica arte ceramica — più semplice — della Transilvania, la quale oggidì è di nuovo decaduta, ecc. ».
A. DIANOLA - L. F. M ARSIGLI E LA TRANSILVANIA 253
Sette nazionalità dunque, coesistenti e frammiste nel medesimo territorio, con lingue, religioni, occupazioni, giudici e perfino fogge di vestire diverse, non ci autorizzano a sostenere la unità etnica della Transilvania. E si noti che il Marsili non fa neppur cenno, nella sua elencazione schematica, ma precisa, della nazione ebrea, che pure doveva già avere suoi rappresentanti — forse ancora numericamente assai scarsi — in Transilvania, come nelle altre regioni dell’Europa orientale.1
Questo breve ma interessante studio d’insieme, a cui accrescono pregio le illustrazioni colorate che lo accompagnano, non fu preparato o fatto preparare dal Marsili, come i precedenti, per determinati scopi ufficiali, ma evidentemente per soddisfare a quella curiosità scientifica, che lo spingeva a rendersi conto di tutto in modo chiaro e sintetico, un po’ per le abitudini d’osservazione contratte durante i suoi studi e la sua preparazione universitaria, un po’ per il bisogno d’informazioni esatte e positive proprio di chi esercita la professione delle armi con funzioni di comando e di rigorosa responsabilità.
Ad analogo impulso sono dovuti gli altri scritti, suoi o di altri, e le notizie da lui raccolte e ordinate su particolari argomenti, che non si connettessero con le sue mansioni e con le necessità militari del momento. Tali, per esempio, le ricerche sui funghi, o quelle sulle miniere e sulle acque minerali, sulla fiora e sulla fauna, o intorno alle famiglie nobili, alle circoscrizioni ecclesiastiche della Transilvania, e via dicendo, accompagnate— sempre che fosse utile o necessario — dal relativo corredo di illustrazioni figurate, non prive, talvolta, di pregi anche artistici, e sempre di un alto valore scientifico, per la immediatezza delle fonti e per la esattezza e precisione con cui molte sono condotte e rifinite: sicché chi voglia rendersi conto delle condizioni della Transilvania sulla fine del secolo XVII non potrebbe prescindere dal conoscerle e studiarle, senza privarsi
1 Sullo stato degli Ebrei in Levante 11 Marsili dà notizie nel voi. 52 a carte 617-640.
254 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
con ciò di un materiale documentario di prim’ ordine. Come non potrebbe esimersi dalla loro piena conoscenza lo storico, che volesse fare la narrazione particolareggiata degli eventi militari e politici di quel periodo così importante, o il geografo, che, curioso di conoscere la configurazione oro-idrografica della Transilvania o la storia della cartografia ad essa relativa, volesse avere sotto gli occhi un materiale cartografico vario, ricco, inedito e, quasi tutto, di prima mano. Chè mi par difficile possa trovarsi in raccolte anche pubbliche, quali possono esistere, per esempio, nei Musei, negli Archivi e nelle Biblioteche di Budapest o di Vienna, così copiosa dovizia di mappe, disegni, schizzi — o minuziosamente curati o gettati giù in fretta e alla brava — intorno alla regione transilvana, quanta ne contiene il carteggio del Marsili. E così dteasi dell’epistolario e dei numerosi documenti ufficiali, il cui insieme va senz’altro annoverato fra le « fonti storiche », a complemento di quanto esiste negli Archivi di Stato, già noto più o meno agli studiosi della storia ungherese.
5. Conclusione.
Questo brevissimo cenno sintetico, che, per ragioni di economia, ho concentrato sulla sola Transilvania, lascia comprendere di quanto interesse sia tutto il rimanente materiale, che riguarda non pur l’Ungheria, ma molte altre regioni dell’Europa carpatico-danubiana in ispecie, la Turchia, la Jugoslavia, la Dalmazia, nonché la Svizzera, l’Italia, la Francia meridionale, l’Olanda, tutti i paesi insomma che il Marsili vide e visitò più o meno a lungo; sì che a commemorare il centenario di così illustre scienziato dovrebbero trovarsi uniti i rappresentanti di quasi ogni paese dell’Europa.
Ma, per limitarci ancora alla nazione ungarica, noi esprimiamo, più che il desiderio o la speranza, la certezza che il Governo e i Corpi scientifici dell’Ungheria — come già fanno numerosi ricercatori italiani — vorranno e sapranno togliere in-
teramente dall’immeritato oblio in cui tuttora giacciono per la maggior parte, per farli conoscere alla grande massa degli studiosi, documenti così preziosi e originali della storia e della civiltà magiara, dovuti all’amore e alla diligenza indagatrice di questo grande italiano, degno di essere annoverato fra i primissimi nella secolare, ininterrotta, ricchissima storia dei rapporti culturali italo-ungheresi.
D o tt. A lb e r t o G ia n o l a L ettore d’italiano presso l’TJniversità di Szeged.
A. GIANOLA - L. F. MARSIGLI K LA TRANSILVANIA 25&
Idee precorritrici (li Luigi Ferdinando Marnili h u la struttura dei monti.
Fra tutte degnissima di essere onorata dall’ Italia nuova, per intensità ed altezza mai sminuita di pensiero e di azione, la figura di Luigi Ferdinando Marsili si delinea sempre più fulgida a misura che i cultori delle più varie discipline vengono meglio esplorando la miniera incredibilmente doviziosa dei manoscritti Marsiliani. Non vi è forse esempio, nella storia delle scienze, di un capo di eserciti, ed uomo politico insieme, che queste attività abbia più largamente sposate a indagini multiformi e profonde su le scienze militari, geografiche e storiche da un lato, su le scienze naturali dall’altro.
Scienze naturali in largo senso; e in quella invidiabile visione d’insieme che tutti i nostri sommi hanno avuto, e che troppi oggi riguardano come un ostacolo, invece che un aiuto, a ricerche feconde — come se l’ala del pensiero fosse destinata ad afflosciarsi, piuttosto che irrobustirsi, in un più libero ed ampio spazio di volo. E come tutti i grandi naturalisti italiani, il libero volo condusse anche Marsili ai problemi della Terra, che nei viaggi e nelle soste in tante e tanto diverse contrade gli avevano a più riprese tentato la mente.
Non intendo qui di soffermarmi sulle indagini minerarie, abbondanti anche nei manoscritti inediti, e che per numero e varietà, come per diligenza di rappresentazione e sagacia di ricerca, pongono l’autore in degnissima luce. Nè è il caso di far qui una disamina delle osservazioni, pur ricche d’interesse geologico e morfologico, che si possono trarre dalla grande opera sul Danubio e paesi danubiali : e neppure di attingere all’opera, pel suo tempo mirabile, che può considerarsi il primo trattato
19
258 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
di oceanografia e nel quale sono profuse tante osservazioni nuove d’interesse anche geologico diretto o indiretto.
Molte note, più o meno estese e relative a svariati argomenti geologici, a noi rendono prezioso sopra tutto il volume 90° dei manoscritti Marsiliani conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna, volume che ha per titolo generale « Schedae prò structura orbis terraquei ». Ho scelto, fra esse, quelle che meglio possono giovare a illustrarci le idee del nostro autore intorno ad alcune questioni di geologia generale, a cui il suo pensiero tornava con particolare insistenza.
Da un secolo Ulisse Aldrovandi aveva creato il nome della scienza della Terra. Superati, per virtù precipua degli intelletti nostri, i pregiudizi contro la pertinenza dei fossili a organismi realmente vissuti, le menti dei ricercatori si acquetavano ormai alla spiegazione riconducente la loro origine al diluvio universale. Non se ne occupò ex professo il Marsili; ma tuttavia il suo va posto accanto al nome del Ciampini — primo a riconoscere e dimostrare l’esistenza di elefanti fossili (1688) — per gli avanzi notevoli di Elephas prirnigemus da lui scoperti nelle paludi vicine al Danubio, accuratamente figurati negli acquerelli inediti del mscr. 4-17, ed esattamente individuati e descritti nel Danubius Pannonico-Mysìcus *. La mente del Generale, in armonia con la sua febbrile attività, non poteva per altro indugiarsi in raccolte paleontologiche, a quei tempi necessariamente sterili di risultati scientifici immediati. E assai più egli veniva arricchendo il museo dell’istituto di Bologna con minerali e rocce (sciaguratamente perduti in sèguito), e con serie di acquerelli tratti dal vero sotto la sua direzione.
Uscito nel 1669 il libretto mirabile di Nicola Stenone, il Marsili ne trasse vital nutrimento. I lunghi viaggi lo inducevano naturalmente a fare osservazioni comparate e a seguire con interesse le dislocazioni subite dagli strati sedimentari e rese evidenti dagli spaccati naturali.
Nel verso del foglio 41, cartella G, del mscr. 90, vi è una sua nota che merita di essere integralmente trascritta.
1 Cfr. C a p e l l i n i G., Elefanti fossili nel R. Museo Geologico di Bologna, parte I I . Mem. R. Acc. Se. d. Ist. di Bologna, (V I I ) I I I , 1916, p. 63.
« Della strotura delli Monti ».
« La strotura de’ Monti, che in tanti viaggi ho osservata, la riduco a tre principali. Tutto d'un sasso unito, di ruvine irre-
M. G0RTANI - LA STRUTTURA DEI MONTI 259
golari, e di strati. La prima non admette alcuna subdivisione; la seconda, che si vedde nell’accumine dell’alpi travagliata da
260 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
venti, da liquefationi delle nevi, e pioggie, non può essere ordinatamente distinta, che in solchi, che si fanno dall’aque, che dal cacumine al piede defluiscono perpendicolarmente quasi al centro, e spostano, e rompono la loro naturale strutura. La terza delli strati, per la diversità de’ medemi a riguardo delle diverse linee, che questi tengono, e varie posizioni loro, è capace delle seguenti divisioni. Le linee sono, ò rette, ò circolari, ò iregolari serpegianti. Le rette sono ò paralelle, ò oblique, ò perpendicolari all’Orizonte. Le circolari sono approssimanti al perpendicolare, ed oblique all’Orizonte. L ’irregolari non sono, che a serpi.
Tutte quasi queste sorti di strati si veddono lungo del lago d’ Uri, e molti altri passandosi S. Gottardo » 1.
1 Per meglio chiarire il pensiero del Marsili, credo opportuno di trascrivere qui le diciture apposte ai singoli schizzi schematici della figura (v. pag. preced.), conservando il medesimo ordine di disposizione:
L i S t iv in e irrego lari Tutto d’un sasso. Tutto di strati,che (sono-) nella su- mità dell’ A lpi.
S tra t i d i lin e e re te perpendicolari.
Strati di L inee rette perpend ico lari (sic) a ll’ Orizonte. Appresso del lago di Zug.
Strati di L inee parale lle a ll’ Ori(zonte).
L inee circolari inclinate a ll’ orizonte. Appresso del la g o d’ Uri.
L inee circolari quasi p e rp en d ico la r i al- l ’ Ori (zonte). A p p resso del lago di Lugano.
Strati di linee serpegianti.A p p resso del lago d’ Uri.
Strati meniali esatis- simi.Appresso del la g o d 'Uri come sono anche le colonine appresso di Stucardo
nel Virtemberg.
«M e n ia l i » chiama l ’autore (da moenia) gli strati regolari la cui disposizione ricorda quella delle opere murarie.
Questo sviluppo meditato dei concetti di Stenone sulla disposizione degli strati, non è che un appunto per trattare l’argomento in modo più ampio. Appunto steso in fretta, come risulta dalla figura cancellata (l’ultima della seconda fila orizzontale) e dalla non corretta dicitura apposta alla figura precedente, dove, per lapsus calami, « perpendicolari » sta invece di « olblique ». Ma ad esso si riferiscono osservazioni di cui il Marsili ci ha fortunatamente lasciati documenti magnifici, negli acquerelli che oggi compongono parte del medesimo gruppo C del mscr. 90. Le tavole 71 a 82 di tale raccolta, eseguite a colori nel formato di cm. 23 per 35, e alcune delle successive, si possono definire come una serie di figure, istruttiva anche oggi, per illustrare i principi fondamentali della tettonica in base a sezioni naturali fedelmente riprodotte: strati orizzontali, inclinati, verticali; pieghe dolci o variamente compresse, diritte o rovesciate; grovigli di pieghe in complessi di strati fortemente contorti (vedine alcuni riprodotti nelle Tav. I - I I I e V). Esempi tratti in maggior numero dalle sponde del lago dei Quattro Cantoni, ma in parte anche da altri distretti alpini, dal Württemberg, dalla Liguria, dall’Appennino bolognese. E, oltre a queste figure di particolario di singolari elementi, una preziosissima rappresentazione d’insieme, che può dirsi il più antico abbozzo di sintesi tettonica (Tav. IV). Anche ad un esame superficiale, massime quando si abbia presente qualche fotografia o un ricordo esatto dei luoghi, questa figura, dal titolo « situs montium ad Uriensem lacum », non si presenta già come la rappresentazione quasi meccanica del paesaggio offerto dalle due sponde del ramo di Uri del lago dei Quattro Cantoni, ma è invece da riguardarsi come un primo tentativo di interpretazione tettonica, o quanto meno di coordinamento, studiato in base all’analisi dei singoli elementi che, disegnati a parte nelle tavole precedenti, sono qui fusi per mostrarne la connessione reciproca. Si ponga mente sopra tutto alla metà della tavola, che si riferisce alla sponda occidentale del lago.1 Qui vi è più che lo sviluppo dello schema Steno-
M. G0RTANI - LA STRUTTURA DEI MONTI 261
1 Occidentale in realtà, mentre risulterebbe orientale stando a ll’in dicazione della figura, dove le lettere N e S sono invertite.
262 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
niano: vi è quanto basta per assicurare a Luigi Ferdinando Marsili il vanto di precursore nei riguardi della tettonica.
Per fortuna, è possibile di fissare la data precisa di tali osservazioni: 1705. Nel Tomo I I dell’autobiografia manoscritta, a pag. 226, il Marsili dice appunto che nel 1705 partì « per Ferrara, Modena, Milano e Svizzeri»; e a pag. 228 precisa: «In questo mio soggiorno degli Svizzeri frà la solitudine me la passai a fare più solide annotazioni nel Governo di quella Repubblica, sopra l’origine delli Conti d’Ausburgo... Nelli studi della natura p er la s t r u t t u r a d e ’ M o n t i , raccolsi pietre varie e diedi principio alla serie, e phenomeni de’ legni, ed a quella dell’ali de’ pennati, dove tanta varietà di colori s’osserva, in più annotazioni sopra delli luoghi ». Periodi che bene rispecchiano la fervida attività di quell’ingegno straordinariamente versatile.
L ’importanza delle osservazioni Marsiliane suaccennate è messa ancor meglio in luce da figure e parole dell’autore stesso, che fanno parte della sua monografia sul Garda, ora in corso di stampa por cura del prof. Longhena. Dopo avere illustrato profili di monti variamente costituiti dell’una e dell’altra sponda, e di aver cercato le corrispondenze fra i vari gruppi di strati, il Marsili così si esprime:
« Da’ notati accidenti si fa chiaro, che il superficiale aspetto degli strati non deve ingombrare la mente di chi l’osserva per dubitare, che la disposizione degli strati nella gran fabbrica del mondo non abbia avuto il suo sistema regolato, e che piu- tosto sieno un effetto del caso, come io, quando ero nell'Elvezia, sfavane in dubbio vedendo attorno de’ laghi così frequenti della medesima le sponde con i strati superficiali in quelle varie forme che feci delineare dal Maver pittore di Vintertur in un libro che conservo appresso di me e che permisi al mio compare Saiser di copiare che poi stampò nell’opere sue; e ne’ posteriori miei altri viaggi per l’Europa ne osservai anche in diverse altre figure, che ho conosciuto chiaramente accidentali per le tante addotte ragioni, e ciò avviene nella superficie; che se addentro, come in alcune miniere ho veduto, provengono da quelle inclinazioni diverse, che l’Eterno Facitore dar volle al corpo de’
M. GORTANI - LA STRUTTURA DEI MONTI 263
monti, come si mostrerà nel trattato della mentovata struttura organica della Terra, perochè nel corpo della Terra vi è quello stesso regolato sistema che vediamo nell’altre gran fatture di Dio e quelle irregolarità che incontriamo di continuo nelle diverse parti di questo globo non furono cossi fatte a principio, ma prodotte da tante cause morbose, che da Lui si permettono acciochè svenga e illanguidisca per poi a suo tempo estiguersi a simiglianza de’ corpi de’ viventi ».
Questo brano, oltre a indicarci l’autore degli acquerelli eseguiti sotto la direzione del Marsili, è interessante anche perchè, da quanto la contorsione dello stile ci permette di rilevare, conferma come il Marsili ritenesse dovute agli agenti esterni le obliterazioni e alterazioni superficiali degli strati, e dovute invece a « cause morbose », inerenti alla vita del corpo terrestre, le dislocazioni e contorsioni che ne hanno alterata la giacitura originaria.
« Si vedono alterate le corrispondenze esatte degli strati— prosegue il Marsili — fra una riva e l’altra del nostro lago, per ragione delle diverse inclinazioni fra esse nelle loro falde, atteso che quelle de’ monti più alti, come del Monte Baldo, e respettivamente all’orizonte dell’aqua del lago pajono prossimamente perpendicolari ad esso, laddove quei de’ monti men’erti dimostrano un angolo sull’orizonte medesimo più ottuso; e questo aspetto, che punto non altera l’interno ordine degli strati, chiaramente m’insegna, unitevi altre circostanze, la formazione de’ monti, che a Dio piacque fare per dividere dalla terra le aque, lo che mostrerò nella prefata struttura organica della Terra col fondamento non di sole speculazioni, ma dimostrazioni di fatto, alcune delle quali pure in questo lago si riconosceranno ».
Il lettore avverte di leggieri come questo passo rivesta una speciale importanza, perchè è uno dei primi accenni all’ originaria continuità degli strati costituenti montagne elevate, e alla possibilità di dedurre dalle dislocazioni di essi il modo di formazione dei monti; e perchè dà maggiore risalto all’abbozzo di coordinamento tettonico dei monti di Uri, di cui s’ è prima discorso. E veramente ardito, per il suo tempo, è il tentativo,
264 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
abbozzato dal Mar sili, di rintracciare la corrispondenza primitiva degli strati così diversamente disposti sulle due rive opposte del Garda.
E ora veniamo ad un altro primato Marsiliano: abbozzi di profili stratigrafici e di rappresentazioni cartografiche di condizioni geologiche.
Anche prescindendo dai profili geologico-minerari che richiederebbero una illustrazione a sè stante (e sull’interesse e importanza dei quali credo utile di richiamare l’attenzione dei competenti), i suoi manoscritti contengono un buon numero di profili particolareggiati tratti da cave a giorno e da sezioni natu rali. Fra i primi ne scelgo un paio, tratti dalle « Note dei strati delle Cave de’ Marmi, che sono in Monte Baldo » (Manoscritti Marsiliani, voi. 90, cartella A, fase. 20): tali note sono precedute da osservazioni degne di rilievo su « che cosa contribuisce al Marcimento, e ruvina delle Pietre e Monti » 1, e constano di schizzi topografici e sezioni di cave, con indicazioni sul colore, natura e spessore dei vari strati, sulle vene che li attraversano, sulle ammoniti che vi si rinvengono (vedi le figg. 2 e 3, a pagg. 10 e 11).
1 Credo utile di riportare senz’altro tali osservazioni.
« C h e cosa c o n t r ib u is c e a l M a r c im e n t o , e r u v in a
d e l l e P ie t r e e d e i M o n t i » .
« Cocinatura delle P ietre nelli Monti si fa per le piogie, che s’ insinuano nei Ladini, ai quali s’insinua l’aqua per mezzo delle Vene, massime bastarde, e di poi nell’estate facendo gran caldo la pietra bagnata si cuoce, avvendo osservato li cavatori, che le pietre sane, e fo rti admet- teranno a quattro piedi di grosezza il caldo, e quando la pietra è marza anderà dentro il caldo sino a 10 piedi.
Questo caldo dura sino a tanto, che vengano piogie di durata d'ore, perchè per lina rosata si fa una subulizione, che aumenta il calore. Torna di poi dopo la piogia il calore, e di novo piogia. e cossi si scompagina la strotura della pietra.
Nel marzumo della pietra si mantiene sempre il colore della pietra, ma si discioglie come in luto.
M. CORTA.NT - LA STRUTTURA DEI MONTI 265
Sono schizzi che anteeipano di oltre mezzo secolo quelli di Giovanni Arduino, opportunamente messi in degna luce or non è molto da Giuseppe Stegagno 1 rivendicando un nuovo primato italiano anche in questo ramo delle discipline geologiche.
F reddo.
Nel freddo le nevi penetrano nei ladini, dentro dell! quali l ’aqua della neve s’agiacia, e poi venendo sole, che tramanda caldo, comincia a causare una rarefazione nel ghiacio, che nelli pezzi rotti dì pietra chiamata marza causa pronte, e visibili rotture anche con schiopi.
V e n t i .
La Tramontana distrugge la pietra. L ’aqua per il contrarlo l ’aumenta, perchè lega col sole, e di lei umido, tutte le parti pulverine, sopra possibile indurendole.
P io g ia .
Questa nell’inverno massime s’insinua frà li Laidini, e per molti giorni benché non piova. Esce per li ladini che tagliano nel cavare il Marmo.
B o t a m i .
L i rotami, che cadono dalla somità del Monte per le sopra descritte cause si vanno unendo in certe concavità de’ Monti, come è nella Camilla, dove stanno sopra la creta, e doppo della creta cominciano li marmi, e fra essi piantano Viti, e Mori, chè fanno benissimo.
T e rra .
Questa sopra li Monti si precipita per le piogie ed in maggior copia quando la liquefatione de’ giaci l ’ha discompaginata. Tutti asseriscono, che la terra cala a vista dai Monti ».
Queste brevi note (e si tenga presente che trattasi di un semplice appunto, scritto sopra un foglio volante al solo scopo di fissare le idee) mostrano come il M arsili fosse riuscito a formarsi un concetto abbastanza esatto della degradazione e dei fa tto ri di essa, tenuto conto delle imperfette cognizioni fisiche del suo tempo. Troviamo indicati e raccolti, sia pure con inesattezze ed errori, l ’azione e g li effetti dell’alternanza di temperatura, dell’impregnazione acquea (facilita ta dai giunti di stratificazione), dell’insolazione e del gelo (con osservazioni circa la profondità a cui arrivano), del vento e della gravità. Si noti anche l’osservazione relativa al modo in cui si formano i crostoni di materiali detritici, legati dall’acqua e dal sole.
1 S tegagno 6 . , I l veronese Giovanni Arduino e il suo contributo al progresso della scienza geologica, Verona, 1929.
Fig. 2. - Rappresenta la metà sinistra (B ) di una cava di marmo bianco della contrada Camilla. Sotto il cappellaccio di « sassi marci » avente uno spessore di 12 piedi, sono indicati, dall’alto in basso, 6 corsi di marmo bianco, 4 di marmo misto di bianco e rosso (ove i ladini — in- terstrati, giunti — « sono grossi come un foglio di carta e mediante un cuneo si può separare un corso dall’a ltro » ), e 1 di marmo tutto rosso; « doppo di questo corso viene pietra salvatica per fa r muri ». D i fianco, l ’annotazione che « in questa (cava) non v i è vena maestra ».
Fig. 3. - Sezione di una cava di marmi baldensi, compresa fra due «V en e M aestre» e segnata da due «V en e Bastarde», di cui la superiore « discende e sì slarga discendendo e poi sì perde », l ’inferiore « va in su, si stringe montando e poi sì perde ». Sotto gli alberi e la « Terra lavorativa » si trovano successivamente i marmi « Gialo Paiado, Gialo più carico, Giallo come sopra, Gialo dorato dove regna la miniera di ferro più che negl’a ltri strati, Rosato bello, Gialo di Paglia, Gialo e Rosso », e finalmente uno « Giallo, e rosso, ma il gialo sminuisce ». In calce, le note seguenti : « Le Cape Cornua Amonis si trovano in tutti li corsi - Le Vene maestre sono alla magior distanza fra loro P ie : 20, e la minore pi : 4. - Questo marmo posto sul foco diuenta rosso ».
268 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Ma anche più interessanti sono i profili stratigrafici, fra i quali pure ne riproduco due molto significativi. Il primo, per quanto semplicissimo, è notevole per lo scopo preciso che l’autore si è prefisso e il metodo che ha seguito. Il foglio (61 del mscr. 90 C), è occupato nella metà superiore da uno schizzo topografico,o pianta, dei dintorni di Montpellier, e nella metà inferiore dal disegno che riproduco (fig. 4) e che è per l’appunto un profilo riferito a una località ben contrassegnata sulla pianta e ricavato sopra tutto per precisare la posizione di un orizzonte ad ostriche. Lo confermano la dicitura posta in calce, nonché una nota che si legge sul verso del foglio: « Orizzonti, e strati di Pietre figurate atorno di Monpillié ».
-
_I"f' II.. i ' I»
-A.KrevcyK**
< C ~___ _i________ _£7------- ?i.
. ¿o ~TUy
Fig. 4. - Profilo geologico presso Montpellier. - Sopra uno strato di « Travertino sabionizzo » posa uno strato di « Sabionizzo », e su questo uno di « Ostreghe » cui fa seguito la « Terra laborativa ». In basso la dicitura : « Profilo della Postura de’ diversi Terreni doue è la linea del Ostreghe, e che è dell’angolo della strada detto T u r de Burgas segnato nella pianta ».
Per l’altro profilo, manca ogni indicazione che permetta di stabilire il luogo in cui fu rilevato ; esso si trova, contrassegnato dal n. 8, nella cartella A, voi. 90, dei manoscritti, con la semplice dicitura « Profili per la struttura della Terra ». Ed è un
270 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
vero profilo geologico, non ostante il criterio utilitario delle indicazioni, con note precise circa lo spessore e natura dei singoli gruppi di strati, la presenza di fossili, la presenza di un livello acquifero (fìg. 5).
Significato e valore analogo hanno alcune sezioni dedotte dallo scavo di pozzi in pianura, conservate nei fascicoli A 5 e A 6 dello stesso voi. 90: pozzi della Barigella, di Cò di Sàvena e di Minerbio nel Bolognese, e (forse per confronto) anche un pozzo di Amsterdam.
Ma ho avvertito come il Marsili si palesi veramente precursore dell’Arduino anche nella cartografia geologica. A parte alcune mappe riportanti la disposizione topografica di cave e miniere, merita cenno a tale riguardo una cartina (mscr. 88 D 2) « che mostra la linea che tengono le miniere di solfo, olio di sasso, fuochi ecc. da Bologna a Perticara » : cartina appena abbozzata, ma alla quale serve di opportuno commento 1’« Itinerario da Bologna a San Pellegrino su l ’Alpi di Modena, ed indi alla sommità del più alto Monte della Lombardia detto Cimone », rimasto, benché completo, fra i manoscritti Marsiliani inediti, e pubblicato lo scorso anno dal Longhena.1 Spiega ivi appunto l’autore come sua prima cura sia stata quella di considerare come fossero disposti i fuochi appenninici, le salse, gli affioramenti petroliferi e le miniere di solfo; e ciò, egli dice, perchè
1 L o n g h e n a M., Lu ig i Ferdinando M orsili sull'Appennino Modenese e sul Cimone, « L ’Archiginnasio », X X IV , pp. 75-103, Bologna, 1929.
Fig. 5. - Profilo geologico di località ignota (probabilmente del Veronese). - Le indicazioni autografe apposte al disegno sono, dall’alto in basso, le seguenti : « Qui hanno trovato le conchilie - Vena di terra - Pietra da lavoro - Linea sotile invisibile che con bieta separano - Linea con terra di mezzo piede - Linea di terra sotile come l ’altra di sopra - Da una linea perpendicolare all’altra piedi 6 - Come sono buone l ’altre - Da una linea perpendicolare piedi 10 - Troppo dura per il travaglio - Da una linea a ll’altra perpendicolare piedi 10 - Aqua che sorte dalla linea - Troppo dura per il travaglio - Da una linea a ll’altra perpendicolare piedi 20 ». Di fianco (a destra), quasi a dar ragione della varia rientranza delle testate, l ’annotazione : « I l sole, è la piogia consumano la pietra ».
M. GORTANI - LA STRUTTURA DEI MONTI 271
« le tante osservazioni nelle miniere de’ metalli fatte in molte parti d’Europa m’insegnarono che le linee loro lungo tratto di Provincie intiere mantengono il loro corso ». Il risultato, fondamentalmente giusto, che quelle manifestazioni si allineano lungo una zona dell’Appennino emiliano-romagnolo, dà particolare risalto a cotesto primo abbozzo di carta geologico-mi- neraria.
. N" ' \ n" v\<*- Sot(■ cTtL*~
vAr t< 1
r /
Fig. 6. - Schizzo geotettonico della baia di La Ciotat (Lasciotat), con la dicitura seguente : « Nel loco A ho vedduta la spiagia tutta coperta di Glarea. Nella punta B ho vedduto li strati obliqui corrispondenti a quelli della C, e sotto aqua si vedde il piano orizontale posto, e diuiso come mostrano le cime delle lastricate di pietre a taglio. Nella punta D ho vedduti li strati quasi approssimanti al perpendicolare, e che nel mare andavano obliqui come è nel loco E » .
272 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Una cartina geologico-tettonica, primizia notevolissima pur nella sua semplicità, figura come un appunto staccato nel foglio 47, cartella G, del voi. 90. La baia di La Ciotat, sulla costa provenzale, vi è rappresentata con segni riferentisi non soltanto alla natura di alcuni punti della zona di spiaggia, ma altresì alla disposizione degli strati e alla loro presumibile prosecuzione nel mare 1 (fig. 6).
Chiudo questi cenni con la trascrizione di alcuni pensieri del Marsili, esposti in un foglietto di 3 pagine contrassegnate col n. 14 nella cartella A del solito voi. 90.
« Punti per l’Organica Struttura della Terra ».
« Il corpo della Terra... è di sustanza cossi eterogienea per pottere con quella facilità d’un animale sottometterlo ad un esame anatomico sotto d’un angusto tetto. Questa difficultà è slatta senza dubbio quella, che ha disperati li curiosi eruditi a metterli altra mano, che quella di sedentarie speculazioni, senza nè meno essersi data briga di riconoscere le parti, che la compongono ò separatamente, ò unitamente.
« Li matteriali, che compongono questa grand’oppera di Dio furono di pura roca, e terra col tratto del tempo alterate, e fattane una cosa, che n’è più terra nè roca.
1 Prosecuzione che a più riprese il Marsili cercò di indagare, in differenti località : come risulta, oltre che da un paragrafo della sua grande opera sul mare, anche da un appunto del mscr. 90 A 15, che suona cosi : « Unione dei strati montani con quelli submarini deU’Isole o del Mare. — Ho incontrato costante la continuazione dei stratti delli Monti con quelli dell’ Isole, e Penisole del Mare con nove osservazioni a Cassis, che si porteranno in figura. Ed altre nel lago di Garda per non dovere più dubitare che il Vaso, o cratera del Mare non sia della stessa matteria lapidea dei Monti e che tutte l ’altre eterogenee che lo vestono siano accidentali.... anzi che molte siano vegetabili con metodo che meglio dimostrerò qui, che nella storia del Mare » . — Le acute osservazioni sulla prosecuzione degli strati nel fondo della conca benacense e sotto i materiali sciolti delle rive, sono rese ora di pubblica ragione mercè la stampa della preziosa monografia Marsiliana sul Garda (v. il cap. I).
M. GOKTANI - LA STRUTTURA DEI MONTI 273
« La mole pierosa per più ragioni durerebbe continuarsi sino al centro del globo terreo, ed aqueo dal sito dove termina la grossa terrea, e l’orizonte inferiore della mole dei mari. Io non mostrerò, che le profondità pierose, e di roche diverse, se non le vedute in più miniere d’Ungaria, e con la probabilità, che cossi continui fino al centro della Terra fra quelli tagli de’ condoti, che noi mai veddremo per insegnarlo con quella evidenza, che dimostrerò dentro delle miniere.
« La parte pierosa diminuise ò per li gieli, ò per certe piogie in tempo che è il sole, ò per la limatura dell’aque nelle stesse pietre formando arena, che il mare regietta tanto più presto che può.
« La parte pierosa si è disorganizata in qualche parte per li terremo tti statti al sud0.... Veddi la Terra trema : ma non mai però hanno deformata la strotura della Terra, non avvendo ved- duto se non nella Croazia inferiore dove li teremoti sono frequenti, che hanno ridotto il paese, fra li fiumi Culpa, e Corona tutto pieno di pozzi, escavati dallo sbasamento che ha fatto il piano superiore, che è tutto con poca sterile terra di pietra, e fra tali escavazioni conviene di cavalcare con bon ordine per non cadere in essi girandoli e col sentire un rimbombo calpestando il cavallo la superficie.
« Il foco, che vediamo nei Vesuvj polimentati da matteria ignea duverebbe distrugere la parte pierosa, calcinandola e per conseguenza rompendo la strotura del mondo, ma questo foco non avvendo una radice da quello (che) molti dicono centrale non dura sempre in grado eguale, perchè il di lui principio non è da quel primario magazino igneo, ma dall’accidente fatto dal- l’imistione di vapori, ò sulferi ed altri componenti, che con l’unirsi danno le fiame, come a Monpellié vidi. Quando il foco venisse continuamente, da un foco consistente la mole terra aquea sarebbe dalla creazione del mondo sino ad ora in gran parte discompaginata ».
Così il grande bolognese, riconosciuta a buon diritto l’inconsistenza delle elucubrazioni fatte dagli eruditi e pensatori lontani dal contatto con la natura, dalla sua personale esperienza trae argomento a congetture sull’ interno del globo, e delinea
20
274 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
in poche righe Fazione demolitrice degli agenti esterni. Riconosce, sia pure con errori scusabili al tempo suo, la connessione fra certi terremoti dei paesi eminentemente carsici e il fenomeno carsico stesso. E getta, credo per la prima volta, l’idea che la terra sia interamente solida e che i fenomeni vulcanici siano da ricondursi non ad un fuoco centrale, ma a reazioni chimiche locali. Dovrà trascorrere oltre un secolo prima che tale ipotesi venga formulata oltr’alpe nella più antica forma che fosse conosciuta finora.
Fra Ulisse Aldrovandi e Lazzaro Spallanzani, Luigi Ferdinando Marsili si inserisce degnamente nella serie dei grandi naturalisti di cui si gloria la terra emiliana.
M ic h e l e G o r t a n i
M. G0RTAN1 - LA STRUTTURA DEI MONTI 275
SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
Tavola I. - Riproduzione dell’acquerello Marsiliano conservato nel mscr. 90, cartella C, f. 73. - Il nucleo della dolce e regolare piega anti- clinale è formato dagli strati c meniali » , di cui la dicitura porta una succinta definizione. Certamente dettata dal Marsili, essa dice in fatti : « Mons Gaissstiig et Fronalp prope Brunnam ad lacum Uriensem, ubi strata superiora areuatim tendunt, et crassiora sunt - inferiora itidem arcuata sunt, murum artefactum repraesentantia ».
Tavola I I . - Figura superiore - Riproduzione dell'acquerello Marsiliano conservato nel mscr 90, cartella C, f. 81. - I l bellissimo esempio di piega ribaltata è accompagnato da questa didascalia : « Mons Kolm dietus ad lacum Uriensem, e stratis ita compositus ut vertex eius supra incurvatus quasi videatur, et stratorum positura quasi perpendiculariter arcuata videatur ».
Figura inferiore - Riproduzione dell'acquerello Marsiliano conservato nel maser. 90, cartella C, f. 80. - L ’acquerello è accompagnato dalla dicitura : « Mons anf der Werehi dictus ad lacum Uriensem, in vertice e stratis ad horizontem versus plaga merid. inclinatis, in basi areuatim in- flexis compositus ».
Tavola I I I . - Riproduzione dell’acquerello Marsiliano conservato nel mser. 90, cartella C, f. 78. - E ’ accompagnato dalla seguente didascalia : « Montis Axemberg extremum, è stratis serpentino et miro modo incurvato duetu compositum » .
Tavola IV. - Riproduzione dell'acquerello Marsiliano conservato nel mscr. 90, cartella C, f. 82 : « Situs .Montium ad Uriensem lacum ».
Tavole V. - Figura superiore. - Riproduzione dell’acquerello Marsiliano conservato nel mscr. 90, cartella C, f. 88. - La dicitura che lo accompagna (< Ichonographia cryptae prope Canstadium, ubi ossa fossilia inventa fuerunt, v. in obs. quae Bononiae sunt » ) precisa che si tratta dell'altura sita nei dintorni di Cannstatt nel Wttrtteanberg, dove è la grotta in cui furono rinvenuti molti avanzi fossili di cui taluni inviati dal Marsili al Museo di Bologna. Per tali avanzi (di Elephus antiquus) cfr. Cap e l l i n i G. : E le fan ti fossili nel R. Museo Geologico di Bologna, 1. c., pag. 55.
Figura inferiore. - Riproduzione dell’acquerello Marsiliano conservato nel mscr. 90, cartella C, i . 89. Lo accompagna la seguente didascalia : « Mons quidam prope Linz Comitatus Tirolensis è stratis perpedicula- ribus compositus, ita ut antrorsum visus ex integro frusto compositus esse videatur ».
T av . II
* ' V
„V ' r ~ . , 7 ^ • -
t&S'S è t '& ß f K t . ¡ • \ v : í ¿
'■>?'<• \ . ‘ ^ * d à k .
__________ __ 4 jiü a j _
I fondamenti botanici nell'opera <li L. F. Marsili.
I biografi più accreditati ili Luigi Ferdinando Marsili (la figura di lui non ha avuto sempre, specialmente in Francia, la sorte favorevole di un grande come il Marsili fu) dicono che essendo di indole irrequieta e di intelletto apertissimo fino dall’ infanzia, principiò presto a viaggiare. A quindici anni, infatti, egli era a Padova per dedicarsi alla Botanica e in generale alla Storia Naturale per la quale si sentiva molto trasportato. 1
Leggendo i diari del Marsili si ha subito l’ impressione di trovarsi di fronte a un ingegno superiore e di versatilità non comune. Egli è soprattutto un osservatore pronto e perspicace,,
1 G. F a n t t j z z i : Notizie degli S critto r i Bolognesi, Bologna, V, pag. 286
e seguenti. Bologna, 1786. « In età d i 15 anni si portò col padre a Venezia, ed a Padova. Quivi all'udire le lezioni di Bottaniea nell’Orto de’ Semplici di quella Università, e della sua attenzione, e piacere nel ricevere da quel Lettore le Piante, sopra le quali g li era occorso di ragionare, si rilevarono i prim i contrassegni di quel grandissimo genio, e sommo profitto, che doveva di lui poi svilupparsi per l ’ Istoria Naturale ».
Prima di questa, il Fantuzzi aveva pubblicato una biografia speciale e assai pili vasta del M arsili : Memorie della V ita del Generale Co. Lu ig i Ferdinando M orsig li, Bologna, 1770, pag. 2. « In età di 15 anni si trasferì col padre a Venezia, e lo segui anche a Padova. I l piacer singolare, ch’ei dimostrò nelle replicate visite a quell’Orto Botanico, la frequenza, e l ’attenzione colla quale si prestò a quelle lezioni, la diligenza, e la cura di conservare come preziosissimo dono, le Piante a lui consegnate da quel Lettore, furono i prim i indizi del genio per le cose naturali, che cominciava a sorgere in esso, e che coltivato dovea divenire, come divenne, grandissimo » .
278 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
ansioso del nuovo, con serietà e ponderazione, mai con trasporto capriccioso e fantastico. Scienze naturali, arte, costumi, monumenti, iscrizioni, tutto è per lui motivo e oggetto di curiosità e di studio; le ricerche sul mondo delle piante si intrecciano con quelle sul mondo animale: la geografia è intesa nel suo signifi cato più vasto e più profondo. Dallo studio morfologico del terreno e del mare, egli sale per gradini a tutte le branche di questa scienza e in ciascuna fa pompa di acutissimo sapere, finché non giunge ai limiti dell’ etnografia nella quale pure si mostra dotto di straordinaria capacità e cultura. L ’ arte militare è la sua palestra insuperabile; il Marsili è lo scienziato principe di essa e ogni sua parte gli è famigliare; conosce la struttura degli eserciti e la psicologia degli elementi che li compongono, dai gregari ai più alti comandi; indica quali debbano essere i sistemi di fortificazione, i mezizi di attacco e di difesa fino al modo di riuscire a concludere gli armistizi e la pace: egli sa costruire piazzeforti e trincee ed altri apprestamenti guerreschi, sicché si può dire un maestro nella tecnica militare e nella valutazione dell’influenza degli elementi morfologici del terreno per le operazioni di guerra. La geografia militare risulta cosi nel Marsili una vera scienza professata sul terreno per combattere e vincere un nemico forte ed agguerrito, e la difesa del Raab ha destato in ogni tempo l’ammirazione dei competenti perlo studio generale e particolare che egli ci ha lasciato su quella linea del fronte in cui doveva venir fatto prigioniero del ne mico (1682).1
1 II battesimo della sua gloria m ilitare è sul Raab, ma purtroppo la schiavitù nella quale egli cade, g li apre anche il periodo della disdetta, benché dalla prigionia riesca a salvarsi miracolosamente, datii tempi e i l paese.
Le opere m ilitari da lui compiute sono molte e sempre condusse a termine i lavori con tanta abilità e in tempo così breve da meritarsi continue promozioni dall’ Imperatore. Pugnò valorosamente a Neuhausel, la cui fortezza assali, stando sempre alla testa dei suoi granatieri ; e, sebbene colpito da una palla, che lo sbalzò da cavallo, ebbe la soddisfazione di vedere inalberata sulla rocca la bandiera dell’ Imperatore e udì il grido della vittoria. Ricominciato l'assedio di Buda, che per
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 279
« In quasi tutte le descrizioni geografico-militari del Marsili si considera preliminarmente, dice il Bruzzo,1 il valore assoluto dei singoli elementi geografici dal punto di vista della guerra e se ne determina poi il valore relativo, dedotto dalla importanza (strategica logistica e tattica, che quelli possono avere nelle operazioni svolgentisi in un dato momento storico sopra un dato campo di guerra »,
I diari del Marsili sono pieni di annotazioni argute e originali, di disegni, di cenni di ogni genere, e dimostrano che egli mai, come Leonardo, si arrestava dal prendere appunti di tutto quanto incontrava ; in mare o in terra non perdeva momento che non impiegasse in riscontri ed osservazioni. Anche durante la prigionìa la sua mente era sempre in moto.
Abile ingegnere per il suo ¡profondo studio delle matematiche (come si può rilevare dalle tante opere di fortificazioni, dì ponti e di apprestamenti di difese), anche nella vita del campo i!l tempo che gli rimaneva veniva da lui dedicato allo studio e alla raccolta dei materiali più disparati. Non muoveva passo che avesse fisso l’occhio ed intesa la mente sul terreno che percorreva, per esaminare quant’esso gli mostrava e ogni cosa osservava minutamente e di tutto prendeva memoria. « Essendo noto questo suo genio a Soldati, a Guastatori, a Terrazzani, tutti a gara correvano al suo alloggio con le mani piene di ciò, che credevano potergli piacere, e tutti i suoi domestici sapevano quanto bastava per sollevarlo, e profittevolmente aiutarlo nelle sue virtuose occupazioni » . 2
Ebbe il Marsili un’anima certamente tempestosa e insaziabile di sapere, ma quadrata, e qualunque cosa gli potesse accadere,il cervello gli restava sano e salvo; egli ebbe il prestigio della mente e il comando su se stesso, e anche oggi, dopo due secoli, noi vediamo che resta un uomo vero, nonostante il tempera-
consiglio d’alcuni era stato abbandonato, ne furono diretti così ingegnosamente i lavori dal M arsili che la città cadde espugnata. Presa la piazza, primo pensiero del Conte fu di salvare i tesori della scienza, che era tenuta colà in alto onore dai Turchi stessi.
1 G. B r u z z o : Lu ig i Ferdinando Marsili, pag. 33, B o logn a , 1921.2 G. F a n t u z z i : 1. c.
280 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
mente esuberante e temerario, se non impulsivo, influenzato però, sempre, da un’ardita forza spirituale, insofferente di chilo ostacolasse nei suoi propositi, mentre era vigilantissimo della disciplina dei suoi subordinati.
Tra gli altri suoi ammiratori — uno per tutti —, il matematico idraulico Ortensio Zaglii o Zago di Vicenza scriveva al Marsili a Vienna pieno di stupore per la sua straordinaria dottrina e la vasta e nobile opera da lui compiuta « non sapendo comprendere come sotto lo stesso elmo possano racchiudersi due menti così diverse, l’una applicata tutta all’azioni belliche, l’altra alle speculazioni litterarie » . 1
Nel Catalogo dei Manoscritti di Luigi Ferdinando Marsili conservati nella R. Biblioteca Universitaria di Bologna (lo zelo di Lodovico Frati compose quel Catalogo2 con profonda venerazione verso la memoria del nostro insigne concittadino), figurano molte volte le citazioni che si riferiscono ad argomenti del mondo delle piante, trattati da un uomo, il quale, benché abbia risolto la sua carriera nelle armi e nell’arte difficile della diplomazia, si dimostrò eruditissimo in tutte le scienze principali e seppe emergere a belle altezze anche nella Botanica. Lo studio delle piante fu una delle sue passioni più promettenti e certo in lui dovettero assai influire, dopo quanto aveva imparato a Padova, gli insegnamenti del Malpighi e defi Trionfetti che a Bologna onoravano lo studio col loro sapere e che egli frequentò assiduamente.
Anche Geminiano Montanari fu a Bologna un suo maestro. La Storia Naturale ebbe così in lui il sussidio immenso e vivificatore della Filosofia e delle Matematiche mentre lo Studio
1 Voi. L X X IX dei Mss. Alarsiliani.
2 L. F r a t i : Catalogo dei M anoscritti di Lu ig i Ferdinando M arsili conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna. Firenze, 1928. — Ringrazio vivamente l'amico sig. Romeo Monari della R. Biblioteca Universitaria di Bologna delle premure solerti dimostratemi per la compilazione del presente lavoro.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 281
fioriva per Fattissima autorità che gli veniva pure da quel celebre modenese.1
Il sapere del Marsili varcava già fin dalla sua adolescenza i confini della città natale. Questo è certo per la dimestichezza che egli andò ben presto ad avere con un numero eletto di dotti della nostra scienza, italiani e stranieri (fra questi ultimi era in cordiale amicizia con Giovanni Seheuchzer di Zurigo), oltre che, in modo assai degno, con i suoi maestri e, più innanzi negli anni, con quel Lancisi al quale poi doveva dedicare, si può dire, le conclusioni intorno allo studio dei funghi che forma l’argomento fondamentale della sua cultura botanica.
Il carteggio botanico molto ampio col Trionfetti dimostra la cura che il Marsili pose, anche durante le sue più attive e pericolose azioni militari, a studiare le piante: la dichiarazione che egli fa nella prefazione al Tomo V I I 2 dei suoi Manoscritti, prova come nel Trionfetti egli avesse accresciuta, fin dagli avvenimenti di Ungheria, la sua massima fiducia.
« Ex meis castris multa scripsi eruditissimo Dom.° Trionphetti Canonico et Lectori Botanico in Vniversitate Bononiensi, qui mihi transmisit omnes sententias Auctorum, et observationes expositas in libri«: sed piane inconsentaneae fuerunt «un di- ctis nostris assiduis operationibus : in istis quoque quas, cum ipso, per literas, habui dissertationibus, late me expressi, su* per mea hypothesi... ». 3 E v’è di più, perchè il Trionfetti, che gli tenne per lunga pezza ambo le chiavi del cuore e della mente, fu il solo che ricevette tutte le raccolte, da ogni parte ove egli si trovava; raccolte che forse non vennero però mai studiate a fondo da quel prefetto dell’Orto Botanico di Bologna e che sono andate miserevolmente disperse.
1 G. T ir a b o s c ii i : Biblioteca Modenese degli S critto r i etc., Modena, I I I , 1783.
2 Ms. cart., in-fol., 52 X 38, contenente numerose tavole acquarellate a colori.
3 Interessante è la lettera del Marsili al Trionfetti datata dalla Selva Belinaz il 14 novembre 1699 e riportata dal F a n t u z z i : Memorie della Vita etc., pag. 281, alla quale il Trionfetti risponde lungamente, ma soltanto con erudizione bibliografica.
282 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Fu il caso fortuito o il calcolo prestabilito che portarono il Marsili a innamorarsi del paese tra il Danubio, la Sava e la Drava fino alle porte della Valacchia? Forse fu il caso. Non potendo compiere i suoi voti per l’incontro con una gentildonna, stabilì di abbandonare la Patria e recarsi a Costantinopoli oive si formò quella cultura sussidiaria e indispensabile per accettare poi le missioni che gli vennero in seguito affidate. Nessun luogo al mondo poteva anche allora, più di Costantino,poli (come della Turchia in generale), essere più adatto per garantirsi quel corredo di cognizioni e quel carattere speciale che può fare di un uomo, il quale ne abbia la capacità e le attitudini, un capo militare.
La regione danubiano-carpatica, che il mare limita urlante al Quarnero giù dalle chine del Velebit e dei primi Dinara verso l’ Italia colle sue selve immense (ai tempi del Marsili era molto più selvaggia di oggi) e la ricchezza dell' humus, palpitava di quella vita vegetale che ha sedotto ogni naturalista che se ne è occupato da allora fino a noi. Così, egli si perdette su quei monti e dentro quelle selve sterminate e giù nei piani malarici e nella puszta, raccogliendo sempre e classificando e mandando materiali in Italia e all’estero per confronti e pareri.
I l Marsili si adattò facilmente con i popoli danubiani. Il Danubio non è per essi soltanto un fiume sacro, come il Gange per gli Indiani; la regione che il Danubio solca è abitata da popoli mistici portati alla poesia, al canto, all’amore, alla pietà. Fin dai tempi di Strabone, il quale aveva viaggiato tanto, noi sappiamo che la razza dei Ceti, agglomerati intorno ai Carpazi, era rinomata per il suo istinto bellicoso e religioso ad un tempo ; essa ebbe un Zamolehi che predicava la superiorità dell’anima sul corpo contro ogni concetto materialistico e ammetteva la immortalità dello spirito. L ’idealismo era sovrano sopra tutto il paese che il Danubio solca, e quella natura che pur oggi vi regna, facendo filosofi e pensatori quei popoli, dovette sorprendere anche il Marsili, che era quasi un tipo della Rinascenza e per tanti lati somiglia agli Enciclopedici originali: geniale non solamente in guerra, ma anche nella organizzazione dello Stato
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 283
e, più di tatto, instancabile di nuovi studi per la mente feconda e incontentabile, votate al sapere.
Il Marsili, dotato così di vasta intelligenza pensosa e di prodigiosa preparazione, era nato in un’epoca in cui la curiosità del conoscere, investigando la natura, aveva stimolato gli uomini di scienza a viaggiare più che fosse loro concesso, anche per raccogliere materiali per la fondazione dei Musei di storia natu rale, e ravvivare le Accademie e i Templi della scienza per le dispute scientifiche e filosofiche.1
Così, egli diventa in mezzo al fragore delle battaglie e all’apprestamento degli eserciti o nei convegni diplomatici un’assetato che ha sempre bisogno di sfruttare i fenomeni naturali e ajpprofondirli, vivendo liberamente là dove essi si presentano agli occhi attoniti e rifiutando il sapere artificioso per volgere lo spirito al fondamento sperimentale degli studi: la raccolta prodigiosa che egli ha fatto del materiale micologico e la sua rappresentazione illustrativa in centinaia e centinaia di carte, anzi in volumi enormi ancora manoscritti ¡per mano sua e di decine e decine di segretari e disegnatori, le dissertazioni sull’argomento, i vari « tentamina » per una classificazione dei funghi, sia epigei che ipogei, sono una prova della tenacia e dell’acutezza della mente del Marsili nel campo scientifico e basterebbe questo solo materiale per dargli quel posto di benemerito, che i contemporanei gli concessero e i posteri gli devono consacrare in modo imperituro. Molti anni egli rimase nei paesi danubiani per continuare, durante le pili ardue missioni che gli vennero affidate, i suoi studi, come per la raccolta di manoscritti orientali e di materiale scientifico di ogni genere di cui fece ingenti collezioni.
La mia vita venne quasi interamente spesa in una parte di quei paesi stessi o assai vicini a quelli che esplorati, studiati,
1 Per la parte grandissima avuta dal Marsili nell’ordinamento del- l’Università e dell’Accademia delle Scienze cfr., fra g li altri, Don G. G. B o l l e t t i : D ell’origine e de’ progressi delV Institu to delle Scienze di Bologna etc., Bologna, 1T63. Ne attestino poi g li studi speciali e profondi compiuti con infaticabile amore dall’illustre concittadino prof. Ettore Bortolotti.
284 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
illustrati dall’insigne bolognese, il mio destino di uomo votato alla scienza e alla ricerca del vero volle che anch’io esplorassi scrupolosamente per farne argomento di cultura. Io comprendo così l’ anima del Marsili rivolta per natura alla ricerca di tesori scientifici non mai prima esplorati. Io mi spiego quella tempra, la quale si schiude a mano a mano che l’orizzonte danubiano, mistico sempre nei suoi piani sconfinati e nelle sue montagne selvose e imipenetrabili e regno dell’orso e dominio della vita più patriarcale, si stende su tante razze diverse che rappresentano una civiltà così lontana dalla nostra e che sul Marsili deve avere profondamente influito, già fin dal primo momento in cui egli vi giunse da Costantinopoli. Io penso ancora, perciò, che il viaggio a Costantinopoli abbia veramente trasformato là mente del Marsili. L ’incantesimo di quella città sopra un’anima pensosa occidentale non può che avere contribuito a sedurlo, trasformandolo e rendendolo in breve tempo un appassionato seguace di quel mondo, così vario e così diverso dal nostro.
Le conoscenze botaniche del Marsili, di questo italiano che, come fu scritto, fecondò delle sue opere e del suo sangue le terre straniere, sono molte e profonde. Egli è un dotto del tempo in cui visse eziandio in questo campo delle scienze naturali. Egli scrive delle cose vedute anche intorno alle piante con mente lucida e sicura, riuscendo a rendere chiaro il suo pensiero, e ciò sebbene debba usare la frase involuta allora corrente, più per l’imperfezione delle conoscenze che si avevano e per l’incertezza delle leggi che governavano la Storia Naturale. Il Mar- sili ha preferito per scuola l’aperta campagna; il suo laboratorio è principalmente quello che gli offrono le selve, i prati, le acque della regione danubiano-carpatica e dei Balcani. Là egli ha esplicato la più bella parte della sua straordinaria attività: quello rappresenta veramente il periodo aureo della sua vita tormentata.
Chi potesse disporre dell’ ingente materiale botanico da lui raccolto con tanto amore e per tanti anni — materiale che non si sa oggi dove possa trovarsi o sia andato a perdersi — si po-
A. BALDACCI I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 285irebbe stabilire il grandioso contributo da lui portato alla conoscenza della flora dei paesi esplorati. Poiché la botanica Marsi- liana comprende principalmente la floristica regionale, se non sistematica, dei paesi nei quali egli dovette soggiornare per le sue incombenze di guerra; la sua predilezione appare specialissima per i funghi e i muschi (che allora comprendevano anche i licheni) e in minor grado per le fanerogame. Il Vischio forma con queste piante uno degli argomenti più assillanti della sua mente.
Passando in rassegna i manoscritti botanici superstiti del Marsili (a noi pervenuti assai disordinati), si resta ammirati dei volumi di disegni colorati che riguardano le raccolte dei funghi, le quali dovevano essere originariamente cospicue, anzi enormi. Egli conferma parecchie volte di aver mandato al Trion- fetti un’intera collezione : dove mai potrà essere questa « Collectio fungorum vegetantium in Regnis Croatiae et Hungariae; quod volumen ad praefatum Doctorem Canonicum Trionfettum misi, ut illud botanico methodo ordinaret.... Volumen autem jam repe- ritur inter mea manuscripta in publico Instituto Scientiarum et Artium, suo tempore luci mandandum.... Tanta collectio fungorum fuit in causa, ut delineatoribus, qui in castris erant, imperaverim ut flguras formarent, composito ingenti volu- mine.... » ?
Il Marsili non è dunque, soltanto un erudito collezionista, ma pure un disegnatore di notevole potenza e accuratezza oltre che un nomenclatore e descrittore. Nonostante tanto materiale di raccolta e di disegni, le sue pubblicazioni botaniche sono, tuttavia, relativamente poche. Io credo che la ragione di ciò debba ri cercarsi nel suo insaziabile desiderio di perfezionare sempre più i suoi studi e le sue osservazioni, e ciò forse più che l’incertezza del Trionfetti a incoraggiarlo a pubblicare. Non appare, almeno dai rapporti con il Marsili, che anche allora l’antico prefetto dell’ Orto botanico di Bologna dovesse essere un maestro di grido, e ciò sembra tanto vero perchè il Marsili finì poi per rivolgersi all’Arciprete della Pieve di Biulrio, D. Francesco Bar- tolucci, abbandonando anche il celebre Lancisi cui aveva dedi
286 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
cato la « Dissertatio de generatione Fungorum » 1 intorno alla quale deve aver lavorato «forse più di una ventina d’anni, considerando i criteri che in proposito era andato esponendo al Mal- pighi e al Trionfetti nelle sue numerose lettere.
Il Trionfetti è un umanista, uno studioso, ma non uno scienziato. Non vedo in lui, tanto più nel carteggio col Marsili, un solo momento di viva luce originale, nè quello spirito di criticao polemico da cui si possa arguire una mente non solo superiore, ma anche mediocre.
Non si può escludere, comunque, che il Marsili non dovesse avere fiducia estrema nel Trionfetti almeno durante la campagna di Ungheria (perchè egli era forse la sola persona di fiducia sulla quale potesse contare): anche nel volume I I I 2 dei Mss. Marsiliani si trova un fascicolo di « figure diverse spetanti al Tomo de Fonghi che il Sig. Can. Trionfetti rivedrà per scegliere ». È certo, del resto, considerando il carteggio, che tutto il materiale micologico da lui raccolto sai stato mandato al Trionfetti senza che però questi abbia risolto mai nulla d’importante e abbia anzi finito per farlo perdere. Era un materiale troppo ingente per una mente così modesta!
La « Dissertatio » è l’ opera di un dotto che non aveva fretta e che voleva sempre studiare. Per il suo tempo, essa risulta un vero trattato di micologia, diviso in tante parti, esatto, chiaro, convincente. Bisogna aver sott’occhio la corrispondenza del Marsili con il Trionfetti fra il 1699 e il 1703 per comprendere come tutto l’enorme materiale micologico accumulato dal Marsili venisse preparato durante le fatiche della guerra con la più ardente passione e illustrato quasi sempre con disegni dal vero di cui alcuni, autoptici, sono veramente artistici.
Se noi pensiamo che la vera scienza dei funghi non ha avuto principio che nel primo quarto del secolo scorso con Bulliard, Persoon, De Candolle, Fries e pochi altri che arricchirono la
1 L. F. M a r s i l i : Dissertatio de generatione Fungorum ad Joannem M a rtin i Lancisium, cu i accedit eiusdem responsio, pag. 7, Romae, 1714 in-folio.
2 Ms. eart., in-fol., 54 X 38% con figure all’acquerello.
A. BALDACCI • I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 287micologia con numerose e preziose scoperte, e poniamo mente che prima di loro Linneo non aveva descritto che un centinaio di specie di funghi, dobbiamo convenire che il Marsili fu un precursore non superato dallo stesso Tournefort, avendo potuto dare con il numero stragrande di specie raccolte in tante parti dell’Europa e studiate scrupolosamente, una classificazione anche se questa non possa dirsi naturale dal punto di vista fisiologico e morfologico di questi vegetali.
La chiave data dal Marsili ha il suo valore, e tanto più lo rivela quando si rifletta che fino alla metà del secolo X V III i funghi non erano quasi stati considerati dai naturalisti come una classe distinta di piante e con la parola Fungi, che comprendeva pochissime specie mangerecce o no, non si faceva per essi alcuna distinzione generica o specifica, se non superficiale.1
1 Ofr. Nova Plantarum genera iuxta Tovrn e fo rtii methodvm disposita.._ Avctore Petro Antonio M ichelio F ior. Florentiae, 1729. Anche la classificazione del Micheli (1. e., pag. 140), benché accuratissima e ricavata da circa 1400 specie, non è però che un tentativo ancora superficiale e non rappresenta un passo in avanti nella tassonomia dei funghi. I l Micheli fu in rapporti col Marsili (o ltre che coll’Institutum Scientiarum Bono- niense) come si può desumere dall’ « Elenchus eorum qui tabulas huic operi adnexas suis sumptibus aeri incidi curarunt » di cui si dà la citazione a pag. 4 dei Nova plantarum generai La Dissertano de genera- tione Fungorum del Marsili è citata nel « Syllabus Auctorum » ai quali i l Micheli ricorse, sebbene nulla appaia del magnifico volume Micheliano che sia stata considerata l ’opera del naturalista bolognese. Invero, il Micheli però, sulla questione dei semi o delle spore ha superato 11 M arsili; egli vede e sostiene la sua scoperta senza entrare in discussioni inutili, dimostrando di essere stato quel genio botanico italiano che la scienza ammirerà nei secoli. Sembra da ammettersi che le scoperte del Micheli siano state tenute segrete fino alla pubblicazione dell’opera e che nulla sia trapelato al Marsili, il quale doveva portare nel sepolcro il suo desiderio, per il quale aveva tanto lottato, di poter sostenere senza alcuna dubbiezza i « semina » nei funghi, mentre il M icheli (che lavorava nel silenzio, parallelamente al nostro) aveva raggiunto il suo sogno poco prima della morte del Marsili. Questo punto della storia della biologia dei funghi dovrebbe venire illustrato a dimostrare, comunque, che la fortuna del Micheli, il quale doveva sapere tutto del Marsili e ne seguiva i passi, trova origine anche dalle ricerche che si facevano a Bologna e che ave
288 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il Marsili non può evidentemente diventare d’un tratto il micologo perfetto da un piano così rudimentale in cui la scienza dei funghi «i trovava al suo tempo, quando correvano ancora su questi vegetali le più bizzarre e strane leggende e i naturalisti non vedevano in essi che il prodotto dell’umido della terra e i risultati della putrefazione di materie organiche.
A questo punto, ecco che il Marsili si rivela l’osservatore e l’interprete delle forme dei funghi, oltre che il raccoglitore e il disegnatore esatto e instancabile, diventando un provetto specialista, anzi un’ autorità che oggi dev’ essere rivelata ed affermata. Egli si era assicurato un fondamento con lo studio delle specie del Bolognese cui pare si dedicasse fino dai più giovani anni e con questa preparazione gli fu relativamente facile raggiungere la compilazione della flora micologica della regione danubiano-carpatica, che un competente in materia potrà un giorno terminare ad onore sommo del nostro concittadino e della scienza. Il Marsili è il vero precursore del Micheli.
vano dato un risultato tangibile. Ma forse è altresì possibile che il M icheli, il quale disponeva ilei grandi mezzi di cui era dotato il suo Istituto, conoscesse la Phytognomonica del napoletano Dalla Porta (ed. 1*, 1588) e si deve a lui il primo accenno della presenza di « semi » nei funghi tanto epigei quanto ipogei (Ofr. P. A. Saccardo : I I primato degli Ita lia n i nella Botanica, Padova, 1893, pag. 71 ; questo cenno è desunto a sua volta da una memoria del Casati inserita nei Rendiconti della R. Accademia delle Scienze di Napoli, 1870, pag. 118) che è del seguente tenore : « E fungis semen perbelle collegimus exiguum et ni- grum in oblongis praesepiolis v. liris latens e pediculo ad pilei eir- cumferentiam protensis ; et praecipue ex illis qui in saxis proveniunt, libi decidente semine perenni facilitate seritur et pullulat. Falso igitur Porphyrius Deoruin filios fungos et tuberà dixit, quod sine semine prove- nirent. Sic in tuberum corticibus, ut in Cupressi pilulis, nigrum etiam latet semen : ob id in sylvis ubi sepius prodierint et computruerint semper proveniunt». I l Dalla Porta è del resto un precursore come si può arguire pure in De Fungis, Francofurti 1592, pag. 763-768 dove r ipete, contrariamente all'opinione suddetta di Porfirio e a quella di Fania <i funghi « neque florem neque seminimi vestigia demonstrare » ) « quod falsum esse iam alibi diximus, quippe semen ferunt » . Cfr. G. B r u z z o ,
©p. eit., pag. 97-99.
Linneo descrive nella seconda metà del secolo X V III un centinaio di specie di funghi; quante ne ha raccolte e disegnate o fatte disegnare il Marsili molto più di mezzo secolo prima? Le carte che egli ci ha lasciato portano i disegni a parecchie centinaia e questo è un punto di gran conto per dimostrare la volontà e l’occhio instancabile dell’insigne bolognese.
Tuttavia è deplorevole che la « Disserta tio » sia rimasta quasi sconosciuta e nessuno ne parli, mentre costituisce una pietra miliare nella storia della micologia. Quando nel 1714 comparve quest’opera, il Marsili non aveva ancora potuto sciogliere alcuna delle grandi incognite sopra la vita dei funghi per le discrepanze profonde che continuavano a tenere divisi i nauralisti del tempo. Perciò, egli si limita a ricordare ciò che avevano scritto i predecessori, botanici e medici, da Teofrasto e Plinio fino ai contemporanei, i quali cominciarono, benché in numero esiguo e sempre con sospetto, ad ammettere i « semi » nei funghi.
Il Marsili ritiene giusto il concetto dei contemporanei di dividere i funghi in tre classi di cui la prima è rappresentata dai funghi che egli considera seminiferi, mentre la seconda è formata da specie che si riproducono dai «'frustuli » (probabilmente i miceli) e la terza ha origine dalla putrefazione di corpi specialmente 'legnosi. Questa credenza, senza che si avesse il coraggio di escludere le due precedenti, era ancora ai tempi del Marsili, come del Malpighi stesso, quella più corrente e rappresentava la più logica interpretazione che si potesse allora sostenere senza farsi cogliere da alcuno. La fama del Malpighi era frattanto diventata altisisma e generalmente apprezzata, nonostante gli oppositori : egli veniva ritenuto come il più competente anche nello studio dei funghi, sebbene a un certo punto, nell’ « Anatome plantarum » sia costretto a scrivere : « Obscu- rissimus mihi est fungorum exortus, et adhuc post multos co- natus ignotus: ut pauca tantum cursim enuntiare possim ad excitandam potius aliorum solertiam, quam ad certa ac vera aperienda » . 1
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 289
1 M . M a lp ig h i : Anatome Plantarum , I I, pag. 66, L o n d in i 1679.
21
290 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il Marsili trasforma le sue classificazioni e finisce per stancarsi di esse per appassionarsi sempre più intorno alle indagini sulla generazione dei funghi. Nonostante le sue diligenti ricerche non riesce però a trovare traccia di semi nei funghi, sebbene ne intuisca la presenza e l’ammetta in taluni dei più piccoli, come in quello che egli chiama fungillo di Menzelio e in specie affini classificate tra i « fungilli calyciformes ».
Egli si appresta a studiare questi fungilli anche con l’aiuto del microscopio, ricavando una serie di osservazioni che sono consacrate principalmente nella Tav. A. dell’opera e che rivelano la grande esattezza dell’autore nelle sue indagini pazienti.
Il fungillo di Menzelio è evidentemente una Gasteromicete, forse un Cyathus dal cui peridio le spore vengono lanciate fuori, come avviene nei Lycoperdon, Tulostoma, Geaster e simili. Il micelio è stato intuito dal Marsili (« fungi per ipsorum frustula propagentur »), come è realmente, intrecciato in forma di fiocchi, di frange e cordoni bianchi; ma ciò che più conta è la visione che il Marsili ebbe del « corpo fruttifero » o sporoforo, il quale offre l’umore zuccherino e con esso le spore ai ditteri ed altri insetti adatti alla disseminazione. Egli intuì ciò di cui tuttavia non parla, perchè non è in grado di dare alcuna spiegazione chiara, giungendo anzi nel contrasto a contraddire e negare sè stesso e mettendosi a un certo punto « contra fauctores seminum in fungillis », quasi per dar ragione anche agli avversari che di « semina » di funghi a Bologna non volevano sapere e si servivano di questo pretesto per denigrare il Marsili e fors’an- che il Malpighi. Non così era a Firenze col Micheli dove pare che la Scuola di Bologna, giudicando dal silenzio del Micheli intorno agli studi micologici dei nostri naturalisti, non venisse considerata.
Siamo nel 1714 e la confusione raggiunge il colmo: dire e disdire è una cosa sola, e ciò continua a mantenere l’ equivoco più strano. Oh ! tempora ! Oh ! mores !
In mezzo a tanto groviglio di pareri però, già nella « Dissertati© » il Marsili contempla le tuberacee, le quali sono da lui ammesse decisamente nella classe dei funghi e descritte con dili
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 291
genza sia per il substrato (situs) in cui vivono, sia per l’odore, il sapore, il colore, quanto per il micelio (tela aranea instar)1 e per ogni loro particolarità. « Tuberà similia sunt in omni fungo » ; tuttavia anche qui i contrasti fra un’idea e l’altra sono enormi e portano alle congetture più strane, sicché le tube- racee possono anche venire considerate come prataiuoli sotterranei e simili.
Se il Malpighi venne dal Marsili bollato di ingenuo con tanto « di vir elarissimus » per la sua confessione sull’ ignoto processo della riproduzione dei funghi, non altrettanto però egli fece per il Trionfetti a favore del quale sostiene le argomentazioni, senza tuttavia specificare che cosa siano i « semi », e benché, com'è noto, si sappia che essi non rappresentavano, in sostanza, nulla di chiaro. Finché gli fu possibile, il Marsili si destreggiò tra il Malpighi e il Trionfetti, sostenendo i criteri dell’uno, che aveva grande fama, ma piegandosi più volentieri per l’amicizia, che nutriva per lui, verso il Trionfetti. La corrispondenza epistolare che egli ebbe col Malpighi non è certamente così assidua come quella che risulta avere avuto col Trionfetti. Dipese ciò dal fatto che il Trionfetti era legato a quella triade formata dal fratello suo Giovanni Battista, dal Dalmini e dallo Sbaraglia che con tanto accanimento e deplorevole acredine combattevano le dottrine del Malpighi?
Indubbiamente il Malpighi era sommo, nonostante le sue manchevolezze, mentre il Trionfetti non appare, ripeto, che un mediocre. Se il Malpighi non fosse venuto a morte, è probabile, io penso, che gli studi del Marsili sul mondo delle Crittogame (la cui vita ed il cui sviluppo erano un’incognita a quei tempi) sarebbero giunti a portare la micologia nel principio del 1700 ad un certo progresso, abbinandosi l’intelligenza dell’uno con la te
1 I I M arsili indovina così la funzione miceliare, il qual fatto è di alta importanza poiché con esso prepara il campo alle esperienze del M icheli a Boboli e a Monte Oliveto e contribuisce a porre la micologia nella sua giusta direzione. Cfr. G. T a b g io n i-T o z z e t t i : N otiz ie della vita e delle opere di P. A. M icheli, Firenze, 1858, pag. 400 e seguenti; G. B b u z z o : Op. cit., pag. 100.
292 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
nacia dell’altro. Perciò l’amicizia del Marsili per il Trionfetti, facendogli velo agli occhi, lo dovette disorientare dallo scopo diretto a cui egli tendeva e che lo assillava con la ricerca della vera origine dei funghi, non riuscendo, nonostante tutte le cure da lui poste per risolvere lo spinoso argomento, a carpire alla natura la soluzione del problema.
Anche a Brisacco (Breisach) il Marsili continuò con ininterrotto zelo ad appassionarsi dei funghi, cercando di perfezionare gli esperimenti della loro coltura che aveva già iniziata alcuni anni prima con l’ottenere qualche scarso risultato: a Brisacco potè averne un grande numero sui diversi substrati, senza mai giungere però a scoprire la ragione della loro comparsa.
Comunque, la classificazione dei funghi non è grande cosa nella « Dissertatio » (dove il Marsili divide i funghi in « duo genera », ossia « terrestres et quos lignum profert »), mentre una classificazione di gran lunga più accurata, sebbene debba ritenersi poi abbandonata, e che a me sembra, per la sua curiosità, degna di essere fatta conoscere, risulta manoscritta da un amanuense nel tomo V II dei cimeli conservati nella R. Biblioteca Universitaria di Bologna. (Y. tav. pag. 18-19).
Evidentemente la « Dissertatio » del Marsili dovette fare la più lusinghiera impressione sull’animo del Lancisi cui veline dedicata ed egli rispose con uno studio che l’insigne nostro concittadino pubblicò nel suo lavoro.1 -
Il Lancisi esordisce entrando direttamente nel vivo della questione dei semi e abbia o non abbia capito il Marsili, o non voglia capirlo (probabilmente perchè egli stesso non sa e non osa pronunciarsi: la sua cultura di naturalista era superficiale e la fama di lui veniva evidentemente esagerata per la posizione che aveva presso il Pontefice), qualcosa vuol dire e così si esprime: « In primis autem doctrina tua dignum, et veritati apprime con- sentaneum illud est, quod a generatione fungorum semina pror- sus eliminaveris. Nam, quamquam sint nonnulla inter vegetabi- lia, quae ad fungorum species referantur, semen habentia » (cita
1 J. M. Lancisi! Dissertatio epistolaris de Ortu, Vegetatione, ac T extura Fungorum ad Coni. L. F. Marsilium. Romae 1714.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 293
il caso « tipico » del Typhoideus Fungus di Malta) riguardo al quale « dubitali possit, an illa subrotunda corpuscula quae in campaniformis plantulae centro reperiuntur, sint vera semina ».
Il Lancisi è tutt’altro che felice perchè il Typhoideus Furigli 8, o Fungo maltese, non ha nulla a vedere con i funghi, essendo una fanerogama (il poligamo Cynomorium ooccineum di Linneo 1 della famiglia delle Balanophoracee), ossia il Fungus Ty- phoides coccinella Melitenais di Boccone2 che il botanico siciliano aveva preso e divulgato egli stesso per un fungo, nominandolo in tal guisa per la forma che ricorda quella della Typha. È naturale che in una fanerogama si vedessero i semi!
Dunque, per quei tempi e per il Lancisi, non v’era che il « fungo » di Boccone del quale si potesse ammettere che avesse i semi. 3
Distrutta così con l’esempio del fungo di Malta la credenza dei sostenitori dei semi nei funghi, il Lancisi affronta la questione dei « suboscura, et tenuissima corpora quae in fungo- rum rimulis delitescunt », i quali sono per lui « insectorum ovula, ac feces », perchè « ad fungos generandos seminibus non est opus » e « fungi ex muli Amo procreantur ».
In sostanza i funghi sotto un certo aspetto si possono para-
1 Amoenitates Academicae, IV , Dissert. 65 (cum icone). Linneo conservo il nome generico elei Micheli, aggiungendovi quello specifico. Le figure di Linneo non sono altro che la riproduzione di quelle del Micheli.
2 lconfa et descriptioncs rariorum plantarum etc., 1674, pag. 80-82 (cum icone, tab. 43). Il Micheli (in Nova plani, genera, pag. 17, tab. 12) aveva già riconosciuto la pianta (da Ini nominata Cynomorium piirpu- reum officina rum ) per una fanerogama parassita e fu il primo a disegnarne i fiori maschili e femminili e dargli il nome generico di Cynomorium (1729), riportandone la descrizione esattissima, la sinonimia, la distribuzione geografica, l’epoca di fioritura e di fruttificazione ecc.
3 B o n a m ic u s J o h . F r a n c . : B rev i» notitia plantarum quae in Melitae et Oaulos insù li s observantur (Ms. del 1670 citato dal Sommier e dal Oa- ruana Gatto in F lora melitenais nova, Firenze, 1915) descrive questa pianta col nome Fucus spieatus coccineus melitenais, pianta singulari» et rarissima nunc prim um euriosis e vulgata, ma essa si trova già menzionata nel 1647 dal Commendatore dell’Ordine di Malta Abela nella sua « Descrizione di Malta ecc. » .
FU N G I
ALII
Cam pestres si- ve in pratis na- scentes non nisi exacta aestate, ib i leguntur propter odorem, ex omnibus ii max im e salubres habentur: et ob colorem tam supra a lb e n te m quam in fra mi- niatum gratissimi aspectus
Super terrain umbrosis campis in pratis humectis
Sylvestres
Super terra vel ad extremitates sy lvaru m , vel in harundinum recessibus sub- crescentes
Super arboribus
quales Fungus Faviginosus, I e I I Species, Lobelii, Mauracher, seu Spitzmorchen vel Stock-M orgen dicti; nec nisi vere Majo ve l Aprili musco tecti, in sylvis prove niunt (caeteris tardius aliquanto pulu- lantibus)
ÌQuercu Betuia Corylo Fraxino
Super aridis lign is Í Quercino (vel inter spineta \ Abietino fruticosa) f Betulino
Hortenses(de his nobis sermo non est) et qui in pulvinis seruntur
4i maceriis, seu parietibus ruinosis fimetis muscofoliis arborum aridis
crescentes
Ad n a s c e n t i a epotius seu vitia arborum et de- viationes succi nutrititii quasi fungi
modo in quercu, et tunc fit pianta, toto genere diversa, Visct quando vero ab aere externo lambitur, (Est tamen muscus alius, a pluviis quide
\ modo in arboribus caeteris: fit gibber seu tumor morbidii
Subtus terralatentes, tubera terrae potius quam fungi dicendi, qui in tractatione
Et hi fin g i sunt, quoad superna, vel
orbiculati I plani acuminati
I la eves ; maculati
hique iteram i crassi- in metam surrectiI depressi, sive tenues et terrae incubantes
Omines isti sunt, quoad substatiam, ve l:
quoad inferna,
quoad colorrem:
quoad reliquas qualitates :
quoad usum et effectum
I flexiles, seu cartilaginosi lignosi, seu solidi fasti, seu tomentosi foliosi ramosi muscosi spongiosi porosimembranaceiproliferipluribus, communi ortu simul nascentibus clavati
| pulvinati
\ redati ( radicati
/ flavescentes, sive buxei ) albidi
Ìspadicei, sive purpurei atro - livescentes
odorem suavem spirantes odore graves, sive foetidi pulverulenti intuslaeteum et dulcem succum prodentes exsucci
/' esculenti, sive innocui } non esculenti, sive perniciales ( letales, ut muscarius
dicta: videlicet, quando succus inspissatnr in agre: evanida fit aura, succus crispatur in museum, uliginosi eaeli, super cortice lign i aridi fruticans)
nodosus, arborem strangulans.
hanc non veniunt.
MSS. Marsiliani (cod. 1044) n° V I I Nova Fungorum Collectio
(pagine prelim inari)
296 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
gonare per la loro generazione, secondo il Lancisi, alle galle. Il noto archiatra (lei Papa Clemente X III vuol continuare dopo ciò a trattare l ’argomento, ma si perde in congetture e lungaggini che non è qui il caso di riportare perchè non servono a rilevare alcuna cosa seria, se non il desiderio di voler trattare, in concorrenza col Marsili e per farsi bello con lui, una questione che egli conosceva appena genericamente, ma che non doveva aver mai approfondito. Prova di ciò è la chiusa del suo lavoro al Marsili : « Te, clarissime Marsili, ducem habui et incentorem. Tu enim magna cum Italiae gloria Institutum con- didisti quo certe nihil superior aetas ad augendas liberales disciplinas vidit illustrius ».
L ’operosità botanica di lui fu molto varia e la sua produzione scientifica sul mondo delle piante assunse forme e vesti singolari; prima egli è osservatore e raccoglitore in campagna, poi diventa disegnatore e descrittore di specie, quindi critico ansioso di apportare sempre più nuove conoscenze alla sua erudizione e a quella versatilità scientifica che tutti gli riconoscono. Non si deve dimenticare, infatti, che il Marsili partecipò notevolmente a quel movimento di idee e a quel rinnovamento di metodi di cui una parte dei dotti del tempo (purtroppo sempre pochi in mezzo alla malvagità dilagante dei più, e sempre come succede) sentiva il bisogno e che prese qualche ardimento, qui in Bologna, specialmente dalle sublimi concezioni del Mal- pighi.
Il Marsili, dotato di ingegno forte e vivace e protetto da salda dottrina, nelle sue ricerche andava avanti con quella volontà che mai non abbandona l'uomo desideroso di arrivare ed ottenne i risultati notevoli nel campo micologico appunto per le sue qualità superiori.
Ma è ai funghi che il suo pensiero si rivolge più che a qualsiasi altra branca di vegetali. Intorno ai funghi egli dovette formare, se si deve giudicare dai disegni e cataloghi rimasti (ossia dal materiale informe e disordinatissimo che ci è pervenuto superstite), collezioni preziosissime e ingenti, non adagiandosi nè sugli allori, nè sulle tristezze e mai cessando di
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 297
raccogliere e studiare. Come vedremo, egli giunse così fino agli ultimi giorni della sua vita interessandosi dei funghi.
Il contributo Marsiliano ai progressi della micologia segna un’orma di cui nessuno può disconoscere l’importanza. Anche senza la « Dissertatio », ciò che resta del materiale micologico di lui costituisce un patrimonio di notizie che, (piando verrà pubblicato, servirà autorevolmente alla storia di questa branca di vegetali. Le sue raccolte nella regione carpatico-danubiana, allora ignota e vergine sotto questo punto di vista, gli servono con l’aiuto dei suoi corrispondenti alla decifrazione di molte e molte specie nuove, suscitando grande interesse nello scoprire fatti ancora non provati o nel confermare ipotesi stabilite da altri.
Una lettera inedita al Lancisi e conservata nel Tomo LXXXVI1 dei manoscritti Marsiliani posseduti dalla R. Biblioteca Universitaria di Bologna chiarisce come il Marsili avesse sempre, fin dagli anni più giovani, un particolare diletto a considerare le diversissime specie di funghi « crescenti con tanta celerità e coll’aiuto delle piogge e di qualche poco di sole tanto nei legni che nella terra e aver avuto più volte giusto motivo di domandare aiuto e lume ad intendere come la vegetazione di queste imperfette piante si facesse dalla natura ». Premette di aver studiato col Malpighi e col vivente Trionfetti, che considera come suoi maestri in questo campo. Ed è veramente peccato che sia andato perduto quasi tutto il carteggio del Marsili col Trionfetti.
Osservando l’abbondanza dei funghi che nascono sul fimo, egli dice a proposito della loro origine : « fra me ragionavo che qui (per i funghi) non vi poteva essere quel decantato seme uguale a quello delle perfette piante, quando non si avesse voluto addurre che i cavalli le avessero mangiate dentro dell’erba e poi rimessele in quei luoghi entro il secesso.
« Come i supposti semi regolati de’ funghi avessero potuto in tanta abbondanza essere stati trasportati dentro dell’erbe e
1 Ms. cart,, in-4, composto di 16 fascicoli di vario formato, tutti contenuti in una busta legata in mezza pergamena.
298 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
poi come questi dentro lo stomaco del cavallo si fossero conservati senza veruna alterazione nella loro struttura, per essere capaci di una così regolata ed abbondante vegetazione......
Le più ingenti raccolte micologiche del Marsili sono degli autunni 1699 e 1700 « castramentando nelle vaste selve del Regno di Croazia e principato di Transilvania per ristabilire i limiti fra i due Imperi ». Colà « mi trovai — egli ha lasciato scritto — fra una così grande affluenza di diverse specie di funghi e di terra e di legni, che mi risolsi di tentare de’ medesimi una grandissima raccolta per mezzo d’una multiplicità di que’ guastatori che meco avevo, facendomene portare e co’ la terra e co’ legni da dove crescevano per meglio esaminare la loro origine....
« Una così gran raccolta m’obbligò commettere a’ disegnatori che meco tenevo di farne le figure componendone un grosso volume intitolato Raccolta de’ Fanghi crescenti ne* Regni di Croazia e d’Ungaria e spedii alle mani dell’erudito Sig.r Dott. Can. Trionfetti perchè volesse ordinarlo sotto il metodo botanico come fece coll’unione d’altro gran numero di questi dell’agro bolognese, esistendo fra miei manoscritti entro l’istituto delle Scienze per attendere a suo tempo d’essere pubblicato ». Il fatto è che, come ho detto, di questa Raccolta non esiste più traccia, che io sappia, e ciò rappresenta una perdita grave j>er la storia della scienza.
Il Marsili però si preoccupava sempre della riproduzione dei funghi senza tuttavia riuscire mai a scoprire traccia in essi di organi riproduttivi o ad accertarsi che quelli che intuiva, ma non chiariva, erano tali.
« Fra questo numero di migliara e migliara di fonghi nè gli occhi miei nè quelli di altri che avevo presso di me e che istrussi, potettero vedere neppure un segno di verun seme, nè al piede, nè per il caule, nè nell’umbella, tanto negli stati d’es- ser piccolissimi, adulti, vicini alla putrefazione, putrefatti ed anche secchi; solo al piede molte volte s’incontrarono certi piccolissimi globetti,, che non erano che giovani fonghi. Ed altre volte nella parte interna dell'ombrella, alcuni grani, e massime dov’erano vermi, e questi piazzati facean vedere ch’erano pure
A. BALDACCI ■ I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 299
ova di insetti; oltre che fra quelle rughe delle ombrelle erano attaccate dal glutine de’ medesimi insetti, senza veruna organica struttura di connessione....
« Sin d’allora m’ espressi con mie lettere al medesimo Sig. R. Can. Trionfetti, che non era possibile di mantenere l’assunto presosi da alcuni, che il fongo nascesse di seme ammaestrando in ciò le tante mie diligenze praticate e tentate per iscoprirlo e che nelle selve della Croazia avevo incontrato un’altra oscurità nella storia della natura toccante le diversità de’ muschi crescenti e ne’ legni lavorati e nelle calvaria degli appiccati, già da molto tempo pendenti dal patibolo senza che in essi pure avessi ritrovati i semi, tanto nella primavera che nella state, autunno ed inverno e delle diverse spezie di questi ne feci una raccolta che al medesimo pure spedii coi rami scolpiti da celebre artefice per pubblicarne la dissertazione ».
In questa lettera al Lancisi nella quale disdice se stesso (e fa vedere con l’incongruenza dei tempi l’eterno dubbio (che, ripeto, serpeggiava fra gli studiosi d’allora ad ammettere apertamente gli organi riproduttivi nei funghi) continua parlando del Vischio e dei tentativi da lui fatti per riprodurlo. La riproduzione nei muschi e nel vischio è pure il suo punto fisso, come nei funghi.
« Ne’ muschi lignei massime sino a quest’ora per li semi resto all’oscuro ». Dunque, « massime per i muschi » egli restava all’oscuro. Ciò che significa come diversamente la pensasse — e già il fatto è altrove ammesso — riguardo alla riproduzione nei funghi. Ma poiché egli aveva grande opinione per il Lancisi conclude : « Toccherà a lei ad esaminarla meglio (la relazione) con autorità da maestro, con amore di amico e con quel- l ’obbligo dirò così che l’adempirebbe il nostro Mons.r Marcello Malpighi se fosse in vita, giacché ella si gloria e con ragione di seguitare il di lui metodo per questi nobili ed innocenti studi ». Troppa grazia, sant’Antonio, quest’unto al Lancisi, sì da ammetterlo alla stregua del Malpighi ! Ed è strano, comunque, che non appaia mai in queste osservazioni il nome del Micheli, il quale pure lavorava con molta serietà intorno allo stesso argomento.
300 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il materiale che ci resta dei funghi è in gran parte di disegni all’acquerello. Il Tomo X V II1 è il più omogeneo e contiene anche una lunga introduzione manoscritta. Esso è intitolato : « Com. Aloysii Ferdinandi Marsili Specimen nistoriae Xaturalis Fun- gorum ». 2
L ’iconografia è raccolta in tanti gruppi secondo la metodologia di quel tempo; qua e là sono state disegnate anche sezioni al microscopio di matrici fungine. Il Tomo termina con un capitolo : « De origine ac modo generationis Fungorum ».
Questo voluminoso materiale lascia ritenere di avere servito come una preparazione alla « Dissertatio » 1 : in esso, infatti, si tratta di ogni argomento che riguarda i funghi di cui si descrivono le specie, che ci sono rimaste quasi tutte disegnate ad naturarli. I funghi sono riportati all’acquerello, più raramente con disegni a penna per intero e in grandezza naturale, oppure in proporzioni ridotte; questi e quelli figurano anche sezionati e visti dall'alto (pars superior) o dal basso (pars inferior). Sono ricordati nomi volgari (per lo più in tedesco, ma anche in slavo, per quanto assai meno): dalla terminologia volgare risulta che il contatto del Marsili dovesse essere più frequente con elementi tedeschi, che con indigeni, e che da quelli più che da questi egli ricavasse le sue notizie. Quasi tutte le specie sono determinate e le determinazioni vengono sovente accompagnate da aggiunte illustrative su caratteri differenziali.
Questa collezione è in grande stile. Il Marsili non si è limitato soltanto a raccogliere e quindi a disegnare o far disegnare i funghi più vistosi o appariscenti, ma dimostra che lo hanno attratto con pari curiosità anche i più piccoli, anzi i più minuti, ossia quelli a vita assolutamente effìmera, di poche ore, ciò che rivela l’occhio sperimentato, perfezionato e direi quasi
1 Ms. cart., in-fol., 45x30, con circa 300 tavole colorite all’acquarello e incollate sulle pagine.
2 II materiale che ha servito alla « Dissertatio » si trova anch’esso disordinato nei manoscritti Marsiliani. Del resto l ’incuria degli uomini per le carte Marsiliane in un determinato periodo di tempo è manifesta anche per le altre opere, pubblicate o no, del nostro naturalista.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 301
infallibile in questo genere di raccolte, e capace e desideroso di afferrare sempre nuove novità per aumentare il patrimonio delle sue raccolte.
« Fungi arborei inter spineta, fruticeta, vel arborum caudi- cibus aut ramis innascentes » sono elencati a seconda delle piante che prediligono, e si può dire che il Marsili abbia raccolto materiale da ogni pianta o di selva o coltivata, sia delle regioni inferiori, sia di quelle più elevate, ma sempre dentro il dominio, a quanto pare, delle boscaglie, senza invadere mai le regioni subalpine o alpine.
Il Tomo V II del Catalogo attuale (che non corrisponde a quello originale come si rileva dal titolo dato dal Fantuzzi)1 ha un’ importanza particolare, potendo far supporre che possa trattarsi di un materiale preparatorio per quella Raccolta de’ Fonghi ecc. che egli mandò al Trionfetti e che venne a perdersi. Forse potrebbe trattarsi anche di un duplicato trasformato. Ad ogni modo il suo titolo è questo : « A. F. Com. Mar- sigli: Nova Fungorum Collectio in qua cuiuscumque generis fungi, terreni aeque ac arborei, quos annis 1699, 1700 transeunti Authori per Croatiam, Slavoniam, pratis silvis, nemoribus natura praedandos posuit; ad nativum expressi repraesentantur ». Anche questo volume è un imponente documento probatorio della volontà, anzi dell’attività instancabile ed inesauribile del Marsili per la ricerca di tesori micologici nelle solitudini barbariche in cui erano avvolte le parti montuose dei paesi che egli era costretto ad attraversare o nei quali per necessità delle sue occupazioni doveva fermarsi. L ’anima dell’insigne bolognese veniva ancor più vivificata dalla permanenza in quei luoghi dove gli si rivelavano patrimoni di studio che i suoi occhi andavano continuamente scoprendo per arricchire le sue collezioni e il suo sapere « ita ut tot solitudines inter ac horridissimas sylvas positi non nisi fera rum, quae in proximis ibi districtibus grassa- bantur, caede, ac venatione taedia illa curarum levare posse- mus. Postquam vero et ipsae sylvae languentiores inde quo
1 G. F a n t u z z i : Memorie della Vita del Generale Marnigli, nota seguente.
302 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
que essent. factae, ad desperationem fere melancoliae redacti era- mus. Jion nisi ergo solimi studium naturae restabat; quod ani- mos nostros potenter incessi!, ac stimulos addidit in illis sylvis angnlos.... cunetos perreptare: ut si quid natura (quae illic in tanta ubertate luxuriat) procreasset, potissimum quod ad Vi- scum, Fungos, Muscum, in quibus iam diu curam nostram po- suimus, attinet... inveniremus » . 1
1 I I testo, copiato evidentemente da un amanuense che non conosceva il latino e non sapeva decifrare il carattere del Mai-sili (ciò pure porta alla considerazione che i Tom i posseduti dalla R. Biblioteca Universitaria non siano quelli originali mandati al Trionfetti, ma copie ordinate dal Mar sili per tenere sempre sotto g li occhi ciò che g li serviva per continuare le ricerche e per qualunque controllo), è stato corretto in questa edizione e suona, a ll’incirca in tal modo: «Cosicché fra tanti deserti e orridissime selve non eravamo capaci di alleviare le noie delle nostre cure se non colla uccisione e la caccia degli animali che si aggiravano in quei prossimi distretti. Ma poiché anche le stesse selve divennero di poi più languenti (rare), eravamo quasi ridotti alla disperazione della melanconia. Non restava dunque se non l’amore (o lo studio) della natura, il quale potentemente invase gli animi nostri e aggiunse stimoli di percorrere ogni angolo di quelle selve, affinchè, se la natura (che quivi lussureggia in tanta libertà) avesse creato qualche altra cosa, specialmente attinente al Visco, ai Funghi, al Musco, nei quali già da lungo tempo abbiamo posto la nostra cura, avessimo potuto rintracciarle ». Per le indicazioni dei Tom i originali veggasi : G. F a n t t t z z i ,
M emorie della vita del Generale M orsigli, passim, in note.Particolarmente interessante è il seguente passo del F a n t u z z i , l. c.,
pag. 184 : L ’altro oggetto « era quello dello studio delle generazione de’ Funghi, Musco, e Visco, come rilevasi dalla raccolta di questo genere di piante lasciata fra suoi manoscritti... » . Questo oggetto, ossia la raccolta originale dei funghi, era così intitolata : « Nova fungorum col- lectio, in qua cujuscumque generis Fungi terreni, aeque ac arborei, quos annis 1699, et 1900 transeunti Auctori per Croatiam et Sclavoniam, Pratis, silvis, nemoribus natura praedandos posuit, ad nativum expressi reprae- sentantur. »
« Plurium generimi Musei, formis, figuris, coloribus variegati ; solo, saxis, arboribus decerpti; H istoriae naturalis ad hanc quoque par- tem absolvendae novum specimen.
« Item Visci historiae novae condendae prima rudimenta, sive folia, fruetus, semina Visci, aere impressa. Demum Catalogus Itinerarius, hoc est Syllabus universalis plantarum et herbarum, quas per Croatiam,
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI BCC. 3 0 »
La parte del Tomo dedicata ai funghi risulta la più importante ed è divisa in:
a) fungi terrestres, terrae, musco, foliis arborum aridis lignis innati;
b) fungi arborei, inter spineta, fruticeta vel arborum cau- dicibus ant ramis innascentes.
Nel volume I II si distinguono tre parti tutte dedicate ai funghi. La prima parte comprende disegni di funghi di varie specie: taluni sono ottimi e rappresentano individualità facilmente riconoscibili, mentre altri non potrebbero portare che a determinazioni incertissime o impossibili dei tipi, figurati da disegnatori poco esperti e che il Marsili non era evidentemente in grado di sostituire con altri migliori, che non aveva.
La seconda parte è intitolata : Fungorum in itinere limitáneo Cis-Danubiano passim collectorum ac naturalibus suis coloribus et figuris depictorum Liber. Questi disegni sono molto scadenti.
La terza parte s’ intitola : Catalogus fungorum terrae, arbo- ribus musco foliis arborum aridis etc. Questo catalogo è cancellato a lapis e dovrebbe quindi ritenersi ripudiato più tardi dal Marsili.
Nel 1714 esce in bella edizione ricca di tavole accurate, la « Dissertatio de generatione Fungorum » intorno alla quale il Marsili aveva diligentemente lavorato con assiduità e passione per intere decine di anni. In essa i tartufi sono considerati nello stesso modo degli altri funghi. È da credere che questo argomento, che lo aveva attratto fin d’allora, fosse già entrato nella sua visione per occuparsene poi particolarmente a miglior tempo, certamente anche per tentare, con nuove ricerche di superare le stesse incertezze che sui tartufi aveva espresso il Malpighi. Questi non era nome da poter venire trascurato e
Bosniam, Sclavoniam, Hungariae inferioris, et Walachiae portionem, eunti Marsilio flora colligendas in aprico posuit sponte nascentes anno 1700 cum aliquot plantarum figuris ad nativum colorem exh ibitis». Tutto questo materiale era compreso, secondo il Fantuzzi, in un volume che portava il n. 3.
3 0 4 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
perciò il Marsili, che si era tenuto molto cauto e in un doveroso riserbo a proposito dei funghi epigei, non poteva certo più arditamente esprimersi sulla generazione delle « Tartufole », che « benché crescenti sotto terra a differenza dei funghi che vegetano fuori della medesima, ad ogni modo fra di loro vi è un’analogia tale da poter credere fra loro quasi un uguale principio ».
Liberatosi dal gravissimo peso che gli dava lo studio dei funghi con la pubblicazione della « Dissertatio », il Marsili comincia dal 1714 ad occuparsi a fondo dei tartufi sui quali possedeva già notizie di carattere generale, e si mette a interessare un numero infinito di corrispondenti. Il 1714 è dunque un anno di base nella vita del Marsili perchè liberandosi di uno studio già completato, può avviarsi a completarne un altro di non minore importanza.
Come aveva fatto per i funghi epigei, il Marsili tiene a preoccuparsi, riguardo ai tartufi, di ricercare gli stadi più eminenti della loro vita, fissando soprattutto l’attenzione se mai, come aveva tentato per i funghi, avesse potuto trovarne il modo della riproduzione, a ciò sforzandosi di poter giungere col seguire gradatamente il ciclo di sviluppo dell’individuo dalla superfìcie del terreno fino alla sua sede sotterranea e dandosi conto di tutte le sue relazioni coll’ambiente.
Se anche egli non è giunto ad alcuna conclusione di rilievo, per il tempo in cui operò, tuttavia il suo nome resta legato ad una serie vasta di osservazioni sovente geniali, e ad ogni modo sempre oculate e pratiche: per questo il materiale da lui lasciatoci sui tartufi sarebbe meritevole di venire illustrato se non altro per dotare la storia degli ipogei di un’infinità di notizie che meritano di essere conosciute. Che il Marsili perseguisse instancabilmente le sue ricerche e volesse giungere a capo di ogni sua idea, almeno di quelle che più ruminava nella sua mente avida di novità, è dimostrato da un questionario con 34 richieste ai collettori e cavatori di tartufi che egli aveva incaricato perchè gli procurassero materiali e notizie.
Con il questionario in discorso egli dimostra la sua inesauribile e insaziabile curiosità di aver notizie sulla vita dei
A. BALDACC1 - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 305tartufi da quanti glie ne avrebbero potuto procurare. Il Tomo LXXXVI dei Manoscritti del Mar sili conservati nella R. Biblioteca Universitaria di Bologna è quasi interamente dedicato ai tartufi. Il fascicolo 10°, oltre gli accenni copiosi che sono pure in altre cartelle del Tomo, è tutto dedicato a interrogazioni e domande del Marsili ai più esperti cavatori di tartufi dei monti di Spoleto e Norcia, oltre che degli agri di S. Giovanni in Persiceto, Budrio, S. Agata, Nonantola o Nolantola nel territorio di Bologna : tutto ciò in riguardo alla « storia naturale dei tartufi » per investigarne la loro generazione, ossia per rintracciarne « i semi », dolendosi di non esser potuto ancora venire a capo di nulla, e chiedendone venia. Il Marsili deve essere stato incontentabile e aver messo sossopra mezzo mondo per la « Tube- rorum historia ».
A mano a mano che le risposte venivano, egli le andava elencando e illustrando con la massima esattezza. Perciò nel Tomo sono contemplate tutte le risposte avute dai detti luoghi alle domande fatte, che hanno sempre un fondamento, il quale si può dire scientifico, e riguardano la topografia dei luoghi che producono tartufi in rapporto alla esposizione e alla durata della loro fertilità e alla profondità in cui vivono, i caratteri della superficie del terreno e la possibilità che altri funghi possano vivere dove nascono tartufi all’epoca della loro generazione, il mese elo stato della luna in cui i tartufi cominciano a prendere il colore e il profumo specifico, l’epoca in cui essi si presentano nella loro maggiore perfezione. Egli richiede terra o « matrice tartufaria » per poterla esaminare col microscopio (su questo punto è fatta speciale raccomandazione ai cavatori perchè, se il bisogno lo richiedesse, il Marsili è disposto a recarsi sui luoghi a vedere la terra per meglio riconoscerla nel suo stato naturale fresco): chi interrogherà, è pregato di diligenza per rinvenire, se è possibile, che cosa sia questa matrice e se vi sia possibilità di avere da matrice tartufaria trasportata altrove, produzione di tartufi come prima. Poi domanda l’effetto che possono avere le nevi, le piogge e i geli sulla produzione e chiede se i querceti siano i luoghi più favorevoli allo sviluppo di questi funghi.
I cavatori vengono interpellati da persone amiche, intelli22
306 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSH.I
genti ed erudite, che il Marsili prega dei loro pareri e delle loro considerazioni. Il materiale, intanto, affluiva da tutte le parti. Sempre più, per ciò, egli si andava appassionando all'argomento, a mano a mano che l’approfondiva, avendo scelto « dall’infinito de’ vegetabili quelli pochissimi che sino ad ora all’occhio universale hanno lasciato oscura la loro organizzazione, e più il metodo col quale si generano ».
Mentre a tutti raccomanda il buon senso perchè le notizie siano quanto mai precise e tali da poter servire ad una dissertazione sui tartufi, come aveva fatto per i funghi, egli si mette a fare a profusione abbozzi di disegni e classificazioni di terreni e di materiale scientifico. La sua preoccupazione resta tuttavia quella di scoprire il modo di vegetare delle diverse specie dei tartufi nei diversi substrati, sia nei querceti, nei castagneti, avellaueti e simili. Egli non tralascia di ricercare anche le larve degli insetti di cui i tartufi sono la preda, studiando gli insetti formati che si aggirano alla superficie delle tartufaie. Non contento di tutte queste indagini, si dirige a scienziati stranieri perchè lo illuminino sopra questo o quel punto che egli si è posto, per dirimere controversie e dubbi che gli vengono ora direttamente, ora per ignoranza altrui.
Lo studio sui tartufi del Marsili non ha nessuna pertinenza colla gastronomia, ma è soltanto rivolto alla scienza pura, e anche questo lato è commendevole e mostra la serietà dell’uomo che vuol mantenersi sempre nel piano elevato del sapere.
Tra i suoi corrispondenti più solerti sull’argomento appare con un fascicolo di lettere l’arciprete Francesco Barto- lucei dal 1714 al 1720.
Questo prelato, originario di Castel S. Pietro, venne nominato nel 1694 Arciprete della parrocchia di Budrio che resse, dice il Fantuzzi, « con somma lode fino all’anno 1726, in cui cessò di vivere li 16 marzo, compianto da tutti per le sue doti di sapere, e per l’attenta cura al suo ministero » . 1 II Bartolucci era dottore in Diritto Canonico e Diritto Romano, ma era anche colto nella Storia Naturale ed essendo amicissimo del
1 G. F a n t u z z i : Notizie degli S critto ri Bolognesi. I , pag. 377.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 307
Marsili, lo aiutò nelle sue ricerche erudite sopra i funghi in generale e i tartufi in particolare, come attestano le sue numerose osservazioni, ricerche e lettere dell’epoca suddetta.
Io penso che il Bartolucci abbia avuto una gran parte nel- l ’influire sul Marsili a continuare lo studio profondo dei tartufi per tentare di sciogliere, con questi vegetali, il problema sulla generazione dei funghi alla quale non era mai potuto riuscire di dare una lucida interpretazione e a sostenerla sulla base di fatti accertati. E quando il Fantuzzi, riferendosi al Bartolucci, scrive che questi si era dedicato a ricercare la generazione dei tartufi, pone la prova di quanto si viene asserendo.
Non mi consta che nonostante il suo notevole sapere e la sua continua ed intelligente attività, l’ Arciprete Bartolucci abbia lasciato qualche pubblicazione. Dai manoscritti che ho avuto in visione, estraggo una classificazione dei funghi che mi sembra meritevole, ma nella quale tuttavia non sono inseriti gli ipogei, che probabilmente egli stentava a ritenere per funghi o prodotti affini, come il Malpighi, il Marsili ed altri ammettevano.
1) Fungi pileati aut non interne lamellati;2) F. pileati et interne lamellati;3) F. pileati ac rugosi vel faviginosi;4) F. membranacei pulveruleuti, hoc est maturi, dehiscen
tes ac pulverem effundentes;5) F. cancellati liquorem foetidum includentes;0) F. coralloides;7) Idem arborei ealyciformes, pelviformes ac similes;8) F. arborei, varioribus dedaleis figuris distincti;9) F. arborei satis carnosi, duri aut solidi.
Naturalmente la generazione dei tartufi avrebbe dovuto essereil fondamento del nuovo lavoro per il quale il Marsili aveva stabilito un sommario con l’ introduzione, la descrizione botanica delle specie, i luoghi natali di essi in monte, collina e pianura, la diversità delle corteccie per porosità, colorazione e struttura interna, ponendo principalmente mente alle differenze fra i tartufi dei nostri paesi e quelli dell’Umbria (dove il nostro concittadino si teneva in carteggio con Monsignor Lazzaro Pai-
308 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
lavicini, Governatore di Spoleto, che gli mandò durante il 1715 notizie, disegni e materiale), senza dimenticare di tener conto della vegetazione dei terreni tartuftgeni e degli insetti tartu- fovori.
Una gran parte della fortuna di tutto questo lavoro del Marsili risale al suo fedele collaboratore Arciprete Bartolucci, il quale appare veramente il più preciso aiuto suo. Egli risponde sempre con esattezza assoluta al questionario Marsiliano, interrogando a decine i cacciatori o cercatori di tartufi e risolvendo tutte le notizie raccolte in una relazione dettagliata al Marsili, e ciò nonostante che fosse angustiato da malanni. L ’Arciprete esclude la presenza di tartufi dove vegetano gli olmi.
Un altro corrispondente degno di memoria è anche il Dr. Domenico Passeri di Norcia che manda una relazione intorno alla natura e generazione dei tartufi, compreso un elenco di specie di questi ipogei che nascono nel territorio di Norcia e richiamando l’attenzione anche alle specie proprie dell’Abruzzo finitimo. Il Marsili si dimostra grato a questi due fedeli interpreti della sua passione e manda a regalare a ciascuno di essi una copia della « Dissertatio de generatione Fungorum ».
Tra i corrispondenti non poteva mancare Lelio Trionfetti, ma le notizie di lui intorno a questo argomento sono generiche « di seconda mano, e stanche e monche, rivelando anche la sua poca attitudine o volontà per questi studi ; nè manca il Dr. Marcantonio Laurenti, filosofo e medico, pubblico professore e poscia medico di Benedetto XIV; egli stende una relazione con una lettera del 9 gennaio 1715 sull’analisi dei tartufi.
Il fascicolo 12 del Tomo LXXXYI contiene oltre il testo e l ’intero materiale che ha servito per formarlo, anche l’atlante di tutte le tavole autoptiche che dovevano andare annesse alla Dissertazione « sempre con l’avidità e speranza di rintracciare particolarmente in cos ifatte piante inperfette quei regolati semi che vediamo nelle piante perfette ». Ecco ancora chiaramente espressi qui il punto altissimo cui tendeva infaticabilmente il Marsili; con un lavoro di tanti anni egli voleva giungere se non a scoprire nei tartufi — organismi da lui divinati affini ai funghi — il modo della loro generazione, come
A. BALDACCI - 1 FONDAMENTI BOTANICI ECC.
appunto dice il titolo del suddetto fascicolo 12. Grandiosa concezione, degna soltanto, dati i tempi, di una mente vasta ed elevata ! Perchè nella « Dissertatio de origine Fungorum » egli poco aveva trovato di ciò cui si appassionava, nè il Malpighi e il Trionfetti, dei quali si tessevano allora le lodi, gli diedero miglior risultato. « Generatio fungorum apud Malpighiuin admodum obscura ». Perchè, girando direzione o seguendo un altro criterio, non avrebbe potuto giungere allo scopo se « tube- rorum et fungorum principium idem est »? Se cercando il seme— le spore — negli epigei non riesce a trovarle e pur non credendo ancora ai loro semi, li intravvede e li sente, non ha dubbio che essi esistano; perciò non li esclude e vuole arrivare a scoprirli per via traversa, col mezzo dei tartufi. È strano che il Micheli non appaia mai in questa grandiosa rete intessuta con tanta e così intelligente e tenace abnegazione. Forse il Micheli, che ha una posizione ufficiale ed è scienziato di laboratorio, disdegna scendere a incontrarsi con un semplice privato, per quanto intelligente dei suoi studi.
Forse è il dubbio del Malpighi che lo invita a persistere. Il sommo naturalista bolognese e Maestro suo è chiamato « erudi- tissimus » anche in una busta del Tomo LXXXVI. E se dal Marsili in altro luogo e forse assai prima egli è chiamato ingenuo, mentre qui è eruditissimo, vuol dire che il sapere del Malpighi altamente lo influenzava e bramava tenergli dietro, tentando di scoprire ciò che al nostro naturalista non era stato concesso. Fu in quel torno che egli intensificò lo studio dei funghi, appassionandosi sempre più a questi vegetali principalmente, come si è visto, durante le campagne di guerra. « Mea militaria munera quae etiam in castris diu gessi, inter prata et venationes per syl- vas, mihi praebuerunt occasionem videndi tot diversas specie» fungorum, quas in ulla alia Italiae parte, multo minus in patria mea nunquam videram ». E fu allora che venne formato 1’ « ingens volumen » di quella « Collecfio Fungorum » che fu mandato al Trionfetti e di cui non sappiamo nulla, benché a lui premesse tanto vederlo pubblicato!
Mentre era riuscito molti anni prima a stabilire che il micelio va inteso come parte del corpo degli epigei (quos tamen
310 MEMORIE INTORNO A h. F. MARSILI
ramusculos fungosae esse substantiae ego quidem non adeo ne- gaveriin, praecipue quod cum ipso fungo connexionem aliquam liabere videantur), giunge finalmente ad ammettere quest’organo anche nei tartufi.
Nella preparazione del suo voluminoso studio sugli ipogei, il Marsili non dimentica di ricercare quanto è stato scritto anteriormente a lui, scendendo da Dioscoride fino ai suoi tempi. Interessante, fra le carte conservate a questo titolo, è una copia dell’« Opusculum » del Ciccarello.1
Non v’è dubbio che il cammino percorso dal Marsili dalla giovinezza fino alla morte per illustrare la vita dei funghi non gli abbia dato molte sorprese, facendogli acquistare una competenza in materia che forse nessun altro del suo tempo, compreso il Malpighi, raggiunse mai. In principio, egli non aveva potuto che seguire il Malpighi stesso, il quale molto si dibattè particolarmente per la questione delle radici e dei semi dei funghi, senza ottenerne risultato sicuro. Il Marsili non trovava modo, allora, di veder meglio del maestro. « Obscurissimus mihi (il Malpighi scriveva) est ipsorum (dei funghi) exortus, et adhuc post multos conatU8 ignotus ut pauca tantum cursim enuntiare possim ad excitandam potius aliorum solertiam, quam ad certa ac vera aperienda ». E — sempre allora — egli non sa allontanarsi dagli antichi e crede che i funghi « sunt excrescentiae terrae, nec semen, nec florem habent, sed sponte nocte una, aut altera e terra emergunt ex quadam commixtione salis sulphuris iuncta terrae pinguedini » secondo l’espressione del Morison nel Dialogo unito all’opera « Hortus regius blesiensis auctus », uscito a Londra nel 1669. Queste idee egli riafferma a Trionfetti in una sua lettera del 20 giugno 1703 da Brisacco colla persuasione di avere risolto in tal modo la questione circa l'origine e la natura dei funghi. Era il periodo d’oro del suo carteggio col Trionfetti al quale, come si è visto, mandava tutte le sue rac
1 Opusculum de tuberibus, Alphonso Ciccarello ph.vsico de Maevania auctore Patavii 1564. - V i è aggiunto un opuscolo: De Clltiunno flumine celeberrimo.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 311
colte e tutte le sue vedute durante l’intera sua attività di soldato e di diplomatico. Gli anni lo dovevano però portare gradatamente alla realtà e pur nella dubbiezza, che è qua e là manifesta ancora nella « Dissertatio », la presenza dei « semi » e la funzione del micelio sono due fatti da lui assicurati alla scienza.
L ’ossessione del Marsili è di giungere alla sicurezza assoluta della presenza dei semi nei funghi e intorno a ciò non lascia alcun artifìcio; siamo qui tra il 1720 e il 1730. Ma ciò che più stupisce in questa sua incessante e sconfinata attività è di sapere com’egli trovasse il tempo di occuparsi con tanta diligenza di simili studi difficili e complessi, egli che, specialmente dopo la sventura di Brisacco e durante l'ultimo decennio della sua vita era sempre in viaggio, in Italia e fuori ! Quale gigantesca forza agiva in lui!
Un giorno verrà chiarita la parte senza dubbio notevole che gli studi Marsiliani sui funghi in generale e sui muschi ebbero per il Micheli.
Non contento di tutto questo, il Marsili aveva anche provveduto ad una « dissertazione sopra diversi funghi, che nascono ne’ siti dove si cavano li tuberi esculenti, e con l’edizione di un’altra sopra due altri funghi, che nascono altrove, cioè di certi prataioli, che crescono l’uno nell’altro, e di un altro fungo di figura di clava, che ha sembianze d’avere li semi ».
La sua mente era instancabile a ricercare novità sopra novità e intorno a qualsiasi argomento che si riportasse alla vita dei funghi o epigei o ipogei, e tutto voleva vedere e discutere e controllare per chiarire le relazioni esistenti fra gli uni e gli altri.
Il Marsili morì il 1° Novembre 1730, restando fedele fino all’ultimo ai suoi studi sui tartufi. Vi è ancora una lettera del 23 Luglio 1730 conservata nello stesso Tomo LXXXYI in cui rammenta la scoperta di un « fungo corallino » da lui fatto disegnare e del quale dà le notizie che gli era riuscito raccogliere.
Più che alle fanerogame, egli si sentì trasportato alle crittogame. E che egli abbia limitato i suoi studi a queste piante
312 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
è detto da lui in una lettera senza indirizzo nè data esistente nel Tomo LXXXYI. « Noturn tibi est.... cuín longo itinere Pan- nonias peragrabam et Illyricas regiones, fungorum, muscorum et visci historiam naturalem incepisse ».
Poco o nulla egli ci ha lasciato scritto dei muschi (sensu antiquo), benché le collezioni che ci rimangono siano abbastanza copiose, specialmente nel Tomo V II dove si trova una figura con un « frustulum musei ex quo enatum apparet fioscu- lum perelegans et amabilis aspectus, colori» cinnabarini, in ar- borein quandoque exaratis fibrillis.... et subtilissimo pilo minore etc. ». Che cosa sarà questo « frustulum musei » dal quale esce fuori questo fiorellino elegante? Forse uno sporogonio dello stesso muschio? Comunque il Marsili si rivela anche qui osservatore diligente.
Muschi e licheni, selaginelle e licopodi sono considerati dal Marsili in una stessa categoria come si può vedere nella seconda parte del Tomo V II (« plurium generimi musei, foimis, flguris, coloribus variegati; solo, saxis, arboribus decerpti; Ilisto- riae naturalis ad liane quoque partem absolvendae novum specimen »). Questa parte contiene una specie di prefazione e un indice, oltre le tavole rispettive delle specie a penna e all’ac- quarello. Il Tomo XIV è un « liber in quo musei varii arboribus, lignis, lapidibus, passim decerpti ac collecti, in natura exhiben- tur ». Vi è premesso un indice. Si tratta di una collezione vera e propria di essiccata di muschi, licheni, selaginelle, licopodi con alcune alghe senza alcuna indicazione di località. Come generalmente accade negli altri codici, anche qui le determinazioni non sono di mano del Marsili, ma non si può dubitare che esse siano Marsiliane, essendosi egli dedicato anche ai muschi con una certa passione, come per i funghi, parlando del « muscorum ortus » nella « Dissertatio de generatione Fungorum ».
Nel Tomo IV, parte 6*, del « Catalogus plantarum » sono elencate alla lettera F oltre 50 specie di funghi e alla lettera M una serie di muschi (muschi e licheni) sulficenteinente descritti a uno a uno. Astraendo dai tartufi che, come lasciò scritto nella classificazione dei funghi sopra riportata, non vennero trattati nella « Dissertatio de generatione Fungorum », avendo
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 815
stabilito di farne argomento a parte, egli considerò come una divisione dei funghi le « Adnascentiae potius seu vitia arborum et deviationes succi nutrititii, quasi fungi » che sono suddivise in due gruppi dei quali uno il Vischio, costituisce il fondamento, mentre nell’altro stanno le galle e le deformazioni.
« Ubi Viscus aut fungus vegetat in arbore, ibi inftrmatas tumescens arboris est, quod ipsum nec nisi in cortice con- tingit, quo super erumpunt haec producía : ita ut, arbor < Inani incipit generare fungos, aut viscum, iam anima sua vegetativa incipiat deficere, atque similiter credi potest de musco: quia quanto plus arbores erectae aut sideratae incipiunt steri- lescere, eo magis teguntur ista senectute ». Così ha lasciato scritto nel Tomo V II la cui ultima parte è parimenti dedicata al Vischio, con una intera storia di questa pianta che aveva interessato tanto la fantasia del Marsili. Qui è superfluo riprodurre i suoi concetti sul Vischio, ritenendo sufficiente ricordare le belle tavole con disegni a penna di questa « pianta toto genere diversa Viscus dieta ». Nientemeno il Marsili considerava in un catalogo annesso allo stesso Tomo V II dieci « varia genera Visci ».
Del Vischio egli ha parlato ampiamente trovandosi notizie in quasi tutti i Tomi dei suoi manoscritti che riguardano le piante. È da ritenersi che anche sul Vischio egli avesse composto un volume speciale che il tempo dovette manomettere portando al disordine attuale il materiale specifico superstite. Comunque il Vischio era diventato un’ altra sua ossessione. Nella parte ottava del Tomo IV sono rappresentate cinque sezioni di legni a colori per mostrare l’ inserzione del Vischio nel corpo legnoso. Le specie matrici non sono identificabili. Nella parte quattordicesima dello stesso Tomo una serie di 4 carte con disegni a colori rappresentano diversi stadi della vita del Vischio nell’abete. Nella parte sesta nel « Catalogus plantarum » ivi annesso si trova alla lettera V una serie di forme di Viscus a seconda delle diverse specie di alberi sui quali esso vegeta. La parte ventunesima dello stesso Tomo riporta una tavola a co- lori del Vischio.
314 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
In quanto alle fanerogame, il Marsili non ci ha lasciato che un materiale scarso in confronto ai funghi e agli altri gruppi di piante finora considerati. Noi sappiamo che egli incominciò a studiare le fanerogame a Padova. D’altra parte, egli ci assicura fin dalle prime righe della lettera al Lancisi nella « Dissertalo de generatione Fungorum » che si occupò delle piante dalla prima giovinezza, dichiarando essere i suoi maestri l’illustrissimo Malpighi degno di sempiterna memoria e Lelio Trion- fetti. Saremmo tuttavia quasi per credere che il Malpighi e il Trionfetti, assorti più tardi, con criterio e ingegno ben diversi, intorno al problema della generazione dei funghi, orientassero la mente dei Marsili verso questi organismi e lasciasse, perciò, in secondo ordine le fanerogame.
All’infuori di cataloghi di piante, nulla rivelano i manoscritti Marsiliani che egli si sia dedicato in modo particolare alle piante superiori, nè il carteggio che il nostro grande tiene col Trionfetti e con altri ci appalesa di più.
In ogni modo, come ho detto, sulle fanerogame non ci restano del Marsili che semplici cataloghi, uno solo dei quali è stato pubblicato nel « Danubius Pannonico - Mysicus » 1 e illustrato dal Neilreich. -
Prima di quest’opera egli aveva pubblicato il « Prodromus Operis Danubialis », che è un saggio cospicuo di un’opera magnifica », come il Cassini la chiamò 3 e che illustra la vasta, sconfinata regione, la quale fu veramente la palestra dove il Marsili era stato destinato a raccogliere i titoli più alti anche per la sua immortalità scientifica.
Il Danubio pannonico - misio è un’opera di grande mole e di
1 Danubius Pannonico - Mysicus, observationibus geographicis, astro- nomicis, hydrograficis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus ab Aloysio Ferd. Com. Marsili Socio Regiaruin Societatum Pa- risiensis Londinensis Monspeliensis, Haghae et Amstelodami, 1726. Nel 1700 aveva pubblicato un Prodromo di questa opera mirabile.
2 A. N e il b e ic h : Die botanischen Leistungen des Dr. Burser und des Conte M arxigli in Nieder-Österreich, in K. K. Zool.-bot. Gesellsch., Wien, 1866.
3 Ofr. G. B k u z z o : 1. C., pag. 74.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 315straordinaria importanza scientifica per la conoscenza geografica della regione danubiana centrale e porge notizie di molto conto sulla determinazione astronomica dei principali punti, sulla conformazione delle ricchezze naturali di essa, sull’idro- grafia del Danubio, sulle antichità, sui prodotti del suolo, sulle acque ecc. La parte botanica risulta la più ridotta ed è riportata nel V I Tomo con un semplice catalogo nel quale « ea tantum genera reposuimus, quae circa Danubium in nemoribus, insulis, col- libus, aliisque finitimis locis sponte sua proveniunt, et quae sal- tem pro temporum, graviorumque munerum ad alia nos vocan- tium difficili conditione observare potuimus » (VI, 51). Il catalogo è condotto « ordine alphabetico ex Tabernemontani Historia reformata... et ex Caspari Bahuini Pinace ».
Sono notevoli i disegni inediti divisi in due gruppi con tavole di diversa dimensione che si trovano intercalati nel Tomo IV della Collezione dei manoscritti del Marsili. Si tratta di disegni a penna, di perfetta esecuzione che rappresentano una trentina di specie e che secondo Lodovico Frati dovevano servire per l’opera Danubiale. Io noto tuttavia che essi non hanno niente a vedere con le piante pubblicate, le quali anche secondo il Neil- reich non risulterebbero determinate giustamente e stanno a rappresentare una raccolta personale, non riportando il Marsili alcuna delle piante del Danubio ricordate da Clusio. Ad ogni modo, il Neilreich ha elencato queste piante, come pure altre fanerogame danubiane del Marsili, coi nomi del metodo del- P Endlicher. I dati Marsiliani non hanno nell’odierno stato delle conoscenze della flora delle piante superiori della regione media del Danubio (dove le specie vennero raccolte ed elencate durante la guerra colla Turchia) alcun altro valore di quello puramente storico.
L’ habitat è riportato per ogni specie. Quando si ricorda, il Marsili ha tenuto conto anche della località. Questo catalogo del « Danubius pannonico -'mysicus » comprende qualche centinaio di specie che sono per la massima parte diffuse in area geografica vasta e quindi molto note: in generale si tratta di piante cornimi dell’Europa centrale.
316 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Ciò sta a dimostrare che egli non aveva particolare preparazione per la flora fanerogamica e per le sue rarità e i suoi endemismi. La cosa si rivela, del resto, dai diversi cataloghi manoscritti, il più importante dei quali è compreso nel Tomo IV del Fondo Marsili della nostra Biblioteca e che si intitola : « Catalo- gus itinerarius, hoc est Syllogus universali» plantarum et herba- rum quas per Oroatiam, Bosniam, Sclavoniam, Hungariae infe- rioris et Valachiae portionem euntibus nobis, flora colligendas in aprico posuit sponte naseentes, a mense Maio ad mensem Octo- bris usque inclusive anni MDCC cum aliquot plantarum flguris ad nativum colorem exliibitis ». Questo catalogo di fanerogame disposto per ordine alfabetico di mano non Marsiliana è diviso in tre parti regionali, ossia : 1° piante raccolte in Croazia « intra fluvios Savum, Unnam, Glinam et Colapim»; 2° piante della Bosnia; 3° piante della Sclavonia, Ungheria e Valacchia.
Sembra che questo catalogo, il quale è il piti ricco di quanti il Marsili ci ha lasciato per le fanerogame debba venire intercalato da un altro elenco esistente nello stesso Tomo e che si intitola : « Catalogus itinerarius hoc est Syllogus universalis plantarum herbarumque quas per Bosniam, Sclavoniam et Hungariae portionem euntibus nobis flora colligendas in aprico posuit per menses Julium et Augustum, praeter eas quas jam per Croatiam collegimus, exceptis quibusdam quarum catalogus infra...». Mentre per il Catalogo precedente non mancano gli habitat (loca ge- neralia) e le località (loca specialia) e si danno per alcune specie i disegni dal vero, questo secondo catalogo non è che un nudo elenco per ordine alfabetico con la sola enunciazione della specie, senza menzione alcuna di habitat e di località. Anche questo catalogo è diviso in tante parti secondo le regioni ed è stato composto da un amanuense del Marsili che ha lasciato monco il testo latino.1
1 Questa e le altre citazioni sono diverse nel testo dei Tomi superstiti in confronto alle indicazioni del Fantuzzi, 1. c., ciò che dimostra, una volta di più, come i Tomi originali debbano essere andati perduti e come quelli superstiti siano il risultato dell'ordinamento affrettato di reliquie di materiale caduto in disordine.
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 317Un terzo catalogo è il seguente: « Catalogus plantarum in
tra fluvios Savum, Colapim, Unnarn, Glinarn, Slunitzam, sponte nascentium cum synonimis botanicorum laudatissimorum se- cundum ordinem alpliabeticum ». In questo catalogo sono compresi, alla lettera M, i muschi di cui sopra si è parlato e alla lettera V, il Vischio.
Un catalogo di alberi e frutici indigeni della Svizzera per la raccolta di legnami utili, disposto in ordine alfabetico, apre il Tomo IV. In esso si hanno accanto alla nomenclatura botanica le denominazioni tedesche delle specie citate.
Questo Tomo IV° è il più importante per le fanerogame e risulta di diversi fascicoli sparsi di cui uno contiene 19 carte con circa una trentina di specie di fanerogame della valle del Danubio, tutte facilmente determinabili. I disegni sono a colori. Segue una tavola a colori con disegni di un albero indecifrabile, che il Marsili descrive nel retro del foglio, come producente un frutto a guisa di ghianda di cui si cibano i porci e che dà un legno bellissimo. In questo fascicolo si trova anche il disegno di una pianta di cappero in flore.
Segue una tavola a colori con un pessimo disegno di albero di Tasso ( Taxus baccata) e di un ramo nel retro del foglio precedente con una lunga annotazione sulla stessa pianta.
Il Marsili faceva disegnare anche i frutti e un fascicolo di 4 carte segue per questo scopo la tavola del Tasso. Altri disegni di frutta ad acquarello sono sparsi altrove senza ordine alcuno, incolpabile al disordine in cui caddero le carte, come è di tutto il materiale precedente.
Seguono due carte con due disegni a colori, irroconoscibili ; l ’uno sembra essere di un rizoma di graminacea, probabilmente delle nostre valli bolognesi di cui il Marsili si occupò assai degnamente.
Non trascura il Marsili le piante coltivate. Il noce richiamò la sua attenzione e disegni di questo albero si trovano sparsi e al solito confusi senz’ordine qua e là tra i materiali superstiti.
Come fu generalmente fino a Linneo, i libri di flore con gli « erbolari » e le raccolte di piante in genere assai di rado si occupano dell ’habitat dei vegetali che si raccoglievano o si
318 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
annotavano, e tanto meno si teneva conto delle località speciali. Laonde è questa lacuna che anche in Marsili è frequente e troppo sarebbe pretendere che egli solo vi avesse posto mente e non l’avesse lasciata. Molto ha fatto coll’indicare sovente le regioni dove le sue piante vennero raccolte e le selve dei monti da lui esplorate. D’altra parte non sarebbe forse diffìcile cercare fruttuosamente le località delle piante elencate nei cataloghi quando si prendessero come base di ricerca gli accampamenti (« ex meis castris 1700 ») che egli tenne tra la line del 1600 e il principio del 1700.
Ma dove sono andate a finire anche queste collezioni di essiccata che potrebbero vantaggiosamente servire come contribuzione alla conoscenza della flora fanerogamica delle regioni percorse dal Marsili?
Non importa se queste collezioni non sono copiose come le raccolte dei funghi il cui numero è di gran lunga superiore e senza confronto; ciò che interessa sapere è che egli fu un osservatore diligente ed acuto anche per le fanerogame, non poche delle quali, specialmente di quelle disegnate, sono preziose per quei tempi, tanto più perchè vennero raccolte qualche volta anche durante i brevi intervalli tra il fragore delle armi e il tumulto delle battaglie, quando il Marsili continuamente ricercava e raccoglieva, quasi incurante di ogni pericolo per la sua vita.
Il Marsili è un naturalista illustre, un geografo insigne, un architetto militare celebre, un soldato valoroso, un cittadino benemerito. Il ricchissimo materiale che egli donò alla sua città natale e che illustra un' immensa regione dell’ Europa, ancora oggi meta di ricerche e campo di studi profondi, oltre che di lotte politiche che possono sconvolgere nuovamente il mondo, è un monumento imperituro che si innalza sublime dentro un orizzonte vastissimo dell’umano sapere.
Nato per la scienza, ma portato dal destino anche alle armi e alla diplomazia nelle quali pure brillò, accoppiando il coraggio per l’avventura all’ingegno meditativo, dalle più alte vette della fortuna precipitato nel fondo delle miserie e abbandonato da
tutti, il Marsili, lavoratore instancabile e geniale in ogni momento fausto o avverso della sua vita, devoto all’Umanità che ha servito brillantemente dall’adolescenza all’ultimo giorno della sua vita, merita veramente che egli sia sempre presente nella memoria delle nazioni da lui servite e prima d’ogni altra, dopo la sua Bologna, dell’Ungheria per la quale mise a disposizione tutto sè stesso.
Il Marsili muore soddisfatto dell’opera compiuta, ma non può essere pago dell’altrui riconoscenza. Ho trovato scritto nel Chierici 1 che « gli uomini d’ingegno, i benefattori dell’Umanità non confidino mai troppo nella giustizia de’ loro contemporanei e massime in quella de’ potenti» e purtroppo questo detto è sempre vero. Il nome di Luigi Ferdinando Marsili, sacro all’Italia, celebre nella scienza e nell’arte della guerra, è stato per troppo lungo tempo contrastato da molti alla gloria e a quei piani della celebrità ov’egli deve emergere. Bologna ha un dovere di madre verso il Marsili che non si può compiere con una semplice dimostrazione formale limitata alle nostre modeste mura e a qualche cerimonia, ma vuole che la solennità della commemorazione di questo immortale assurga a una festa mondiale della scienza e in quella occasione sia costituito un Comitato di dotti perchè tutte le carte manoscritte superstiti del nostro grande vengano sistemate e pubblicate in tanti volumi speciali quanti sono stati gli argomenti da lui elaborati e in mezzo a difficoltà enormi portati a termine. Per i botanici il primo volume deve essere quello importantissimo sui Tartufi, togliendo finalmente dal silenzio e dal disordine in cui si trova la trattazione di questi vegetali singolari che la morte non gli permise di dare alla luce.
Bologna, Pasqua - Monzuno, Ferragosto 1930.
A. B a ld a c c i
A. BALDACCI - I FONDAMENTI BOTANICI ECC. 31i>
1 T. C h ie b ic i : I I Conte Lu ig i Ferdinando M arsili. Cenni biografici, Bologna, 1871.
Gli strumenti di fisica.
Ferdinando Marsili colla fondazione dell’ Istituto delle Scienze quale la concepì e la realizzò va considerato come il fondatore della maggior parte degli attuali Istituti Scientifici della Università di Bologna ed in particolare come il fondatore di quell’ Istituto fìsico che ora prende il nome da Augusto Righi.
Se pur fu nei voti e nelle speranze del munifico donatore, certo si è che questa ultima istituzione dovè ricevere un crisma di perfettibilità e di luminoso avvenire del quale le prime manifestazioni si ebbero con gesti numerosi di alta magnanimità verso di essa. La storia principalmente ricorda la munificenza grande di S. S. Benedetto XIV che quasi sembrò oscurare l’iniziale, e quelle del Principe D. Giovanni Lambertini, del Marchese Giuseppe Angelelli, del professore Bartolomeo Beccari, di Gio. Lodovico Quadri e di coloro che nel 1790 contribuirono per 1’ acquisto a Firenze del famoso Museo Cowperiano. Il tavolo destinato inizialmente a ricevere intorno a sè professori e studenti per la istruzione, diventava nel 1815 (un secolo dopo) un bello ed ampio anfiteatro capace di numeroso uditorio.
Della donazione Marsiliana, la parte che riguarda la fisica, se si tien conto dello stato nel quale si trovava questa scienza in quel tempo, è veramente notevole.
Siamo ai primi del 1714. Meccanica antica, di Galileo, di Newton; pneumatica torricelliana e di Boyle nella quale già spunta la teoria cinetica dei gas; ottica antica e di Newton; misurazioni termometriche ma non ancora termologia; feno
23
322 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
meni presentati dalle caiamite; formano la base di ogni sperimentazione. Si comincia, a dir vero, a considerare anche lo studio della elettricità che dovrà poi costituire quel capitolo grandioso come sappiamo, ma esso non ha ancora sensibile base strumentale se si eccettua il rudimento di macchina elettrica ideata da Ottone di Guericke e la sua modificazione suggerita da Hawksbee, facilmente realizziabili in laboratorio secondo specifiche istruzioni che si trovano nei libri del tempo.
Orbene, il dono del Marsili tocca tutti gli argomenti su indicati se si eccettua la elettricità.
Questa tenue esclusione prova forse una deficenza nel donatore, di cognizioni nel campo della Fisica, o trascuratezza di questa Scienza nella fondazione del nuovo Istituto? No certo, anche perchè il Marsili ne riconosceva l’altissima importanza a risolvere grandiosi problemi della Natura, e perchè egli stesso si era occupato di essa varie volte. Egli aveva difatti fra altro ideato un pesa liquori, aveva studiato la colorazione dei cristalli ed aveva indagato a lungo sul fenomeno di fosforescenza presentato dal cosidetto fosforo di Bologna discutendo su ipotesi di sua interpretazione una delle quali (quella di Hawksbee)lo considera un fatto elettrico.
Forse la esclusione dimostra invece che il Marsili ammetteva implicitamente che chi avrebbe tenuta la cattedra di Fisica nel nuovo Istituto doveva possedere tendenza ed abilità a realizzare in laboratorio strumenti e dispositivi di agevole realizzazione o in altre parole quello che noi oggi chiamamo abilità sperimentale e che purtroppo è rara in chi debba anche avere— come il fisico — tendenza alla sobria e retta speculazione. Ciò in quel tempo poteva considerarsi una diritta professione di fede. Perchè dopo tutto, quanto a metodo, la Fisica attraversava allora un periodo non molto buono.
Dopo la grande instaurazione in essa operata dal Galilei e per la quale larghi progressi e larga messe aveva dati la ricerca sperimentale, dopo la mirabile opera di indagine particolare e di coordinazione che fece grande Isacco Newton, si era avuto un periodo quanti altri mai felice, ma purtroppo esso era stato
L. AMADUZZI - GLI STRUMENTI DI FISICA 323
di non lunga durata. La meritata fortuna di grandi e geniali ipotesi aveva portato a deplorevoli imitazioni per la spiegazione di fatti singoli e di secondaria importanza e si era molto diffuso il vezzo, quasi metodo nuovo ed infallibile di ricerca, di sbrigliare la fantasia invece di piegare la intelligenza a trarre per mezzo della esperienza nuovi elementi di progresso.
Luigi Ferdinando Marsili — troppi segui ne ha dati — era uomo fattivo e di equilibrio e non poteva vedere la fisica se non quale essa deve essere, scienza cioè che trae strumento ed alimento dalla speculazione ma sopratutto dalla esperienza e dalla osservazione. Nessuna meraviglia quindi che nel nuovo Istituto delle Scienze la faccia intervenire sì a compiere il suo doppio ufficio di maestra e di esploratrice con quei mezzi di dimostrazione e di ricerca che in quel tempo sono quanto di più e di meglio non potevano desiderarsi, ma sottintenda anche nei maestri coll’abito a pensare ed a meditare l’abito ad operare.
L ’elenco degli strumenti di fìsica si trova completo nello strumento di donazione che come è noto fu pubblicato e del quale dò qui la riproduzione delle pagine che alla fìsica si riferiscono; ma, valendomi di uno scrittore del tempo, mi piace dare una indicazione sostanziale di tali strumenti accennando anche alla distribuzione loro nelle sale dell’istituto.
L ’appartamento della fìsica — si direbbe ora l’ Istituto di Fisica — comprendeva tre camere. La prima era destinata a ricevere gli studenti, che in essa venivano raccolti attorno ad una lunga tavola sulla quale venivano disposti volta a volta gli strumenti per le dimostrazioni del professore. Ad un estremo della tavola stessa era però fissata stabilmente una pompa pneumatica di Boyle. Vi erano inoltre parecchi termometri e barometri, principalmente per la dimostrazione delle proprietà fìsiche della atmosfera.
Ai muri della camera erano appesi parecchi quadri rappresentativi di cascate naturali di acqua (come quella di Tivoli, quella di San Lorenzo al disopra di Quebec nella allora detta Nuova Francia e altre) e di iridi formantisi nei loro getti, di sorgenti di acque minerali diffuse in Europa (come quelle di
324 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Forge, di Bourbon e delle montagne modenesi). In uno degli angoli della camera era infine una Fontana di Erone.
La seconda camera conteneva caiamite naturali varie in colore ed in forza. La più considerevole era di color grigio-ferro, pesava 18 oncie e poteva sostenere 25 libbre. Il dottor Beccari che ebbe per primo la direzione dell’appartamento od Istituto di Fisica potè su di esse fare un corso annuo di lezioni sulle virtù dei magneti, il che a dir vero sembra prodigioso per la scienza magnetica del tempo. In questa medesima camera era anche disposto un armadio a vetri nel quale si conservavano sotto chiave utensili propri alla dissezione di corpi di animali destinati all’uso del professore di fisica.
Nella terza camera era disposta un’altra pompa pneumatica su un bel piedistallo che però veniva usata raramente essendo l’altra già indicata più comoda all’uso. Un tavolo fissato tutt’ingiro alle pareti sosteneva disposti in bell’ordine vari modelli e strumenti di statica, stadere romane, leve, bilancie, piani inclinati, puleggie, dispositivi a ruote dentate, cunei e la vite di Archimede. Entro un armadio a vetri erano conservati sotto chiave quattro eccellenti microscopi uno dei quali del celebre Campani.
Vi era ancora un lungo piano inclinato nel quale era stata scavata una scanalatura opportunamente graduata per le esperienze di Galileo sulla caduta dei corpi lungo un piano inclinato. Infine la camera conteneva una specie di quadrante in ottone diviso esattamente in gradi e minuti sul suo orlo e posto verticalmente su di un piedistallo con annesse alcune sfere in avorio pendenti dal centro sul limbo, e ciò per fare esperienze sulla accelerazione dei corpi che cadono, per dimostrare l’isocronismo delle oscillazioni pendolari e per dimostrazioni sull’urto dei corpi ed altro.
Del materiale donato dal Marsili nulla o quasi più rimane. La conoscenza che in quasi cinque lustri di mia permanenza nell’istituto Fisico di Bologna ebbi ad acquistarmi degli strumenti e degli apparecchi in questo esistenti ed il particolare esame che col consenso del prof. Quirino Majorana attuale direttore di quell’istituto fece di recente dietro mia preghiera
L. AMADUZZI - GLI STRUMENTI DI FISICA 325l ’aiuto dott. Cesare Pirotti permettono una siffatta dolorosa asserzione: che con relativa sicurezza si può solo dire che rimangano soltanto tre microscopi con modelli di statica e stadere. I tre microscopi sarebbero della fabbrica Dollond di Londra e come tali sono anche indicati nel primo dei più sotto citati inventari. Potrà esistere anche qualche strumento in vetro ma non è possibile identificarlo. Ma lo strano è che nulla a riguardo di tale materiale come dono del Marsili risulti in modo specifico e chiaro dai due inventari che rimangono, il che rende diffìcile fissare l’epoca o le epoche di scomparsa, certo però anteriori al 1890. Il primo, redatto dal prof. Silvestro Gherardi, ha per titolo: «Catalogo del Gabinetto di Fisica della Pontificia Università di Bologna chiuso in Agosto 1835 colle aggiunte degli anni consecutivi». Esso incomincia colle parole: « L ’ordinamento dell’ Accademia delle Scienze dell’ Istituto di Bologna, avvenuto nel 1745, dava origine a questo cospicuo gabinetto ». Il secondo inventario va fino al 2 marzo 1874 ed è controfirmato dal prof. Emilio Villari, dal Rettore della Università Albicini e dal ragioniere capo C. Ganni e porta il titolo : « Ministero della Pubblica Istruzione - Inventario della proprietà mobili dello Stato, esistenti al 31 Dicembre 1870 nel Gabinetto di Fisica della R. Università di Bologna, compilato a termine dell’art. 17 e seg. del Regolamento generale per la Amministrazione del Patrimonio dello Stato e per la contabilità generale, annesso al Regio Decreto 4 Settembre 1870, N. 5851.
Quale la sorte degli strumenti che più non esistono fra quelli che il conte Marsili aveva donati?
Fra i cultori delle scienze sperimentali ve ne hanno che sentono solamente se pur vivamente 1’ assillo della ricerca ed altri che a siffatto amore, cui tanto deve il progredire dell’umano sapere, associano il culto di tutto ciò che nel passato servì alla costruzione di qualche gradino della grande scala di ascesa o testimonia di qualche elemento del sapere degli avi. Degni di encomio i primi quando lascino tranquilli i resti dell’opera dei predecessori, il che purtroppo non sempre avviene, ma più degni di encomio i secondi perchè mostrano una scienza
326 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
che direi di indole più nobile, in quanto sorretta e accompagnata da un animo gentile.
Se si pensa che da Marsili a noi lunga fu la serie dei professori di varia indole nel senso su esposto, che nel giugno del 1796 si ebbe una invasione francese con asportazione di materiale dalla biblioteca e dai vari gabinetti universitari (seguita peraltro da una restituzione dal 1815 al 1818 che per la fisica si disse totale) e che in tempi meno lontani si ebbe una vendita all’estero da parte del prof. Emilio V illari1 con ricupero parziale in seguito ad intervento di studenti, professori ed Autorità Accademiche, ci si può render conto se non in modo specifico, almeno generico delle dispersioni.
Il Quincy, nella terza parte della sua Vita del Marsili, preludendo alla « descrizione dei Capitali che contengono gli appartamenti del Palazzo dell’ Istituto, scriveva : « J’espère qu’on me saura gré d’ avoir éclarci cet endroit de la generosité de ce grand Homme, qui insensiblement pourrait tomber dans l’oubli faute de monuments ». Egli alludeva evidentemente a monumento che doveva esser messo — e non fu per modestia del Marsili — nel Palazzo dell’ Istituto a ricordarne l’opera e l’azione magnanime. Se il Quincy scrivesse ora, colla locuzione < faute de monuments » potrebbe purtroppo comprendere, almeno per la parte di fisica, quei monumenti più eloquenti di ogni altro che sono gli stessi strumenti donati.
Però il ricordo dell’atto munifico e dell'alta mente del donatore è ancora vivo e a lungo durerà perchè durerà il ricordo della azione da essi esercitata mercè l’uso che degli strumenti fecero i maestri dello studio, modesta o grande che essa sia stata. Nessuno potrà difatti impedire che si pensi — la storia del resto lo dimostra — esser stata la buona dotazione iniziale incitamento e sprone a tenere con ricchezza al corrente delle
1 Napoletano, succeduto, dopo un breve interregno di Antonio Paci- notti allora professore all’ istituto tecnico di Bologna, al Dalla Casa. Se il Pacinotti non fosse stato ritenuto non degno dell'alta cattedra bologuese lo Studio potrebbe ora probabilmente contare con tutti gli strumenti Marsiliand il nome glorioso dell' inventore della dinamo fra «quelli dei suoi Maestri.
L. AMADUZZI - GLI STRUMENTI DI FISICA 327
nuove conquiste della fisica, sopratutto quando comparve apertamente sulla scena la elettricità, il Gabinetto fisico dello Studio bolognese, nel quale, sulle macchine del Marsili e sulle nuoveil buono e grande Luigi Galvani studiò e sentì quell’amore da lui apertamente dichiarato per la Fisica da cui la scienza e l’umanità ebbero quella vivida luce che attraverso ad Alessandro Volta, ad Enrico Hertz, ad Augusto Righi, insieme alla più intima cognizione del fenomeno luminoso ed alla meravigliosa sintesi delle energie fisiche che gli uomini di scienza e di laboratorio elaborarono, dette modo a Guglielmo Marconi di fare, con un apparecchio ideato proprio in quelle stesse sale per la Fisica che avevano raccolto la donazione di Luigi Ferdinando Marsili, la prima prodigiosa trasmissione attraverso al libero spazio che stupì il mondo e che fa sperare dal genior ancor desto di Lui nuovi prodigi.
Parma, Istituto fisico della R. Università.
L avoro A m a d u z z i
Le anticaglie (li Luigi Ferdinando Marcili.
Il generale conte Luigi Ferdinando Marsili, tra l’altro, fu anche archeologo e pure nel campo antiquario lasciò traccia del suo ingegno perspicace e del suo vivido spirito, dimostrando qualche nota di originalità e palesandosi, talora, come un precursore. Il volume secondo della sua magnifica opera Danubìu8 Pannonico Mysicus, Aia ed Amsterdam, 1726, è un volume interamente archeologico e suscita in special modo l’interesse di noi Italiani, perchè vi sono raccolte ed esposte con lucido ordine tutte le testimonianze di romanità del limes danubiano, notate dal Marsili con amorosa cura durante le campagne della lunga guerra tra Sacro Romano Impero e Turchia dal 1682 al 1699.
Ma altri scritti archeologici ha lasciato il Marsili. Due sono editi; uno è la Lettera intorno al ponte fatto sul Danubio sotto l’impero di Traiano, indirizzata al R. P. D. Bernardo di Montfaucon, in data da Roma, 27 aprile 1715 (è inserito questo scritto nel suddetto secondo volume del Danubius Pannonico- Mysicus) ; l’altro è la Mémoire sur l’usage et les effets des lampes qui se trouvent dans les anciens sépulcres, ed è inserito nel- 1’ opera del De Limiers, Histoire de l’ Académie appelée l’ In - stitut des Sciences et des Arti établi à Boulogne en 1712, Amsterdam, 1723, a pag. 278 e segg.
Altri scritti sono inediti e nell’ utilissimo Catalogo dei manoscritti di Tyuigi Ferdnando Marsili, conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna, Firenze, 1928, di Lodovico Frati, sono sotto i seguenti numeri. Nel fondo Marsili cod. 1044, n. 1 (Aegyptiorum, Etruscorum, Romanorum suppellex ecc.), n. 25
23*
330 MEMORIE INTORNO A L . F . MARSILI
(Idoli Egizi, 4 memorie), n. 29 (in Miscellanea, 1“ memoria dal titolo Fragmenta antiquitatum variarum etc. ad opus Danubiane inserventium), n. 101 (Miscellanea antiquitatum variarum, v. I, quattro memorie), n. 102 (id., v. II, cinque memorie; nella quarta è compresa la sopra citata lettera sul ponte di Traiano a B. De Montfaucon). Negli altri fondi della Biblioteca: ms. 1043: Dissertazione sopra la Tavola Annonaria che è nella stamperia bolognese di 8. Tommaso d’Aquino, la cui interpretazione si fa coU’aiuto d’altri fragmenti antichi configurati e dalla quale
si prende occasione di ragionare dell'annona civile e militare, scritta dal conte Luigi Ferdinando Mar sili. Questa memoria si trova riprodotta nell’opera del De Limiers, a p. 228 e segg., col titolo Mémoire sur un marbre antique trouvé à Rome, que l’on
croît être un voeu consacré à Cerès.Ma il generale Marsili fu anche raccoglitore di anticaglie,
non per sè, ma per costituire nel suo Istituto delle Scienze e delle Arti in Bologna un gabinetto di Antichità. È naturale che il suolo di Roma e delle sue vicinanze abbia fornito al Marsili la maggior parte di questi documenti archeologici. Otto volte nella sua vita fu il Marsili a Roma, ma, lasciando da parte le dimore in Roma nel 1677, dopo la morte della madre, quando era diciannovenne, nel 1680 e nel 1681, dopo la morte del padre, quando era tra i frequentatori della corte di Cristina di Svezia, nel 1688 quando ebbe per due volte dall'imperatore Leopoldo I incarichi diplomatici di grande fiducia presso il pontefice Innocenzo XI, nel 1708 quando fu nel giugno a Roma fugacemente per assumere dalle mani di Clemente XI il comando delle soldatesche pontificie contro gl’imperiali, si può asserire che solo nelle tre ultime dimore a Roma, nel 1711 per agevolare la nascita dell’istituto, negli anni dal 1713 al 1715, in cui il Marsili visse nell’ambiente papale protetto e ben voluto da Clemente XI, e nel 1724, quando il generale si recò presso Innocenzo XIII, il grande scienziato e guerriero bolognese raccolse antichità di vario genere. Fu anzi nel 1714 che il Marsili si occupò in Roma della situazione esatta della etrusca città di Yeio, la nemica implacabile di Roma, che da parecchi dotti era collocata a Civita
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 881
Castellana; il Marsiii fu sostenitore della idea che Veio sorgesse a Isola Farnese, e con ragione.
Le antichità del conte Marsili non erano tutte di provenienza romana: alcune furono raccolte in Germania, altre forse provengono dall’Ungheria, altre da Bologna, dalla Etruria, dall’Italia meridionale. Anche dalle antichità egizie fu attratto il Marsili, tanto è vero che nel 1715, pure essendo quasi nel cinquantesimo- settimo anno di età, da Roma si era recato a Bologna per porre in atto un suo disegno di ardua esecuzione: partire per l’Egitto al fine non solo di studiare il Nilo secondo le direttive già seguite per studiare il Danubio, ma anche di raccogliere ampia messe di monumenti della millenaria, splendida civiltà egizia per il gabinetto degli Antichi del suo Istituto. Questo disegno rimase allo stato di mero progetto perchè, per ordine di Clemente XI, nello stesso anno 1715 il Marsili dovette occuparsi della difesa delle spiaggie dell’Adriatico contro le minaccie dei Turchi e dei Barbareschi. Dopo sopraggiunsero altri impedimenti e nulla si fece.
Le anticaglie marsiliane furono raccolte nella cosiddetta Stanza delle Antichità e nell’Atrio della sede dell’istituto delle Scienze e delle Arti, inaugurato solennemente il 13 marzo 1714 nel palazzo disegnato da Pellegrino Tibaldi nel 15G0, già del cardinale Poggi e poi passato successivamente in possesso delle famiglie Celesi di Pistoia, Banchieri, Dal Gallo, acquistato infine per l’istituto dal Senato bolognese ed ora sede della R. Università. Notizie su questa Stanza delle Antichità e dell’Atrio si hanno in in H. Quincy, Mémoires sur la vie de Mr. le comte de Morsigli, Zurigo, 1741, I I I parte, p. 128 e segg., IV parte, pag. 84 e segg., in F. M. Zanotti, De Bononiensi scientiarum et Artium Instituto atque Academia Commentarvi, Bologna, 1748, p. 8, in G. G. Bolletti, Dell’origine e de’ progressi dell’Instituto delle Scienze di Bologna, Bologna, 1751, p. 55 e segg.
L ’Atrio a pianterreno è il lungo ambiente che dopo l’ingresso principale costeggia uno dei lati del cortile del palazzo; ivi erano raccolte iscrizioni antiche e frammenti di antiche sculture. La Stanza delle Antichità era pure a pianterreno nel lato posteriore del palazzo e veniva dopo la Stanza del Nudo e dopo
332 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
le Stanze delle Statue, ove erano raccolti i gessi di sculture antiche, inviati, per la maggior parte, da Roma dal cardinale Ulisse Gozzadini. Le antichità raccolte nell’Atrio e nella Stanza a loro destinata costituirono il nucleo primo del Museo d’An- tichità della Università.
Infatti nel 1743 si aggiunsero alla raccolta Marsili altre due raccolte. La prima era il Museo Aldrovandiano, che il sommo naturalista bolognese conte Ulisse Aldrovandi (1522-1605) aveva formato; la seconda era il Museo Cospiano, fondato dal senatore bolognese marchese Ferdinando Cospi (1606-1686). I due Musei già appartenevano alla città di Bologna ed erano conservati insieme nel palazzo Pubblico di questa città: il Museo Cospiano era stato edito dal cremonese Lorenzo Legati nell’opera Museo Cospiuno annesso a quello del famoso Ulisse Al- drovandi, Bologna, 1677. Ma tanto il Museo Aldrovandiano quanto il Cospiano contenevano oggetti non solo di antichità, ma anche di Storia Naturale e questi ultimi furono introdotti nelle sei stanze dell’istituto situate nel piano superiore del palazzo Poggi e destinate alle raccolte naturalistiche ; ora sono le prime sale a destra della R. Biblioteca delPUniversità.
Ma, sia prima che dopo il 1743, vi furono incrementi nella Stanza delle Antichità per opera di munifici donatori. Tra questi donatori dobbiamo menzionare il gentiluomo veneto Urbano Sa- vorgnan, ma specialmente il grande Pontefice bolognese Benedetto XIV che, negli anni del suo memorabile pontificato dal 1740 al 1758, non dimenticò mai la sua diletta Bologna e specialmente lo Studio secolare e l'istituto delle Scienze e delle Arti. Tra i doni di papa Lambertini sono da menzionare circa mille e cinquecento monete greche e romane, contenute in due ricchi scrigni con ornati di bronzo dorato; questo fu il nucleo del ricchissimo medagliere dell’ attuale Museo Civico di Bologna.
Quando, nel 1781, nell’istituto si fondò la cattedra di Archeologia e Numismatica, il cui primo titolare fu Jacopo Tazzi Biancani, si dovettero aggiungere alla stanza delle Antichità altre due stanze ; ma l’angustia con l’aumento delle collezioni si fece ben presto avvertire. Nel 1803 l’antico Studio, o Univer
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 333
sità, fu trasportato nel palazzo dell’istituto e nel 1810, essendo stato conservato l’insegnamento di Archeologia e Numismatica, che dal Biancani era passato a monsignore Floriano Malvezzi e poi al canonico Filippo Schiassi, si pose mano nella estate al trasporto del materiale antiquario in sede più ampia. Si costituì in tal modo il Museo delle Antichità della Università, il quale fu distribuito a pianterreno del palazzo Universitario in sette sale, oltre l’ingresso ed oltre due ambienti; uno era l’ufficio del Direttore e titolare della cattedra di Archeologia e Numismatica, l’altro serviva da magazzino. Tutto il nuovo Museo fu descritto dallo Schiassi nella Guida del forestiere al Museo delle Antichità della Regia Università di Bologna, Bologna, 1814.
Il Museo delle Antichità della Università rimase in questa sede finché, in seguito a R. Decreto del 29 novembre 1878, sanzionante la Convenzione concordata tra Autorità governativa e municipale, il 7 luglio del medesimo anno, si addivenne ad una fusione del Museo stesso con il Museo di proprietà municipale. La unione e la fusione dei due Musei diedero origine all’attuale Museo Civico, allogato nel palazzo di proprietà del Comune di Bologna e che si può considerare come una continuazione del palazzo dell’Archiginnasio o sede antica dell’Uni- versità, e che comprende i locali di quanto era l’Ospedale di Santa Maria della Morte, già inalzato nel sec. XV. Il nuovo Museo Civico fu inaugurato il 25 settembre 1881.
Così le anticaglie di Luigi Ferdinando Marsili si possono considerare come il nucleo primo attorno a cui, in due secoli, vennero a costituirsi le ampie e pregevolissime collezioni dell’attuale Museo Civico di Bologna.
Ora la biblioteca di questo Museo Civico possiede due codici legati in pergamena, ove sono riprodotte a colori in olio le anticaglie di Luigi Ferdinando Marsili. Ciascun codice misura cm. 42,50 per cm. 28,50; il primo codice contiene 55 tavole, il secondo 53. L ’intestazione manoscritta preposta a ciascuno dei due volumi è la seguente: Copia delle Anticaglie de’ Marmi, - di Porfido, e di Bronzo - et altre Pietre - ritrovate in più Parti - raccolte ■ dall’Illustriss. Signor Conte Luigi - Ferdinando Marsiglij - Generale di Sua Santità, - donate al
334 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
l’Illustrissimo Reggimento - di Bologna ■ sua Patria - per ereger y Jnstituta Marsigliana - e fedelmente poste in - Pittura. Nel primo volume segue la dicitura: Libro Primo; nel secondo: Libro Secondo.
Nessuna indicazione di anno: ma è verosimile che tutto ciò comprenda un primo fondo di donazione, la quale sarebbe da identificare con la donazione compiuta con atto solenne in Bologna sotto gli auspici del Cardinale Legato Lorenzo Casoni 1’ 11 gennaio 1712. Infatti manca la riproduzione di monumenti, che certamente appartennero al Marsili e che passarono poi nella Stanza delle Antichità dell’ Istituto.
Così manca il gioiello della collezione Marsiliana, cioè la famosa testa marmorea detta il Fauno dalla macchia. Si tratta in realtà di una egregia scoltura ellenistica rappresentante o un giovine Centauro o un Satiro ; trovata sulla via Appia presso la tomba di Cecilia Metella, passò in possesso del Marsili, che la collocò nella Stanza delle Antichità dell’Istituto. Ivi non rimase a lungo; il Quincy nelle memorie della vita del Marsili, stampate nel 1741 (parte III, p. 135 e parte IV, p . 88) riferisce che questo marmo passò nella collezione del cardinale Alessandro Albani, nipote di Clemente XI. Il Senato bolognese gli cedette tale scultura, che aveva eccitato la sua ammirazione, considerando gli obblighi di gratitudine che l’istituto aveva verso il compianto suo zio, Sua Santità Clemente X I; in compenso il cardinale diede all’Istituto alcuni strumenti di astro nomia che furono collocati nell’Osservatorio.
Alessandro Albani fu appassionato raccoglitore di opere d’ arte antica e costituì la insigne collezione Albani, seguendo anche i suggerimenti di Giovanni Gioacchino Winckelmann, che nel munifico cardinale ebbe, nella sua dimora a Roma, un protettore ed un amico. Ed il Winckelmann esalta il Fauno dalla macchia, chiamandolo « una delle più belle teste dell’ antichità riguardo alla maestria del lavoro, che appartenne altra volta al celebre conte Marsigli, ed or si vede nella villa Albani. » {Opere, Prato, 1830, v. II, p. 302). Anche il Fauno dalla macchia fece parte della immensa rapina napo
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 3 3 5
leonica e passò con molti marmi Albani a Parigi nel mostruoso Museo Napoleone; fu allora che il marmo fu indicato come le Faune à la tache, in causa di due macchie verdastri sulla gota destra, sul sopracciglio e sulla fronte pure a destra, dovute al contatto di bronzi ossidati (Monuments untiques du Musée Napoléon, v. II, tav. 18).
Nel 1816, allo scioglimento del gran Museo Napoleone, il Fauno dalla macchia fu acquistato da Luigi I di Baviera per la sua Glittoteca di Monaco, di cui appunto in quell’anno si iniziava la costruzione. E nella Glittoteca di Monaco il marmo marsiliano è tuttora conservato (Furtwängler A., Beschreibung der Olyptotek König Ludwig’s I, 1900, n. 222; Brunn-Bruck- mann, Denkmäler der griech. und römischer Skulptur, n. 5, A ; Rodenwaldt G., De Kunst der Antike, Hellas und Rom, 1927, tav. 462).
Ma che nei due volumi di pitture ad olio conservati nella biblioteca del Museo Civico di Bologna siano riprodotti i monumenti del primo nucleo di anticaglie donate, come dice la loro intestazione, all’illustrissimo Reggimento di Bologna per ereger l’Instituta Marsigliana, cioè nel 1712, si deduce anche da un elenco di monumenti antichi inserito nell’ opera del Quincy, parte IV, p. 84 e segg., intitolato Les pièces d’anti- quités les plus rares, qui se trouvent dans le Cabinet du Comte Marsigli, et doni il a fait donation à VInstitut le 22 d’aoüt 1715, sont les suivantes. Ora nessuno degli oggetti antichi del documento addotto dal Quincy figura nei suddetti due volumi di pitture ad olio.
Ma ecco il contenuto di questi due volumi; nel primo si hanno i monumenti seguenti in einquantacinque tavole:
Tav. l.a - Urna marmorea rettangolare con coperchio sagomato ad altare; nella parte anteriore è la inscrizione:
DIS M ANIBUS SACRUM
MARCIAE SECUNDAE
L. PASSIENUS HERACLA
CONIUGI BENEMERENTI
FECIT ET SIBI
336 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARS ILI
Museo Civico; sala VII, M.T a v . 2.” - Anfora a volute apula: sul collo testa muliebre
con ornati; sul corpo scena di tributo alla tomba di un guerriero (cf. tav. 12).
Pellegrini G., Catalogo dei vasi antichi dipinti delle collezioni Palagi ed Universitaria, Museo Civico di Bologna, 1900, n. 564.
Museo Civico; sala VI, F, G.Tav. 3.“ - Idria apula: parte posteriore (cf. tav. 4).
Pellegrini G., op. cit., n. 549.Museo Civico; sala VI, F, G.Tav. 4.“ - Idria apula: scena di tributo alla tomba di una
donna (cf. tav. 3).Pellegrini G., op. cit., n. 549.Museo Civico; sala VI, F, G.Tav. 5." - Urna marmorea romana a forma di vaso biansato
con coperchio.Museo Civico, sala VII, L.Tav. 6.“ - Cratere a campana lucano : coppia nuziale accom
pagnata dal dio Hermes psicopompo (cf. tav. 59).Pellegrini G., op. cit., n. 502.Museo Civico; sala VI, F, G.Tav. 7.“ - Cratere a campana apulo: Eros che insegue una
donzella (cf. tav. 63).Pellegrini G., op. cit., n. 588.Museo Civico; sala VI, F, G.Tav. 8.“ - Kelehe etnisca di fabbrica volterrana : sul collo
busto giovanile; sul corpo figura di pigmeo con lancia e scudo (cf. tav. 70).
Pellegrini G., op. cit., n. 410; Ducati P., Storia dell’arte
etnisca, 1927, p. 512.Museo Civico ; sala VII, G. (si v. Ducati P., Guida del Museo
Civico di Bologna, 1923, pag. 84).Tav. 9.a - Cratere a campana apulo : Satiro che insegue una
Menade (cf. tav. 65).Pellegrini G., op. cit., n. 592.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 337
Museo Civico; sala VI, F, G.T a v . 10.® - Idria apula : scena di tributo alla tomba di una
donna.Pellegrini G., op. cit., n. 548.Museo Civico; sala VI, F, G.T a v . 11." - Cratere a campana attico, dell’inizio del sec. IV
a. C. : tre figure efebiche ammantate (cf. tav. 61).Pellegrini G., op. cit., n. 287.Museo Civico; sala VI, F, G.T a v . 12.a - Cratere a campana apulo: due figure efebiche
ammantate (cf. tav. 69).Pellegrini G., op. cit., n. 598.Museo Civico; sala F, G.T a v . 13.a - Anfora a volute apula : scena di tributo ad una
tomba (cf. tav. 2).Pellegrini G., op. cit., n. 564.Museo Civico; sala VI, F, G.T a v . 14.“ - Anfora romana di alabastro con coperchio.Museo Civico; sala IX, E.T a v . 15.“ - Moggio bronzeo romano.Non esiste nel Museo Civico.T a v . 16.a - a) Bustino bronzeo di Minerva.Museo Civico; sala IX, H.
6) Bustino bronzeo caricaturale di uomo-gallo (si cf. Per- drizet, Bronzez grecs d’Ègypte de la collection Fouquet, 1911, p. 60, n. 97, t. XXVIII). Falsificazione (?) del sec. XVI o XVII.
Museo Civico; sala XVI, vetrina dinanzi al modello del Nettuno.
c) Piccola mano destra bronzea con calamo tra il pollice e l’ indice.
Museo Civico; sala XVIII, vetrina centrale a destra del- 1’ ingresso.
d) Maschera bronzea di putto con lunga chioma.Museo Civico; sala XVIII, vetrina centrale a destra del
l’ingresso.e) Bustino bronzeo di uomo barbuto; sec. XVI.
24
338 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Museo Civico; sala XVI, vetrina dinnanzi al modello del Nettuno.
/) Bustino bronzeo stilizzato muliebre.Non esiste nel Museo Civico.
g) Piccola testa bronzea muliebre ammantata.Non esiste nel Museo Civico.
h) Bustino bronzeo di Giove (?): lavoro romano.Museo Civico; sala IX, H.
i ) Figurina bronzea con corona radiata di sacrificante: tardo lavoro etrusco.
Museo Civico; sala V ili, D.A;) Mano bronzea col medio staccato dall’ anulare.
Museo Civico; sala IX, B.I) Figurina bronzea di felino sdraiato.
Museo Civico; sala XVIII, vetrina centrale a destra del- l ’ ingresso.
T a v . 17.“ - a) e i) Due manichi bronzei di situla.Museo Civico; sala IV, H.
b) Bronzetto pendaglio di forma allungata di fallo. Museo Civico; sala IX, H.
c) Terracotta rappresentante una figurina muliebre ammantata; arte ellenica della seconda metà del sec. IV a. C.
Museo Civico; sala IX, H.d) Coperchietto di bronzo con pomello.
Non esiste nel Museo Civico.e) Anello bronzeo con punte all’ ingiro non identificabile.f ) Moneta romana non identificabile.g) Statuetta egizia di porcellana verde rappresentante una
defunte.Museo Civico; sala IV, F.
h) Dado di osso etrusco.Museo Civico; sala V ili, B.
A) Chiave bronzea romana.Museo Civico; sala IX, H.
1) Piccola mano sinistra di argilla.Non esiste nel Museo Civico.
m) e ri) Due monete romane non identificabili.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 339
o) Terracotta rappresentante una figurina muliebre ammantata con bambino nel braccio sinistro.
Non esiste nel Museo Civico.T a v . 18.“ - a) Specchio etrusco inciso, con le figure di Telefo
ed Achille.Gerhard E., Etruskische Spie gel, IV, tav. OCCXC.Museo Civico; sala V ili, B.
6) Specchio etrusco inciso, con la scena di Giunone che allatta Ercole.
Gerhard E., op. cit., I l i, tav. CXXVI.Museo Civico; sala V III, vetrina piccola sotto la finestra
(Ducati, Guida ecc., p. 87).c) Vasetto bronzeo globulare e strigilato.
Non esiste nel Museo Civico.d) Coperchietto bronzeo (umbone di oggetto): lavoro
etrusco.Museo Civico; sala V il i , B.T a v . 19.“ - a) Tegame bronzeo romano.Museo Civico; sala IX, H.
b) Specchio etrusco inciso: due figure affrontate, esecuzione sciatta e tarda.
Museo Civico; sala V ili, B.c) Specchio etrusco inciso: figura di Lasa; esecuzione
sciatta e tarda.Museo Civico; sala V ili, B.
d) Scatoletta rotonda di materia non identificabile.Non esiste nel Museo Civico.T a v . 20.® - Frammento di rilievo marmoreo ellenistico, con
scena forse riferibile al ratto delle Leucippidi da parte dei Dioscuri.
Schreiber T., Die hellenistische Reliefbilder, tav. XCI, 2; Ducati P., in Miscellanea di studi critici in onore di Ettore Stmipini, 1921, p. 1 e segg.
Mueso Civico; sala VI, parete I (Ducati, Guida ecc., p. 68).T a v . 21.a - Testa fittile votiva di donna; età etrusco-romana
e forse di provenienza da Veio.
340 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Museo Civico; sala V ili, H.T a v . 22.“ - Testa fittile votiva di donua; età etrusco-romana
e forse di provenienza veiente.Museo Civico; sala V ili, H.T a v . 23.“ - Testa marmorea muliebre di tipo arcaicizzante.Museo Civico; sala IX, D (Ducati, Guida ecc., p. 92).T a v . 24.“ - Parte anteriore di piede destro muliebre di
marmo.Museo Civico; sala IX, H.T a v . 25.“ - Mano destra marmorea impugnante un bastone.Museo Civico; sala IX, H.T a v . 26.“ - Piede marmoreo destro maschile.Non esiste nel Museo Civico.T a v . 27.“ - Residuo di statuetta marmorea: due piedi su ba
setta.Non esiste nel Museo Civico.T a v . 28.“ - Residuo di statua colossale marmorea del tipo
prassitelico delPApollo in riposo: braccio destro appoggiato nella parte posteriore del capo.
Museo Civico; sala VI, L (Ducati, Guida ecc., p. 68).T a v . 29.“ - Torso ignudo marmoreo di efebo, acefalo; di arte
prassitelica.Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 135 e segg.,
n. 4, fig. 5.Museo Civico; sala VII, L (Ducati, Guida ecc., p. 77).T a v . 30.“ - Torsetto ignudo marmoreo muliebre acefalo, rap
presentante forse Afrodite al bagno; di arte ellenistico-romana.Museo Civico, Sala IX, E.T a v . 31.“ - Torso marmoreo eroico, acefalo; forse rappresen
tante un Dioscuro. Copia romana da originale greco della seconda metà del sec. V a. C. Rinvenuto a Bologna, nella via Barberia.
Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 147 e segg., n. 8, fig. 9 e Storia di Bologna, I tempi antichi, 1928, p. 408.
Museo Civico; sala IX, E (Ducati, Guida ecc., p. 92).T a v . 32.“ - Torso marmoreo di Afrodite accovacciata del tipo
dello scultore Doidalsas; attualmente è acefalo, mentre nella
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 341tavola è provvisto della testa, senza dubbio opera moderna di restauro.
Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 139 e segg., n. 6, fig. 7.
Museo Civico; sala VII, O (Ducati, Guida ecc., p. 78).Tav. 33.“ - Frammento di scultura marmorea: torso acefalo
maschile appoggiato ad un tronco di albero.Museo Civico; sala IX, E.T a v . 34.“ - Torsetto m arm oreo m aschile acefalo.
Museo Civico; sala IX, E.T a v . 35.“ - S i v. la tav. 88.
Tav. 36.“ - Statuetta marmorea di putto con otre sulla spalla sinistra; priva del braccio destro e delle gambe. Arte elleni- stico-romana.
Museo Civico; sala IX, E.Tav. 37.“ - Frammento di mosaico policromo su fondo aureo,
rappresentante il volto di fronte del Redentore. Arte romanica..Museo Civico; sala XVIII, nella parete tra le due finestre
(Ducati, Guida ecc., p. 245).T a v . 38.“ - Testa m arm orea m uliebre rom ana su busto d i
porfido.Museo Civico; sala VII, L, in alto a s.T a v . 39.“ - B usto m arm oreo m uliebre. È antico?
Museo Civico; sala IX, F, in alto.Tav. 40.“ - Testa bronzea di fanciullo ricciuto; arte elleni
stica, sec. I I a. C.Museo Civico: sala IX, B (Ducati, Guida ecc., p. 93).Tav. 41“ - Testa efebica mutilata di basalto; qui collocata
in un medaglione di pietra rossigna. Copia di originale bronzeo greco della metà circa del sec. V a. C. e rappresentante forse Apollo.
Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 128 e segg., n. 1, fig. 1 e 2.
Museo Civico, Sala VI, C (Ducati, Guida ecc., p. 72).Tav. 42.“ - Busto marmoreo muliebre. È antico?Museo Civico; sala IX, D, in alto.Tav. 43.“ - Busto marmoreo di fanciullo ricciuto. È antico?
342 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Museo Civico; sala IX, D, in alto.Tav. 44.* - Testa marmorea barbuta su busto di porfido; An
tonino Pio?Museo Civico; sala VII, L.Tav. 45.“ - Testa m arm orea m aschile im berbe su busto di
porfido ; età dei Severi?
Museo Civico; sala VII, M.Tav. 46.“ - Testa m arm orea (? ) m aschile b a rb u ta ; lavoro
moderno.
Non esiste nel Museo Civico.Tav. 47.“ - Testa marmorea giovanile barbuta ; secolo I I I
d. C.Ducati, in Revue archéologique, 1911, II, p. 164 e segg.,
fig. 20; Ilekler A., Die Bildniskunst der Griechen und Römer, p. 275, b; Poulsen F., in Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Hist. - fil. Meddelelser, XV, 4, 1928 p. 22 e seg., n. 2, tav. XXVI, 40.
Museo Civico; sala VII, B (Ducati, Guido ecc., p. 76 con fig-)-
Tav. 48." - Urna marmorea romana con coperchio a forma di cimasa di altare; lato posteriore disadorno, lato minore de stro con imagine clipeata sostenuta da due genietti (cf. tav. 104).
Museo Civico; sala VII, O.Tav. 49.“ e Tav. 50.“ - Doppia erma muliebre di arte arcai
cizzante di marmo rosso, arte ellenistico-romana.Tav. 51.“ - Umetta fittile etrusca di fabbrica chiusina: sul
coperchio figura di defunta semi-sdraiata; nel lato anteriore a rilievo il duello tra Eteocle e Polinice; sull’orlo del coperchio la iscrizione : Thasphia Thactrei Muliapi FI. (si cf., per tale genere di urne, Bruun E. e Körte G., I rilievi delle urne etnische, II, 1“, p. 32 e segg.).
Museo Civico; sala V ili, tra A e B (attualmente manca la testa alla figura della defunta).
Tav. 52.“ - Umetta fittile etrusca di fabbrica chiusina; sul coperchio figura della defunta sdraiata, nel lato anteriore il dèmone dell’aratro, il cosiddetto Echetlo (si cf. Körte G., I rilievi delle urne etnische, III, 1916, p. 5 e segg. ; ivi tale rappre
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 343
sentazione è riconnessa col mito biblico di Samgar uccisore di 600 Filistei con l’aratro; si v. Libro dei Giudici, 3, 31).
Museo Civico; sala Vili®, A.Tav. 53.® - Urna marmorea romana, rotonda (è rimasta solo
la parte anteriore, adorna a rilievo di armi e di insegne animalesche); nel mezzo è la targhetta con la iscrizione:
D m SHERMIPPO
AUG. LIB. PROC.
SCAENIC. VLP
AMANDA. ET. VLP
PR IM ITIVA . PATR
B. M . POSVERUNT
Proviene da Roma.Corpus Inscriptionum Latinorum, VI, n. 10.088; Altmann
W., Die römischen Grabaltäre der Kaiserzeit, 1905, p. 133; Ducati P., in Revue wrcliéologique, 1911, II, p. 157 e seg., flg. 15.
Museo Civico; sala VII, O (Ducati, Guida ecc., p. 78).Tav. 54. - Due erme faunesche di bronzo; arte del rinasci
mento, prima metà del sec. XVI.Museo Civico; sala XVI, B (Ducati, Guida ecc., p. 207).Tav. 55.“ - a) Bustino bronzeo muliebre con cuffia (?) in
capo.Non esiste nel Museo Civico.
b) Bustino bronzeo di personaggio imberbe: lavoro romano.
Museo Civico; sala IX, H.c) Figurina bronzea di giovinetto inginocchiato ; arte fran
cese (?) del sec. X III.Museo Civico; sala XVI, vetrina dinanzi al gruppo dell’Al-
gardi (Ducati, Guida ecc., p. 204).d) Bustino bronzeo di Minerva.
Museo Civico; sala IX, H.e) Statuetta bronzea muliebre ammantata; lavoro del ri-
nascimento.
346 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARS ILI
Pellegrini G., op. cit., n. 288.Museo Civico; sala VI, F.Tav. 68.® - Cratere a calice attico; ultimi tempi del sec. V
a. C. : la vittoria in una gara auletica (cf. tav. 64).Pellegrini G., op. cit., n. 286, fìg. 34.Museo Civico; sala VI, F (Ducati, Guida ecc., p. 64).Tav. 69.a - Cratere a campana apulo: Satiro inseguito da
una Menade (cf. tav. 12).Pellegrini G., op. cit., n. 598.Museo Civico ; sala "VI, F, G.Tav. 70.“ - Kelebe etrusca di fabbrica volterrana; sul collo
busto giovanile; sul corpo figura di pigmeo con spada e scudo (cf. tav. 8).
Pellegrini G., op. cit., n. 410, fig. 68; Ducati P., Storia delia ceramica greca, 1923, fig. 343 e Storia dell’arte etnisca, 1927, p. 512, fig. 610.
Museo Civico; sala VII, G (si v. Ducati, Guida ecc., p. 87).Tav. 71.a - a) Bronzetto a forma di testa di Fauno.Non esiste nel Museo Civico.
b) Bronzetto a forma bovina.Museo Civico; sala IX, H.
c), d), e) Tre chiavi di bronzo romane.Museo Civico: sala IX, H.
/) Bronzetto a forma di cavaliere.Non esiste nel Museo Civico.
g) Lucerna bronzea del rinascimento a forma di testa di moro.
Museo Civico; sala XVI, vetrina dinanzi al gruppo dell’Al gardi (Ducati, Guida ecc., p. 205).
h) Bronzetto a forma di rana.Museo Civico; sala IX, H.
i) Bronzetto minuscolo di forma indistinta.k) Bronzetto: due figurine di quadrupedi su di un’asti
cella.Museo Civico; sala IX, H.
I) Chiave di bronzo romana.Museo Civico; sala IX, H.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. M ARSILI 347
m) Bronzetto a forma di volatile.Museo Civico; sala IX, H.
n) Bronzetto a forma di cervo.Museo Civico; sala IX, H.
0) Bronzetto a forma di lepre accosciata.Museo Civico; sala IX, H.
p ) Bronzetto a forma di sorcio.Museo Civico; sala IX, H.
q) Bronzetto a forma di aquila.Museo Civico; sala IX, H.
r ) Anello di bronzo romano con iscrizione.Museo Civico; sala IX, H.Tav. 72.“ - a) Fibula bronzea villanoviana ad arco ingrossato. Museo Civico; sala V ili, B.
6) Moneta romana non identificabile.c) Pinzetta di bronzo.
Museo Civico; sala IX, H.d) Oggetto non identificabile di ferro (?).e) e /) Due monete romane non identificabili.g) Cuspide di lancia di bronzo.
Museo Civico; sala V ili, B.h) Puntale bronzeo.
Museo Civico; sala IX, H.1) Strumento chirurgico bronzeo romano a forma di cuc
chiaio.Museo Civico; sala IX, H.
k) Piccolo rasoio bronzeo di forma allungata.Museo Civico; sala V il i , B.
I) e m) Due monete romane non identificabili. n ) Candelabro etrusco.
Museo Civico; sala V ili, B (è conservata solo la parte inferiore in cui sono infisse le branche),
o) Anello bronzeo gemino.Museo Civico; sala V il i , B.
p) Cucchiaio d’osso.Museo Civico; sala IX, H.
q) e r) Due monete romane non identificabili.
348 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
s) Piccolo scalpello romano bronzeo.Museo Civico; sala IX, H.
t) Moneta romana non identificabile. u) Strumento bronzeo a forma di spatola ; utensile chirur
gico romano.Museo Civico; sala IX, H.
v ) Fibula bronzea villanoviana ad arco ingrossato con sporgenze laterali.
Museo Civico; sala V III, B.w) Strigile bronzeo (parte anteriore).
Museo Civico; sala IX, H. x ) Strumento chirurgico bronzeo romano a forma di stret
ta spatola.Museo Civico; sala IX, H.
y ) Moneta romana non identificabile. z) Anello bronzeo gemino.
Museo Civico; sala V ili, B.a’) Moneta romana non identificabile.
Tav. 73. - a) Lungo spillone di osso romano.Museo Civico; sala IX, H.
b) Cucchiaio di bronzo, con orlatura adorna di ovuli. Non esiste nel Museo Civico.
c) Strumento a punta, assai allungato di bronzo (?). Non esiste nel Museo Civico.
d) Strumento filiforme con sei sferette.Non esiste nel Museo Civico.
e) Chiave romana di bronzo.Museo Civico; sala IX, H.
f ) Specchio etrusco a rilievo, con la scena di Filottete (Pheltute) medicato da Macaone (Machan) : seconda metà del sec. V a. C.
Gerhard E., Etruskische Spiegel. IV, tav. CCCXCIV, 2; Ro- scher, Lexikon der Mithologie, I II , 2, c. 234 e seg. ; Ducati P., Storia dell’arte etnisca, p. 329, fig. 375.
Museo Civico; sala V III, piccola vetrina sotto una finestra (Ducati, Guida, ecc., p. 87).
g) Asticella di osso con scodelletta terminale.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 349
Non esiste nel Museo Civico.h) Pinzetta di bronzo.
Museo Civico; sala IX, H.i) Strumento bronzeo appuntito a foglia lauriforme.
Non esiste nel Museo Civico.k) Rasoio bronzeo villanoviano di tipo allungato.
Museo Civico; sala V ili, B.I) Asticella di osso con scodelletta terminale.
Non esiste nel Museo Civico.m ) Cucchiaio bronzeo romano.
Non esiste nel Museo Civico.Tav. 74.“ - Statuetta marmorea di personificazione di fiume:
arte ellenistico-romana.Museo Civico; sala VI, M (Ducati, Guida, ecc., p. 68).T a v . 75." - Testa fittile votiva di giovane ; età etrusco-rom ana
e forse di provenienza veiente.
Museo Civico; sala V ili, H.Tav. 76.a - Testa fìttile votiva di giovane; età etrusco-romana
e forse di provenienza veiente.Museo Civico; sala V il i , H.Tav. 77.a - Busto di erma marmorea muliebre: arte elleni-
stico-romana.Museo Civico ; sala VI, C.Tav. 78.“ - Residuo di statua marmorea : due mani intrec
ciate.Non esiste nel Museo Civico.Tav. 79.“ - a) Residuo di statua marmorea: mano sinistra
stringente un attributo.&) Residuo di statua marmdlrea: mano sinistra strin
gente un attributo.Museo Civico; sala IX, H.T a v . 80.a - Residuo di statua marmorea : piede destro ma
schile su base a contorno circolare.Museo Civico; sala VI, L.Tav. 81.a - Residuo di statua marmorea: piede sinistro ma
schile su basamento.Non esiste nel Museo Civico.
350 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
T a v . 82.* - Residuo di statua marmorea: mano sinistra maschile distesa su roccia (?).
Non esiste nel Museo Civico.T a v . 83.“ Torso m arm oreo efebico (qu i provvisto d i testa,
ora m ancante ); copia rom ana da orig ina le greco della prim a
m età del sec. IV a. C.Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 132 e seg.,
n. 3, fig. 4.Museo Civico; sala VI, M (Ducati, Guida ecc., p. 77).Tav. 84.“ - Gruppo marmoreo frammentato rappresentante
un Satiro giovine che tiene a cavalcioni Dioniso bambino; arte ellenistica del sec. I l i a. C.
Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 143 e segg., n. 7, fig. 8; Minto A., in Ausonia, V ili, 1913, p. 94, fig. 4; Lawrence A. W., Later greek Sculpture, 1927, p. 101.
Museo Civico; sala VII, M (Ducati, Guida ecc., p. 77, con figura).
T a v . 85.“ - Torsetto m arm oreo maschile ignudo, ripiegato
a ll’innanzi.
Non esiste nel Museo Civico.Tav. 86.“ - Torso marmoreo acefalo di Afrodite; arte elle
nistica.Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 139, n. 5,
fig. 6.Museo Civico: sala VII, L (Ducati, Guida, ecc., p. 77).Tav. 87.“ - a) Torso m arm oreo maschile.
Non esiste nel Museo Civico.6) Parte superiore di torso marmoreo femminile.
Non esiste nel Museo Civico.T a v . 88.“ - Si v. la tav. 35; le due tavole riproducono in
sieme un solo monumento. Rilievo marmoreo frammentato con la scena di Poseidon che sorprende Amimone alla fonte; arte ellenistica.
Schreiber T., Die hellemstische Reliefbilder, tav. XLIV.Museo Civico; sala VI, L (Ducati, Guida ecc., p. 68).T a v . S9.“ - Torsetto m arm oreo maschile acefalo, ignudo
con clam ide su lle spalle.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 351
Museo Civico; sala IX, E.Tav. 90.“ - Torso marmoreo maschile, acefalo, ignudo.Museo Civico; sala IX, E.T a v . 91.“ - Busto marmoreo di Lucio Vero.Ducati P., in Revue orohéologique, 1911, II, p. 161 e seg.,
n. 17, fig. 18; Poulsen F., in op. cit., p. 21 (opera moderna?)..Museo Civico; sala VII, G (Ducati, Guida ecc., p. 76).Tav. 92.“ - Testa marmorea romana di giovinetto, su busto
di porfido.Museo Civico; sala VII, N.Tav. 93.“ - Busto marmoreo di Gallo barbuto ferito, già cre
duto rappresentante Laocoonte, poi un gigante; copia romana dell’età degli Antonini da originale pergameno della fine del sec. I l i a. C.
Förster R., I ahrbuch des deutschen archäologischen Instituts, 1891, p. 189, tav. 3; Bienkowski P. R., Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst, 1908, p. 51 e seg.,, fig. 74-75.
Museo Civico; sala VI, C (Ducati, Guida ecc., p. 72).T a v . 94.“ - Testa bronzea di bam bino ricciuto.
Museo Civico; sala IX, B.Tav. 95.“ - Testa marmorea romana muliebre su busto di
porfido.Museo Civico; sala VII, N.Tav. 97.“ - Testa marmorea di bambino: età degli Antonini..Strong. E., La scultura romcma da Augusto a Costantmo,
II, 1924, p. 393, fig. 240.Museo Civico; sala IX, su colonnetta presso l’ingresso alla
sala VI.T a v . 98.“ - Testa m arm orea rom ana di guerriero su busto di
porfido.
Museo Civico; sala V II, O.Tav. 99.“ - Testa marmorea romana muliebre su busto di
porfido.Museo Civico; sala V II, O.Tav. 100.“ - Testa marmorea (?) maschile, barbuta; lavoro
moderno.
352 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Non esiste nel Museo Civico.T a v . 101.a - Busto marmoreo muliebre; di antichità sospetta.Museo Civico; sala IX, F.T a v . 102.“ - Statua di Afrodite del tipo della « Venere dei
Medici», e, per l’appoggio laterale, del tipo della « Venere Car pitolina ».
Forse è riprodotto il calco in gesso esistente già in una delle aule della Accademia Clementina al pianterreno dell’istituto.
T a v . 103.a - Erma marmorea di ITermes barbuto; da originale della seconda metà del sec. V a. C., con tre iscrizioni greche di contenuto morale.
Per le iscrizioni si v. Kaibel, Inscr. graeoae Siciliane et I tal ine, n. 1201 ; per l’erma Ducati P., in Revue archéologique, 1911, II, p. 130 e seg., n. 2, fig. 3.
T a v . 104.a - Urna marmorea cineraria romana (cf. tav. 48): lato anteriore e lato minore sinistro con imagine clipeata sostenuta da due genietti.
Museo Civico; sala VII, O.T a v . 105.“ - Mensola marmorea con, a rilievo, una pianta
sorgente da un vaso e due figure muliebri accosciate ai lati, tenenti ciascuna una conchiglia; lavoro romano. Su questa basetta figura di palmipede.
Museo Civico; sala dei frammenti architettonici, F (Ducati, Guida, p. 24). La figura di palmipede non esiste nel Museo Civico.
T a v . 106.“ - Statuetta di marmo bianco con testa e mani di marmo nero: riproduce il simulacro di Afrodite venerato in Afrodisia di Caria (età imperiale romana).
Museo Civico; sala VI, C (Ducati, Guida ecc., p. 72).T a v . 107a - a) Statuetta fittile di uomo sbarbato, avvolto
nel manto; caricatura ellenistico-romana (personaggio di commedia?).
Non esiste nel Museo Civico.6) Statuetta fittile di venditore; caricatura ellenistico-
romana.Non esiste nel Museo Civico.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE DI L. F. MARSILI 353
c) Statuetta egizia funeraria di porcellana grigia (ou- shabti).
Museo Civico; sala IV, F.d) Statuetta egizia funeraria (oushabti) di porcellana ver
dastra, tenente nelle mani gli oggetti dell’agricoltura, con iscrizione nel corpo mummiforme.
Museo Civico; sala IV, F.e) Statuetta egizia accosciata di legno, rappresentante
la dea Neftis.Museo Civico; sala IV, I.
/) Statuetta di personaggio accoccolato; grottesco ellenistico.
Museo Civico; sala VI, N.T a v . 108.“ - P icco la urna di m acigno rettango lare con iscri
zione:
D. M.
C. DECIMVS
ASCIANVS ET
DECIMIA SECVN
D ILIA SABINO F IL
PIENTISSIM O FECER
V IX IT ANN XV I) XXX H VI
Corpus Inscriptionum Latinarum, n. 16767 (dalla vigna Ot- tina a Roma).
Museo Civico; cortile primo, arcata /.
L ’elenco delle antichità riportato dal Quincy non dà adito, all’infuori di pochi casi, ad identificazioni certe con monumenti che si trovano ora al Museo Civico.
Comincia il Quincy col menzionare genericamente le lucerne trovate nelle catacombe di Roma, in tombe della Germania e di Toscana (queste lucerne saranno quelle esposte nel Museo Civico ; sala IX, B ed I). Poi sono menzionate tre patere fittili, un vaso fìttile lacrimatorio, una Vittoria con toro condotto al sacrifizio (di quale materia?), due figure fittili di un cignale e del dio Termine, un vaso. Si passa ad ex-votis di Veio, che ora sono
25
354 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
distribuiti nel Museo Civico tra la sala V il i , H e la sala IX, H ; la figura di donna tutta ammantata è da identificare con la statua fittile nella Sala V III, E.
Non esiste nel Museo Civico il bassorilievo marmoreo, menzionato poscia dal Quincy, rappresentante un soldato incoronato di edera e trovato in una tomba vicino alla chiesa di S. Sebastiano sulla via Appia. Le due erme marmoree che quindi vengono addotte, l’una con due teste muliebri, l'altra con una testa muliebre, e cou una barbuta di Dioniso, sono nel Museo Civico; sala VI, C. Non identificabili sono le iscrizioni sepolcrali ornate di figure grottesche; più non esiste nel Museo Civico, e non credo nemmeno che esista altrove, la pittura a fresco strappata da un muro del palazzo imperiale di Danzica (!) nel 1715 e rappresentante la figura di un fiume stante, un gruppo di tre donne appoggiate al tronco di un albero, al cui piede si snoda un serpente, i l i pare che qui il buon padre Quincy sia in preda alla più sbrigliata fantasia. Menziona quindi il Quincy il cosiddetto Fauno dalla macchia, due statue di Iside, una di bronzo e l’altra di marmo, non identificabili. Così la testa d’ Iside su di un piedistallo di alabastro sfugge ad una identificazione, mentre la rana di marmo di fattura squisita, che il Quincy chiama petite, è forse la grande rana di marmo scuro, forse ornamento di fontana, perchè traforata nel senso dell’altezza, ora nel Museo Civico, sala IX, H (cf. Ducati, Guida ecc., p. !)1).
Il Quincy nel dar notizia di tutti questi monumenti fa cenno della questione della localizzazione di Veio, per cui il Marsili tanto si interessò nel 1714 a Roma, e di due scritti del Marsili: quello, già menzionato, sull’uso e gli effetti delle antiche lucerne, inserito nel volumetto del De Limiers, e quello sull’origine e l’uso dei Termini (si v. nei manoscritti del fondo Marsili nella R. Biblioteca della Università di Bologna, 11 u. 102, E: Memorie per li dei Termini e più cose Etrusdhe; è un fascicolo di cartelle 43 in parte autografe e con disegni a pernia e ad acquarello).
A tutte queste anticaglie si aggiungono due monumenti.
P. DUCATI - LE ANTICAGLIE 1)1 L. F. M ARSILI 355Il primo è un frammento di rilievo votivo ellenistico di un
certo Melanthios ad Asclepio per grazia ricevuta : vi è conservata la parte superiore ilei dedicante sotto aspetto di uomo anziano, semi-calvo e vi è la iscrizione dedicatoria (Museo Civico; Siila VI, II; Ducati, Guida ecc., p. 07 e seg. : per la iscrizione si v. Kaibel, Inscript, graecae Siciliae et Italiae, n. 2283). Insieme con la erma della tav. 103 dei sopra descritti due codici, fu questo rilievo studiato per la prima volta da Luigi Andrucci, De incerto quodam simulacro et de Melanthi voto deque Asclepio, Bologna, 1710: passò esso nella Stanza delle Antichità dell'istituto, ove è menzionato da P. M. Zanotti e dal Belletti, presso i quali autori pure si identifica questo ottimo Melantio (Melanthios), semplice borghese, con il favoloso Melante, prima re di Messenia, poi di Atene e padre <li Codro.
Il secondo monumento è dato dai frammenti di un rilievo marmoreo di rozza esecuzione, ma interessante perchè il suo contenuto si riferisce ad un panificio (Museo Civico, sala IX, D; Ducati, Guida ecc., p. 92; è riprodotto da Bltìmer H., Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste hei Griechen und Römern, I, 1912, p. 44, fig. 19). Come si desume dal titolo della dissertazione, che il Marsili scrisse su questi frammenti di rilievo, essi, prima di passare nella Stanza delle Antichità nell' Istituto stavano nella stamperia di S. Tomaso di Aquino, in Bologna, che, in seguito alla munificenza dello stesso Marsili, fu fondata il 215 luglio 1728 ed affidata ai Padri Domenicani.
Così si costituì la collezione di anticaglie dell’istituto delle Scienze e delle Arti: non fu dapprima, come ben si vede, molto cospicua tale collezione, anche se si aggiungono i monumenti non riprodotti nei due volumi di pitture ad olio del Museo Civico di Bologna e non menzionati dal Quincy. Si noti poi che non solo il Fauno dalla macchia esulò dalla raccolta, ina, a quanto si deduce dal controllo fatto sulle tavole a pittura suddette e sul testo impreciso e fantastico del Quincy, altri monumenti che figuravano tra le anticaglie marsiliane, ora più non esistono nel Museo Civico di Bologna e non si sa dove siano
mdati a finire.
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Ma, anche così modesto, Fassieme di oggetti contenuti nei primi tempi dell’istituto di Bologna nella Stanza delle Antichità, ha la sua importanza. Si osservino i due Musei Aldro- vandiano e Cospiano esistenti pure in sedi separate a Bologna sino al 1743, sino cioè al tredicesimo anno dopo la morte di Luigi Ferdinando Marsili. Questi due Musei sono un’accolta di oggetti di ogni genere, di ogni specie: sono Musei di curiosità. Basterà dare un’occhiata alla tavola, che accompagna il testo del Museo Cospiano di Lorenzo Legati e che riproduce l’aula del Museo: vi è di tutto un pò, distribuito nelle vetrine, appeso alle pareti e tutto ordinato secondo un mero criterio estetico. Lo stesso nano baffuto che, provvisto di una lunga bacchetta, vi è rappresentato accanto ad una vetrina con una piccola erma stretta nella sinistra, in funzione di dimostratore, come mostro della natura, è anch’esso un oggetto degno del Museo, una curiosità.
Niente di tutto ciò nell’istituto Marsiliano. Ivi le anticaglie sono severamente sceverate dagli altri oggetti naturalistici; ìiu tale netto distacco, per cui la Stanza delle Antichità mell’Isti- tuto si può considerare come un genuino nucleo capace di aumentare e di diventare, come diventò, un cospicuo Museo archeologico, si rivela 1’ alta mente organizzatrice e riiordina- trice del Marsili. Anche qui, cioè anche nel campo dell’archeologia, come negli altri campi della Scienza, Luigi Ferdinando Marsili, gloria italiana, si distacca dagli ingegni enciclopedici del suo tempo, e col suo poliedrico sapere e con la sua lucida saggezza rende scientifico ciò che era empirico ed addita nuove vie agli specialisti delle usingole discipline; anche qui il Marsili si palesa come un pioniere, come un precursore.
P e r ic le D u c a t i
Il oolite Marnigli e il Caffè,
i.
In v ia r io per Costantinopoli.Luigi Ferdinando Marsigli iu un suo curioso e rarissimo
opuscolo ricorda : « l’esercizio fatto in tempo della mia schiavitù appresso di Amet Bassà di Thimisvar (che davanti Vienna per veleno datogli dal Visire terminò i suoi giorni); avegnac- chè per mio meccanico esercizio nella di lui Corte dovetti per molti giorni in una affumicata tenda esercitare l’arte di Cuoco del Cave, non solo per la quantità necessaria all’ uso della sua domestica corte, ma anche per quello che bisognava a tener fornita una bottega che si potrebbe equiparare a una posteria delle nostre; impiego che mi ha erudito nell’arte di preparare il Cavè, d’osservarne molti effetti, e che mi ha data la vita mentre con questo mezzo m’ero fatto conoscere da quei Iìognia- chi che mi comprarono, in quel tempo appunto dovevo soccombere al preparatomi colpo della sabla (sciabola) in pena della fuga tentata ! ».
11 Mai-gigli conobbe giovanissimo la vita dei Turchi e l’uso del caffè e i pregi singolari e lodati di questa bevanda.
Nato nel 1658 in Bologna, a venti anni, nel 1679, era un giovane entusiasta, amico degli studi, delle osservazioni, dei viaggi, della vita avventurosa, e domandò a Venezia di porsi al seguito del Bailo Civrani, mandato dalla Repubblica a Costantinopoli. E, come fu costante sua regola, notò le cose viste e osservate, raccolse documenti, disegnò piante geografiche e topografiche. Egli descrisse con cura tutto il viaggio, le isole visitate, le qualità e le caratteristiche dei paesi e le varie coltivazioni, comprese l’uva e il vino che i Mussulmani
358 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSH.I
non dovrebbero bere. Così descrive il sorbetto, tanto in uso in Oriente, e poi la « bionda bevanda » : il caffè. « Viene dal Cairo — egli scrive — ed è somministrato a tutta la Turchia, ed in particolare a Costantinopoli, dove sono due grandi magazzini nei quali si arrostisce la detta semenza, che poi da altri è finissimamente polverizzata in mortai di bronzo e distribuita per le botteghe, dove si vende poi a dramme, così preparata : una dramma la pongono in un litro d’acqua facendola bollire fintante che sia imbevuta del suo amaro sapore, e così calda, senz’altra correzione, è goduta dai Turchi, i quali usano presentarla a qualsiasi persona non solo nei loro pranzi, ma anche nelle visite.
Usano ancora, per il gran freddo, il Galeppo, acqua di miele rinvigorita della polvere di radica del semplice detto:... e chiamato dagli arabi Ini ».
Il Caffè, nuova bevanda, adunque entrò subito nelle osservazioni e nello studio del Marsigli, fino dai venti anni.
Egli narrò pure il viaggio di ritorno (1(180), che fece non più col Bailo, perchè il Civrani fu richiamato dopo soli undici mesi a Venezia, e fu sostituito dal Donati; ed il nostro volle restare e visitare altri paesi. 11 viaggio fu compiuto con un nuovo compagno: Gaetano Foresti, e fu fatto nel l(i80. Partirono da Costantinopoli il 22 agosto e viaggiarono per terra, lungo il Danubio; si fermarono a Belgrado, studiarono luoghi e costumi. Tl Marsigli aveva già in animo di scrivere un'opera vasta sull’impero ottomano.
Nei 151 volumi grandi dei suoi manoscritti documenti e appunti di studio, lasciati all'istituto delle Scienze (e descritti dal Dott. Frati)l, dal Marsigli fondato a Bologna, e oggi affidati a quella Biblioteca Universitaria, si custodiscono gli appunti e le note per il viaggio a Costantinopoli (voi. 51 e 52), e per la «storia » futura, appuuti in parte illustrati nel 1906 da Ludovico Frati in una memoria inserita nel Nuovo Archivio
Veneto (Venezia).
1 Edizione OiseUki - Firenze 1928, iu-4.
L. RAVA - IL CONTE MARSIGLI E IL CAFFÈ 35»
In quei volumi si conservano pure : « Il libretto delle osser- razioni che facevo a Costantinopoli » e le note per il libro, che fu pubblicato a Roma per N. Alenassi nel 1681 (in 16° grande di pagg. 108) col titolo : « Osservazioni intorno al Bosforo Tracio, o vero Canale di Costantinopoli, rappresentato in lettere alla sucra reale Maestà di Cristina Regina di Svezia ». con una grande carta topografica del Bosforo, descritta (la L. F. Marsigli.
È questo il primo lavoro a stampa (almeno il primo libro) dettato e composto in forma di una lettera alla avventurosa e famosa Regina, diretta da Roma, il 15 agosto 1681 :
Dice il nostro :« Ho camminato per molti paesi, ho osservato i costumi di
varie nazioni, ho girato insomma gran parte dell' impero ottomano ed in Costantinopoli (dove per molto tempo dimorai appresso all’Eccellentissimo Signor Pietro Civrani, Bailo della serenissima Repubblica di Venezia, successore nella medesima carica all’Ecc. Signor Giovanni Morosini, oggi Procuratore ».
Il Marsigli fu dunque anebe dei devoti ammiratori della Regina Cristina la quale aveva abdicato alla Corona di Svezia, ma teneva corte a Roma, indiceva feste, proteggeva letterati, fondava accademie. Cristina aveva scritto di sè francamente:
« Mes occupations sont de bien manger et de bien dormir; étudier un peu, causer, rire et voir le comédies françaises, italiennes et espagnoles, et passer le temps agréablement ».
Quando venne in Italia, Venezia la fece passar al largo dicendo che in città c’era la peste; Bologna l’accolse con grandi fese e un solenne ricevimento e ballo nella « Sala d’Èrcole » ; a Roma grandi accoglienze aspettavano l’ ospite illustre e bizzarra, che veniva... in incognito! Bei quadri del tempo, esposti nella mostra (1930) della « Roma del seicento », rappresentano le feste sontuose fatte per riceverla.
Ma ritorniamo al viaggio.Le osservazioni del Marsigli sono nuove e acute, specie per
le correnti marine e lo studio delle maree nel Bosforo. Natu ì almente l’italiano precursore fu dimenticato o iguorato — so
360 MEMORIE INTORNO A L. I<\ MARSILI
lita vicenda! — da coloro che scrissero dopo di lui, come il Maury, considerato fondatore della oceanografia moderna.
Da questi primi studi trasse poi il Marsigli tema per il lavoro maggiore: « Histoire physique de la mer » pubblicato nel 1725, e anche per la notevole e ampia « memoria » al grande G. B. Morgagni sull’ origine, sui colori e sulla struttura delle perle, di cui aveva parlato nel libro sul Bosforo Tracio. E raccolse materiale per altro libro « sullo stato militare de Turchi », tema nuovo e che doveva molto interessare gli Stati in guerra col Turco.
Ritornato in patria, il Marsigli si recò a Roma ed ebbe il dolore di perdere il padre; e si fermò a Roma, dove strinse amicizia con uomini eminenti e coltivando la relazione con Cristina di Svezia, come egli ricorda nella sua Autobiografia.
Scoppiata la guerra fra Austria e Turchia, il Marsigli si recò a Vienna a offrir i suoi servizi all’imperatore Leopoldo, che lo accolse e lo collocò come moschettiere presso il bolognese Maresciallo Capraia. Così divenne soldato e poi architetto militare, ed ebbe incarico della ricognizione del fiume Raab, compito che egli assolse con grande abilità, descrivendo il terreno, disegnando la carta dei luoghi e delle fortezze, e costruendo opere di difesa.
Abbandonato da 200 Dragoni Ungheri quando i Turchi, al Raab, si fecero più minacciosi, fu fatto prigioniero. E fu trattato con ogni crudeltà: spogliato delle vesti, bastonato, ferito, trascinato a piedi nudi al campo di Abaffi, principe di Transil- vania : dove nascose l’essere suo, si disse servo d’un mercante di Venezia, e fu venduto come schiavo per 17 talleri.
« Fui dato infine per servitore di un credenziere che teneva pubblica bottega di caffè, in cui io dovevo abbruciar il caffè, cuocerlo, e distribuirlo ai compratori... ». E dovette anche lavorare alle trincee, e fare da facchino, portando legna e gabbioni e simili materie. Così, osservatore quale era, ebbe campo di vedere come i Turchi disponevano le trincee, e l’ assito delle loro batterie.
L. RAVA - IL CONTE MARSIGLI B IL CAFFÈ
II.
Il libro sul “ Cavè
I Turchi marciavano verso Vienna. Per render più svelta la marcia dell’esercito venne l’ordine del Gran Visir di uccidere tutti gli schiavi, maggiori di 16 anni. 11 Marsigli pensò alla fuga. Fu preso, e rivenduto, sempre come schiavo, a due fratelli bosniaci, per il prezzo di 24 talleri, ma colla promesssa fatta da lui di riscatto per cento zecchini, che sarebbero stati pagati da un mercante di Seraievo. Codesto mercante — che era stato beneficato dal Marsigli presso il bailo Civrani — si rifiutò di riscattar l’iufelice giovane che, rimasto schiavo, dovette sopportare ogni sorta di patimenti e di privazioni, quasi nudo, piagato, pieno d’ insetti, affamato, misero !
Finalmente fu il buon Civrani che potè riscattarlo inviandogli 200 zecchini. Il Marsigli ritornò in patria nel 1684 e potè adempiere a un obbligo di cuore, e ringraziare a Venezia il suo benefattore.
La guerra continuava; Marsigli che conosceva la fortezza di Buda, dove i Turchi si erano rinchiusi, seppe dare utili consigli per l’assedio: e alfine nel 1686 vedere la vittoria degli imperiali. Era tornato alla guerra dove potè dare consigli ai capi, bene conoscendo i luoghi. Fu alla presa di Buda; raccolse allora codici e libri della biblioteca di Mattia Corvino, e piante e disegni, che formano oggi una raccolta di rari cimeli nella ricca serie dei suoi manoscritti a Bologna.
Dopo la presa di Buda, il nostro Marsigli fu inviato a Roma presso il Papa, che lo mandò poi a Vienna presso l’imperatore per trattar delle cose di guerra.
Nella fermata a Vienna il Marsigli conobbe il cardinale Buonvisi, e scrisse allora, e a lui presentò, la « Storia del Cavè », che stampò a Vienna nel 1685 in un libretto di poca mole, metà scritto in italiano e metà in lingua turca.
II libretto sul Caffè è dedicato, anzi, ripeterò, brindato, al Cardinale Buonvisi di Lucca.
Di Cardinali Buonvisi due ne ricordano le storie e le ero-
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
nache, ambedue lucchesi: il primo, Gerolamo, nato nel 1007, di nobile famiglia, studiò a Roma; fu presidente dell’Annona, e sotto Innocenzo X fu preconizzato arcivescovo di Leodicea. Ritiratosi invece in patria, e venuto Alessandro V II (Chigi) amico suo, fu chiamato a Roma, maestro di Camera e nel 1657 Cardinale di S. Girolamo degli Scliiavoni, con la Legazione (li Ferrara. Passò poi alla chiesa di Lucca dove sostenne questione col Governo. Ebbe amici ed estimatori che volevano eleggerlo Papa nel Conclave di Innocenzo XI. Ritornato a Lucca vi morì nel 1G77 di 70 anni, dopo venti di Cardinalato, ed ebbe tomba in quella Cattedrale.
Il secondo Cardinale Bonvisi fu Francesco, nipote di Girolamo, nato a Lucca dalla stessa nobile famiglia nel 1025. Dignitoso e dotto sacerdote, fu chiamato a Roma dallo zio Cardinale e fatto Cameriere da Alessandro V II, e canonico late- ranense.
Seguì il Cardinale Chigi a Parigi: tornato a Roma fu segretario della Congregazione delle acque; arcivescovo di Tessa- lonica, e poi Nunzio a Colonia per affari di alta importanza e contro ottomani. Eletto Re Sobiesky fu nominato nunzio in Polonia.
Clemente X con lo stesso ufficio lo spedì a Vienna presso al Censore nel 1075, dove diede buone prove di zelo per la Chiesa.
Nel 1081 ebbe la porpora (la Innocenzo X I: e nel 1090 fu da Alessandro V i l i trasferito al vescovato di Lucca. Ivi morì nel 1700 dopo 20 anni di Cardinalato, e fu sepolto nella Cattedrale.
Ricordate codeste notizie possiamo concludere che è questo il Cardinale Bonvisi cui è dedicato il « brindisi col caffè » del nostro scienziato avventuroso.
L. RAVA - II, CONTE MARSIGLI E II, CAFFÈ 363
eco il frontespizio del raro opuscolo:
B E VANDAA S I A T I C A ,
B R I N D A T Aa lP E m in cn t i iI ìm oB O N V I S I ,
N u n z io Apoftohco apprejfo la, M ae{id dellIm peratore , ère.
Da L U I G I F E R D I N A N D O C O M A R S I G L I .
Che narra l'HtJloria Medica del Cave.
V I E N N A d A V S T R J A , Appretto GIO.- V A N GHELEN , 1 6 8 5
364 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
III.
storia del ('affé.Sentiamo ora il Marsigli. Riproduco dal rarissimo opuscolo
che si trova (che io sappia) solo nella R. Biblioteca di Bologna. A Roma non esiste.
Eminentissimo Signore,
I Legislatori de’ costumi più scielti più morali non tralasciarono di seguitare l’uso de’ Conviti, parendogli forse, che non si potesse dar contrassegno di maggiore affezzione à suoi Conoscenti, che fargli commune il proprio alimento; sapendosi, che quel grand’ huomo di Platone lià tal costume seguitato, con celebrare Conviti alla posterità resi memorabili, mentre erano motivo d’eruditi discorsi, che i Convitati ammaestravano con quella ilarità appunto la Tavola produe; Permetteva, che nella Limpidezza delle Bevande si mostrassero reciprocamente il candore del loro cuore, e che nell’instabilità d’un Liquore palesassero la costanza della loro amicitia, invitandosi coi Brindisi, Vostra Eminenza; che hà un’ elevatezza d’ animo solo capace l ’imitare quei Huomini hanno meritato una perpetua gratitudine dalla Posterità, con haverli resi tanti benefizii, nel Dogma, e nell’operazioni, non può à meno di seguitarli anco nel tempo di dar sollievo, e divertimento allo spirito di continuo affaticato in quei maneggi sono proprii di quella Porpora porta, e di quel Carattere sostiene in Benefizio di tutto il Mondo Cliri- stiano; sovenendomi haver l’inteso dir più volte, che l'ora del pranzo non la considera solo per il tempo di dar col Cibo il dovuto sostentamento alla materialità del Corpo, mà ancora di sollevar l’animo dall’oppressioni delle cure cou l’havere Commensali, che promovino discorsi fondati in una gioviale erudizione, che danno stimoli d’apprendere à chi l’ascolta, e risvegliano la naturale gioialità di V. E. che nella gallanteria ogn’uno sovrapassa in pari grado di quello fà nella serietà; intende pure da ogni parte augurii di quella salute, che appunto i Convitati si sentono infondere dalla sostanza di sì delicate bevande, che li fà saporire; e perciò non è meno obligo d’ossequio, che di gratitudine augurare à V. E. quell’utile medesimo si prova per la di lei Generosità; & Io, che in ora hò una Bevanda straniera da introdurre nella Tavola di V. E. col
L. RAVA - IL CONTE MARSIGLI E IL CAFFÈ 365motivo, che gl' habbi da essere salutifera, è ben giusto, che gliela presenti in un riverente brindesi, con l’usata parola (alla salute di V. E.) essendo la bevanda del Cavè piena di tali qualità, che usandola non potrà il di lei temperamento che ricevere sollievo in quelle parti alle volte disturbano la di lei perfetta salute. Sò che parerà strano ad ogn’uno, che Io vogli parlare dell’arte di Medico quando non è mia professione, mà spero che V. E. conoscerà, che le ragioni addurrò non sono che riportate da Soggetti appunto, che nelle medicina hanno sommamente spiccato; e vedrà pure, che un Turco s’uniforma nello spiegare le Virtù del Cavè ai sentimenti di tutti gl’altri, che n’hanno parlato; e di più in esso leggerà l’origine, augmento, e maturazione, e preparamento del frutto del Cavè, per ridurlo in istato, che sii atto à potere formarne tal Bevanda; e perchè non riesca strano di vedere, che Io narri la produzione di detta pianta in forma tanto contraria à quelli tino d’ora n’hanno scritto, hò risoluto di puramente mettere sotto gl’oechi di V. E. in Idioma Turco, & Italiano quella Relazione mi diede l’Auttore, che è stato Cuseim Efendi, uomo, che non solo frà Turchi hebbe la stima per le cariche nell’impero Ottomano esercitate, e per l’esatte Historie hà scritto, mà ancora frà quei Christiani, che l’hanno nella Corte di Costantinopoli pratticato, come hò havuta l’occasione di far’ lo, che nel rammemorare frà me medemo i di lui talenti, e sapere, e buona legge d’amicitia, non posso à meno di non compiangere, che sii morto nella falsa Religione Maomettana. S’aggiunge alle notizie, che hò ricavate dai detti luoghi, l’esperienza presa ne’ viaggi hò fatti col Bailo Ciurani ne’ Paesi della Turchia, e l’esercitio, che ho dovuto bavere, in tempo della mia Schiavitù appresso di Arnet Bassà di Thimi- suar, che avanti Vienna per veleno datoli dal Visire terminò i suoi giorni: avegnache per mio mecanico esercitio nella di lui Corte dovetti per molti giorni in una fumicata tenda esercitare l’arte di Cuoco del Cavè, non solo per la quantità era necessaria all’uso della sua Domestica Corte, mà anche per quello bisognava à tener fornita una Bottega che si potrebbe equiparare à un’ Hosteria delle Nostre; impiego, che m’ hà erudito nell’arte di preparare il Cavè, d’osservarne molti effetti, e che mi hà data la vita, mentre con questo mezzo m’ero fatto conoscente di quei Bosnachi, che mi comprorono in quel tempo appunto dovevo soecunbere al preparatomi colpo della sabla in pena della fuga tenta; e perciò, V. E. dirà, che il Cavè in me hà liavuta una gran virtù, e che è ben giusto, che sii grato nell’esal- tare le sue qualità intrinseche. È noto à V. E. che l’huomo non puole per decreto della Natura sottrarsi dalla necessità del
MEMORIE INTORNO A L. F. MAHSII,I
l’alimento, per sostentare in vita se medesimo, provando giornalmente gl’incitamenti della fame, e della sete; e perchè indispensabilmente hà stabilito questo tributo, non lui mancato ancora di rendere la Terra fertile di biade, d’animali, di frutti, d’acque, accioche con industria possi l’huomo pagarlo, componendosi cibi, e bevande per nutrirsi. Ambi questi appetiti, causa d’agitazione al Nostro Corpo per tante ragioni, sono stati nella varietà de’ tempi, e frà le varie Nationi diversamente satiati, componendo cibi, e bevande di differenti gusti. È stata questione frà molti, se sii più necessario l’applicarsi à cacciar la sete, ò la fame; mà tanti esempi hanno fatto stabilire all’huomo, che sii più penosa la sete, che la fame; e perciò è giusta ogn’at- tenzione à comporre Bevande; essendo stati ancora compatibili quelli, che le lordure medeme se gli sono rese scavi; liaven- dosi il caso di Dario, che posto in fuga da Alessandro si trovò necessitato per liberarsi dalla sete di bevere acqua putrefatta, e dai puzzolenti cadaveri resa infetta, e pure gli riuscì grata restandi distrutto l’appetito della sete, che non puole essere che grande, come cagionato ila una vilicatione de’ nervi, che restano compressi dall’avidità delle tuniche per la mancanza dell’humi- dità nelle fauci della gola, & dello Stomaco, e per quell’acre- dme de’ ssali, che le sudette Tuniche tormenta, & agita; mà la Clemente Natura con l’havere come hò detto non solo tirate dalle fauci della terra così limpide acque, e generati frutti ripieni di suo, ha dato commodo con ogn’uno di questi fluidi liberarsi non solo da così penosa agitazione, mà ancora d’assistere alla digestione, col macerare con questi nello stomaco i cibi indigesti, & attenuarli per il passaggio; e perchè il Kilo che è quel fluido espresso dalle sostanze de’ cibi resti nelle sue parti grasse, assottigliato, e più facilmente possi scorrere frà l’angustie de’ vasi lattei.
Nella varietà de’ tempi anche variamente furono pratticate le bevande, mentre i nostri primi Padri, non havendo peranche conosciuti i doni della Natura, si valsero dell’aeque de’ fonti, e fiumi; e doppo liberata la terra dal castigo dell’universal Diluvio, e fattone Coltore il buono Padre Noè, che conobbe bene, che era utile l’industria di far crescere la vite, prevedendo il vantaggio, che ne doveva l’humanità ricavare dal di lei frutto, dando l’esempio alla Posterità, di qual danno anche sii il soverchio gustare del di lei grato liquore. Questa pianta non peranche fatta commune, e non proportionata à tutt’i Climi, come n’abbiamo hoggi l’esempio in quelli in tante parti d’Ale- magna, lià obbligati tali Popolo à cercare con l’industria compo- sitioni di tali liquori, che in parte possino far la vece del vino.
L. «AVA - IL TONTE MARCIGLI E IL CAFFÈ
Gli Ebrei uso[ro]uo varie bevande di frutti, ohe generalmente erano comprese sotto il nome Aasis, che significa sugo atto ad esser bevuto, e compreso da Corpo di Natura humida, mentre la parola Aafas, vuol dire comprimere, & i frutti più frequenti erano il fromeuto, i iteri &c.
Gli Egittii non potendo per cagione del Clima, ò per la natura della terra così argillosa radicare la vite, furono loro pure obligati di ricorrere ad altra bevanda, componendone una particolarmente d’orzo, che à mio giudizio non doveva essere dissimile dalla birra; bevanda tanto universale, che hù mentovato essersi servito gli Ebrei, di maniera che l’inventione della birra praticata in hora cossi familiarmente nelle Parti Settentrionali, si puoi credere babbi principiata nell’ Orientali.
Molte Nationi, & ancora la Romana stimarono delitiosa bevanda la pura acqua calda, è gelata, come da più Poeti si deduce. Mischiorono pure l'acqua & il vino, che doppo riscaldati l’ infondevano mirra, mastice, croco, balsamo, amonio, cina- morno, & altri Aromati di simile natura, che tutti servivano non meno à dilettar il palato, che ad accendere i spiriti.
Ne’ tempi d’ hora non dubito che V. E. non sii per dire, che il gusto delle Bevande sii di gran longa migliorato, essendo incessante l’attestato appresso la di lei Tavola, mentre le varie Nationi non solo à gara degl’antichi, mù ancora dell’ una, e dell’altra, hanno composti grati liquori, secondo la commo- dità de’ mezzi, e proprii instituti.
L ’Italia, che à il dono della natura dell’abbondanza del vino, cura poche altre bevande, fuorché quelle sono originate dal medesimo vino, come l’acquevite, e qualche volta più per lusso, che per sodisfazione, gode anche di straniere bevande fuori del vino.
La Francia universalmente abbondante di viti vuole saporire il frutto d’esse posponendo ogn’altra bevanda, eccetto una gran parte delle Figlie, che per mantenere il candore delle loro guancie equale à quello del cuore verso i loro amici, si privano di questa sodisfazzione, negligendo l’Assioma medico; siccome pure il popolo della Normandia prattica le bevande di succo <!'• pomi, essendo questi in quella Provincia abbondanti di tali frutti.
L ’ Inghilterra Regno «laila Natura arricchito di tante prerogative, ad ogni modo per mancanza delle viti, bisogna confessi per propria bevanda le varie sorti di birre, che con noti ordinaria delicatezza fabrica.
Gran parte dell’Alemagna pure pari querela dell’Inghilterra tiene contro la Natura, per non haverli permesse qualità suffi
3K8 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
cicnnti da potere coltivare le viti, essendo ella ancora obligata ù servirsi delle birre.
L ’Ungheria, che si crede gloriosa di superare ogn’altra Nazione nell’ esquisitezza de’ vini, celebrando più d’ ogn’ altro, e senza torto il suo Tochai, non vuole ammettere nessun’ altra bevanda, che ’1 vino, che per renderlo più forte, e più salubre usano l ’ infusione dell’ absinto.
La Polonia benche tanta quantità di vino consumi, la deve ad ogni modo portare da parti straniere, e confessare per propria bevanda la birra, & il miod.
In un Clima così caldo come la Spagna le viti sono abbondanti, che danno vini di gran forza, e di gusto non solo grato à nazionali, mà anco à stranieri; scicome pure eccede ogn’altra nazione nel comporre più artifiziate bevande, e massime la Cioc- colatta.
La Turchia benche abbondante d’esquisiti vini coltivati da quei Christiani tributarii, che l’ habitano, non ammette 1’ uso d’essi secondo un precetto della superstiziosa loro legge Maomettana, che li divieta il Vino ; & in molte parti dell’ Impero Ottomano questo punto di legge è inalterabilmente obbedito, & in molte altre ancora deriso; mentre i Turchi nelle Provincie d’Europa in gran profusione lo bevono, e per il contrario molto astinenti ne sono quelli dell’Asia, Inventori della maggior parte di quelle bevande che si servono di presente i Turchi, per compensare alle delizie del vino, per non sempre servirsi del- l’ insipidità dell’ acque communi.
Le bevande de' Turchi ad imitatione di quelle pratticarono i Romani, le distinguono in calde, e fredde, havendone d’ambe le sorti l’nsso giornalmente; e frà le fredde danno con ragione il primo loco alla delciatezza del sorbetto fabricato di zuccaro ben chiarificato, e misto con una portione di qualche suggo di frutti, e fatto odoroso ò con ambra, ò con muschio; & ancora pratticano di bevere quell’acque, dentre delle quali hanno fatto bollire, ò il Cibibo, ò l’uva passa, ò altri frutti secchi, come peri, brugne; bevanda molto più famigliare nelle Provincie della Servia, e Bosnia, così abbondante di brugne, frutto, che con la sua sostanza, e con il sapore dava quell’acqua, in cui era bollito, e con quel spirito, che era tirato à forza di fuoco iu un lambico, in forma eguale di quello si facci l’acqua- vita, restorava la debolezza del mio corpo afflitto dalle miserie della schiavitù, che in tal Paese m'era dolorosa, per la mancanza del cibo, e bevanda: Per una specie di bevanda i Turchi contano pure il latte congelato, e fatto agro, dandoli il nome d'.Tugurt: la Plebe ancora hà in costume un'altro liquore coni
là. BAVA - IL CONTE MARSIGLI E IL CAFFÈ ¡¡69
presso dal miglio, che equiparar si puole alla birra, e si chiama Bosa.
Per bevande calde pratticano la nominata Salep fatta con acqua calda, miele, e polvere della radice di Satirion, pianta, che con gran diligenza raccolgono nel Monte Olimpo, che alle sue radici tiene la Città di Bursisa ne’ tempi passati residenza degl’ Imperatori Ottomanni, che con l’ acquisto d’ Andrianopoli, e Costantinopoli la lasciarono ; e l’ Inverno più d’ ogni altra staggioue se ne servono, dicendo, che si preserva dal freddo, e che li fomenta pochi altri decenti appetiti.
Alcuni pochi gran Signori si sservono di quella bevanda, che frà noi vien nominata Tè, e fra loro Ciay; Ma più di tutte le dette è frà la Nazione Turchesca in uso, anzi necessaria quella pretendo sii salutifera à V. E. cioè del Cavè, introdottosi da non molto tempo in quà per la maggior parte della Christia- nità con l’occasione del frequente commercio si tiene con la Corte Ottomanna, ò con il benefizio delle prede fatte ò in mare, ò in terra, come più volte è accaduto all’Armata di S. M. C. che riportando gloriosse vittorie hà ritrovata quantità di quelli semi, che preparati, come à V. E. dirò, formano la bevanda del Cavè, che cominciatosi à saporire frà noi Christiani si è postaio frequente uso, fuorché appresso di lei, che per tante ragioni, che riguardano sempre alla di lei salute, si deve lasciar persuaderne di beverne, e non privare di questo vantaggio i di lei commensali, che dovranno ascoltare con V. E. quello dice circa la virtù, & origine di tal frutto il sopranominato Cosain Efendi, che nella sua spiegazione mostra la verità dell’origine di questa pianta, confrontando le menzogne de’altri Turchi, che ne hanno scritto, non che di molti curiosi Christiani, che ne hanno parlato per semplice relatione, e non con l’evidenza, che hà havnto esso nel tempo era nell’Arabia felice con Commissioni publiche; e per sottrarmi dall’indignazione di quelli hanno stampato tali relationi diverse di quelle darò à V. E. e per fare che sinceramente apparisca in questa bagatella Posatezza, l’ordine, il talento del detto Turco, metto sotto i di lei occhi la scrittura medema mi diede lui in Idioma Turchesco, & annessa la traduttione in Italiano, accioche gl’ esperti della lingua Turchesca possino incontrare l'una con l’altra; e per chi si trova privo della cognizione della lingua Turchesca, credo che gli basterà di sentire, che il Sig. Cavallier Meninschi maggior Interprete di S. M. C. per le lingue Orientali habbi leggalizata la medesima Traduzione per fedele, e giusta.
26
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
IV.
Ut Memori» sul ( ’affé «li Cofani Efelidi.Dopo la storia del caffè, opera del Marsigli, viene uell’opu-
scoJo la « memoria » scritta iu lingua turca, di Cofani Efendi. chiamato per soprannome Hefar Sen, cioè di mille virtù o scienze. Così parla il turco (leggo la traduzione) : « Per esser stato scoperto il Cavè nei secoli prossimi passati, nelle trattazioni dei semplicisti, descritte da medici antichi, non ne viene in alcun libro di loro mentovata, o spiegata cosa veruna, e per il contrario molti moderni hanno fatto più dicerie o diposti concernenti la qualità, profitto, danno e natura di esso ». Descrive quindi l’albero del caffè, il frutto, il grano, le scorze, il modo di brustolare i grani, e conclude che bevendone modestamente si ha salute e allegrezza.
Continua poi il Mar sigli :
« Ad una tale relazione, fatta dal nominato turco, toccante l’origine et augmento della pianta e frutto, e usi, è ben giusto succeda a dire a V. E. quel di più mi pare necessario, e ho appreso, fra le catene della schiavitù, che mi condannò per molto giovine, come ho detto, a professar l’arte di cucinare questo frutto, che per esser ridotto in stato proprio di formare la promessa bevanda, è necessario avvertire molte particolarità, che nel- l’ esporle a Lei in hora vengo anche ad acquistar le istanze che m’hanno fatto tante ricerche per sapere ogni osservazione prattieata da Turchi per tale preparazione per la quale qui espongo a V. E. quanto ho praticato e veduto e ho inteso a dire per rendere la bevanda nella sua maggiore esquisitezza. E perciò spero che ognuno in avvenire mi lascierà in pace con queste richieste (39) ».
11 nostro qui descrive il modo di abbrustolire il caffè, di riporlo in vasi, di farne una polvere simile al tabacco di Spagna, di far bollire, dì mettere zucchero, fatto odoroso con acqua d’ambra, cedro e gelsomini, o simili.... E conclude che, a suo giudizio « ai temperamenti umidi, come quello di V. E. sii sommamente giovevole l’ uso del Cavè, che come legalizzata dal- l’ esperienza e dall’ opinione di tali huomini, è ben giusto che
L. RAVA • IL CONTE M ARSIGLI E IL CAFFÈ
<lia l’esempio con l’bavere nel cuore, e nella bocca il motto « alla salute» che (leve nutrire per veliere continuato il buon servizio della Santa Sede e di S. M. Cesarea che come desiderosi del bene pubblico hanno scelto, nelle così importanti congiunture «l’ora, valersi della di Lei prudenza e zelante opera, non solo giovevole ai tempi, anche ai futuri che col leggere i di Lei maneggi comprenderanno quanto V. E. operò e quale esempio di sè lasciò ».
V.
I primi trattatisti del caffè. - li. Mag r i.
Nello studiare la monografia il brindisi sul caffè del Mar- sigli credevo fosse stato primo il nostro a trattare in istampa di tale argomento. Ma invece, nel silenzio dei trattati e delle Enciclopedie, ho potuto ritrovare un altro studio sul caffè (e forse altri potranno esistere) in forma di lettera, di Domenico Magri, scrittore Maltese del seicento, sulle virtù del caffè; lettera diretta (1671) al Cardinale Brancacci suo amico e protettore.
Il .Magri (1004-1672) nato a Malta fu prete dell'Oratorio a Koma, e canonico della Cattedrale di Viterbo dove morì nel 1672. Scrittore ecclesiastico di molta fama al suo tempo, gli si deve il Hierolexicon (Roma T657), libro utile per gli studi sulla Sacra Scrittura, e un Trattato latino sulle contraddizioni apparenti della Sacra Scrittura (ristampato a Parigi nel 1863); un viaggio al Monte Libano (1664) e la lettera ricordata su « Le virtù del Caffè» stampata del 1671 iu 8° e dedicata al Cardinale Brancacci che aveva scritto...: Jm virtù della Cioè- colata.
La letteratura del caffè in Italia comincia così con lettere e dediche a Cardinali, e con una gara fra amici della cioccolata e amici del caffè.
Il libro del Magri ha per titolo:« Virtù del Kafé - Bevanda introdotta nuovamente nel-
l’ Italia con alcune osservazioni ¡jet' conservar la sanità nella vecchiaia.
372 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il Magri ricorda che il caffè « è bevanda molto praticata nella ma patria (Malta), e oggi introdotta in Italia e in altre parti d’ Europa con evidentissima cura di « morbi disperati » ; e descrive i cavalieri e altre persone qualificate che ogni mattina si trasferiscono al bagno degli schiavi « per gustare quel decotto nelle officine pubbliche ovvero lo manipolano nelle proprie case per assicurarsi meglio della sincerità dell’ingrediente non falsificato (già allora si falsificava?!); anzi i medesimi medici non soamente lo lodano ma lo bevono ancora frequentemente esperimentandolo salutifero ».
Egli scrive la relazione sul caffè dopo avere « con molta diligenza reiterate informazioni dai più periti turchi artefici di tal decotto, e dalle lettere di medici europei dimoranti in diverse parti dell'Oriente, i quali con la speculazione fisica e con l’esperienza continuata da molti anni, hanno penetrate le virtù occulte del caffè ».
Sentiamo ora la ricetta del Magri (il libro è raro) per falla bevanda e gli usi e le virtù di essa:
« Il Caffè si nomina Kabua dagli Arabi, dal Medico Aspino Bau, ed è una specie del Cavau indiano più minuto. Questa bevanda si prende calda assai, a sorsi, nell’acqua con zucchero,o con qualche odore ed altre droghe secondo il gusto di chi beve; ma il proprio è prenderla schietta, come si dirà. Vien molto lodata, giovando universalmente a tutte le età, e a tutti i sessi; e però si prende in tutto l’Oriente, nell'Africa e nell’india, ed anche dai nostri Europei, da sani e ammalati, da giovani e da vecchi.
Il Caffè è un seme poco più grande del fagiuolo, con la scorza nera, dentro però è bianco di questa figura 1, con una fis- sura in mezzo, come la fava, le foglie simili a quelle del ciliegio. Si pone dunque il detto seme in un tegame di terra, o tiella di rame, nella quale si fa brustolire sopra la brage con maneggiarlo sempre acciò non s’abbruci, per poterlo poi pestare bene in un mortaio pulito in maniera che la polvere non
1 Qui il Magri, non contento della descrizione fatta, disegna al Cardinale un seme di caffè.
L. RAVA - II, CONTE MARSIGLI E IL CAFFÈ 373
diventi molto nera, ma piuttosto lionata oscura. Meglio riesce arrostirlo nel forno: avvertendo che se il seme restasse arido e molto abbruciato non vale a cosa alcuna. Così ben pesto, e ridotto in minutissima polvere fina, sisetaccia.
Si prende poi un vaso stagnato di rame, ovvero un cucumo di terra invetriato, dentro del quale si mette per esempio una foglietta d’acqua, che si fa vollire, e poi dentro questa acqua bollente si gettano due cucchiaiate ordinarie, cioè un’oncia in dieci d’acqua della polvere, e per un altro quarto d’ora si lascia bollire, avvertendo sopratutto che la schiuma non esca fuori nel bollire, perchè quella è la sostanza migliore del caffè; se bene Antonio de Scobbis nel suo Teatro farmaceutico inette in venti libbre d’acqua una e mezza di caffè, ma sino alla consumazione dell’acqua che riesce il medesimo. Dopo bollito si tirerà il vaso indietro, lasciandolo riposare così per lo spazio di un Credo, facendo intanto un poco di posa la polvere nel fondo, come farà anco nella scodella, la quale polvere nelle officine si rimette in un altro vaso ricuocendola : e poi di quell’acqua così colorita o ben colata si servono per rifare il giorno seguente il decotto con infondervi manco polvere per esser l’acqua carica della medesima polvere già posata e levata via.
Questo seme di natura sua è caldo e secco. Riscalda lo stomaco, aiuta la digestione prendendosi due ore dopo il cibo, giova contro il catarro, e mirabilmente conforta la testa, scaccia il sonno e dà forza per resistere alle vigilie degli studenti, e reprime anche i moti del senso venereo ed è favorevole a mantener l’uomo casto. Giova più l’inverno che l’estate, ed è più efficace prenderlo senza la scorza. In Inghilterra si è sperimentato assai giovevole contro l’ idropfìa e la podagra, onde ragionevolmente scrisse Andrea Belluense « cuius vires depredicat Alpinus ad arcendam putredinem,, ad cor recreandum, ad ca- pitis dolores, et ad virium recreationem ». Dalle foglie si cava una acqua stellata, la quale giova agli affetti del cuore, ed anco infusa con mandorle se ne cava l’olio. Di esso decotto parla Gianni Behino nell’istoria delle piante (lib. 8, cap. 21). Tutti avvertiscono di non intorbidirlo; ma lasciar che facci la posa nel fondo.
Avanti di berlo nella scodella vi si mette del zucchero, piùo meno, secondo il gusto di chi lo beve. Vi si possono mettere tre o quattro garofani per odore nel bollire, ovvero dei semi di card amono, che sarà più stomacale e conforterà la testa. Ma
37+ MEMORIE INTORNO A L. I*’ . MARSILI
l'uso più ordinario è di berlo con un poco di zucchero e qualche goccia d’odore d’estratto di muschio ovvero d’ambra.
Si suol anco bere la mattina con prender qualche boccone di pane o ciambella, ma poco: ovvero si beve (lue ore dopo il cibo, perchè aiuta la digestione. Per i melanconici non riesce troppo buono, i quali lo potranno prendere più chiaro e meno denso. Chi vorrà vegliare la sera lo prenda due ore dopo cena, che si sentirà la testa sgravata, ontro il catarro si beve con zucchero candido ed avanti di prenderlo si mangia qualche cosa leggiermente, perchè così impedisce la bile: ma per l’ordinario non si suol prendere cosa alcuna.
Gli orientali bevono il caffè in ogni tempo; anzi anco nella mensa in luogo del vino, e chi l’usa spesso ne sente grandissimo giovamento che però si può bere quattro volte la settimana, nè si richiede tempo per digerirlo, e però si può frequentemente bere: poiché non si trova che mai abbia nociuto ad alcuno. Leva le ostruzioni e le oppilazzioni. L ’esperienza continua ci dimostra chiaramente che il caffè toglie mirabilmente ie flussioni catarrali e altre infermità cagionate dalla miniera del fegato, e questo opera senza pregiudizio dello stomaco, come di sopra ho dimostrato. Laonde i turchi per l’ordinario mai patiscono flussioni nè dolori di denti, nè sono tormentati dalle podagre o da simili infermità, anzi stimano che il fumo giovi contro il male degli occhi, ai quali accostano la scodella prima di berlo ».
Il Magri fa seguir al suo studio la relazione di un medico scritta da Costantinopoli ad un gentiluomo raguseo, relazione che ripete le solite cose, o, meglio, dice le cose ripetute dal Magri, sul modo di fare e di presentar il caffè — cosa diffici lissima, egli dice — e sull’uso di offrirlo ai visitatori: e dell'efficacia sua sulla salute e sulla bellezza delle donne.
E riferisce esso pure le parole di Prospero Alpino (nel suo volume De piantis Acmi pii, [cap. 10]), e insieme la descrizione di Antonio De Scobbis, nel suo Teatro Farmaceutico, impresso a Venezia nel 16f>7.
Conclude il Magri col dichiarare che ha riferito tutte le notizie sul caffè raccolte nel suo soggiorno a Malta, in attesa di poter ripartire con le galere pontificie fermate a Malta in quarantena.
L. BAVA - IL CONTE RIARSIGLI K IL CAFFÈ 375
E gli piace ricorda re che ebbero gli infermi grandi cure dal Gran Maestro, il quale aveva eretto una nuova infermeria, « provvedendola di medici, chirurgi, pollami (!) e ogni sorta di medi «amenti, con spese considerabile, facendo curare, con le mani avvezze a maneggiare le armi trionfali, non solo ai soldati, ma anche alla più vile ciurma dei forzati e degli schiavi »
L’Alpino — nato a Marostica nel 15 e laureato a Padova nel 1578, — era buon medico e studioso di cose naturali. Seguì il gentiluomo veneto Emo, che andava console al Cairo. Rimase tre anni in Egitto, studiò la flora e ritornò in Ttalia ricco di notizie e di erudizione; fu medico di Andrea Doria a Genova, poi si recò a Padova, dove fu chiamato alla « Cattedra dei Semplici », ed ebbe nel 1603 la direzione dell’orto botanico. Fece l’Alpino conoscere a Padova l’uso della bevanda araba nuova del caffè; e forse si deve a lui la spinta all’apertura in Venezia di quelle botteghe deI Caffè che dovevano poi affermarsi in Italia e al di là delle Alpi. -
VI.
Caffè e cioccolata.Che rispose l’eminentissimo «difensore della cioccolata »?Il Cardinale Stefano Brancacci, nato a Napoli del 1018,
fu prelato di consulta, poi inviato inquisitore a Malta da Innocenzo X, e da Alessandro V II destinato alla nunziatura della corte di Torino, e poi nella Repubblica di Venezia. Nel 1070 fu fatto vescovo di Viterbo e Cardinale nel 1(581 e morì a 04 anni del 1082.
1 Roma, 1671.
- V. su l ' A lv in o Capparoni : Profili rii M ed ici e naturalisti celebri italiani. Roma. 192">.
Vidi notato in un catalogo di libri antichi il volume « Scelta di opuscoli interessanti, tradotti da varie lingue». Milano, Marelli, 1776; e, tra tali opuscoli, una dissertazione di Giovanni Ellis sul Caffè. Non ho potuto vedere questo libro.
376 MEMORIE INTORNO A L. P. M ARSILI
Il Card. Brancacci lasciò una raccolta di dissertazioni latine « su diritti e privilegi di cardinali » sui « conclavi » e altri argomenti, e una diatribe sul Cioccolato, dove lungamente esamina se il cioccolato, con l’acqua, rompa il digiuno ordinato dalla Chiesa (aa chocolates, aqua dilutus prout hodierno usti aorbetur, ecclesiasticum frangat jeiunium » : e decide pel no. Ma la questione non tini così alla svelta, perchè sorse l’Hecquet a confutarlo nel suo Trattato delle dispense di quaresima.
La dissertazione « sul cioccolato » fu stampata a Roma nel 1665, e ristampata poi nella Raccolta delle dissertazioni latine nel 1672.
Ecco il titolo del libro, curioso e raro che è ricordato dal Magri :
Fruneisci Mariac Cardinali* de lira acati in de Cliocolatis pota diatriba praelo mbiecta, Instante Dominico Magri meletensi Canonico tlieologo Ecclesiae Cathedralis Viterbensis.
Precede una lettera: Benevolo lectori Dominimi* Magrus 8. D. che loda la diatribe con alte parole per lo scrittore « inul- tiplici eruditione solidaquc doetrina refertam », e cita Seneca :
Veaiet tempii* quo ¡sta quae menu- latent, in lucei a dies extraheat et loagiori* aeri diligeatia.
Il libro del Brancacci si chiude cou le lodi di Album Culminili archiatra, e con una ode latina di Luigi Ferroni, della C. di (}., in lode della cioccolata:
O nata terris arbor in ultimi»E x mexioani gloria littoris
Faecunda succo, quo snperbit aethereum Chocolata nectar
Tibi omne lignum cedat; et omnium
Propago florum *.
Dopo la diatribe se sia o no il cioccolato contro il digiuno, l ’autore viene a trattare con uno studio speciale: Methodus ad conciniaudaia cliocolatis potionem eiusque qualiltate phy- sicae, e narra della comparsa in Europa della cioccolata, venuta dal Messico; e del modo di prepararla.
Ma a noi basti... il caffè.
1 Pag. 37. M D O LX IV , Roniae apnd Alexander.
L. RAVA • IL CONTE MARCIGLI E IL CAFFÈ ;ì77
VII.
Amici e nemici del Caffè.Caffè e cioccolata ebbero in seguito di tempo cultori, difen
sori, ammiratori, panegiristi1. Tra tanti ammiratori sorse pure qualche voce nemica e basti citar il Redi nel suo sonante inno ai vini d’ Italia :
beverei prima il velenoche un bicchier che fosse pienodell’ amaro e rio caffè,
ma a lui risponde il francese lodando:cette liqueur si chèrequi manquait à Virgile et qu’ adorait Voltaire.
E finalmente ebbe il caffè un poeta e un poema. C’è progresso !E il poeta si rivolge non più a un Cardinale ma senz’ altro
al Papa. Il poeta è il ferrarese, dotto e colto, Lorenzo Barotti, storico ed erudito egregio di Ferrara, che compose un poema in due canti di bellissime ottave ariostesche, e lo dedicò a Papa Pio VI nell’ occasione delle nozze del nipote di lui, Conte Luigi Braschi con Costanza Falconieri.
E lo diede a stampare con l’usata maestria al celebre Bodoni di Parma.
I l C a f f è
CANTI DUE
Agli eccellentissimi Sposi il Signor Conte
e la Signora Donna Costanza, Falconieri
Lorenzo Barotti -
1 Cito ad esempio : G. C. C i m i s i : Storia e natura del cuffè. Firenze, 1731. - G. D e l l a R o s s a : Uso ed abuso del caffè. 2‘ edili, con aggiunte intorno alla Cioccolata. Verona, 1760. - G. M a ss ien : I l Caffè ; poema didasc. latino e italiano s. 1. n. a. - E u g e n io E n asocc : Capitolo il lode
del Caffè-Cioccolata. - G. B. F i l i c i : Parere sulVuso della cioccolata. F irenze, 1728. - D . C o n c in a : M em orie sull’uso della cioccolata in tempo
di, digiuno. Venezia, 1748. - G. B. A n fo s s i : Uso e abuso della Cioccolata. Venezia.
2 Parm a : stamperia reale, d i pagg. 38, in 8», 1781.
378 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSH.I
« Il vostro gran Zio — egli scriveva — si degnò di accettare l’offerta che io gli feci d’ un’ opera contenente le memorie di non pochi scrittori miei paesani. L’ onore che io ne ricevetti fu sommo.
Eccovi dunque, eccellentissimi Sposi, un poema clip osa venirvi innanzi: non già come frutto di una immaginazione fertile e viva ma come produzione di un grato cuore e devoto. Tenue n’ è 1' argomento, non però in guisa che avvilisca troppo il dono ».
11 poema è agile, elegante, e ricco di belle ottave.11 Barotti scrisse altri poemi, oltre questo del Caffè; ri
cordo la Fisica, le Fontane, il Tempio di Pellade, lodati e ammirati al suo tempo e oggi pure non dimenticatoli: li Ber- tana nella sua opera su « l’Arcadia » lo ricordò degnamente.
V ili.
La bottega del caffè.Dopo l’erudizione, la poesia e la medicina, venne l’industria.La prima bottega di caffè fu aperta — è noto — a Costa n-
ninopoli nel 1554. In Francia Luigi XIV nel 1 <»44 fu primo a bere la profumata bevanda ; ma in Italia si usava già, e il caffè, nel 1(J38, si vendeva caro a Venezia, ma come medicinale. Xel 1676 il Senato Veneto si dovette pertanto occupare della vendita del caffè offerto da spacci appositi. Xel 1683 fu aperta una bottega nelle Procuratie nuove; ed altre nel 1700 nelle Procuratie vecchie e nuove. Xel 1720 fu Floriano Francesconi che aprì la bottega oggi ancora fortunata : nel 1775 venne il caffè del Quadri di Corfù. 1 due caffè « Florian » e « Quadri » fioriscono oggi pure nella piazza meravigliosa.
Poi « il Menegazzo » alle Mercerie a Venezia, ritrovo di letterati, e centro dei litigi tra Baretti e Schiavo. Era così detto da Menico, grasso proprietario ed era convegno dei letterati questo, mentre era il Caffè « dei segretari » quello di S. Zit- liano, dove andava il Gratarol nemico della bella Procurato-
L. RAVA • IL CONTE MARSIGLI E IL CAFFÈ! 371)
ressa Tron.1 E presto ebbe Venezia più che duecento piccoli caffè. A Parigi sorse il Caffè di Procopio aperto nella fine del 1G00 dal siciliano Procopio Cutelli.2
Vienna, pei caffè, seguì Venezia e ne contese il primato. Si è detto di recente:
« Le origini del Caffè viennese sono lontanissime, poiché risalgono nientemeno che ai tempi dell'ultimo assedio dei Turchi. Nel quartiere delle Favorite, a poca distanza dall’illustre Accademia Teresiana, c'è una via intitolata al signor Kolschitzky, al quale i viennesi, amianti delle tradizioni e riconoscenti versoi benefattori, hanno eretto anche un bel monumento. Francesco Giorgio Kolschitzky, negoziante serbo nonché informatore degli eserciti assediati, fu il fondatore del primo Caffè di Vienna alla commovente insegna del « Cuore fraterno ». Duecentociu- quant’anni or sono, camuffato da commerciante turco, egli attraversò ripetutamente le schiere nemiche, capitanate dal terribile Solimano, per portare al Duca di Lorena i disperati appelli del Conte di Starhemberg che difendeva la città. Passata la bufera, messi in fuga gli infedeli, che abbandonarono nei loro accampamenti ogni ben di Dio, l'accorto Kolschitzky chiese ed ottenne che nella spartizione del bottino gli venissero assegnati trecento sacelli pieni di chicchi verdognoli che nessuno, all’infuori di lui, sapeva che cosa fossero. Li ebbe e fece fortuna, poiché si mise a vendere il caffè, preparandolo come aveva visto fare in Turchia. Da principio andò girando per le vie con bricchi e tazzine; poi il commercio prosperò, e Kolschitzky, pur facendo pagare soltanto un « kreuzer » la tazza, riuscì ad aprire una bottega che aveva quattordici vetrine ».
Era sorto così il primo Caffè d’Europa? o fu Venezia? Parigi cominciò soltanto più tardi, nel 1724.
Da allora, a Vienna, i locali per la vendita del caffè turco si moltiplicarono a vista d'occhio e i Caffè viennesi diventarono
1 V. Rava: I I nemico della introna. Roma, Soc. Dante Alighieri, 1930.2 Pei Caffè di Venezia, si veda : Tass is i : Curiosità veneziano, V Edi
zione. 1915. pag. 104.
MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
famosi nel mondo per il loro sfarzo e più- l'accurato servizio. Alcuni erano addirittura proverbiali, come il « ('afte d’Ar- gento » aperto da un certo Neuner nella Plankengasse ».
E a Roma, sulla line del 1700, il Caffè del Veneziano, aperto in una casa al Corso, che esisteva dove ora sorge il Palazzo della Cassa di Risparmio; nel 1842 il caffè Pedrocchi a Padova, che fu teatro di scene patriottiche e luogo di convegni geniali, ricordato tante volte nelle cronache.
Il caffè passò adunque dalle farmacie alle case e dalle case alle botteghe aperte. E Venezia le curò con passione.
Carlo Goldoni, osservatore acuto della vita civile e delle usanze dei suoi tempi, ne studiò la vita, e fissò con arte mirabile i caratteri della bottega del caffè, con Don Marzio maldicente, emulo dei quattro Rusteghi.
Pietro Verri a Milano offrì il caffè ai suoi amici dotti, raccolti in una sala del palazzo paterno, e aprì l’ accademia dei pugni, nome adatto alle discussioni vivaci, e intraprese la pubblicazione del « Caffè » organo di critica vivace e di aspirazioni rinnovatrici; e sul «Caffè» del Verri Rinaldo Carli di Capo d'I.stria, pubblicò quell’articolo su « La Patria degli Ita* liani » che è come la prima strofa del grande inno per il nostro risorgimento e fu accolto da Giosuè Carducci come l’inizio o la sinfonia del poema glorioso, che animò tanti cuori, costò tanti sacrifici e doveva compiersi ai nostri giorni con le canzoni di Vittorio Veneto.
IX.
ConclusioneLuigi Ferdinando Marsigli fu adunque il primo italiano — e
dei primi in Europa — a trattare del Caffè, e dell’uso e delle virtù di tale bevanda, che doveva poi rapidamente diffondersi in Europa e formare base di uno dei più ricchi e importanti traffici mondiali, e insieme dar vita ad un’industria geniale, la bottega del Caffè, che sorse a Venezia, dopo di Costantinopoli, fiorì a Parigi col siciliano Procopio, crebbe con splendore a Vienna, e si diffuse rapidamente nel mondo.
L. RAVA - IL CONTE M ARS IOLI E IL CAFFÈ 381
E il Marsigli fu caffettiere! e (come disse) dovette « professar l’arte di cucinar il caffè », e « far il cuoco del caffè in una bottega che si potrebbe equiparare a una bottega delle nostre ».
Prima della fine del secolo XV III non esisteva nè la bottega nè il caffettiere; infatti nella « Piazza di tutte le professioni del mondo (Venezia 1645) il Garzoni di Bagnacavallo 1 non parla dei caffettieri, « pur ricordando ogni sorta di arti e mestieri e professioni, anche le più strane e dimenticate, come acromanti, aromatari, alieti, auguri ballonieri, boccalari, cal- nalesti, formatori di epitafi, optici, profeti, otiosi di piazza, poeti ecc. ».
Lasciando la storia del caffè e delle botteghe del caffè, e ritornando a noi, L. F. Marsigli resta unico uomo nella storia, che nato di nobile famiglia, dotto, studioso, viaggiatore, osservatore, fisico, geografo, militare e stratega, abbia parlato con competenza speciale e personale del caffè. Era stato, nelle svariate vicende della sua vita, anche schiavo di un pascià, e cuoco del caffè » alla sua corte, e di più reggitore della Bottega del caffè che il « Bassa » possedeva, e che il gentiluomo di Bologna dovette condurre faticosamente, finché non potè trovare scampo dalla servitù, e riscattarsi dal duro lavoro, per riprender la sua vita operosa di studioso, di scienziato e di militare, nella quale ben altre e dolorose avventure l’aspettavano. A duecento anni dalla morte, l’Italia e l’Ungheria (1730) ricordano oggi le sue dotte opere e i suoi studi. Ed anche questo singolare capitolo della sua vita meritava un ricordo nella città, che gli diede i natali, che ebbe da Lui 1’ « Instituto glorioso delle Scienze », e sempre — con animo grato — l’onorò e l’onora tra i precursori e i maestri che ad essa crebbero fama nel mondo.
L u ig i R av a
1 Vedi, sul Garzoni e le sue singolari opere, Rava: Ravenna nel Seicento. Bologna 1927, in « A tti R. Deputazione Storia patria delle Ro- magne » .
La fondazione dell' I stitu to e la R iform a d ello “ S tu d io .. d i K olopiu.
Lo Studio di Bologna, che sul finirò del Secolo XVII" mostrava i segni di una irreparabile decadensa, si sollevava ai più alti fastidi nel secolo seguente, per la creazione di un nuovo organo, che raccogliendo e coordinando le energie latenti, ancora vive e vigorose nella nostra città, indirizzava verso un più alto ideale di scienza lo spirito ardente ed operoso che animava la gioventù bolognese, ed integrava l’insegnamento dogmatico, tradizionale della nostra Università, con una istituzione di scienza sperimentale, dotata del più copioso materiale scientifico che a quei tempi fosse dato di raccogliere, governata «la saggi ordinamenti, illustrata da scienziati insigni, le cui opere la resero famosa in tutto il mondo civile.
Questa istituzione è sorta per opera di un uomo veramente grande, Luigi Ferdinando Marsigli, che ad essa dedicò gli anni migliori della sua vita, sagrifieò opere d’ingegno, fortuna, averi, e perfino la pace domestica, e, con instancabile tenacia, con inconcussa fede, con inesauribile genialità di risorse, seppe superare le difficoltà che ad ogni passo gli si opponevano, pur fra la diffidenza, la prevenzione, la derisione degli increduli, l’inerzia, la ostilità subdola e palese delle autorità accademiche e cittadine.
1 codici delle nostre biblioteche, le filze dell’archivio di Stato contengono gran copia di documenti che attestano l’attività dal Marsigli sviluppata nei 40 e più anni (dal 1685 al 1727) trascorsi dal primo concepimento al compiuto perfezionamento dell’opera. Ho scelto fra essi quelli che, per essere inediti o poco
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
noti, potevano recare qualche nuovo lume su lo svolgimento dei fatti e sulle loro reciproche relazioni, distinguendo tre successivi periodi:
Il primo è caratterizzato dalla vivace reazione contro il rilassamento degli ordinamenti scolastici ed il perseverare di viete tradizioni, di male consuetudini e di metodi retrivi, che erano ad un tempo causa di decadenza ed ostacolo alla attuale applicazione di salutari riforme.
Nel secondo periodo, dimesso ogni progetto di riforme nell'antico Studio, si volge il pensiero alla fondazione di un nuovo istituto, dove i metodi nuovi ed i nuovi indirizzi possano essere liberamente seguiti e sviluppati, e che valga ad integrare l’antico, nelle parti ove esso si era mostrato arretrato o deficiente. La generosità del fondatore e la saggezza del Principe danno corpo alla magnanima idea.
Nel terzo periodo, infine, dallo stesso fondatore con vigile cura si sorvegliano i primi inizii della nuova istituzione, per impedire che in essa si trapiantino i mali germi, che furono causa della decadenza dell’antica, e per far sì che essa cresca sana e vigorosa, accelerando la sua ascesa verso quella ideale perfezione che egli aveva vagheggiato.1
Avverrà poi, col beneficio del tempo, che anche nel vecchio Studio penetri lo spirito vivificatore dei tempi nuovi, e, ad un dato momento, si vedranno messe in atto le auspicate riforme, e delle due istituzioni formata una. sola nella moderna Università degli studii, che dall’istituto Marsigliano, prenderà nella loro geniale intima essenza le costituzioni, ne adotterà i prin- cipii ed i metodi, e perfino la sede, trasportata dall’antico Archiginnasio nello splendido palazzo dell' Istituto.
1 Quest’ultima parte sarà di speciale interesse, sia per una più sicura conoscenza delle vicende dell’istituto e delle opposizioni e dei contrasti che, a cagion d’esso, amareggiarono g li ultimi anni della vita del Marsili, sia ,per la luce, affatto nuova, che ne verrà sopra fatti e personaggi ad esso contemporanei.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 385
I.
Decadenza dello Studio Le “ Memorie „ dell’ Arcidiacono M arsigli
Il malgoverno della « Gabella Grossa » che costituiva il principale cespite delle entrate dello Studio e la perniciosa pratica nella nomina dei Lettori, fondata sulla opinione che: «Tesser cittadino porti un jus acquisito alla Lettura e l’anzianità del dottorato la prelazione per essa, e.... tanto le prime Letture, quanto gli aumenti successivi siano inamovibili di lor natura », avevano portato, da un lato la decadenza degli studii, d’altro lato la impossibilità di sovvenire alle spese degli stipendi, « ancorché meschini, per sì gran numero di Lettori ».
Fu dunque necessario di « Fermare il corso dello Studio », ed il 29 Agosto 1668 il Senato statuiva di « non inscrivere in quell’anno nè nei successivi nuovi Lettori, per fino a tanto che quelli già inscritti fossero ridotti in tal numero da potersi soddisfare regolarmente coi redditi della Gabella ».
Verso il 1689 si tornò a parlare di nuove condotte, e si ventilarono progetti atti ad impedire la rinnovazione dei lamentati inconvenienti. Ma i Collegi si fecero a sostenere la pretesa dei dottori cittadini, di aver la cattedra per Jus acquisito ed a tempo indeterminato, senza soggezione di conferma.
Era allora Arcidiacono, Cancelliere Maggiore dello Studio Mons. Antonio Felice Marsigli, che, mosso dal desiderio di veder rifiorire il nostro Studio, diede alle stampe alcune « Memorie per riparare i pregia dizii dell’Università dello Stadio », che ora per intero riprodurremo, perchè costituiscono uno dei più importanti documenti della storia del nostro Studio, perchè degnissime di considerazione per la prudenza e la saggezza dei partiti proposti, necessarie a conoscersi da chi voglia intenderelo svolgimento dei fatti che diedero origine alla fondazione dell’ Istituto.
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSH.I
M E M O R I EPER RIPARARE 1 PREGIUDIZI DELI,’ UNIVERSITÀ DELLO
STUDIO DI BOLOGNA, E RIDURLO AD UNA FACILE
E PERFETTA RIFORMA 1
(Stampato in Bologna M D C L X X X IX . P e r g l i Eredi di A n ton i P isa rri.Con licenza de S uperiori).
Le mine di questa Università, che non solamente ha distinto la Città di Bologna da ogni altra, che componga l’Ecclesiastico Dominio, ma, che senza le prerogative, o di Dominante, o di Capo di Provincia, l'ha posta fra le più riguardevoli dell’Italia e dell’Europa, sono giunte ad un segno, che bisogna o senz’al- cuna dimora applicarvi i rimedi, o disporsi a vedere in ora per sempre l’ intera caduta.
Io non mi studierò nè con esagerazioni, nè con forza di motivi, a persuadere questa necessità cognita e deplorata sì vivamente, che siccome efigge l ’ universale dolore, così obbliga ciascheduno a contribuirvi per quanto possa le propria applicazioni, non che me, che a ragione del carico debbo essere precisamente tenuto. Entrerò dunque prontamente nella materia,
1 1/ esemplare della Biblioteca dell'A rchiginnasio di questa Stampa (estremamente rara) porta a questo punto la nota manoscritta : « Credesi « opera di Mons. M ors ig li Arcidiacono di Bologna, m orto Vescovo di « Perugia il 15 Luglio 1710 ».
Nella Biblioteca delV Università esiste una copia manoscritta nel Codice 086 al N. 48, che porta l’ annotazione : « Copia manoscritta di una « scrittura stampata — et si dice di Mons. Arcidiacono M ars ilj — , et ha « dato causa alla lite presente et alla totale ruina del Studio, invece di « riform arlo , come pretese » .
Nel Manoscritto 12."> della Biblioteca Universitaria, al N. 25, (A. 1725) sotto il titolo : « Annotazioni sopra una scrittura concernente il regolamento del pubblico S tu d io », ricapitata in mano del Sign. Cardinale Giorgio Spinola, si legge :
«.... affinchè non più vacilli dell’ università nostra, e coneeguente- « mente della città nostra quel poco di reputazione loro rimasta, sono « le riflessioni suddette applicate ai paragrafi d i una scrittura stam- « pata 40 anni or sono, in occasione che lo Studio fu soggetto agli scon-
E. BOKTOLOTTl - LA FONDAZIONE DELL* ISTITUTO ECC. 387
seguendo un Metodo che renda con l’ordine la chiarezza, e che col mezzo dell’uno e dell’altra brevemente istruisca di quanto occorre.
Io prendo a considerare il Corpo dell’Università ripartito in tre principali Membri che lo compongono. Il primo è de’ Dottori ili Collegio, tanto Artisti, quanto Leggisti; il secondo de’ pubblici Lettori; il terzo degli Scolari. In ciascheduno di essi discorrerò a parte de’ mali, e di quei Rimedi, che avrò creduto più propri, pili miti, e di più sollecita applicazione.
Ile ' Dottori (11 Co lleg io .
L’uno e l’altro Collegio, tanto de’ Leggisti quanto degli Artisti, ha due principali incombenze; l’una è di fare un rigoroso esame sopra l’abilità de’ Giovani addottorandi, rendendone l’attestazione all’Arcidiacono, appresso del quale unicamente, per
«c e r t i nei quali è poscia novellamente caduto, forse perchè nulla di « ciò che la scrittura medesima proponeva fu eseguito. 8 i cred’ ella parto « di Mona. M ars ilji, allora Arcidiacono, poi vescovo di Perugia ', e tanto « basta perchè il Senato non v’ attendesse ; cosi perchè è sua massima « di non ammettere proposizione che possa dirsi d i persona particolare, « anche di ordine senatorio, quantunque ottima talora ed utilissima, come « perchè tra quel dotto prelato e il Senato non correva mai troppo buona « armonia ».
Queste concordi annotazioni, il contrasto fra l ’ Arcidiacono Marsigli, che voleva riform are lo Studio, i Collegi che volevano la perpetuazione degli abusi che generarono la sua decadenza ed il Senato che era contrario ad ogni innovazione, la perfetta rispondenza fra le idee esposte in questa scrittura e quelle che informano il « Parallelo » scritto da Luigi Ferdinando Marsigli, che più oltre pubblicheremo, fanno ritenere, meglio che probabile sicura, la attribuzione a ll’Arcidiacono Marsigli della presente memoria. Ciò a parziale rettifica della affermazione del Costa, il quale, avendo trovato un esemplare di questa Memoria nell’Archivio di Stato fra le carte dell’Assuntela , dalla frase: « Che a cagione del carico debbo essere precisamente ten u to », che si legge nelle prime linee della memoria, credette dovesse attribuirsi ad uno dei quattro assunti (Francesco Ghisilieri senatore, Gregorio Casale cavaliere, Bonaventura Boselli nobile, Paolo Salaroli mercante) che furono in carica nel 1689. Ma appunto quella frase indica ¡ ’Arcidiacono, Cancelliere maggiore dello Studio, che presiedeva alla più alta mansione: il conferimento delle lauree.
388 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Concessione Pontificale ed Imperiale risiede la Facoltà di addottorare; l ’ altra di sopraintendere al maneggio, ed all’ esigenza della Gabella Grossa, che è il Fondo destinato da lunghissimo tempo per lo stipendio de’ Lettori, e per ogni altra occorrenza dello Studio.
In ciò che riguarda alla prima incombenza, non pochi sono gli abusi, perchè in ora trascurandosi, o con troppa facilità dispensandosi l’uso delle rigorose Costituzioni, si ammettono al Dottorato i Giovani coll’ommissioni particolarmente delle due importantissime condizioni, che siano preceduti cinque anni di Studio in quei gradi in cui si addottorano, e che si sia tenuta la pubblica Conclusione sulle Scuole, che era il Cimento ed il Saggio del Candidato; oltre il facilitarsi molte altre rilevanti particolarità.
Da questa maniera di addottorare ne segue, che in un’abbondanza eccessiva di Dottori, che abbiamo, ci manchino i buoni Lettori, e che in Legge particolarmente, ove consisteva la fama maggiore del nostro Studio, si scarseggi infìno degli Avvocati, servendoci in gran parte di Forestieri, come si vede, si difficuiti a provvedere le Giudicature de’ Magistrati, e a somministrare i Soggetti per le poche Cariche di Roma a noi spettanti; che i Collegi stessi, che sono l’anima dello Studio, per la qualità im portante delle loro incombenze, non si possono riempire che di quei Soggetti che in ora si trovano; che vale il dire: con un progresso miserabile di male in peggio, si disponga la Città, morti che siano quei pochi Vecchi che sostentano l’autico decoro, a rimanere priva affatto di quel credito, che ancora le avanza.
Per rimediare a questo sì grave pregiudizio, che è la prima sorgente di tutti gli altri, sarebbe necessario, che il zelo dei Signori Dottori di Collegio si contentasse recedere dal facilita- mento delle dispense, provvedendo che non si dispensasse di volta in volta, come ora si pratica, senza alcuna necessità o giusta causa chi si sia, dalle Costituzioni giurate, spettanti particolarmente al tempo richiesto negli Studi, e al sostenimento delle pubbliche Conclusioni. Piuttosto meglio sarebbe moderarle in ordine al quinquennio, quando paresse troppo rigoroso, ed in
E. BORTOLOTTI LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 389ogni altra particolarità, che sembri inadattata ai tempi presenti, per poi osservarne inviolabilmente, rimanendo però sempre fermo l’obbligo delle pubblichi' Conclusioni, o di altro equi valente Saggio, che seco necessariamente porti il rimettere l’uso tanto importante de’ Circoli e delle Conferenze, in ora affatto perduto con sì grave pregiudizio, troppo essendo chiaro che la coltura e la buona disciplina della Gioventù, non si può conseguire che con due importanti mezzi: del tempo, e dell’esercizio.
Penserei inoltre, che, per meglio cautelare la condizione del tempo dovuto negli Studi, si aggiungesse una nuova Costituzione, che ogni Scolaro studente in Bologna, e che qui voglia addottorarsi, debba esibire le Fedi giurate del suo Maestro, di avere studiato per quegli anni che ordinassero le Costituzioni, e che debba farlo d’anno in anno per isfuggir la fraude, nel produrlo solamente alla fine del tempo nel quale non è sì facile a riscontrare la verità. E che queste si dovessero registrare dal Xotaro dell’Arcidiacono in un libro a ciò destinato, o da altri conforme meglio si pensasse. Ciò servirebbe non tanto per regolare i Dottorati, quanto per norma ai Signori del Reggimento nella distribuzione particolarmente degli Aumenti ai Lettori, come più a basso si dirà.
In ordine al maneggio della Gabella Grossa, che è l’altra principale incombenzza dei Dottori di Collegio, è necessaria una piccola digressione per ben introdurci alle difficoltà correnti. Già nei tempi antichissimi gli Stipendi dei Lettori si ricavavano dal pubblico Tesoro della Cassa del Comune, ma perchè, o per i Moti di Guerra o per gli altri accidenti, non venivano puntualmente somministrati, Eugenio IV, con sua Bolla nel 1437, determina per loro Salario e per Dote dello Studio, la rendita della Gabella Grossa, e per maggior cautela aggiunge, che in caso che questa Gabella non bastasse, rimanga assegnato ancora il Dazio del Sale.
Paolo II, con Bolla emanata nel 1465, amplia la concessione, e dispone, che in mancanza della Gabella■ Grossa■ debbono soccombere lutti i Dazi della Città al mantenimento dello Studio, ben comprendendo quei Savi Pontefici, che nulla dovevasi ri
390 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
sparmiare per conservare ciò, che era l’importanza maggiore, la sussistenza, l’utile, e il decoro della Città.
Giulio II poi, con altra sua Bolla nel 1509, per meglio assicurare che i Lettori fossero pagati, leva il maneggio della Gabella Grossa al Pubblico e ordinario Tesoriero, e deputa una Congregazione di Dottori di Collegio, dando loro facoltà di sopraintendere all’ esigenza di essa, e di maneggiarla a loro beneplacito. Concessione, che susseguentemente si conferma da Leon X, da Clemente V II; e dal B. Pio V con ampliazioni ancora maggiori.
Sotto Clemente VII, succedette l’inconveniente, che si erano distribuiti salari sopra le rendite della Gabella a segno, che molti Lettori restavano indietro dei loro pagamenti, onde per ovviare in avvenire a simile abuso, ordina questo Pontefice, nella stessa Bolla che conferma ai Dottori il maneggio della Gabella pubblicata del 1523, che si determini un assegnamento, e si limiti l’impiego del denaro fino alla somma di ventiseimila con alcune Condizioni, e riserve, conforme appare dalla Bolla medesima. Provisione che nei precisi termini, fu rinnovata dal B. Pio V in altra sua Bolla particolare nel 1568.
Così salutevole ordinazione si pose a poco a poco in disuso, a segno che nel Pontificato di Clemente V i l i s’incorse nello sconcerto di prima, impiegandosi il denaro degli stipendi dei Lettori pili del gettito della Gabella ; per lo che s’indusse il Pontefice, con suo Breve, a variare il maneggio di essa, aggiungendo ai Dottori un’Assunteria di Senatori, su il motivo principalmente che, spettando al Reggimento la distribuzione del denaro, pareva conveniente che il medesimo, per mezzo dei suoi Assunti, avesse notizia della rendita di essa Gabella, a fine di che ordina ancora un annuo Bilancio.
Ma nonostante la cautela di questa aggiunta di Senatori, si è nuovamente ricaduto nell’inconveniente di prima, essendosi dati stipendi tanto eccedenti l’entrare della Gabella, che è convenuto fermare il moto allo Studio, e vedere impossibilitata la distribuzione di nuove Letture, e di nuovi aumenti. E sono ormai quindici anni, che si sta in questo miserabile posto, con tutti quei (pari pregiudizi che purtroppo proriamo.
E. BORTOI.OTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 391
Il rimedio di questi nuovi replicati inconvenienti non devesi cavare altrove, che dal rimettere puramente in osservanza la (istituzione di Clemente V II rinnovata dal B. Pio V e fermare ut\ assegnamento di denaro per l’impiego dello Studio se non su la stessa quantità, almeno pigliando le misure sicure sottoil gettito della Gabella. Così assicureremo che più non si facciano eccessi di Spese, daremo comodo ad avanzi in estinzione •li <lebiti, e a cumuli per l’occorrenze, come di condurre Emi nenti o per altro; e così forse si potrebbe ancora determinare un Fondo fisso al Monte dell’Annona, senza più bisognargli il supplemento della Gabella Grossa, da clic è provenuto una gran parte dei presenti sconcerti. Io crederei, che si potesse con tutta sicurezza determinare per lo studio un impiego di lire trentacinque mila sul seguente scandaglio:
L ’entrata della Gabella Grossa, quindici anni sono, conside- ravasi più di lire 60 mila. Si è poi questa andata diminuendo per la diminuzione del Traffico, per l’abu.so dei Contrabbandi, e per altri inconvenienti. L’affitto ordinario però è stato fra leIO e 50 mila lire. Anzi si sa di sicuro, che nell’anno pausato 1688, in cui l’affitto correva, come anche corre, sopra lire mila, perchè dato nei tempi dell’eccessivo scandalo dei Contrabbandi, si sono ricavate più di lire 60 mila, chiarendolo ad evidenza il gettito del Monte dell’Annona non appaltato, che ha una regolata proporzione alla Gabella Grossa, così confermandosi che, non la diminuzione del Traffico, ma l’abuso impunito dei Contrabbandi cagionava sì rilevante diminuzione. Onde su questa ispezione crederei, che fosse molto moderato il fermare l’impiego di lire 35 mila e che ci accostassimo ancora all’intenzione dell’antica ordinanza di Clemente V II considerata la variazione della moneta dai tempi di allora ai nostri correnti. Ma perchè la pratica ci ha fatto conoscere quanto sia facile la trasgressione di sì fruttuosa osservanza, sarà necessario, per meglio stabilirla, ricorrere all’aiuto di un altro ripiego, del quale parlerò qui a basso, trattando dell ’eccesso del numero dei Lettori, e passando al secondo Membro componente il Corpo dell’Università, che è de’ Lettori dello Studio.
392 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
l»e ’ Letto ri «lello Studio .
Questo è quel Corpo in cui si sono introdotti disordini grandi, i maggiori dei quali a due si riducono. All’ eccesso lei numero sopra il bisogno, ed al mal servizio, che rende la maggior parte dei Lettori. Nel 1677, che è il tempo, in cui si fermò interamente il moto allo Studio, si contavano quasi centocinquanta Lettori tra Ordinari e Straordinari, conforme consta dai Rotoli di allora 1. Sì eccessivo numero, che ancor oggi in gran parte dura, nulla affaticando, ritiene come in pensione lo stipendio della Lettura, e pretende di soddisfare all’obbligo colla semplice apparenza di presentarsi allo Studio per un momento di tempo, lasciando tutto il peso del servizio pubblico a poco più di dodici Lettori, che mossi da buon zelo, e da vero conoscimento del debito di coscienza, e del pubblico onore, insegnano a quei pochi Scolari, che ora si trovano, che in quest’anno, è pure vero, sono appena sessanta Matricolati fra Leggisti ed Artisti, cioè a dire in numero assai minore a quello dei Lettori, che nonostante la mancanza di tanti dopo il moto fermato allo Studio, oltrepassano ancora i novanta.
Per levare l’abuso dell’eccesso del numero, basta semplicemente riprendere l’antica ordinazione fatta da Nicola V, quale con sua Bolla dell’anno 1150 per rimediare ad uno sconcerto simile al presente, prefigge il numero certo di quarantasei Lettori tra Ordinari e Straordinari ripartito nelle sue Rubriche, proibendo in avvenire l’accrescimento di essi.
Riposta in osservanza sì necessaria Costituzione non solamente si rimedia all’inconveniente dell’eccesso del numero dei Lettori, ma si assicura la limitazione del Fondo, per il mantenimento di essi, non potendo in modo alcuno sussistere l’uno senza l’altro regolamento, che è quello che sopra si era accennato.
Io non intendo però, che si debba restringere al numero preciso di Nicola V, ancora che sia abbondantissimo, e sulla pratica di tutte le altre più famose Università di Europa, e che
1 I Rotuli dell’anno 1676-77 segnano 161 lettori, 81 leggisti, 80 artisti.
E. B0RT0L0TTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 393
era sufficiente in quei tempi nei quali si insegnava in Bologna a tante migliaia di Scolari, nè meno al preciso impiego di lire trentacinque mila, bastando accordare la massima dell’uno, e dell’ altra limitazione, nel rimanente con un più esatto scandaglio delle rendite della Gabella, e su l’ispezione delle Rubriche delle Letture bisognevoli si potrà meglio ridurre alla praticail pensiero.
Rimediato all’abuso dell’eccesso del numero dei Lettori, limane da pensare all’altro, che riguarda il mal servizio, che in ora da questi si vende, per obbligarli nell’avvenire a soddisfare al debito della carica nel leggere pubblicamente e nell’inse- gnare alla Scolaresca.
Sinora è corsa un’opinione di pretendere i Lettori Cittadini, che tanto le prime letture, quanto gli Aumenti siano innamo- vibili di loro natura, da che n’è seguito, che avendo essi ottenuto
la Lettura, e un competente Alimento, più non temendo il castigo della Remozione, hanno interamente trascurato il servizio.
Già Nicola V, nel regolamento che diede alla nostra Università con sua Bolla emanata nel 1448 ordinò, che tutti i Lettori si dovessero confermare d’anno in anno, molto ben prevedendo, che senza il timore del castigo, che è la Regola ordinaria e più sicura delle operazioni degli Uomini, non potevasi mantenere lo Studio. Ma ciò a nulla ha servito, perchè mettendosi affatto in disuso sì necessaria osservanza, i Signori del Reggimento praticano la semplice formalità di porre in conferma con un solo partito tutto il Corpo dei Lettori al principio degli Studi.
Sarà dunque necessario osservare la Costituzione di Nicola V, e con tutto rigore praticare la Regola della Conferma, che, per accomodarla all’ uso delle altre Università di Europa, potrà farsi di tre anni in tre anni, avvertendo di porre a partito
ciascheduno Lettore, e non tutto il Corpo assieme.Io propongo piuttosto la conferma di triennio in triennio, che
d’anno in anno, stimandola di più frutto. Così in un triennio meglio si ferma il giudizio delle operazioni del Lettore, e così, variando i tempi delle Collezioni delle Letture, ne segue che con minor tedio d’anno in anno si possa porre il partito di quelli,
394 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
nei quali al principio degli Studi spira il triennio, che non saranno che pochi, e per ragione del ripartimento, e per la restrizione del numero. Se questa Regola si praticherà con puntuale Osservanza, vedremo in un momento rimesso lo Studio e servitoil pubblico con tutta esattezza.
Altri minori sconcerti vi restano da levare per introdurre una perfetta Riforma tra Lettori nell’ordine di leggere, d’insegnare, ed in altro. Ma in ciò basterà prendere le Costituzioni che ultimamente si fecero nel 1641 ; nelle quali alcune poche cose si devono aggiungere, ed alcune variare, essendo nel rimanente concepite con somma avvertenza, e molto bene adattate all’uso dei nostri tempi.
Proposti i rimedi per riparare ai principali disordini dello Studio, resterà in ultimo luogo la massima difficoltà, che consiste nel venire all’esecuzione dei progetti, col Fondo di Gabella quasi tutto impiegato, e con un numero ancora■ eccessivo di Lettori, ed in gran parte di niun servizio.
Grande veramente è la difficoltà per eseguire la Riforma sollecitamente, conforme richiede il bisogno, e senza strepito di lamenti. Nondimeno spererei di proporre pensiero tale, che agevolasse l’effettuazione, o almeno dasse eccitamento a qualche altro migliore.
Io non propongo che si venga al sommo rigore, o di levare, o di dimezzare gli stipendi a chi non ha servito, nè serve. Pro- porronne uno più mite, ove la tolleranza del Principe abbia da spiccare senza battere la parte del rigore. Si distinguono i Lettori in due Classi : In quei pochi che rendono il servizio, e in quei molti che l'hanno trascurato, e lo trascurano. Con questi ultimi si pratichi una generosa compassione, e considerandone molti che hanno l’unico assegnamento di vivere, e molti il comodo di ben vivere su le Letture, se gli accordi di godere gli stipendi presenti fino alla sepoltura, lasciando loro, come in Patrimonio, l'abuso dei tempi nei quali sono vissuti. Ed altro danno non risentano, che di essere inabilitati per sempre ai nuovi Aumenti, rimettendo alla loro Coscienza il debito di servire nell’avvenire.
Segregata questa Classe dei Lettori che non servono, tutta la speranza del mantenimento dello Studio si riduce all'altra
E. BORTOI.OTTI • LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 395
Classe di quei pochi che servono, che come sopra dicemmo, non eccedono di molto il numero di dodici. Fermato questo Capitale, che unicamente ci avanza, si volge tutto il pensiero ad accrescerlo con nuovi Soggetti, ed a procurare la coltura di nuovi Allievi nella seguente maniera :
Cosa certa è, che le rendite presenti della Gabella ora sopravanzano di qualche somma le spese non solamente dello studio, ma di qualsivoglia natura, avendo già il tempo fatta quasi la necessaria operazione. 11 sopravanzo è tale, che non è lontano a somministrare il comodo di lire cinque mila, che bastano per Fesecuzione del mio pensiero. E dato ancora che in ora non fosse nella Gabella questo preciso avanzo, dobbiamo però pensare al modo di ritrovarlo, perchè nella maniera che io propongo di regolare gli Stipendi nell’avvenire, poco più di un Novennio darà comodo abbondantissimo di rimborsare ogni prestito, o di soddisfare ad ogni debito che si potesse esser fatto. Quando i casi sono gravi ed estremi, bisogna sorpassare ogni difficoltà, nè caso più grave, nè più estremo, può mai avere il nostro Pubblico, che quello di riparare con prontezza e vigore al precipizio dello Studio, che più non può soffrire dimora nella riparazione. Ed in ora appunto dobbiamo raccordarci di quanto disposero i sopra riferiti Pontefici Eugenio IV e Paolo II, col sottoporre ai bisogni dello Studio tutte le rendite della Città, per non angustiarci in qualche piccolo intoppo, che presentemente si riscontrasse. Nello stesso tempo due passi si debbono fare. Provvedere di nuovi Lettori, ma altresì premiare quei pochi Vecchi, che per quattordici anni continui vi hanno servito senza mai ricevere alcun Aumento, e che con zelo tanto esemplare hanno portato sulle spalle Finterò peso della fatica, e sostenuto quel poco di avanzo di credito, sul quale vive ancora il nostro Studio.
Il dare solamente nuove letture senza questi pochi Aumenti, sarebbe un minare totalmente lo Studio, oltre il commettere un atto di somma ingiustizzia. Poscia che, irritati i Vecchi Lettori nel vedere che si dispensasse denaro pubblico senza che per loro precedesse qualche premio, forse desisterebbero dall’affaticare, ed abbandonerebbero le Scuole a i pochi nuovi giovani, che vale il dire inesperti, senza credito, e col solo capitale delle speranze.
396 MEMORIE INTORNO A !.. F. MARSIL.I
Conforme si è detto, questi lettori benemeriti eccedono di pocoil numero di dodici. Ad essi, almeno per caparra dell’avvenire, si potrebbe dare un piccolo Aumento di lire duecento per ciascheduno, e in tal guisa con poco più di lire due mila e quattro- cento si faccia il nuovo riempimento. A dar meno del primo solito stipendio nello stato presente, in cui si propone d’imporreil castigo nel caso di mal servizio, s’ incorrerebbe nell’ altro estremo, e non contrapporremmo il premio con proporzione alla pena, ed ogni inferiore stipendio non anima abbastanza i soggetti al travaglio.
Nella scelta dei nuovi Lettori non piccola sarà la difficoltà, perchè, trovandoci con un numero eccessivo di Dottori tutti aspiranti alle Letture, ma in gran parte della qualità che abbiam detto, e con poco, o gnuno esercizio, quando non segua la scelta con somma avvertenza, daremo nello sconcerto di prima, e porremo sullo Studio persone inabili, e senza speranza di uscita.
Nè deve a ciò ostare l’ opinione corsa finora che l’ essere Cittadino porti un ius aquisito alla Lettura, e l’ anzianità del Dottorato la prelazione per essa. Simile opinione è tanto insussistente, quanto perniziosa. Non sussiste per Bolla, o per Costituzione che vi sia. Non deve sussistere per riguardo dell’uso troppo screditato dal successo, e dalla pratica da cui è nata gran parte dei presenti sconcerti. La ragione totalmente la contraddice, poscia che, fatta legge quest’uso, ne segue che per conseguire la lettura basti addottorarsi in qualsivoglia modo, indi lasciar correre il beneficio del tempo con sicurezza di ricevere dall’età un premio, che non deve attendersi che dalla fatica, e dal merito.
L ’abilità, che in ciò dev’essere l’unico requisito, non si piglia nè col nascere Cittadino, nè coll’esser nato e addottorato prima di un altro, ma coll’aver fornito dalla natura il talento, e conseguito dallo Studio la coltura di esso.
Devesi inoltre riflettere ad un altro importantissimo punto, qual’è il non essersi fatti per quindici anni nuovi Lettori; ne segue che i più anziani nei Dottorati in ora si trovino vicini all’età di quarantanni, cioè a dire non solamente senza l’eser-
E. BOKTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 397
tizio necessario per la Cattedra, ma incapaci di più riprenderlo, onde bisogna scegliere tra questi quei soli pochi di conosciuto credito; per altro, riuscendo più sicuro il porre in opera l’ultima Gioventù, studiosa però, e di buona aspettazione, fondando sopra di essa quella speranza, che disperata si rende nei Dottori di età avanzata.
Nell’ avvenire non sarà poi grande la difficoltà, perchè una gran parte dei vecchi Dottori esclusi si aqueteranno, e penseranno ad altra maniera di vivere fuori delle Letture, ed i nuovi Dottori, quando si pratichi il proposto rigore di addottorare, saranno molto minori di numero, o di qualità migliore e più sicura da porre in opera. Conforme il concorso delle Letture non sarà più con tanta folla, quando ciascheduno conosca di dovere veramente affaticare, e rendere il tanto laborioso servizio di insegnare alla Gioventù. Moltissimi affacciandosi alle letture, su la speranzza di ricavare, col mezzo delle Clientele e delle amicizie, la perpetuità dei buoni stipendi, senza volontà di servire, ed ancora col conoscimento dell’inabilità a poterlo fare.
Dovrebbonsi ancora dispensare in ora le. Letture straordinarie che si potrebbero ridurre ad otto, cioè a quattro con solito stipendio di lire cento, ed a quattro senza stipendio, la metà Ar- tiste, e la metà Leggiste; disponendo che le straordinarie senza stipendio fossero il primo gradino per ascendere, dopo uno o due anni, alle straordinarie con stipendio, indi alle ordinarie; e la spesa di queste non eccederebbe le lire 400, che vale il dire non sarebbe con rilevante alterazione del proprio impiego di denaro.
Fu questa sorte di Letture istituita fino da tempi antichissimi, a ciò che servisse come di prova della prima Gioventù, dalla quale poi con sicurezza si promovessero i Lettori Ordinari, ed i Maestri migliori. Si possono dispensare con tutta facilità, ed occorrendo moltiplicare ancora particolarmente le non stipendiate, sebbene il numero proposto sembra sufficiente. Basta solamente invigilare alla riuscita che fanno i Giovani, per regolao di promoverli alle Letture Ordinarie, o di licenziarli spiratoil tempo. Ed è questa la nostra antica maniera di sementare gli Uomini, per così dire, che tanto fruttuosamente si praticava,
398 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
senza moltiplicare a questo fine un numero eccessivo di Lettori Ordinari.
Per levare poi ogni occasione ai vecchi Lettori, che non servono, di dolersi per essere dichiarati incapaci di Aumenti nell’avvenire, si lasci in ora libertà a chi si sia di presentarli, e di esibirsi a riprendere l ’attuale, vero, e reai servizio, leggendo, e nelle Scuole ed in Casa, conforme esige il bisogno degli Scolari. Se questi tali per un corso ragionevole di tempo, come di un triennio, soddisferanno all’obbligo loro, attualmente servendo, siano non solamente esentati dall’inabilitazione dell’Aumento, ma graziati dell’Aumento medesimo, e posti fra i componenti in numero vivo dei Lettori prefissi. Ed in caso di non aver servito, si ripongano nella Classe degli inabilitati agli Aumenti, non potendo alcuni in simil forma dolersi, che di se medesimo.
Soddisfatto con questo ripiego in qualche parte alla grati tudine verso i Vecchi, che hanno ben servito, e dato animo ai Giovani nella nuova aggregazione, coll’impiego iu tutto di lire cinquemila incirca, si pazienti un triennio ad impiegare altro denaro, lasciando correre il benefizio del tempo, nella mancanza dei Lettori, quale ordinariamente suol succedere nei più Vecchi, e di stipendi migliori.
Spirato il primo triennio, si distribuisca l’avanzo del denaro, vacato dentro esso, in nuovi Lettori ed in nuovi Aumenti, e lo stesso si faccia a capo del secondo, e del terzo Triennio; così compito un Novennio incirca, si vedrà senza difficoltà e senza strepito terminato il regolamento.
Il successo è infallibile, perchè troppo è chiaro, che se del 1677 i Quarteroni o siano i Salari importavano precisamente lire 63391, ed ora non importano, che lire 36674 ; che l’avanzo di dodici anni non ancora finiti, è stato di lire 26717 ; onde con questa proporzione ne segue che un Novennio ci darà vicino lire 20000 di avanzo, al quale sopraponendo lire 5000, che iu ora distribuiamo, e lire 8000, incirca, che importa il vecchio stipendio dei Lettori che servono, conforme ho io calcolato, ci ridurremo insensibilmente ad un nuovo impiego di lire 33000, cioè di poco discosto dalla proposta somma. Un Novennio poi somministra tempo bastantissimo per dar comodo alla Gioventù di studiare,
E. B0RT0LOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 399
e «li farsi nuovi Allievi per riempire fruttuosamente il numero «lei Lettori che si sarà prefisso.
Progettato il ripiego per dare presentemente il tanto necessario moto allo Studio, il modo poi di eseguirlo colla pratica della conferma, senza alcuna occasione di doglianze, è facilissimo colla seguente avvertenza. In questo nuovo moto si fanno «lue cose: Si dà Aumento ai vecchi Lettori benemeriti, e si danno nuove Letture ai Giovani di buona aspettazione. Da qui avantii vecchi Lettori avranno due sorti di stipendio. Il primo sarà l ’antico, cioè quello che avevano avanti la riforma ; il secondo sarà il nuovo, che conseguiranno in questo primo Aumento e in altri dopo essa riforma. Lo stipendio antico rimanga nella supposta natura «l’innamovibile, e si accordi ai vecchi Lettori serventi, come in ius acquisito di perpetuità in questa parte, conforme si sarà accordato alla Classe dei Lettori non serventi. Gli Aumenti nuovi, come che dati con la legge nuova, siano soggetti alla conferma in capo d’ogni Triennio, acciocché se qualcheduno di essi Lettori desistesse per malizia di servire al Pubblico, debba essere castigato con levargli tutto il nuovo Aumento. Ne’ nuovi Lettori tanto la prima Lettura, quanto i susseguenti Aumenti siano sottoposti alla Conferma del triennio, e possano essere privi affatto e dell’ utile, e del decoro delle Letture, e levati dal Rotolo dello Studio, quando maliziosamente trascurino il servizio.
Nè deve ostare la difficoltà, che la passione di qualcheduno «lei Corpo del Reggimento potesse cagionare l’esclusione di qualche Lettore con poca giustizia, sì perchè non è sì fàcilmente da supporsi in un Congresso tanto numeroso e tanto qualificato, sì perchè l’esperienza mostra nel medesimo Reggimento, e negli altri «lue maggiori Corpi della Città, cioè nella Congregazione della Gabella e del Monte di Pietà, ove ogni anno si pongono al partito tutti i Ministri, che niuno mai si disfaccia, quando non vi sia un pubblico e ben giustificato demerito, sì perchè, «lato ancora che fosse possibile qualche sconcerto, deve a questo preponderare il tanto maggiore ed il tanto più facile da succedere, dell’abuso del mal servizio dei Lettori, considerando per
400 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
buon ripiego non quello, che leva tutti i pregiudizi, che ordinariamente non si trova, ma bensì quello, che impedisce i maggiori.
Oltre che i Signori del Reggimento potranno da qui avanti servirsi di una regola infallibile per conoscere chi veramente serve, e non serve, che sarà di far esibire nell’ Assonteria di Studio d’anno in anno, la nota delle fedi degli scolari Studenti, che avrà presso di sè, o il Notaro dell’Areidiacono, o chi sarà a ciò deputato, dalle quali rileverà la certa cognizione dei Dottori che servono, e che non servono, e di quelli, che hanno più credito e più concorso, per praticare con norma sicura la giustizia del premio e del castigo.
Del rimanente, il pensare in oggi di aggiungere nuovi Lettori senza pensare nello stesso tempo alla maniera di farli ben servire, è lo stesso che incontrare l’ultima ruina dello Studio, perchè, come si è addimostrato, il male non nasce dalla mancanza dei Lettori, essendone in eccesso, ma dalla qualità di essi, e dal mal servizio, che rendono, e l’accrescere il numero senza il necessario provvedimento, è lo stesso, che canonizzare gli abusi passati iu aumento dei futuri, e rendere disperato per sempre il buon servizio, cioè a dire il risorgimento dello Studio, il di cui deplorabile Stato non ha bisogno di lenitivi, ma dei più risoluti rimedi.
Questi sono i mali maggiori dei due primi Membri componenti il Corpo dell’Università dello Studio, che in ristretto, come abbiamo veduto, a quattro principalmente si riducono. All’abuso nell’ addottare. AH ' impiego non regolato del denaro della Gabella. All'eccesso del numero dei Lettori. Al mal servizio, che questi rendono. Si rimedia al primo colla pura osservanza delle Costituzioni eseguita colle proposte cautele. Si rimedia al secondo eseguendo le Ordinazioni di Clemente V II e del B. Pio V, col formare un fisso assegnamento del denaro della Gabella in quella somma, che in ora si stimerà bene. Al terzo, rimettendo in uso la disposizione di Nicola V che prefigge il numero dei Lettori. Al quarto praticando l’altra disposizione del medesimo Pontefice, che comanda sì rigorosamente la Conferma dei Lettori d’anno in anno, ma che meglio potrebbe ridurre al Triennio.
Dal che chiaramente rileva, che tutti i pregiudizi presenti dello Studio non da altri procedono, che dalFaver posto in di-
E. B0RT0LOTTI LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 401
suso le nostre antiche savissime provisioni, e che per rimetterlo, non dobbiamo che puramente riprendere le medesime, senz’ai cuna immaginabile novità. Resta in ora di trattare brevemente del terzo Membro, che, come a principio dicemmo, si forma dagli Scolari tanto Artisti, quanto Leggisti.
Degli Scolari.
Questo Membro ha bisogno di poca riforma, solamente essendone bisognevole in due particolarità, facili tutte da rimediare, che sono in ordine alla Costituzionne, e in ordine ai Privilegi.
Gli Scolari, tanto Artisti quanto Leggisti, hanno separata- mente le loro differenti Costituzioni da essi fatte per Ius, che in ciò portano, conforme ancora di darvi l'esecuzione. Sono queste concepite, e fra Leggisti particolarmente, con molte particolarità antiche, inadatte ai tempi presenti, onde sarebbe necessario accomodarle. Al che volentieri acconsentirebbero gli Scolari, bastando solamente dar loro assistenza e mano perchè poi fossero dai Signori Superiori confermate, e ricevessero il necessario vigore.
I Privilegi che godono per moltissime Concessioni di Pontefici e d’imperatori, sono così ampli, che maggiori non possono desiderarsi. Sarebbe solamente necessario, che N. S. insinuasse ben premurosamente ai Signori Cardinali Legati, che in tutto ciò che non pregiudica notabilmente alla quiete del governo, abbondassero per l’esecuzione, e praticassero ogni sorta di cortesia e di distinzione tanto al Corpo, quanto a ciascheduno di essi Scolari, col mantenere le prerogative onorifiche, e facoltative, in quella guisa che studiosamente praticano tutti gli altri Principi, e die si è sempre ancora qui praticato per lo passato, considerando questo Membro per quello che compone veramente lo Studio, e che porta fuori il nome del benigno accoglimento che ricevono in una Patria, stata sempre Maestra e Madre della Gioventù.
Nè in ora deve sminuirsi in noi la considerazione per la piccolezza, e per la qualità del numero, ma devesi considerare in
28
402 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
esso, tal qual ora siasi, il nostro interesse e la nostra intenzione di vederlo accresciuto, e qualificato. 11 contenuto di questi Privilegi è espresso nelle loro Matricole, ed in varie loro particolarità.
Soggiungerò solamente, che per rimettere l'affluenza degli Scolari, vi sarebbe un rimedio facilissimo, e in mano tutto di N. S., su l’esempio puramente degli altri Principi. Hanno questi procurato di minare gli Studi dello Stato Ecclesiastico, e particolarmente di Bologna, non solamente coll’aprirne altri nei loro Paesi, ma col proibire ai Sudditi sotto pena d’inabilitazione ad ogni Carica, e sotto altre rigorosissime, lo studiare, ed il prendere altrove la laurea Dottorale. Ora dovrebbe N. S. rimettere le proprie Università con quegli stessi mezzi, che hanno tenuto i Principi per minarle, ordinando, che niuno tanto dello Stato, quanto Forestiero, potesse avere Cariche nello Stato, e particolarmente in Roma, quando non avesse studiato nell’Università del dominio Ecclesiastico, ed inoltre aggiungendo una Condizione vantaggiosa alla due Città primarie, col distinguere che i sudditi potessero studiare in quelle Università dello Stato, che volessero, e i Forestieri dovessero farlo determinatamente in Roma, o in Bologna. Così in un momento si vedrebbe tutta l’Italia, e gran parte dell’Europa correre a queste due Città, essendo la Corte del nostro Principe, e lo Stato suo troppo necessario alla Fortuna di qualsivoglia Nazione.
E questo è quello, che mi è sovvenuto di accennare su l’ur- genze così grandi del nostro studio.
Quanto io espongo può mettersi a momenti in esecuzione, tutto essendo in nostra mano con somma facilità, e senza novità alcuna, conforme sopra si è mostrato, e che io principalmente mi sono proposto, pretendendo non di dare il Disegno di nuova Fabbrica, ma solamente il modo di sostenere l’antica ruinosa e cadente, sulla stessa pianta, sulla stessa misura, e su l'aspetto di prima. Se in ora ci applicheremo all’Opera, nonostante ancora tanti altri esterni pregiudizi, che non sono sì facilmente riparabili da noi, vedremo immediatamente rimessa l’Università di Bologna di credito e di frequenza. Vive ancora l’antica gloria negli avanzi di valenti Uomini che pure abbiamo. Non è ancora
E. B0RT0L0TTI - LA FONDAZIONE DELL* ISTITUTO ECC. 403
estinto il buon genio, e la buona indole per continuare la successione di essi. E troppo inoltre è adattato il sito, e la costituzione del Paese al comodo di studiare per ragionevolmente sperare un buon esito al nostro intento.
** *
Le savie proposte contenute in queste « Memorie » furono in parte accettate da alcuni senatori e dalla Assunteria, ma, fieramente avversate dai Colleghi, generarono una lite che si trascinò dinanzi la Curia Romana fino verso il 1(594.
Il Pontefice Alessandro V i l i ne avocò a sè la risoluzione ili merito, e fece intendere la sua mala disposizione verso la Assunteria degli Studi ed il Reggimento per la cattiva amministrazione della Gabella, gravemente danneggiata da contrabbandi e da frodi imputabili agli stessi membri del Senato, e per le insufficienti condotte dei Lettori; perciò il Senato cercò, come via d'uscita, un accomodamento coi Collegi. Questi infatti si riunirono in « Congregazione di Studio » il 26 Novembre 1694, e deliberarono tre proposizioni, che furono sostanzialmente accolte dal Senato con la « Ordinanza » seguente, approvata addì 27 Novembre, confermata dal Legato addì 2 Dicembre 1694.
** *
Ordinationi e Costiti/turni da osservami in avvenire circa laCollazione delle Letture sul Pubblico Studio.1°) Le Letture da darsi ai Cittadini e Fumanti abilitati e
dottorati « alla Bolognese » noti s’intendano soggette a conferma; e coll’onorario di L. 200, e sia ciò anche per i condotti ad tempii s colle sole L. 100.
2°) Li suddetti Lettori, dopo aver adempiuto a quanto si richiede, siano d’età d’anni 25, e vivano onorevolmente et abbino difeso le pubbliche Conclusioni.
Volendo in avvenire incamminarsi a tale conseguimento, debbano presentare li loro requisiti all’IU.mo Reggimento con
404 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
memoriale iu cui abbiano a specificare la materia, e sia loro lecito lo specificarne sino a due.
Quando vi sia un certo numero di tali supplicazioni, Fili.ino Reggimento, a relazione dei Signori Assunti di Studio, abbia a porli tutti a scrutinio, e secondo la prevalenza dei voti, fra essi scrutinati, si intendano tatti essi abilitati e gradatamente preordinati al conseguimento della Lettura, la quale debbano essi conseguire prelativamente a qualunque altri che dopo di loro
concorreranno in altri simili scrutini.3°) Che venendo il caso di avere a conferire letture e che lo
stato della Gabella si veda atto a darle, l’Ill.mo Reggimento abbia a passare un partito davanti al Superiore di dare tante Letture senza individuare li soggetti, ma solamente le materie, et allora si abbino a porre in Rotolo tanti dei suoi Dottori, che saranno stati come sopra preordinati.
4°) Che le suddette determinazioni o Costituzioni abbiano ad osservarsi invariabilmente in avvenire in tutti li soggetti che di nuovo si addotteranno, tua per questa volta solamente s'intendano ammessi a conseguire la lettura, prelativamente ad ogni altro, tutti li Dottori cittadini e fumanti abilitati ed addottorati tutti alla bolognese come sopra... et i quali abbino a rotolarsi per l'anzianità del loro dottorato.
5°) Le materie....Leggisti: 1. Legge civile; 2. Legge Canonica; Somma
Rolandina.Artisti: 1. Filosofia; 2. Medicina teorica; 3. Lettere
Umane; 4. Teologia; 5. Le Matematiche; 6. L’Hidrometria.6°) Inerendo al Senato-Consulto del 10 Marzo 1578, ri
manga invariabilmente stabilito per l’avvenire che ogni volta
che ci siano dottori cittadini o fumanti come, sopra, non si possa mai chiamare alla Lettura alcun forestiere, parlando sempre delle seconde Letture, e cioè non eminenti.
E, venendo il caso di averne pure a condurre per mancanza di tali cittadini o fumanti, ciò abbia a farsi con partito del- l’Ill.mo Reggimento, ottenuto in numero legittimo di due terzi di voti; et in condizioni da osservarsi da tali forestieri nelle
E. BOKTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 405
dovute parti le Costituzioni delio Stato... massime per aver prova con tal mezzo della loro abilità e sufficenza.
** *
Tutte le più importanti conclusioni delle « Memorie » del- l’Arcidiacono, venivano così misconosciute, e confermati gli abusi che erano stati segnalati come causa prima della decadenza dello Studio. Lo stesso Marsili, caduto in disgrazia, era nel 1701 levato dalla carica di Arcidiacono, e solo alle intercessioni di altri personaggi, promosse dal Generale Marsili, suo fratello, dovette la nomina a Vescovo di Perugia.
II.
Il “ Parallelo di Luigi Ferdinando Ma risialiNonostante la decadenza degli ordinamenti scolastici, il
nostro Studio aveva conservato buona fama, perchè questa non è affidata alla moltitudine dei Lettori inetti e negligenti, ma allo scarso numero di quegli uomini singolari il cui nome segna un’epoca nella storia della Scienza. E, quando lo studio delle Leggi accennava a languire, Bologna eccelleva nelle discipline scientifiche, che lino dal secolo XVI ebbero qui i più illustri cultori.
Alle deficenze dell’insegnamento pubblico, faceva riscontro l’iniziativa dei privati cittadini, che si raccoglievano in Accademie, ove facevano prova dei loro talenti e si esercitavano nel libero esperimento. Notevolissimo fu l’impulso dato dall’ « Ac- endemia degli Inquieti », fondata nel 1690 da Enstai-chio Manfredi, riformata nel 1704 ad opera del Morgagni, dello Stancari, dello stesso Manfredi, e volta ad indirizzo spiccatamente sperimentale dalla nuova costituzione, la quale imputava a colpa il voler sostenere quelle cose che non si possono ricavare dalla diretta osservazione o verificare coll’esperimento, o dimostrare con sicuro raziocinio.
Questa Accademia raggiunse il suo più completo sviluppo
MEMORIE INTORNO A L. I'. MARSILI
quando, coll’entrare nelle case del Marsigli, potè usare per i suoi studii ed i suoi esperimenti della ricca biblioteca e del copioso materiale scientifico raccolto dal Generale Luigi Ferdinando Marsigli.
Il Marsigli, che dal confronto con le università forestiere, da lui visitate, aveva tratto giudizio sulla decadenza della nostra, avrebbe voluto che le esercitazioni della Accademia fossero trasportate nell’Archiginnasio, e quivi formassero oggetto di pubblico insegnamento.
A tale intento propose al Senato bolognese di cedere allo Studio tutte le sue collezioni scientifiche e la sua biblioteca, affinchè si potessero instituiré insegnamenti sperimentali pari a quelli che egli aveva riscontrato nelle maggiori Università forestiere.
Presentò perciò alla Aasunteria dello Studio una sua proposta di riforma, intesa, non solo a migliorare l’ordinamento degli studii nel senso già indicato dall’Arcidiacono, ma anche a modificarne profondamente lo spirito ed i metodi.
Le linee generali di quel progetto, sono anche quelle che poi egli seguì nella Fondazione dell’Istituto, come si potrà vedere dal confronto delle proposte contenute nel « Parallelo » (sino ad ora rimasto inedito) che ora pubblicheremo, con le Consti- tazioni dell’ Istituto.
Parallelo 1 dello stato moderno della Università di Bologna
con l’ altre di Ih de’ Monti
A ll’ III.ina Assunteria di Studio,Uhi sfrissi in i Sign ori,
Prima d’abbandonare la Patria, voglio avere soddisfatto a tutto che mi impone il debito di grato cittadino della medesima, in quel soggetto che è il più decoroso ed il fondamentale di quella fama che ha la città di Bologna, fra le tante nazioni oltramontane che ho praticate nei tempi di buona e di avversa mia fortuna.
1 Dal ÌIss. segnato col X. fi; 10 della R. Biblioteca TJniversi^iria, (Cod. N. r>6 ex Biblioteca Marsiliana).
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELI.' ISTITUTO ECC. 407
Questo mio riverente e cordiale ricordo sarà un testimonio, non solo appo delle SS. VV. Ill.me, ma ancora de’ nostri posteri, che parti,j con quei sentimenti di gratitudine che gli obblighi di natura e d’onore impongono ad un onorato cittadino.
Fu gloria e benemerenza immortale quella de’ nostri antichi padri, che s’applicarono ad essere restitutori di quelle scienze che tante barbare nazioni avevano calpestate. Non pensarono solo di rinnovarle per l’uso de’ propri cittadini, ma ancora d’e- stenderne il benefizio ed il frutto di così vasto istituto a prò delle nazioni più remote, che a gara correvano a questa nostra città, come i figli in seno alla madre, per nudrirsi di quelle erudizioni, che s’affatticò di potere e sapere comunicare a tutta l’Europa, che, all’esempio di questo nostro Archiginnasio, stabilì tante scuole, che, nel progresso de’ tempi, benché figlie, pare che superino, anzi che mettano in oblivione questa loro madre.
Una sola città, come questa, con un piccolo territorio, non poteva in altra forma rendersi più famosa, che col mezzo della letteratura, che s’acquista senza l’aiuto degli eserciti e de’ vasti dominij, ma solo con l'applicazione e l’opera dell’ingegno.
111.mi Signori, l’ingegno, iti questo felice clima, non manca, l’applicazione s’intepidisce, perchè alle volte s’apprende la fatica, che si crede maggiore di quel premio che si è solito a dare dalle SS. VV. Ill.me a chi cerca, per la fortuna e la gloria, gli studi j.
L ’auge di credito che in ora si possiede da tante Università di là de’ Monti, proviene da i viaggi di quelle nazioni, e da i premij che ottengono quelli che sono capaci di fare nuove discoperte nelle scienze, che procurano di esaminare con metodo più digerito di quello antico, che si pratica tuttavia nell’Uni- versità delleiSS. VV. Ill.me; che forse, su questi lumi, che intraprendo di darli, piglieranno motivi di correggere me, e di migliorare tutto che si fa nei paesi esteri.
L'Italia da’ stranieri, per la parte delle scienze, ormai si mette in oblivione; vedendo quelle, che non impieghiamo i nostri ingegni, benché forse più feraci de’ loro, ad uniformarsi a quei nuovi metodi di studiare, che la loro somma applicazione, ed indefessa fatica, e sommi dispendij che mecenati hanno stabilito,
408 MEMORIE INTORNO A L . F. MAItSII.)
e che è quello, 111.mi Signori, vorrei consigliare s’imparasse da noi, spogliandoci di tanti antichi abusi e di qualche nostra troppo eccedente presunzione, stabilendo per lo Senato-Consulto massime o leggi rimodernate.
In tutte l’Università di là de’ Monti, il jus consulto ha avuto la sua origine dall’Italia, e da Bologna principalmente. L’occasione di reggere vasti stati gli ha obbligati a travagliare su questa materia, formando trattati legali che punto non cedono ai nostri antichi.
Si sono applicati in tutte le parti delle matematiche, e levati nuovi vasti trattati, sopra di quelli principali antichi, che i nostri padri gli insegnarono.
Nella fisica, che è la scienza che conduce alla vera cognizione dello studio della natura in tante sue parti, gli oltramontani ora superano in tutto e per tutto noi italiani.
Concorre a questa loro superiorità l’ applicazione, la costanza nelle fatiche, la munificenza de’ mecenati, le peregrinazioni. Gli studi sacri con le frequenti dispute nate dalle diverse eresie, sono in un gran fervore, fra una estraordinaria applicazione alle lingue morte.
Vi concorre ad animare questa loro attenzione, il vedersi pronti e facilitati i mezzi della stampa, che è quella la quale comunica all’Universo le loro operazioni con ambi i prendi, e della fama, e del guadagno, comodità che difficilmente si ritrova in Italia e particolarmente in Bologna.
Mi permetteranno le SS. Loro Ill.me che combini questo stato generale delle scienze che ora s’insegnano nelle Università di là de’ Monti, e che, sopra d'ogni una, proponghi uno od altro ricordo : e che l’esaminino, e vedano con la loro prudenza se fosse praticabile, per mantenere la gloria antica di questa Università, adattandosi con nuove direzioni a promuovere le scienze, secondo il giusto e nuovo metodo che si pratica.
Prima d’ entrare suddivisamente nella materia, dovrò arditamente stabilire la massima che i fondi e somme di contanti costituita dalla munificenza delle SS. VV. Ill.me ed approvata da Sommi Pontefici è superiore allo stato d’una sola città, come è questa, e maggiore di quello si trovi anche in metropoli di va
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 409sti Stati: solo mi sia permesso di dire che basterebbe di ripartirlo per un minor numero di soggetti, che fossero obbligati, nella considerabile somma di quelli, un giusto stipendio alle loro
molte fatiche, e non un debito della graziosa pensione alla qualità di cittadino, come susseguentemente, con più chiarezza da se si manifesterà.
Per gli Studii sacri.
Su questi, come sono fatti dentro dello Stato della Chiesa, non è da dubitare che saranno i meglio coltivati, non mancando, a quelli che li praticano, speranze di prendi nella Chiesa, che da Sommi Pontefici dipendono.
Mi permetteranno però le YV. SS. 111.me che loro dicchi quello che esagerai con la Santità di N. S., cioè che gli studii delle lingue Ebraiche, Caldee, Siriache, ed Arabe, erano affatto neglette da’ nostri teologhi, come se questi avessero dimenticato il pregiudizio grande che ne riportò la Religione Cattolica al Concilio di Costanza, per avere avuti in quello i nostri Sacri Padri tutti ignoranti in quelle lingue, quando gli eretici, tanto versati in esse, trionfarono con interpretazioni, alle quali la nostra ignoranza non sapeva resistere.
(ìli eretici moderni, su questi studii di lingue, sudano giorno e notte, avendo scuole aperte, come fra uoi della lingua latina, per erudire la gioventù a vantaggio della erudizione sacra e profana.
Il tenere in fervore questo studio, 111.mi Padri della Patria, è un preparare alla difesa della Chiesa di Dio un numero d’Uo- mini, che saranno necessari,]' un giorno, a tutto che potrebbe succedere, pur troppo secondo i moderni apparati delle cose del mondo.
Si mi dirà che i maestri mancano; e questi saranno ritrovabili, con uno stipendio considerabile, pigliandoli fra termini di condotta per qual di anni, ed obbligando li cittadini che hanno a questo il talento, a studiarle, che sarebbe con maggior concorso,
410 MEMORIE INTORNO A L . F. MARSILI
quando lo Stato di N. Sig. emanasse una bolla, che la perizia in questa lingua dovesse essere un indispensabile requisito per potere ottenere certi impieghi della Chiesa.
Per lo studio delle leggi.
Questo è quello che ne' secoli addietro rese famosissima l’Uui- versità di Bologna perchè da lei ebbe l’origine dopo la depressione della barbarie, che aveva resa l’Italia incolta.
Ne tempi addietro era in una grande distinzione, perchè chi voleva in questo profondarsi, era obbligato di venire nella detta Università. In ora, come sopra dissi, che lo studio delle Leggi si pratica in tutte le parti d’Europa, si è reso così comune, che ne’ tempi moderni ne meno se ne fa più caso.
Le SS. W . Ul.me, che sono in debito di confermare questa miniera, che fu la prima dello studio di Bologna, di tanti soggetti che si resero capaci sino delle Tiare, vorranno considerare se forse il numero di queste letture, non fosse maggiore del bisogno, e che non fosse forsi più utile il risparmiare il numero di quelle per avanzare danaro da impiegare a distinguere i professori dell'altre scienze più rare, e che servono ne’ tempi moderni di gran lustro ad una Università.
11 metodo che si pratica, servendo di norma gli altri paesi, non lascia luogo da ricordare alle SS. VV. Ul.me alcuni miglioramenti, in paragone di quello che si pratica nei paesi di là dei Monti.
Della Medicina.
Questa è una scienza che è nata e cresciuta sulle osservazioni fattesi sopra della organica struttura dell’uomo, e della natura de’ fluidi, che circolano per essa, e delli accidenti morbosi, che occorrono in ambo le parti, e nell’istituzione dei medicamenti, proporzionati a quei mali che nascono o dal disturbo dell’organica struttura, e dall’alterazione della natura di detti fluidi.
L ’anatomìa insegna la struttura organica, e questa da nostri antichi padri nell’Università fu instituita con quel metodo di
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELI/ ISTITUTO ECC. 411
sofistici argomenti, più per far spiccare l’esperienza di argomentare, che la dottrina dimostrativa per erudire gli scolari.
Questa maniera deve avere la sua conservazione per un puro decoro delle cattedre, senza però che le SS. VY. Ill.me negligano di sentire il mio riverente consiglio fondato su quello ho veduto praticare nelle Università ultramontane, e che col racconto d’esse giudicheranno non essere che d’un sommo utile.
Per tutto l’inverno, almeno, si sogliono praticare corsi d’anatomia privata, nei quali i professori fanno l’iutiera ostensione di tutte le parti componenti il corpo umano. Molti sono quelli, che lo fanno per debito prescrittoli dalle Leggi dell’Università, e molti per erudire se stessi e gli altri che gli intendono.
Sono pure continuate le sezioni particolari delle parti, fra continuati esperimenti, comprovanti l’ estensione delle diverse strutture ed usi di esse.
Tutto questo 111.mi Signori, manca in questa Università, non potendo supplire per un intero anno quel strepitoso e frettoloso corso d’anatomia d’otto o dieci giorni, dove la gioventù non vede, tutto che ha bisogno la qualità di scolaro.
Sarebbe necessario di costituire almeno tre corsi d’Anatomia in un inverno, per la mentovata ostensione delle parti componenti il corpo umano. Una quarta per uso de,’ chirurghi, come si pratica nella famosa Università di Montpelier, facendosi sopra d’un cadavere, nel pubblico teatro anatomico, insegnare ai giovani chirurghi tutte le manuali operazioni chirurgiche, esercizio che dà li primi erudimenti alla mano di quelli.
Qui si fa una gran pompa di aver letto qualche libro di autore Ultramontano, che ha scritto col fondamento dell’osservazione ed esperimenti; si raccontano su di lui massime, se gli fanno metafisiche opposizioni, giacché non s’affatticano a farne delle fisiche con osservazioni in contrario, ed alla fine, fra un unione di cose dette da gli altri, e non mai riscontrate con gli effettivi tagli ed esperimenti, si giudica degli altri senza prima conoscere se stessi, nè avere fondamento da stabilire un sodo sistema da se stesso nuovo e uniforme a quello degli altri.
Marcello Malpighi, di gloriosa memoria, e venerato da tutte le nazioni ultramontane, diede esempio come si doveva osser
412 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
vare l’emulazione, molti hanno sdegnato l ’imitarlo; non avendo sentito alla «li lui fama e gloria maggiori coutrarij, che i proprii cittadini. Devo rendere giustizia alle di lui ceneri, col l’assicura re alle SS. VV. 111.me che l’ho sentito di là de’ Monti citare con l’epiteto di Divino Malpighi, e che più d’una volta sono stato interrogato come era possibile che in Bologna non vi fosse chi imitasse le di lui pedate nel cercare nuove discoperte della natura. li, per verità, con pace di tutti gli eruditi, dopo delle di lui opere, in questa Università non ne abbiamo avute altre, che tirino l’applauso delle nazioni straniere. E, quando fosse istituito il buon ordine per l’anatomia, non mancherebbero forse ingegni che farebbero quanto, e forse più, del defunto, di grata e gloriosa memoria, a questa nobilissima Università.
La cognizione dalla natura de’ fluidi, non mai i medici di Bologna la potranno conoscere, niente di più di quello che lor viene insegnato da’ libri oltramontani, giacché la scienza della chimica non è nè praticata, nè conosciuta.
Questa mancanza rende la medicina in Bologna d'un debo lissimo frutto, non potendosi correggere le parti peccanti de' fluidi, se prima la perfetta natura di quelli non si conosce mediante li tanti esperimenti chimici, che la possono insegnare.
Dalla notizia di questa ne viene l’invento de’ nuovi medicamenti, o di sapere applicare gli inventati jhh- sanare le parti difettose.
Questa necessità si è conosciuta nelle più grandi Accademie del Mondo, e per questo, si sono instituite cattedre che apprendono tutte le manipolazioni, tanto sopra de' vegetabili, che fossili, ed animali.
Supplico le SS. VV. 111.me a non perdere tempo ad instituire questo, nuova cattedra, con tutte quelle formalità che si praticano altrove, e che individuerò ogni qualvolta risolvano di farlo.
Da questa instituzione la fisica, la cognizione della natura, la medicina, in pochissimi anni risorgeranno, fra la vivacità di questi ingegni.
Non voglio lusingare le VV. SS. Ill.me, che la medicina sia in quel buono stato che molti vantano. La mancanza di gente che scriva buoni libri, il non vedere osservatori, la scarsezza di me-
E. BOKTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 413
dicamentare, gli infelici successi ne’ mali cronici, il non veder® un mal violento che termini, se non dopo una lunghissima convalescenza, che li porta per lo pili all’etisi o all’idropisi, la rarità di uomini vecchi, benché si sia in un aria felice, senza guerra, peste, o fame, e che al tempo de’ nostri padri erano in tanto numero, fanno dubitare che la medicina che di presente si pratica, ne possa avere una gran colpa.
Quale sia la pratica ed imtituti de medicamenti, basta solo ricorrere ai protocolli delle vecchie speziarle, per combinarli con li nuovi; dove si vedrà, che la scienza de diversi medicamenti adiuvanti alla natura, in caso d’essere oppressa dal male, è totalmente posta in oblivione, fra quel sistema di vedere ne’ mali che fa la natura, servendosi di bagatelle, che nè provano, nè risolvono; lasciando che la natura combatta col male; senza avere un aiuto nella medicina che la conforti; anzi con la dieta, con l’emissione di sangue, così forti, con tanta copia d’acqua, benché superi quel male, la rendono così destituita, che nell’età di 50 anni la rendono incapace di restituirsi nel vigore che dovrebbe essere, e di più rendersi soggetta a quei morbi che lasciano un breve resto di vita miserabile, che è quello si vede in Bologna, e non già nei paesi oltramontani.
Se l’instituzione di una cattedra chimica non risveglia la medicina dello stato dove è di presente, sarà un cattivo sperare salute in Bologna da questa. E, siccome il sommo zelo delle SS. VV. 111.me, informate di quello si pratica altrove con tutto utile del pubblico, e quello che occorre, con altrettanto danno in Bo- logna, non è da dubitare che li apporteranno il rimedio più proprio.
Della Fisica.
Questa è quella scienza, che nel secolo addietro, col metodo di tanti esperimenti, si ha sviluppata più cose della natura che erano ignote a noi. Qui la chimica pure ha la più gran parte, essendo impossibile d’essere un buon fìsico esperimentale all’uso moderno, senza d’avere una perfetta cognizione della chimica.
Crederei che le SS. VV. Ul.me potessero in un sol soggetto
414 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
unire 1« <lue letture di chimica e di tìsica esperimentale, non risparmiando considerabile stipendio, per avere un soggetto che se gli applichi con tutto lo spirito, senza divertirsi in altro.
Da queste due letture, o in una, o in due persone, l’Università di Bologna risorgerà in concorrenza delle straniere, non potendo mancare in pochi anni un numero considerabile d’allievi di portata.
Bella Botanica.
Li continui libri che l’Inghilterra, l’Olanda, la Francia ci danno di queste scienze, fanno conoscere in quanta stima ed applicazione sia appo di quelle nazioni, e che tutte impararono questa scienza, come di tutte l’altre parti della natura, dal nostro concittadino Plinio Aldrovandi; e pure da tanto tempo in quà, in questa materia, nè più insegniamo, nè impariamo da gli altri, per mancanza di quelli mezzi che sono necessarii a mantenere questa scienza nel suo flore.
Hanno le VV. SS. 111.me un professore di Botanica, che è il Can. Trionfetti, che possiede nei paesi stranieri la fama che gli è dovuta, e maggiormente potrebbe mettere in perfetto stato questo studio, quando gli fossero somministrati quelli comodi che sono necessari per la coltura e conservazione delle pian te esotiche e più rare del mondo, che sarà sempre mia cura il provvederne le SS. VV. 111.me, ogni qualvolta si risolvessero di precedentemente fabbricare il conservatorio per l ’inverno; e come questo dovesse esser, si direbbe, quando le SS. VV. Ill.me fossero risolute a farlo.
Questa scienza, in una Università famosa, come la nostra, è necessaria alla medicina, eome gli antichi e moderni ci insegnano, ma di più è divenuto un impegno d’onore e di fama d’ averla in quello stato perfetto che li supplico di metterla, animando così erudito professore, preparando un orto migliore di quello di Palazzo, e fabbricando il prementuato conserva- torio.
E. B0RT0L0TT1 - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 415
Delle Matematiche.
Sarebbe superfluo di ricordare all’intelligenza delle SS. LL.111.me, di quale utile decoro sia questa scienza in una Università, di modo che, con questa sicura notizia che ne hanno, passo ad individuare quali siano le parti d’esse che dovrebbero essere coltivate a misura delle scuole straniere, instituendo a mio parere 4 letture.
La prima e fondamentale, quella dell ’Algebra, come ebbe il defunto Stancari, invece dell’altra dell’antica geometria d'Euclide.
La seconda d’Astronomia, da coltivarsi mediante l’Osserva- torio ;
La terza che trattasse delle materie fisiche che fossero ridotte al dimostrativo mediante la geometria.
La quarta che ammaestrasse la gioventù per tutte quelle parti della matematica che riguardano alle arti, cioè le meccaniche, V architettura militare e civile, la prospettiva, la planimetria, 1’ aritmetica, la geografia e tutto che concerne al militare.
Questa è quella cattedra 111.mi Signori, che deve servire più d’ogni altra ai nostri figli e per questo ancora, spero che vi sarà premurosa.
Da queste quattro cattedre che riguardano le matematiche, ben provviste d’uomini esperti o almeno desiderosi d’affaticare, anche dopo che saranno beneficati dell’effettivo impiego, ne verrà un grande utile ai cittadini ed un sommo decoro all’intiera Università.
Queste sono quelle parti delle matematiche che hanno bisogno di essere tenute coltivate con continui esercizj, esperimenti ed accademia, il che tutto dipenderà dai voleri delle SS. VV. 111.me, invigilando ai soggetti provvisti, di fare tutto che devono.
Delle Istorie Profane.
Quanto sia importante alla vita civile ed erudita la perfetta ed ordinata notizia dell ’Istoria profaiui, e massime quando sia appoggiata ad una perfetta cronologia, non v’è bisogno d’ esagerarlo alle SS. VV.Ill.me; ma bensì di ricordarli che decoro ed utile di questa Università, devono attendere l’Emenda di
416 MEMORIE INTORNO A L . F. MARSILI
questa ommissione, imtituendo una cattedra che precisamente insegni questa bella scienza, che, con l’ordine necessario, è negletta.
Ne darò alle SS. VV. III.me un esempio occorsone ne' giorni passati, che volendo comunicare il Tomo delle Antichità del- l'Opera mia del Danubio a qualche soggetto che lo censurasse, fui così sfortunato di non trovare in tutta questa Università chi in simile materia fosse versato.
Le qualità d' un tale soggetto dovrebbero essere quelle di ben intendere la lingua greca, ed essere versato nelle Matematiche, massime per la parte astronomica, affine, non solo di poter conoscere fondatamente gli errori della cronologia de' tempi, ma anche di sapere da se stesso correggerli. Li sog getti che abbino le notizie matematiche non mancheranno alle SS. VV. lll.ine fra questi moderni studiosi, e non sarà già lo stesso per la lingua greca. Vero è che la provvisione fatta da loro d'un nuovo lettore di lingua greca potrà in breve tempo abolire questa ignoranza, incaricando al lettore di questa nuova lettura di doversi in quella lingua sollecitamente profondare.
Delle Lingue Orientali.
Nell'articolo degli studi Sacri ho bastantemente esagerato che questa Università si trovi priva di lettori di tali lingue, che furono le naturali dei primi Padri dell'umanità, e che una gran parte d'esse di presente si parlano da tante nazioni fuori d’ Europa.
Non dubito che le SS. VV. 111.me, tanto per il debito che hanno verso il servizio della religione, che di promuovere l’erudizione, cercheranno di venire alla scelta di un lettore versato in queste per poterle insegnare alla gioventù, che, come dissi, vedendosi animata dal premio prossimo d’impieghi Ecclesiastici, vi concorreranno in gran numero a studiarle.
Per trovare uno o due simili soggetti, che siano capaci di occupare questa cattedra, sarà necessario di commettere alla Amb., che ricorra a Nostro Signore, perchè conceda qualcheduno di Propaganda Fide. Ilo inteso che in Napoli vi sia
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 417
una scuola di dove forse si potrebbe tirare qualch’ uno. In Parigi parimenti vi è qualche esercizio e mi incarico io di scriverne al dottissimo Monsieur La Crucié primo interprete del Ee cristianissimo. L ’istessa diligenza potrebbero le SS. VV. 111.me far praticare in Vienna, dove questa scuola, al mio tempo, fu cominciata e con sommo profitto; avendo di presente S. M. Cesarea un considerabile numero d’interpreti squisiti, tutti tedeschi.
Quando tutte queste diligenze non producessero il desiderato effetto, dovrebbero risolversi di mandare un paio di giovani a studiare nella Propaganda Fide.
Dalle Università protestanti non v’è rimedio di tirare alcun soggetto, benché siano in gran numero, giacché tutti quelli che le studiano profondamente, non sono che eretici. Che non ammettano agli Uffizi della Chiesa, se non quelli che per lo meno siano fondati in queste lingue orientali, e massime l’ebraica.
La mia libreria, che dono al Pubblico, di tanti manoscritti, sarà d’un giovamento sommo alla gioventù che se gli applicherà, anzi, che potranno pigliare motivo di tradurre uno d’altro volume, e perchè di tutto ne conosco una somma necessità, ne rinnovo le mie più vive instanze alle SS. VV. Ul.me.
Sin qui ho scorso le diverse facoltà che compongono un pubblico Studio, e individualmente esaminate nel loro essere quelle che sono in questa nostra Università, e l’altre che mancano a misura del moderno metodo di studiare, e che è il più gradito nel mondo litterario, di modo che non mi resta alcun rimorso d’aver taciuta alle SS. VV. Ill.me veruna di quelle notizie che ho imparate nella lunga pratica che ho avuto nei paesi ultramontani.
Restami solo che mi vaglia della concessami libertà, di consigliarli a distinguere largamente con stipendj particolarmente li professori delle Matematiche, degli Studii naturali, delle Lìngue-, giacché tutte queste sono scienze che non portano che il quotidiano utile, che hanno i legali e medici.
Quando la gioventù riconoscerà che vi siano letture con emolumento pingue da poter vivere, non è da dubitare che non
2'J
418 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
s’applichi a questi studij, chè, senza ili questo premio, delle letture, li lauderebbe in una somma povertà.
Vorranno pure, per ultimo, soffrire, che conviene di praticare una somma diligenza d’animare allievi, che siano capaci di succedere ai maestri, e massime nelle scienze abbandonate degli utili quotidiani, perchè se si quieterà su quel servizio che rende vivendo un tal lettore, e non pensare che sarà dopo la di lui morte, si troveranno le SS. VV. Ul.me sempre nell’ angustia di non sapere di chi provvedere queste cariche, e quando quelli siano anche viventi, dover soffrire poca gratitudine, minacciando di volere passare in altra Università, quando non abbino aumento, nel che andrebbero più ritenuti vedendo le SS. VV. Ul.me ricche d’alunni.
Per aver un buon numero di Giovani capaci in tutte queste facoltà, sarà facile all’Ill.ma Assnnteria di Studio esercitando la di Lei autorità a punire i negligenti maestri che, o per timore della fatica, o per gelosia che lo scolaro non venga sopra di loro, non insegnano con quella tolleranza ed applicazione che dovrebbero alla propria coscienza ed onore, e gli esempi che comprovano questo disordine non sono rari nè antichi.
Da tutto che ho detto avranno motivo le SS. VV. Ul.me di compatire se poco ho inteso l’Università estere, per poterne fare il paragone con questa nostra, e dimostrare quanto ho dimostrato. A questa mancanza supplirà sufficientemente quello zelo che ho palesato e paleserò sempre, in tutto che possa essere dell’ utile di questa nostra comune Patria che in questa parte dell’Università, sarà felicissima sotto gli auspici della Santità di N. S. che le professa un paterno amore per non lasciarla mai priva d’ogni assistenza che gli sarà ricercata.
S’unisce pure l’altra fortunata congiuntura di dovere questa città essere governata per qualche tempo dall’Eminentissimo Card. Casoni, nuovo prossimo legato a Latere, che meco si espresse di volere per ogni strada mostrare il di lui affetto verso di noi, in tutte le cose, e massime a dar mano a far fiorire l’ Università.
Da questa unione di cose e alla conoscenza che tengo del
E. B0UT0L0TTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 419
zelo che nudriscono le SS. VV. Ill.me per la gloria ed utile della Patria, mi conviene di sperare che in brevissimo tempo l’ Università sarà in un vigore maggiore che mai sia stata ; anzi che ripiglierà l’antica superiorità a tutte l’altre dell’Europa: che è quello le auguro con cuore da vero concittadino e con quell’ Ossequio che è dovuto a chi ha l’ onore d’ essere com’ io
delle SS. VV. Ill.me
D i casa 9 Novembre 1709.
m .
Le “ Costituzioni „ dell’ Istituto
La riforma proposta nel « Parallelo... » benché tanta profonda conoscenza dimostrasse, e dei motivi di decadenza dell’antica Università, e dei mezzi più opportuni al suo rinascimento, e nonostante la generosa offerta del dono del materiale scientifico e della biblioteca, non fu punto presa in considerazione; generò anzi una violentissima reazione, perchè avrebbe violato troppi particolari interessi e troppo inveterati abusi.
Gli stessi parenti suoi si opposero fieramente alla donazione del Marsigli, accamparono diritti sul materiale scientifico da lui raccolto, e scacciarono dal palazzo avito l’Accademia degli Inquieti.
Il Marsigli abbandonò dunque quel progetto di riforma, e fu anche sul forse di trasportare fuori d’Italia tutto il materiale da lui accumulato, ma prevalsero i saggi consigli del Legato protempore, Cardinal Casoni e del Pontefice Clemente XI, per la Fondazione di un Istituto autonomo, nel quale le nuove idee potessero essere liberamente seguite, senza per nulla turbare l’andamento degli studi della vecchia Università.
La fondazione dell’istituto è fatto ormai troppo noto, perchèio abbia ad indugiare in minuti particolari; lascierò piuttosto
420 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
che lo stesso Marsigli ne dia notizia riportando un brano della « Istruzione al Signor Biagio Ferrari » ad uso di Mons. Prospero Lambertini, che si trova manoscritta nel Mss 2013 della Biblioteca Universitaria di Bologna.
Instruzione Finale al Signor Biagio Antonio Ferrari per la riduzionee regolamento migliore dell’ istituto. 1Questa fondazione, per misericordia di Dio, ed assistenza dei
miei Santi Avvocati, mi venne in capo l ’anno 1685 col motivo noto a Dio di giovare, di servire la Patria, e massime all’Or- dine Nobile di essa, e particolarmente per instruirla nelle parti che possono fare un abile soldato, figurandomi che con tali aiuti avrebbero preso l ’animo di uscire dall’ozio della Patria e procacciarsi la fortuna. Di poi, inoltrandomi negli studi fisici, per eseguire V Idea dell’opera del Danubio, pensai estenderla maggiormente, e, benché occupato nella guerra, sempre fui in corrispondenza con tutte le accademie, rispettivamente a noi oltramontane, e sempre più conobbi che nella mia Patria bisognava per le scienze seguitare l’esempio, per le Matematiche del Cassini, e per lo studio naturale, nella parte così necessaria della medicina ed anatomia, del mio riverito maestro Marcello Mal- piglii, come per gli studi naturali del canonico Trionfetti ; e con questi tre più volte comunicai questo mio pensiero per erigere un tale Istituto, che più insegnasse per gli occhi, che per le orecchie, e che rimettesse in Italia quel buon gusto che prima vi fu posto dall'accademia del Cimento, stata madre di tutte le accademie oltramontane che, col crescere, fra la loro applicazione si ebbero poca gratitudine alla nostra Italia.
Questa Idea quando la comunicavo a qualcheduno, o che gli spaventavo, o che mi tiravo il concetto di visionario; non potendo credersi che mai fosse potuto arrivare a fine quella raccolta metodica, che Dio mi assistette di poter fare nella forma che era 14 anni sono; giacché il fondamento di tale fondazione e metodo di studiare esigeva una così vasta raccolta, con ordine
1 Dal Mss. 2013 delia Biblioteca Universitaria.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL1 ISTITUTO ECC. 421di serie per tutte le facoltà che in esso Instituto si dovevano trattare.
Questa raccolta si cominciò a mettere dentro della mia casa paterna, anche con dare comodo alla gioventù, di quei tempi più studiosa che la moderna ; e fra questi comodi ebbe principio YAccademia fisica e sperimentale e presi in mia casa alla custodia di quei capitali, e per le tante raccomandazioni, EustaccMo Manfredi.
Le mie sventure, note a tutto il mondo, privandomi dei mezzi per poter continuare in quelle gran spese precedenti, mi obbligarono ad una specie di pausa; ma non già mi spaventarono l’animo, perchè ritiratomi in Provenza fra l’applicazione e commercio di uomini grandi, e somma mia angustia di vivere, per risparmiare a benefìcio di quella raccolta, che ivi feci, con intenzione di unirla alla numerosa che era in Bologna, spedita dalle più remote parti oltramontane e sino dall’Asia, paesi che peregrinai nei tempi felici o con autorità di comandi militari,o rispetto di ministerio politico.
Le congiunture strane che accadettero alla Santa Sede per causa della sorpresa di Comacchio, inspirarono a la Santa Memoria di Clemente XI0 a chiamarmi per prendere il comando delle Armi Ecclesiastiche. Questa congiuntura, da me inaspettata, mi diede comodo di rivedere la mia prima raccolta, spedita in Patria, che trovai confusa, lacera, diminuita, che è quello che appunto suole accadere al Capitale degli sfortunati.
Il mio soggiorno in Roma mi diede motivo di raccolte spettanti all’erudizione antica, che pure è una parte che mi ero ideato nell’ Instituto. Tale impiego mi dava qualche comodo di denaro, e il soverchio, per il mio decoroso mantenimento, l’impiegai per l’augmento de’ Capitali per il mentovato Instituto.
Terminato il bisogno militare, per la pace seguita fra nostro Signore e l’imperatore, riflettendo a più savie considerazioni sopra il mio sfortunato Stato, rispettivamente alla Maestà dell’imperatore, pensai al mio primario ritiro in Provenza, e, dopo aver terminato moltissime spese, e massime della Specola, nella mia istessa casa paterna, e per l’opera dell’istesso mio fratello conte Filippo, che sino a quel punto mostrò di accudire alla mia
422 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
notagli idea, senza mai minima opposizione, dovetti sentire una mattina da lui stesso che non si voleva nè da lui nè da gli altri della famiglia questo bordello nel Palazzo. Risposi che gli avrei posto il rimedio da loro desiderato, ma che solo mi dispiaceva die lina tale repugnanza non si mi fosse dimostrata prima dì dar la mano a fare tante spese di fabbriche.
Era allora Legato il Signor Cardinale Casoni, che aveva intima notizia di me per il negoziato che con lui feci a nome di Cesare per escludere il Signor Cardinale Fiirstenberg dall’elettorato di Colonia e che da quel tempo fino alla sua morte sem pre mi continuò; et con esso communicai la parlata del fratello ed il pensiero che avevo di far tutto trasportare in Provenza, ed ivi lasciar forsi di me una memoria.
Questo degno porporato gagliardamente si oppose a così fatta estrazione da una città che allora, come Legato, egli governava ; e che poi non sarebbe stata approvata, come egli diceva, in Roma dal Papa.
Preliminarmente mi ricercò sua Eminenza se veramente ero risoluto di dare per la causa pubblica questi Capitali. Risposi di sì costantemente, ed allora fra le voci che aveva sparso il fra- fello che tali Capitali non fossero più miei ma suoi, per li de nari che del suo proprio aveva dati nelle mie sventure, mostrando a tutti le ricevute che mi aveva fatte, senza mai unirle il confronto dei Capitali miei, con i quali aveva ricevuto denaro anche maggiore del rimessomi, il medesimo signor Cardinale Legato si risolse di fare portare tutto in un gran salone dentro del S. Ufficio di Bologna ».
A tenore della risoluzione di restituiremi in Provenza, ed anche per levarmi dagli impegni col mio sangue, dopo di aver sentito l’aperture fattemi fare dal Reggimento di Bologna, con- stituii più Cavalieri anche Senatori, come miei Mandatarii, e pochi giorni dopo del mio arrivo in Marsillia, questi mi scrivono che il Conte Filippo, mio fratello, si era dichiarato pubblicamente col Reggimento di Bologna che di tali Capitali non ero più padrone, per li tanti debiti, che avevo non solamente con lui, ma ancora con tant'altri soggetti, e che ero decotto, e senza più avere di che vivere.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 423
Pochi giorni dopo così strano avviso, mi capita l’altro che Monsignor Vescovo di Perugia, comune fratello nostro, era in extremis, senza più speranza di vita, di modo che una sera mi risolsi alla partenza per Livorno, sopra d’una piccola feluca, che in meno di quattro giorni mi vi condusse, ed ivi con la diligenza delle Poste, passai a Firenze, dove Monsignor Mattei, allora Nunzio, mi diede l’infausta notizia della morte del fratello Vescovo. [15 Luglio 1710].
Continuai egual diligenza del viaggio lino a Bologna, dove trovai che il Conte Filippo non aveva comunicata la morte ai parenti, per poter far tutto che fece, in sequela di aver persuaso il moribondo fratello a quel testamento col sospetto che io fossi suo debitore, dal che ebbe fondamento così gran lite, che mi obbligò di passare a Roma, e con tale occasione potere rappresentare a Nostro Signore questa mia idea dell’Instituto ; che mi ordinò un giorno di metterla in iscritto e che di siffatta maniera gli piacque, che promise di volerla assistere col riflesso dell’utile di Bologna a lui suddita, e decoro a tutto il suo Stato ; ed allora si cominciò il trattato più sodamente col Reggimento di Bologna, ormai assicurato che la voce sparsa che, tali Capitali dovessero essere a difesa dei miei debiti, veramente era insussistente.
Quella Santa Memoria di Clemente XI0, Padre delle Scienze, non solo mi dava consigli per eseguire ciò, ma risolse anzi, nella forma che lo stesso Reggimento alla prima domandò; ed alla seconda istanza, mostrando difficoltà, la Santità sua gli disse per persuaderlo, che a lui non avevo domandata una minima ricompensa per la mia prestatagli servitù, e che adesso lo supplicavo di questa fra tante opposizioni e stravaganze tentate da chi doveva piuttosto promuovere col grazia; e che passo per degni riguardi sotto silenzio.
Le Costituzioni dell' Istituto delie ScienzeEretto in Bologna sotto li 12 Dicembre 1711.
Da’ tempi antichissimi sino alla nostra età, avendo sempre avuto l’alma città di Bologna cura particolare di allevare nel suo grembo le Scienze, e di esercitare una diligente cultura;
424 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
conforme ha fatto conoscere nella Fondazione e mantenimento del Pubblico Studio, il quale avendo prodotto a beneficio di tutto il Mondo moltissimi uomini celebratissimi per le Virtù, per 1« Dottrine, e per qualunque Scienza, è stato degno d’essere confermato privilegiato dalle Bolle de’ sommi Pontefici, e dai diplomi degli Augusti imperatori, e conservando tuttavia, per naturale istinto e benefica influenza de’ Cieli, quest’indole generosa agli studj in tutti i suoi figli, e specialmente nell’eccelso suo Senato, andava questo con matura gravità consultando qualch'Opera memorabile, la quale manifestasse la Sua Magnifica Liberalità e benevolenza alla Filosofia, alle Matematiche, e consecutivamente all’Arti più cospicue della moderna Meccanica.
Quando il generale conte Luigi Ferdinando Marsilli, Nobilissimo cittadino di questa patria, che nelle sue cariche e frequenti spedizioni militari esercitate ed intraprese a varie e distanti parti d’Europa, per ardui affari, e di guerre, e di paci, in servigio della Sacra Cesarea Maestà di Leopoldo Primo Im- peradore, di glorosa memoria, e dipoi della Santa Sede Apostolica; avendo avuto genio di raccogliere e di fornirsi, con applicazione dispendiosa:
di molti rari strumenti per le Matematiche e Filosofia espe- rimentale ;
d’un museo di fossili;d’una storia de’ semi e vegetazioni delle piante terrestri e
marittime;d’una lunga serie di testacei; d’una biblioteca di libri delle migliori edizioni; di un gran numero di manoscritti arabi, persiani, turche-
sebi, e greci;d’un museo di antica erudizione;d’uno studio militare di modelli per fortificare e per fon
dere;di strumenti necessari a diverse arti; di molte antiche statue di marmo; d’un sortimento di scelti caratteri per le stampe,
o parecchi altri arnesi, con fine sempre da lui inteso di recare
H. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 425
con l’uso loro utile e gloria alla sua amatissima patria ed agli ingegni studiosi, ed avendo poc’anzi soddisfatto a questo virtuoso suo desiderio, con fare autentico Dono al pubblico del complesso di tanti capitali da lui radunati.
Li padri coscritti hanno abbracciata questa congiuntura, per mettere in esecuzione, ed in vista di tutti i secoli avvenire, le Idee le quali andavano disegnando nelle loro menti, per beneficiare principalmente la scenza, e poi le Arti.
Ed avendo conosciuto che la migliore utilità che apportar si possa alle une ed alPaltre è quella ((’illustrarle con le osservazioni, con le sperienze, e con le pratiche opportune, e d’istruir- ne tutti quelli, così proprij nazionali, che forestieri, quali fossero volonterosi d'apprenderle.
Quindi è che, col prudentissimo Consiglio, benignissimo favore dell’Eminentissimo Cardinale Casoni, Legato a latere di Bologna, insigne fautore de’ Studij, avendo essi fatto ricorso per mezzo del loro Ambasciatore Ordinario residente in Roma, conte Filippo Aldrovandi, alla Santità di Nostro Signore Papa: Clemente XI0, che Dio lungamente feliciti, perchè si degnasse d’approvare quelle strade che se gli proponevano, per condurre a questi lodevolissimi fini. E Sua Beatitudine, mossa da quella magnanima e beneficentissima propensione per la quale ha restituito all’antico suo credito la celebre Università dello Studio di Urbino, fomentata l’Accademia Romana degli Arcadi Letterati, esaltata a’ suoi primi gradi l’Accademia di Roma delle Tre Arti liberali, Pittura, Scultura, ed Architettura, e decoratane qui in Bologna altra simile con l’onore del suo Nome, essendo clementemente condiscesa a segnare in un suo Chirografo spedito sotti li 18 dell’ ultimo passato Luglio, la Grazia richiesta,
hanno per Senato Consulto decretato d’aprire sotto i fausti Auspici] d’un Pontefice Massimo fautore sì glorioso de’ Studi più insigni, e sopra il valido appoggio d’un Legato Apostolico sì benemerito de’ studii medesimi, una nuova sede alle scienze, con profitto ancora delle Arti, e di erigervi un’istituto, ove liberamente si possa mettere in uso la ricca suppellettile di tanti
426 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Capitali scientifici, e meccanici donati dal Generale conte Luigi Ferdinando Mar siili,
sono perciò passati all’elezione d’uomini per costumi e per dottrina ragguardevoli, con l’assegnamento a ciascuno d’un congruo Stipendio.
L ’uno de’ quali, col nome di Presidente, avrà la generale so- praintendenza di tutto l ’istituto,
l’altro, come segretario, terrà registro degli Atti dell’istituto, e i rimanenti, che si chiameranno Professori, avranno l’uf
fizio di esercitarsi in que’ titoli che professeranno, e d'insegnare a chiunque volesse apprendere, le Scienze da loro professate.
I titoli delle Scienze, e facoltà, ciascuna delle quali avrà il suo professore, saranno: d’un Astronomo, d’un Meccanico, d’un fisico Sperimentale, d’un /storico della Natura, d’uno Spargi- rico, e di un Bibliotecario.
Ed affinchè dall’ampio apparato di tante cose, e dalla scelta di soggetti sì accreditati siasi certo di ritrarre quel giovamento universale, che è stato il primario oggetto di questa nuova fondazione, dopo maturo esame si è venuto dall’eccelso Senato alla legittima approvazione ed intimazione de’ seguenti Capitoli, da osservarsi inviolabilmente, tanto dal presidente quanto da’ professori ed Ufficiali dell’istituto delle Scienze, fino a tanto che, per miglior bene, a lui piacesse di disporre altrimenti.
C a p . I - Del Culto Sacro.
Art. 1. - Li professori, e qualunque persona si eserciterà in questo Istituto, dovranno riconoscere per Autore Dio Ot timo Massimo, ed implorarne da Lui, a maggior sua gloria, la conservazione e gli avanzamenti, mediante intercessione della Santissima Vergine Maria. Ed acciocché si provi efficace protettrice di quest’Opera, in tutti gli Strumenti e scritture si praticherà VE poca ab incarninone; lasciando per altro che, in ciò ehe riguarda le osservazioni astronomiche, si usi la pratica elo stile dell’era corrente.
2. - Saranno pure riconosciuti e venerati per protettori S. Tommaso d’Aquino, S. Carlo Borromeo, e la nostra S. Cat-
E, BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 427
terina de’ Vigri, e nella Cappella domestica, che si erigerà ne l’istituto, dovrà solennizzarsi da professori e studenti la Festa della Santissima Annunciazione, con la celebrazione d’una messa, in rendimento di grazie a S. D. de’ beni che si ritraggono dall’istituto, e delle sue infinite Misericordie, usate specialmente in tal giorno col generale conte Luigi Ferdinando Marsilli.
C a p . II. - Dell’ Elezione del Presidente, del Segretario e de’ Professo-ri.
Art. 1. - Tanto il presidente quanto il segretario dell’istituto saranno eletti dal Senato. I loro Uficj saranno vitalizj, purché possano esercitare ed effettivamente esercitino il loro Ministerio in conformità delle presenti Constituzioni, quando però non fossero impediti per giuste cagioni, da approvarsi dal- l’Assunteria dell’istituto; ed, occorrendo, dal Senato.
2. - Li professori saranno eletti dal Senato per un solo quinquennio.
3. - Due mesi avanti che spiri questo termine, dovranno li professori dimandare al Senato la conferma, e non dimandandola, i Posti s’intenderanno vacanti, e si aprirà il campo al concorso.
4. - Sarà però sempre in libertà del Senato di rimovere da l’ Istituto qualunque soggetto, che avesse notabilmente demeritato.
C a p . I l i - Del Presidente.
Art. 1. - Dovrà il presidente tenere la sua abitazione dentro il palazzo dell’istituto, per poter meglio assistere alle sue incombenze.
2. - Invigilerà, che fra tutti li professori passi reciproca corrispondenza, e procurerà che tutte le costituzioni vengano, con bell’ordine e quiete, esattamente osservate.
3. - Regolarmente, in fine d’ogni bimestre, dovrà informare l ’Assunteria soprastante all’istituto, di tuttociò che dalla medesima gli venisse richiesto.
428 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
4. - Se il Presidente fosse ancora professore d'alcun titolo,0 custode speciale d’alcun Capitale dell’istituto, dovrà osservare que’ Capitoli, che competerauno a tale professione e custodia.
C a p . IV - Del Segretario.
Art. 1. - Il Segretario avrà facoltà d’intervenire a tutti gli Esercizij, e i professori dovranno in ogni tempo, e ad ogni di lui richiesta, dargli comodo delle loro stanze.
2. - Terrà memoria distinta di tutte le Operazioni più rimarcabili, che si faranno negli esercizii dell’istituto, facendo menzione degli Autori, e principali Manipolatori, ed a questo line1 professori dovranno dargli in iscritto ragguaglio delle Operazioni, che anderanno facendo ne’ loro esercizj. Quando i professori esibiranno il foglio delle Materie, come al Cap. V, il Segretario porgerà in iscritto all’Assunteria un distinto racconto dell’anno antecedente, e di tutto ciò che di rimarcabile sarà seguito.
3. - Doverà tenere aperto commercio colle Accademie Oltramontane a nome dell’ Istituto, e registro di tutte le lettere, osservando per le lettere e spedizioni quanto si è ordinato all’articolo 2° del Cap. XII.
4. - Avrà, come tutti i professori, dipendenza dal Presidente, e lo terrà esattamente ragguagliato di quello che succede.
5. - Il Segretario dell’ Istituto servirà ancora di Segretario l’Accademia delle Scienze dell’istituto.
Ca p . V - Da’ Professori.
Art. I. - Nel principio del mese d'Ottobre il Presidente e Professori si raduneranno a congresso nella Sala dell’istituto, per conferire e divisare, con comune consiglio, le materie che ciaschedun d’essi, secondo i suoi titoli, volesse trattare negli esercizj dell’ imminente anno scolastico, e fattasi da ciascuno scelta di quella materia che sarà da lui giudicata più profit
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL- ISTITUTO ECC. 429
tevole e necessaria, circa la metà del suddetto mese si presenteranno tutti insieme all’Assunteria dell’istituto, e gli proporranno le loro materie con il figurato della spesa, che separata- mente crederanno siano per importare gli studi di ciascheduna, per ricevere la Pubblica Approvazione.
2. - Essendo state approvate le materie dall’Assunteria del- T Istituto, ciascun professore ne’ giorni ed ore prescritte dovrà trovarsi alla sua stanza dell’ istituto, per ivi operare intorno alla materia a lui spettante, per lo spazio continuato delle due ore destinate, dimostrando amorevolmente a tutti quelli che vorranno imparare, sieno cittadini o forestieri. S’incarica però loro d’usare una distinta parzialità per quelli della famiglia Marsilli, che bramassero d’essere istruiti.
3. - Avranno i professori particolare avvertenza di non fare negli esercizj alcuno studio o discorso scientifico, che convenisse alla forma d’una Lezione, od che si potesse chiamare una vera Lezione propria delle cattedre del Pubblico Studio, dovendo gli esercizj versare principalmente nella pratica delle osservazioni, operazioni, esperimenti, ed altre cose di simile natura. S’imputerà a gran colpa la trascutaggine di questo articolo.
4. - Se il Senato facesse istanza alli professori dell’ Istituto, di qualche esame, esperimento, o altro, dovranno subito servirlo. E se da qualche cittadino, scolaro, artefice, o altra persona privata fossero pregati di direzione ed assistenza, in cose della loro professione, dovranno soddisfarli discretamente.
5. - Essendo ricercati i professori, di qualche esperimento creduto profittevole, dovranno compiacere l’istanza, ed assistere in persona all’ esperimento. Quando però l’ esperimento fosse dispendioso, dovranno i professori chiedere licenza al presidente, il quale avrà facoltà di concederla fino alla somma di L ir ...., se importasse maggior spesa, il presidente dovrà prender licenza dall’Assunteria dell’istituto.
6. - Ogni professare dovrà eleggersi un Compagno di sua soddisfazione, che l’assisterà negli esercizj. Eletto che l’abbia, dovrà darlo in nota al Presidente, e pregarlo che sia da lui accettato, e, seguendo l ’accettazione, s’intenda il professore ob
430 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
bligato in sicurtà al Senato, che per il suo Compagno non patirà alcun danno l’istituto. Non potrà mutare il compagno senza l’approvazione del Presidente.
7. - Ogni professore avrà la chiave delle proprie stanze, e l’inventario di tutte le cose contenute nella Stanza, o Stanze, destinate alla sua professione. Nel tempo delle Vacanze estive dovrà rincontrarlo in compagnia del Presidente, ed ogni volta che gli fosse ordinato dall’Assunteria dell’istituto.
8. - Ogni professore godrà del comodo de’ Libri della Biblioteca, e particolarmente di quelli che fossero pertinenti alla di lui professione, salva però la disposizione dell’Articolo 5° del Cap. X III.
9. - Conserveranno i professori diligentemente nelle proprie stanze, a disposizione dell’Assunteria dell’istituto, tutte quelle Opere che, a spese dell’istituto, fossero state da loro fabbricate, e di tali Opere, che facessero, daranno una nota distinta al Segretario, che dovrà prima essere riveduta da Censori, che saranno destinati dall’Assunteria dell’istituto.
C a p . VI - De1 Giorni ed ore degli esercizj.
Art. 1. - Sarà uficio del Presidente l’aver formato avanti il principio dell'anno scolastico il Calendario dei giorni degli esercizj dell’istituto, regolandolo sempre in forma che in ogni settimana abbia un esercizio in un giorno che non sia impedito dalle lezioni del pubblico Studio, nè dalle Ragunanze dell’Ac- cademia delle Scienze. Il Calendario sarà esposto nell’istituto a comodo di tutti.
2. - Oltre alli giorni che saranno assegnati nel Calendario agli esercizj, ciascun professore dovrà eleggersi un giorno a suo piacimento della settimana per li suoi esercizj, ed avanti che termini l’esercizio del giorno elettivo, avviserà i suoi studenti qual sarà il suo giorno elettivo per l’esercizio della settimana seguente, e lo noterà in una tabella, che pubblicamente starà appesa per avviso e commodo di tutti quelli che volessero intervenire.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL* ISTITUTO ECC. 431
3. - Le ore degli esercizj saranno dal principio dell’ anno scolastico lino a quaresima ; dalla prima ora della notte in punto fino alle tre.
4. - Dal principio di quaresima fino a tutto Aprile, dalle ore 24 tino alle due.
5. - Dal principio di Maggio fino all’Assunzione della Beatissima Vergine, dalle ore 20 fino alle 22.
C a p . V II - Delle Vacanze.
Art. 1. - Il Presidente registrerà nel Calendario i tempi delle Vacanze, con avvertimento che quelle di Natale non prin- cipjino prima della festa di S. Lucia fino all’Epifania. Quelle di Quaresima dalla domenica delle Palme fino all’ Ottava di Pasqua. L’estive dalla Madonna d’Agosto fino a tutti li Santi.
2. - Saranno ancora vacanti tutti que’ giorni ne’ quali si facesse l ’anatomia sul pubblico Studio.
3. - Se però in tempo di ferie o di vacanze, ed ancora nel corso degli esercizj, fossero i professori avvisati dal Presidente a trasferirsi all’istituto per servire qualche forestiero o per qualche urgente bisogno o pubblico commando, dovranno esser pronti ad andarvi.
C a p . V i l i - De’ Stipendj.
Art. 1. - Sarà assegnato il suo stipendio a ciascun degli ufficiali dell’istituto da pagarsi loro, ad ogni tre mesi compiuti,, la rata.
Ca p . IX - De’ 'Negligenti.
Art. 1. - Se alcun professore o altro ufficiale dell’istituto mancherà, a giudizio dell’Assunteria, notabilmente al debito suo, sarà dal Senato rimosso perpetuamente dall’Ufficio, e surrogatovi altro soggetto.
432 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
C a p . X - De’ Custodi.
Art. 1. - Quelli che saranno destinati a custodire que’ Capitali dell'istituto, che non cadono sotto l’uso de’ titoli delle professioni, dovranno fedelmente e con pulitezza conservarli, dare, occorrendo, discreto comodo ai professori di prevalersene, mostrarli cortesemente a’ forestieri ed alle persone di qualche distinta qualità.
2. - Avranno presso di loro un inventario di tutte le cose commesse alla loro custodia, per riscontrarle col Presidente nel tempo delle Vacanze estive, e sempre che gli fosse ordinato dal- l ’Assunteria dell’istituto.
Ca p . XI - Dell’ Accademia degli Inquieti.
Art. 1. - Essendo che l’Accademia degli Inquieti va con molto onore di questa Patria elevando uomini insigni in tutte le facoltà, si dichiara che debba essere annessa a quest’istituto, sperandosi che la benignità del Senato sia per condiscendere a confermare le Leggi di quella ed a favorirla della sua Paterna Protezione.
.2. - Lasciando pertanto la sua prima denominazione d’Accademia degli Inquieti, dovrà chiamarsi: Accademia delle Scienze dell’istituto di Bologna ed ivi farà liberamente le sue Radunanze nel luogo che le sarà destinato.
3. - Non dipenderà dal Presidente dell’istituto, ma solamente dal proprio Presidente, anzi, tanto il Presidente quantoi professori dell’ Istituto, dovranno far godere all’Aceademia con modo più speciale de’ Studiosi, i comodi dell’ Istituto e in tutto assisterla e compiacerla, senza però mai derogare alla disposizione delle presenti Costituzioni.
C a p . XII - Dell’ Erario, e Spese.
Art. 1. - Per le spese che occorreranno negli esercizj del- T Istituto, l’Assunteria soprastante spedirà i suoi mandati in testa del Presidente, il quale, tenendo presso di se il denaro
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 433
riscosso, l’ impiegherà in provvedere quanto sarà di bisogno a’ professori ne’ loro studj ordinarj.
2. - Dovrà far riscuotere le lettere o stampe che fossero dirette all’istituto o Accademia delle Scienze, ed egli con il Segretario aprirà li Plichi e le Lettere, per vederne il contenuto. Ed all’incontro farà francare e spedire quelle lettere o stampe, che dall’istituto o dall’Accadeinia fossero indirizzate ad altri Paesi.
m-
C a p . X III - De’ Capitali e Suppellettili.
Art. 1. - Conserverà il Presidente un Inventario generale di tutti i Capitali e Suppellettili dell'istituto, e nel tempo del- l’Ultime Vacanze estive dovrà rincontrarlo diligentemente a Capo per Capo, ed avanti il principio degli esercizj riferirnelo Stato all’Assunteria dell’istituto.
2. - Sia però pronto a farne sempre il rincontro ogni volta gli venisse ordinato dalla suddetta Assunteria.
3. - Il Presidente aggiungerà subito al suo Inventario generale tutto ciò che l’istituto acquistasse, e lo farà subito aggiungere all’inventario particolare di quella professione, alla quale tal cosa acquistata appartenesse. Dell’acquisto fatto renderà immediatamente consapevole l’Assunteria dell’istituto.
4. - Se per alcun accidente mancasse alcun Mobile, Strumento, o altra cosa dell’istituto, ne farà memoria in un Libro a parte, e ne avviserà subito l’Assunteria dell’istituto.
5. - Dalli professori non si trasporterà capricciosamente alcuna cosa da un luogo all’altro, ma solamente per uso dei medesimi, e per quel solo tempo che avranno bisogno, nel qual caso dovranno gli estraenti lasciare una ricevuta in mano del professore o custode di quella stanza dalla quale si dovrà trasportare.
6. - Sotto qualsivoglia pretesto non si potrà mai portare alcun Capitale o altro mobile fuori del Palazzo dell’istituto, senza espressa licenza del Senato. Derogheranno però sempre a questa Legge le riverite istanze del Sig. Generale Marsilli, alle mani del quale, avrà facoltà il Presidente di consegnare
■&>
434 MEMORIE INTORNO A L . F. MARSILI
personalmente e dare in prestito, ciò che richiedesse, con prendere da lui un attestato in iscritto della sua ricevuta.
7. - Si permetterà pure al Professore che avrà la stanza delle statue, di fare all’Accademia Clementina della Pittura, il prestito di quei inaimi, che per suo studio addimandasse, ma però coll’obbligazione in iscritto de’ principali uffiziali del- l’Accademia, di restituire il pigliato ad ogni richiesta di esso professore, e purché l’ Accademia Clementina si mostri grata all’istituto, compiacendolo, ricercata, di qualche disegno o configurazione, essendo dovere che fra 1’ una e 1’ altro, passi nna lodevole corrispondenza.
C a p . XIV - Del Custode delle Officine e del Palazzo dell’ Istituto.
Art. 1. - La sua elezione si farà dall'Assunteria dell'istituto. Dovrà tenere la sua abitazione nel quartiere che gli sarà destinato dentro il palazzo dell’istituto.
2. - Custodirà tutte le Officine delle Arti, facendo buon governo di tutti gli strumenti delle medesime. Serberà un Inventario di tutte le cose commesse alla di lui custodia, e ad ogni istanza del Presidente o dell’Assunteria sarà pronto a fare il rincontro.
2. - Con la permissione del Presidente darà comodo a tutti li Professori di potere adoprare gli strumenti delle Officine, ma però dentro la stanza delle Officine, e non fuori della medesima.
4. - Desiderando qualche estraneo di prevalersi di tali Officine, non potrà soddisfarlo senza licenza del Presidente.
5. - Dipenderà dagli ordini del Presidente, che dovrà sempre puntualmente eseguire, e procurerà che sieno serviti i professori nel tempo degli esercizj.
6. - Farà mettere in pronto le illuminazioni e tutto ciò che per preparamento degli esercizj gli sarà ordinato dal Presidente.
7. - Farà aprire e chiudere il Palazzo a debiti tempi.8. - Farà che si mantenga monda e pulita tutta l’abitazione
dell’istituto.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 435
9. - Farà che sieno portate le polizze ed avvisi a’ professori quando gli sarà comandato.
Ca p . X V - Durabilità delle presenti Costituzioni.
Art. 1. - Si dovranno tutte, ed in ogni sua parte, osservare inviolabilmente queste Costituzioni dal Presidente, Segretario, Professori e Custodi dell’ Istituto, finché per la mutazione de’ tempi, e per miglior uso di Scienze ed Arti, paresse al Senato di variarle o abrogarle in tutto o in parte, nel qual caso gli ufficiali suddetti saranno obbligati all’osservanza di quelle nuove Costituzioni, che venissero ad essi prescritte.
2. - Incontrandosi nelle presenti Costituzioni, o nelle future contingenti, qualche Capitolo, Articolo, Paragrafo e particellao parola di dubbia intelligenza, spetterà unicamente aWAssun- teria dell’istituto l’interpretarla e dichiararla, ed alle dichiarazioni ed interpretazioni di quella tutti i Ministri dell’ Istituto dovranno quietarsi.
Actum Bononiae in Palatio Magno. . . .
IV.
Contrasti e Consensi - Le Nuove Dotazioni - Commiato
Le Costituzioni dell’ Istituto furono integrate da opportune convenzioni fra il donatore, il Reggimento di Bologna e la Santa Sede, in modo da assicurare i mezzi pel suo funzionamento.
Il Reggimento di Bologna si assunse le spese dell’apprestamento dei locali e della manutenzione; pel primo titolo furono stanziati scudi 25.000, e pel secondo titolo furono assegnate all’istituto Lire 2.600 di rendita annua sul Monte Sussidio. Ma quelle somme si manifestarono insufficenti; ed il Marsigli, per non veder la ruina della nuova instituzione, prima sovvenne del proprio, perchè almeno fosse apprestato il mobiglio idoneo
436 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
al ricovero del materiale scientifico, poi ricorse per sussidi alla Santa Sede.
Ottenne che fosse devoluto all’istituto il provento di certe cariche, che importava un annuo reddito di circa Lire 5.000; poi, visto che tale reddito non sarebbe stato liquido se non alla morte dei beneficiari, ottenne che fosse in parte anticipato, e che fosse devoluta all’istituto anche la tassa che, per diritto di Stampa, veniva allo Stato per la pubblicazione dei pubblici Atti di Governo, infine ottenne un sussidio di 15.000 scudi per la continuazione delle fabbriche.
Ma, sia l’apprestamento delle aule, che la costruzione della Specola andavano troppo a rilento, in modo da far credere al Marsigli che quei 15.000 scudi non finissero... in fondo a Reno !... mentre poi, d’altra parte, si andavano introducendo nella nuova istituzione quei medesimi abusi che erano stati causa della rovina dell’antico Studio.
I reclami verbali a nulla giovavano, e le denucie formali alle autorità cittadine ed allo stesso Legato, non facevano che procreare interminabili liti che aduggiavano l’animo del generoso ed impaziente generale. Ma gli si presentò una occasione che gli diè modo di poter imporre una pii! fedele osservanza delle disposizioni statutarie.
Per la stampa della sua magistrale opera sul Danubio fu- iono offerte al Marsigli vantaggiose proposte da una rinomata società libraria di Amsterdam. Il Marsigli accondiscese alla stampa, rifiutò qualsiasi pecuniario compenso, volle solo in cambio una copiosa e rara collezione di libri scientifici, che non erano compresi nella Libreria dell’istituto, e si trovava all’Haia per la vendita della famosa libreria del Cardinal del Basco, ed una raccolta di « Cose naturali delVIndie » (cioè dell’America) che il Vallisnieri giudicò « da se stessa poter for- « mare un Museo, di cui forse in quel genere non sarà il sc- « condo in Italia ». Egli intendeva di lasciar tutto ciò in dono all’istituto, ma a condizione che fossero rimossi, insieme con gli abusi introdotti, le cause che avrebbero potuto favorirli.
Si recò egli stesso, nonostante la di lui oltre sessagenaria età, con lunga navigazione da Livorno a Londra ed indi ad
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 437Amsterdam, curò la stampa dela sua opera e la raccolta del materiale, che affidò a mani sicure e fece poscia trasportare a Bologna.
Ma le condizioni che egli voleva imporre per la consegna di questo materiale all’istituto, non garbavano punto, nè agli Assunti dell’istituto, nè al Reggimento di Bologna; chè troppo strana cosa pareva il dover rinunziare a tradizionali privilegi e ad inveterate consuetudini. Perciò si fecero al Marsigli opposizioni d’ogni specie; lo si volle costringere a cedere, senza condizione alcuna i capitali da lui raccolti, che erano frutto dell’opera d’ingegno da lui compiuta, prima col resistere alla richiesta della consegna del manoscritto e dei disegni relativi all’opera danubiana, da lui antecedentemente depositati nella libreria dell’istituto, poi, quando il Marsigli ebbe fatto valer il diritto che a lui veniva per l’articolo 6o, Cap. X III delle Costituzioni, col tentare di far venire direttamente dall’Olanda quei Capitali1, infine col denigrarne il valore2.
La controversia, cominciata nel 1721, si trascinò per vari anni, senza mai venire a definitiva conclusione, finalmente nei primi del 1726 la Curia Romana, cui era stata deferita la soluzione, diede incarico a Mons. Prospero Lambertini, dotto, probo, illustre prelato bolognese, (che fu più tardi cardinale di Bologna ed infine papa Benedetto XIV), di raccogliere le ragioni delle due parti e di riferirne, col parere e con le opportune proposte, al competente tribunale.
1 « Questa librarla è tutta nelle mani del Sig. Cesare Sardi, cava- « liere lucchese, che negozia cosi nobilmente in Amsterdam, e che a « quest’ora farà quelle disposizioni che ordinerà l ’Assunteria, e che « questa volta, munita di un mio mandato, non avrà quelli affronti « che si poteva figurare, quando da sè stessa tentò, inscio me, di voler « esercitare jurisdizione sopra de’ capitali consegnatili da me, mio man- « datario legale in una tal Piazza, dove la pontualità nell’ordine e « mezzo del negozio è a ll’ultima perfezione, senza riguardo nè mene a « teste coronate, non chè ad un’Assunteria di Bologna, che colà, assi- « curo V. E., non sanno nemmeno che cosa sia, ridendone fra loro » (C fr. lettera al Card. Ruffo del 1° Settembre 1726).
1 « Quattro uccellini, farfa llette, ed un mazzo di canne d’ india... ! » ÌC fr. lettera al Card. Buffo del 13 Settembre 1726).
438 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il Marsigli nominò suo procuratore certo Signor Biagio Ferrari, e le pretese dell’Assunteria e del Reggimento di Bologna furono sostenute dall’Ambasciatore dei bolognesi presso la Sante Sede.
Ci furono conferenze e convegni, il Lambertini prese molto a cuore la cosa, e, come dimostrano le lettere di lui che si conservano fra i manoscritti marsiliani nel Cod. 2013 della Biblioteca Universitaria, diede prova di molto senno, di tatto squisito e di perfetta conoscenza della questione.
In seguito alle di lui conclusioni, intieramente favorevoli al Marsigli, la Segreteria di Stato, con lettera 3 Agosto 1726, dava le opportune norme ai Cardinal Legato, perchè venissero accettate, insieme con le donazioni del Marsigli, le condizioni, meglio idonee ad un miglior funzionamento dell’istituto, che il Marsigli aveva proposte. La sola condizione non bene accolta dal Lambertini, perfetto conoscitore degli uomini e dei tempi, fu quella intesa a « levare V ingerenza dell’ Istituto dal Reggi- « mento e darla al Legato », per la considerazione che : « ... col « tratto di tempo, un aiutante di camera del Cardinale Legato « diventerebbe il padrone dell’ Instituto ».
Il Marsigli accettò immediatamente la transazione proposta dal Lambertini e gli uffici del Cardinal Legato, ma l’As- sunteria, seppe frapporre curialeschi ostacoli in modo da procrastinare di un altro anno la definitiva risoluzione. Ed in quel frattempo, tante furono le insinuazioni, i libelli a carico del Marsigli, ispirati e propalati da personalità cittadine che avrebbero dovuto mostrare gratitudine al Generale per le generose sue elargizioni a prò degli Studi, e dagli stessi parenti suoi prossimi che appartenevano al Senato ed alla Assunteria di Studio, che al fine il Marsigli, disgustato, dopo aver firmato l’atto di donazione e le nuove costituzioni che assicuravano la defintiva sistemazione dell’ Istituto, dispose la pubblicazione degli « Atti Legali » concernenti la fondazione dell’istituto, e poi lasciò la città e la Patria, e volle perfino rinunziare al nome avito ed allo stemma di famiglia.
I particolari di questa vicenda, che si possono ricavare dalla
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL* ISTITUTO ECC. 439
lettura degli scritti contenuti nel Mss. 2013, più volte citato, ci rivelano nuove, poco note benemerenze del Lambertini e del Marsigli verso l’ Istituto e verso gli studi scientifici. Raccoglierò qui, evitando le inutili ripetizioni e le parti meno concludenti, i più interessanti fra quegli scritti, disposti secondo l’ordine cronologico degli avvenimenti, in modo che ne risulti una viva e fedele esposizione delle vicende del nostro Istituto negli inizii della sua vita accademica.
« Supplica a V E.mo e R.mo Card. Ruffo, legato di Bologna » .
.... La fondazione dell’ Instituto, posso dire che fu l’oggetto della mia vita....
.... Il medesimo Reggimento mi obbligò, unitamente al di lui ambasciatore, di sollecitare da Nostro Signore, prima il Chirografo di deroga del Fidecommisso che era sopra il Palazzo dove di presente sta 1’ Instituto : un secondo Chirografo per scudi ventieinquemila da impiegarsi la maggior parte per le fabbriche. Pochi anni dopo conobbero che la somma dei venti- cinquemila scudi era stata tenue, m’obbligarono a supplicare da N. S. l’assegnaziozne in perpetuo del provento di certi ufizi soliti a conferirsi da’ pontefici a cittadini di questa Patria, grazia che supplicai prostrato a di Lui Santi Piedi, per finale ricompensa della mia prestatagli servitù, e che alla fine con un altro Chirografo m' accordò.
Dopo di aver ottenuto quest’altro dalla somma Beneficenza del Santo Deiunto Pontefice, mi figuravo di credere che il Reggimento intraprendesse il fin del promessomi con tanta solennità, ma mi riuscì tutto contrario, scusandosi che tali proventi erano ancora remoti, perchè bisognava attendere la morte di quelli che li possedevano.
Io, che vedevo tante delle stanze ohe compongono l’Insti- tuto in istato imperfetto, anche fra le mie angustie e vessazioni di liti, mi risolsi con grandissimo dispendio di terminarle del mio; come V. E. ne potrà avere il riscontro....
440 MEMORIE INTORNO A L . F. MARSILI
« Chirografo di Clemente X I a vantaggio dell’ Instituto del 10 gennaio 1120 ».
.... Con altro nostro Chirografo delli 16 Febbraio dell’anno 1715 furono da noi soppressi gli uffici soliti concedersi da questa Santa Sede, e de’ quali pagansi agli ufficiali che li godono senza alcun esercizio e peso, gli emolumenti della Camera della detta Città di Bologna, cioè:
Calcolatore della Camera,Notaro de’ Calcoli,Capitano della porta di Palazzo,Custode della Torre degli Asinelli,Due soprastanti alla Zecca,Custode delle munizioni,Soprastante alla condotta de’ soldati,Campioniere del Pesce,
et applicatine gli emolumenti certi et incerti, ordinari e straor- dinarj, secondo che fossero andati vacando, assieme colla rendita delle fosse della Città, al Reggimento della medesima, in perpetuo, sotto il preciso obbligo di averli intieramente a derogare nella terminazione e totale compimento di qualisisiano cose necessarie alla felice consevazione e decoroso incremento del celebre Instituto eretto sotto i nostri Auspicij nella detta città, in cui trovasi già collocata la Libreria et altro per uso di scienze naturali di filosofìa esperimentale, d’astronomia e di matematica, generosamente donatali dal Generale Conte Luigi Ferdinando Marsilij....
.... diamo e concediamo al detto Instituto delle Scienzze... il libero uso et attuale possesso di tutti li sopradetti ufficij, ancoraché vivano li Possessori de’ medesimi, con ordinare, conforme noi ordiniamo al detto Reggimento della nostra città di Bologna suo Depositario e ministri, che in avvenire debbano pagare al detto Instituto o al suo Depositario tutti gli emolumenti, rendite o risposte solite darsi annualmente o mensualmente o in altre maniere alli detti Officiali dallo stesso Reggimento, coll’obbligo però del medesimo Instituto o dei suoi amministra
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL5 ISTITUTO ECC. 441
tori di soccombere a tutti quei pesi ai quali era soggetto il il detto Reggimento....1.
Lettera al Cardinale Origo, scritta intorno al 1720, per fa r noti g l i abusi introdotti nell’ Istituto e quello che ancora mancava per i l (¡'no compimento. 2
(Quello che manca al Compimento dell’ Instituto.
Nella Specola vi è da avvertire che anco i più intendenti architetti giudicano che possa essere pericoloso di caricarlo con travertini in quella quantità e mole che è espresso nel disegno, e siccome un siffatto improporzionato carico potrebbe nel progresso del tempo causare la di lei rovina, e con essa quella dell’ Instituto, si supplica riverentemente V. E. a voler ordinare tutte le immaginabili precauzioni per impedirla, servendosi piuttosto di stanghe di ferro che causano minor tracollo. Che, già che è indispensabile il dover stabilire un corridore attorno al rivo del muro della Specola per comodo di fare le osservazioni rispettive a tutte e quattro le regioni del Cielo, in questa pure si potranno stabilire a diversi piani, un buon numero di stanze per comodo degli osservatori; avvertendo che quelle che sono al piano della loggia della libraria potrebbero essere unite all’appartamento del Bibliotecario.
Questa essendo una delle parti più essenziali dell’Instituto, esige e sollecitudine, applicazione ed economia, essendo già da
1 Queste sinecure, costavano al Reggimento una somma doppia di quella che era stata prestabilita per lo stipendio dei professori dell’is t ituto. Troviamo in fatti fra le carte del Marsigli la notazione seguente: « La prima rendita dell’Instituto, fondata sul Monte Sussidio, è di « L ire Duemilaseicento, l ’altra rendita, che di presente non vi è, ma col « tempo sussisterà per la morte di quei che godono le cariche dalla bene- « licenza di N. S. soppresse in favore dell'Instituto, poco mancarà alla « somma di L ire Cinquemila, che unita a ll’altra di L ire Duemila e sei- « cento, avrà l ’Instituto L ire Settemila e seicento » .
2 Per rispondere alle Informazioni richieste dalla Curia Romana in ordine alla domanda di un sussidio di scudi 15.000 fatta dal Generale Marsigli, a vantaggio dell’istituto, per il Compimento delle Fabbriche,
442 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
sette anni che questa professione astronomica rimane incolta per mancanza di questa fabbrica, nonostante il così numeroso apparato d’instromenti e considerabili stipendij che si pagano al Manfredi.
Ed infine, qualunque diligenza che l’autorità e sapere della E. V. potrà commettere all’Assunteria, non sarà mai maggiore del bisogno per la sicurezza della detta Specola, risparmio, buon gusto e comodo della detta.
Il Vaso della Libraria che si occuparà, per tutta la loggia che riguarda l’orto dei semplici, non ha bisogno d’altre fabbriche che di quelle che riguardano a fare la volta e chiudere li grandissimi finestroni, improporzionati; ordinarie finestre per aumentare lo spacio da tenere le scanzie. Queste si dovranno fare con buon intendimento, come io stesso individuaré, alla similitudine di quelle della Minerva; e valersi di legname ben custoditi, che per tempo devono essere cercati, non essendo sì facile in questa città ritrovare abete e noce di vena, che siano ben tenuti.
Quest’opera deve essere unicamente fatta dall’ottimo falegname; stà nella Salicata, di faccia al Convento S. Francesco; e che esso pure fece le scanzie, non essendoci altro nella città, che sia capace di tal lavoro; che, replico, deve esser fatto, e con buon gusto e molta semplicità, andante, con le proporzionate scorniciature, e senza niun intaglio, e con due scale lumache, da collocarsi dentro delle pilastrate di legno, che saranno alla porta dell’ingresso, come appunto si è praticato in quelle della Minerva di Roma.
E perchè è indispensabile che il bibliotecario abbi il suo alloggio dentro dell’Instituto, propongo che allo stesso piano della libraria se li accomodino le due stanze che sono dentro la Specola allo stesso piano, come ho già detto di sopra.
L ’altro braccio della Loggia sovrapposto all’elaboratorio chimico, è quello che resta assegnato alli Capitali militari, che oltre i fatti, gran numero restano da farsi da me; ma. non ha bisogno d’altro che di finire la di lui volta in quella guisa che pure parte di essa si fabbricò dal Signor Dott. Rondelli, cd aprire alla parte opposta al cortile le finestre. Subito che
E. BOBTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL1 ISTITUTO ECC. 443
questo vaso sarà in istato, da me, con ogni sollecitudine si darà la mano a mie spese, a far finire tutti li Capitali, che a me costa essere mancanti, per ridurla veramente a una scuola militare, di quello che avanti dell’invento del cannone e dopo di esso si praticava e si pratica; ed infine ambe queste fabbriche, che rispettive al nome paiono gran cosa, non sono che bisognose di breve tempo e mediocre spesa per terminarle.
Il Laboratorio Chimico non ha bisogno pure di gran fabbrica, perchè sotto del Vaso per l’equipaggio militare, sta fabbricato nel sostanziale da muri e gran parte della di lui volta, bastando unicamente fare la stanza e piano della medesima loggia ben lastricata, come in forma d’arcova, che si estenda dentro del piccolo prato e che abbia una grande apertura verso l’uditorio, che esisterà nel Vaso grande. Dentro, nel mezzo della medesima stanza, vi sarà una campana ben fatta da cammino, per sotto collocarvi li fornelli. La fabbrica dovrà essere sospesa e rimessa ai voleri dei manipolatori chimici, che per lo più hanno le loro particolari maniere per questi, parte dei quali vorranno mobili su le ruote per condurli dentro anche alle volte dello stetsso prato.
Dentro la stessa Loggia vi dovrà essere un teatro di scalenate di legno ordinario che faccia fronte alla stanza dei fornelli, affinchè la gioventù studiosa, che sarà questa facoltà in grandissimo numero, possa con comodo e buon ordine per se stessa sentire l’esposizione del professore e vedere le operazioni e manipolazioni, che per un corso Chimico dureranno quaranta giorni.
Quel braccio contiguo di muraglia, che divide il piccolo prato dall’orto de’ semplici, potrà dar comodo ad un’officina che tenga, a comodo della città, medicamenti venali, e sopra stabilirli due o tre stanze massima per i manipolatori ed anco il professore, quando avesse bisogno d’assisterli con la propria persona, uno o altro giorno.
Tutte le Officine prementovate per tornire, legar libri, per servizio della Libraria, per riparare orologi, e per ebanista, stante i lavori per gli esperimenti ed instromenti e per la pic- c©la fucina, io procurarei di metterle tutte di seguito in una
444 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
linea longo la loggia, pigliando buona parte di quel sito a piano terreno dove vi è un magazzeno di legnami, facendo le loro aperture che guardijno nella loggia, e tentarei, anzi, di prolungare lo stesso tratto di sito, pigliando dentro un certo angolo di scoperto infrapposto ai SS. Malvezzi, e muro della libreria, per aver comodo da fare una stanza con banchi per disegnare d’architettura, aprendo per il di lei ingresso, la porta murata opposta all’Accademia del nudo, liberando la suggezione di quella scuola d’architettura e mettendola in vicinanza a quella del Nudo, per maggior comodo e de’ maestri e della gioventù.
L ’orto dei semplici è già da se stesso fatto, bastando ridurre il piano in un livello migliore e determinare i siti esposti a levante per i conservatorii jemali, già che non intendo che in quest’orto vi siano che le piante esotiche e provenienti dagli oltramontani, e che non ho accettato per mancanza de’ medesimi conservatorij jemali, dentro dei quali potersi mettere tuttii vasi d’esse, pretendendo che in quest’Orto, in terra, nulla si pianti essendo la città bastantemente provvista dell’Orto di Palazzo delle erbe et alberi comuni.
Per i Conservatorij, a suo tempo si daranno i disegni, non essendovi per questi molte fabbriche solide, ma con legname e posticcie pel verno, che si chiudono con vetriate lavori di paglia ed altre cose.
Infine sarà questa 1’ ultima cosa dopo le fabbriche solide, già che per questo sito devono transitare quasi tutti li materiali durante il tempo della fabbrica.
.... Secondo i miei calcoli, quando una somma economia si pratichi, dalla somma di quindicimila scudi, dopo aver fatte le consapute fabbriche e reintegrato il capitale della dote per per la libraria, alienato, come sopra si disse, vi potrà rimanere qualche danaro considerabile da intestare a prò dell’ Insti- tuto....
Istruzione al Segnor Biagio Antonio Ferrari.
.... Passarono alcuni anni, che l’Instituto era ridotto piuttosto una apparenza che una sostanza, e quando mi dolevo di ciò, mi si diceva che non avevano più denaro, e non bastava
E. BOUTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 445
che io gli dicessi che si erano obbligati di stabilire il medesimo Instituto con la loro prima richiesta a Nostro Signore, « che di più avevano a conto della mia servitù, ottenuto il secondo onorevole aiuto delle note cariche benefiche, che li Papi in Bologna dispensavano a chi loro pareva, quando adesso, morendo li possessori, il Senato ne era lui il distributore.
Per andare avanti, provvedendo in qualche parte io del proprio, levandomi, per così dire, il pane di bocca, feci fare tanti armarij ed altri capitali, a fine di impedire che le robe non deperissero ed anche facessero la sua mostra a comodo di chi avesse volutto studiare, ed anche per non far perdere d’animo l ’universale della città; le quali cose, donate che erano state, incombeva all’ Instituto di farli i comodi da conservarle, e non più a me, a tenore del convenuto.
Alla fine, sotto la legazione del Cardinale Orighi, il Senato, carico di debiti, domandò chirografi per l’imposizione di nuove gravezze per la città, per pigliare a censo contanti.
Fui curioso di investigare se fra li debiti del Senato avevano fatta menzione di quello che esso Senato ed intiera Patria avevan meco per terminare le fabbriche promessomi nell’istro- mento, giuratomi ai piedi di Sua Santità nella persona del Signor Cardinale Legato Casoni, e ne riportai dei sorrisi, quando mi dolevo.
In una tale contingenza non mi spaventai punto, ricorrendo a Sua Santità con una supplica mia, che con franchezza militare le dicevo che sotto la fede, non del Reggimento, ma di Sua Beatitudine, avevo dati così rilevanti Capitali, e che Lui ed io eravamo impegnati con tutto il mondo, e che supplicavo Sua Santità di trovare altro espediente alli miei Capitali, o di permettere che nella nota dei debiti che tiene la città, vi fossero messi 15.000 scudi, che erano debitori all’Instituto per l’Instromento prementovato, mentre tanto appunto importaveno le spese che rimanevano da farsi.
La vantaggiosa informazione che diede il Cardinale Origo sul mio memoriale, mandato da Nostro Signore a Lui per quella, se ne riportò il paterno assenso di Sua Beatitudine, purché loS.tato ecclesiastico di Bologna volontariamente avesse voluto
446 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
contribuire per questi 15.000 scudi la di lui quota; ed a pena questo da me pregato, con esemplare prestezza ed amore alle lettere gli diede assenso e consumò lo sborso.
11 Senato sin dal tempo che era Legato il Sig. Card. Origlii e per due anni quasi della legazione del Sig. Cardinale Ruff'o, in possesso di tal contante mai pose mano alle mentovate fabbriche, scusandosi meco il Decano dell’Assunteria che lui chiamava gli assunti e che non venivano, e se si parlava con gli assunti, questi si dolevano di non essere mai chiamati dal medesimo decano.
Fra queste procedure e del Senato e della Assunteria, ebbi più volte ricorso al Signor Cardinale Ruffo, e già tutta la Plebe sino di questa lentezza, dopo avere un nuovo aggravio, e gli ecclesiastici stessi più d’ogni uno gridavano, e sempre col dubbio che anche questi 15.000 scudi non andassero giù per il Reno.
Nonostante tale lentezza, che palesava un poco buon animo per il proseguimento dell’Instituto, per ragione di Stato del- l’Eccelso Senato, io mai ebbi dubbio che le fabbriche poi non si dovessero assumere, con così forti fondamenti che avrei avuto, da strillare in Roma; feci una rivista per tutto l’Insti- tuto per veliere che Capitali mancavano in esso per il di lui perfetto stato, e quali notizie mi erano necessarie, per dare raccordi come gli esercizii studiosi si dovevano praticare, e per ciò conseguire vidi che non vi era altro espediente che quello dei viaggi in Olanda ed Inghilterra per consultare con quelli eruditi ed avere da essi aiuti per la raccolta de’ Capitali bisognevoli.
Nel mio continuato stato di disgrazia della Maestà del- l’Imperatore, conobbi impossibile il viaggio per terra, di modo che mi risolsi, al primo il’Ottobre del 1721, (rimbarcarmi su nav.e inglese per rendermi ad ambi gli emporij di Londra e di Amsterdam, dove nello spazio di 22 mesi, fra viaggi e dimora, mi riuscì di raccogliere quei Capitali che appunto rendevano in uno stato perfetto l’Instituto, e di fare una raccolta d’una intera rara biblioteca, per ricompensa dell'Opera del Danubio; e che sono il fondamento delle mie doglianze, avendo veduto
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECO. 447‘
nella mia lontananza, benché si fabbricasse, tutto per il resto della disposizione dell’Instituto in disordine; e col peso della mia stessa conscienza di non commettere questi nuovi rilevanti Capitali al mal uso dei vecchi; anzi riflettendo all’ora prossima di andare davanti di Dio, di avere ricorso al mio Sovrano, Padrone dell’Instituto, se, con l’esperienza di 14 anni non fosse meglio di alienare tutti li fondi dell’Instituto, e convertirli a sollievo di tanti debiti della Città, nonché di pensare all’esito di questi nuovi per impiegarne il ritratto nelle note cause pie.
E, per essere sicuro, in questa mia agitazione della Conscienza, non ho possuto avere più sicuro ricorso che a quello del mio Principe, che ha la qualità di Vicario di Dio in Terra, perchè pensi egli al modo di meglio assicurare li Capitali, li fondi e l’uso d’essi per promuovere le scienze a gloria di Dio e del di Lui principato, o, ciò non potendo essere, per li peccati della mia Patria, che almeno tutto vada a beneficio del Popolo per altra strada; mentre per la parte che a me tocca,, tutto sottometto ai sovrani voleri di Sua Santità
Motivi delle Doglianze di Luigi Ferdinando Marsigli.
Base della fondazione è l’Instromento fra il Senato e me, e questo già fu spedito ni Signor Biagio Antonio Ferrari sotto li 22 Giugno 1725.
L ’altro dovrebbe essere quello del Breve Pontificio confirmatorio della fondazione, che io supplicai da Nostro Signore, essendolo a servire nella di lui villeggiatura di Castel Gandolfo,. e copia di quella supplica, che allora gli diedi, è annessa a questa Informazione, che chiaramente esprime la necessità che vi era che questo Instituto, per il governo e buon ordine da
farsi dal Senato, dovesse, come hanno tutte le altre cose della
Città, avere la dependenza dal Legato; e maggiore mi crebbe la necessità di procurarsi ciò, in quanto che vedevo le manipolazioni che si facevano perchè li Legati non avessero nel l’Instituto una minima ingerenza....
448 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Conservazione del Capitali.
Questa ha per base un esatto catalogo ben circumstanziato, di tutti li capitali, che non essendo stato fatto nell’instru- mento fra il Senato e me, che in una forma molto grossolana all’uso notarile, si convenne fra gli assunti e me di buona fede di farne fare con l’assistenza de’ professori uno di tale esattezza; anzi che di più si comprarono gran libri di carta bianca mercantile per farli scrivere sopra tali inventari], ed esibendosi il Signor Senatore Segni di volere lui accudire a tuttoeiò, sono 1% anni che tali libri andarono nel di lui palazzo, senza che mai più sia stato fatto nè meno il titolo ai libri, non che li inventarij.
In questo spazio di 14 anni in tutte le diverse stanze ho fatto un’aumentazione di capitali, che fa la somma poco meno della prima donazione, e perchè allora viveva il Signor Canonico Trionfetti, d’erudita memoria, mi confidavo nelle sue memorie, giornali, che di ciò poteva perchè nella di lui annua ricognizione di tuti li Capi, a stanza per stanza, ne faceva commemorazione. Dopo la di lui morte, il nuovo Presidente, di natura lento, dicendo di essere occupato per la Notomia, lasciò passare molti mesi più dell’anno, prima di dare principio a fare la di lui relazione annua di quei capitali che si fossero accresciuti o diminuiti dall'Assunteria del medesimo Instituto, perchè poi si avesse fatto la relazione convenuta fra l’Assunteria e me al Pieno Senato.
Questa Cognizione di poco ordine per li cataloghi fu una causa perchè cominciassi a pensare diversamente su l’augu- mento di considerabili nuovi Capitail per esso, che sono pronti da consegnarsi dopo d’un miglior regolamento, senza del quale, tanto il Signor Cardinale Paolneci, quanto Monsignor Lambertini conosceranno essere giusta la mia proposizione di volere più tosto far godere questo dono alla mia Patria con la vendita di questi nuovi Capitali per erogarsi il ritratto di questi Capitali alle note Cause Pie, e che tutto il rimanente anche si alienasse a sollievo dei debiti della città; perchè in tal guisa poco dopo della mia- morte tutto comincierà a smarrirsi
E. B0RT0LOTTI - LA FONDAZIONE DELL' ISTITUTO ECC. 449
senza che sul principio, fra tanta molteplicità di cose, uno se ne avveda.
Di modo che per questa precauzione non vi è mezzo termine, ma una soda sicurezza d’eseguire il concertato.
Fra li Capitali uno de’ maggiori è quello de’ Libri stampati, manoscritti di lingue esotiche e nostrane, cioè latina, italiana e francese, che si trovano nella Biblioteca, così disordinata e meno coltivata da studiosi con discredito non solo dell’ istituto, ma di tutta la città, perchè di questa gli stranieri sino nelle stampe ne hanno parlato, quasi con deriso e compassione, e come che l’importanza ne vuole una particolare classe, da tutti gli altri Capitali qui sotto la stabilisco per dimostrare le cause e quelle rimediarle.
Della Libreria.
Il primario disordine è provenuto che in 14 anni mai questa base de l’Instituto è stata provvista d’un Biblioteca/rio che sia stato capace di studii fatti precedentemente nelle parti necessarie per un cosifatto impiego; e poi perchè in questo tempo hanno cambiati tre Bibliotecarij senza che niuno di loro sia morto, ma per accomodare unicamente li favoriti dei senatori, che in loro vita mai avevano pensato ad un simile impiego; ma solo trovando questa occasione d’aver quel piccolo stipendio ricorrevano con importunità sino alla donne per ottenerlo, e poi, dopo ottenuto l'impiego, ricusare la dimora giornaliera alla Libreria, per comodo di chi volesse studiare, e loro nel medesmo tempo almeno abilitarsi a quello che non sapevano, e tenere filo di commercio con tutte le biblioteche di Europa e con i più famosi librari, e sollecitare o l’esito o la permuta dei duplicati libri, di mettere in ordine la bella officina di legatore di Libri per legare li tanti libri sciolti, che sono in essa; e che per questa ra-gione di Germania• con tanto dispendio mandai a Bologna■.
Se si faceva da me querela di ciò, si rispondeva che il salario era troppo poco, affidati da Protettori che gli avrebbero sostenuti senza che si affaticassero. Se io abbia fatti sopra
31
450 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
di ciò lamenti con l’assunteria, Dio me ne farà la giustizia, ed appunto perchè io lo sollecitavo, bastava perchè non fosse fatto nulla, e che si pensasse al contrario che dicevo, e che è la pratica che quei signori hanno per 14 aniii avuta verso di me, che se dicevo bianco ero sicuro che pensavano al nero; e senza veruna cognizione di queste materie, nelle quali io m’ero impratichito a costo del mio denaro, delle mie fatiche e d’una pratica presa in tutte le Accademie d’Europa; e sino essere arrivati a volere spendere più a far male che meno a far bene, perchè questi raccordi provenivan da me, che fui obbligato ad un silenzio, per non impedirli che se mai Dio gli avesse spirato bene di farlo, col motivo che l’avesSi detto io.
Vacò il posto di Bibliotecario, che il Senato promosse al posto di Segretario, che si doleva di tale impiego per il poco salario, perchè nella Biblioteca l'inverno vi era troppo freddo e l’estate troppo caldo, cose a me dette. Con una lettera la più umile, la più rispettosa pregai l’Assunteria di avere riflesso al dottore Bianconi, sacerdote benestante stato per tanti anni nel seminario di Padova a studiare le lingue greca et ebraica con quel profitto che qui attesta il di lui maestro Signor Dottore Fagiolati, celebre in tutta Europa, e che ha reso la lingua greca massime tanto famigliare fra li preti di questa Diocesi che la latine, per la fondazione del venerabile Cardinale Bar- berigo e cura del defunto posteriore Cardinale Cornaro e poi per il Consiglio che lasciò l’abbate Bacchimi benedettino avanti della di lui morte, nel tempo che il Senato gli diede una lettura per l’erudizione: e di più tale di lui abilità confermata dal Padre maestro Gotti; gtìacchè io non mi dò per intendente di queste lingue. Ebbi riflessione a proporre questo anche all’incombenza che tiene di custodire la contigua stanza detta dell’Antichità, per quando mai il Signor Marc Antonio Sabatini avesse voluto eseguire la sua prima idea di mettere in quella stanza la sua bellissima serie di medaglie, della qual materia non vi è neppure uno in Bologna che sappia leggere le lettere più chiare attorno di queste, nè infine che abbi una minima, ben minima, notizia della erudizione antica, perchè chi ne sapeva è morto, e chi vive non ne ha fatto un minimo studio;
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 451
e pure se venisse il caso che si volesse fare un professore dell’erudizione antica, si sentirebbero tanti concorrenti, chi protetti da Dame, chi da senatori, chi dal segretario maggiore, causa della distruzione moderna d’università, e che senza riparo sarà dell’Instituto.
Fu proposto di fare un esame dei concorrenti, che erano al numero di tre, e quello proposto da me, oltre alla latina, era, come ho detto, pratico della lingua greca et ebraica. Un altro niente di più che la latina, e conoscitore delle buone e cattive edizioni; il terzo, che è quello che ha ottenuto il posto, sempre studente delle matematiche, disse di sapere l’inglese ed il tedesco. Di queste lingue rna'i avanti di me si parlò, che l’avrei possuto giudicare, oltre che queste lingue a poco servano per un Bibliotecario.
S’approvò da tutti il ripiego dell’esame, chè materie o lingue che sono veramente necessarie ad un Bibliotecario : ma quando si sentì che l’esaminatore doveva essere il Martelli, chi si strinse nelle spalle, chi si mise a ridere, concordando tutti che per le mani di questo doveva essere rovinato l’Instituto, ed il Bianconi, per il savio consiglio di tutti li di lui amici e in Patria e fuori di Patria, si ritirò da un concorso, sentendo un esaminatore che appena sa fare un sonetto italiano, che volesse essere giudice delle lingue esotiche, che fece fare la S. Memoria di Clemente XI, per l’erudito Abbate Asémén, ma perchè riuscisse quello che è si fece che l’altro si ritirasse dal concorso, di modo che restò solo quello che si voleva e che anche resta provvisto del posto, esibendosi tutto solo che era pronto agli esami ma sapendo di non esservi chi lo sapesse esaminare in quelle lingue che lui diceva di essere esperto; si venne alla di lui elezione derogando dal proposito dell’esame, e che, nella perfezione che egli è, ne sa tanto ed è tanto capace quanto sarei io nel consiglio del Papa; e se con questo modo mai l’Instlituto nonché la parte della libreria possa essere in istato di durata e di rendere quei servigi a Dio, al nostro principe, alla Patria, il Signor Cardinale Paolucci e Monsignor Lambertini lo riferiranno a Nostro Signore, e se d'i buona coscienza
452 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
posso dare questo nuovo rinforzo guadagnato con le mie fatiche, quando non vi sia piò rimedio lo do e stabile.
Per la provvista del Professori.
Benché abbia detto molto dei disordini che sono nella scelta di questi nel precedente capitolo, ad ogni modo qui bisogna farne anche con la ripetizione del sopradetto una più diffusa informazione.
Si è stabilita la massima, fra quelli che pretendono di essere letterati in Bologna, che le letture nel pubblico Studio sia un assegnamento benefico riservato ai soli cittadini, dopo di aver fatta una conclusione sul Studio pubblico e senza relazione, come sono li statuti del medesimo, che è stata fatta, e di poi essere assistito dai senatori, non informati da quelli che sono capaci di giudicare dell’abilità loro, ma solo persuasi dalla lor inclinazione di dare non un premio alla virtù; ma un aiuto a quelli che per vivere; quando un tale senza la speranza di avere l’alimento per vivere oziosamente, avrebbe potuto applicarsi a qualche arte meccanica con più utile delle loro famiglie e non togliere ai veri eruditi il premio che dai nostri antenati gli fu assegnato. Nella nuova fondazione del l’istituto pretendono, come gli succede, che le cariche del medesimo si debbano dare unicamente ai cittadini, e senza che veruno pensi d’abilitarsi per una di quelle facoltà che in esso si professano, nè che tampoco gli senatori pensino di incamminarli con l'esortazioni e le comminatorie che, venendo le vacanze de' professori che si averebbe avuto ricorso alla condotta di forestieri, come fu praticato nei tempi antichi dentro del- l’Università con tanto utile della medesima, come sarebbe ancora se se ne pigliassero per l’Instituto, dove vi è il nuovo metodo di studiare non praticato mai per li tempi passati fuori che dalla gloriosa memoria del Signor Marcello Malpighi; atteso che, vedendo Professori stranieri che saprebbero il modo di valersi di così gan mole di capitali, si risveglierebbero, pigliando gusto per le scienze o per non vedersi levare da tali forestieri il pane, stuellerebbero, che è quello di presente non
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 453
si fa. La nobiltà che oltre all'utile de’ stipendi avrebbe il punto della gloria, questa non studia più niente, e quando dirò che, alla riserva del figlio del senator Grassi, neppure uno ci ha alli esercizii dell’istituto, dentro del quale pongono li piedi unicamente per accompagnare forestieri.
Come ho di sopra detto se domani si aprisse il concorso al professore dell’erudizione antica, dove neppure uno in Bologna vi è che ne sappia un ombra, troveranno subito più concorrenti, e chi avrà più voti nel Senato sarà il più erudito per determinazione di chi non sa neppure che sia una medaglia, e questo sarà posto in possesso della di lui stanza con tutte le cerimonie senza che sappia conoscere l’uso di quei capitali che gli vengono consegnati.
Delle Mercedi.
Si dirà che la mercede è tenue, ma terminate tutte le spese delle fabbriche non sarà tanto tenue l’assegnazione fatta dalla Santa Memoria di Clemente XI, oltre che si deve riflettere che ogn’uno di questi professori hanno unita la lettura su l’Uni- versità, ed alcuni, come il Manfredi, il Bazani Presidente, ed il Segretario, le hanno considerabilissime, e per il stipendio dell’Instituto il medesimo Manfredi favorito dai Senatori, gli furono assegnate 600 Lire, levandone 50 da tutti gli altri per farli questo stipendio, e di più si tenne per dieci anni esente dal suo esercizio nel medesimo Instituto per tenerlo occupato nella vasta ed utile opera del Reno, per la quale era pagato, nonostante la lettura dell’acque che lo costituisce in tal debito; come tirò pur sempre lo stipendio all’Instituto con universale esclamazione, ma così piaceva ai senatori e così dovette essere, con avvilimento di chi avesse voluto studiare e danno per cinquecento doppie alla cassa di una nascente fondazione.
Si convenne, senza metterlo in iscritto, fra li due savij e vecchi senatori Santini e Bentivogli, a quali si deve molto questa fondazione, perchè uno era decano dell’assunteria di Studio e l’altro dei magistrati, che quelli che si fossero distinti nell’Instituto con nuove scoperte da stamparsi, che se li sarebbe
454 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
dato aumento sulla lettura pubblica, ma tutte furono parole, per dar luogo alla passione de’ senatori che, non intendenti nè delle materie, nè dell’utile che si può cavare dall’Instituto, degni tutti, ma per la scelta de’ soggetti di capacità e d’amore alla gloria della Patria pretendono che tutto ciò che hanno sia debito di dirglielo.
Per toglier in parte il lamento alle tenuità d i (S tip en d i, m i
notai l’instromento della donazione dello Studio naturale del- l ’Indie, mettendoli per condizione di mia ricompensa che s i
facesse il calcolo di tutte le rendite dell’Instituto presenti ed avvenire, per la morte di certi uni che godono quelle cariche che resteranno alla loro morte soppresse per la beneficenza delia S. Memoria di Clemente XI a fine che fossero applicate alla Cassa dell’Instituto ; e farne una detrazione di quanto si deve per l’augmento della libreria, per qualche esperienza ed il resto per lo stipendio ai professori e farne di presente un ripartimento che dia animo a medesimi professori ed, a misura di quello che dia effettivamente, darglielo, e quello che anderà vacando ripartirlo proporzionatamente a tutti. Ma ciò fu ributtato dall’Assunteria, facendomi rispondere per il di lui segretario che non si voleva far ciò, ma tener bassi gli assegnamenti com’erano, ed avere nella loro cassa il denaro per premiare li benemeriti che si distingueranno, e per questo anche non si stipulò l’instrumento di tale donazione, importando a loro più il costituirsi sovrano che di vedere stabilita la fondazione fra sì giuste regole a loro non grate, perchè gli legavano le mani e che mettevano tutto in quel chiaro che loro non vogliono’, massima ch e è stata la rovina nella quale è la città per troppa condiscendenza de’ Pontefici.
DelP Accademia de’ Pittori.
Questa tanto per la pittura che scoltura ed architettura si trova freguentata da più di cento scolari di diverse nazioni e porta il nome di Clementina in ricognizione che la S. Memoria di Clemente XI la stabilì con tanta sua grazia, e questa è quella nella quale si vede del profitto, facendosi uomini distinti in quel
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 455
le tre arti. Li direttori di questa, che è un numero scelto, alla sorte da quella degli accademici e che con molta applicazione assistono ai studiosi d’ogn’una di queste arti, e senza che questi, ne pure abbiano mai pretesa una minima mercede, quando devono vivere col loro pennello, che per tutto l’inverno sta ozioso, la sera che impiegano a tale caritatevole assistenza.
Quando muoiono questi accademici, l’accademia ha il jus di eleggere de’ nuovi che devono essere confermati dal Senato. La Accademia presentò le di lei elezioni ed il Senato le confermò, ma poi il Segretario maggiore li pose una gabella d’un certo denaro per avere l’espedizione, la quale non si volse, e con tutta ragione, pagare dai nuovi eletti soggetti; dimostrando che loro non avevano mercede per tale impiego, che gli era di sommo aggravio, che volentieri soffrivano per servire alla Patria ma che poi non si sentivano di volere maggiormente aggravare la loro povertà col pagamento di quel denaro, col quale potevano vivere qualche giorno con le loro famiglie; di modo che nel corso di 14 anni, essendo mancato il maggior numero degli accademici canonicamente fatti, fra tali pretensioni del Martelli rimane in sospeso anzi in istato periclitante una cosa così bella e così utile.
Quando cominciai la mia stamperia con l’intenzione pure di darla all’Instituto, che non feci poi anche per consiglio di qualche senatore dell’istessa Assunteria dell’Instituto e per l’esempio di tanti narrati disordini, ricorsi ai Piedi di Nostro Signore Clemente XI per ottenere un breve per il privilegio di stampare in essa li pubblici avvisi che da Legati si concedeva a qualche stamperia in Bologna, per la quale concessione di presente li due fratelli Sassi lo godono.
Un tale utile si soleva calcolare di cento doppie annue. Quell’amoroso pontefice voleva che di presente la mia stamperia entrasse in possesso, il che ricusai per non portare la rovina alla famiglia dei Sassi, e solo contentarmi di un annua pensione dai medesimi di 46 scudi, che attualmente mi passano.
Già è noto che donai tuie stamperia al convento di S. Domenico, per la quale attualmente il convento ne fabbrica il vaso fuori di esso, e prima di partire ultimamente da Bologna, volsi consegnare legalmente questo Breve della S. Memoria di Cle
mente XI, con la condizione che, morendo li due fratelli Sassi, l ’Instituto entrasse in possesso di questo utile, mettesse all’incanto un tal privilegio per darlo a chi avesse esibito il più ; ma, prima di liberarlo, che fosse fatto sapere alla stamperia Bolognese in mano di domenicani, se loro volevano al maggiore prezzo esibito, perchè m’intendevo si avessero la prelezione.
Esibij la mia pensione, che attualmente io godo, perchè fosse impiegata alla spesa dei premij per chi delle tre facoltà una volta l’anno avesse disegnato, su l’esempio di quello si pratica in Roma, anziché di più feci fare per mano del P. Alessandro Solaroli, per distribuirsi nell’anno scorso ; ma nè l'uno nè l’altro si concluse restando il breve senza assegnazione, l’accademia sienza premij, e la ragione di ciò perchè loro avrebbero volsuto avere il Breve, e non lo darò, essendo cosa mia e da me stesso pensata, se la stamperia Bolognese in mano dei domenicani non averà tal prelezione, che non sian stabiliti li premij, e che il rimanente di tal previlegio sia assegnato precisamente ad una cosa utile dell’Instituto.
Dell’ Accademia delle Scienze.
Questa nacque in mia casa, e stando in Germania le diedi sempre tutte le assistenze. Quando si fondò l'Instituto da me si concordò che passasse per le di lei radunanze nell’Instituto, che potesse valersi di tutti li Capitali dell’Instituto per li di lei stu- dij, e dopo di tal trasporto guadagnò la fama per tutta l’Italia ambendo gli eruditi di questa d'essere ammessi in essa, comunicando le loro operazioni a questa.
Quando fui in Inghilterra, in Olanda, li più eruditi di quelle celebri Accademie mostrarono desiderio di esser a questa ammessi, ma rimpatriando e domandai il catalogo degli accademici e fra essi trovai il nome del dotto Andrea Michelli, che poco anzi andava in cavalcata a fare processi, e ne feci la perquisizione del motivo di così stravagante associazione, mi fu dimostrato che era nata da violenti comandi di senatori che, per fini politici mi fu detto li avevano data una lettura criminale nello Studio pubblico ; quando vidi questa associazione stimai bene, per sfug
456 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
E. B0RT0L0TTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 457
gire una volta qualche strapazzo degli oltramontani all’Instituto, di fare la proposizione de dieci dei più rinomati Oltramontani.
Quando fui in Amsterdam trovai una compagnia di librari che si stipulò meco di stampare gli Atti dell’Accademia di Bologna, con il regalo di un luigi d’oro per foglio al segretario e quaranta esemplari gratis, e quando credevo che una tal recognizione annua al segretario avesse dovuto stimolarlo ad operare e darmene un ringraziamento, come l’istessa assunteria, trovai piutosto sgarbi, non che gradimento, e sono due anni che il negozio resta così, con derisione di tutte le nazioni che domandano che cosa conclude un così grande apparato dell’Instituto di Bologna della di lui Aecedemia delle scienze; ed in cambio che PInstituto augumenti la gloria della nostra Patria, servir di prova dell’inabilità moderna o della disapplicazione nei cittadini, giacché forestieri non si vogliono per più tosto stare in questa derisione che continuerà, senza un pronto rimedio a tuttili disordini, giacché quando era in mia casa, era florida per migliore ordinamento e desiderio di studiare, che d’anno in anno- per li -sopracennati motivi declina e si riduce al nulla.
Prova che in Bologna non si stndij.
Sarà il rammentarsi che da 50 anni in quà non s’è veduto- uscire un opera che abbi grido, essendo stata l’ultima quella del Malpighi.
Li libri delle case private si sono venduti, le botteghe de librari sotto le scuole sono ridotte a termini, e li padroni di quelle muoiono dalla fame. Nelle librarie pubbliche, e massime in quella dell’Instituto, non si vede veruno che la freguenti, dolendosi che nell’estate vi sia caldo e nell’inverno freddo; e se sia possibile di studiare senza libri ogni uomo sano lo giudicherà.
Per comparire eruditi hanno stabilito una massima tra loro- di lodare, d’applaudirsi, di dire che sono belli ingegni, ed in fine che sono uomini grandi; non volendo esponersi mai ad altercazioni nè ai cimenti di emulazione. Li senatori che ne dovrebbero essere li giudici per distribuire giustamente li premij,.
458 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
non intendono nulla servendosi per informatore del Martelli, che dopo che diventò segretario maggiore, oltre alla di lui dottrina poetica, li furono infuse tutte le scienze, ed ancheil dono delle lingue.
La nobiltà, come dissi, non solo non attende alli studij, ma ne ha avversione, e derisione, e gli uomini di bassa estrazione, tutti dediti, all’esempio della nobiltà, all’ozio; fra i nomi de letterati di presente si mangiano quello che una volta dava lustro ed emolumento all’ordine Patrizio nobile.
Cominciai l’Instituto nell’età di ventidue anni con quella specie degli studij che si facevano nella mia Patria ed essendo stato per venti anni lontano dalla medesima, credetti sempre che vi fosse lo stesso genio e volontà di studiare come era allora ; e questo con ogni calore mi impegnai a fare, che ho fatto, ma alla fine, avendo volsuto Iddio che io resti illuminato del falso supposto nel quale ero, per tutto quello che ho rappresentato, e che conosco d’approssimarsi il tempo d’andare avanti di Dio, che è stato lui l’illuminatore per sua misericordia, « massime con gli ultimi esempi, mi sono trovato in debito, dopo -di tale cognizizone, di ricorrere al principe, o perchè tutti questi abusi per quanto è possibile siano levati, o perchè non potendosi levare, giudichi con gli esposti fondamenti se sia meglioil disfare l’Instituto, dando tutto il ritratto dei miei Capitali a beneflzo de’ debiti della città, opera con Dio meritoria per l’anima mia, e che ritira il suo premio ed effetto nell’istesso atto dell’ esecuzione.
Io sempre ringraziai Iddio ed il mio sovrano che abbia scelto mons. Lambertini dotto, probo, speditivo, e conoscitore del presente per prevedere l’avvenire, e con l'opera del Signor Biagio Antonio Ferrari essere instrutto di tutto che con molto tedio aveva dovuto leggere in questi fogli, a fine che si venghi alla deliberazione di un miglior regolamento o della soppressione.
Quando il mio riverito Signor Ferrari si trovasse rispetto al merito dell’uno e dell’altro punto in dubbio, doverà sempre ximettersi all’oracolo del Signor Cardinal Paolucci, stato Padre
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 459
di questa fondazione, come è mio particolare, antico, vero protettore e padrone, per potere rispondere concludentemente in mio nome in tutto che lui fosse dubbioso avanti di Monsignor Lambertini, che nel riverirlo in mio nome che non posso avere in migliori mani che nelle sue la mia conscienza e la mia fama.
La SS.ma Nonziata, S. Pietro, S. Tommaso d’Aquino, San Carlo Borromeo e Santa Caterina da Bologna sono li protettori dell’Instituto, e questi guideranno il mio Signor Conpadre a parlare in mio nome in tal guisa informato, come Monsignor Lambertini a difflnire, e so che la causa, come compatriota e come mio amico gli è cara.
Verbale del « Congresso » tenuto in casa di Mons. iximbertini, sopra g li affari del Signor Generale Marsìgli.
Sabato 30 Marzo (1726) fu tenuto in casa di Mons. Prospero Lambertini il Congresso sopra gli affari del Signor Generale Marsigli, et ad esso intervennero Mons. Ansidei ed il Signor Battaglini ben pratico della città di Bologna, ov’è stato molti anni in qualità di giudice, e che fu sostituto del P. Salaroli, che non potè intervenire pel dolore dei calcoli, nè fu stimato bene chiamarvi, come si era detto, il Signor Biagio Antonio Ferrari, perchè si fece la riflessione che, chiamandolo, bisognava chiamare anche il segretario del pubblico... di Bologna, e così fare, non un Congresso, ma un Contradditorio.
Nel Congresso dunque fu risoluto che non si parlasse di levare l’ingerenza al Reggimento e darla al Legato, si perchè non si ponno rescindere così facilmente le cose pattuite, sì perchè col tratto di tempo, un aiutante di camera del Legato diventerebbe il padrone dell’ Instituto,
e fu altresì risoluto di non parlare dell’esercizio dei speziali per tre anni avanti di passare all’esame, essendosi questa ritenuta un’idea non riescibile,
e parimenti fu risoluto di non parlare di levare dall’In- stituto chi forsi senza merito vi fosse stato messo, bastando il prendere le misure per il futuro, senza curare il passato,
e, perchè il Signor Generale ha detto di aver intenzione di cedere all’Instituto la privativa degli avvisi, con certe con
460 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
dizioni, di voler inoltre fare nna donazione di altri Capitali con nuove condizioni, e di volere finalmente che si metta la scomunica a chi estrarrà o libri o altra cosa dall’Instituto, quindi è che si è detto che mandi l’idea delle donazioni con i nuovi ('apitali, e che si faccia un memoriale sopra la proibizione dell’estrazione, non dandosi dal Papa questo breve senza la domanda, e non potendosi consigliare al Papa, e nè meno prendere idea di consigliarlo a confermare cosa veruna, se non si sa la sostanza del confirmando.
In ordine alle scansìe, disposizione dei libri e vaso capace
per la Libreria, si ha notizia che il vaso è destinato, che una gran parte delle scanzìe è fatta, e che l’altra si va facendo, e poi per ben sapere il tutto, si è risoluto di far scrivere per segreta informazione a Monsignor Yicelegato, come pure per sapere se si conservano bene le suppellettili.
In ordine alla alienazione del capitale di annua rendita di Lire J/00 si è detto che per ora non si parli, ma che, eseguito il rimanente, si scriva per Segreteria di Stato, che si mandino i conti di tutta l’entrata e di tutta l’uscita, volendo il Papa essere sicuro della fedele erogazione del denaro.
Finalmente si è detto che si comandi per Segreteria di Stato il fare un inventario esatto di camera per camera di tutto ciò che è uell’Iustituto, dando un termine da prefiggersi
che si restituisca la cassetta al suo loco, che vada processionalmente la compagnia del riscatto, che si eseguisca il concordato coi padri domenicani, che non si scludano dalle cariche i forestieri, che ciò si notifichi con pubblico editto, in cui ancora si
dica che non si paghi cosa veruna per la patente,che si faccia al Signor Generale l’ instromento della quie
tanza della restituzione dei manoscritti,che le chiavi si tengano dai professori, cioè da ognuno
quella della sua camera, e che le possino dare al custode per pulire le camere senza però dal restare essi disobbligati caso che mancasse qualche cosa.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 461
Lettera dì Mons. Lambert ini a L . F. Marsigli. 1
13 Luglio 1726.
.... Suppongo che V. S. sarà stata ragguagliata dal nostro comune amico Signor Ferrari, di quanto si è operato con Monsignor Lercari2, e della speranza che si ha, che questa sera parta il dispaccio per il signor Cardinal Ruffo, al quale V. E. non farebbe male a scrivere due righe, dandosi per intesa della propensione che mostrò meco in Roma, e per l’Instituto, e per Lei, della lettera della Segreteria di Stato, che in seguito della detta propensione si è procurato di far scrivere a Lui, e della prontezza che Ella avrà in fare quanto sarà comandato dalla di lui venerata persona; piacendo molto a Sua Eminenza di essere lodata e stimata, ed avendo ancora qualità meritevoli di lode e di stima....
.... I fogli da me trasmessi alla Segreteria di Stato sono succinti e conclusivi, ed avanti di darli ho voluto che passino sotto l’occhio tanto di Mons. Ansidei, quanto del Signor Ferrari, che hanno avuto la bontà di approvarli, nè vi è stata occasione d’incomodare Mons. Merlini, essendosi ritrovata ogni compitezza in Mons. Lercari.
Il Signor Ambasciatore di Bologna ha detto d’avere molti plichi, nè mai gli ha esibiti, ancorché il Signor Ferrari, per sovrabbondare in finezza, non abbia mancato di insinuargli la consegna. Io poi, che resto creditore di risposta alla mia lettera scritta a i Signori Assunti nel fine del mese di Marzo o nel principio di Aprile, non ho stimato di far altro che mostrarmi pronto a leggere, quando mi fossero stati esibiti i plichi....
1 Nella filza d’onde ho tratto questi documenti esistono parecchi interessanti lettere di Mons. Lambertini, che varrebbe la pena di pubblicare.
5 Mons. Lercari era Segretario di Stato.
462 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
IM tera di L. F. M ar sigli al Card. Ruffo, del Settembre 1726.
.... Non per avere giustizia, ma per meritare compassione, all’esempio della ingratitudine praticatasi verso di me dall’As- sunteria dell’Instituto, e con Tesservi dentro per mio maggior rammarico il Senatore della famiglia mia, si mette sotto la lettera . I / la scrittura sotto scritta « Pubblico di Bologna » con interessargli a loco a loco gli Ordini e Popolo della Città e territorio, che bisognò attendere per sette mesi e rispondergli in trent’ore di tempo, stando sull’Osteria di Chioggia, che nauseò tutta Roma; e che mi rese immutabile per l’assistenza di Dio nella rassegnazione a tutto quello fosse piaciuto a Nostro Signore, Sovrano per la Dio grazia di questa Città, e sempre con indifferenza, o per la manutenzione dell’Instituto ; o disfacimento di esso, per convertirne e gli Capitali miei, e tante Grazie di Sua Santità, a benefìzio di quei poveri dei quali nella scrittura si fa il pubblico sollecitatore in essa scrittura, senza che però essi mai del Loro abbino dato un jotta, e siccome N. Signore ha aggiunto al comando delle esecuzioni l’autorità d’aggiungere o diminuire che credesse utile, e se nel di Lei animo instrutto dall’ evidenza di quello che in Roma non possono vedere, credesse utile di replicare a N. S. che fosse il miglior partito quello del disfacimento, sono sempre sommesso ai consigli di V. E. e de’ Sovrani voleri di N. Signore, spogliato da ogni mondana passione e solo vestito del servizio dei poveri, che è quello di Dio, ai piedi del quale mi preparo di comparire, con le prove che amai la mia Patria a segno di essere indifferente a perdere ogni mondana soddisfazione di lasciare una memoria di me con il danno di un così grande numero di questi, ai quali credevo di servire con un’opera che mi ha costato il corso di tempo di 40 anni, e di tutto quello che mi ero- guadagnato fra una vita sfortunatissima e stentatissima.
La comunicazione di questa scrittura ha per oggetto anche di ottenere la permissione da V. E. di stampare e comunicare a tutti gli ordini che compongono questo sottoscritto Pubblico
1 Questa non si è rinvenuta fra le carte Marsigliane nè altrove.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL* ISTITUTO ECC. 465
con la mia lettera dovutagli di ringraziamento per lo stabilimento o disfacimento dell’Instituto ; ed anche per giustificare la mia instanza che, in veruna delle occasioni che vi dovessero essere le persone del Segretario Maggiore o li due tanto benemeriti fratelli Manfredi; che, o se ne astenghino, o che gli sia vietato; e quando questi al sommo decoro dell’Eccelso Senato fossero neeessarij, sperarò tanto nella Giustizia di V. E. che in quel caso mi sia permesso di sostituire per le stipolazioni un mio Legale mandatario, non essendo conveniente che d’av- vantaggio m’esponghi a tanti inconvenienti, che mi potrebbero essere sollecitati dalla vista d’uomini che tanto hanno operato, come a me consta, contro della mia convenienza, ed il di più sarà esposto con la riverente mia viva voce a V. E.
Nella stessa ora che sarà fatta, la stipolazione, o da me immediatamente, o mediamente da mandatario, che V. E. mi accordi la carità di lasciare per sempre questa mia Patria, statami sempre così fatale, quanto benefica la carità e clemenza de’ Sommi Pontefici, che hanno regnato durante la mia vita ragionevole, e per questo anche può essere V. E. sicura che io in ogni loco dove Dio mi condurrà, che sospirerò sempre l’occasione di spargere il mio sangue per la Santa Sede, come glorierò di aver dovuto terminare questo corso dell’Instituto sotto la direzione ed autorità di V. E....
Lettera di L . F . M orsigli al Card. Ruffo.
13 Settembre 1726.
Corrispondo con il solito mio profondo ossequio all’istanze che mi vengono fatte, che con V. E. mi «pieghi per le nuove donazioni imminenti da farsi da me, dopo che in un atto legale saranno perpetuati gli ordini sovrani di N. S. nella forma che si è trovata giusta da V. E. tutta amore per il bene di una tal fondazione che ha per iscopo la gloria della Patria ed il Servizio di Dio, informazione che distinguo nei seguenti articoli :
Le donazioni sono due: Una della Libraria scieltami in Olanda per ricognizione o regalo per l’opera del Danubio, l’al
404 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
tra verte su la Storia Naturale dell’india, che totalmente manca nell’Instituto.
In che consista la libraria appunto l’avviso d’Amsterdam di Catalogo d’ essa stampato colà, e qui ristampato per le istanze di questi letterati, che hanno desiderato un così fatto select unito insieme, ne darà a V. E. tutta l’informazione, come alla Città, in confronto della scrittura manfredianal, senza che ulteriormente m'estenda con V. E. che col di Lei sapere giudicherà se Bologna nè altre città habbino mai havuto un simile complesso di libri di tal peso, e che la sorte ha dato per la vendita della famosa libreria di Parigi del Card, del Basco, all’Haia, e, senza, di questa, in molti anni non si sarebbe fatta una tale unione dei più celebri corpi che sino d’ora le stampe abbino pubblicata.
Dunque questa libreria è tutta nelle mani del Signor Cesare Sardi Cavaliere lucchese, e che negozia così nobilmente in Am sterdam ; e che a quest’ ora sarà incassata, e che mediante un mio ordine a lui, ne farà quelle disposizioni che ordinerà l ’Assunteria, e che questa volta, munita d'un mio mandato, non avrà quelli affronti che si poteva figurare, quando da se stessa tentò, inscio me, di voler esercitare jurisdiaione sopra dei Capi tali congegnatili da me, come mio mandatario legale in una tal Piazza, dove la pontualità nell’ordine e mezzo del negozio è aH’ultima perfezione, senza riguardo nè meno a teste coronate, nonché ad una Assunteria di Bologna, che colà, assicuro V. E. non sanno che cosa sia, ridendone fra loro.
Questo mio mandato sarà posto ai Piedi di N. S. consegnandolo legalmente a V. E. che lo rappresenta, dopo che sarà giurata l’osservanza dei Punti nuovi per il regolamento migliore dell’Instìtuto....
.... Per la Storia Naturale Indica, nella scrittura manfrediana descritta: « Quattro uccellini, farfallette, ed un mazzo di Canne d’india... », in Bologna sarà ritornato quel catalogo che si mandò a Roma, che vedutolo e consideratolo, con l’atte-
1 Si riferisce a quella sottoscritta : « Pubblico di Bologna », d i cui nella lettera precedente.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 465
stato di più del famoso Vallisnieri di Padova, che poco prima l ’aveva veduta in Bologna, vollero che per credito della Patria tutta, promettessi di non pubblicare un sì fatto attestato, in confronto dello scrittosi dal Manfredi, a nome di cotesto Pub blico, che si vanta d’avere un scielto d’ uomini di profondo sapere....
IM tera del Vallisnieri al Marsigli.
16 Marzo 1726.
.... fui dipoi condotto dal Signor Dott. Giuseppe Monti a vedere le Cose Naturali delle Indie, che ancora tumultuariamente in sua casa si conservano, e che S. E. il Signor Generale Marsigli aveva portato da Amsterdam, dalle quali restai sorpreso per la .copia, bellezza e rarità delle medesime, che da se stesse ponno formare un intero museo, di cui in quel genere non sarà forse il secondo in Italia, possendosi chiamare un tesoro pellegrino, portato in Bologna per illustrare la medica e naturale storia ed osservare nel mondo vecchio in uno raccolto il più scelto di quello nuovo, ammirabile Mondo, stimandoio assai più questa giunta, per la difficoltà di ottenerla, che quesi tutto il resto che vidi nell’Instituto.
In fede di che,
A n t o n io V a l l is n ie r i , Pubblico Prim. Profess. ecc.
Convenzione stipulata col Reggimento di Bologna.
Die 21 Martii 1727.
Congregatis Illustrissimis DD. Reformatoribus Status Li- bertatis Civitatis Bononiae in numero XXVIII. in camera Eminentissimi et Reverendissimi Domini Cardnalis Legati, in ejus presentía, et de ipsius consensu et volúntate inter ipsos infra- scriptum Partitura positum et legitime obtentum fuit, videlicet.
Omissis....
32
MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
III.
Di promettere che uè il Sign. Segretario Maggiore pio tempore per li Partiti delle Aggregazioni ai posti vacanti nell’Ac- cademia Clementina, nè il Cancelliero che prò tempore servirà all’Assunteria de l’instituto per le relazioni dei concorrenti o nominati ai posti suddetti dell’ lnstituto, non potranno mai pretendere o ■conseguire da uovelli Aggregati, che potranno essereo cittadini o forestieri, i quali non saranno esclusi dalle Cariche di detta Accademia, mercede o ricognizione alcuna, a tenore anche de’ Chirografi di rinunzia di tali emolumenti fatti dal moderno Signor Segretario Maggiore Dottore Pier-.]acopo Martelli sotto li 19 Giugno 1726, e dal moderno Segretario dell’As- sunteria delFIstittuo Dottor Gabriello Manfredi li 28 Agosto 1726.
IV.
Di assegnare ed obbligare anche con le clausole di Cessione di Ragioni, patto del Constituto, speciale e privilegiata Ipoteca ed in ogni miglior modo che di ragione far si possa, un’annua somma di Lire Quattrocento degli effetti, che in maggior somma si ricavano, dall’annuo fitto delle Fosse della Città, per dote ed assegno della Libraria dell’istituto, e di obbligarsi come sopra ad erogar queste annualmente in perpetuo a comodo e per uso e mantenimento della Libreria suddetta.
V.
Di stabilire e destinare al Signor Presidente prò tempore dell’istituto il luogo dell’Abitazione nel Palazzo dell’istituto, e di consegnare al medesimo un duplicato di tutte e ciascuna le chiavi delle Stanze de’ Signori Professori, da restar presso di lui o suoi successori, e di ridurre l’Uffizio di Custode del Palazzo dell’istituto in tutto e per tutto ai termini che vengono prescritti nelle Constituzioni di esso Istituto, fatte li 12 Dicembre 1711 e confermate con Breve di Papa Clemente XI° di felice memoria 12 Giugno 1715 al Cap. XIV.
VI.
Di promettere che qualunque volta il Sign. Generale Marsilli ottenesse dalla Santità di Nostro Signore un Monitore di Scomunica contro gli estraenti qualsivoglia cosa dall’istituto, essi Signori Assunti lo faranno pubblicare ed affìggere per maggior
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 467
■cautela dell’istituto medesimo, e di tutte le suddette cose di promettere l’osservanza nella migliore e più valida forma che far si possa, anche mediante giuramento e coll’obbligazione de’ Beni dell’istituto medesimo.
Lettera datata 7 Gnigno 1727 di L . F. Marsigli, al Senatore Alessandro Marsigli.
Nel tempo stesso che per mezzo del Signor Avvocato Danzi faccio sapere a V. S. 111.ma pronta la mia mossa da questa città, da me tanto malamente stata servita, perchè esiga da Lei la restituzione di quei fogli che sono il fondamento del mio credito con la Corte Cesarea, che depositai nelle di Lei mani partendo per Inghilterra ed Olanda, e che unitamente restituisca in mio nome a V. S. Ul.ma, come il più vecchio, dopo me, de’ nostri Rami de’ Marsilli, l’armi gentilizie della Casa, che per tanti anni, e massime nel tempo delle mie fortune, mi fu senza dispiacere permesso di servirmene; atto che sarà autenticato con l ’effettiva frazione d’uno di quei molti che resteranno sepolti nell’Archivio di S. Domenico, essendomene composto uno proprio a me, che mi servirà sino alla morte, in alleviamento di quel disavvantaggio che le mie prementovate sventure hanno prodotto alla loro nobilissima discendenza.
Dopo che saranno terminate certe disposizioni che impediranno il disordine che potrebbe seguire con la mutazione del Cognome, sarà ancora questo atto egualmente dei sigilli eseguito.
Quando l’eccessivo amore di questa Povertà di Bologna verso ■di me non mi avesse trattenuto, come è noto a tanti uomini savij, avrei fatto lo stesso passo di dimettermi dalla cittadinanza di questa mia Patria, per secondare il genio di questo Eccelso Senato espresso per mezzo dell’Assunteria dell’Instituto delle Scienze ed Arti, dove V. S. Ul.ma è uno degli Assunti, con la sottoscrizione ad essa « Il pubblico di Bologna » presentata <lal loro Ambasciatore nella corte del nostro comune Sovrano e che sarà a suo tempo nota ai vivi ed ai posteri; affinchè in me stesso imparino.
Il medesimo Sign. Avvocato annuncierà a V. S. Ul.ma che
468 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
lui, ad ogni di Lei richiesta, sentirà quello che della mia porzione paterna fossi debitore nella lite comune, col Sig. Silvio Marsilli, per dovermene dimettere con una somma ubbidienza alla Giustizia del Principe, che in breve sarà informato di quello che per 19 anni ho tenuto celato.
Queste mie espressioni V. S. 111.ma vorrà far passare al Signor Marchese Giorgio di Lei fratello, come al Signor Conte Filippo, ed al di lui figlio d'età capace d’intendere tutto ciò, e col mio profondo rispetto sono,
DI Casa li 7 Giugno 1727.
L u ig i F erd in an d o M a r s il l i
C o m m ia t o
A tutti gli Ordini della città di Bologna
Volle l’Onnipotente, ch'io pigliassi la condizione umana fra Voi altri, in tempo che le Scienze e le Arti erano l’occupazione maggiore degl’ingegnj nobili e civili ; e ch’io stesso ne godessi l’esempio fra le Scienze appunto e fra le Arti liberali, sotto la disciplina de’ più esperti Maestri, in quel tempo felice in cui questa Università, e massimamente l’Ordine Nobile, con tanta applicazione se ne approfittava.
Nell’età mia pertanto di diecinove anni abbandonai il tetto paterno, per cercare nella mia geniale vocazione alla Milizia aumento di credito, il che a volo mi riesciva, sempre però fra le vicende di buona e avversa fortuna ; e quel vantaggio che io ne incontrava, lo riconoscevo per un frutto degli insegnamenti che mi erano stati dati nelle Università di Bologna e di Padova.
Nel tempo poi che io rifletteva a questo debito, pensai sempre al modo di pagarlo; e però piacque a Dio, che dopo due anni di servizio in attuai guerra contro i turchi, sotto le gloriose insegne di Leopoldo Cesare, mi risolvessi a stabilire nella Patria un Capitale Instruttivo alla Nobiltà della medesima, per tutti quegli Studi che potessero spianar loro la strada a facilmente apprendere i fondamenti necessari, per incammi-
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL* ISTITUTO ECC. 469
Darsi alla milizia in aumento del Lustro delle loro famiglie, a gloria della Patria, e a beneficio ancora della Religione, la quale restò così bene con l’armi servita, nella gran Guerra di dici- sette anni contro de’ turchi.
Questo mio descrittovi oggetto, fu il principio di quell’Insti- tuto che ora possedete per la grazia di Dio, e per la beneficenza della Santa memoria di Clemente XI, poiché avendo io posto ai suoi piedi, volle col suo grande intendimento e col bel genio per le scienze e per le Arti, non ostante i molti disturbi che patì nello Stato ecclesiastico, promuoverlo con tante benemerenze, ed anche in forma piò estesa di quello primo embrione; perchè appunto, vivendo io ancora sotto le tende, pensai che bisognava ampliare una tal formazione a beneficio della Storia Naturale, delle Matematiche, e della buona moderna filosofia, in modo che ognuno avesse potuto in esse approffittare con l’evidenza di Capitali, che gli avessero insegnato egualmente per gli occhi, che per le orecchie.
Per giungere dunque a questa perfezione, non risparmiai nè fatiche nè spese, nè congiunture che anche fuori delle mie forze avessero potuto farmi arrivare all’ideato mio fine.
Vi è noto quali e quante avversità della fortuna mi occorsero, per dovere probabilmente dubitare del fine, che a raccontarvele solamente vi obbligherei a fondervi in lagrime, e per questo passo sotto silenzio in questa mia lettera i miei sofferti disagi. Posso dirvi della mia costanza in volervi servire con tale fondazione, per rendere questa Città, se non superiore, almeno eguale alle maggiori moderne Università e Accademie di Francia, d’Inghilterra, dell’Olanda e della Germania, unendovi un Complesso, ch’esse certamente fino ad ora non hanno, come l’inventario generale di sì fatti Capitali, depositato all’Archivio di S. Domenico; ad ognuno di voi lo paleserà, con una ordinata suddivisione, ogni qualvolta vi compiaceste di volerlo leggere, con le necessarie precauzioni.
Pensai che lo stabilimento e l’esercizio di questa mia idea, dovesse essere appoggiato a questo Senato, col quale capitolai, affinchè fosse da esso destinata una perpetua Assonteria di sei Senatori, che in vita presiedessero a tale governo, acciocché essi
470 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
vieppiù sempre, accrescendo nell’amore ed esperienza verso tale mia fondazione, la rendessero anche più profittevole, e l’aumentassero in beneficio Vostro, come altresì di tutte le Nazioni del Mondo.
Per assicurare la durata di tale impresa, non ho mancato, o miei riverenti Ordini, che componete questa Città, di ricorrere agli aj uti che mi sono stati permessi contro a tante opposizioni, che leggerete nella Unione di questi Atti Legali, che ho stimato di pubblicare, perchè negli Archivi di tutte le Università, sia custodito un Esemplare, che possa istruire i nostri successori di quel buon cuore ch’ebbi sempre, di rendere alla Città di Bologna, ciò ch’Ella mi diede ne’ miei studij, quando ero io in età così tenera, e così giovanile. E perchè ancora, vedendo io non succedere in tutto prospera l’amministrazione di un corpo così erudito, e così illustre sì nella mia Patria che nell’Italia, non abbiate Voi a dolervi ch’io non avessi pensato a tuttociò ch’era profittevole, che l’esempio di tant’altri disordini, che sono stati gli Autori della moderna decadenza in cui al presente è la Città di Bologna.
Si comproverà la verità di quanto Vi espongo nel prementovato Archivio di ¡S. Domenico, dove vi sono Volumi di queste proposizioni, che a Dio sono note se ad altro tendevano, che al servizio di Lui e di tutti voi altri; che raccomanderò a Dio; e alla Oran protettrice del medesimo Instituto Maria Vergine nel mistero della Incarnazione, giorno a me felice, perchè in quello fui redento dalla barbara schiavitù dei Turchi.
Con questi sentimenti Vi lascio, e vado a trovare il mio ideato Sepolcro, cosa, che spero sia per essere di maggior quiete alla poca vita che Dio vorrà concedermi, e di mezzo alla mia eterna salute ; giacché, nell’avere a Voi altri servito, col frutto delle fatiche d’una vita così stentata, com’è stata la mia, non ho potuto incontrar l’universal gradimento: e perciò per quelli pregate Dio, e con l’aiuto de’ Santi protettori vostri, invigilate alla manutenzione di questo Instituto delle Scienze e delle Arti, tanto acclamato nell’Europa, e siate disposti a rendere a me la giù stizia che, se perirà, non sarà stato per mia inavvertenza, dopo che risolsi di darne l’amministrazione a questo Reggimento.
E. BORTOLOTTI - LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 471
Raccordandovi che la proprietà di tanti Capitali è tutta vostra, e come vostra la dovete raccomandare a Dio ed al principe, restando a me il peso di ringraziare specialmente gli Ordini Ecclesiastici Regolari e Secolari, per quel prontissimo assenso che prestarono sulla somma di quindicimila scudi, per cui supplicai ultimamente la santa memoria di Clemente XI con li favorevoli uffici del Signor Cardinale Origo, allora Legato di questa Città, acciocché si effettuasse il totale compimento del medesimo Instituto: e, sentendo la mia morte, degnatevi di corrispondere a questo mio buon cuore, che per voi ho conservato constante fra la buona e la avversa fortuna, con raccomandare tutti l’Anima mia al Supremo Giudice; e cordialmente v’abbraccio.
Il vostro cordialissimo concittadino
L u ig i F e rd in an d o M a r s il l i
E o to re B o r t o lo t t i
L. F. Morsili a Parigi.
Il conte Luigi Ferdinando Marsili, dopo la sua condanna del 18 febbraio 1704, ricorse alla protezione del re di Francia Luigi XIV, e andò a Parigi nel 170G per ringraziare il sovrano di avergli restituiti gli onori militari, dei quali era stato degradato. Il re ed i ministri lo accolsero colle più onorevoli testimonianze di stima e di clemenza. Le osservazioni che egli fece durante il suo soggiorno a Parigi sono notate in una vaechettina autografa, intitolata : Osservazioni diverse erudite fatte a Parigi e MonpUlier (Montpellier) da I (ìen. Mar siili nell’anno 1106, ed anche: Libro delle mie anotazioni in Parigi (voi. 84 A).
Al Louvre il conte Marsili osservò « l’ornato dell’architettura » e principalmente « la nuova facciata, fabbricata da mon- sieur Colbert », chiamandola « una cosa moderna, bella e di buon gusto ». « Nel Louvre (egli scrive) vi è il giardino detto le Tui- leries, consistente in allées e parterres, fatti con piccolo busso, in vari disegni di fogliami, arabeschi, e nel mezzo il terreno per fiori. Nel rimanente, fuori dei recinti di bussolo, il terreno è tutto coperto d’arena ed ornano le allées del vero orto con arbori di busso elevato a piramide, a globi ed a varie figure, tagliati con forbici e sono galantissimi. Hanno boschetti di vari albei'i a Versailles, ove sono apparati di siepi e di tasso alte due nomini ».
Il Marsili conversò coll’Aubéry, medico del Duca d’Orléans, che gli diede una lezione de’ suoi principii chimici. Visitò il Seminario, o Collegio delle Quattro Nazioni, fondato dal Cardinal Mazarino, «d’assai buona architettura », e la Bastiglia, si
32
474 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
tuata alla porta di S. Antonio, co’ suoi « torrioni rotondi » e muri altissimi. In essa «v i sono arsenali, fonderia e prigioni». Ammirò l’architettura dell’abbazia di Saint-Germain, della quale scrive che « è una bella fabbrica. Vi è il Padre Mabillon, autore del De re diplomatica e degli Annali di S. Benedetto ». Indi prosegue : « Ho veduta una fontana, con figure in marmo di mezzorilievo, che stimo la migliore scultura di tutta Parigi ».
A Versailles osservò nel palazzo l’entrata di un « cortiletto con due ali guernite di busti antichi d’imperatori; ma meschina come le scale. Vi è una galleria con tutti i muri di specchi, statue, urne antiche superbissime, ed è con la volta dipinta dal Lebrun. Questa galleria è cosa reale. I gabinetti del re sono tutti di specchi, con ornamenti di legno e stucchi dorati; altri con tappezzerie, quadri de’ primi maestri d'Italia in abbondanza. Le scale sono meschinissime. La facciata dalla parte del giardino è bellissima. Nel giardino vi sono vasi di marmo di Carrara, con bassorilievi bellissimi; statue di bronzo e di marmo. Le stalle sono magnifiche e quasi la più bella cosa. L ’acqua vi è condotta con arte e dispendio infinito. Le suppelettili sono immense nel numero e nella riechiezza».
« I gabinetti del Delfino sono magnifici e di gusto. Uno per le pitture dell’Albani, e l’altro tutto di specchi che coprono le pareti ed il soffitto. Vi sono attaccati certi modioncini, che sopportano vasi di cristallo di rocca, di porcellana, e piramidi di vasetti di agata e simili pietre. Confesso che questo gabinetto mi è sembrato una cosa galante ».
Vide pure il gabinetto delle medaglie del re, « costruito in figura sessaugolare », cinto all’intorno da un armadio alto tre piedi, « entro il quale sono le cassette delle medaglie. Sopra questo armadio vi sono ornati di specchi, modioncini e piedestalli che sostengono statuette di bronzo, vasi di cristallo e d’agata. Nel mezzo del gabinetto v’è una tavola che assomiglia a un armadietto, con piccoli tiratori, dove sono tutte le monete curiose e medaglie coniate sino al giorno d’oggi. I cammei di pietre Sua Maestà li tiene dove sta a scrivere, divertendosi a vederli da sè, e disposti pure con egual ordine delle medaglie ».
L. FRATI - L. F. MARSILI A PARIGI 475
Dice il Marsili d’avere udito cantare il Te Deum nella cattedrale di Nótre-Dame, « chiesa gotica », dove vide 1’« Arcivescovo Cardinale tovaglia (Noailles), mitrato, tutti gii arcivescovi, il Cancelliere di Francia, che sedeva in sedia da braccio senza appoggio di dietro, ed aveva il cuscino di velluto per inginocchiarsi. Alla sua destra aveva il Consigliere di stato, in robba negra. Attorno a loro, a destra entrando eravi il primo Presidente di Parigi ed i Consiglieri vestiti di rosso, con stole guer- nite d’ ermellino. La musica era indegna ».
Nell’Osservatorio il Marsili esaminò gli strumenti, cioè: « i ■quadranti, sestanti, e cannocchiali ». Eravi « il cannocchiale che si gira sull’asse d’un trepiede di legno, che resta immobile nella meridiana, ed il cannocchiale che si eleva, si abbassa, e si gira secondo il bisogno, essendo posto sopra un canale di legno ».
Gli mostrarono il pavimento d’una stanza dove era un emissario disegnato, « che vanno mutando secondo le osservazioni ».
Il figlio del celebre astronomo Cassini gli mostrò il suo trattato per elevare il piano della meridiana di Parigi e determinare così la distanza di tutti i luoghi a questa meridiana.
Il 29 gennaio 1706 il Marsili volle vedere la coltivazione dei funghi usata in Francia e ne scriveva a lungo. Poi visitò il celebre botanico Giuseppe Pitton di Tourneport (1656-1708) per vedere il suo gabinetto, « che consiste in pesci, conchiglie, coralli, fossili e frutti delle Indie (massime dell’America) e piante secche». Quanto ai pesci «ha cose buone; ma non straordinarie ». Avea una « serie assai bella di tartarughe, frutti, droghe e semi bellissimi».
Tra i fossili il Marsili vide una specie di smeraldo e topazio tubolare, quadrangolare, che cresce nei monti dell’Alvernia, e di questa pietra il sig. di Tournefort gliene donò alcuni pezzi. Avea pure una serie perfetta di conchiglie, che sorpassava quella raccolta dal Marsigli. Per i coralli, a riguardo dei colori, fuori del turchino, ne avea di tutte le sorte immaginabili. Di piante marine avea pure una bellissima collezione e molte trovate nel territorio di Parigi. Tra le altre alcune Echiniti, che nell’interno aveano pietra focaia nera.
476 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Il Pitton occupavasi allora del suo viaggio in oriente, ed avea intenzione di pubblicarlo nella prossima estate; ma invece uscì al pubblico solo nel 1717. Gli disse che il territorio di Parigi abbonda di vetriolo, e che l’Orto botanico avea 3800 piante. Pre- tendevasi che fosse più considerevole di quelli di Londra e di Amsterdam.
L ’Hôtel (les Invalides parve al Marsili « sontuosa, cinta di fosso muragliato. La facciata è nobile; il cortile maestoso, con portico. La chiesa mediocre nell’interno; ma nell’esterno sontuosa per la bella cupola di piombo e dorata in certi luoghi. Le scale sono comode, i corridoi laterali e le stanze e la disposizione dell’abitabile è confusa, oscura e malintesa. Tutto l’interno non corrisponde alla magnificenza della piazza, della facciata e del cortile ».
Il Marsili visitò pure il Gabinetto delle statue antiche e moderne di Francesco Girardon. « Questo è il miglior statuario (egli scriveva) ed è quello che ha fatto la grande statua a cavallo del Re, in bronzo, nella piazza di Vandòme, che credo sia ora al mondo. Ha fatto molti lavori a Versailles ed effettivamente è buon maestro ».
Giovanni Méry, eccellente anatomico e chirurgo, mostrò al Marsili nel suo gabinetto lo scheletro d’un bambino di nove mesi, die visse alcune ore, e che era senza cervello e midollo, coi nervi provenienti dalle localizzazioni ordinarie, « cosa che fa battere il capo nel muro (egli scriveva) a riguardo degli usi attribuiti al cervello ».
Il Marsili visitò pure le Accademie di Parigi, e dice che la. scultura era superiore alla pittura nella qualità e nel numera delle opere.
Dopo essere stato un mese e mezzo a Parigi, prese congedo dal re di Francia, che disse ai suoi ministri: avete osservato quello elle è uscito f Esso è il conte Marsili-, che tanto ha servito la casa d’Austria e così ingiustamente fu degradato per l’affare di Brisacco. Quanto grande sia stata questa ingiustizia lo so
molto bene.L ’Accademia reale delle scienze di Parigi diede al Marsili
testimonianza di alta considerazione mediante la seguente let-
L. FRATI - L. F. MARSILI A PARIGX 4 7 7
tera autografa del suo segretario perpetuo Fontenelle il 13 mag- gio 1705 :
« L ’Académie Royale des sciences de Paris a reçu votre lettre datée de Lug, du 0 Mars. Elle a été bien aise d’y trouver votre apologie et elle l’a lue avec plaisir. Il ne lui appartient pas de juger les souverains, et elle se tien surtout ce qui les regarde dans le silence et dans le respect ; mais comme il y a longtemps qu’elle connoist votre capacité et pour la guerre et pour les sciences, elle sera toujours fort disposée à croire tout ce qui vous est le plus avantageux. Vous l’obbligerez fort, Monsieur, de vouloir bien entretenir avec elle votre ancien commerce sur les matières de sciences, et principalement sur la géographie, où vous avez fait des découvertes particulières; tout ce que voua lui mandez sur le position des montagnes de l’Europa, lui a donné beaucoup d’envie d’en être instruite plus à fond; elle profitera avec plaisir de vos lumières et y joindra les sciences. Je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur
F o n t e n e l l e » . 1De Paris, ce 13 mai 1705.
L odovico F r a t i
La Stamperia (li L. F. Marsili.
Il noto cronista Anton Francesco Ghiselli narra, sotto il 170i)r che recatosi a casa del Generale Luigi Ferdinando Marsili, vide «una stanza con i torchi pei- far stampare ogni sorte di carattere, anche delle più remote parti del mondo » ; e poco dopo aggiunge che vide anche « una stanza con libreria di circa trenta casse di libri eletti, di quali, nota il cronista, se potrò darò nota ; intanto dico che sono di tutte le lingue più straniere, araba, turca, greca, ebrea, caldea, persiana, indiana et altre, con tutti i loro caratteri per stampare » . 1
Appar chiaro che da lungo tempo il Marsili aveva raccolti questi materiali tipografici dei quali evidentemente intendeva dotare la nuova istituzione che egli stava (per fondare.
La donazione di tutta la mirabile e copiosa suppellettile artistica, scientifica e letteraria, avvenne, come è noto, nel 1711, e i relativi atti furono allora pubblicati e ristampati più tardi. 2 Ora, al capo V i l i de Capitoli della Donazione fatta dal Marsili al Senato bolognese leggesi : « L ’illustrissimo Senato non permei terà mai che alcun capitale donato dal signor Generale sia tra
1 Vedasi la Cronaca del Ghiselli nella Biblioteca Universitaria di Bologna, al voi. L X X IV (errore per LX X V ), pp. 44-45. I.a indicazione m i è stata favorita dal prof. Em ilio Lovarini.
2 . i t t i legali per la fondazione dell’ Instituto delle scienze ed arti liberali per memoria degli ordini ecclesiastici e secolari che compongono la città di Bologna. Bologna, nella Stamperia bolognese di San Tommaso <TAquino, 1728. E ’ il primo strumento « Instrumentum Honationis » etc.
480 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
sportato fuori dalla Casa dell’lnstituto..., anzi prendendo a cuore l’illustrissimo Senato l’accrescimento di questi capitali, si riserva a tempi più felici di augmentarli, e particolarmente il capitale della Stamperia ». Il materiale tipografico era dunque, nello stesso annno 1711, stato portato dalla casa del generale nelle sale dell’istituto, in attesa che fosse messo in funzione e potesse dare i desiderati frutti.
Scorrendo gli Inventari delle cose donate al Senato e collocate nel palazzo dell’istituto, in via San Donato, possiamo vedere in che consistevano questi « capitali » per la stamperia. Fra gli altri, infatti, c’è 1’ « Inventarium typographicum, hoc est characterum et aliorum octo capsulis ligneis in varia locula- menta distinctis contentorum, quibus typis olim mandatus est Prodromus Operis Danubialis » *. Delle otto casse, cinque contenevano i caratteri in piombo del così detto Tento grosso, le altre tre i caratteri del Cannoncino, carattere corsivo: le prime erano del peso di circa 220 libbre, le altre del peso di libbre 126; nel complesso libbre 353 ed oncie una. Ai caratteri si aggiungevano « quaedam laminae tenues ex auricalcho prò compositione chara «terum ad impressiones num. 54 et ponderis in totum lib. 5 ». 2
Da quanto sopra appare che la tipografia marsiliana funzionava già prima del 1711, giacché nell’inventario si dice che con quei tipi che egli donava all'istituto era già stato stampato il Prodromus operis danubialis, uscito infatti senza data, ma che ora si può affermare essere anteriore al 1711, o almeno non posteriore a tale anno. Guardando a quella produzione, che molto probabilmente è la prima uscita dalla tipografia marsiliana, possiamo farci un giusto concetto del genere dei caratteri dalla tipografia posseduti.
L ’intenzione del Marsili, che la stamperia assurgesse a maggior importanza, risulta chiara dalla stessa convenzione della
1 Inventaria rerum omnium illustrissimo et excelso S em tu i Bononiae ab illustrissim o et excellentissimo v iro D. Co. Aloysio Ferdinando de M arsiliis donatarum in gratiam novae Seientiarum Institutianis. S. a. n. t.
2 Questo inventario è posto verso la fine del volume, e precede quello della Libreria. Si compone di una sola carta.
A. SORBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 481
donazione; e poiché probabilmente il Senato non potè destinare ad essa i fondi che erano necessari, e d’altra parte perchè nei locali dell’istituto, già subito occupati per il meraviglioso sviluppo delle cattedre di scienze, delle scuole, dei musei, non eravi posto sufficiente per un grande e decoroso impianto tipografico, il generale Marsili pensò egli stesso alla costruzione di un locale adatto, non lontano dall’istituto e da questo dipendente. La notizia ci è confermata e illustrata dal P. Pellegrino Antonio Orlandi in un suo manoscritto intorno allo sviluppo della tipografia in Bologna che conservasi nella Biblioteca dell’Archiginnasio a cui pervenne insieme al fondo Hercolani ’ . Dice appunto l’Orlandi, sotto l’anno 1719: « In quest’anno è terminata la fabbrica d’una nuova Stamperia, la quale medita il signor conte e generale Luigi Ferdinando Marsili di erigere a benefizio e vantaggio del nuovo Instituto delle scienze, da lui eretto e fondato col famoso dono fato all’Eccelso Senato di Bologna d’un’infinità di libri e di altre cose preziose, come dall’Instromento di donazione pubblicato alle stampe da Costantino Pisarri. In questa sono già eretti quattro Torcoli a tutta perfezione, con tutti i materiali et utensili necessarii, posti all’ordine per stampare libri e tirare rami. E per intagliare i polzoni, formare le matrici e fondere i caratteri sulle forme più belle d’Olanda e d’ogni altro paese oltramontano, ha condotto Monsù Antonio Keblin nativo di Bisanzone, eccellentissimo artefice, il quale di presente travaglia a misura delle commissioni che dall’autore sopradetto gli sono suggerite in absenza del signor conte Generale, che si trova in Roma, ove si spediscono l’opere che fa, le quali sono clementi» simamente gradite dal N. S. il quale gode in vedere in Bologna instituita sì bella stamperia » 2. La fabbrica dovette essere costruita in via Centotrecento.
1 Ms. B. 252. I l manoscritto dell’Orlamli ha il titolo, non del tutto esatto rispetto al contenuto : « Origine e progressi della Stampa dall’annoM COCCXXXXII sino al MDOCCXIX ».
3 A pagg. 128 e 29 del Ms. B. 252 della Biblioteca comunale dell’Ar- •chiginnasio. — Cf. G u i d i c i « , Cose noi., I, 393.
482 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
La grande simpatia che il papa aveva per il Marsili e il conto in cui teneva la nuova tipografia, della quale, come ci attesta l’Orlandi, nel passo sopra riportato, il pontefice ammirava i saggi, indussero lo stesso generale Marsili a chiedere, a beneficio della « Stamperia bolognese », la concessione di privativa (ovvero il privilegio) di stampare e distribuire « Avvisi », ossia giornali, e Relazioni e pubblicazioni periodiche di qualsiasi natura ; concessione che il pontefice si mostrò tosto pronto a concedere.
Ma c’era un guaio : fino allora tale facoltà di stampare « avvisi », relazioni e giornali l’aveva sempre goduta la tipografia dei Sassi, antica e stimata. Il Generale Marsili, per non togliere ad essi una tale attività e, d’altra parte, per recare un beneficio ugualmente alla sua stamperia, si accordò coi fratelli Carlo Alessio e Clemente Maria fratelli e figli di Giovanni Antonio Sassi, che allora dirigevano la casa tipografica, lasciando loro una tale niziativa, finché vivessero, col patto però che essi dovessero versare ogni anno, in due rate, a beneficio della stamperia marsi- liana, duecento lire bolognesi. Tali patti furono conchiusi il 5 maggio dello stesso anno 1719, cori questo documento:
« Sperandosi quanto prima dalla suprema beneficenza del Regnante Pontefice Clemente XI, la speciale Grazia, e Privileggio privativo ad ogni altra Persona, Università, e Collegio, ed a solo comodo, e favore della nuova Stamperia Bolognese erretta da Sua Eccellenza Sig. Conte Luigi Ferdinando Generale Marsilli in questa Città di Bologna, a piedi dell’umilissime suppliche, per parte di Sua Eccellenza porrette a Sua Santità, di poter imprimere, ed estradare gli Ebdomadali Avvisi, ed ogn’altra Relazione, soliti distribuirsi in questa Città, per errogarne l’Emo- lumento da ricavarsi a comodo, e mantenimento dell’lnstituto delle Scienze, Opera anch’essa riguardevolissima di Sua Eccellenza in questa Patria; ed essendo stati, tanto per il passato, come di presenti detti Ebdomadali Avvisi, e Relazioni impressi, ed estradati dagl’infrascritti Signori Fratelli Sassi pubblici Impressori in questa Città, e volendo Sua Eccellenza Signor Co: Luigi Marsilli, non ostante, che la detta Grazia, e Privileggio sia per farsi come sopra a comodo di detta Stamperia, ed Instituto suddetto, che però un tale Esercizio d'imprimere, ed estradare
A. S0RBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 4 8 3
detti Ebdomadali Avvisi, resti nelle Persane di detti, ed infrascritti Signori Fratelli Sassi, sotto le Condizioni, e Convenzioni, delle quali abbasso, che intendono, tanto Sua Eccellenza, quanto detti Signori Fratelli Sassi di ridurre a pubblico e giurato lustro- mento. Quindi è, che Constituito personalmente d’avanti li Testimonj, e me Notar» infrascritti sua Eccellenza Sig. Conte Luigi Ferdinando Generale Marsili della bo. me. Sig. Carlo Francesco Nobile, e Patrizio di questa Città della Parrocchia di Santa Maria Mascarella, spontaneamente &c. ha promesso, e si è obbligato d’impetrare da Sua Santità tal Grazia, privativa ad ogn’altra Persona, Università, e Collegio, & ex nunc prò tunc a favore di detta Stamperia Bolognese, d’imprimere, ed estradare detti Ebdomadali Avvisi, ed ogn’altra Relazione con la Condizione, che Viventi li detti, ed infrascritti Signori Fratelli Sassi, detta privativa debba essere a loro favore, nè possono, se non seguita che sarà la morte naturale degl’infrascritti Signori Carlo Alessio, e Clemente Maria Fratelli de Sassi, un tale Privilegio,o privativa, essere esercitato in detta Nuova Stamperia, nè in altro luogo, nè da alcun’altra Persona, ma che quella solo abbia il suo effetto, ed esercizio nel caso della mancanza naturale dell’ultimo dei detti Signori Fratelli Sassi, e non prima, nè altrimenti &e. Ed all’incontro li prefati Signori Carlo Alessio, e Clemente Maria del fu Sig. Gio. Antonio Sassi Cittadini di Bologna delle Parrocchie di S. Michele Arcangelo, e S. Martino Maggiore rispettivamente, spontaneamente &c. per se &e., e sotto l ’ obbligo generale de’ suoi Beni presenti, e futuri, hanno promesso, si sono obbligati, impetrata che sarà da Sua Eccellenza suddetta la Grazia ne’ modi, e forme sopraespresse, mediante la quale essi proseguiranno loro, e di ciascuno di loro Vita naturale durante solamente, e non più oltre, ad imprimere, ed estradare detti Ebdomadali Avvisi, e Relazioni, di dare, pagare, ed annualmente sborsare alla detta Nuova Stamperia Bolognese, ed al principale Ministro, ed Agente della medesima Lire Ducento di quattrini, moneta di questa Città di Bologna, in due rate, termini, cioè la metà della Solennità della B. V. del Mese d’Agosto, e l’altra metà alla Solennità del Santissimo Natale di ciaseun’Anno, col principiare il primo Pagamento a quella delle Solennità suddette,
484 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
che sarà più vicina, dopo l’essersi da Sua Eccellenza ottenuta tal Grazia. Ed inoltre di dare, e consegnare all’Agente suddetto di detta Stamperia Bolognese, in ogni Settimana, e nel giorno istes- so, che si pubblicano gli Avvisi in questa Città, numero dieci Esemplari de’ medesimi, ed ogni qual volta si pubblicheranno Relazioni, numero cinque Esemplari di quelli, e ciò alla detta Stamperia nuova Bolognese, ed a comodo della medesima, il tutto senza eccezione, o contradizione alcuna specialmente &c. e generalmente &c. con li patti de’ pegni, e Precario in forma &c. Convengono poi espressamente le dette Parti, per patto sostanziale fra di loro, che se li detti Signori Fratelli Sassi, o alcuno di loro, sinché coime sopra naturalmente viveranno, mancherà, o mancheranno nel pronto, ed intero Pagamento delle annue Lire ducento di quattrini come sopra, dovute, e nella pronta Consegna de’ suddetti Esemplari e favore di detta Stamperia, decadino essi, e ciascuno di loro dal comodo delPImpressioue di detti Ebdomadali Avvisi, e Relazioni, non ostante, che la Grazia suddetta da impetrarsi potesse dirsi comprensiva d’essi Signori Fratelli Sassi, e che immediatamente il Jus d’imprimere come sopra vadi, e resti a comodo di detta nuova Stamperia Bolognese, come se detti Signori Fratelli Sassi fossero ambidue naturalmente morti, ed il tutto senz’altra interpellazione, o requisizione, col rinunziare adesso per allora essi Signori Fratelli -Sassi a qualunque eccezione, che potessero dedurre, ed allegare in contrario, perchè così è stato fra esse Parti espressamente convenuto. Quia sic &c. Quae omnia &c. poena Scutorum Centum &c. quae pena &c. re- fectionibus damnorum &c. obligationibus Bonorum &c. etiam in forma Reverendae Camerae Apostolicae &c. latissime exten- den. &c. pacto Precarii &c. Renunciationibus Beneflciorum &c. Juramentis &c. » 1.
1 Conventiones in ter excellentiam D. Comitem Aloysium Ferdìnandum Oeneralem M arsilli ecc. Bologna, Nella stamperia bolognese di S. Tommaso d'Aquino, 1728, in fol. Sulla Stamperia M arsili vedi anche lo scritto di G in o R o c c h i , La stamperìa bolognese fondata dal generale L u ig i Ferdinando M arsili, in « Archiginnasio », anno I, Bologna, R. Tipografia, 1906.
A. SORBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 485Nonostante il nuovo locale, e il cospicuo contributo di cui so
pra, e nonostante l’opera assidua che alla tipografia marsiliana dava il francese Keblin, la cosa non procedette così come era cominciata; a cagione di parecchie circostanze che ci sfuggono.
Forse fu il Keblin ad assentarsi, giacché poco dopo non troviamo più alcuna notizia di lui in Bologna ; forse fu la difficoltà di sorvegliare le opere da stampare e la scelta di esse, forse fu l’impianto ampio e notevole che fece proprio nel 1720 Lelio dailla Volpe con parecchi altri soci, e molti capitali, e tre torchi, che tosto iniziarono una grande e fruttuosa produzione.1 Tutte queste contingenze, e la impossibilità di potere unire la stamperia all’istituto, dovettero persuadere il Marsili a compiere un altro gesto generoso, e nello stesso tempo tale da recare alla istituzione, da lui tanto amata, un successo ben diverso e un complesso più organico e più redditizio. Il gesto fu dal Generale Marsili compiuto nel 1721, colla donazione della stamperia e di tutto il materiale ai Padri Domenicani, in data 7 maggio.
La donazione fu poi confermata in forma ampia e solenne con rogito del notaio Agostino Ignazio Pedretti il 12 luglio 1724, atto che credo opportuno di riprodurre integralmente, data la sua grande importanza :
« Quantunque gli studi di Sua Eccellenza infrascritta Sig. Co : Luigi Ferdinando Generale Marsili, non siano indirizzati a materie di religione, nientedimeno il giusto zelo, che per la medesima prova, lo costrinse fra i suoi molti viaggi, e commerzio, con tante Nazioni varie di Religione, dopo la nota fondazione dell’Insti- tuto delle Scienze, e delle Arti, a pensare, e risolvere ciò, che fosse all’Instituto medesimo corrispondente, ed all’istessa Religione proficuo. E qual intanto più propria, e convenevole cosa poteva Egli determinare, di quello sia la Stamperia che munita fosse di caratteri, non solamente Latini, ma eziandio di tutte le lingue Esotiche, che si aspettano, e conferiscono alla Storia Sacra, cioè la Greca, l’ Ebraica, 1’ Arabica, e d’ altre tante? Perocché, se
1 A. S o r b e l u : Storia della stampa in Bologna. Bologna, Zanichelli, 1929, pag. 164 sg.
480 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
stato vi fosse il comodo facile, ed opportuno per le stampe nelle Lingue sopra accennate, certa cosa è, che si sarebbero animati moltissimi a studiarle, ed a professarle, quando veduto avessero il modo da pubblicare l’erudite loro fatiche, a benefizio della Re ligione, e a vantaggio dell’erudizione, ed a gloria del nome loro. Le quali cose tutte seriamente pensando, e chiaramente scorgendo, fece, e terminò l’Unione d’una Stamperia. Ma quando ebbe ciò con molta industria eseguito, stette non poco tempo dubbioso, se questa, che occupa con tante parti, che la compongono, un sito assai vasto, dovesse collocarla nell’Instituto, ed al governo, e direzione del medesimo sottoporre.
« Scorgendo poi, che mancava il Sito per Lei necessario dentro il palazzo dell’Instituto medesimo, e diverse altre considerazioni passandogli per la mente, e quella in specie, che col tempo servir dovesse tale Stamperia, per confutare col benefizio dell’Esotiche Lingue l’Esposizioni d’Eretici Commentatori, animato dalla Bolla della S. M. di Paolo V, la 65“ in ordine, per la quale ingiunge il professorato, ed esercizio di tali Lingue, massimamente fra religiosi, le quali Lingue non professando molto gli Ecclesiastici Cattolici, particolarmente d’Italia, non potevano fondatamente intender' i dogmi, per mancanza di tali necessarie Notizie, coll ’assistenza d’iddio, e de’ di Lui Santi Protettori, e particolarmente del di lui Avvocato San Tommaso d’Acquino, che fu quegli, in cui per la buona educazione de’ di lui Genitori, il Sig. Generale essendo anche fanciullo, prese fidanza particolare; pensò a dare la custodia, l’uso, e la Direzione a’ Religiosi, Sodi Difensori della Religione Cattolica, e capaci di porre la Stamperia medesima perfettamente in esecuzione.
« Laonde per alquanti mesi, ora a questa, ora a quella Religione rivolgendo il pensiero, alla perfine Iddio volle illuminarlo, sicché trascelse la Religione Domenicana, giacché in questa Città può dirsi che sia la di lei Metropoli, mentre qui visse, e qui sta bili più saldamente il Patriarca S. Domenico un così grand’Or- dine per servigio della Chiesa, e qui finalmente per Divino Volere, lasciò egli il suo Santo Corpo. E perchè nel tempo medesimo della sopra riferita determinazione, aveva Sua Eccellenza premura che la medesima Stamperia, come che fosse donata all’intera Reli
A. SOBBOLLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 487gione Domenicana, restasse nondimeno in Bologna, sotto la libera amministrazione, e governo de’ Padri di questo Convento di San Domenico, ed a solo utile del medesimo Convento, nominati nel suo seguente Instituto, affinchè, ed alla Religione servisse, ed all’Instituto suddetto nelle forme da esprimersi, e risolvette, che fra i susseguenti Capitoli, fosse il fondamento tale, che detta Stamperia non sarebbe, nè per tempo, nè per modo alcuno alienata da questo Convento, e che di più sarebbe stata intitolata la Stamperia Bolognese. Ciò tutto seco stesso determinato, ed indi conferito al Padre Maestro Generale Cloche, di chiara memoria all’ora vivente, fu di coman consenso della Religione, e particolarmente di questo Convento di Bologna, ricevuta tal benigna disposizione di Sua Eccellenza, di dover la Stamperia, quantunque donata alla Religione intera, sussistere in Bologna per sempre, sotto la libera Amministrazione ad utile come sopra.
« Morto pertanto il detto Padre Maestro Generale, in tempo che governava il Padre Maestro Molo Procuratore Generale e ciò sotto li 7 Maggio 1721, solamente fu stipulato fra Sua Eccellenza, e li detti, ed infrascritti Padri di S. Domenico, a favore dell’intera Religione Domenicana, il primo provisionale Instrumento di Cessione, e Donazione di tutti quei Capitali, che allora componevano la Stamperia medesima, sotto l’espressa condizione di doversi la medesima, come che allora mancante di più e diversi Caratteri, interamente perfeaionati da Sua Eccellenza, e perfezionata che fosse, ulteriormente convenire; e concordare in Capitoli, e Patti fra esse Parti da stabilirsi, anzi da richiedersi da Sua Eccellenza predetta, e come più latamente sta espresso -nel sopra accennato Instrumento per me Notaro infrascritto rogato, al quale &e. Qual Cessione, e Donazione si rattificò poi nel Capitolo Generale tenutosi per l’elezione del Padre Maestro Gene- ralle Pipia, il quale anch’esso pure in tante lettere a sua Eccellenza predetta scritte, ebbe ratta, e ferma una tale Cessione, e Do nazione, perchè a suo tempo fosse data esecuzione totale alla Consegna, e Capitoli della medesima Stamperia, col titolo di Bolognese.
« E siccome li RR. Padri del Convento di Bologna non hanno potuto fin’ ad’ ora risolversi alla scelta del sito da stabilirvi
488 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
l’uso, e la permanenza di essa, è stata fin qui differita la finale Consegna d’ altri Capitali, e dato compimento a ciò, che poteva perfezionare una sì riguardevole Opera. Ed avendo Sua Eccellenza Sig. Co : Luigi a riserva delle Matrici Greca, Araba, ed Ebraica, e d’ alcune altre Latine, non per anche trovate di totale di lui soddisfazione, ma che promette trovar quanto prima, perchè resti compita, e perfetta tal fondazione di Stamperia, come a basso, dato compimento alla provvista delle altre, giusta il convenuto nel sopra espresso primo Instrumento, e benché prima d’ una tale consegna dovessero convenirsi quei Capitoli, che fossero stati di soddisfazione di Sua Eccellenza, e forse con obblighi perpetui alla Religione, anche concernenti Suffragi, ed Orazioni, perpetui per la di lui Anima, e propria Casa, ciò non ostante, ponendo solo a’ piedi di Dio il già da lui fatto, e presentementet da (farsi, con isperare nella di Lui infinita Misericordia, determinò di venire ad una finale consegna degli augmentati, ed aggiunti Capitali, senza imporre verun'aggravio resguardante il di lui proprio interesse, e senza alcuna riserva di rivocare, anzi con la precisa rattifica della prima Cessione, e Donazione, nel modo però solamente, che si dirà qui a basso, benché quella fosse posta sotto condizioni di Capitoli da convenirsi, e ¡solo con le infrascritte esortazioni a’ Padri per essi da accettarsi per il buon regolamento della Stamperia medesima, sempre a maggior gloria d’iddio, e della nostra Religione Cattolica, di modo che sempre sia, e resti in libero dominio della detta Religione Domenicana, e sotto la libera amministrazione, ed utile de’ Padri di questo Convento di Bologna la Stamperia medesima.
« Lo che tutto volendo esse Parti col presente Instrumento mandare ad esecuzione, e ad una tale generosa Opera di Sua Eccellenza, dar pieno compimento, sono venute alla stipulazione del medesimo, ne’ modi, e forme seguenti, cioè. Quindi è, che costituito personalmente in presenza de’ Testimoni, e di me Notaro infrascritto Sua Eccellenza Signor Conte Luigi Ferdinado Generale Marsiglj, figlio della bo. me. Sig. co. Carlo Francesco Nobile, e Patrizio di questa Città di Bologna, della Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Strada San Donato, spontanea
A. S0RBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 4 8 »
mente &c. per se &c. ha rattificato, e rattifica la Cessione, e Donazione, come sopra s’è detta, dell’anno 1721, in ogni, e singola parte della medesima uniforme, e non contraria alla presente disposizione, perchè per totale esecuzione della medesima, non avesse esso convenuto, ed ora convenga con perpetue Convenzioni, e Condizioni con detti, ed infrascritti RR. Padri, rinunziando espressamente a qualunque eccezione, che potesse dedurre, ed allegare in contrario. Successivamente Sua Eccellenza predetta Sig. Co : Luigi Ferdinando Generale Marsiglj, al quale spettano gl’infrascritti Capitali di Stamperia da esso Lui augmentati in Caratteri, ed altri descritti nell’inventario in quest’atto presente consegnato a’ detti Padri, ha dato, ceduto, e donato, dà, cede, e liberamente dona Alla Santa, ed Universale Religione Domenicana per l’uso, e compimento della Stamperia detta Bolognese, sempre però d’amministrarsi a comodo di questo Convento de’ Padri di San Domenico di Bologna, e per la medesima Religione, alli molti RR. Padri Priori, ed altri RR. Padri degni in questo Convento di San Domenico di Bologna, convocati, congregati, ed insieme capitolarmente radunati nell’infrascritto luogo de’ loro Capitolari Congressi, premesso il suono della Campanella Capitolare, e servate l’altre cose solite a servarsi conforme lo stile del loro Convento (seguono i nomi dei Padri Domenicani convenuti), tutti Padri Vocali, e che hanno voce nel loro Capitolo, e che sono soliti quello rappresentare, essendo più di due Parti delle tre presenti, e per detta Religione Domenicana, stipolanti, ed accettanti. Tutti li Capitali già descritti in detto primo Instrumento, parte presso di loro esistenti, parte tuttavia situati nella Casa posta nella Via di Centotrecento, ove Sua Eccellenza predetta aveva collocata la Stamperia medesima, e finalmente li descritti, ed annotati nel sopra consignato Inventario, ed augmentati da Sua Eccellenza predetta. E ciò con tutte, e singole le Clausole opportune, e translative di dominio, secondo il Clausolario de’ Signori Notari di questa Città di Bologna, Per l’effetto, anzi per totale esecuzione del transferito dominio, ed af- fiinchè detti, ed infrascritti RR. Padri possino a loro libera disposizione, e piacimento, trasportare li Capitali della Stamperia medesima tuttavia esistenti in detta Casa di Cento-trecento, il
490 MEMORIE INTORNO A L. F. M ARS ILI
Signor Co: Luigi Generale Marsiglj ha (lato, dà, e consegna al Molto Reverendo Padre Priore la Chiave della Casa medesima, ove tuttavia si conservano parte de’ Capitali medesimi, come così quella detto Rever. Padre Priore ricevendo, e presso di sè ritenendo, ad effetto di trasportare li Capitali medesimi, e da quelli rendere vacua, e libera la Casa medesima, prima degli 8 maggio dell’Anno prossimo avvenire 1725, ha detto &c., ed ha rinunziato &c.
« E perchè manca il Carattere Greco, e li sopra citati per tota, le compimento di quei Caratteri, che Sua Eccellenza promise di provvedere, per rendere l’Opera perfetta, perciò restando ferma una tale sua promissione per detti Caratteri mancanti, quelli, ritrovati che sieno da Sua Eccellenza, come ne ha quanto prima disposta la previsione, ha promesso, e si è obbligato quelli immediatamente consegnare a li detti RR. Padri, per totale perfezione della detta Stamperia, e adempimento del di Lui obbligo.
« Non ostante poi, che nel sopra riferito primo Instrumento di ■Cessione, e Donazione, fatto l’Anno 1721, restasse convenuto di dover trattare de’ Pesi, che si sarebbero adossati alla Religione Domenicana, ed al Convento di San Domenico di Bologna; ora Sua Eeccellenza suddetta, con la di lui pia massima, di rimettere tutto a’ piedi di Dio, risolvendo come sopra una tale Condizione apposta, la di cui esecuzione principalmente a lui poteva compet- tere, come Donatore, intende di non voler fare, come non fa minima menzione d'Obblighi alcuni alla medesima Religione, ancorché questi dovessero riguardare alla di lui Anima, revocando tutti apposti, e prima voluti, rimettendo tutto alli detti Santi di lui Avvocati Domenico, e Tommaso d’xVequino, che intercedano da Dio quel sollievo, che potrà essere giovevole alla di lui Anima, inspirando all’universale Religione Domenicana, di pensare a far quello, che crederanno utile aH'Auima di esso Donatore, che per il corso intero della sua Vita, fu, come sanno, tanto affettuoso alla medesima, solo passando alle seguenti esortazioni, che hanno per oggetto il buon successo di quest’Opera, e della Stamperia medesima, quale però per parte di detti, ed infrascritti RR. Padri del Convento di San Domenico come liberi Amministratori
A. S0RBKLLI - LA STAMPERIA DI L. I<\ MARSILI 491
suddetti, restando accettati, come Capitoli da adempiersi, espone li seguenti Capitoli, cioè:
« Primo. Li Padri pred. dovranno fabbricare il luogo per la Stamperia, capace di cinque Torchi, della Gettarla, Bagnadoria della Carta, d’un luogo per far le Tinte, Magazzino da mettere in supressa le Robbe stampate, Sciogaderia per seccare le Carte, e comodi di abitarli, che si crederà necessario per utile della Stamperia, e comodo per il Correttore, e piccola Compotisteria, dove si tirerà, e pagherà il Denaro, ed in detto sito collocare tutti e singoli Capitali predetti, ed ivi ponere in uso la Stamperia medesima, col rendere vacua, e libera la Casa del Donatore, prima degli otto di Maggio dell’Anno prossimo avvenire 1725.
« Secondo. Deve esser la detta Stamperia governata da un’As- sonteria composta de’ RR. Padri, Priore di questo Convento &c., Inquisitore, Reggente, e Lettori nell’Università pubblica di questa Città, duranti tali loro Uffizj, e detti Lettori pubblici, quando sieno figli del Convento, preferendo sempre li Padri Maestri in Provincia, di modo che sieno sempre almeno in numero di sei. E quanto a’ detti Reverendi Padri Assonti, per non avere a convocare per qualunque affare l’intera Assonteria, in ciascun Mese, secondo l’ordine, cominciando dal Rever. Padre Priore, uno de’ suddetti Assonti avrà il governo in qualità di Direttore e di Capo.
« Terzo. Li Padri suddetti saranno tenuti di stampare quel- l'Oipere che fossero veramente composte da Professori dell’Insti- tuto, senza verun’utile, e solamente col rimborso delle spese, <?on espressa condizione per evitare qualunque inconveniente, che non si presentasse alla Stamperia Opera sotto nome dell’ Instituto come Autore dell'Opera, o Opere da stamparsi, sotto nome dell’Instituto, debba personalmente presentarsi al Reverendissimo Padre Inquisitore, e Molto Reverendo Padre Vicario, pro tempore ed ivi che tal Professore non potesse, o per sua assenzao per qualche altro legittimo impedimento, personalmente presentarsi, potrà esibire il giuramento per esso pigliato in forma autentica, e per Rogito di Notaro, alli detti Padri, prima di stamparsi l’Opera suddetta. Come pure l’ illustrissima Assonteria dell’ Instituto volesse stampare cose d’ onore, direzione, e
4 92 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
buon’ incamiminamento dell’ Instituto per regola dei Professori, debbano li Padri tutto ciò stampare, qualvolta concerna le cose predette ; col solo rimborso delle spese.
« Quarto. S’obbligano li Padri a nome della Religione predetta, anzi del Convento suddetto, di tener sempre in questa Stamperia impiegati gli artefici di qualunque sorta, Bolognesi, instruendo ancora Scolari nati in Bologna, o nel Territorio, quelli impiegando, fino alla loro abilità ne’ meccanici lavori, senza però escludere, che non si possa pigliare qualche Artefice Forestiere, ed eccellente, che instruisca meglio di tutte le parti sue la detta Stamperia, e d’altri Stampatori.
« Quinto. Ai primi Vespri della Vigilia di San Tommaso d’Acquino, ed intero giorno della di lui Solennità, si osserverà rigorosissima Festa di tutti gli Artefici della Stamperia, mentre il detto gran Santo, e Dottore sarà il Protettore della medesima, e ciò, alfine che antecedentemente al giorno di detta Festa, abbiano il comodo di confessarsi, e nel giorno susseguente festivo debbano, niuno eccettuato, se non veramente gl’infermi, assistere alla Messa da celebrarsi da un Padre da deputarsi, ed ivi tutti comunicarsi, applicando tali Divozioni per l’Anima del Signor Donatore, e prosperità della Stamperia, pienamente ascoltando le esortazioni Cristiane, che per l’Anima loro, e delle loro famiglie, ed anche per il diligente loro Ministero loro verranno dal zelo di detto Padre insinuate, lo che terminato, tutti uniti passeranno a godere in quella Collazione, che piacerà al Padre Priore, di loro permettere; e da’ Vespri dovranno essere al servizio della Chiesa, sino al tramontare del Sole, senza intraprendere qualunque piccolo lavoro della loro Arte, e tutto lo stesso si osserverà per la Festa della Patriarca San Domenico, senza però alcuna Collazione, quando la carità del Padre Priore, e li diligenti, e fedeli diportamenti, di detti Artefici, non li facessero qualche merito.
« Sesto. Attende il Signor Donatore da’ Padri del detto Convento gli atti di maggiore pietà loro proprj verso li detti Artefici, e Serventi alla Stamperia, lo che eserciteranno, quando unoro più Operarj infermatisi durante la loro malattia, contribuiranno loro della metà de’ loro Salarj, purché la malattia non
A. SOKBELLI - LA STAMPERIA DI L. l<\ MARSILI 493
Marca tipografica della « Stamperia bolognese »
Il « motto » del Marsili per la sua Stamperia
494 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
fosse incurabile, e fatta cronica; nel qual caso sono pregati li Padri d’aver loro una particolare riflessione nel comparto delle quotidiane elemosine del Convento in favore di essi, del cbe ancora si pregano, quando per la morte di qualche Artefice, restassero Vedove con figli, e figlie in istato di non potersi sostenere, e se i figli fossero capaci d’operare ed imparare per la Stamperia, senza però acquistare alcun Jus a medesimi, si preganoi Padri ad introdurli nell’esercizio predetto. E quando mai un Operaio di detta Stamperia avrà per anni 40 continui servito alla Stamperia, in grado però di buon Operaio nel suo Esercizio, computando li detti Anni 40 dagli Anni 20 dell’età del medesimo, in cui avesse servito alla Stamperia, s’intenda questi giubilato, e goda della sua mercede, e salario, fino al giorno della di lui morte.
« Settimo. Si conviene ; che la Marca della Stamperia istituita dal Signor Donatore, debba usarsi in perpetuo, col medesimo riflesso, che egli stesso ebbe, scegliendola; perchè è un Sole figurante quello, che porta in petto, S. Tommaso d’Acquino, a cui piacque aggiugnere il Motto Nihil mihi; e perciò vuole, che questa inalterabilmente sussista, nè possa essere mai mutata, per qualsivoglia motivo, come nella Stamperia il Nome di Bolognese.
« Ottavo. Tutti quegli Operarj che hanno assistito il prefato Signor Donatore a ridurre, e governare la Stamperia suddetta fin qui, non demeritando con cattivi portamenti, sieno confermati ne’ loro impieghi.
« Per ultimo. Raccomanda all'Orazione dell'intero Ordine Domenicano, e particolarmente di questo Religiosissimo Conventa la presente di lui Casa, e di lei Discendenza » . 1
I patti, e sopratutto quelli che riguardano i diritti e le condizioni e garanzie degli operai, sono di un interesse così vivo e precorrono tanto i tempi, che sembrano stabiliti nel secolo presente. Tutti i suoi operai dovevano essere conservati in servizio, e doveva loro darsi metà del salario se malati, una pensione dopo un servizio di quarant’anni, da computarsi dopo i venti di età;
1 A tt i legali ecc. cit., istrumento terzo.
A. S0RBELLI - LA STAMPERIA DI L. P. MARSILI 495disponeva anche che nel giorno della festa di San Tommaso, al quale santo la tipografia era intitolata, tutti gli addetti alla tipografia, operai e capi, si unissero insieme a colazione. Bella fraternità, di cui si è persa, andando in cerca non so di quali malefiche utopie, la tradizione!...
* * *
1 Padri Domenicani si misero tosto all’opera. Mantennero- tutti i tipografi che aveva il Marsili, altri ne aggiunsero, chiar marono alla direzione uomini provetti e iniziarono la stampa di parecchie opere, non escluse alcune assai importanti di professori dell’istituto e delPUniversità. Il Marsili ne fu molto contento, e in segno del suo gradimento, volle donare ai frati di San Domenico otto grandi quadri o meglio stendardi rappresentanti otto azioni miracolose del santo, sotto la protezione del quale, come si è detto, era stata posta la Tipografia. Tutto ciò risulta dal seguente atto dello stesso notaio Pedretti, in data del- l’8 marzo 1727.
« Avendo in tanti, e replicati Atti pubblicati Sua Eccellenza Sig. Co: Luigi Ferdinado Generale Marsiglj, ed in quelli massime, che risguardano lo stabilimento dell’Instituto, e de’ Capitali della Stamperia, detta Bolognese, dimessa all’intiero Venerabile Ordine Domenicano, sempre contestato essersi egli totalmente diretto all’Angelico, e Massimo Dottore S. Tommaso d’Aquino, perchè l’illuminasse, e l’assistesse coll'aiuto Divino, e gli venissero somministrati quei mezzi, che dopo una lunga serie di anni si ricercavano, per condurre a fine tali riguardevoil operazioni, e al miglior grado possibile per il servizio, gloria, e beneficio di questa di lui Patria, e vedendo lo stato, in cui a Dio piacendo, ritrovasi, e l’Instituto medesimo, e la detta Stamperia, di modo che non abbisogna a questi ulteriore di Lui assistenza, atteso massime il buon regolamento d’entrambi; determinò per fine, ed a perpetua memoria far riconoscere l’affetto, ed amore al suddetto S. Tommaso di lui gran Protettore, anco alla vista pubblica, e specialmente di questa Città, col risolvere di far fare l’operazione d’otto Stendardi, in cui restassero deli
MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI
neate otto riguardevoli azioni della Vita di sì gran Santo da rimettersi a’ RE. Padri di questo Convento di San Domenico, per custodirli, e servirsene nella processione, che, come abbasso, e nel tempo infrascritto, bramava Egli, si facesse sempre gloria a Dio. Benché di tale sua determinazzione avesse stabilito lasciarne l’esecuzione a di lui Successori, ed Eredi, ciò non ostante, nel riflesso di più motivi, risolvette di dar esso vivente compimento ad una tale determinazione. Ciò tutto anco per Testimonio, e riconoscenza dell'affetto, che a’ RR. Padri infrascritti di questo Convento di San Domenico di Bologna, da’ quali ne ha sempre ricevuto, e riceve vicendevole corrispondenza, com- municato, per riportarne la di loro generosa accettazione da essi precedentemente con loro Capitolo convenuta sotto le infrascritte condizioni, e volendo col presente Instrumento stabilirne una perpetua ordinazione: Quindi è, che costituito personalmente davanti li Testiimonj, e me Notaro infrascritto Sua Eccellenza suddetta Sig. Co: Luigi Ferdinado, della bo. me. Sig. Co. Carlo Farncesco Marsiglj Nobile, e Patrizio di questa Città, di sua spontanea Volontà, ed anco per se stesso, suoi Eredi, e Successori, qual volta che da esso vivente (che Dio lungamente conservi) non restasse adempito all’infrascritta obbligazione, promette, e si obbliga di dare, e consegnare con ogni più sollecitudine possibile alli Molto RR. Padri Priore, ed altri Padri del- l’Ordine de’ Predicatori, degenti in questo Convento di S. Domenico di Bologna, Convocati, Congregati, ed insieme Capitolarmente radunati nell’infrascritto luogo de’ Capitolari congressi premesso il suono della Campanella Capitolare, e servate l'altre cose solite a servarsi, conforme lo stilo, ed uso del loro Convento (sono indicati i nomi dei padri convenuti), tutti Padri Professi Vocali e che hanno voce nel loro Capitolo, e che sono soliti quello rappresentare, essendo più di due parti delle tre del li Padri Vocali presenti, stipolanti, ed accettanti: Gli otto Quadri, o sieno Stendardi, ne’ quali resteranno come sopra, dipinti da diversi Professori di Pittura le rappresentanze più Gloriose della Vita del detto Angelico Dottore S. Tommaso d’Aquino, e che resteranno compiti quanto prima sotto la magistral direzione del Sig. Cav. Franceschini, dal di cui esimio Pennello ne sarà pure uno
A. SORBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 497
formato, e nell’atto di tale consegna si compiacerà il P. Priore pro tempore di questo Convento farne con Descrizione la ricevuta, che allora si dovrà consegnare a me Notaro, per registrarla in fine del presente Instrumento dopo le Clausole Generali, ed a consegna seguita, e quella pienamente effettuata, come sopra, secondo il preconvenuto fra detto Sig. Co. Luigi, e detti RR. Padri, restano stipolate le seguenti Capitolazioni da perpetuamente osservarsi e sono le seguenti, cioè: Ricevuti che avranno li suddetti RR. Padri gli otto Quadri, come sopra, collocheranno li medesimi nell’Atrio della Libraria dello stesso Convento di S. Domenico, da indi non ammoversi, se non qual volta verrà il caso dell’infrascritta Processione per essi da farsi, col riporli però sempre in detto luogo. In ogni venticinque anni, principiando il computo dei medesimi dal dì della prima apertura dell’Instituto, che fu il 13 Marzo 1713, e così in consimile giorno in ogni venticinque anni compiti come sopra, saranno tenuti come li Padri suddetti s’obbligano con le necessarie licenze di andare processionalmente partendosi dal loro Convento di S. Domenico con l’alzamento degli otto Stendardi come sopra, al Palazzo dell’Instituto situato nella Strada di S. Donato, ed alla Cappella dedicata alla Santissima Vergine Annonziata in quella eretta, e immediatamente, che avranno avuto gli Stendardi suddetti, dovranno essi RR. Padri adempiere alla prima Processione, come sopra, quale si calcolerà per quella, che doveva farsi nel giorno dell’apertura del detto Instituto come sopra, e così alli 13 Marzo 1738, compimento degli anni venticinque, fare la seconda Processione, e così di venticinque in venticinque anni proseguire, come sopra. Piamente facendo una tal Processione gli stessi Padri con Inni, ed Orazioni divote, e a gloria di Maria Vergine risguardanti il Mistero della Incarnazzione nell’andare alla detta Cappella dell’Instituto, quella accompagneranno, ed ivi giunti porgeranno preci all’Altissimo, ed alla Gran Madre Maria, e a Santi Avvocati di esso Instituto per ottenere ogni buona assistenza, e regolamento del medesimo Instituto, e che a gloria di Dio concorrendo soggetti l’aumentino in ogni di lui parte, e nel ritorno al Convento di S. Domenico, vengono instantemente supplicati da Sua Eccellenza suddetta di recitare il Salmo Miserere
34
498 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
con tre Deprofundis, e le Litanie de’ Santi, e ciò per Carità, ed in suffragio dell’Anima di esso Sig. Co. Luigi, qual volta fosse stata chiamata al supremo Tribunale di Dio, e giunti alla Chiesa, ed alla Cappella del glorioso S. Tommaso d’Aquino, loro piacerà rendere grazie a Dio de’ benefìzj fatti, e massime a favore di questa Patria nell’Instituto medesimo. Quia sic &c. Quae omnia &c. poema dupli &e. qua poena &c. refectionibus damnorum &c. obligationibus Bonorum &c. pacto preearii renunciationibus Be- neficiorum &c. Juramentis &c.
Tenor Receptiomis sequenis est, videlicet. Adì 21 Giugno 1727.10 infrascritto Vicario moderno del Convento de’ Padri di S. Domenico, ho ricevuto da Sua Eccellenza Sig. Co. Luigi Ferdinando Generale Marsiglj gl’infrascritti otto Quadri rappresentanti otto azioni Gloriose del nostro Angelico Padre S. Tommaso d’Aquino, fatti fare, e donati da iSua Eccellenza suddetta secondo11 convenuto con li Padri di cotesto Convento per la stabilita Processione da farsi all’Instituto delle «Scienze, ed Arti, come all’Instrumento rogato il Sig. Agostino Ignazio Pedretti. Li Quadri sono li seguenti, cioè di altezza oncie 60, di larghezza oncie 44. Il primo rappresenta S. Tommaso, che inghiottisce la Carta dell’Ave Maria. Il secondo S. Tommaso, che presenta Pane, e si trova cangiato in rose. 11 terzo S. Tommaso nell’atto di cacciar la Femmina. Il quarto S. Tommaso alla Tavola del Re di Francia, che confonde i Manichei. Il quinto S. Tommaso, a cui apparisce la Beata Vergine, e S. Paolo. Il sesto S. Tommaso, che presenta le sue Opere a Gesù Cristo. Il settimo S. Tommaso, che presenta l’Uffizio del Corpus Domini a Urbano Quarto. L’ottavo S. Tommaso, e S. Agostino in Gloria. Io F. Giuseppe Maria Agudio moderno Vicario in Capite nel Convento di S. Domenico di Bologna affermo, quanto sopra. L. S. » 1
* * *
L ’importanza maggiore della « Stamperia bolognese di San Tommaso d’Aquino », come si chiamò, consisteva nel fatto che
1 A tt i legali, cit., ¡strumento quarto.
A. SORBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 499
era ricca di caratteri esotici, sopratutto orientali, dei quali difettavano allora le altre tipografie bolognesi, e, può dirsi, mancavano le italiane in genere, fatta eccezione della pontificia di Propaganda fide.
Ora nell’anno 1728 si presentò al generale Marsili una singolare fortuna, quella di venire in possesso di molti caratteri e punzoni e matrici per alfabeti orientali assai rari, e precisamente quelli stessi che il granduca Cosimo di Toscana aveva donati a Clemente XI.
Morto il detto pontefice, tutta questa preziosa suppellettile passò nelle mani del cardinale Alessandro Albani nipote del papa, delle cose di cultura amantissimo, e dal cardinale passarono quindi al generale Marsili.
Il Marsili pensò tosto che questa rara suppellettile avrebbe assai giovato alla sua Stamperia, o meglio alla stamperia da lui donata all’Ordine domenicano per la Casa di Bologna, e perciò non pose tempo in mezzo e volle, con altro pubblico atto dello stesso notaio Pedretti, donarla ai frati di S. Domenico. L’atto ha la data del 26 giugno 1728 e merita di essere riferito integralmente, sopratutto per conoscere qual pregio e dovizia aveva la collezione di caratteri di cui la Stamperia bolognese andava ora arrichendosi.
« Restava sommamente a cuore di Sua Eccellenza infrascritta Signor Conte Luigi Ferdinado Generale Marsiglj, anco in sequela delle stipolate Donazioni per esso fatte della Stamperia detta Bolognese, e suoi Capitali, per Rogiti di me Notaro infrascritto, a comodo dell’insigne Ordine Domenicano, e di questo celebre Convento di Bologna; li medesimi capitali aumentare, acciò sempre più perfetta si rendesse la fondazione della medesima Stamperia fatta da Sua Eccellenza suddetta, d’indi ceduta, e come sopra donata. Che però non tralasciando alcuna diligenza, massime per ritrovare caratteri corrispondenti agli idioma, e stile di Nazioni straniere, ha finalmente ottenuto dalla somma beneficenza dell’Eminentissimo, e Reveredissimo Signor Cardinale Alessandro Albani Nipote degnissimo della Santa Memoria di Clemente XI (sotto la di cui protezione, e al di cui sommo merito fondò, e dedicò pure l’Eccellenza Sua Signor Generale
500 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
Marsilli l’Instituto delle Scienze, ed Arti a perpetua memoria e benefizio di questa di lui Patria) ha dico ottenuto dal detto Eminentissimo Albani in dono prezioso, e riguardevole più Matrici di Caratteri della lingua Araba, Turca, e Persiana, e cioè gli stessi Caratteri delle Lingue sopra accennate, che dalla gloriosa memoria dell’Altezza Reale Gran Duca Cosimo furono allo stesso sommo Pontefice Clemente XI di già in dono presentati. Questi dunque pervenuti alle mani di Sua Eccellenza ; ha determinato ad ogni buon fine, ed effetto darli, cederli, e passarli al possesso, e consignarli alla Stamperia medesima Bolognese, sotto la Protezione dell’Angelico Dottore S. Tommaso d’Aquino, per ivi conservarle, e custodirle, ed in ogni occorenza servirsene sempre in aumento della Stamperia medesima, e di lei comodo come sopra. Che però costituito personalmente d’avanti li Testimoni, e me Notaro infrascritto l’Eccellenza Sua C. Luigi Ferdinando Generale Marsilli della chiara memoria Sig. Carlo Francesco Nobile, e Patrizio di questa Città, di presente della Parrocchia di S. Silvestro, spontaneamente &c. per se &c. ha dato, ceduto, dimesso, consegnato, e caso sia il bisogno, liberamente donato, Alli Molto RR. Padri dell’Ordiine di S. Domenico infrascritti, che di presente risiedono al Governo di detta Stamperia Bolognese, quali sono li seguenti, cioè: Molto Reverendo Padre Maestro F. Antonio Boeri da Tabia Lettor Pubblico di Bologna, Vicario Provinciale, e Priore del Convento di S. Domenico, Reverendissimo Padre Maestro Fr. Paolo Girolamo Gallarate di Milano ex-Provinciale, ed Inquisitore Generale di Bologna, Molto Reverendo Padre Maestro Fr. Giuseppe Maria Agudi di Milano ex-Provinciale, Molto Reverendo Padre Maestro Fr. Tommaso Maria Caneti Lettor Publico, Molto Reverendo Padre Maestro Fr. Gio. Michele Providoni Dottor Colleggiato, e Presidente della Stamperia, presenti, e che a comodo di detta Stamperia Bolognese, e per uso della medesima hanno liberamente accettato, e ricevuto dalFEccellenza Sua suddetta Sig. Generale Marsilli le Matrici de’ Caratteri delle Lingue Araba, Turca, e Persiana esistenti in una cassetta di Legno, e descritte nel seguente modo, cioè: Primo: Persiano, Testo d’Aldo, consistente in Matrici nu.112. Secondo : Arabo, Testo, nu. 162. Terzo : Arabo, Testo d’Aldo,
A. SORBELLI - LA STAMPERIA DI L. F. MARSILI 501
degli Evangeli nu. 194. Quarto : Turco Arabo, Garamone un. 162. Quinto: Persiano minuto nu. 317. Sesto: Arabo, Silvio nu. 308. Settimo : Persiano, Testo d’Aldo nu. 113. Ottavo. Residui di Corpi Arabici nu. 374. In tutto pezzi nu. 1742. Come così li suddetti odierni RR. Padri Presidenti dette Matrici di Caratteri ricevendo dal generoso animo di Sua Eccellenza iSig. Generale Mar- silli, ed in aumento de’ Capitali della Stamperia suddetta, hanno detto, e confessato a quelli avere avuti, e ricevuti, e sopra ciò hanno rinonziato a qualsiasi eccezione, e con l’assolverne ¡’Eccellenza sua suddette da tale spontanea consegna, e dimissione, ed hanno promesso, e si sono obbligati quelli sempre, ed in ogni tempo conservare, e custodire nella medesima Stamperia per uso, e comodo della medesima, nè quelli estradare in alcuna forma, e ciò nel migliore, più valido, ed efficace modo di ragione possibile » . 1
In seguito a questo nuovo dono di un materiale tipografico di grande rarità, nessuna tipografia di Bologna e della regione potè gareggiare colla Marsiliana di S. Tommaso, per ciò che si riferiva ai caratteri esotici e sopratutto orientali; peccato peraltro che troppo poche opere si stampassero nelle quali potesse trovare impiego il sopra indicato materiale!
I rapporti fra i Domenicani del convento di Bologna con la tipografia, da un lato, e il Generale Marsili, dall’altro, corsero lieti e amichevoli, ma per poco tempo ancora: il Marsili morivail primo novembre 1730.
Liberi oramai di speciali obblighi, i Padri Domenicani fecero della tipografia un istituzione loro, allentarono i legami coll’Uni- versità e coll’istituto, chiamarono alla direzione tecnica della tipografia Giuseppe Maria Fabbri, tipografo di buon nome, proprio l’anno seguente alla morte del Marsili ; e non molto tempo dopo stabilirono una società, per la gestione della tipografia, con Tommaso Colli, che divenne così il compadrone dell’azienda. Il Colli diede un grande sviluppo all'industria, da avveduto e colto
1 A tti legali ecc. cit., ¡strumento quinto.
502 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
e onesto che era, oltre che valentissimo e capacissimo nell’arte sua. Compose egli pure delle operette, sopratutto di argomento religioso, talvolta non firmandole, e si acquistò singolari benemerenze per la cultura colla pubblicazione di opere voluminose e importanti. Per la tradizione dialettale bolognese ottenne una fama, starei per dire impensata, colla pubblicazione da lui iniziata, e continuata sino ai nostri giorni, del lunario che ha per titolo « Al Duttor Truvlein » !
A lb a n o S o r b e l l i
Bibliografica Mamliana,
OPERE DEL MARSILI
Ossservazioni in torno al Bosforo Tracio ovvero Canale di Costantinopoli.... Roma, Ang. Tinassi, 1681.
Bevanda asiatica brindata a ll’ Emin. Botivi si nunzio apostolico... (la L. F. M a b b ig l i , che narra V liistoria medica del Cavò ossia Caffi. Vienna, 1685.
Dissertazione epistolare del Fosforo minerale o sia della pietra illu minabile bolognese. Lipsia, 1698. (C ’è una seconda edizione in cui la dissertazione è tradotta in latino da Andrea Cristiano Escliem.iiaeh. E ’ del 1702).
Danubialis operis Prodromus. Norimbergae, 1700.Prodromus operis danubialis. Amsterdam ed Aja, senza l'indicazione del
l'anno. (Certo questa copia, che ha correzioni sulla precedente, è posteriore al 1722, quindi contemporanea al contratto con i librai d i Amsterdam, e alla copia della Bibl. Comun. è unito il foglio con le condizioni della sottoscrizione).
Informazione sopra quanto gli è accaduto nell’ affare della resa di B ri- sacco. Senza data e senza luogo di stampa, pp. 45 (Furono aggiunte altre scritture in sua difesa ; in latino, pure senza data e luogo di stampa).
E xtra it d’una le ttre écrit de Cassis, près de Marseille, le 18 de de- cetnbre 1706 à M . l'Abbé Bignon... touchant quelques branchee de corail qui ont fleuri. «Journal des Sgavans », tomo 35°, 1707, pp. 346-359. (Tradotta in italiano ed inserita nel Brieve Ristretto del Saggio fisico intorno alla storia del mare scritta alla R. Accademia delle Scienze di Parig i ora esposto in una lettera a Cri- stino Martinelli. Venezia, 1711, pp. 5-14).
M ém oire envoyé de Marseille, le 21 de fevrie r 1707 à Monsieur l'Abbé Bignon.... pour servir de confirmation à la découverte des fleurs dn corail. « Journal dee Sgavans », tomo 36°, 1707, pp. 302-310.
504 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
(Tradotta e stampata nel Brieve R istretto del Saggio fisico intorno alla storia del mare scritta alla R. Accademia delle Scienze di Parigi, ora esposto in una lettera a Cristino Martinelli. Venezia, 1711, pp. 14-22).
Brieve Storia, in cui si narrano le cagioni della passata guerra fra lo Imperadore e la Casa Ottomana, e ciocche nell'assedio di Vienna, e per alcun tempo da poi a Turch i avenne; composta da uno storico turco, e nella nuova volgare favella ridutta. A l Signor P ietro Garzoni, Bologna, Costantino Pisarri, 1709. (A Bologna non si trova : esiste nella Bibl. Nazionale di Budapest : la citano l ’Apponyi ed il Veress. Certo è la stampa del Ms. 57 carte 407- 446 « Relazione dell’ assedio di Vienna fedelmente dall’ idioma turco tradotta »).
Brieve ris tre tto del Saggio fisico intorno alla storia del mare scritta alla Regia Accademia delle Scienze di Parigi, ora esposto in una lettera a Cristino M artinelli, nobile veneto. Venezia, 1711, presso Andrea Poletti. (Annotazioni intorno alla grana de’ Tintori detta Kermes. In una lettera ad Antonio Maria Vallisnieri).
Dissertano de generatione fungorum ad Joannem Mariani Lancisium. Romae, 1714, presso Frane. Gonzaga.
Lettera a Clemente X I circa Tesarne del L itto ra le del M. Adriatico. (1715). (V. Bologna vecchia, voi. 4°, carte 131-134).
Lettera al Sig. Antonio Vallisnieri. in Opere di. A. Vallisnieri. Tomo 2, p. 359.
Lettera scritta al Sig. Antonio Vallisnieri intorno all'origine delle anguille. del 21 giugno 1717. « Giornale di Venezia », Tomo 29, p. 206.
n is to ire physique de la mer. Amsterdam, 1725.Danubius Pannonicus-Mysicus observationibus geographicis, astronomicis
Hydrographicis, historiéis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus. Ilagae, Ametelodami, 1726. (La versione francese, pure in sei volumi, fu stampata a ll’A ja da Giov. Swart, nel 1744).
La Hongrie et le Danube. Compendio dell'Opus Danubiale. A ja, p. Giov. Swart, 1741. (E ’ citato dal Michieli).
A tti legali per la fondazione dell' Institu to delle scienze ed a rti libera li - per memoria a tu tti g li ordini ecclesiastici e secolari della città di Bologna. Bologna, Stamperia di S. Tomaso d’Aquino, 1728.
(Contiene: — Instrumentum donationis... favore... Senatus et eivitatis Bononiae in gratiam novae in eadem scientiarum insti- tutionis. 11 genn. 1712. — Donatio... facta RR. Patribus S. Dominici. 12 luglio 1724. — Conventiones inter.... et reverendos Patres S. Dominici. 18 marzo 1727. — Cessio et conventiones inter... et Accademiam Clementinam. 21 marzo 1727. — Conventiones
M. LONGHENA - BIBLIOGRAFIA MARSILIANA 505
inter... et homines arcliiconfraternitatis Sanctae Mariae <le N ive (22 marzo 1727). Contiene la narrazione della sua schiavitù e della sua liberazione, pp. V I-X II. — Strumento di una seconda donazione fatta al Senato di Bologna a favore dell’istituto delle Scienze in essa eretto. 24 marzo 1727. Contiene le Costituzioni dell’ istituto delle Scienze. — Conventiones inter... et L. Alexium et Ch. Ma- riam fratres de Saxis. 5 maggio 1719. — Cessio seu donatio... RR Patribus S. Dominici. 26 giugno 1728).
Stato m ilitare dell’im perio ottomano, incremento e decremento del medesimo. Haya ed Amsterdam, 1732, voi. uno in due parti. (C ’è una traduzione in russo del 1737).
Epistola de Ponte sub im perio T ra jan i supra Danubiutn extructo ad... patrem Bernardum de Montfaucon. Novus thesaurus antiquita- tum romanarum congestus ab Alb. Henr. de Sallengre. Tom. 2” A ja, 1748, pp. 989-994. Nel « Giornale di Venezia » Tomo 22, p. 116. (E ’ la lettera originale che il Sallengre tradusse in latino).
Lettere al Canonico Paolo Gagliardi sopra lo stato antico dei Cenotnani. Nelle « Memorie Istorico-Critiche intorno all'antico stato dei Ce nomani ete. raccolte da Antonio Sambuca ». Brescia, 1750, p. 336.
Memorie idrauliche sulle acque stagnanti. (V . Raccolta di autori ital. del moto delle acque. Tomo X V I).
Alcune lettere inedite al Canonico Le lio T rion fe tti per la fondazione d ell'is titu to delle Scienze di Bologna, pubblicate da G. Giuseppe Bianconi. Bologna, Sassi, 1849.
Gli atti dell’Accademia di Lipsia. Tom. I, suppl. p. 207. Si lodano « le osservazioni e lo studio sul Bosforo tracio ».
A tti dell'Accajdemia di Parigi 1710, carte 23. E ’ riportato un estratto del saggio de L 'h is to ire physique de la mer. A pag. 48 sono inserite le Obscrvations sur V analyse des Plantes Marincs et principalement du Corail rouge. A pag. 69 le Observations sur Ics plantes de la mer.
SCRITTI SUL MARSILI
A d o l f o A l b e r t a z z i - Avventure e m ilita ri imprese d’uno scienziato ( I l Conte Luigi Ferdinando Marsigli). Nuova Antologia, 1901, luglio, pp. 252-68.
R. A l m a g i à - Sullo sviluppo della conoscenza delle profondità marine. « Boll, della Soc. geogr. ital. », 1905, p. 440.
M a r ia E m i l i a A m a l d i - La Transilvania attraverso i documenti del Conte L . F. M orsili. « L ’Europa orientale », 1927-29.
P. A m a t d i S. F i l i p p o - Biografia dei viaggiatori italiani. Voi. I, pp. 709-714.
506 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI
G i o v a n n i A b n a u d - Monografie d 'illustri ita liani. I l Conte L. F. M arnigli. « Il Politecnico » voi. X, 1861, pp. 171-198.
G. I». Baseggio nel Tipaldo - Biografìa degli Italiani illustri. 1841, voi. 8, ( Vita del M orsigli).
M a t h a e u b B a z z a n i - In obitu Comitis .4. F. M orsili. Bononiae, 1734..T. B e l ic z a y - M ors ig li élete es munk&i. Budapest, 1881.C o s im o B e r t a c c h i - Geografi ed esploratori ita lian i contemporanei. Mi
lano, 1929, Capitolo I, pp. 21-4.G. G. B o l l e t t i - D ell’origine e de' progressi dell'is titu to delle Scienze
di Bologna e di tutte le Accademie ad esso unite. Bologna, L. Della Volpe, 1767. C’è un'edizione anteriore, del 1751 ed una edizione posteriore, del 1780, anonima.
F i l i p p o B o s d a r i - Francesco Maria Zanotti nella vita bolognese del "100. A tti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le Romagne. Quarta serie, voi. V i l i , fase. I - I I I , pp. 5-11.
G B r u z z o - Dei movimenti delle acque del Benaco in un Ms. del 1725. Contributo alla storia degli studi limnologici in Italia. A tti del V I I congresso Italiano. Palermo, p. X LV I. [Comunicazione non svolta].
— — Lu ig i Ferdinando M orsili. Nuovi studi sulle sua vita e sulle opere m inori edite ed inedite. Bologna. Zanichelli, 1921.
V ic t o r C a r u n - H isto irc de la zoologie. Parigi, 1880, p. 356 e p. 365.T i t o C h ie r i c i - I l Co. Lu ig i F. M orsili. Cenni biografici. Bologna, 1871.De bononiensi scientiarum et artium instituto atipie Aeademia Com-
mentarii. Bologna, 1745, tom. 2, parte I. De senatoribus insti- tuti praefectis, pp. 5-11. De Corallio, pp. 74-78.
Giov. B a t t . C o r n i a n i - I secoli delle letteratura italiana. Brescia, 1812, voi. 8”, pp. 339-351.
E m i l i o C o s t a - La fondazione dell'is titu to delle Scienze ed una riform a dello studio bolognese proposta da L. F. M orsili. Studi e memorie per la storia dell’tJniversità di Bologna. Voi 5° (1919).
Enr. A lb . D ’A lb e rt is - Come la navigazione da diporto possa validamente contribuire allo studio della geografia fisica dei mari e dei laghi. A tti del I Congr. geogr. ital., voi. 2«, Genova. 1894, p. 72.
G . D a l l a V e d o v a - L'oceanografia. A tti della Soc. ital. per il progressodelle Scienze. Napoli, 1910, pag. 61.
B e r n a b d o D e F o n t f .n e l l e - Ocuvres. Paris, 1766. A l tomo VI, pag. 399- 417, Elogc de M. la comte M orsili.
H. P. I ) e I . i m i e r s - H isto irc de VAcadémie appellée l ’In stitu t des scicn-ces et des arts établi à Boulogne en 1~12. Amsterdam. 1723.
J o h a n n D o p p l m a y r - Historisclie Nachricht von den niirnbergischen Mathematica und Kiinstlern. Niirnberg, 1730.
P e r ic l e D u c a t i - L. F. M orsili. « Resto del Carlino >, 3 febbr. 1929.
M. LONGHENA - BIBLIOGRAFIA MARSILIANA 507
G. B. E b c o l a n i - Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna dalla sua origine a tutto il 1880. Bologna, Zanichelli, 1881.
A n g e l o F a b r o n i - Vitae Italoruni doctrina exccllentìum qui saeeuìis X V I I et X V I I I fioruerunt. Voi. 5*, pp. 0-64. Pisa, 1779.
G io v . F a n t u z z i - Memorie della v ita del Oen. Co. L. F. Marnigli. B o
logna, 1770._ — S critto r i bolognesi. Voi. 5°, pp. 286-327. Bologna, 1786.La Festa letteraria del R. Liceo Galvani e il conte Ferd. Marsili. R i
cordo di S. F. De Dominicts. Bologna. Fava e Garagnani, 1874. [E ' un cenno del discorso del Prof. Alfonso Colognesi, cenno pubblicato dalla « Gazzetta dell'Emilia » del 24, 25 e 26 marzo 1874. I l discorso del Prof. Colognesi non fu pubblicato, nè m 'è riuscito trovarlo presso 1 parenti].
L o d o v ic o F r a t i - I l viaggio da Venezia a Costantinopoli del Conte Lu ig i Ferdinando M ors ili (1679). Dal Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie, 1901.
------- L 'Is titu to delle scienze nel 1116. « I l Progresso», Bologna, 12 gennaio 1922.
------- I l settecento a Bologna. Remo Sandron, 1923, pp. 147-168.------- Catalogo dei manoscritti di L. F . M arsili conservati nello B iblio
teca Universitaria di Bologna. Firenze, Leo S. Olschki, 192S.I c i l i o G u a r e s c h i - L. F . M orsigli e Ui sua opera scientifico. Memorie del-
l ’Accademia delle Scienze di Torino. Serie 2*, voi. 65, 1916.— — La chimica in Ita lia dal 1750 al 1800. Parte I, pag. 3*57.G iu s e p p e G r atteri - L. F. M ors ili fondatore dell'oceanografia. « R e s to
del Carlino », Bologna, 2 luglio 1929.S iegm und GfNTHER - Hamlbuch dcr Geophysik. Stu ttgart 1897-!>9,
voi. 2”. pag. 376.G a e t a n o L e n z i - Descrizione dell'is titu to delle Scienze di Bologna, col
quadro delVUniversità ed i l novero delle Accademie. Bologna, 1841.G. L eske - Abhandlungen zur Naturgeschichte Chemie Anatomie, Me-
dizin und Physik aus den Schriften des Instituts der Kiinste u. Wissenschaften zu Bologna. Brandenburg, 1781.
M. L o n g h e n a - Un uomo di anni e di scienza nel '700, L. F. Morsili. L a c Cultura Moderna » , maggio 1926. pp. 264-273.
------- L. F. M arsili e le sue osservazioni sul Mare Adriatico. Bologna,1926, pp. 10.
—- — Alpinismo nel Settecento. Bologna, 1927.------- I l gen. L. F. M arsili e la raccolta delle sue carte geografiche.
X Congresso geografico. Milano, 1927.------- L. F. M arsili sull’Appennino Modenese e sul Cintone. « Archigin
nasio ». X X IV , 1-3 (1929), pp. 31.------- Uno dei fondatori dell'oceanografia - L. F. Marsili. t Le vie d’I
talia », sett. 1929. pp. 707-712.
508 MEMORIE INTORNO A L . F. MARSILI
M. L o n g h e n a - Una lettera sul viaggio da L ivorno a Londra ed alle coste olandesi di L. F. M ors ili ad H. Boerhaave. Annuario del R. Liceo Scientifico A. Righi. Bologna, 1929-30.
-------Un uomo d’arme e di scienza del "100 - L. F. M ors ili (1658-1730).Casa Editrice Alpes, Milano, 1930.
M ic h e l e M a y l e n d e r - Le Accademie d 'Ita lia . Accademia degli Inquieti. Voi. 3° pp. 300-01. Accademia delle scienze dell’ istituto, Voi. 5*, pp. 126-8.
S e r a f in o M a z z e t t i - Memorie storiche sopra VUniversità e VIstituto delle Scienze di Bologna e sopra g li stabilim enti e i corpi scientific i alla medesima addetti. Bologna, 1840.
M i c h e l e M e d ic i - Memorie storiche intorno le Accademie scientifiche e letterarie della città di Bologna. Bologna, Sassi, 1852.
A. A. M i c h i e l i - I l fiume Danubio e l'Ita lia . « Boll, della SocietO geografica italiana ». Anno LV, 1921, pp. 397-103.
G i u s e p p e M o n t i - De scriptis Comitis A loysii Ferd. M arsilii. De bono- niensi scientiarum et artium instituto atque Academia Commentarli. Bologna, 1746. Tomo 2% Parte 2*, pp. 378-388. [Molti poi sono gli accenni al Marsili in questo ed in altri volumi dei Commentarli ].
A u g u s t N e il r e ic h - Die botanischen Leistungen des Dr. Burser i i. des Conte M ors ig li in Nieder. Oesterreich. (Verhandlungen d. K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien), 1866.
G. P ie t r o N ic é r o n - Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres. Tom. 26°, ag. 212-227.
C h a r l e s N o r d m a n n - Quelques rechcrclies récentes sur l'océan. « Revue de deux mondes », 1913, p. 218.
O . P e s c h e l - Geschichte der Erdkunde. München 1S78, p . 733.L. D. G. H. D. Q u i n c i - Mémoires pour la vie de M. le Comte De M ar
silii. Zürich, 1741.
L. R a v a - L ’opera di L. F. Marsili. Rievocazione fatta in Senato e riportata dal « Resto del Carlino » del 17 gennaio 1929.
Relazione della Funzione pubblica avuta in Bologna 11 13 di marzo 1714 in occasione di aprire il nuovo Instituto delle scienze. Bologna per C. Pisarri, 1714.
V. R o s e n - Remarques sur les manuscrits orientoux de la collection M arsigli à Bologne. A tti della R. Accademia dei Lincei. Serie 5*, vol. X I I della classe di Scienze morali, 1885.
A l b a n o S o r b e l l i - L u ig i F. M arsili e VUngheria. «R es to del Carlino», 28 marzo 1929.
C a r l o T a g l i a v i n i - I l lexicon marsilianum. Un dizionario latino-rumeno- ungherese del sec. X V II . Studio filologico e testo. Bucarest, 1930 (Accademia Rumena).
M. LONGHENA - BIBLIOGRAFIA MARSILIANA 509
C a b l o T a g l i a v i n i - L. F. Marnigli e la scrittura runica dei S icu li di Tran- silvanm. « I l Comune di Bologna », aprile 1930, pp. 9-17. [SI veda la bibliografia per quel che riguarda i rapporti del Marslli ooll'Un- gheria e con i Rumeni].
M i c h e l e T a l m a n n - Elenchus librorum orientalium manuscriptorum a D. Coin. A. F. M ors ili collectorum. Vienna, 1702.
J. T h o u l e t - Océanographie. Paris, 1890, p. 281.—. — Un des fondateurs de V Océanographie. « Revue scientifiques »,
tom. V I I I (1897), p. 801 e segg.E n d b e V e r e s s - A bolognai M orsigli - iratok magyar vonatkozasai. Bu
dapest, 1906.------- O róf M ors ig li Alajos Ferdinand olasz hadi mcrnôk jelentesei es
terképei Budavar 1684-1686 ik i ostromuirol, visszafoglalasarôl es helyrajzàrôl A. székesfôvaros megbizasabol bolognai, romai, karlsruhei es becsi leveltarakban gy iijto tte s kiizli, bevezetessel és jegyzetekkel bôvitve. Budapest, 1907.
------- I l Conte L . F. M ors ili e g li Ungheresi, in « Studi e memorie i>erla storia dell’UniversItà di Bologna », vol. X, 1929.
G io v a n n i V e r o n e s i - Storie e r itra tt i di uomini utili-, benefattori del- l'Umanità. Bologna, 1835, voi. 2“.
Vite e r itra tt i di 30 Illu s tr i Bolognesi. Bologna, 1835, pp. 11-18.C h r is t ia n o W is s m ì t l l e r - Der geograyh Lu ig i F. O raf Morsigli. Dis
sertation. Ntirnberg, 1900.F. M . Z a n o t t i - De bononiensis Scientiarum et artium In s titu ti atque
Academiae origine et historia. Commentarli dell'Accademia, vol. I, pp.1-50.
G ia m p ie t d o Z a n o t t i C a v a z z o n i - Vita del Ocn. L. F. Morsili, in Storia dell’Accademia Clementina Bologna, 1739, vol. I, pp. 113-132.
E ’ annunziata una monografia del Dott. B e l a B e v il a q u a del Museo M ilitare di Budapest sul Conte L. F. Marsili.
A cura di M a r io L o n g h e n a
INDICE
P r e f a z i o n e ......................................................................................Pag.
Lodovico Marinelli - L u ig i Ferdinando M arsili uomo di guerra »
Renzo Reggiani - La riabilitazione m i l i ta r e ..................................»
Luigi Simeoni - I l Generale M arsili e la difesa dello Stato pontific io nel 1 7 0 8 -9 .........................................................................»
Giuseppe Bruzzo - L ’opera m ilitare e scientifica d i Lu ig i Ferd inando M arsili nella difesa della costa pontificia dell' Adriatico »
Bruno Ducati - La marineria M usulm ana ...................................... »
Mario Longhena - L. F. M ars ili g e o g ra fo ...................................... »
Giovanni Natali - Uno scritto d i Lu ig i Ferdinando M ars ili su lariform a della Geografia .............................................................. »
Alberto Gianola - L. F. M arsigli e la T ra n s ilv a n ia ................... »
Michele Gortani - Idee precorritric i d i Lu ig i Ferdinando M arsili
su la struttura dei m o n t i ......................................................... »
Antonio Baldacci - 1 fondamenti botanici nell’ opera di L. F. M arsili »
Lavoro Amaduzzi - G li strumenti di f i s i c a ................................. »
Pericle Ducati - Le anticaglie d i Lu ig i Ferdinando M arsili . . »
Luigi Rava - I l conte M arsigli e i l C a ffè ...................................... »
Ettore Bortolotti - La fondazione dell’ Istituto e la R iform a dello
« Studio » di B o lo g n a .............................................................. »
Lodovico Frati - L. F. M arsili a P a r i g i ...................................... »
Albano Sorbelli - La Stamperia d i L. F. M a r s i l i ........................»Bibliografia Marsiliana, a cura di Mario L o n g h e n a ................... »
V
157
91
145171187
221
233
257277321329357
383473479503




















































































































































































































































































































































































































































































































































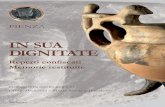
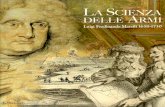












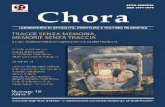

!['Pie Memorie' [An Unknown Motet by Noel Bauldeweyn]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334bb0b6c27eedec605dd06/pie-memorie-an-unknown-motet-by-noel-bauldeweyn.jpg)


