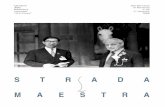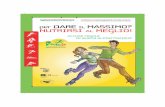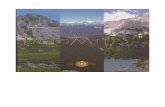Una strada per il Moncenisio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Una strada per il Moncenisio
ATLANTE STORICO DELLA "PROVINCIA DI SUSA"
a cura di
Pier Giorgio Carino - Livio Dezzani
Le Strade - Vol. l 0
UNA STRADA PER IL MONCENISIO da Vittorio Amedeo II di Savoia
a Napoleone I Bonaparte
Ed. Tipolito Melli - Susa
ATLANTE STORICO DELLA "PROVINCIA DI SUSA"
a cura di
Pier Giorgio Carino - Livio Dezzani
Le Strade - Vol. 1 °
UNA STRADA PER IL MONCENISIO da Vittorio Amedeo II di Savoia
a Napoleone I Bonaparte
Ed. Tipolito Melli - Susa
© Tipolito Melli s.n.c. - Susa -Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione del testo, delle stampe e delle fotografie.
Finito di stampare dalla Tipolito Melfi s.n.c. nel mese di ottobre 1986
INDICE
-Ai lettori. ....................................................................................... .
-Prefazione di Augusto Cavallari Murat . ..... , . . . . . . . . . . .... .... . ...... . . . . . . . ...... . . .
-«La città di Susa e le comunità della Valle Cenischia nella seconda metà del XVIII secolo».
- Cenni di vita economica e sociale. l) Un confronto su scala regionale . ............................................ .. 2) Susa e le comunità della V al Cenischia . .................................. . .
3) Considerazioni conclusive . .................................................... .
-«La viabilità per il Moncenisio nel XVIII secolo». 4) Il tracciato viario ad inizio settecento . .................................... . 5) Gli interventi del 17 49 nella parte alta del percorso . ................ .. 6) Gli interventi del 1752 e la "Nuova strada" . .......................... . .
- Inserti: documentazione iconografica I - La viabilità Susa-Venaus-Novalesa-Ferrera tra XVII e XIX secolo
(favole I·XIII) . ............................................... .................................................. .
II · La viabilità nella zona delle Scale tra XVII e XIX secolo (favole XIV· XXV) ........... .
7) Le Òpere di manutenzione . .................................................... . 8) Nuove soluzioni per l'ingresso in �ovalesa . ............................ .. 9) La strada coperta del Moncenisio . .......................................... .
10) Il collegamento viario tra 'la strada reale ed il monastero di San Pietro in Novalesa . ........................................................ ..
11) Le cappelle della piana di San Nicolao . .................................... .
12) L'antica strada del Moncenisio: oggi, vincoli ambientali e proposte di salvaguardia . ...................................................... ..
- Inserti: cartografia di sintesi III - La viabilità Susa-Venaus-Novalesa-Ferrera, tra XVII e XX secolo (Tavola n. 1 in
allegato) . ........................ .................... , ...................... ........... ................ ............ .
IV - La viabilità ne/h zona delle Scale, tra XVII e XX secolo (Tavola n. 2 nel testo) ........ .
-Appendice I: I lavori della strada napoleonica in rapporto al perc0rso settecentesco . ... . . .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .... . . . . . .. ·-· . . . . . . . . ..... . . . . .... . . . . ... .. : .. . . ... . .
-Appendice II: Gli interventi del 1752 nel rendiconto finanziario del misuratore Benedetto ...................................................................... .
-Appendice III: Toponomastica tra '600 e '700 lungo la strada reale in vili Cenischia . ................................................................................. .
-Appendice IV: Gli Intendenti della Provincia di Susa nel XVIII secolo . .. .
-Bibliografia e fonti documentarie . ...................................................... .
-Tavola in .allegato - Antica e nuova viabilità per il Moncenisio. Visione cartografica di insieme: r·iferimenti toponomastici; percorribilità dell'antica strada.
pag. 5 )) 7
)) 11 )) 12. )) 13
)) )) ))
19 27 30
)) 54 )) 80 )) 104 )) 107 )) 108
)) 111 )) 117
)) 122
)) 125 )) 129
)) 130
>> 133
)) 136 >> 141 )) 142
5
AI LETTORI
Scopo del presente volume è di illustrare il percorso stradale che da Susa saliva al Moncenisio, prima delle imponenti opere fatte eseguire da Napoleone all'inizio dell'ottocento. Lo studio analizza particolarmente il tracciato utilizzato nella seconda metà del XVIII secolo, periodo in cui importanti lavori migliorarono la percorribilità della grande strada transalpina, già da secoli fittamente utilizzata.
Il volume si presenta, altresì, come primo 'élemento di una collana- denominata "Atlante Storico della Provincia di Susa" -che si pone l'obiettivo di illustrare, essenzialmente, aspetti "materiali" della storia della nostra valle.
Negli ultimi anni si è assistito ad una importante ripresa di attenzione per la storia valsusina: lo spirito dei volumi che comporranno questo "Atlante Storico" è quello di riuscire a ricostruire materialmente l'ambiente nel quale tali eventi ebbero corso. La rete stradale, i corsi d'acqua, gli insediamenti civili e militari, le attività produttive sono svariati elementi che caratterizzarono una valle mai isolata, ma sempre strettamente legata ai grandi traffici europei.
In tale logica, vogliamo sottolineare due elementi caratteristici di questo volume. In primo luogo, gli "Inserti: documentazione iconografica" che, pubblicando e descrivendo venticinque cartografie e disegni di insieme dedicati all'antico percorso per il Moncenisio, apportano elementi spesso inediti ad una puntuale ricostruzione sul terreno della viabilità settecentesca.
In secondo luogo gli "Inserti: cartografia di sintesi" costituiti da due serie di tavole esplicative consentono sia un confronto tra l'antica e l'attuale viabilità, sia di localizzare gli oltre 150 toponimi che costituiscono un'appendice al volume. Le tavole in allegato, come sarà illustrato dal cap. 12, vogliono avere, tuttavia, anche un altro scopo: quello di servire come base di riferimento per ripercorrere, oggi, ciò che resta dell'antica viabilità, ponendosi anche come elemento di riflessione per gli interventi di salvaguardia e di tutela storica-ambientale relativi alla Val Cenischia.
Infine, si ricorda ai lettori che lo studio del tratto iniziale della strada reale del Moncenisio -dall'uscita di Susa al ponte di San Rocco ed al passaggio sotto il forte della Brunetta - sarà trati-ato in un successivo volume dell'''Atlante Storico'', espressamente dedicato al nodo viario di Susa.
Gli autori
Ringraziamenti
Gli autori intendono rivolgere un particolare ringraziamento ad Ettore Patria, in primo luogo per il suo fondamentale impegno a promuovere la conoscenza della storia va/susina, e quindi per le notizie ed i documenti da lui cortesemente reperiii e fomiti, come ed unitamente al figlio Pier Luca.
Il ringraziamento è da estendere ad Alfr·edo Gilibert, per aver gentilmente messo a disposizione la sua collezione di immagini e memorie va/susine.
Si ringraziano altresì per la c�llaborazione e la disponibilità le Amministrazioni Comunali di Venaus e Novalesa, nonché l'Amministrazione Provinciale di Torino, di cui è da ricordare il costante impegno per la salvaguardia e la valorizzazione dell'Abbazia di Novalesa.
7
PREFAZIONE
di Augusto Cavallari - Murat
Lo studio filologico scavante scientificamente nelùz memoria della storia, come per trarre una stratigrafia delùz polpa esistenziale urbanistica, la quale si rinnova e cancelùz continuamente, esige un particokzre atteggiamento mentale ed una disinibita moralità professionale.
Lo dissi molti anni fa, proponendo che differenti e non conniventi siano le équipes che rispettivamente studiano il passato filologicamente e Néquipes che progettualmente propongono le i m-· magini antz'che che possono utilizzarsi nelkz pianificazione proiettando le n{d futuro.
La misceùztura delle due dette specializzazioni di operatori oppure anche solo la connivenza d'essa, a mio avviso determinerebbe inquinamento e·dannositd. Nell'arte-scienza urbanistica in generale e nell'arte-scienza ter7itoriale in particokzre, non ritengo esistano vie di mezzo.
Ecco perchè, avendo visto lavorare gli autori del/p indagine· sulle vicende delle strade del Moncenisio tra i tempi di Vittorio Amedeo II di Savoia e quelli di Napoleone I Bonaparte, accondiscendo a presentar/i, Pier Gi01gio Carino e Lìvio Dezzani, quali esemplari di persone di quel primo tipo di équipes che non destano sospetto di parzialità e di disattenzione; quali personaggi coi quali simpatizzo, perchè sono storiografi e come storiografi non possono distorcere la realtà per tornaconti speciali.
Dai loro eùzborati emerge chiaramentè che i tracciati stradali extraurbani non furono applicazione di mera geometria matematica su una geomeflia topografica qualsiasi; bensì ebbero anche motivazioni economiche e sociali maturate nelùz storia degli uomini ed in continua metam01fosi . . Tali motivazioni economiche e sociali vanno considerate particolarmente in relazione al flusso delle ineluttabili modificazioni topografiche di essenza idraulica e geologica estranee alle determinazioni umane; quantunque le motivazioni economiche e sociali siano fenomeni pure di sofferto contrasto all'ineluttabilità dei fenomeni naturali; sono la contrapposizione degli uomini agli accadimenti materiali di natura.
Nel presente racconto storiografo diventa fascinante l'immagine d'un taritorio che vividamente trasmuta dalla uniformità distributiva della gente di civiltà romana e benedettina (come wr manto continuo sia pure modulato nei modi dei gromatici veteres e dei neogromatici medioevali) ad una discontinuità di localizzazione ·umana in relazione alle integrazioni dei redditi (assommandosi alla produttività agraria la redditizia occupazione dell'organizzazione dei traspor'fi, quale fu specificamente l'attività dei portatori, mulattieri, portantini e vetturini, cioè guidatori di 11Sedie11 ch'erano carrozze, eccetera).
Le minuscole comunità delùz Valle Cenischia (Mompantero, Giaglione, Venaus, Novalesa abbandonata dall'Abbazia, Ferrera) s'eguagliano quasi tra loro e con l'operante comunità segusina, come se questa fosse solo pari tra eguali comunità concatenate nonostante la differente dignità burocratica e amministrativa di Susa nelùz "Provincia" ad essa intestata: ciò accadeva nei tempi felici dei secoli XVII -XVIII allorchè pùì che mai era utile il lavoro del tmsbordo oltre monti. Invece la vitalità socio-economica delle piccole comunità cenischie, prima concatenate in armonica esistenza, s 'appiattr' nel puro livello agricolo per quasi azzerarsi a 1/orchè il tracciato stradale napoleonico di valico rese inutile il locale mestiere dei trasbordatori, in quanto il nuovo tracciato francese si specializzò in vantaggio di genti lontane (a Lione, a Torino, a Milano).
8
Attualmente si constata che il declassamellto è diventato piiÌ robusto trasfomtando alcune delle co,mmità cenischie in me<i toponimi inconsistenti oppure talora cancellati a fronte della prestanza urbana della città di Susa (come mostrano illuminanti statistiche di raffronto).
È ovvio che siffatta cinematografica vividezza delle antiche mutazioni del tipo indicato costituiscano per me qualità interessante di piacevolezza estetica nella attuale storiografia del te>ritorio; gidcché oggi appare inestimabile "capitale " il paesaggio nell'accezione conquistata dalla pertinente disciplina.
Il detto paesaggio va/susino, nel tratto cenischio preso in considerazione, s'impreziosisce notevolmente per la presenza del Forte della Brunetta, gigantesca opera militare destinata a costituire ostacolo non raggirabile, causa d'arresto certissimo degli eserciti valicallli, immagine d'intimidazione suprema. Per essere stato ricavato da/ monte incombente (coi prestigiosi due Berta/a e De \Villencourt e Pinto di Barré) mediante laba�iosissimo scavo intemo ne/la roccia e mediante rifiniture della superficie manipolando/o quasi fosse una scultura onde accenturame il carattere geometrico prezioso di macchina militare indemolibi/e ed esaltame il carattere suntuosamente prezioso d'oggetto antico, primigenio quanto le Alpi nonostante la somiglianza tipologica con /e fortezze costruite nella pianura da muratori anzichè da minatori, la sua lavorazione costituì localmente e per alquanto tempo fonte di ulteriori guadagni per la popolazione che provvedeva parzialmente ad alloggiare le maestranze dell'eccezionale cantiere.
Io, scrittore innamorato del tenitolio e descdttore dello stesso (appartenente alla nuova tendenza collimante non con il primo Barthes ma con l'ultimo meno noto Barthes), estrapolerò qui a modo mio, ovviamente se me lo pe>metteranno gli scrupolosi amici storiografi forse pitì.sensibili alla prospettiva esattissima materiale del citato Braudel.
Pertanto mi sia concesso di volgere lo sguardo indietro e privilegiare secondo sentimento un momento rispetto ad rm altro, affermando che si può comprendere l'orgoglioso piacere che sicuramente provavano i Savoia p lima della risoluzione napo!eonica a contemplare quella Va Ile Cenischia che dovette apparire loro sul cammino pçr il valico del Moncenisio una serratura inviolabile in fanna di elegante araldica fibula. Per la Monarchia assolutistica e guen·iera dei Savoia la Brunetta dovette essere un monile splendido e fervoroso, fatto di nastri aerei (i tomanti), percorsi da fa�miche emblematiche, incentrati su quella specie di "pietra dura", entro la quale si muovevano le colorate divise degli mmigeri vigilanti sui destini della plima piccola patria subalpina.
Ecco concludersi con una pennellata figurativa questa mia prima emozione di lettore attento e interessato.
Tuttavia non posso tacere d'altre due osservazioni di lettore altrettanto attento ed interessato: l 0: si tratta del contributo che il presente studio offre a chi si interessi della questione della struttura delle "Provincie " e dei loro capi gli "Intendenti ", problema che è stato recentemente sviscerato partendo dal >igoroso maneggio archivistico e non anche dall'azione. operativa osse>vata nella realtà in atto come si è stampata sul paesaggio; 2 °: si tratta poi del confronto istituzionabile tra i mezzi operativi sabaudi ottocenteschi e quelli successivi francesi nell'ambito ottocentesco della scuola dei "Ponts et Chaussées" ..
Vediamo/i separatamente. Certamente la prima considerazione, essendo la meno nota, è anche la pitì affascinai/le. Essa
affascina scientificamente e solo scientificamente; ma è difficile da seguire e capire per chi non è del mestiere. Chiede attenzione, fiducia ed una premessa.
Questo discorso segusino partecipa alla ricerca dei modelli di comportamento operativo sabaudo dei secoli X VII, X VIII e XIX entro la geografia dell'intera compagine statale di là e di qua delle alpi ed anche a/diVi de/ mare. La conoscenza di siffatti modelli di comportamento operativo
9
passa attraverso l'inqagine delle caratteristiche speciali ed h�epetibili dei concreti reali operatori professionali dei quali tempo fa ci si disinteressava 6astando la supetficiale affetmazione che la professione dell'architetto piemontese fosse unica e si conseguisse dopo un biennio universitario in Torino ed tm perfezionamento presso l'Accademia di San Luca in Roma. Invece in Piemonte non esistettero operatmi d'architettura d'eguale itinerario formativo; non esistettero attività isolate di eroi milici, bensì attività collegiali di uomini inquadrati in un'unica struttura accogliente svariate figure di gamma fisionomica differenziata. Siffatti operatmi collegiali, erano parecchi: architetti civili militari e idraulici patentati come prima detto; ingegneri militari e misura/ori fattisi entro la struttura statale compatta che li usava anche quali architetti formandoli in tale finalità e manovrando/i massicciamente soprattutto tramite gli Intendenti. Tramite gli Intendenti la massa operativa s'inseriva nel vertice dello stato assolutistico, nel Monarca stesso ch'era responsabile di ogni anche minima operazione progettuale ed attuativa.
Gli Intendenti erano come cerniere del processo formativo, occhi e mani del Monarca, collocati in ben detetminate zone del tenitorio. Il quale tenitorio era dapprima frazionato in aree di derivazione feudale con illlitolazione aristocratiche medioevali, cioè principesche, ducali, marchionati, comitali, baronali, signorili, ecc.; ed infine, nella fase di riordino globale in mmonia con le celebri Costituzioni Sabaude (via via promulgate negli anni 1723, 1729 e 1770), trasformate in circoscrizioni amministrative chiamate appunto "Provincie", le quali tuttavia non pervennero a consolidarsi razionalizzate che verso la fine del Settecento alla vigilia dell'incmporamento del Piemonte nella Francia (mentre è noto che a/diVi dei confini franco-piemontesi vennero organizzate successivamente la Repubblica Cisalpina ed il Regno d'Italia).
La Provincia di Susa Sabauda scendeva a valle sino ad Avigliana lungo due paralleli assi, quello della Dora Riparia e quello del Sangone; mentre a Nord confinava con la successiva Provincia di Saint-]ean-de-Morienne.
.,,
Qual' era il reclutamento degli Intendenti? Quale la loro evoluzione professionale? Quale scalata di caniera era riservata a questi che ho chiamato cerniere occhi e mani del Monarca? Potrebbe un improvvisato dittatore di stato totalitario ti10demo sperare di avvalersi d'analoga perfetta organizzazione non avendola egli stesso costruita per proprio comodo, pezzo per pezzo (pezzo non petfettamente eguale agli altri prossimi), organizzando/a in autentica sintesi operante anzichè in semplice sommatoria di elementi prefabbricati?
Alcune parziali lisposte ai quesiti ho cercato di fomire nell'(lrticolo inserito nel catalogo della Esposizione di Carouge ( 1986) spaziando da Cagliari e Sassari a Nizza Marittima ed a Annecy, oltreché ad Alba e a Casale Monfenato. Le risposte definitive non potranno aversi che dopo avere perlustrato tutte le Pmvince dell'intera compagine statale sabauda. Ricordo, ad esempio, d'avere impostato intuitivamente il problema a Cagliari a proposito del Capitano Ingegnere Saverio Belgrano di Fama/asco e dell'Architetto in quell'isola sarda Giuseppe Viana trasfetito poi a Carouge ( 1 961) presentando il primo elenco degli operatmi d'architettura colà (si veda per comodità la ristampa di quei primi studi in "Come carena viva ", edito dalla Bottega d'Erasmo tminese, 1981-82). Se già negli studi pitì t·ecenti si notano nel m bino scientifico le quote di partecipazione attiva nel dare forma alle città ed alle campagne (riserbandò la quota più alta agli Ingegneri militati) tuttavia il problema della piena conoscenza del gigantesco organismo statale, con tutte le variazioni locali e con tutte le analogie di modello comportamentale, resta aperto e vivo.
Incuriosisce nell'attuale libro il notevole personaggio Antonio Bongino che succedette a capo della Provincia segusina nel 1750 al Nicolis di Bmndizzo, ma al quale in effetti fu affidato 1111 tratto di responsabilità esorbitante la collana delle comunità prima elencate afferenti alla sede nonna/mente, cioè con l'aggiunta del tratto cosiddetto "delle Scale" facente giutidicamente parte dell'Intendenza della Mariana. Questo adattamento pmticamente necessario al buon andamento delle strade di valico e trasbordo noti è che 11110 delle tanto svariate derivazioni della nonnalità
lO
che accadevano. Inoltre di Bongino si conosce ora 14 provenienza, dei misura tori, e l'approdo fi· naie ne/177 3 a Intendente Generale presso la Corte. Vicenda personale paralle/4 a quella di Felice De Vincenti, che dal grado modesto di Ingegnere e Ingegnere Capitano pervenne a coprire l'importantissimo molo di Presidente del Collegio degli Edili in Toli11o col grado di Generale e quasi arbitro in moltissime cose anche nel conferimento delle Patenti d'architetto.
Nell'attuale libro, assoluta novità è costituita dall'intreccio con 14 schiera burocratica degli Ufficiali della connessa schiera degli Impresali (esempio i Mosca, i Pozzo ed i Rosazza). A questo proposito è da segnahre l'autentica per/4 delle scoperte, appunto l'esecuzione con i soliti Impresati della "galleria eseguita per esperimento" di protezione antineve co11·endo parallelamente o lateralmente alla strada a cielo aperto, di be11 177 metti (sezione larga 4.00 e alta 3.60) progettata forse e diretta tra 1775 e 1779 dal misuratore Boine. Progmitrice delle gallerie montane in zona di valico?
L'annunciata seconda considerazione, quella rehtiva al confronto tra gli opératoti settecenteschi piemontesi e gli operatori ottocenteschi di scuo/4 pmigina, riserba grande interesse scientifico nonostante sia stata parecchio studiata.
Intanto perchè mostra una linea di concomitanza che è anche di collimazione impreveduta; e poi perchè indica l'importanza del mantenimento del/4 cultura tecnologica entm le vie del/4 formazione. del/4 classe politica, le quali oggidì tm po' dappertutto sono state abbandonate, tranne che in Francia.
L'Ècole des ponts et chaussées parigina non era estranea al/4 vita del paese. Educava la dirigenza delh cosa pubblica a fidarsi poco delle improvvisazioni dei /egulei e dei frastomanti al1'ingapopolo. Dagli ingegneri dei ponti e strade di provenienza parigina il re Carlo A{berto trasse il nerbo. dei suoi mirabili spelimentatori tecnico architettonici plima della sconfitta di Novara. Sono celebrati quali modelli civici gli sperimenti stilistici carlalbertini (vedi "Come carena viva", vol. 1 °).
Tuttavia non si deve dimenticare che i diligenti del Risorgimento italiano /urano ingegneri "Ponts et Chaussées" per cominciare da Camillo Benso di Cavour (anche lui impegnato al Frejus) per giungere a Quintit10 Sella, assi portanti del/4 prima politica tmitatia, unitamente ai Menabrea ed ai Pa/eocapa d'affine mentalità raziocinante . .
LA CITTÀ DI SUSA E LE COMUNITÀ DELLA VALLE CENISCHIA NELLA SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
- Cenni di vita economica e sociale -
l. UN CONFRONTO A SCALA REGIONALE.
11
Questa ricerca sulla viabilità attraverso il Moncenisio nel XVIII secolo si apre nella convinzione che sia compito- ed interesse- della storia locale confrontarsi con i risultati della storiografia maggiore, inserendo i propri lavori -forzosamente parziali- nel quadro generale che quest'ultima traccia. Alla storia locale spetta tuttavia anche il compito di fornire alla storiografia maggiore elementi di documentazione e di verifica, allo scopo di meglio comprèndere lo spessore e l 'entità dei fenomeni, spesso descritti ed analizzati solo a scala regionale. La sterminata biografia e casistica che anima i grandi lavori storici del Braudel (1) è la riprova più affascinante di come la storiografia maggiore si nutra del materiale offerto da infiniti rivoli di storie locali.
In primo luogo, è possibile verificare come ii momento di relativa alta congiuntura economica attraversata a metà settecento dalla Valle di Susa-con un periodo di pace ed i cospicui lavori per i forti della Brunetta e di Exilles- corrisponda, a scala più generale, ad un momento economicamente favorey0le per l'intero Stato Sabaudo. Ne da testimonianza il noto studio di Giuseppe Prato (2) �he, con riferimento ai "Popoli del Piemonte", fornisce i seguenti dati, espressi in Hlire" deWepoca:
Reddito Capitale Abitanti Reddito pro capite
1700 . 50.669.625 548. 130. 132
804.367 63
1750
126.307.189 1.6 77.841 .577
1 .174.454 7 1. 4.10
In questo preciso quadro economico s i inseriscono le vicende costruttive della strada del Tenda (3), la maggiore impresa di viabilità che interessò il regno a metà del XVIII secolo. Questa era destinata ad assicurare uno stabile sbocco del Piemonte verso il mare ed a con-
(1) F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), Torino 1982; 3 voll. In particolare i1 3° volume I tempi del mondo è interessante per comprendere come, nel corso del XVIII secolo, si sia messo in moto quel processo di crescita che doveva portare alla società in cui oggi viviamo.
(2) G. PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo del secolo XVIII, Torino 1908. (3) Lo studioso francese Marcel Blanchard dedicò alla viabilità alpina, negli anni '20, alcuni studi estremamen
te documentati e ricchi di riferimenti. Tali lavori, purtroppo poco noti oggi in Italia, sono stati di notevole interesse per la compilazione del presente studio. In particolare si fa riferimento al saggio Les Routes des Alpes Occi
denta/es d l'epoque napo/éonienne (1796-18 15), Grenoble 1920. Si veda anche al riguardo l'Appendice I e le note relative.
12
sentire l'approvvigionamento del sale, anche al di fuori del controllo dei vicini francesi; la strada fu interessata, negli anni '80 del secolo, da importanti lavori, volti ad ottenere un percorso stabilmente carrozzabile. Non si tratta, di certo, di opere importanti e complesse come quelle che verranno realizzate per il Moncenisio sotto il regime napoleonico. Si tratta, tuttavia, di lavori ben più costosi di queJli analizzati da questo studio: basti pensare 'che comportarono hi spesa - solo nel 1782-1784-di oltre 3.000.000 di lire. Onere pesantissimo per le finanze del Regno che diede origine ad una contribuzione straordinaria, di cui troviamo traccia anche nei bilanci dei vari comuni della nostra valle.
In secondo luogo, dal confronto con gli studi condotti dal Venturi sul "settecento riformatore" (4) possono derivare spunti di notevole interesse per meglio inquadrare la figura del principale attore nella vicenda della nuova strada per il Moncenisio: l'intendente della Provincia di Susa, Antonio Bongino (5). Avremo modo, nei paragrafi seguenti, di ritornare sugli atteggiamenti illuministici di questo amministratore pubblico dell'ancien régime sabaudo; atteggiamenti che naturalmente vanno visti nel contesto degli usi e dei modi di pensare del settecento. Dall'ampio testo del Venturi risulta tuttavia chiaro come finanzia, tecnica, economia politica e grandi investimenti infrastrutturali siano -a metà del XVIII secolo- elementi nuovi, ma già affermati, nel dibattito politico dello Stato Sabaudo. È questo, pertanto, il quadro di riferimento in cui dobbiamo iJ?serire - per meglio comprendere e valutare- sia la situazione socio-economica dei singoli comuni, sia il lavoro intrapreso per potenziare la strada del Moncenisio.
2 . SusA E LE coMUNITÀ DELLA VAL CENrscHrA. Per meglio comprendere la vita economica e sociale della provincia di Susa (6), a metà del
XVIII secolo, ci è di grande aiuto l'indagine che il "Generale di Finanze" -l'equivalente
(4) F. VENTURI, Settecento li/om/(1/ore, Torino 1969-1984, 5 voll. Si fa particolare riferimento al1 ° volume; le prime righe del capitolo VI ben rendono il senso dell'epoca alla quale questo studio fa riferimento: Nel 1748 si era aperto il pùì lungo pe1iodo di stabilità e di pace che mai abbia avuto l'Italia dell'antico regime ... gli italiani non videro guerre né mutamenti di frontiere (con l'eccezione, marginale, della Conica) Ira i/1748 e la Rivoluzione Francese. Mezzo secolo di Pace.
(5) l3ongino Antonio, avvocato. Il28 luglio 1740 nomina a primo ufficiale dell'Intendenza Generale delle Fabbriche e Fortificazioni. Dal 28 gennaio 1750 sino al 7 niaggio 1755, intendente della provincia di Susa; nomina ottenuta per le virtuose qualità di dotllina, saviezza, pmdenza, esalfeua e zelo per il nostro servizio. Il 20 giugno
1755 venne nominato intendente delle miniere ed a supplire le veci di primo ufficiale della Segreteria di Guerra e successivamente quella di intendente generale del Regno di Sardegna. Volendo approfondire il discorso sugli intendenti, e sulle strutture da loro amministrate, si veda: H. CosTAì\·IAGNA, Une bistoire de "l'Intendenza" dam Etats de tme-fenne de la Maison de Savoie a l'epoque modeme, in B.S.B.S., LXXXIII (1985) 2-0 semestre, pp. 3 73· 467.
(6) Sotto la Provincia di Susa erano riunite tutte le terre della valle, sia la parte superiore ricordata come la "vallee cedée:' sia l'inferiore, ed inoltre quelle dell'alta val Sangone, il tutto per un'estensione di l .395, 70 chilo· metri quadrati.
Amministrativamente i vari comuni erano raggruppati in otto mandamenti, rispettivamente di Cesana, Oulx, Susa, Bussoleno, Condove, Almese, Avigliana c Giaveno. Come unità amministrativa la Provincia di Susa scomparve, assorbita da quella di Torino, nel 1859, nel corso di un riordino territoriale delle province del Regno. Da tale data Susa divenne sede di sottoprefettura, con giurisdizione su tutte le terre già della provincia, e capoluogo di circondario.
13
del nostro ministro- Degregoris richiese agli intendenti di tutte le province, con lettera circolare del 7 marzo 1750 (7). .
Le notizie relative alla Provincia di Susa vennero desunte dall'intendente Bongino e raccolte nel 1 75 3 sotto il titolo di Notizie statistiche intorno alle Comunità e Valli componenti la Provincia di Susa, contenute in un volume di fogli a/fogliati n. 296 (8). La relazione si apre con un ampio saggio di inquadramento, al quale l'Intendente volle dare il significativo titolo di Ragionamento generale sovra la Provincia di Susa, situazione e benefici della medesima, de' disastri, et incomodi a quale soggiace; dell'indole, e de' costumi de' Provinciali, loro commerci, della conservazione de' boschi, abusi intrÒdotti, e modo di riparar/i.
Il saggio introduttivo, e globalmente tutta la relazione, può essere preso a valido esempio di quel clima illuministico al quale si è rapidamente accennato poc'anzi. Tra i diversi passi meritevoli di attenzione, possiamo ricordare il giudizio molto positivo dato sull'operosità degli abitanti della montagna, che ... con quanta immensa fatica, e con quale sollecitudine, ed industria questi abitatori di montagna abbiano procurato di migliorare lì loro terreni con rìdtme a coltura ogni quantunque angusto sassoso, ed ingrato angolo .... I problemi della miseria contadina, delle alluvioni, delle zone paludose sono messi a fuoco non solo con precisione, ma anche con umana partecipazione alle vicende di una vita popolare spesso difficile. Significativo è l'accenno fatto al ruolo del tutto particolare che ricopriva, nell'economia locale, la forte presenz
·a militare: ... Il soggiorno della soldatesca presidiata· in Susa, e ne' forti di Exilles, Bm
netta e Santa Maria, è alla medema di molto vantaggio, poscìa che vi entrano li vini, vìttelli, formaggio, buttirro, e simili comestibìli ....
Ampio risalto è dato, naturalmente, alla descrizione del sistema viario che vede nella città di Susa il suo punto centrale; l'Intendente sottolinea, tuttavia, le difficoltà che si incontrano nel mantenimento in ordine delle strade reali, spese alle quali non possono assolutamente provvedere - con le loro deboli forze - i soli comuni attraversati. I traffici sono correttamente visti, tuttavia, come una sicura fonte di reddito per la Valle . . . poìche essi mulatieri e comerciantì sì m/fermano in Avigliana, in Bossoleno, ed alla Novalesa, e consumano lì comestibili e li fieni che esse terre e le vicine possono avere di più del bisogno ....
Dopo questa ampia sintesi introduttiva -della quale ci siamo limitati a dare alcuni cenni più significativi� la Relazione si sviluppa attraverso una serie di schede, ognuna delle quali è dedicata ad un singolo comune. Nei punti che seguono daremo un rapido cenno delle schede riguardanti i comuni di Susa, Mompantero, Giaglione, Venaus, Novalesa e Ferrera: sarà cosl possibile comprendere interessanti aspetti sulla realtà settecentesca di ogni singola comunità, sulla loro consistenza demografica e sulle attività economiche svolte, aspetti totalmente differenti dalla situazione odierna.
(7) Il 7 marzo 1750 il generale delle finanze Degregory diramava agli intendenti delle provincie del Regno una lunga e diffusa circolare nella quale venivano descritte dettagliatamente le mansioni da svolgere nell'esplicamento del loro incarico. In particolare, ogni intendente doveva procedere ad una visita personale di tutti i luoghi sottoposti aUa sua giurisdizione, conducendola a termine nel periodo massimo di tre anni, e dar risposta ad un dettagliato elenco di domande, relative ai vari aspetti economici, sociali ed infrastrutturali di ogni provincia.
La relazione sulla Provincia di Susa è pertanto redatta in ossequio a tale disposizione; da notare che essa non era stata rintracciata dal Prato al tempo della redazione della sua citata opera, dalla quale sono state ricavate le informazioni di cui sopra. (Cfr. Prato, op. ci t. p. 12 e ss.).
(8) A.S.T., Sez. di Corte, Paesi in genere per Provincia, Provincia di Susa, m. 9 1 . n. 19.
14
Susa
L'Intendente certifica una popolazione in totale di 1600 abitanti, di cui 278 minori ai 7 anni. La popolazione è data in crescita a partire dal 17 16, data erroneamente citata come di 'inizio dei lavori alle fortificazioni dellà Brunetta. Tutta la città pare vivere attorno alla presenza delle imprese dei lavori edili per i forti e delle relative guarnigioni. Infatti l'attività agricola è marginale, come pure quella manifatturiera . . . ne/ 1752 il signor Vassallo Medaglia ha fabbricata una filatura di sei fame/etti in cui si saranno travag/iati 200 circa mbbi di cochettL, mentre una fabbrica di carta detta la Paperia, posta lungo il Cenischia, risulta abbandonata.
Il contante che resta alli particolari di Susa, formula che l'Intendente usa per calcolare una sorta di reddito pro-capite, è indicato in 3 L 750 lire/anno, con una forte prevalenza (ben 15.000 lire) per gli affitti delle case ... abitate parte dalla tmppaJ parte dal/i negozianti ed artisti, dagl'osti e cabaretierL.
In definitiva si trae 'l'impressione che Susa stesse attraversando una fase di crescita economica "drogata", connessa più agli interventi straordinari dello Stato, che non a solide forme di produzione autonoma del reddito.
Mompantero
Il comune alle porte di Susa aveva una popolazione di 785 abitanti, di cui 70 minori di 7 anni. Il reddito degli abitanti è calcolato in 16.640 lire/anno, con una quasi assoluta preponderanza (13.000 lire) delle vendite di vino.
C�rioso l'accenno che è fatto al carattere degli abitanti, definiti re/ligiosi quasi sino alla superstizione, un'altra prova del clima nuovo in cui viveva e ragionava l'Intendente.
Giaglione
Al comune è attribuita una popolazione di 1 .298 abitanti, di cui 208 in età inferiore ai 7 anni. Giaglione aveva un'economia tipicamente agricola, con predominanza nella produzione di fieno, segala, castagne e vino. È forse il caso di sottolineare come tra queste non compaiano le patate, il cui uso si diffonderà in valle solo all'inizio del 1800.
Il reddito della comunità è valutato in circa 15 .080 lire/anno, con una forte prevalenza delle vendite del-vino (8.750 lire) e dei vitelli (3.600 lire). Si tratta, quindi, di economie agricole abbastanza consolidate.
.
Non mancano cenni alle dure condizioni di vita, tipiche dell'epoca: ,., in questo luogo non si mangia altro che pane di sega/a e per fare un'economia nel pane, è costumanza in questo luogo di cuoccere una sol volta all'anno, sicchè questo pane essendo molto duro non se ne' fa la consumazione a pmporzione di ciò che nelle altre terre .. . ,
Venaus
Il comune di Venaus risulta avere una popolazione di l .050 abitanti di cui 150 minori ai 7 anni, mentre il reddito della comunità è stimato in 12.814lire/anno. Tale valutazione con-
15
sente al Bongino di sviluppare alcune interessanti considerazioni sull'apporto che a tale modesta economia locale avrebbe potuto dare la strada del Moncenisio che, dall'anno prima ( 1 752), attraversava il paese. Qualcheduno avrebbe potuto infatti fare il portantina, ma . .. questi abitatori trovandosi non essere a portata del detto Monte Cenisio non hanno occasione d'impiegarsi, e pretendono anzi quelli della Novalesa escludere detti terrazzani dal detto traffico del Monte Cei1isio quantunque questi particolari allora che si tratti di spianm� e raddobbare la strada di detta montagna siano obbligati di accorervi con un maggior numero di persone eziando di quante- somministrano le .Comunità della Novalesa, e Ferrere, e nell'anno scorso sendosi da Sua Maestà comandato che in Susa alla Novalesa si facesse una nuova strada per servizio del com, mercio passando per il luogo di Venaus, abbandonata intieramente l'antica strada, questa Comu
. nità è .stata nella obbligazione di contribuire in maggior parte sia in contanti per la fabbrica de ponti pennanenti e singolarmente del gran ponte sovra la Sinischia ... e siccome questi terrazzani sentono l'incomodo per detta strada del Monte Cenisio pretenderebbero ancora per conseguenza di essere a parte de vantaggi che dal traffico di detta montagna possono ricavarsi, e non volendosi che siano partecipi di un tale guadagno, v01�ebbero dalla detta contribuzione essere liberati. Veramente se qùesti particolari fossero anche chiamati a fare il /oro giro sulla detta montagna ne verrebbe a risultare una pubblica utilità a passaggeri, poichè quelli della Novalesa, e della Ferrere si venebbero a contenere nel dovere, e non fare indebite esazioni da detti passaggeri, poichè si servirebbero dell'opera di quelli di Venaus, oltre di che nel passaggio di molti commercianti di detta montagna avendosi maggior quantità di persone il pubblico potrebbe essere meglio servito ....
Novalesa
Venendo a parlare di Novalesa, "porta" dal lato piemontese al valico del Moncenisio, l 'Intendente incontra una realtà economica drasticamente diversa,· nella quale accanto all'attività agricola coesiste un'importante componente legata ai traffici.
Il paese ha 680 abitanti, di cui 104 in età inferiore ai 7 anni. Essi sono impegnati massièciamente nei traffici del Moncenisio, pur possedendo un numero limitato di bestie da soma: sono infatti conteggiati solo 25 muli e 25 somarelli, dati che indicano quanto contenuto ed artigianale - pur nella sua importanza-dovesse essere il traffico per il Moncenisio, in confronto al grandioso sviluppo assunto in epoca napoleonica. A questo riguardo è interessante ricordare che vari mulattieri di Lanslebourg operavano, sfruttando la carenza di bestie, in Novalesa.
Il reddito della comunità è di 26.989 lire/anno, con una forte incidenza dei redditi derivati dai trasporti, come evidenziato nella.relazione dai due passi che seguono:
... L'altro comercio considerabile di questo luogo li è il traghetto della montagna del Monte Cenisio colli !ori muli da traghetto per il trasporto di balle, sedie, ed altro, e si fa il calcolo che ogni multo possa guadagnare per cadauno giomo lire 20 e per muli 25 lire 9.125 ....
. .. Più li particolari di questo luogo servono di portantini per il traghetto di detta montagna per la concor�ente di sessanta circa persone e fatta la comune servendo l'opinione del pub/ico questo commercio fmtta a detti particolari all'armo lire 2000 ....
Ferrera
Con Ferrera (citato nella relazione come "Ferrere") giungiamo al più specializzato dei paesi connessi al traffico sul Moncenisio: . . . li particolari di questo luogo sono la maggior parte
16
dell'anno impiegati al trasporto dal/4 Novalesa a Lanebmgo e fanno anche diversi viaggi a Torino ....
La popolazione è modesta, solo 105 abitanti e di cui ben 25 di età inferiore ai 7 anni, ma dispone di 22 muli: il risultato è un reddito notevole- ben 6.387 lire/anno - nonostante che gran parte dell'alimentazione (essen�ialmente segale e vino) debba essere acquistata presso altre comunità, per ovvi motivi di quota e di clima.
È interessante, anche in questo caso, riportare integralmente due passi, relativi ai redditi derivanti dalle attività di trasporto:
... Si calcola che il profitto di questi particolari per tale traghetto e commercio rilievi per cadauno mulo oltre quanto necessmio per proptio mantenimento lire 20 e per muli 22 lù� 8000 . . .
... Più una parte di quésti particol<�ri f a anche il mestiere di portantina trasportando per la detta montagna le Persone Civili che hanno occasione di questa passare ... e da questo ricavavano lire 750.
QUADRO STATISTICO RIEP!LOGATIVO
Susa e le comunità della Val Cenischia: dati statistici al 1753 e confronti con il 1984
1753
Comuni Popolazione Totale Minore di anni 7
(val. ass,) (val. ass.) % sul totale -:-------
Susa 1.600 278 17,)8
Mompantero 785 70 8,92(**)
Giaglione 1.298 208 16,02
Venaus 1.050 150 14,29 -
Novalesa 680 104 15,29
Ferrera 105 25 23,82
Totali 5.518 835 15,13
·-----
· ·
Reddito("') Totale Per abitante
Lire (Lire/ah) -
)1.750 19.16.10
16.640 . r---e-
21.4
15.081 l 1.12.5 - ---
12.814 12.4
26.989 39.13.10
6.)88 60.16.10
109.662 19.17.5
1984
Popolazione 31.12.1984
7.122
641
674
1.015 -
520
42
10.014
Distribuzione percentuale
--
della popolazione 1753 1984
- - --
-
29.00 71.12 · -
---
14.23 6.40_
2).5) 6.73 --
19.04 10.14
12.32 5.19 -
1.90 0.42_
100.00 100.00
(*) I dati finanziari che si riportano sono espressi in moneta settecentesca; senza altra indicazione le cifre si riferiscono a lire, soldi e denari. Le monete allora in uso ed il loro rapporto di valore erano i seguenti: l'obolo che valeva 2 denari, 12 denari che valevano un soldo, 20 soldi che valevano una lira, e 3 lire che valevano uno scudo.
(**) Dato anomalo, peraltro corrispondente a cause ora non valutabili.
Il quadro statistico riepilogativo che riportiamo consente di sviluppare una serie di interessanti confronti, relativi -in primo luogo-alla situazione nelle comunità quale emerge dall'indagine del 1753, ma estendibile anche alla realtà di oggi.
Il primo dato che emerge con chiarezza è quello relativo alla netta prevalenza, a metà del settecento, dellè economie concernenti i trasporti attraverso il Moncenisio, rispetto a quelle prevalentemente agricole. I redditi principali di Novalesa e Ferrera, pur calcolati con l'approssimativo metodo del Bongino, sono enormemente superiori non solo a quelle dei circonvicini comuni agricoli, ma anche a quelli della stessa Susa. L'equazione che lega le economie terziarie a redditi maggiori ha radici antiche, che anche nella realtà valsusina di duecento anni orsono trovano puntuale conferma.' Da valutare anche con la massima attenzione la distribuzione della popolazione tra i comuni considerati: nonostante l 'importante ruolo di Susa - capoluogo di provincia ed importante centro militare- essa ha una popolazione di poco prevalente sugli altri centri. Del tutto diversa è la situazione oèlierna che - a fronte di una popolazione quasi raddoppiata, nell'insieme dei sei comuni considerati- ne vede, tut-
l. PlANA DI VENAUS. Tratto superstite dell'antico percorso, tramediante la piana di Venaus, utilizzato sino al 1752.
2. PIANA DI VENAUS. Vista panoramica con in primo piano il percorso realizzato nel 1752 (a fianco della strada attuale); in secondo piano Oungo la linea elettrica) tracce del percorso utilizzato sino al 1752; sullo sfondo il Cenlschia e le pendici della Brusà.
17
18
tavia, ben il 7 1 , 12% concentrato nella sola Susa. I mutamenti nella distribuzione della popolazione negli ultimi duecentotrenta anni sono pertanto stati vistosi: anche sotto questo aspetto, lo ieri è ben difficilmente paragonabile all'oggi, sotto la spinta di mutamenti profondi, spesso strettamente correlati all'evolversi delle vie e dei mezzi di trasporto.
3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Dai dati sopra presentati si può pertanto trarre l'impressione che la Valle di Susa - ed in particolare le zone più vicine al capoluogo - abbiano raggiunto, nella seconda metà del XVIII secolo uno dei punti più elevati del proprio sviluppo economico; naturalmente non in valore assoluto - le condizioni di miseria erano ancora significativamente diffuse - ma in termini relativi, rispetto ad altre situazioni dello Stato Sabaudo.
H lungo periodo di pace, ed il notevole peso che vengono ad assumere il forte della Brunetta (9), i lavori stradali ed il rinnovo urbano della città di Susa - con la riplasmazione di quasi tutti gli edifici dell'attuale centro storico - sono gli elementi che concorrono a realizzare un'ampia distribuzione del reddito, oltre che ad alimentare- in Susa -lo sviluppo di un ceto borghese, fatto di pubblici amministratori e di mercanti.
Una situazione, quindi, di relativo equilibrio che non verrà più ricostruita dopo il trauma della Rivoluzione: nonostante i grandi lavori della strada napoleonica, nonostante i progetti di una "nouvelle ville" disegnati dal Derrien, la città di Susa non sarà più elemento centrale in un sistema di relazione che ha ormai i suoi terminali a Torino, a Milano, a Lione.
Se analizziamo poi, con un altro passo in avanti, la situazione nei primi anni della Restaurazione, non possiamo che ritrovare conferma a quanto detto: la città che ottenne di "intercettare" la parte terminale della strada del Moncenisio, che si battè contro il trasporto degli uffici pubblici nella "Casa Rosazza" e che resta dominata, non solo materialmente, dalle rovine della Brunetta, è - per molti versi - una città ormai lontana dalla visione di progresso pensata, mezzo secolo prima, dall'intendente Bongino.
(9) Il sino ad ora misconosciuto forte della Brunetta fu per tutto il XVIII secolo uno dei perni del sistema difensivo del Regno Sardo, garante della sicurezza dello stato ed apportatore di un sino allora pressochè sconosciuto periodo di pace e benessere per la valle di Susa. Il progetto del vasto complesso fortificato, che si estendeva sulle eminenze a nord di Susa tra la Dora ed il Ce11ischia, venne eseguito ad opera dell'ingegnere Antonio Bertala, ma non sono da dimenticare gli apporti dati alla costruzione ed alle successive integrazioni dal De \Xlillencourt; da Ignazio Bertela, e dal Pinto di Barri. I lavori di costruzione, intrapresisi nel1708, si protrassero per vari decenni, sia per la notevole entità degli interventi da eseguirsi e sia per la meticolosa cura prestata nella realizzazione delle varie opere della ciclopica piazzaforte. È da ricordare che gran parte del complesso fortificato venne ricavato nel vivo sasso inglobando nella massa rocciosa - con un colossale lavoro di mina e di scavo -le varie opere: bastioni, cortine, fossati, casematte, caserme ... Emblematico della qualità dei lavori eseguitisi è il particolare - e quanto mai dispendioso - intervento effettuatosi su tutte le masse rocciose della fortificazione rifinendole lavorando alla martellina, conferendole quell'aspetto monolitico e speculare all'insieme tuttora riscontrabile. Da un sifatto lavoro ne sortì un'opera che rappresentò per tutto il XVIII secolo la "Perla'' del sistema difensivo del Regno Sardo; mostrata a selezionati ospiti con legittimo orgoglio, in un qualche modo rappresentatrice di quel nuovo corso - a misura europea - dello Stato Sabaudo.
Con la fine del secolo si viene a chiudere la storia delle fortificazioni segusine: il trattato di Pace di Parigi nel 1796, a seguito dei rovesci militari subiti contro la neonata Repubblica Francese, sand infatti lo smantellamento di gran parte del sistema difensivo del regno, da qui la fine della Brunetta. Scomparve cosll'unico baluardo che riuscl a bloccare, come non accadeva più da tempo memorabile, le porte della valle di Susa alle ricorrenti invasioni delle armate francesi.
19
LA VIABILITÀ PER IL MONCENISIO NEL XVIII SECOLO
4. IL TRACCIATO VIARIO AD INIZIO SETTECENTO.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non disponiamo di documentazione sufficentemente completa per ricostruire nel dettaglio il percorso della strada per il Moncenisio tra il XVII ed il XVIII secolo. I documenti a noi noti consentono, tuttavia, di definire almeno a grandi linee la situazione della viabilità tra Susa ed il Moncenisio, prima degli interventi di ridefinizione dei tracciati attuati nel corso del settecento.
Una serie di documenti risalenti agli anni 1620-1623 ( 10) contribuisce a chiarire, quantomeno, i punti fondamentali del tracciato. Con riferimento al tratto di strada che da Susa l'isaliva verso Venaus, leggiamo infatti che ai rappresentanti di quest'ultima comunità è stato ordinato . . . doversi amover le pietre movibili dal rivo C01bione sino alla Cornale o siano albre, di longa in longa per mira alkz Brugiada . . . . Sono cosl citati due punti importanti del tracciato:
. la Cornale e la Brugiada. Nella prima località, posta all'inizio del territorio di Venaus, la stra-da attraversava con un ponte la bealera dei Molini, opera allora fondamentale ped'irrigazione delle terre del comune. Mentre con il t�ponimo di Brugiada (o Brusà, in grafia settecentesca) si identificava lo scosceso versante sinistro della valle, antistante la piana di Venaus; alla base di queste pendici la strada attraversava il Cenischia su di un ponte in legno,
,ricordato anch'esso come della Brusà (11). Tra i due ponti la strada si spingeva diagonalmente nella piana, con un percorso ancor oggi ben individuabile.
Il successivo andamento della strada dal ponte della Brusà risalendo verso la Novalesa, ci è noto grazie ad una serie di documenti del 1722, relativi ad una lite tra le comunità di Venaus da un lato, e di Ferrera e Novalesa dall'altro (12). La strada reale seguiva, dal ponte della Brusà sino alla regione dell 'Esclosa, la riva sinistra del Cenischia, facendosi pericolosamente vicina sia al fiume - con periodici rischi di alluvioni-, sia al versante montagnoso . della Brusà, dal quale erano frequenti le c�dute di pietre e massi.
Tali pericoli, uniti al desiderio di accorciare il cammino, spingevano i viaggiatori ad attraversare diagonalmente la piana, dal ponte della Brusà sino a quello dell'Esclosa (13), creando
(1°) A.s.T:, Se�. Camerale, Visite per stradè, Art. 47> m. 5. (11) A rigu-ardo del ponte della Brusà ci è nota la sua tipologia strutturale nella prima metà del XVIII secolo,
probabilmente non dissimile da quella seicentesca e precedente. L'intendente Bongino in una lettera del 9 luglio 1752 così lo descriveva: . . . non è se non /e due mura a secco elevate per una certa altezza e di una grossezza compettente sovra quali appoggiano· sei travi osieno tronchi d'alberi di ma{esine bene incavigliati tra di loro ed affermati sovra radici, che fanno figura di dormiglioni sovra le dette mura a secco . .
(12) A.S.T. , Sez. Riunite, Ufficio Generale delle Finanze, Prima Archiviazione, Ponti e Strade, m. l n. 9. (13) Il ponte delJ'Esclosa sino al 1722 doveva essere di ristrette dimensioni, alla stregua di una passerella. I l
Bertela nel citato documento riferiva infatti che . : .le sedie, per portarsi a Susa, non ponna presentemente in altro
20 ��� .... .w .......... � ...... ,�� .. �.- r�, .......... .
-r �f, ,
. - . ; . ,
� �� .. J !I
3. VENAUS. Ingenua rappresenta· zione deU'abitato, in un particolare di un disegno della prima metà del XVIII secolo.
4. NOVALESA. Cappella di San Sebastiano posta all'estremo occi· dentale dell'abitato.
Ili, !(-- .... ., . . ;,· 1 . J • .
- - ·. ,. ....... --lJ l � • ' , • i.( .. .. -- l �,
·. \ . . l ..... f , "' " -"t"' __ ,.._ ;; . . . , �/ .1.1., l • • � , ' j · t1 1 - - · · · · ·' .# • ' ' J . . .. . �_r .· .. - .....4. ;"'
. . ' . ' . � • ! G ' . :. J
. '
. . ,
2 1
5. SANTi\ MARIA DI NOVALESA. Insediamento !tingo un antico percorso per il Moncenisio.
6. NOVALESA. Confluenza del 1 io Riondo nel Cenischia; sulla destra, appena intclleggibile, tracce dell'ant ico percorso su sponda sinistra.
22
un sentiero "abusivo" che danneggiava i coltivatori di Venaus: da qui la lite, conclusasi con il divieto ad usare la scorciatoia. Proprio per derimere la controversia, nel maggio del 1722, il percorso stradale in questione fu visitato dall'ingegnere Giuseppe Ignazio Bertela (14): la relazione, con l'allegato tipo dimostrativo (si veda la tav. II), che ci è rimasta di tale sopraluogo è essenziale per meglio definire la viabilità della zona all'inizio del XVIII secolo. Al riguardo il Bertela cosl scriveva: . .. Viaggiandosi dal Monte Cinisio, Ferrera, Novalesa e luoghi circonvicini per andare a Susa, si tiene una strada, che distendendosi al Lungo della valle, viene a giungere al timpetto d'un ponte chiamato Esclosa, il quale attraversa il fiume Sinischia sul ten·itorio della comunità di Venaus. Avanti il detto ponte d'Bse/osa, la strada preddetta si partisce in due, de' quali una dalla testa del mentovato ponte si porta a girare sul piede d'un mollte domandato della Brucciata; e l'altra dal medemo ponte va a passare per Venaus, e da ivi continua sino alla strada maestra, che conduce alla città di Susa ....
Risulta chiaro che il percorso principale, la strada reale, percorreva la sponda sinistra del Cenischia, mentre solo un percorso secondario toccava Venaus: si comprende cosl meglio anche la portata della rivoluzione viaria che verrà attuata nel 1752.
Superato il bivio del ponte dell'Esclosa, risalendo la valle, il viaggiatore si trovava ad attraversare il territorio pianeggiante della Novalesa, con un percorso più vicino al corso del Cenischia, tuttora ben visibile, rispetto al percorso attuale (che ricalca il tracciato del 1752); attraversando il Marderello e poi il Claretto, si raggiungeva quindi Novalesa. In tutta la parte pianeggiante del percorso (da Susa a Novalesa), la strada tendeva pertanto ad assumere un andamento il più possibile teso e rettilineo. Questa scelta riduceva indubbiamente la lunghezza del percorso viario, ma lo avvicinava pericolosamente ai corsi d'acqua ed alle zone franose, generando i problemi che vedremo più avanti.
Attraversato l'abitato, la strada si avviava ad affrontare la rapida salita per il Moncenisio, con una serie di tracciati, che si sovrapposero nel tempo, e che a noi non sono ancora ben noti: li descriveremo perciò, qui di seguito, in quello che reputiamo sia l'ordine cronologico. L'estrema periferia nord di Novalesa era rappresentata dalla cappella di San Sebastiano; da qui il percorso - che riteniamo più antico - superato il rivo Giolio raggiungeva la frazione di Santa Maria. In questa tuttora sussistono i resti di una cappella, già citata in periodo medievale come di Sancta Maria ad radicem montis o come di Sancta Mm·ia . ad P ed es Montis Cenisii (1 5) . La cappella di Santa Maria costituiva anche un punto nodale nell'erga-
luogo passare se non per la detta strada, che gira al piede del mentovato monte della Brucciata . . . evitando perciò il ponte dell'Esclosa non adatto al transito (ricordiamo che le "sedie" erano un tipo di vettura leggera, a due ruote e due posti, particolarmente diffuso nel XVIII secolo). Nel maggio del 1728 una nuova escrescenza del Cet1ischia determinò l'asportazione dei ponti dell'Esclqsa e della Brusà, che vennero nel luglio di q1,1ell' anno ricostruiti integralmente. La piena delle acque determinò tta l'altro l'asportazione degli argini ed un ampliamento dell'alveo del Cenischia nella regione dell'Esclosa, che obbligò a ricostruire il ponte non più con unica campata, ma con due . . . la comunità presente fante due per esser l'acqua grossa larga spamiata cioè altre n. 20 craviate tra ambi ponti . . . . Come asseriVano nella stima dei danni Patiti il . . . misrm1tore camerale Gabriet A m primo di Giaveno ed dali Nobil Philippo Bellet di Giaglione qual ha asierito haver travaliato nella cmltl'ution de sudetti ponti . . . , in A.S.T ., Sez. Riunite, Imendem:a di Susa, m. 114.
(14) Bertela Giuseppe Francesco Ignazio, nato Roveda (1676-1755), ingegnere di Sua Maestà, figlio adottivo dell'architetto Antonio Bertela. Nel1725 maestro delle fortificazioni, nel1728 inge;snere col grado di luogotenente colonnello di fanteria, nel173 1 primo ingegnere di Sua Maestà, nel1742 per le particolari sue benemerenze gli venne conferito il titolo di conte di Exilles. Il suo nome è legato alla costruzione dei forti della Brunetta, di Exilles, di Fenestrelle ed alla cittadella di Alessandria.
(15) L'identificazione dei resti della cappella di Santa Maria, inglobati in una casa colonica della frazione orno-
23
nizzazione, per scopi agro-silvo-pastorali, del versante montagnoso che da Novalesa risale verso il massiccio del Rocciamelone. A tale proposito è doveroso sottolineare l'interesse per uno studio generale dell'organizzazione del territorio novalicense che, se non è sviluppato in questa sede, dovrà tuttavia essere oggetto di ulteriori riflessioni.
Da Santa Maria, questo itinerario si inerpicava a mezza costa sul ripido versante sinistro del Cenischia, superando il do Riondo, sino a raggiungere una zona meno scoscesa, a valle della cappella di San Pancrazio. Osservando attualmente la zona, si nota come il territorio attorno al rio Riondo sia stato sconvolto da un ampio movimento franoso, come testimonia anche la parcellizzazione catastale. Sul posto sono intelleggibili solo con sforzo le tracce dell'antico percorso che, invece, ritroviamo ancora ben conservato dalla zona di San Pancrazio fino alle porte della Ferrera.
l documenti in nostro possesso non ci consentono di datare l'epoca in cui il percorso stradale si sp�stò, forse a motivo del movimento franoso, dalla sponda sinistra a quella destra del Cenischia, nel ripido tratto di salita tra Novalesa e Ferrera. Non possiamo neppure escludere che, per periodi di tempo anche lunghi, siano coesistiti percorsi, in sponda sia destra che sinistra, tra loro alternativi sulla base di motivazioni stagionali e di più agevole per-corribilità. ,
Un importante documento del 1622 (16) ci consente, 'tuttavia, di formulare ipotesi e verificare importanti punti di tale tracciato, In codesto è infatti già indicato il percorso in salita sulla riva destra del Cenischia partendo dalla Novalesa, con chiari riferimenti alle Volte, a Pietra Becua ed alla località di Ferrera Vecchia. È importante notare che tale percorso viene chiamat9 camino novo si può quindi pensare che,
' ancora all'inizio del l600, lo spostamento
del percorso viario su sponda destra - od il suo prevalere su quello in sponda sinistra -fosse considerato come cosa recente.
·
Le manchevolezze della documentazione- rintracCiata non ci consentono, tuttavia, di chiarire definitivamente tale questione: se infatti l'antichità della cappella di Santa Maria ci fa pensare ad una più antica origine del percorso in sponda sinistra, quale spiegazione allora dare al toponimo già medievale di Ferrera vecchia? Un punto è tuttavia chiaro: nel XVII secolo la strada non entrava in Ferrera, come fa attualmente, sulla sponda destra del Cenischia. In un punto imprecisato, a meno di un chilometro a valle dell'abitato di Ferrera e comunque più in alto di Ferrera Vecchia, la strada - infatti - riprendeva il percorso in sponda sinistra, attraversando il Cenischia· su un ponte detto del Milanese, per proseguire quindi verso l'abitato.
All'interno della Ferrera, che ricordiamo svilupparsi su entrambe le sponde del Cenischia, si trovavano già allora tre opere di attraversamento: abbiamo infatti menzione nel 1622 del cosiddetto Ponte del Mezo , Tramite questi, la strada attraversava nuovamente il corso d 'acqua e, passando innanzi alla cappella di Santa Barbara, lasciava l'abitato e si inoltrava verso il colle,
Il percorso - mantenendosi su sponda destra - risaliva le pendici sino a raggiungere i punti obbligati di passaggio di Ponte Sutto ed il -successivo di Pietra Stretta, per inoltrarsi poi
nima, la si deve a monsignor S. Savi. Inoltre in Val Susa Antica, vol. II, di N. BARTOLOMASI, Pinerolo 1985, alle didascalie delle illustrazioni n. 59 e 60, come alle pp. 505-507, vengono avanzate delle pertinenti congetture a riguardo della possibilità che tale sito fosse già nell'antichità un luogo di culto. (16) A.S .T., Sez. Riunite, Sez. III, Visite per Strade, op. d t . , Testimonia/i di visita di Giulio Cesare Del/i Gioanni duca! notaio, del 30 marzo 1622.
24
7. FERRERA, cappella di San Pan· crazio. Lungo il percorso in riva si· nistra dd Cenisrhia.
8. FERRERA, la Pt'm Becua. Stori· co punto di confine tra Ferrera e Novalesa.
9. FERRERA VECCHIA. Resti del pilone intitolato n San Lorenzo.
10 . FERRERA. Ingresso nel paese, su sponda sinistra, secondo il percorso utilizzato sino al 1749.
25
26
nella piana d-i San Nicolao. Il tragitto successivo non ci è noto con precisione, ma alcuni punti fermi del percorso, quali le cappelle di San Nicolao e di San Maurizio (17), ce lo delineano posizionato sul lato meridionale della piana; dovevano perciò sussistere tre ponti su altrettanti torrenti immissari di destra del Cenischia, uno di questi denominato nel 1622 come Ponte di Maut. È inoltre da ricordare che la cappella di San Maurizio segnava il limite amministrativo tra Savoia e Piemonte (18). Da qui iniziavano le temute "Scale" che, con ripidi tornanti sovrastati dalla montagna della Scala - che come si ricordava: . . . è quella che cagiona la perniciosa va/anca in tempo d'inverno e di primavera . . . (!') - risalivano alla Gran Croce.
In quest'ultima parte di strada si intervenne nel 1711 modificando il tracciato: la dizione di cammino nova delle Scale identificò sino al 1752 questo nuovo percorso. Ma sino ai grandi interventi svoltisi in t<lle data è probabile che sussistettero sulle Scale due percorsi tra di loro alternativi: sia il citato "cammino novo" che il precedente, Tale coesistenza ci è documentata in modo particolare da due disegni: in primo luogo nella mappa del comune di Lanslebourg del "Cadastre Sarde" del 1728-1729 (tav. XVI); opera quanto mai dettagliata che permette di effettuare una precisa ricostruzione, sia stradale che ambientale, della piana del Moncenisio. L'ulteriore è un disegno riproducente lo stato dei trinceramenti della piana di San Nicolao nel 1743 (20), in cui è documentato schematicamente il percorso stradale dalla Ferrera sino alla Gran Croce (tav. XVII),
(17} A riguardo delle suddette cappelle si veda il capitolo XI. (18) Si veda sempre a riguardo il capitolo XI. L-
a cappella di San Maurizio segnava inoltre il limite di competenza per la manutenzione della strada; nel tratto sottostante spettava all'intendenza di Susa e di ripiego alle comunità della Val Cenischia, mentre il tratto delle Scale, come il restante del percorso sul Moncenisio e la discesa in Mariana, spettava all'intendenza di Saint Jean de Maurienne, e perciò alla comunità di Lanslebourg. Nel corso dei favori intrapresisi - come vedremo - nel1752, il limite di competenza non venne rispettato; la responsabilità dei lavori, vista forse la globalità dell'intervento effettuato sul versante piemontese, venne infatti assolta totalmente dall'intendente di Susa Bongino.
(19) La pericolosità del sito cagionava spesso un tributo di vite umane. In una relazione di visita del 1752 (si vedano i riferimenti in testo della nota 42) si riportava: . . . ivi sono stati sepolti come si è allegato da dette persone, due uomini stati uccisi in esso sitto nella scorsa pdmavera della va/anca caduta dal detto colle della Rossa, vedendosi per tale effetto ivi piantata una croce di legno bianco . . . . (10) U n ulteriore e non secondario aspetto legato alle vie di transito sul Moncenisio è stata da sempre l'esistenza di opere di difesa a protezio
.ne e blOcco del colle. Trattare di'queste, come pure dei risvolti di storia militare
inerenti al transito, ci porterebbe ben lungi dai problemi sinora trattati; diamo perciò solo una descrizione di quali erano le difese del Moncenisio in periodo settecentesco. Tali opere, rimaste sinora nell'obblio, si reputavano totalmente scomparse; ma nel corso delle ricognizioni, effettuate per rinvenire le parti della strada reale tuttora esistenti, abbiamo avuto occasione di riscoprire vestigia del trinceramento delle Combasse. Tali opere sono state al centro di uno studio già pubblicato, del quale riportiamo uno stralcio:
. . . Nel 1 709 nel corso delle guerre di Successione di Spagna, sotto la direzione de!l'iugegnere Antonio Bertola, venne fortificata la stretta della valle tra la Finestra d'Arpone ed il Paradiso, sviluppando maggjonnente le difese sul versante destro in posizione di comando sulla piana di San Nicolao. La prima linea di difesa, apprestata sulle alture prospicenti la piana, era fonnata,dalsusseguirsi di tre ridotte, dcordate come ridotta di "San Nicolao", citata anche come forte, "Inferiore di San George" e "Superiore di San George". Alfèspa!le della ridotta di San Nicolao si trovava il trinceramento con corpo di guardia della "Bmriera", opera posta a cavaliere della strada reale in funzione di diretto controllo del transito sulla stessa. Il !tinceramento continuava inoltre al di là del Cenischia, risalendo per un tratto sul versante opposto della valle. La seconda linea della difesa si snodava sulle pendici dell'Arpone con i trinceramenti delle "Combasse"; tale opera venne ampliata tra il febbraio e l'aprile del 1 743, in condizioni ambientali proibitive, con la realizza:done nella parte supedore di rma ridotta quale punto di forza.
Nella parte inferiore questa seconda linea si raddoppiava nei trinceramenti di Peccare/, fortilizio posto in posizione
27
La mappa del comune di Lanslebourg venne già citata e schematizzata dal Lavis Trafford in La montagne du Cenis (21), che, basandosi su di essa, scriveva: . . . L 'Echel!e ou Grand Scala proprement dite consistait, ainsi que Ùl Mappe de 17 30 le m o n tre cklirement, e n qua tre grands Ùlcets d'environ 120, 120, 170 e 26 mètres respectivement plus une "anivée " d'une quarantaine de mètres. Toutefois une serie de quatorze <<lraverses» ou «rampes» pennettait aux piéttons de raccourcir le tra jet entre le débout du troisième et la fine du qua trieme la c et. . . . Ma le "quatorze «traverseS>> ou «rampes»" identificate dal Lavis Trafford quale scorciatoia, erano in realtà il tracciato che venne abbandonato nel 1 7 1 1 . Infatti nel disegno riproducente il teatro degli scontri svoltisi sul Passo di Susa nel 1629 (tav. XIV) le Scale vengono rappresentate come un percorso caratterizzato dal susseguirsi di tornanti, a fianco, ma non nelle immediate vicinanze, delle cascate formate dal Cenischia; con un andamento simile a quello della suddetta scorciatoia. Ritornando ancora alla mappa catastale è da rimarcare che il tracciato segnato come principale, che si avvicinava al corso del Cenischia, è verosimilmente il citato cammi· no nova delle Scale.
L'ulteriore disegno del 1743 riporta una situazione pressochè analoga, l'unica differenza che sussiste è lo scambio di livello d'importanza dei due percorsi: quello maggiore è segnato come minore e viceversa. Tale è da ritenersi o un errore di segnatura, o una situazione momentanea derivata dagli eventi bellici; infatti nel 1 752 il percorso citato come principale era quello che si avvicinava al Cenischia.
Ricordiamo che, in questo volume, l'Inserto II è espressamente dedicato alla riproduzione ed al commento tecnico delle fonti iconografiche sopra citate, e di altre ancora relative alla viabilità nella zona delle Scale. Ad esso facciamo pertanto riferimento per ogni ulteriore approfondimento.
.
5 . GLI INTERVENTI DEL 1749 NELLA PARTE ALTA DEL PERCORSO.
I documenti che abbiamo sinora citato, riferiti a tutto il XVII secolo ed agli inizi del successivo, ci parlano di una continua piccola manutenzione della strada, fatta a carico delle comunità che essa attraversa: si tratta quasi esclusivamente di rimuovere le pietre ed i massi cadutivi e riparare i danni cagionati dalle acque di superficie.
di comando sulla strada reale. Risalendo in quota,. a protezione della cresta dell'Arpone, si trovava ancora il duplice ttinceramento della ''Rocca Negra " ricordato a11che come del Ciannena. Tale opera terminava da un lato in con'ispondenza del /aghetto omonimo, mentre l'estremo opposto sì chiudeva con una ridotta. Discendendo a valle un ulteriore punto di controllo sulla strada reale si aveva all'altezza del "Ponte Nuovo" (*). Il ponte era protetto da un c01po di guardia, mentre in con'ispondenza d'esso sttl versante opposto si trovava il trinceramento con c01po di guardia de!l.<l "Bottigliera " ci!flto anche come del "Paradiso ". Tale fortilizio controllm'a inoltre il percorso che dall'altura del Para,
diso scendeva verso la Ferrera. Il sistema difensivo completato da vari cmpo di guardia come quello delle "Grange Bianche" tendendo alla Ferrera, venne costrttito in a/erme sue parti con funzione diretta di controllo e di blocco della strada reale, onde impedire ad tm eventuale aggressore l'agevole discesa nella sottostante valle· . .
P. G. CORINO, L'attacco spag�wlo dell'Arpone e i ltÙlCeramenti settecenteschi del Moncenisio, La Valwsa, n . 37, Susa 1985.
(*) Il Patite Nuovo sovraccitato, come il similare Ponte di Bottigliera, non erano che attraversamenti secondari che mettevano in collegamento la strada reale con un percorso minore, posto sulla sponda sinistra, che saliva dalla Ferrera sino al l?aradiso. (21) M.A. DE LAVIS TRAFFORD, La montagne du Cenis, SaintJean de Maurienne 1954. È da annotare che tale studio del Lavis Trafford risulta, pur nei suoi limiti editoriali, maggiormente approfondito sul versante francese che su quello piemontese.
28
1 1 . FERRERA, cappella di Sa11ta Barbam. J\ll'esrremirà occidenwlc dell'abitato.
12. PIANA DI SAN NICOLAO. J\ll'estremità orient�le del pianoro, sulle pcndici dell'Arpone, vestigia dei trinceramenti settecenteschi delle Combasse.
13. FERRERA. Tratto della strada reale costruito nel 1749, su sponda destra del Cenischia.
14. FERRERA. Caratteristico edificio, nel centro del paçse, n stretto portico aggettante verso il Ceni· schia; sullo sfondo la parrocchiale di San Giorgio.
" 29
3 0
I primi lavori significativi sul percorso, di cui abbiamo dettagliata notizia, risalgono al 1 749, anno in cui venne completato l' itinerario - interamente su sponda destra - che por
' tava alla Ferrera: veniva cosl abbandonato il ponte del Milanese ed il residuo tratto di percorso su sponda sinistra. Tali lavori furono decisi dall'allora intendente della Provincia di Susa, il conte Nicolis di Brandizzo (22); là relazione che conserviamo sui lavori venne però redatta nel 175 1 del suo successore (23), il Bongino, che vedremo in seguito impegnato nell'organizzazione del rifacimento dell'intero percorso stradale.
Il Bongino spiega che il motivo principale dello spostamento della strada dalla sponda sinistra a quella destra, nel tratto terminale sotto la Ferrera, è dovuto alle frequenti e pericolose valanghe che si distaccavano dal monte Lamet. Proprio nei primi mesi del 1749 una valanga aveva, in questo sito, travolto un gruppo di soldati in marcia.
A dirigere i lavori per il nuovo tratto stradale era stato chiamato il misuratore Pietro Antonio Benedetto (24), che, come vedremo, sarà poi attivissimo nei lavori del 1752. In data 25 e 27 settembre 1749 venne dato ordine ai comuni di Venaus, Novalesa e Ferrera per l'esecuzione dei lavori. Questi furono eseguiti con notevole t·apidità, tanto che le tre comunità interessate potevano presentare il rendiconto finale dei lavori già il 6 novembre dello stesso anno, per un importo di lire 259 . 13.6; somma che, paragonata alle spese che verranno sostenute tre anni dopo per la formaziol)e della "nuova strada", è da ritenersi modesta.
Da notare che, dopo i lavori eseguiti nel 1 749, la strada reale entrava in Ferrera sulla sponda destra, ma subito dopo - con un ponte posto nel sito di quello tuttora esistente, ricostruito in data recente dall'E .N.E.L. - tornava al vecchio percorso in sponda sinistra. Un altro po�te - sito più a monte - riportava nuovamente la strada sulla destra. Questo doppio attraversamento era indubbiamente funzionale per la conservazione di equilibri economici da tempo radicati nell'economia locale; consentiva inoltre di evitare il caratteristico edificio, a stretto portico aggettante verso il fiume, tuttora esistente.
6. GLI INTERVENTI DEL 1752 E LA "NuOVA STRADA".
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, con la m'età del '700 il problema della stra
da del Moncenisio viene affrontato con un'ottica nuova, attenta non solo alle esigenze di manutenzione spicciola, ma anche a lavori di più ampio respiro. L'arrivo del nuovo intendente della provincia, Bongino, ed il suo rapporto di collaborazione con il misuratore Benedetto crearono le basi per. un importante sistema di lavori stradali, destinati a modellare per mezzo secolo - fino ai grandi lavori napoleonici - la viabilità per il Moncenisio.
(22) Nicolis di Br'andizzo Bonaventura Ignazio, conte di (1720-1776). Dottore in legge, intendente di Susa dal 4 maggio 1746 sino al dicembre 1749; in seguito intendente a Cuneo e successivamente ad Alessandria ed infine nel 1773 nomina ad intendente generale della Reni Casa con titolo di maggiordomo.
'
(2J) A.S.T., Sez. Riunite, Ufficio Generale delle Finarlze, Prima Archiviazione, Ponti e Stmde, m. 4 n. 4 Informali�a, cbe l'intendente sottoscritto ba l'onore di trasmettere a/I'Uf/hio Generale delle Regie Finanze sovra t'esposto da Ptetro Caffo della Ferrera . . . in data 7 aprile 1751.
(24) Benedetto Pietro Antonio, nato a Camburzano alla fine del XVII secolo. Dal 1723 qllale misuratore ed estimatore applicato ai lavori dell'Intendenza Generale delle Fabbriche e Fortificazioni. Con la Patente del 15 aprile 1744 per la singolare integri/d con altrettanto zelo ed attenzione ottenne la nomina a misuratore cd estimatore
_ generale delle fortificazioni e fabbriche. Con la Patente del 28 aprile 1780 staqte l'età sua pitì che ottuagenaria
gh venne accordata la giubilazione accompagnata da u11 annuo trattenimento di lire 6ÒO di Piemonte per godeme a casa ma durante la di lui vita.
3 1
L'occasione che,originò tali lavori furono i danni causati dall'alluvione che colpì la val Cenischia nell'autunno del 1 7 5 1 {"). Conserviamo una minuta ed interessante descrizione dei lavori intrapresi, che si sviluppa in circa 50 lettere, ora conservate all'Archivio di Stato di Torino (26) , che l'intendente Bongino, o il suo vice Balegno (27), inviarono al conte di Saint Laurent, ministro e segretario di stato per gli affari interni (28) .
L 'alluvione ed i primi progetti.
Subito dopo l'alluvione, rilevati i gravi danni e - in particolare - l'asportazione di tutti i ponti lungo la strada, il Bongino prende immediati provvedimenti, ed invia a compiere un sopraluogo il misuratore Benedetto ed il suo collega Santus Rusca (29) . I due tecnici, in data 23 ottobre 175 1 , ci danno relazione della loro visita e dei provvedimenti da loro proposti per risolvere definitivamente il problema della viabilità per il Moncenisio. Il Benedetto ed il Rusca propongono una serie di lavori da eseguirsi così articolati:
rifacimento del ponte sul Claretto e nuova sistemazione dell'ingresso in Novalesa (spesa lire 1 .600); sistemazione della strada tra Novalesa ed il confine di Venaus, per evitare che essa diventi alveo del Marderello (spesa lire 1 .380); rifacimento della strada nel tratto tra il ponte dell'Esclosa ed il ponte della Brusà (spesa lire 1 .450);
(H) L'alluvione del 1751 non fu che una delle varie inondazioni che periodicamente si abbatterono sulla val di Susa, cagionando devastazioni e notevoli danni; imputabili senza alcun dubbio alla furia degli elementi, ma che l'incuria degli uomini, specie in date a noi vicine, sembra a volte voler quasi agevolare.
In precedenza al l751 si ha notizia di altre notabili escrescenze, che si riversarono cagionando distruzio?i sulla val di Susa ed in specie nell'area interessata dal nostro studio, rispettivamente nel 1698, 1714 e 1728. E da ricordare che l'alluvione occorsa in quest'ultima data fu forse la più devastante della storia valsusina; sulla sua azione in alcuni altri si ti della valle si sono già soffermati in passato alcuni studiosi di storia locale, quali Bogge, Patria e Roddi.
In una supplica della comunità di Venaus del 15 maggio 1752 (A. S. T .. , Sez. Riunite, Prima Archiviazione, Acque ed edifici d'esse, m. 4 n. 11) - a riguardo dei danni patiti nel corso dell'alluvione del 175 1 - si riportava . . . sul Principio d'ottobre or scaduto talmente ingrossito il tmrente Cinischia col profluvio, - ed escrescenza di tanti rivi in esso . . . che non solo abbia affatto esportati li ponti esistenti sovra il medesimo tmrenie, cioè quello della Bmsà sulla strada reale, e l'altro detto del Sclosa sulla strada tendente da detto luogo alla Novalesa senza, ed eziando le stesse tipe . . . .
Mentre a riguardo delle condizioni della strada reale il Bongino, già il 28 ottobre 1751, così scriveva . . . esso torrente aveva di longa in longa del detto cammino fatti diversi scavamenti della profondiM sino a quattro piedi liprandi . . . cioè drca.sui 2 metri, e come puntualizzava il 14 novembre: . . . la strada oggidi provvisoriamente pratticata altro non è se non se in buona parte l'alveo del torrente Sinischia.: . . (26) A.S.T., Sez. di Corte, Materie Economiche, Vetture Pubbliche, m . 1 n. 4 Lettere e memorie riguardanti la nuova strada da Susa alla Novalesa per Venaus e per la Scala di Moncenisio - 1 752. I documenti che si citano nel testo senza riferimenti archivistici appartengono tutti alla succitata raccolta.
(27) Balegno Carlo Felice, avvocato. Sino al ·1741 ebbe in Susa l'incarico di vice giudice. Il 30 agosto di quell'anno ottenne la nomina a luogotenente dell'intendente della provincia di Susa, mantenendo pur sempre l 'incarico precedente. (28) Saint Laurent Vittorio Amedeo, conte di, ministro e primo segretario di stato per gli affari interni di Sua Maestà.
(29) Santus Rusca Giovanni, regio misuratore. Di origine cuneese, fu "imprenditore delle tappe" prima ai lavori della Cittadella di Alessandria, e poi con simile incarico al forte di Exilles. In tale località sposò nel 1729 Caterina Seha, figlia del chirurgo del forte. Dalla coppia nacquero quattro figli, il secondogenito Giovanni Angelo Santo Rusca fu un valente architetto che operò particolarmente in valle.
32
15. VENAUS. Le pendici della Brusii, viste dalla regione dci Vcr· netti.
16. VENAUS. Antica edicola inti· tolata a San Pietro, all'estremità oricnt:1le del paese.
3 3
ricostruzione del ponte della Brusà a due archi in pietra da taglio (spesa lire 4 .000) (30); spostamento più a monte della strada nel tratto della piana di Venaus (spesa lire 1 . 800); nuovo ponte alla Cornà (spesa lire 200); nel territorio di Susa, diversi miglioramenti viari, fino al ponte di San Rocco (spesa lire 1 .330).
Come si vede, il progetto viario abbozzato dal Benedetto e dal Rusca non prevede per ora sostanziali spostamenti di tracciato: l'intervento è però già pensato in maniera massiccia e vi compare - come rifacimento del ponte della Brus à - la previsione di un grosso investimento per un ponte in pietra lavorata. > La relazione dei tecnici è trasmessa al Ministro degli Interni con lettera del Bongino in data 28 ottobre 1751 ; l'Intendente si preoccupa di segnalare che la spesa prevista in totale - lire 10.640 - è assolutamente insostenibile per le due comunità di Venaus e di Novalesa.
Oltre ai suddetti misuratori, all'inizio del mese di novembre, il conte Benedetto Alfieri {31), effettuò una ricognizione sul percorso. Per nostra sfortuna la relazione sulla visita non ci è pervenuta, anche se citazioni sulle possibili sistemazioni del tracciato da lui suggerite le rinveniamo nelle lettere sia del Bongino, sia del Benedetto.
Le evoluzioni progettuali : l'attraversamento di Venaus.
L'inverno del 175 1 e la primavera dell'anno successivo trascorsero senza che, per ovvi motivi climatici, fossero avviati i lavori lungo la straéla: il Bongino, tuttavia, non demorde dai suoi progetti ed, anzi, apre una complessa vertenza con il monastero di San Pietro della Novalesa per farsi versare una quota dei denari necessari per i lavori stradali (32).
Una lettera del Bongino in data 2 1 maggio 1752 introduce, tuttavia, un fatto nuovo: nel tratto di strada che si avvicina alle pendici della montagna della Brusà si è distaccata une grande frana di pietre che ha reso inaccessibile e pericoloso il transito sulla strada reale {33).
(3°) Il ponte della Brusà, che come vedremo in seguito non verrà più ricostruito, era previsto in questa fase di progettazione dai misura tori Benedetto e Santus Rusca: . . . con due arcate di trabucchi 4 cadauna, suo. pi/.astro, sia mando h in mezzo di pietre di taglio, riffian chi proporzionati e parapetti il tutto di muraglia in calcina ogni cosa considerato ascendeva la spesa per esso Lire 4. 000 ....
{31) Alfieri di Cortemilia Benedetto, conte di (1700-1767), avvocato e primo architetto civile di Sua Maestà. La ricognizione del conte Alfieri sul percorso non fu scevra di inconvenienti, se non tanto per lui, quanto per
chi lo condusse. Il mulattiere Giacomo Bonot di Lanslebourg, che operava in Novalesa, richiese non molto felicemente al conte - per il trasporto della gabbia della sedia di posta - la somma di lire 14, in contrasto con quanto prescriveva la tariffa camerale del 1724. Tale genere di abuso era prassi tra i conducenti, che si facevano forti della necessità del loro servizio da parte dei viaggiatori.
In questo caso per il mulattiere non ci fu certo un gran guadagno. Il Bongino, infatti, convocò innanzi a sé per una solenne reprimenda il mastro di posta, il sindaco e consiglieri della Novalesa, ricordando loro che se il fatto si fosse ripetuto gli avrei fatti cacciare in p1igione. Mentre il Bonot, oltre a restituire il soprapprezzo, trascorse alcuni giorni - probabilmente a rimuginare sulla fattibilità di un adeguamento delle tariffe, problema come si vede assai antico - al forte della Brunetta.
(32) Il traffico sulla strada del Moncenisio, seppure in parte ostacolato dalle manchevolezze del percorso, non venne però a mancare. Abbiamo infatti notizia, in data 16 novembre 1751 , che venne fatta . . . provvisoriamente aggiustare la detta strada almeno in quei posti, che saranno riconosciuti p i lÌ premurosi per non interrompere il commercio . . . .
U3) . . . consiste nell'essersi considerabi!mente spaccata una montagna di territorio parte di Afompantero e parte di Ve-
3 4
17. VENAUS. Interno dell'abita· t o.
18. VENAUS. Vista panoramica del ponte dell'Esclosa e della piana circostante.
35
19. VENAUS . Il ponte dell'Esclosa.
20. VENAUS. Particolare della "manclola" del ponte dell'Esclosa.
3 6
Da qui la decisione, per la prima volta annunciata, d i abbandonare il vecchio percorso eè aprire un nuovo itinerario che entri in Venaus. Tale proposta è autorevolmente suffragata anche da. una relazione dell'architetto Alfieri (34), datata a Torino il27 maggio, il quale concorda con le idee avanzate dal Benedetto: di portare la strada reale in Venaus e di costruire un ponte in pietra all'Esclosa; inoltre suggerisce l'allargamento di tutta la strada al passo minimo di 8 piedi liprandi (cioè circa 4 metri) (35) .
Il progetto originario, abbozzato nell'autunno del 1751, va cosl prendendo forma: non più solo modifiche marginali al percorso
. già esistente, ma un complesso insieme di interven
ti, volti a definire una "nuova strada n.
Com'è immaginabile, una rivoluzione di tale portata nella viabilità della valle non passò inosservata presso le comunità più direttamente interessate: Venaus, Novalesa e Ferrera. Ce ne da conferma il Bongino con una sua del 25 giugno, nella quale contesta i timori degli abitanti della Novalesa, preoccupati di vedersi ridurre i loro proventi legati ai traffici. L'infondatezza che Venaus possa diventare sede di tappa- come temuto dai novalicensi -viene puntualizzato dall'Intendente nella lettera dandoci nel contempo chiaramente l'immagine di un paese che praticamente non ha i numeri per entrare in un gioco più grosso di lui: non ha case capaci a ritirare persone civili, non ha neppur una bestia atta a questo uso, neppure vi sono scuderie o stalle capaci("). Nella sua mentalità razionale ed illuminata, il Bongino, cosl come si curava di evitare eventuali carichi fiscali sulle comunità attraversate dalla strada, è parimenti pronto a non dar credito alle piccole beghe locali. Nel frattempo, stimolata dall'attivismo dell'Intendente, si era messa in moto tutta la macchina burocratica per la realizzazione dei lavori. Sappiamo - pur non avendone trovato copia - che l'ordine di dar corso ai lavori fu dato con il Regio Biglietto del 15 !tiglio 1752. Il Bongino si attivò immediatamente per indire l'appalto dei lavori, che furono affidati all'impresario Giovanni Rosazza (37) in data 26 luglio.
naus ... sovrastando colla sua altezza alla detta strada, tratto a tratto cadono da detta montagna m atelia/i e pietre di tanta mole, che ingombrano ed occupano la detta strada, e li siti vicini ... , infatti due mesi dopo, il20 luglio, in occasione del passaggio dell'ambasciatore francese presso la corte sabauda, il Bongino riportava che occorse .. . Precettare quantità d'uomini per liberare la detta strada da una parte almeno di dette pietre .. . e proseguiva ricordando di come nel giro di pochi giorni nuovamente il transito s<1rebbe stato impedito ... per la qt{antità delle medesime che giomalmente và rotolando ....
(34) Il conte Alfieri lo ritroviamo citato più volte nella corrispondenza, sia nella figura di autorevole,consulente ed avvallatore dei progetti del Benedetto, e sia per proprie progettazioni come quella inerente la risoluzione del problema dell'accesso alla Novalesa (si veda Cap. VIII) e Per un'ulteriore, che non venne realizzata, per modifiche da attuarsi ai corsi dei torrenti affluenti nel Cenischia.
(35) A riguardo della larghezza il conte Alfieri cosl scriveva, che la strada ... dalle vicinanze del ponte di C!osé tende alla Novalesa, e si angusta e ristretta frtl due muri di pietra a secco, di modo che à gran pena e con rischio passar vi puole tm uomo à fianchi di tm calesse, sarei di sentimento, per evitar al grave disordine che nascer ne potrebbe dall'incontro di due sedie o altri legni, che venisse ordinato, non dover essere minore di piedi otto liprandi .. .. Indicazione che venne attuata su tutto il percorso, demolendo i muri laterali preesistenti ed abbattendo varie piante che erano ai bordi della strada.
(36) Nel corso dell'attuazione dei lavori si dovette intervenire nella borgata Brayda di Venaus eliminando alcuni avancorpi di edifici che ostacolavano il transito; demolendo e poi ricostruendo i muri laterali delle case di Giuseppe Clapero e di Lorenzo Rol, il tutto con una spesa di lire 74. Inoltre occorse anche demolire il forno del comune, anch'esso di ostacolo, che venne successivamente ricostruito con una spesa, per la sola manodopera di lire 50 (per il dettaglio di tali spese si veda l'Appendice Il).
(37) Giovanni Rosazza, originario di Piedicavallo nella val d'Andorno, apparteneva a quella schiatta di imprenditori edili biellesi la cui fortuna fu strettamente legata e derivata alle qpere pubbliche, realizzate tra il '700 e
3 7
21. NOVALESA. Vista panoramica d'insieme del corso del Cenischia e del tratto di valle sottostante l'abitato.
22. NOVALESA, Cassine dell'Ora. A fianco della strada reale risalendo la valle.
38
23. NOVALESA. Vista d'insieme dell'abitato.
24. NOVALE�A. La strada reale nelln regione della Pinea.
39
Dall'estate del 1752 la corrispondenza del Bongino con il Ministero degli Interni è un continuo riferimento all'avanzamento dei lavori: di particolare interesse sono le notizie che ci sono trasmesse sul nuovo ponte dell'Esclosa. Si può citare la lettera del31 agosto nella quale l'Intendente comunica: . .. Si travaglia da divasi giomi a fare li scavamenti per le fondamenta del ponte di Venaus, e si provedono le calcine, sabbie, e pietre per la costmzione dei medesimo, di modo che ho luogo di sperare che nei te1mine stabilito dal contratto, cioè per tutto il prossimo mese di settembre, sarà ii medesimo compito . .. , ma- come si vedrà- tale data non sarà rispettata. In una sua successiva del17 settembre, il Bongino ci da un'ulteriore conferma della concentrazione degli sforzi da lui fatta sui cantieri stradali (38) e sul ponte in particolare: comunica infatti di aver destinato il sovrastante Maffei . .. che ho qui tolto dal forte del{a Brunetta, giacchè il Regio Servizio non esiggeva più la sua assistenza a questo forte .. . per controllare e dirigere i lavori del ponte. Inoltre le squadre di scalpellini, che lavoravano le pietre da taglio, sono rinforzate con ... 1111 numero competente di mastri scalpellini che esso ne giomi sco"i si trovava aver impegnati per Regio Servizio a Exilles, ed a Fenestrelle, dove non restavano più necessari ... (39). Questi sforzi consentirono di procedere più celermente con i lavori del ponte; l'alacrità della progressione la ricostruiamo tramite la dettagliata corrispondenza. Il 2 ottÒbre si riporta che .. . le fondamenta del ponte di Venaus sono già a buon segno elevate, e fra breve il ponte sarà portato al piano dell'imposta . ... Il giorno 8 si è già . .. all'impo-sta, domani si principia ad amtare colli centeni, affine di fabblicmvi sopra li volti . .. . Il 12 . . . si stanno presentamente travagliando li volti del medesimo con sedici mastri da muro e 14 mastri scalpellini e li se1venti bisognevoli ....
Alla metà di novembre la strada era pressochè ultimata; il 12 il Bongino comunicava di aver ... l'onore di avanzare a Vostra Eccelienza col finire dell'entrante settimana sarà la medesima te1minata ave il tempo continui bello, co1n'è presentemellte ....
1'800 dallo Stato Sabaudo. Dei Rosazza- quali imprenditori- troviamo menzione in val di Susa sin dalla prima metà del XVIII secolo, impegnati in vari lavori alle fortificazioni della Brunetta e di Exilles. Dalla lettura dei contratti a loro intestati si può ricostruire uno'stretto susseguirsi di impresari Rosazza, probabilmente imparentati tra di loro, rispettivamente: Bernardino, Gio Batta, Pietro Antonio, Eusebio, Antonio, Giuseppe, Bernardo, e dalla generazione successiva Gio Batta e Carlo Antonio. Nel bene e nel male i Rosazza furono legati alle fortificazioni segusine: dopo averle in parte costruite, li ritroviamo alla fine del secolo impegnati nella loro demolizione; in queste opere i Rosazza si distinsero particolarmente, completando per proprio tornaconto ciò che le opere di mina non erano riuscite a fare (si veda P. G. CaRINO, Le settecentesche suppellettili delle cappelle castrensi di Exilles e della Bmnetta, La Va/susa, n. 6, Susa 1 983). In contemporanea ai lavori di fortificazione si ritrovano i Rosazza impegnati in contratti p�r la costruzione di edifici sia civili che religiosi; opere che si protrassero anche nel periodo di occupazione francese e che sfociarono ai primi nell'ottocento nell'edificazione del già citato "Quartiere Rosazza", ed alla parrecipazione nella costruziol)e _della strada napoleonica del Moncenisio.
(38) Dalla meta di settembre operarono giornalmente ai lavori della strada e ponte di Venaus: . .. 300 lavoranti oltre diverse vitture al trasporto di ghiaia. Dalla mettd di settembre sitt a que5/a parte mai è 5tato interrotto, e le semine sono5i da/li particolari gettate ne loro podeti di notte tempo . .. da una lettera del Bongino del 9 ottobre 1752. Alla fine dei lavori risultarono effettuate dalle sole comunità di Venaus e Novalesa- giacchè per quella di Ferrera non si sono rintracciati i dati relativi- le seguenti giornate lavorative: per i lavoranti n. 1 0.987 giornate; per i minatori n. 181 giornate; per le bestie da basto n. 614 giornate.
(39) La citazione che si fa nelle lettere della non più necessaria presenza ai forti, sia per il Maffei come per gli scalpellini, è da riferirsi al fatto che la campagna annuale dei lavori nelle fortificazioni alpi11e iniziava mediamente a marzo, per terminare ad ottobre, stante l'impossibilità eli proseguit·e gli stessi nella stagione invem;le.
Il loro trasferimento ai lavori sJradali, nonostante l'avvicinarsi della cattiva stagione, si spiega con l'estrema impellenza dell'ultimazione delle opere.
40
25. NOVALESA. La strada reale al piede delle Volle.
26. NOVALESA. Il ponte sulla bealera di Bellagarda e Valfredda lungo la strada reale.
42
La sicura abilità dei mastri scalpellini della val d'Andorno (40), che si impegnarono nella costruzione del ponte, può dar spiegazione e parzialmente giustifica l'errore in cui è caduto chi- esaminando solo il manufatto del ponte e non conoscendo la relativa documentazione archivistica - ha voluto attribuirgli origini "romane", e non settecentesche (41).
Le evoluzioni pmgettuali: il nuovo percorso delle Scale.
Sino ad ora abbiamo dedicato la nostra attenzione principalmente al problema della viabilità nel tratto Susa-Novalesa, con particolare attenzione al ponte di Venaus: ma i lavori promossi dal Bongino riguardarono anche il tratto in ripida salita, dalle Volte alla piana di San Nicolao e &i no alle Scale.
L'alluvione dell'ottobre 175 1 aveva devastato in modo particolare la strada nel fondovalle, ma anche il percorso a monte di Novalesa necessitava di radicali interventi ed adeguamenti. Solo 1'8 giugno 1752 il Benedetto viene incaricato - ... quale persona pratica del detto passaggio . . . - di relazionare sulle condizioni del percorso e di preparare un piano di interventi. Il25 dello stesso mese il calcolo delle spese, con tipo dimostrativo delle opere da eseguirsi, è inviato a Torino per l'approvazione, che si ebbe col già citato Regio Biglietto del 15 luglio.
I lavori da eseguirsi erano però definiti solo nel tratto sino alla piana di San Nicolao, giacchè, il progettato nuovo tracciato delle Scale era stato fieramente osteggiato da più par"ti. Prova precisa ne è il verbale del 24 agosto 1752 di una visita effettuata al Moncenisio dal Bongino e dal Benedetto che, in contraddittorio con varie persone interessate - i sindaci di
(40) L'impresario Rosazza, originario della val d'Adorno, si era assunto l'obbligo a far venire dalla loro patria hmti lavoranti che bastino a dar compilo i! lavoro per tutto settembre. Probabilmente erano i medesimi che l'impresario ingaggiava normalmente nei lavori da lui presi in appalto ai forti della Brunetta e di Exilles.
(41) G. \VI ATAGHIN CANTINO nell'articolo Il valico del Moncenisio. in età romana: dati archeologici ed ipotesi di lavoro· , in Le reseau routier en Savoie et e n Piemont- Aspects historique et comemporain, Chambery 1981 alle pp. 29 e 30, come pure A. CROSSETTO, C. DoNzELLI e G. WATAGHIN in Per una carta archeologica della Val/e di Susa in B.S.B.S., LXXIX (198i) pp. 369 e 408, identificavano alcune parti del ponte, quali le basi delle spalle e la pila centrale con i suoi speroni come di origine romana, attribuendoli ad epoca imperiale. Tale attribuzione, che si basaVa sulla diretta osservazione del manufatto alla luce della documentazione rintracciata-- in parte pubblicata in stralcio- viene messa completamente in discussione.
L'opera di attraversamento venne realizzata integralmente ex nova, dal livello delle-fondazioni sino all'estradosso delle volte; il 7 settembre 1752 il Bongino- inequivocabilmente- così scriveva: Questa mattina si è fondato il noto ponte di Venaus. A questo riguardo è da ricordare che per controllare l'operato dell'impresario, nel corso delle opere di fondazione, venne appositamente inviato il capomastro Martinetto.
Le diversità riscontrate dalla \XIataghin nella muratura del manufatto sono probabilmente da attribuirsi, come risulta dalla corrispondenza, alla carenza di pietre da taglio avutasi nel corso della costruzione; fattore che det_erminò, stante l'urgenza di ultimare la struttura e l'approssimarsi della cattiva stagione, l'utilizzo di materiale di minore dimensione e non rifinito, ma facilmente rintracciabile. È inoltre da ricordare che il ponte dell'Esclosa ebbe forma a due campate - con travatura lignea- solo a partire dal 1728 (si veda la nota 13).
Tra la più recente pubblicistica che ha indagato il tema del nascere, nel corso del XVIII secolo, di una moderna scuola tecnica per la progertazione e la realizzazione dei ponti, possiamo ricordare:
-Ponti di Torino, nel n. 9-10 (settembre·ottobre 1981) di Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino; in particolare, il contributo di Luciano Re dedicato all'opera degli ingegneri del "Corps cles Ponts et Chaussees" a Torino.
- I due articoli di Bruno Fortier dedicati a La nascita dell'Eco/e d es Poms et Chaussées in Casa bella, ottobrenovembre 1983.
43
29. NOVALESA. La strada reale nel tratto iniziale delle Volte.
30. FERRERA. La strada reale nl di sopra di Ferrera Vecchia.
4 4
Termignon, Lanslevillard, Lanslebourg, Ferrera e Novalesa, mastri di posta, vecchi conduttori, l'oste della Gran Croce ed il Rettore dell'Ospizio (42)- esaminarono le varie alternative possibili per superare il tratto delle Scale. Tale dettagliata relazione ci illumina su vari aspetti poco noti della viabilità sul colle del Moncenisio.
Il percorso che si decide di abbandonare non è, a sua volta, molto antico: per esplicita dichiarazione dell'Intendente esso era stato aperto nel 17 1 1 , regnando Vittorio Amedeo II. Tutti i convenuti si trovano d'accordo nel ritenere che tale tracciato sia da abbandonare, in quanto pericolosamente esposto alle valanghe ed alla tormenta: le opinioni invece divergono notevolmente a riguardo del posizionamento di quello riuovo.
Alcuni dei convenuti proponevano infatti un percorso in parte nuovo sulla sinistra del Cenischia, ma unito al vecchio con traverse a varia quota. Tale ipotesi venne confutata, e poi scartata, perchè tali traverse sarebbero state a loro volta esposte alle valanghe, non potendosi cosl impedire che .. . il detto passo sarebbe divers,e volte restato chiuso, con pregiudizio dei commercianti ....
Dalla discussione emerge quindi come vincente la proposta delineata dal Bongino e dal Benedetto, con alcune varianti suggerite dall'esperienza degli utilizzatori ed in specie del rettore don Grassis (43).
Particolarmente ·significativa è, in tale logica, la decisione di impedire un percorso che -continuando in sponda sinistra evitando il ponte sul Cenischia- conduca direttamente' all'Ospedale saltando la Gran Croce. Se un tale percorso fase stato attivato sarebbe scomparsa l'occasione di lavoro per l'oste della Gran Croce, che avtebbe abbandonato in tal modo il luogo. Si tratta di un pericolo che l'Intendente vuole assolutamente evitare ... conoscendosi troppo neccessario che restino alla .detta Gran Croce delli abitatori in tempo d'invemo, per servizio de comercianti, e passaggeri .... Il Bongino ordina per tanto di sca1pare un po' di rocco, impedendo l'attuarsi di un percorso non voluto. Questo fatto, come testimonia l'Intendente nella lettera di accompagnamento alla relazione, fa rientrare ogni opposizione alla realizzazione del progetto, fomentata dallo stesso oste della Gran Croce, preoccupato di veder svanire la preziosa fonte di reddito.
Viene inoltre deciso di demolire la vecchia cappella di "Notre Dame cles Neiges" alla Gran Croce, che obbligava la strada a passare in un luogo particolarmente nevoso; tra l'altro la struttura della stessa si presentava in cattive coridizioni con la volta tutta fessurata. L'oste si impegnava a pagare le spese per la ricostruzione della stessa in altro sito: resta così
{42) Si erano recati in quel giorno alla piana di San Nicolao: i sindaci ed i consigli comunali al completo di Novalesa e Ferrera, don Caffo il Vecchio e Gio Batta Caffo come persone solite a trami/are in tempo d'invemo, il mastro di posta della Novalesa Chiapusso e quello delle T averne il medico Francesco Bo n, Antonio C rosata vecchio capo mulattiere di Lanslebourg in rappresentanza di Termignon, per Lanslebourg il castellano Antonio Davrieu, il sindaco Giraud, Giacomo Gravier e Andrea Baudino vecchio mulattiere che da anni 51 traHica m/Monte Cenisio, Gio Batta Tournel oste della Gran Croce, ed infine don Grassis rettore dell'ospizio.
(43) Il rettore dell'ospizio del Moncenisio, don Grassis, assolse nel corso dei lavori un non secondario ruolo di consulente ed attento controllore dell'esecuzione dei medesimi. Il Bongino al suo riguardo, il 27 agosto 1752, scriveva:, ... esso signor Rettore che è migliore conoscitore di me e dell'ingegnere medesimo, come prattico delle situa:doni e dell'eHetto dellt1 neve e ghiaccio sovra la detta montagna ... , incaricandolo inoltre di controllare in assenza del Benedetto se i lavori . . . si fanno a dovere, e quando scorga qualche cosa contrada sia all<l sodeaa del lavom, sia alla bontà del medesimo, favorisca di fanne ne parte . . .. Per ricompensarlo venne dato ordine, il 14 dicembre, a lavori ultimati ... che si fa cino corrispondenza al signor Rettore Grassi a titolo di riccagnizione pelle sue straordinarie attenzioni anche pella condotta della strada del Monte Cenisio Lire 200 ...
45
31. FERRERA. Vista d'insieme dell'abitato.
32. PIANA DI SAN NICOLAO. Il pianoro con sullo sfondo l'erra delle Scale.
46
33. LE SCALE. Tracce appen<t in· telleggibili, tra le rampe napoleoni· che, del tracciato del 1752.
34. GRAN CROCE. Vista d'insie· me.
47
spiegata anche l'origine dell'attuale cappella della Gran Croce, di éhiaro impianto settecentesco; il progetto della medesima è probabile che sia stato opera dello stesso Benedetto.
L'esecuzione dei lavori venne intrapresa con decisione su tutto il percorso, con la speranza di ultimarli prima dell'arrivo della cattiva stagione (44). Ma a ritardare il piano d'avanzamento delle opere era soprattutto la mancanza della manodopera. Stante la stagione, era ormai la fine dell'estate alpina, gli uomini validi di Ferrera, No,,alesa e Venaus erano tutti ... impiegati al ritiro delle loro raccolte ed a gettare la semenza per l'anno venturo ... , e si ricordava che ... sarebbe troppo pregiudiziale a que poveri ten·azzani il dovetgli far presentamente abbandonare le loro montagne ....
E visto che era ormai vicina la festa della "Madonna di settembre", data in cui di norma si ultimavano i lavori agricoli, si sperava che da quel momento si sarebbe potuto contare su un sufficente numero di uomini; come infatti avvenne e si potè arrivare ad av,ere una forza di lavoro media giornaliera in tale sito di 100 uomini (45). Ma l'operato sia dell'impresario, che dei lavoranti, non era certo dei migliori; fu accertato che il Rosazza non metteva di per se molto impegno nell'esecuzione dei lavori in questo tratto. Al che il Bongino per stimolarlo all'operosità diede ordine di .. . applicargli 1111 paio di soldati alle spese ... cosa che subitamente diede ottimi risultati. Mentre dalla parte opposta i lavoranti, in specie quelli di Novalesa, dopo essersi portati sui luoghi dei lavori nel giro della mattinata iniziavano a sgattaiolare via, senza la minima preoccupazione, ed inoltre spesso si presentavano sui lavori privi di alcun utensile. L'Intendente diede perciò ordine di far ... subire l'alloggio militare agli amministratori della Comunità della Novalesa .. . colpevoli di non aver vigilato con diligenza sull'operato dei propri uomini (46), ed anche in questo caso i risultati non si fecero attendere.
L'8 ottobre i lavori per la formazione del nuovo tracciato delle Scale erano pressochè ultimati, come similmente nel tratto tra la piana di San Nicolao e le Volte; mancavano solo più le opere accessorie, muretti, gardefoux .. , interventi questi ultimi che s( protrassero sino all'inizio di novembre (47). Mentre i lavori nel tratto delle Volte si protrassero più a lungo del preventivato, giacchè si dovette fare giocare molte mine coll'uso della polvere per ampliare il percorso.
Nella corrispondenza ritroviamo ripetuti accenni alle ispezioni effettuate dall'Intendente sui luoghi dei lavori. Nel corso di una di queste, svoltasi il 5 ottobre, il Bongino richiese ad alcuni mulattieri quale fosse la loro opinione sul nuovo tracciato delle Scale, e si sentì esporre alcune perplessità a riguardo della pendenza e della sicurezza delle rampe che dalla piana di San Nicolao ascendevano alla Gran Croce. Le rampe, scavate nella viva roccia, mancavano di alcuna protezione sui bordi strapiombanti a valle, fatto che, in caso di maltempo, ren-
(44) A seguire i lavori vennero destinati, stante gli impegni del Benedetto: nel tratto della piana di San Nicolao e delle Scale il capomastro Giovanni Maffiotto, e nel tratto inferiore Bartolomeo Martinetto. Al di sotto della Novalesa vennero invece destinati Federico Lupis, Marco Vergnera ed il Pollone.
(45) Per l'ultimazione dei lavori vennero richiesti, il3 settembre, al vicario della città di Torino l'invio di ... dieci tnastri stemitori di quelli di Graglia provincia di Biella, che sono li p h( esperti in questa materia . .. , che prontamente vennero ivi destinati.
(46) In confronto, in una lettera del Bongino del2 ottobre, si ricordava come ben più meritevole ... quella di Venaus, che ubbidiente agli ordini di questo ufficio ha sempre fatto il suo dovere ..
(47) A riguardo di uno dei siti più pericolosi del tracciato precedente, il ponte Secco si ricordava in una lettera del 16 novembre, a lavori ultimati, che ... altre volte così temuto da passaggie�·i, ora è a tale stato riddotto che vi potrebbe passare una carozza, avuengnacche la /mghezza iui della stmda e di piedi nove !iprandi .. . circa metri 4.60.
48
35. GRAN CROCE. La sctlcccntcsca cappella di Notre Dame des Neiges.
36. FERRERA. La strada reale a monte dell'abitato.
37. FERRERA. Muri laterali lun· go la strada reale.
38. FERRERA. In primo piano resti dell'accurata selciatura della strada settecentesca.
49
50
deva periglioso il transito. La sicurezza del percorso venne subitamente ristabilita, come da proposta degli stessi conducenti, mediante la formazione di muretti a secco e di gardefoux.
Mentre, a riguardo della ritenuta eccessiva pendenza, venne fatto eseguire dal Benedetto nel corso del mese un controllo in confronto tra le pendenze del vecchio e del nuovo percorso. Da tale confronto risultò che la ... antica stmda della scala per ogni trabucco linea le ha' di pendio oncie venti ... pari ad una pendenza del27, 74%, mentre le nuove rampe avevano solo dodici oncie di pendenza pari al 16,64%; sul restante del percorso la pendenza si riduceva a oncie nove in dieci pari al 13,17% (48).
La percezione di una pendenza eccessiva la si doveva al fatto che le nuove rampe si estendevano tra i tornanti per un'ampiezza notevole: la prima di queste, partendo dalla piana, misurava infatti circa 60 metri; in confronto, il vecchio tragitto aveva un andamento quanto mai più spezzato, con rampe nei punti più ripidi lunghe tra i 10 ed i 15 metri. Per agevolare ulteriormente l'ascesa vennero inoltre realizzati lungo la rampa più estesa tre ripiani affinchè li muli carichi possano sovra d'essi riposare . . . , e come riferiva lo stesso Benedetto tutti li quali passano per la detta strada sono contenti.
Con l'ultimazione dei lavori le scelte operative dell'impianto stradale non venivano più messe in discussione; infatti anche la percorrenza rispetto alle antiche Scale era ridotta di un quarto d'ora. Il nuovo tracciato era semmai fonte di preoccupazioni economiche per gli abitanti della Ferrera e della Novalesa, come riportava l'Intendente il15 ottobre: ... siccome la detta strada nuova per essere tmppo bella e troppo facile sarà 1<1 loro rovina, perchè molti particolmi èhe si facevano portare potranno d'or in avvenire discendere comodamente ....
Anche da questo passo è pertanto leggibile l'elemento che era -al contempo -la forza e la debolezza di Ferrera e Novalesa: ambedue le comunità vivevano, infatti, dei traffici passanti per il Moncenisio, ma - paradossalmente -esse erano in posizione tanto più forte, quanto più i traffici trovavano problemi ed ostacoli in una viabilità ancora primitiva.
La nuova logica illuministica, a partire dal settecento, porrà al centro dell'azione dello stato un crescente miglioramento tecnico delle vie di comunicazione, fino ai colossali lavori napoleonici: per Ferrera e Novalesa sarà la fine di un privilegio ed un'uscita obbligata dal palcoscenico della storia delle grandi comunicazioni internazionali.
Con l'approssimarsi dell'inverno del 1752 il lavoro impostato dall'Intendente si avvia pertanto a definitiva conclusione (49), ed il Bongino può cosl segnalare al Ministro, in data 19 novembre, addirittura che: ... li portatori della Novalesa, ma/ sospettosi che siasi resa in così buono stato la strada del Moncenisio, vanno disseminando della zizzania all'orecchio delli passeggeri . . . ('0) .
(48) E da ricordare, a confronto, che attualmente le pendenze massime di norma ammesse per percorsi di montagna variano dal 4% delle strade di grande comunicazione, sino al 9% per quelle locali.
(49) Il costo di formazione del nuovo tracciato stradale - nella tratta Susa-piano di San Nicolao - ascese a Lire ·10.154: 10. Le singole voci che lo compongono le possiamo desumere dallo Stato delle travagli fati fare nell'anno scorso 1752 dalle Commrmità di Venaus, Novalesa et Fet;era . . . , redatto dallo stesso misuratore Benedetto.
Rimandiamo il lettore all'Appendice 2, dove è stato pubblicato in tegralmente il documento; la sua lettura può essere quanto mai interessante per meglio comprendere la tipizzazione dei lavori ed il modo di stesura di simili documenti contabili in periodo settecentesco.
('0) Ma oltre a parlare, i mulattieri operavano anche per screditare la strada. In un post scriptum della lettera del 19 novembre l'Inten dente fa sapere ... che li portantini li quali portavano il signor conte Be/legarde all'occasione del passaggio della 1!101/lagna giouti circa il finiJ'e della strada per una maliziosa loro condotta abbiano gettatolo a basso la sedia, o sia cadrega, e ciò al puro fine di far vedere al detto signore che la detta strada è cattiva e troppo 1ipida ...
51
Sarebbe tuttavia erroneo ritenere che i lavori per la "nuova strada" del Moncenisio fossero veramente ultimati. Ieri come oggi, infatti, un percorso stradale principale -pur completato -abbisogna ancora di opere d'arte integrative e di interventi di miglioria. Inoltre -molto più che nella situazione attuale -la viabilità settecentesca era oggetto di rapido degrado, dovuto sia alla povertà del materiale usato per il fondo, sia all'erosione delle acque.
A partire dall752, inizia dunque una nuova fase nella storia della strada per il Moncenisio, storia fatta di lavori di completamento e manutenzione. A questa nuova fase saranno dedicati i capitoli seguenti, che consentiranno di seguire le vicende della strada fino al grande progetto napoleonico, che non solo renderà obsoleto il lavoro eseguito dal Bongino, ma muterà drasticamente e permanentemente l'economia e le condizioni di vita della valle Cenischia.
INSERTI
Documentazione iconografica
I
LA VIABILITÀ SusA- V ENAus- NovALESA- FERRERA, TRA XVII E XIX sEcoLo (TAVOLE I-XIII)
II
LA VIABILITÀ NELLA ZONA DELLE- SCALE, TRA XVII E XIX SECOLO (TAVOLE XIV-XXV)
53
I due inserti raccolgono una selezione di cartografie e di disegni originali, in parte anche inediti, utili per ricostruire il percorso e le caratteristiche tecniche della strada del MonceniSIO.
Di ogni documento viene forhita una riproduzione fotografica a piena pagina; di fronte, un testo sintetico mette in evidenza i punti più interessanti del documento e ne riporta la posizione archivistica e, ove possibile, l'autore.
54
I
LA VIABILITÀ SusA-V ENAus-NovALESA-FERRERA, TRA XVII E XIX SECOLO (TAVOLE I -XIII)
Tavola I
Su·alcio di un disegno in larga scala riproducente il teatro degli scontri svoltisi sul confine tra il Ducato di Savoia ed il Regno di Francia nel 1 629. I l disegno -benchè approssimativo- ci da una chiara immagine della strada per il Moncenisio nel XVII secolo. Si noti innanzitutto che, oltre alla strada che si diparte dal ponte di San Rocco e risale la bassa val Cenischia su sponda destra sino al ponte della Brusà, sussiste un percorso minore -alternativo - su sponda sinistra, che partendo da Mompantero si innesta sulla strada principale all'altezza del detto ponte. Dalla Brusà - il ponte come si vede è al di sotto di Venaus -la strada prosegue su sponda sinistra e solo al di sopra Novalesa torna nuovamente su sponda destra. Da qui superato il tratto delle Volte la strada ritorna per un breve tratto in sponda sinistra ed entra in Ferrera. Appena superato l'abitato però il tracciato torna nuovamente sulla sinistra per proseguire verso il colle. Si osservino -quale nota di colore- il particolare risalto dato alle cascate formate dal Cenischia.
M. TAVERNIER � 1629
Carte particuliere des Baricades de Suze Jaillon le Gouret et passages d es environs di ce l/es an se voit clairement lassiette du pais lordre'et ataque d es ditte Baricades fait par la Majestè tres Crestienne Louys 13 Roy de France et de Navane le ... de .. . en l'en 1629. Collezione Gilibert - Torino.
56
Tavola II
Carta particolareggiata della piana di Venaus redatta dal Bettola nel 1722 (si veda a p. 22); ·tale disegno è di notevole interesse, in quanto consente una chiara ricostruzione del percorso della strada reale prima degli interventi del 1752. Risulta evidente come il tracciato "sal· tava" Venaus, per appoggiarsi sulla sinistra del Cenischia immediatamente a ridosso dei monti della Bmcciata, in una posizione particolarmente sottoposta alle frane che si distacca· vano dalle pendici del monte. Da notare le opere di attraversamento sul Cenischia: il ponte della Bmcciata sulla strada reale ed il secondario ponte de/l'Esclosa; come pure il viottolo o sia sentiero contmverso che fu alla base del contenzioso tra le comunità di Venaus da un lato e Novalesa e Ferrera dall'altro. È inoltre da notare l'ampia ansa formata dal Cenischia subito a valle del ponte dell'Esclosa: in carte redatte in epoca successiva -e qui di seguito riprodotte- il percorso del torrente taglia più diagonalmente la piana. È probabile che lo spostamento dell'alveo sia avvenuto a seguito dell'alluvione del 1728.
G. BERTOLA - 1722
A.S.T., Sez. Riunite, Ufficio Generale delle Finanze, Prima Archiviazione, Ponti e Strade, m. l n. 9.
57
"' *0.. '- \:
"' '"" ...... . ) ' .
! l l
l �� � . ) 1
l'l' l l)
l ,,
ì
\.l .. t ì 1,. >·rl '\
.-... .l\" ,_,�) "'
t l
,.,
58
Tavola I II
Stralcio della "Carta in Misura" della zon� tra Susa e Novalesa; su questa è chiaramente leggibile il percorso della strada reale successivamente agli interventi del 1752. È interessante annotare come il tracciato utilizzato sino a tale data- dalla Cornà al ponte della Brusà e da qui all'Esclosa -non viene più segnato neanche come viabilità minore. Stante le devastazioni subite il tratto su sponda sinistra, dal ponte della Brusà all'Esclosa, scomparve integralmente; mentre la parte restante, tra la Cornà ed il Cenischia, tuttora in parte esistente, decadde ad un ruolo agricolo. È da rimarcare che tale carta, per le sue particolarità descrittive, è di notevole ausilio affrontando qualsivoglia discorso di ricostruzione ambientale delle valli di Susa in epoca settecentesca.
1760/1770
Carta topografica in misura della Valle di Susa e di quelle di Cezanne, e Bardonneche; divisa in nove parti. V Parte quinta, che comprende i luoghi di Chaumont, Gravere, Meana, la città di Susa, Giaglione, Venaus, Mompantero, e Novalesa, come altresì i colli de I'Amait, de Thures nella Francia; e quelli di Clapis, dell'Assietta, du Grand La c, du Val/an des Morts, de la Va/lette, de la Vieille, delle Fattiae, delle Fin�stre, che discendono nella valle di Pragellato.
A.S.T., S ez. di Corte, Carte topografiche per A e B, Susa n . .3.
60
Tavola IV
Stralcio della "Carta in Misura" della zona tra Novalesa e Ferrera. La strada reale a monte di Novalesa attraversava per primo il rivo Gioglio; si osservi la diversa positura dell'alveo dello stesso, e successivamente il Cenischia, con il ponte al Pie' delle Volte; da qui -su sponda destra - iniziava l'ascesa verso il Moncenisio. Si noti il tratto delle Volte, dove la strada con un rapido susseguirsi di tornanti -ben 56 volte o giri - riusciva a superare la notevole erta della montagna. Si osservi inoltre sul versante sinistro della valle -segnata come viabilità minore -il percorso ante seicentesco che dalla frazione di Santa Maria ascendeva alla Ferrera (si veda a p. 23).
1760/1770
Carta topografica in misura della valle di Susa e di quelle di Cezanne, e Bardonneche . . . , op. ci t. IV Parte quarta, che comprende i luoghi di Thures, Bousson, Sauze di Cezanne, Champlas du Col, Cezanne, Fenils, Moil/eres, Solemiac, Oulx, Sauze d'Oulx, Salebertmnd, Exilles e Le Fm·ere, unitamente ai colli di Ciabaud, de l'Alpe!, e di Servierette nella Francia: come pure quelli di Sestriere, del Basset, del Bourget, Coste Piane, du Blegiè et de Sourde nella valle di Pragellato ed ancora quelli di C/apiè e le Mont-Cenis nella Savoia.
62
Tavola V
Stralcio di un disegno riproducente lo stato delle difese approntate nel 1794 in val di Susa nel corso del conflitto contro la Repubblica Francese. Il disegno -pur approssimativo- ci delinea il percorso della strada reale alla fine del XVIII secolo. Da osservare la particolare ·e precisa raffigurazione del ponte dell'Esclosa, come pure l'ingresso in Novalesa con il ponte sul Claretto. Si osservino inoltre le opere di difesa realizzate a sbarramento del fondo valle: sulla sinistra del Cenischia la Batterie, Ban-aquon, et Retrancbements de Monpantier, mentre sulla destra i Rentrancbements et Ban·aquon du Roe in posizione di comando sul ponte dell'Esclosa e sulla strada reale verso Novalesa.
DE MoNTHoux - 1794
Pian de la Ligne de de/eme accupee par !es C01ps d'Armee commandè par le Generai Baron De La Tour sur /es bauteurs de Suse à la campagne du 1794. A.S.T., Sez. di Corte, Carte topografiche segrete, 20 A V.
64
Tavola VI
Foglio di mappa riproducente la parte orientale del territorio di Venaus nell'accatastamento dell794. Nella stesura del disegno la strada reale vènne in parte utilizzata come limite delle parti del territorio riprodotto; la vediamo infatti rappresentata a delimitazione del lembo inferiore del disegno. La precisione dello stesso ci permette di seguire passo a passo il tracciato della strada nel territorio del comune. Inoltre in pn particolare della mappa raffigurante la Brajda- che riproduciamo a parte- possiamo seguire il percorso della strada nell'interno dell'abitato. Da osservare inoltre la particolare e minuziosa cura data nella rappresentazione dei diversi ìipi di coltura; e si confronti infine il tracciato ec! il posizionamento del Cenischia con quello riportato nei disegni precedenti.
G. GARINO- 19 marzo 1794
Mappa Prima Originate del Tetritorio di Venaus per fa porzione Esiste a levante del!a Strada Reale.
A.C. V.
.J •• • ••••• ·!. .. •. .. ' '• . ···� ',. ,. ��� ·:, ..... ,:·" .. Il �} ... • .. ..._ • .. • •• , . .. . . • • • , ,
. ,, " , .... , , h o ' . ..... . ... ... . . tiJ �· ,, " l .... � .. .. , '' � ,...,""' - •• •" P' rt Il Pr ,, ..-, l Il '\•,.t•N·•• .. · �.;;;,,ì '".. .. " ,, ., , .. ,. ' •. ,,� .. � � .. ..
, i' ... :... t't:' lt ., " , , .. "., ''• \ ,., ··;, , q .. , . .... � . .. l .. • • • ••
.. t •.. l .. • � .. :·· i . . . . . . ,� "·: ... : ... ': .. " • ·.: •. , ' .... ::·
'"/' ' ' ,. · . ":t . l . .. .... · ,.:\.
�� �� � ·� � ... . :'t" , ....... , / .. l
..• ����.·� l ••• } ••• '} ·�'. 'l'/ , :< ,:· '\
·· ....
(
..
...
· .. .. .
' ..
'l I L\ l�\ 1,.
\.
' . ,
:. ,,t,• ' 'l •
·.·r r ,\ · Il;
• l '·/'
,.
,,,
65
..
J
66
Tavola VII
Stralcio del monumentale studio cartografico per l'allora progettanda strada napoleonica, disegno realizzato nel 180 1 (si veda p. 130). Il particolare riprodotto mostra il tracciato della strada settecentesca nell'attraversamento di Venaus. Si noti come l'abitato si sviluppava particolarmente lungo la strada, che si era allora in procinto di abbandonare.
J. H. DAUSSE - 1801
Pian du Mont Cenis depuis Lanslebotllg iusqu'à Suse, avec le proiet de route dans la traverse de celte montagne faisant partie de la comunication de France en Italie. A Grenob/e, le 1er Nivose au 1 1 de la Republique fmncaise. Dausse ingegnieur en chef. (22 dicembre 180 1).
A.N.A.S. -Torino
'·
.. •:
:-·,;· .... r ... , o/ ' \ .
! •. l \ '-:.
l j; i
� . ��) . . ·'
. • • \'1 , ; \!'. ll't l;, i . ' . . . l ,. l·� �. ,, . .. , :
l ... '
!:; ;. • :, ;, ; , • l
.• l
' �· •,,
, l • • " , , -�, ,•
67
ì·
68
Tavola VIII
Altra sezione della cartografia di progetto del l SOl. È chiaramente individuabile il percorso settecentesco della strada reale, citata come Chemin Actuel, con il ponte deli'Esclosa costruito nel 1752 . Si noti inoltre l'arginatura sulla sponda destra del Cenischia. a difesa dei campi della piana di Venaus.
- 1801
Cenis depuis Lanslebomg iusqu'à Suse, avec le proiet de route dans la traverse de , op. cit ..
:.
! .... -. ,
i, l
.. _ _, '\"
. .
.. . .
\·
·;..;:
'l
{ . .. '
l' , I l - · · l l•
•l
-� ( :..� i .... •
..
,-.
_·,· --· .... ...
. '
69
, ., .
'· ,.t' ..
7�
... ...., .. · � · r ·-· �. i/ .
·'
70
Tavola IX
Ulteriore stralcio della cartografia del1801 riproducente la zona di Novalesa. Si veda l'andamento della strada settecentesca nell'attraversamento dell'abitato. Di estremo interesse è il tracciato ipotizzato, e non realizzato, che dal Molaretto sarebbe disceso su Novalesa; al di sotto dell'abitato si sarebbe innestato sul percorso settecentesco con la formazione di una grandiosa piazza circolare ( si veda p. 131). Tale intervento, se attuato, avrebbe in qualche modo salvato il ruolo commerciale di Novalesa.
J. H. DAUSSE- 1801
Pian du Mont Cenis depuis Lanslebourg jusqu'à Suse avec le projet de route dans la traverse de celte montagne . . . , op. cit ..
,., \,'1.
'· !
' ' l
'
i
• • ':·.,o t •
r'
•"',·. .. l 1
..
)'
'·'· .... , "
.. ··'
71
'·
' . ,l
. .
72
Tavola X
Ulteriore sezione della cartografia del 1801, in èui è rappresentato l'abitato della Ferrera con l'area circostante. La strada reale, proveniente dal fondovalle su sponda destra, si spostava su quella sinistra all'ingresso dell'abitato. Alla fine del medesimo la strada passava
'
nuovamente sulla sponda destra per continuare verso il colle. Si noti che nell'interno della Ferrera sono segnati ben quattro ponti sul Cenischia.
). H. DAUSSE - 1801
Pian du Mont Cenis depuis Lanslebo111g iusqu'à Suse, avec le proiet de route dam la traverse de celte montagne . . . , op. cit ..
74
Tavola XI Il preciso disegno di metà ottocento ci consente di seguire con precisione il tracciato della già strada reale, citata come Ancietme Route, alle porte di Novalesa. La carta è di particolare interesse in quanto documenta - cosl pure come il coevo rilievo del "Catasto Rabbini" ( 1859-1860)- il punto di confluenza tra il Marderello ed il Cenischia. Tale confluenza avveniva molto più in basso del punto attuale; per un confronto si rinvia alla cartografia di sintesi, riportata nella tavola in allegato.
1852
Route Paris-Rome (nivellement). Le Mont Cenis-Lansiebourg-Suse.
A. S. C., Cartes et dessim n. 970.
i· l
......... -... _,...--- .
. \ \ ·, :� l \ :
.·, ' , l
' . \. ·,
\l .,\ \'. l} \'\l\ . . :.•
' , . . ,
.. .
l l
.�l
•, .
'l ' ' '\
,· ,: , \ :, :) l l l
·'·' ,i
, .
·,
1 zc:•
, ( l
\ ,,
l l ' .\.
\ \
i -,
: ( ' >
" l .. l l
l 'l'
.\ ,''
''-.• 1.:.
l '- -......
l
l
/
' t
75
76
Tavola XII
Il "Catasto Rabbini" di Novalesa (185 9-1860) non riporta sostanziali modifiche rispetto alla sistemazione settecentesca dell'abitato, ad esclusione dell'intervento attuato nel1775, riguardante il prolungamento della "contrada Maestra" con la risoluzione dei problemi di accesso alla Novalesa (si veda il cap. 8). L'abitato è rimasto come "fossilizzato" dopo la traumatica esclusione dal grande traffico del Moncenisio. Si noti come compaia ancora - lungo l'attuale strada del Ghetto-, segnata come edificio civile al mappale 1088, la cappella che viene menzionata, segnata-con la lettera I, nel disegno del 175 2 riportato a p. 1 09, attualmente scomparsa.
1859/1860
Mappa Originale del Comune di Novalesa.
A.S.T., Sez. Riunite, Catasto Rabbini, mappa T. n. 59.
78
Tavola XIII Il "Catasto Rabbini" di Ferrera (1859) non introduce novità rispetto alla situazione settecentesca: il paese, ormai abbandonato dal grande traffico, ha perso ogni spinta evolutiva sotto il profilo urbanistico.
1859
Mappa Originale del Comune di Femra.
A.S.T., Sez. Riunite, Catasto R!lbbini, mappa T. n. 34.
80
Tavola XIV
II
LA VIABILITÀ NELLA ZONA DELLE SCALE, TRA XVII E XIX SECOLO (TAVOLE XIV-XXV)
Ulteriore stralcio del disegno in larga scala, già riprodotto in parte alla tavola I, raffigurante il teatro degli scontri tra il Ducato di Savoia ed il Regno di Francia nel\6 29. Il disegno, pur nei suoi limiti, ci fornisce però una chiara indicazione della posi tura della strada nel tratto delle Scale in epoca seicentesca. È evidente come il percorso si snodasse integralmente sulla destra del Cenischia con un andamento, per superare il gradino roccioso, caratterizzato dal susseguirsi di tornati e ripide rampe. Si noti anche in questa il.particolare risalto dato alla cascata del Cenischia.
M. TAVERNIER- 1629
Cal"le particuliere des Banicades de Suse Jaillon la Gomet et passages des envimns di ce l/es 011 se voit c!airement . .. , op. cit ..
82
Tavola XV Stralcio di un disegno in larga scala riproducente le posizioni delle forze austro-sabaude nel corso della campagna militare del1708. Il tracciato della strada nel tratto delle Scale è rimasto praticamente immutato rispetto al secolo precedente; manca - come si vede- il tracciato del cammino novo'delle Scale che venne realizzato solo nel 1711 .
EMANUELI
Carta corogmfica delle valli di Susa, Moriena, Bmdonanche, Oulx, Exilles, Cesana, Pmgellato, St. Martino, Perosa, continente li villaggi, cassinaggi, strade tanto reali, che altre, fiumi, torrenti, rivi, con la disimzione de ten·eni fertili, boscareggi e sterili in esse esistenti, come a>1che le morchie, contromarchie, e campamenti dell'annate tanto S.A.R., che de' collegati, l'anno 1708 comandate da detta R.A ..
A.S.T., Sez. di Corte, Carte topografiche per A e B, Susa n. 2.
84
Tavola XVI
Su·alcio dai fogli di mappa del "Cadastre Sarde" del 1728/ 1729 del comune di Lanslebourg; il particolare che riproduciamo è tratto da una copia del medesimo eseguita nel
1733 . Il disegno, pur se catastale, ci da una chiara immagine della zona tra le Scale e la Gran Croce. Si veda innanzi tutto che il limite del territorio riprodotto corrisponde, oltre che a quello delle terre del comune di Lanslebourg, al confine tra còntea di Savoia e principato di Piemonte. Proprio in corrispondenza di questo, all'inizio delle Scale, troviamo posizionata, all'epoca ormai ridotta in ruderi, la cappella di San Maurizio. Come si può riscontrare, sussistono due percorsi sulle Scale: quello principale- il cammino nova delle Scale del1711-più rettilineo che si avvicinava al Cenischia, e quello segnato come minore -già seicentesco- con andamento tortuoso. Si osservi inoltre lo sviluppo dell'abitato della Gran Croce tramediato dalla strada reale, ante gli interventi del1752 che modificarono radicalmente la struttura dell'abitato, nonchè il preciso posizionamento, al di sotto dell'abita-to, di una costruzione, verosimilmente la già segnalata vieil!e capite.
.
1728/1729
La Presente Carte à été copieé sur Loriginal levé en mesure à loccasion de la Mansuration Generale de la Savoye, par /es geomettrer Chades Caesar Prina, Miche! Antoine Ravissoty, Miche! AliIlo/me, et Jean Baptiste Botta, et Joseph Mmipilliand, assistès par /es trabucauter Pien·e A11toine ivfmie Facios, Antoine Simon Gabriel Phissard, Pien·e Rosa, et Jean Amedeo, et par ordre de Momieuri'Intendant ge11eral Jay signe la presente à Chambè1y le 15 Janvier 1733. Cocelli.
A.S.C., Cadastre Sarde, n. 581 bis.
86
Tavola XVII
Disegno riproducente i trinceramenti dell'Arpone all'epoca delle guerre di Successione d'Austria 1742-1748. Il disegno ci da l'esatta positura del sistema difensivo sul Moncenisio in questo periodo (si veda la nota 21), opere che ricordiamo essere in funzione diretta di controllo e comando della strada reale. Nel tratto delle Scale sono segnati due tracciati tra di loro alternativi: quello idenificato erroneamente nel disegno come percorso principale - denominato l'Echelle- già seicentesco, e quello segnato come minore- con andamento più rettilineo- apertosi nel1711 e ricordato come cammino nova delle Scale. Si noti inoltre la citazione della Cape/a di San Nicolao, e quella della Vieill? Capite al di sotto della Gran Croce.
1749
A.S.T., Sez. di Corte, Storia della Real Casa, Storie particolari, cat. III, m. 22 vol. 11 p. 32.
Di tale disegno esiste un'ulteriore copia sostanzialmente identica in A.S.T., Sez. di Corte, Carte Segrete, 32 A I.
88
Tavola XVIII
Stralcio della già citata "Carta in Misura" riguardante l'area tra il piano di San Nicolao ed il.lago del Moncenisio. Come si vede il tracciato della strada reale- post 1752- si spostava, al piede delle Scale, su sponda sinistra per ritornare nuovamente, nel corso dell'ascesa dell'erta rocciosa, sulla destra ed indi proseguire alla volta della Gran Croce. È interessante notare come venga ancora segnato il tracciato precedente su sponda destra. Si veda inoltre
- lungo tale percorso- la segnalazione e posizionamento della Masure de la cbapel!e de Saint-Maurice.
1760/1770
IY Carta topografica in mism·a della Valle di Susa e di quelle di Cezanne, e Bardonnecbe ... , op. Clt ..
90
Tavola XIX Carta di buon dettaglio- redatta nel 1765- riproducente l'alta val Cenischia, dalla piana al di sopra della Novalesa sino al lago del Moncenisio. Si osservi l'andamento della strada reale, in specie nel tratto delle Scale dove, come già rimarcato nel commento della "Carta in Misura", viene ancora segnato, oltre al nuovo tracciato del 1752 su sponda sinistra, quello precedente sulla destra. Tale carta è particolarmente utile per individuare il posizionamento delle numerose margherie poste sulle pendici attorno al Moncenisio.
.
1765 Carte geometrique d'u11e portio11 de Mont Cenis avec ses aboutissen, Levee en 1765. A.S.T., S�z. di Corte, Carte topogmfiche per A e B, Monte Cenisio n. 2.
92
Tavola XX
Interessante veduta prospettica dell'erta delle Scale nella seconda metà del XVIII secolo, anno 1787 circa. Nonostante alcune libertà pittoriche presesi dall'autore, la tavola rispecchia, abbastanza fedelmente, il sinuoso andamento del tracciato stradale post 1752, realizzato per superare agevolmente il notevole gradino roccioso. Si osservi come, al piè delle Scale, la strada si spostava su riva sinistra del Cenischia per ritornare, dopo aver guadagnato quota grazie ai vari tornanti, a 2/3 circa del tracciato, nuovamente sulla destra. Al riguardo si noti come per superare il corso del Cenischia, frammentato in varie cascate, siano raffigurati due ponticon arcata in pietra e calce. Tali opere lapidee vennero eseguite con tali materiali presumibilmente negli anni settanta del XVIII secolo. Il ponte che si intravede in primo piano, ricordato come di San Nicolao, era sito nelle vicinanze della cappella omonima. Tale opera sussisteva ancora nei primi decenni del XIX secolo, come testimonia la sua raffigurazione in alcune stampe di tale epoca. Il secondo attraversamento, sito già in quota, è similiare al primo come costruzione, ma, come si denota, si sviluppava maggiormente in altezza onde superare il tumultuoso corso d'acqua. Tale opera sc�mparve nel corso dei lavori di formazione della strada napoleonica, successivamente al 1811 . Quale nota di colore si osservino, in primo piano sul ponte, i due muli che risalgono verso il colle trasportando parti di una carrozza smontata, mentre sulla destra, su una delle rampe, sta discendendo un personaggio in portantina, trasportato da due "marrons".
1787
Vue dessinée de la p!aine de St. Nicholas sur le mont-Cenis dans !es Alpes Cottienes, ou l'an L'Oit la chute de la petite Doria, et la grande Croix au Sommet. Tavola tratta dal volume di Jean-François Albanis-Beaumont, Voyages dans !es Alpes Grecques et Cottiennes, Genève 1787.
Collezione Gilibert - Torino.
94
Tavola XXI
Carta d'effetto, ma poco dettagliata, dell'area del Moncenisio, datata 1796. A riguardo della strada è interessante annotare la segnalazione della galleria all'imboccatura della piana di San Nicolao, costruita nel 1775-1779, citata come Chemin cauve1t (si veda il cap. 11). Si osservi inoltre come nel tratto delle Scale siano riportati tutta una serie di percorsi, senza tuttavia segnalare utili elementi di gerarchizzazione viaria.
1796 Pian du G,rand Mani Cenis leve dans le mais d'actabre e>d796 la demarcatian des . . .
B.R.T., Disegni Il 26.
96
Tavola XXII
Ulteriore stralcio dello studio progettuale, del 180 l,· sulla strada napoleonica. La viabilità settecentesca- definita Chemin actuel- è chiaramente leggibile, come pure la nuova soluzione poi attuata per evitare le Scale. La nuova strada dall'inizio del piano di San Nicolao si spingeva, con un lungo percorso a mezza costa, sulle pendici del versante destro sino a raggiungere la Gran Croce. Tale percorso sarà però poi abbandonato in seguito della frana caduta nella notte del31 agosto 181 1; successivamente tale tracciato venne poi utilizzato dalla ferrovia Fell. Si osservino i vari ponti segnati lungo la strada settecentesca, ed il posizionamento del Limites du Piemont, ricordando però che il sito indicato non corrisponde a quello dell'antica cap-pella di San Maurizio.
.
]. H. DAUSSE- 1801
Pian du Mani Cenis depuis Lanslebourg jusqu'à Suse, avec le projet de mute dans la traverse .. . , op. cit . .
98
Tavola XXIII
Successivo studio, sempre di epoca napoleonica, relativo alla risoluzione del nodo delle Scale. Realizzato dal Derrien successivamente all'estate del 1811, riporta un completo rilievo dei due percorsi in uso nel XVIII secolo: la Route abbandonnee ante 1752, e quella realizzata in tale data ancienne Chemin Passant par la Feniere. Nel disegno vengono evidenziate, oltre al percorso allora in uso disposto a mezza costa sul versante destro, varie soluzioni alternative onde evitare il sito della già citata frana. Le soluzioni proposte riguardano o la formazione di una lunga galleria, cosl evitando il sito franoso, od altra più drastica, che verrà addettata, concernente il radicale abbandono del nuovo tracciato ed il ritorno della strada nel piano di San Nicolao, affrontando nuovamente le Scale con una serie di tornanti. Si noti inoltre la precisa rappresentazione ed il risalto dato alla galleria settecentesca.
J. DERRIEN - 1811/1813 Pian de la Route actuelle du Mont-Cenis ven la Plaine de Saint-Nicolas, avec divers Proiets de changement de direction tendam à eviter /es eboutemens de Rochers qui ont presicipetement lieu ava n t et apres la Galel'ie souteraine. Copia conforme in data 11-7-1813 , da originale datato 28-11-1811.
Collezione Gilibert - Torino
100
Tavola XXIV
Raffigurazione completa a lavori ultimati delle strade sul Moncenisio; il disegno, opera del Derrien, è datato gennaio 1 816. Vengono riportate: segnato in rosso il tracciato napolèonico, in giallo la diversione Route abbandonee sulle pendici al di sopra della piana di San Nicolao, ed il percorso settecentesco definito ancien chemin.
J. DERRlEN - 1816
Pum de la· Route du Mont-Cenis.
A.S.T., Sez.di Corte, Carte Topografiche Segrete, 7 A III.
�.
� �
;. ì
:� � l: ' ' � ! ·� · J ;,...· �· � '!
-..;: 't � j , � l
' ' . , :l \·
·'' ·( � l "
� . �
'1: .; :k ! l: � ' 'i 'Ì
·� :i ..:.
� l � ., ·. ·, '
� !·
� l: �
... �
' ': " ·, \, "
� ,..-.;:: . . ,
' .
·li
�.' ,
l' . l ·;;� l ::� l! "' . 'l ��v jl il :-:·: � l ,.
.. , l ... . ..
·� . , ' " ·:· il "'
� l l, ' l � 1:
j li ....
·� l t ... ' l,
!
l J .. .... 't .... . ...
'l
� "" . . · . . .l ·'l
.... ' ... � · ··' ••• 'lo-l • ' •
� -.;::
.:::: �
� ·�
l
T 1.
l
. l l
). . �:.:. ·" . "-' ·
. , -1.
�� . , ::; l:
. � � -�� .�\� � � '� ·l;:
� l:: ·� '� \�
....
� � 'l
\
! � t t �U .}1
j � Yt .....:: � ! \ � ·� \\ '" {i �'
"\ . , '
� � ::;
·� � l, ;:: �
'� � .... '·� ' ' ' f �
' ) � �·:t ·" l "" ' ' , l
. , ' 'l ;:: 1 � �
·� � \
� � :j " . ' " l
1: ·' l ' {
' ' \
l
101
�� t
'l ,,
:1 l'
l' r }
102
Tavola XXV
Stralcio del "Catasto Rabbini" riproducente le Scale e l'abitato della Gran Croce nel comune di Ferrera - Altopiano del Moncenisio (1859) (*). La sistemazione stradale di epoca napoleonica è rimasta pressochè immutata. Inoltre è chiaramente leggibile il percorso di attraversamento della Gran Croce da parte della strada settecentesca.
1859
Mappa Originale del Comune di Fenua.
A.S.T., Sez. Riunite, Catasto Rabbini,-mappa T. n . .34.
(*) Porzione del Comune di Lanslebourg, rimasta al Regno d'Italia dopo la cessione della Savoia alla Francia.
104
7, LE OPERE DI MANUTENZIONE.
Dagli atti di visita, che periodicamente i regi misuratori effettuavano per controllare le cgndizioni della struttura viaria, compare evidente la gravosa e pressochè continua incombenza sulle comunità della val Cenischia per la manutenzione della strada reale. Le comunità della valle, se da un lato usufruirono da sempre dell'utile economico dato dal passaggio dei viaggiatori, dall'altro dovettero sempre soggiacere alle pesanti corvèe per la manutenzione della strada. Con l 'apertura del nuovo tracciato tali prestazioni- presumiamo - aumentarono notevolmente, stante la necessità di mantenere in buone condizioni di percorribilità un tracciato oramai effettivamente stradale, sottoposto a condizioni ambientali assai precarie. Le comunità - in occasione dei lavori - dovevano fornire giornalmente 42 uomini, suddivisi tra di esse come da antica consuetudine: . . . veni'uno da quella di Venaus, dieci otto da questa di Novalesa e tre da quella di Fe1rera provvisti ciascheduno de' necessarj utensili e coffe, o siena cesti pel trasporto delle telre . . . (51).
Nelle istruzioni dettate dai misura tori sui lavori da eseguirsi, la tipizzazione degli interventi si ripete con costanza. Particolare cura era data al fondo stradale: . . . si dovrà inghiaiare, e spianare la suddetta strada con spanzone di qual migliore e pit) adatto materia che si potrà . . . , . . . sgombrando/a però p lima delle pietre smosse e rotolatevi dalle coerenti macerie, e nel frattempo si evacueranno ed aplirmmo li fossati, acquedotti e ltmette . . . , prestando sempre particolare attenzione alle masse rocciose minaccianti rovina. Inoltre: . . . si rappezzerà il saliciato in tutti quei tratti, ne quali s'è riconosciutane la necessità impiegandosi le pietre per essi non già in piano, ma bensì di coltello e punta, e meglio come il sito pe1metterà . . . . Per salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori era inoltre ricordato di controllare: . . . li Gardefoux, o siena Bariere, e rimpiazzandasi queste ne tratti ne quali già queste esistevano, e c be ora ne sono sprovisti . . . . Inoltre onde evitare intralci al transito: . . . si taglieranno e scapperanno indistintamente e senz'alcuna riserva, e lispetto tutte le ramaglie, troncbi d'alberi d'ogni specie, e bussonate che ingombrano . . . (") .
Ma non sempre i danni da ripararsi erano determinati dall'inclemenza degli elementi. Per molti proprietari di terreni prospicenti la via di comunicazione era più comodo, per adacquare i propri appezzamenti, far scorrere direttamente l'acqua su di essa, piuttosto che utilizzare' i fossati, cagionando: . . . notabile pregiudicio alla medesima strada, ed eziando grave incomodi ai viandanti e portantini di cadreghe . . . .
A questo riguardo, ]'8luglio 1772, il podestà di Novalesa, Careno, intimava a Giambattista Chiapusso, Giorgio Vergiera, Gianni Mestralet, alla vedova di Filiberto Marchiandi, ad Oldrado Chiapusso ed a Sebbastiano Giordano, proprietari nella regione del Bacchiasso, ossia della Resiga, di riportare . . . in primitivo stato la medesima strada reale nella predetta regione con trasporto di ghiaia, e sabbia per riempimento de' fossi, e canali fomtatisi, tra gionti tre prossimi .. . ("), lavori ben inteso da eseguirsi totalmente a loro spese.
Ma nonostante il preciso invito agli amministratori di vigilare . .. acciochè vengano castigati li contravenienti . . . tale abuso da parte dei proprietari doveva essere quanto mai frequente.
Ma oltre a tali interventi specificatamente di natura ordinaria, a volte i lavori assumevano una caratteristica di straordinarietà, rimanendo pur sempre a carico delle comunità so-
(51) A.C.N., (da ordinare), Relazione sui !avori da eseguirsi in occasione della venuta del Principe e Principessa di Piemonte, in data 14 luglio 1784.
('2) A.C.N., _(da orçlinafe), Relazione sui..., op. cit. ('3) A.S.T., Sez. Riunite, Intendenza di Susa, Relazioni di visita per strade, m. 1 1 5.
105
pradette. Un notevole intervento di tale genere fu quello attuato nel 1775 nel tratto delle Volte. In tale punto, onde superare la notevole erta della montagna, mantenendo una pendenza stradale contenu.ta che ricordiamo era solo del13%, la strada aveva un andamento caratterizzato dal susseguirsi di rampe e tornanti, il-tutto con 56 volte o giri. Nell'occasione si intervenne su 53 di questi . . . gùi acculi che forma la detta strada af!i11che si possa agevolmente dar corso ai trasporti dei equipaggi con cm1·etto11i o sia11 lese ... (54) ampliando in larghezza il tornante mediante riporto di materiale e formazione di muri di sostegno.
Senza alcun dubbio i vari attraversamenti dei corsi d'acqu·a erano, come s'è visto nel corso dell'alluvione del 1751, le opere stradali più fatalmente danneggiabili dalla furia degli elementi. Perciò richiedevano, oltre alla costante opera di piccola manutenzione, interventi periodici di surrogazione delle strutture !ignee danneggiate od usurate. In alcuni casi si dovette però intervenire radicalmente ricostruendo ex nova l'opera di attraversamento danneggiata irreparabilmente da nuove piene dei corsi d'acqua. Nell'agosto del1777le sovrabbondanti pioggie cadute avevano determinato l'asportazione del ponte in legno sul Marderello e di un tratto della strada sottostante. L'opera di ricostruzione, diretta dall'architetto Agostino Marchiandi della Novalesa, venne realizzata in tempi quanto mai brevi. Tra il 2 0 ed il 21 agosto con l'intervento d i uomini delle comunità sia di Novalesa che di Venaus il ponte, lungo metri 9,2 5 e largo metri 4,6 2 , venne portato a termine con una spesa di lire
149 ("). Come si può riscontrare sia i tempi d'esecuzione, che le spese relative furòno assai conte
nute. Ma han bisogna dimenticare che la struttura di tali ponti in legno era nel loro insieme semplicissima: le spalle agli estremi in pietra a secco, sulle quali appoggiavano strettamente affiancate le travi in legno rozz�mente squadrate. ed-incavigliate agli estremi, al di sopra un'orditura trasv.ersale in travetti ed il selciiito in pietra (56).
Stante l'estrema caducità di tali strutture si riscontra, nella seconda metà del secolo, la · tendenza alla loro sostituzione con ponti in muratura; indubbiamente più costosi all'atto
della costruzione, ma nel tempo ben più duraturi (57) .
(54) A.S.T., Sez. di Corte, Materie Economiche, Strade e ponti, m. 3 Add., Relazione del Regio Aiisuratore Bai-ne dello Stato della Strada Reale . . . , in data 14 marzo 1775.
(55) A.C.N., (da ordinare), Relazione e calcolo dell'architetto Agostino Marchiandi in data 2 ottobre 1771 . (56) A questo riguardo si veda la descrizione del ponte della Brùsà alla nota 1 1 .
·(57) Percorrendo l a strada reale alla fine del XVIII secolo, risalendo verso il MonceniSio, si incontravano in progressione i seguenti ponti:
Territorio di Venaus
l) sopra la bealera dei Molini alla Corna, costruito nel 1752 con arcata in pietra e calce, lungo metri 4,60 e largo metri 3,08;
2) sopra la bealera dei Molini nella regione delle Gravere, cQstruito nel 1752 in legno; 3) sopra la bealera dei Molini dirimpetto la fucina, in lastre di pietra, costruito nel 1752; 4) dell'Esclosa nella regione omonima, costruito nel 1752 con due acate in pietra e calce, lungo metri 12,30 e
largo metri 4,62 (tuttora esistente). Terri.torio di Novalesa
5) sopra il rivo Marderelo nelia regione dei Boachiassi, costruito nel 1777 in sostituzione del già i vi esistente dal 1752, in legno, lungo metri 9,25 e largo mètri 4,62; 6) sopra il rivo Claretto all'estremo orientale dell'abitato della Novalesa, costruito nel 1775 con un'unica arca
ta in pietra e calce (tuttQra esistente), sostituiva un ponte in legno costruito nel 1752 posto più a monte; 7) sopra il rivo Gioglio nella regione dei Muneri, costruito nel 1752 in pietra e calce, lungo metri 1,54 e largo
metri 3,08;
106
39. FERRERA. Particolare dei gradoni scavati nella roccia lungo il percorso, realizzati per agevolare l'ascesa.
40. FERRERA, località Ponte Secco. Particolare della sede, scavata nella roccia, pèr il montante in legno di un parapetto (gardcfoux).
107
8. NuovE soLUZIONI PER L'INGREsso IN NovALESA .
. Sino al1775, l'attraversamento della Novalesa rimase praticamente immutato, con notevole impedimento alla circolazione dei veicoli. La Contrada Maestra -che ·attraversava l'abitato con direttrice est-ovest- si trovava infatti costretta, all'estremità orientale del borgo, a deviare dal suo asse in gran parte rettilineo su un_.percorso angusto, caratterizzato da due çurve a gomito. Lo sbocco diretto della contrada sul Claretto era infatti impedito dalla presenza di un fabbricato. Tale percorso, che obbligava le carrozze a procedere con cautela rasentando le mura delle case, corrisponde in parte all'attuale vicolo del Forno.
Il passaggio del torrènte avveniva ad una trentina di metri a monte dell'attraversamento attuale, su di un ponte in legno situato nelle vicinanze di una cappella intitolata alla S.S. Annunziata. Da qui la strada scendeva lungo la sponda sinistra, per poi collegar.si al percorso già visto in precedenza. L}esistenza di un accesso cosl angusto -in contrasto con il restante dell'asse viario � può spiegarsi ipotizzando la preesistenza di un collegamento stradale con la sottostante valle, posto in posizione più a munte rispetto a quelli presi in considerazione nèl presente studio e risalente ad epoca precedente. Di questo può forse leggersi traccia nella viabilità minore che interessa le frazioni di Sant'Anna, Vil!aretto e San Rocco. La possibilità di ampliare il percorso all'interno dell'abitato era impedita dalla presenza del forno .della comunità, tuttora presente nella sua forma esterna. Un palliativo eseguito all'epoèa per agevolare il transito delle carrozze fu il taglio degli spigoli vivi di base degli edifici, intervento ancora ben visibile.
Successivamente all'alluvione d�l1751, che determinò l'asportazione del ponte sul Claretto e di gran parte della strada sulla sponda sinistra, venne proposto dal conte Alfieri un radicale cambiamento per il percorso d'accesso al borgo. I misuratori Benedetto e Rusca, nella già citata relazione di visita del 23 ottobre 1751 (58), formarono un calcolo delle spese relative al nuovo progetto, con tipo dimostrativo che alleghiamo. La strada reale proveniente da Venaus, raggiunto il Claretto, si sarebbe portata sulla sua sponda destra con la formazione di un ponte in legno, posto all'incirca in corrispondenza di quello a struttura metallica
8) "al Pie delle Volte" sopra il Cenischia, costruito nel1771 con un'unica arcata in mattoni, sostituiva un preesistente legno costruito nel 1752;
9) sopra la'bealera di Bellagarda e Valfredda (o dei Prati) �ella regione della Pinea, costruito nell752 in legno, successivamente rifatto con arcata in pietra e calce (tuttora esistente).
Territorio di Ferrera
lO) della Volta ossia ponte Chiapusso sopra il Cenischia nell'abitato della Ferrera, costruito nel 1752 in legno, lungo metri 4,62 e largo metri 3,08; 1 1) di Perrottino sopra il Cenischia nell'abitato della Ferrera, costruito nell752 in legno, lungo metri 4,62 e largo metri 3,08; 12) di Monsieur l'Ab be Caffo sopra il Cenischia nell'abitato della Ferrera, costruito nel 1752 in legno, lungo metri 4,62 e largo metri 3,08; 13) Secco all'imboccatura della piana di San Nicolao, in legno; 14) sul ruscello del Droset nella piana di San Nicolao, costruito nel 1774 con unica arcata in pietra e calce, sostituiva un preesistente in legno; 15) di San Nicolao sul Cenischia nelle immediate vicinanze della cappella di San Nicolao, con unica arcata in pietra e calce, sostituiva un preesistente in legno costruito nel 1752; 16) delle Scale sul Cenischia, con unica arcata in pietra e calce, sostituiva un preesistente in legno costruito nel 1752.
(") Si veda p. 3 1
108
oggi ,esistente. S.ulla sponda destra si sarebbe seguito il percorso della strada antica delmo;wstero, transitando innanzi ad una cappella -segnata sul disegno -della quale si è persa ora denominazione e traccia, per immettersi poi nella Contrada Maestra.
Tale progetto non ebbe però seguito: il costo dell'opera -ascendente a lire 1.600- era infatti troppo per le esauste finanze delle comunità della Novalesa e Venaus. In specie in vista delle notevoli spese per la formazione della costruenda strada: .. . non possono da per se stesse succombere ad 1111 tanto peso, e sarebbe ad 1111 volere spopolare que' te;mzzani o ' ridur/i ad una estrema miseria ... (59). Venne perciò nel 1 752 riattato il percorso già esistente, ricostruendo il ponte in legno con suo sternito in pietra nel sito dove già preesisteva.
La definitiva sistemazione dell'accesso alla Novalesa, nella forma attuale, ebbe risoluzione solo nel 1 775. Nella relazione di visita del16 marzo di quell'anno il misuratore Boine (60) riproponeva infatti, stante la necessità di rimpiazzare urgentemente gran parte della struttura !ignea del ponte sul Claretto, il progetto dell'Alfieri. Ma già ai primi di marzo due consiglieri della Novalesa -Pietro Chiapusso e Gio Batta Vergnera- si erano interessati a rinvenire le possibilità operative per un percorso d'accesso alternativo. Tale ricerca sfocerà nel progetto, probabilmente opera dello stesso Boine, che prevedeva il prolungamento dell'asse della Contrada Maestra demolendo il fabbricato che impediva il diretto sbocco sul Claretto: su quest'ultimo si sarebbe c9struito un ponte in pietra da taglio, con unica arcata a sesto ribassato.
Tra l'aprlle ed il settembre il nuovo tracciato prese forma ad opera degli impresari Longis e Valomme, che curarono, oltre alla demolizione della casa di proprietà di Maurizio Allasia, la costruzione di una nuova sua abitazione su un terreno di proprietà di Giuseppe Allasia.
9. LA STRADA coPERTA DEL MoNCENISIO.
Tra gli interventi attuati nella seconda metà del XVIII secolo, senza alcun dubbio il più emblematico delle costanti cure date per il miglioramento della percorribilità fu la realizzazione della cosidetta "strada coperta del Moncenisio", posta all'altezza del Ponte Secco all'imboccatura della piana di San Nicolao- (61).
In precedenza a tale realizzazione, la strada in tale sito sottostava alle frequenti slavine
(59) A.S.T., Sez. di Corte, Materie Economiche, op. cit., lettera del Bongino del 28 ottobre 1751 . (60) Boine Nicolao, misuratore generale, originario di Settimo Torinese. Dal 1744 impiegato quale geometra e
misuratore presso l'Aziendà Fabbriche e Fortificazioni e del Censimento. Il l luglio 1766 per l'abilità, spelienza, attività, onorate:aa, ed altre lodevoli parti ottenne la nomina a misuratore generale del "Dipartimento delle Strade" ma sin dal 1761 si dedicava particolarmente in tale settore. Il figlio di questi, Giuseppe anch'egli misuratore, era similmente impiegato presso tale dipartimento sino dal 1774.
(61) Un'interessante descrizione della galleria la ritroviamo nel volume di F. LuiNI, Lettere Scritte da più parti d'Europa a diversi amici, e signori suoi ne/1783, Pavia 1785. Il Luini, in una lettera indirizzata a don Leone Stoppani, canonico della cattedrale di Como, in data 2.3 marzo 178.3, ci fornisce una melodrammatica descrizione della sua ascesa al !v1oncenisio. A riguardo della galleria alle pp. 10 e 1 1 cosl scriveva: . . .A due terzi circa del disastroso cammino un profondo generale silenzio par, che mi avvisi di cosa nuova. Mi scuoto, mi levo il pappa fico dal viso, apro gli occhj e vedo ... , anzi non vedo nulla, perchè mi trovo in una grotta oscura e profonda. La guida c'istruisce, che que!la è grotta artefatta a gran va/toni entro le viscere del monte; che è di· cento trabuccbi all'incirca, e che chiamasi po!1te-secco. Marciavamo però sul!a neve soHice, che una luce dubbia da piccio!e fenestrelle tramandata ci di qua11do in quando ci lasciava scorgere con evidenza. Le tomtente, che infi!mw quasi di continuo uno del/e due estreme apertwe della grotta immensa, va la ree an dentro ÙJ vmie riprese, e la dispongono a strati pirì, o meno condensati. Eccoci intanto usciti all'aperto, ed esposti piiì di prima a bmtti passi. Eccoci all'orlo di o11idi precipizi ..
41. NOVALESA. ].:imboccatura del vicolo del Forno dalla Conrra· da Maestra. Da notare lo smussa· mento dello spigolo della costruzio· ne sulla sinistra; sulla destra l'edifi. cio già del forno.
42. NOVALESA. Progetto del 1752 per un nuovo percorso d'ac· cesso all'abitato. Si osservi come la Contrada Maestra sia impedita, nel suo sbocco diretto sul .Ciaretto, dalla presenza di edifici. Figura dimostrativa per dove si è pro· gel/alo far {a strada reale pd ingresso di Novalesa col nuovo Ponte sovra il Torrente Clarello. A: La Contrada grande di Novalesa · B: Strada vec· chia, angmta e ripida · C: Ponte vec· chio stato trasporta/o· D: Strada vec· chia totalmente divaslala · F: Strad(l reale sussistente venendo da Susa· G: Nuovo ponte da constmirsi · H: Nr10va strada gi<Ì aperta dovelidosi rialzar il torrente dal dello ponte sino alla Capella. I Capella. A.C.N.
1 10
----
43. NOVA.LESA. Il ponte sul Cla· retto realizzato nel 1775.
44. FERRERA, localitìt Ponte Sec· co. La strada reale a ridosso del Ce· nischia, sovrastata sulla sinistra dalle pcndici delle Combasse.
1 11
che si staccavano nella cattiva stagione dalla sovrastante zona delle Combasse; cagionando, oltre al di per se pericolo per i viaggiatori, un notevole intralcio al transito. La situazione .era ulteriormente aggravata dalla positura stessa della strada a ridosso del Cenischia.
Già nel 1752, nel corso del tracciamento del nuovo percorso, vennero formati sulle pendici della montagna, per impedire il distacco delle masse nevose,_ due muraglioni in pietra a secco con i relativi ripiani, ma con risultati non soddisfacenti (62).
Venne perciò decisa, e portato a compimento tra il1775 ed il1779, la formazione di una galleria che garantisse la sicurezza del percorso. L'opera fu precorritrice nel suo genere: ne è prova la citazione che se ne fa nei documenti quale galleria iniziata per espel'imento, antesignava di quelle similari opere costruitesi in periodo ottocentesco sulla strada napoleonica.
Strutturalmente la galleria, che aveva una lunghezza di metri 177, venne eseguita quasi completamente in rilevato, appoggiandosi solo in alcuni punti alla roccia. La massa muraria in pietra e calce aveva uno spessore di base di metri 2,40; all'interno la galleria aveva una larghezza costante di metri 4,00, che andava però restringendosi alle imboccature ed•un'altezza in centro volta in metri 3,60. Mentre la copertura al di sopra dell'estradosso era in lose posate in calce. Per dare illuminazione alla galleria, stante la lunghezza e l'andamento in parte curvilineo, vennero realizzate tre aperture nella parte posta in curva verso il Cenischia.
Il manufatto venne realizzato dagli impresari Pozzo e Mosca, non senza vari intralci e difficoltà determinati oltre che dalle condizioni ambientali e costruttive, dalla cronica mancanza sia di lavoranti che di minatori, fatto che determinò il protrarsi dei lavori.
Le varie fasi della costruzione vennero seguite in prima persona dal misuratore Boine, e probabilmente al medesimo si deve la progettazione dell'opera; infatti l'unica rappresentazione che si conservi della galleria, un pregevole disegno che riporta minuziosamente l'evolversi della struttura, è a firma dello stesso.
·L'opera era ancora visibile nel secolo scorso, posta al di sotto della Regia Casa di Ricovero n. 5, seppure danneggiata dal materiale di risulta proveniente dal tracciamento della strada napoleonica: tale situazione è documentata dal rilievo del Catasto Rabbini del 1859. Successivamente, nel corso dei lavori di formazione della diga posta all'imboccatura della piana di San Nicolao, del manufatto scomparve traccia.
10. lL COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA STRADA REALE ED IL MONASTERO DI SAN PIETRO IN NovALESA.
Una particolare diramazione della strada reale merita, per l'importanza della struttura a cui dava accesso, un se pur breve ma doveroso approfondimento.
In occasione del pàssaggio del Moncenisio, l'unica opportunità d'alloggiare in Novalesa per gli Augusti personaggi ed in ispecie alla Reale famiglia con qualche decoro e comodità era quella di sostare al mon�stero; i problemi sorgevano tuttavia nel raggiungerlo con le carrozze.
Sino al 17 71 l'unica strada d'accesso era quella che si dipartiva direttamente dalla Contrada Maestra della Novalesa, la già citata strada antica del monastero. Attraversato il Cenischia su eli un ponte in legno ricordato come di San Pietro, posto a monte della confluenza del Claretto, la strada incontrava sulla sponda sinistra, prima di giungere al monastero,
(62) Da Stato de travagli fatti fare nell'anno 1752 delle Communità di Venaus, Novalesa e Fen·era . . , A.S.T., Sez. Riunite, Ufficio Generale delle Finanze, Prima Archiviazione, op. cit.
r u. 9
ok --1;;, ""'"'-?: e .V..'&v.-.., d-41: �d�,;, z:;.-., .-w.f.Q'/, 9,<' "': • • • ,.. ' ·
"/ ·> .• .
• '· � '0/<"' J/d '"" /Q ""'""'"""·. . .. , ' .
�' Y*-.ù ' "'� -,..,, -·.& � ' . . . • ._ . . . '
. • ' <"'"'�'""""� "' '''=. �.-- -
' •• '""- "' ·��--· - ,,.,. ""'d M '- '
� �
v .. ' ... -•. , - -·---.. .
. �
� . �----1� f .:.__ r-...J.,,_ 'l . : - )1-. --
t/ (J -""'�,� -"'!. _ .,....
,)\, .... l .. \�.r .. "
..;-,��-
' -"''"'-' -� j .r· · �v,<;'li>li7CJ:
. j
•
,.....____,_
1-.4 1-.4 l\.)
l =:::; r .. ..._rr.--.4 - - . 1:-z.c........ ..... -:
45. P;.,,' Prog,,., d,fk G•fk,;, /�" '"' Mon,_, C,.;,io �" k o· � . . .
"<lk �'<lcn�o in �<o,io._ <•lk V;;,;�, fi 14 do • d """' ""�' Ponak, � """ d,/ Gh;.,;,, ' """ ""'�'"''
Toro,,, fi 22 �•"<o lllg N;�k . @ ""'· o�''""'"'""'·
' o Bo,., . A.S. T.' So.. <Ù Con,, c�., ToPogmfi<ho S,.,,, 17 A lV.
----�-�-·�-�·-�,��� �•r,_,,,._._tN�
· · ··��c:
46. STRADA COPERTA DEL MONCENISIO. La galleria settecentesca in un particolare del disegno de\1811 già ripro· dotto alla Tav. XXIII. Si noti, nel proillo altimetrico, la perigliosa posizione della strada reale schiacciata tra il Cenischia ed il pendio sovrastante.
47. PIANA DJ SAN NICOLAO. I lavori per la costruzione della diga all'imboccatura della piana negli anni attorno all920. (Cartolina d'�poca, da negativo di C. Grosso; per gentile concessione degli eredi).
113
1 14
quattro ulteriori ponti: tre sulla bealera del Molino, il quarto, di maggior impegno, sul rio Bar. Tale tracciato non si prestava certo ad un agevole transito: era infatti ricordato come ... nstrettissima viazzo/a pericolosa, e non tragbettabile con vettura spezia/mente ne/l'invemo . .. ("). In occasione della venuta di nobili viaggiatori era a volte necessario -per accedervi comodamente con le carrozze -aprire provvisoriamente sui prati, parallelamente alla predetta strada una pista transitabile, con spese che andavano completamente a fondo perso.
La situazione parve avere risoluzione nel 1771 in occasione del pernottamento al monastero della principessa Giuseppina di Savoia, appena andata in sposa con il conte di Provenza. Venne infatti aperto un nuovo percorso d'accesso, ricalcante in parte la mulattiera del Molard, che si distaccava direttamente dalla strada reale all'altezza del ponte sul Marderello. Da qui discendeva sino al Cenischia che attraversava su un pontè con unica campata a travatura !ignea e spalle in pietra in calce. La strada risaliva poi il versante destro e si collegava all'ultima parte del tracciato preesistente. Il costo della nuova strada, che aveva un estensione di circa 600 metri ed una larghezza identica a quella della reale, ascese a lire 4. 754,2,8.
Il nuovo tracciato non ebbe però vita facile: successivamente al passaggio della principessa i terreni occupati dal sedime stradale vennero, infatti, nuovamente messi a coltivazione. Di conseguenza, nel 1773, in occasione del passaggio del corteo nuziale della principessa
--lvtaria Teresa di Savoia sposa del conte d'Artois, fu necessaria una spesa di lire 2.660 per riaprire nuovamente la strada; solo nel 1775 il percorso potè dirsi definitivo. Nel 1777 il ponte venne infine dichiarato, come da "Viglietto Regio" del 21 gennaio, pubblico e reale.
Ma da parte del monastero, nella persona dell'abate Sineo, venne portata avanti una decisa opposizione al mantenimento del nuovo tracciato. L'intendenza aveva infatti indennizzato, per le terre sottratte alla coltivazione con la formazione della strada, soia alcuni privati; mentre nei confronti del monastero, proprietario di gran parte dei terreni occupati, si riteneva, stante il beneficio acquisito del ben più c.omodo accesso, di accordarsi per una cessione gratuita. Ma il padre abate non era punto di tale opinione, e tanto fece che riuscì ad ottenere, il 12 luglio 1779, per le 180 tavole di terra occupate la somma di lire 1.200.
Ai primi dell'ottocento, negli anni dell'oècupazione francese, stante l'allontanamento dei monaci dall'abbazia, sopravvenne un abbandono del tracciato con il ripristino delle coltivazioni su di esso. Nel 1818 con il ritorno dei religiosi la strada venne nuovamente riaperta, ma da tale data prese avvio un contenzioso con l'amministrazione comunale per la manutenzione della strada e del ponte, che praticamente non ebbe mai risoluzione.
Successivamente al 185 5 , a seguito della soppressione del monastero, non si hanno più notizie certe sull'uso della strada; ma è probabile che i nuovi proprietari abbiano continuato ad usufruire del percorso. Ma alla fine del secolo scorso nuove intemperanze dei corsi d'acqua obbligarono ad intervenire nuovamente sul tracciato. Il rivo Marderello, probabilmente a seguito di un'alluvione, si aprl un nuovo letto in una posizione più a monte del precedente, asportando il ponte e parte della strada. Per usufruire ancora del tracciato fu perciò necessario intervenire realizzando, ex nova due ponti: uno sul Cenischia, a monte del nuovo sbocco, ed uno sul Marderello, con il relativo collegamento stradale.
Tale tracciato fu utilizzato sino al 1957, quando una nuova alluvione determinò la scomparsa del ponte sul Marderello e l'asportazione della travatura di quello sul Cenischia, con il conseguente abbandono del percorso.
(63) A.S. T., Sez. di Corte, Materie Economiche, Strade e Ponti, m. 3 Ad d., Rù;iOstranze dell'Uffizio della Dire:done delle Strade per esplorare le Sovrane intenzioni . . . del 12 gennaio 1777. Un ulteriore accesso, adatto solo al
48. MONASTERO DI SAN PIE· TRO DELLA NOVALESA. Resti del tracciato del 1773 di collega· mento tra la strada reale cd il ma· nastero.
49. MONASTERO DI SAN PIE. TRO DELLA NOVALESA. Resti del ponte ottocentcsco sul Ceni· schia.
1 15
116
50. MONASTERO DI SAN PIETRO DELLA NOVALESA. Vista panoramica nel periodo fra le due guerre con sullo sfondo il rovinoso corso del Mardcrcllo. . (Cartolina d'epoca, da negativo di C. Grosso; per gentile concessione degli eredi).
\ ..
.
· l<.\� :··
. .. - �
. . ' . . ·/--. �. . . .
. .
, ........ . . ......
t·:· "l
• f -�
: ,... . . . � � .. !
51. PIANA DI SAN NICOLAO. Stralcio dal Catasto Rabbini (1859) iiportante la positura degli edifici nella detta piana.
l
1 17
11. LE CAPPELLE NELLA PIANA DI SAN NICOLAO.
All'estremità occidentale della piana di San Nicolao si trovavano, a poca distanza dalla massa rocciosa delle Scale, sul percorso che venne utilizzato sino al1752, due distinte cappelle, importanti nella loro fattispecie, intitolate rispettivamente a San Maurizio ed a San Nicolao.
La prima, il più delle volte non menzionata negli studi o citata imprecisamente come di San Maurizio e Lazzaro (64), si trovava ad una cinquantina di metri dal piede delle Scale. La cappella - costruita dalla comunità di Lanslebourg in onore del patrono della Savoia- datava come costruzione al periodo medievale; posta a fianco della strada, segnava il secolare limite amministrativo tra Savoia e Piemonte. Accanto ad essa era· ricordata la presenza d'una croce sulla quale ... si publicavano ed affiggevano d'ordine del Senato di Savoia contro gl'assenti del Ducato le copie plia che fossero state publicate le Reggie constituzioni .. . ("). Inoltre in detto luogo avveniva la consegna dei prigionieri traslati tra le diverse amministrazioni .. . la famiglia di giustizia di Savoia quelli conduceva sino al detto posto, ed iv i limetteva li prigionieli alla famiglia di giustizia del Piemonte, et viceversa . .. (66). La cappella, che sussisteva ancora all'inizio del XVIII secolo, venne distrutta nel corso delle guerre di Successione di Spagna; nel 1730 se ne scorgevano solo più le fondazioni con pianta circolare.
Ma se della cappella di San Maurizio si è persa oltre che la memoria anche la traccia, quella intitolata a San Nicolao sussiste ancora, pur dimostrando il peso dei secoli e l'incuria degli uomini. .
Negli studi sinora pubblicatisi sui Moncenisio la cappella, seppure citata, non è stata riconosciuta nella struttura chiaramente cultuale ben visibile tra le costruzioni dell'Alpe di San Nicolao. L'importanza fondamentale di tale costruzione è che risulta essere l'unica testimonianza materiale, che oggi sussista nell'area del Moncenisio, di una struttura probabilmente medievale.
Sino dal1418 siamo a conoscenza dell'esistenza nella piana di San Nicolao di un piccolo ospedale, indipendente dall'Ospizio di Santa Maria posto sulla piana del Moncenisio, rifugio dei viandanti prima dell'erta delle Scale. Il19 settembre di quell'anno, in occasione del passaggio del colle da parte del papa Martino V, si trovava a rendere omaggio al pontefice l'eremita fra Giovanni Malabaila, citato in un documento del 1432 quale rectori hospitalium montis Cenisii, cioè dell'ospedale di San Nicolao (67). Tale edificio, come il similare esistente sul versante di Lanslebourg retto da frate Agostino, al momento della venuta del pontefice necessitava di varie riparazioni, dato che fa presuporre -come riporta il Vaccarone- che tali ricoveri dovessero sussistere in tale sito già da vario tempo. Inoltre, come riporta il Bel-
traffico locale, era la mulattiera che dalla regione dei Boachiassi, alla confluenza del Marderello nel Cenischia, ri-· saliva verso il monastero, e da qui alle grange del Parin, Molard e l'Adreit. È da ricordare che in alcuni documenti del1665 e 1686-oltre al ponte di San Pietro -abbiamo rinvenuto rpenzione di un Ponte della Piantata, posto sul Cenischia tra le confluenze in esso del Claretto e del Bar. Successivamente a tali date non si ha più alcuna citazione di un'opera di attraversamento in tale sito.
(64) ]. BELLET, Le co! du .Mont Cenis, Lyon 1976, p. 71. Il Lavis Trafford in La montagne dtt Cenis, op. cit., cita unicamenle la cappella di San ì\icolao, ma posizionan-
dola sul luogo di quella di San .l'viaurizio, al piede delle Scale. (65) A.S.T., Sez. di Corte, Paesi per A e B, i"\ovalesa, m. 12. (66) A.S.T., Sez. di Corte, Paesi per A e B, op. ci t. (67) L. VACCARO\'F., I Principi di Sm·oia attraverso le Alpi nel medioevo (1270-1520), Torino 1902, p. 76 e ss.
.54. CAPPELLA DI SAN NICOLAO. Planimetria di rilievo in sca· la l :200.
.55. CAPPELLA DI SAN NICOLAO. Il lato settentrionale con il vano d'accesso.
1 19
:--+ 490
120
!et (68), sempre in tale occasione i due eremiti indirizzarono al Pontefice una supplica affinchè concedesse un'indulgenza a tutti coloro che avessero offerta un'elemosina all'ospedale od alla cappella di San Nicolao.
Il piccolo ospedale e probabile che non perdurò a lungo, fatalmente fagocitato nel suo ruolo dal più munito ed organizzato Ospizio di Santa Maria, e non secondo dalla vicinanza delle case e locanda della Gran Croce. La cappella invece perdurò ancora come tale fino al settecento: la troviamo infatti menzionata in alcune càrte sia come semplice toponimo, sia raffigurata a lato della strada reale.
Attualmente tra le strutture dell'Alpe di San Nicolao - due edifici a due piani fuori terra disposti parallelamente tra di loro sulla diretrice est-ovest -si ritrova ubicata, in testa a quello meridionale dal lato verso la bassavalle, la cappella dedicata al .Santo. È da ricordare che anche uno dei due edifici sovramenzionati -quello settentrionale - compare nella cartografia settecentesca.
La struttura della cappella è semplicissima: in pianta, un unico vano rettangolare che termina in un abside semicircolare; il tutto con dimensioni ridotte all'essenziale. Esternamen· te la lunghezza, comprensiva anche dell'abside, è infatti di metri 7,90, mentre la larghezza è di metri 4,90, l'altezza in centro volta è di circa m t. 2 , 55 . In elevato la massa muraria, priva esternamente di tracce di intonaco, è alquanto rozza, con soli brevi tratti con disposizione accurata; manca invece completamente traccia di un qualsiasi elemento decorativo.
La cappella presenta l'abside con l'altare volto verso oriente, posizionamento che potrebbe collegarsi alle più radicale ed antiche tradizioni del Cristianesimo primitivo.
La copertura della struttura risulta essere ancora quella originale in mura tura, a volta a botte per l'ambiente rettangolare ed a semicatino per l'abside; al di sopra di queste vi era una copertura in lose, presentamente esistente solo più per un breve tratto. L l unico accesso dell'edificio -posto non in asse rispetto all'altare- si ritrova sul lato settentrionale; le spalle del vano di passaggio presentano alcune sottomurazioni in mattoni che presumiamo d'epoca settecentesca. Nell'interno, illuminato da una sola finestra posta sul lato meridionale a fianco dell'altare, si è conservata traccia dell'intonaco; inoltre nell'abside - incorniciato da un ristretto arco trionfale- si intravedono tracce ormai evanescenti di coloritura rossastra, forse resti di pitture preesistenti.
Dell'altare, che occupava gran parte dell'abside, si è preservata solo più la struttura muraria di base; mentre l'unico elemento, probabilmente appartenente all'edificio sacro, di un qualche interesse è un bacile in pietra presentamente a lena di fronte alla cappella, usafo dagli animali da cortile della margheria come abbeveratoio.
Senza alcun dubbio, nelle condizioni attuali la cappella di San Nicolao non perdurerà a lungo. Stante la scomparsa della copertura in lose, l'inclemenza degli elementi ha già provocato un degrado della volta, con formazione di fessurazioni nella stessa. Inoltre sul lato meridionale, in specie in corrispondenza del vano finestra, si è in presenza di un rilassamento della struttura con distacco di pietre nella parte superiore del muro, e messa a nudo dell'imposta della volta.
In tale situazione siamo certi che il carico sulla volta delle copiose nevicate e l'azione devastante del geJo porteranno sicuramente -sempre che ciò non sia già avvenuto mentre scriviamo- al crollo della struttura. Sarebbe perciò quanto mai auspicabile un intervento anche solo conservativo, se non già di restauro.
(68) J. BELLET, Le col du .Mani Cenis, op. ci t. p. 72.
121
56. CAPPELLA DI SAN NICOLAO. L'abside.
57. CAPPELLA D l SAN NICOLAO. Bacile in pietra, probabilmente appartenente alla cappella.
122
12. L'ANTICA STRADA DEL MONCENISIO, OGGI: VINCOLI AlviBIENTALI E PROPOSTE DI SALVAGUARDIA,
Ormai stabilmente inserita nel paesaggio e nel modo di vivere di tutti noi, la strada napoleonica del Moncenisio ha perso quel carattere di trauma che -pure- la caratterizzò nel periodo di costruzione e nei primi decenni di utilizzo. La montagna ha riassorbito le ferite dovute alle grandi opere d'arte, mentre la Valle Cenischia- una volta secolare crocevia di traffici- dopo un periodo iniziale di decadenza economica, si è affiancata -già nel corso dell'ottocento- al destino economico della conca di Susa.
A distanza di circa 170 anni dall'apertura della strada napoleonica, sono pertanto pochi coloro che sanno ancora distinguere nel terreno le tracce dell'antico percorso settecentesco. Già nelle note iniziali a questo volume, si ricordava come è ambizione degli autori che esso possa servire anche come stimolo e come "guida" per ripercorrere, in piacevoli passeggiate, gli ampi tratti ancora agibili di quella che fu, per secoli, una delle più battute strade d'Europa.
La scomparsa del traffico ha indubbiamente consentito che molti tratti dell'antica strada si conservassero intatti, o almeno in condizioni di percorribilità; in molti punti, tuttavia, gli elementi naturali e l'intervento dell'uomo hanno danneggiato non poco sia la strada, sia quegli scorci paesistici che sono il necessario complemento per chi -ripercorrendo il tracciato -voglia rivivere, a due secoli di distanza, le impressioni del viaggiatore settecentesco. È pertanto necessario un preciso intervento di tutela a salvaguardia della strada, alla preservazione del paesaggio e dei monumenti ivi esistenti.
Il discorso della tutela paesistica della Valle Cenischia assume, peraltro, una particolare attualità nel momento in cui vengono scritte queste note, in concomitanza con l'imposizione sui territori comunali di Novalesa e Moncenisio del cosidetto "vincolo assoluto", ai sensi della legge statale n. 431 dell'8 agosto 1985, meglio conosciuta come "legge Gallasso". Si tratta di un vincolo particolarmente severo, in quanto (art. l quinquies) comporta, fino all'adozione da parte della Regione Piemonte di un apposito "Piano paesistico", il divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Non è questa la sede per discutere della correttezza del vincolo, o della sua utilità in un contesto territoriale- come quello della Valle Cenischia- che non pare di certo interessato da pressioni speculative per quanto attiene alla residenza ed al turismo. È tuttavia chiaro che l'imposizione del "vincolo assoluto" su gran parte della valle postula la necessità di definire rapidamente un "Piano paesistico" che, tenendo conto del ruolo degli Enti Locali e della Comunità Montana, possa essere assunto dalla Regione Piemonte come provvedimento definitivo per la valorizzazione e la tutela ambientale della Val Cenischia.
Le motivazioni in base alle quali è stato imposto il "vinc�lo assolut.o" sulla Val Cenischia fanno essenzialmente riferimento (69), con considerazioni forse opinabili, ad una aggressione urbanistica che, pur se parziale, ha stravolto in alcune zone il primitivo assetto del villaggio l'imettendo tipologie e materiali costruttivi in contrasto con quelli esistenti. Pare pertanto che le motivazioni del Ministero per i Beni Cultm'ali ed Ambientali si basino più su una concezione
(69) Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1985. Ministero per i Beni Culturali - Decreto Ministeriale l agosto 1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territ01i comunali di Novalesa e Moncenisio (p. 99).
123
del paesaggio come valore estetico, piutt0sto che su una presa d'atto di quanto strettamente - nella Val Cenischia- paesaggio e storia siano fusi.
È ambizione di questo studio proporre, invece, la vecchia strada settecentesca del Moncenisio come elemento unificante nella tutela ambientale di tutta la valle. Per ammissione dello stesso proponente della legge n. 431, il vincolo posto sul territorio deve essere solo un momento temporaneo per avviare stabili forme di tutela dei beni artistici e paesistici, in modo tale, anche, da favorire le economie locali.
Ebbene, gli autori di queste pagine sono convinti che la valorizzazione ed il recupero del percorso settecentesco del Moncenisio possa aggiungere un interessante attrattiva turistica alla Valle Cenischia g'ià nota per la rinata Abbazia di Novalesa. Occorre, a nostro avviso, lavorare in due direzioni: il restauro dei numerosi tratti di strada ancora percorribili e la loro segnalazione, affinchè sia nuovamente ricordata la "strada reale per il Moncenisio", quale originale ed interessante occasione di turismo. Nella carta che si è allegata al volume sono stati evidenziati i tratti di strada tuttora conservati; sono stati altresì indicati i punti dai quali- intersecandosi l'antica con la nuova strada- è possibile intraprendere questo interessante "viaggio nel passato".
Gli interventi di manutenzione necessari, dopo secoli di abbandono, sono numerosi, ma si riconducono essenzialmente a quel]a semplice manutenzione che - come abbiamo vistd nel testo- veniva effettuata nei secoli passati: sistemazione di muretti in pietra e del selciato, rimozione dei massi cadutivi, allontanamento delle acque dal percorso, taglio di arbusti. Anche il ponte di Venaus, edificato nel1752, ha retto brillantemente ad oltre due secoli di traffico; pochi interventi di manutenzione ed un'idonea segnalazione possono mettere nella giusta luce un interessante monumento, oggi misconosciuto. A riguardo del monastero della Novalesa è utile ricordare che riattando il pofi te ottocentesco sul Cenischia, ed il relativo tracciato stradale, si verrebbe a formare- accentrato sul monastero- un interessante anello pedonale. E non ultimi da rimarcare gli interventi, quanto mai urgenti, per la salvaguardia della cappella di San Nicolao.
Saremmo tuttavia miopi, se proponessimo una semplice conservazione della strada reale, in quanto tale: la funzione e l'apprezzamento di questo antico modo di viaggiare sono infatti fruibili- ad oggi- solo se la strada è inserita in un paesaggio ed in un contesto architettonico correttamente vissuto e conservato. Sono compiti che spetteranno alla pianificazione paesistica della Val Cenischia. In questa sede vogliamo inoltre ricordare - oltre alla ovvia attenzione per l'Abbazia della Novalesa - la ne�essità di provvedere al recupero della piccole cappelle e delle testimoniànze sparse lungo il percorso della strada reale, nonchè l'opportunità di dedicare rinnovata attenzione al restauro delle case e dei monumenti di Venaus, di Nov�lesa, di Ferrera e della Gran Croce. Centri storici di cui deve essere coglibile l'antica importanza.
Siamo convinti che un simile passato ricco di memorie debba non solo rivivere sulle pagine scritte, ma che possa essere occasione per meglio organizzare ed apprezzare il territorio· nel quale oggi viviamo e che - in quant<> bene improducibile- abbiamo l'interesse ed il dovere di trasmettere alle nuove generazioni.
124
58. PIANA DI SAN NICOLAO. In primo piano il Re/uge 11° XXI sul tracciato che venne abbandonato nell811.
59. PIANA DI SAN NICOLAO. Ponte in pietra, d'epoca napoleonìca, sul rio Giasct.
INSERTI
Cartografia di sintesi
III
LA VIABILITÀ SusA- VENAus- NovALESA- FERRERA, TRA XVII E XX SECOLO (TAVOLA N° l IN ALLEGATO)
IV
LA VIABILITÀ NELLA ZONA DELLE SCALE, TRA XVII .E xx SECOLO (TAVOLA N° 2 )
125
Le informazioni dedotte dai documenti costituenti i primi due inserti e, più in generale, dall'insieme dei documenti analizzati nel testo, sono state raccolte nella cartografia di sintesi, dedicata ai tratti più salienti del percorso viario del Moncenisio. Stante le scale di riproduzione, le carte sono in allegato, inserite in una tasca nella copertina del volume.
Tale cartografia- a differenza di quella riportata nei precedenti inserti- fa riferimento e descrive l'evolversi della viabilità tra il XVII e il XX secolo, in quanto la base cartografica può ritehersi aggiornata a circa l'ahno 1 960.
III - La viabilità Susa -Venaus - Novalesa -Ferrera, tra XVII e XX secolo.
Tavola n° l in allegato. La carta è stata realizzata utilizzando la composizione catastale in scala 1: 5.000 della Pro
vincia di Torino: tale base è stata scelta poichè la cartografia di origine catastale tende a conservare -nella forma e posizione dei lotti- tracce a volte molto durature di opere o situazioni territoriali appartenenti al passato. Tale tavola copre tutto il territorio della Valle Cenischia, dai confini comunali con Susa all'attuale Confine di Stato, conseguente all'ultimo conflitto mondiale.
Considerata l'estensione delle tavole, si ritiene opportuno fornire, di seguito, un'illustrazione articolata per tratti funzionali: ciò anche allo scopo, come ricordato nel capitolo 12, di poter meglio utilizzare tale tavola per ripercorrere, oggi, gli ampi tratti ancora conservati della strada settecentesca.
l 0 tratto: dal confine con Susa al ponte dell'Esclosa (tenitorio comunale di Venaus).
La strada conseguente ai lavori del 1752 (in colore rosso) corrisponde ad un percorso ancor oggi in uso, anche se in più tratti allargato e rettificato all'epoca del potenziamento della centrale E.N.E.L. di Venaus. Da segnalare lungo il percorso settecentesco il ponte della Bmsà (individuato con il n° l) sulla bealera dei Molini e gli altri due successivi, sempre sulla stessa bealera: all'ingresso di Venaus (n° 2) ed all'uscita (n° 3); per l'individuazione dei ponti lungo la strada reale alla fine del XVIII secolo si rimanda alla nota n° 57.
126
Con il n° 4 è quindi individuato il ponte dei!'Esclosa, principale opera" d'arte realizzata nel corso dei lavori del 1752.
Immediatamente a monte del ponte della Comà si diparte il percorso più antico, utilizzato fino al1752. ·Tale percorso (in colore giallo) risulta oggi solo parzialmente leggibile, sia sui terreno, sia sulla nostra carta di origine catastale: esso puntava risolutamente verso il Cenischia, che attraversava con il ponte della Bmsà, da noi individuato con il n° 5 e di cui oggi non esiste più traccia.
Tale percorso più antico costeggiava poi il corso del Cenischia, per raggiungere la regione dell'Esclosa: prima del1752, il ponte dell'Esclosa era una semplice passerella, come da noi ricordato nel capitolo 4.
2 ° tratto: dal ponte dell'Esclosa all'ingresso in Novalesa (tm·itorio Comunale di Novalesa).
Il percorso realizzato nel1 752 (in colore rosso), risulta interamente percorribile, anche se in molti punti ad esso si sovrappongono i recenti lavori di miglioramento della viabilità per Novalesa (non riportati dalla base cartografica).
Venendo a parlare di questo tratto di strada, occorre accennare ai profondi rivolgimenti verificatisi, nell'ultimo secolo, relativamente alla rete idrica che interessa il territorio di Novalesa.
Il rio Crosiglione ha infatti abbandonato il suo percorso più antico, documentato dalle cartografie del XVIII secolo ed anche dal Catasto Rabbini (1860) quando sfociava nel Cenischia all'altezza della Brusà. Attualmente, con un corso molto più breve, confluisce nel Cenischia a monte - e n�n a valle- del ponte dell'Esclosa.
Con un fenomeno analogo, anche il rio Marderello ha drasticamente accorciato il suo corso, spostando a monte la confluenza con il Cenischia:La nostra cartografia, con opportune diversificazioni di Jratto, dà atto degli antichi ed attuali corsi dei torrenti.
Il percorso viario piu antico, antecendente ai lavori del 1 752, (in color giallo) risulta in buona parte ancora intellegibile nel terreno è nelle cartografie: la sua principale caratteristica era una maggiore e pericolosa vicinanza al corso del Cenischia.
Facilmente leggibile, nella nostra carta, è anche l'ingresso della strada reale in Novalesa, che ancor oggi avviene attraverso il ponte in pietra ad un'unica arcata, realizzato .nel 1775.
Un accenno a parte merita la viabilità d'accesso al monastero di San Pietro, oggetto del capitolo 10.
In color giallo è indicato il percorso realizzato nel1771 ed ancora riportato - con il relativo ponte sul Cenischia - dal Catasto Rabbini (1 860).
Risulta evidente come tale ponte (individuato con il n° 6) si sia trovato proprio al punto della nuova confluenza tra Marderello e Cenischia: è così spiegata la sua inevitabile scomparsa.
Conseguentemente alla scomparsa di tale ponte, fu realizzata la variaÌ1te, riportata dalla nostra base cartografica (ma non dal Catasto Rabbini), con un ponte sul Cenischia posto più a monte (individuato con il n° 7): anch'esso ebbe tuttavia vita breve, tant'è che tale collegamento risulta, ad oggi, interrotto.
La cartografia consente anche di cogliere due altri interessanti collegamenti di Novalesa con le pendici del sistèma montuoso del Rocciamelone.
Si tratta, in ·primo luogo, del percorso che -all'estremità nord di Novalesa - sale verso il Passo della Novalesa (3222 metri s.l.m.) e, di qui, scende fino a Bessans nella francese valle dell'Are.
127
Il secondo percorso nasce, invece, dall'ingresso sud di Novalesa e- con un altro accesso anchè da San Rocco- inizia una lunga salita sulle pendici del massiccio del Rocciamelone: lo sbocco finale è il Colle Croce di Ferro (2 5 5 8 metri s.l.m.), dal quale il percorso - definito strada di Lanzo in una cartografia del 1708- raggiunge il Lago di Malciaussia e la valle della Stura di Viù. Come si può comprendere, si tratta di collegamenti certamente minori rispetto alla via del Moncenisio, ma molto interessanti per cogliere lo stretto legame che intercorreva- nell'assetto tradizionale del territorio- tra lo sfruttamento di pascoli e boschi ed i percorsi intervallivi di più lunga gittata.
3 ° tratto: da Novalesa all'attuale confine di stato (tenitori comunali di Novalesa e Moncenisio).
Anche all'uscita di Novalesa verso il valico, il paesaggio attuale si differenzia da quello settecentesco per il diverso percorso dei corsi d'acqua.
L'imponente opera di arginatura realizzata sul Rio Giolio, nell'assicurare la protezione dell'abitato di Novalesa, ha infatti accorciato notevolmente il corso del torrente, portandone a monte la confluenza con il Cenischia. Anche quest'ultimo torrente ha modificato e rettificato il suo corsò (la nostra base cartografica riporta il tractiato precedente) rendendo più difficile il riconoscimento sul terreno del percorso settecentesco. Con i numeri 8 e 9 tuttavia viene indicata la presumibile posizione dei ponti settecenteschi sul Rio Giolio e sul Cenischia, oggi non più riscontrabili sul terreno.
Superato il Cenischia, la strada del1 752, dopo un tratto quasi rettilineo, iniziava la lunga salita delle Volte: superato il confine con Ferrera in località Pera Becua, raggiungeva quindi Ferrera, entrandovi in sponda destra del Cenischia.
Il capitolo 5 illustra come, precedentemente al 1749, l'ingresso in Novalesa avvenisse in sponda sinistra. La nostra carta illustra (in colore giallo) il percorso viario in sponda sinistra del Cenischia che - toccando l'antica località di Santa Maria sopra Novalesa - può ritenersi, nel suo complesso, più antico - o, perlomeno, utilizzato intensamente in epoca più antica - del percorso sulla sponda destra del Cenischia.
A monte di Ferrera, il percorso della strada reale (sempre in colore rosso) risulta ancora oggi facilmente intellegibile e percorribile, fino all'altezza dell'attuale Confine di Stato.
128
(lJ, !l
" "\,
LEGENDA Percorso viario più antico, in sponda destra del torrente Cenischla (antecedente àl 1 7 1 1) . Antico confine t r a Piemonte e Savoia.
Sito della Cappella di S. Maurizio, punto di confine tra Piemonte e Savoia. Ruderi della Cappella di S. Nicolao. Percorso realizzalo nel 1 7 1 1 circa, in sponda destra del torrente Cenischia.
l •
l ! l . 1/. i.
,··
· • '
-- Percorso realizzato nel 1752. nel corso dei lavori oggetto di questo libro; i l percorso affronta le "Scale" sulla sponda sinistra del Cenischia. per attraversarlo con un ponte quasi alla sommità della salita e per ricongiungersi. quindi, al vecchio percorso che porta alla Gran Croce.
) Ponte sul Cenischia, lungo i l percorso di cui al punto precedente . . . Abitato della Gran Croce .
..-...... 'Corso del Cenischia e di altri torrenti della zona, quali sono rilevabili dalle cartogralie del XVIII secolo. - - - Deviazione artificiale del Cenischia, per allontanarlo dalle zone delle "Scale" (lavoro di epoca napoleoni
ca). CD lndividuazione sul territo rio dei toponimi, elencati all 'Appendice 3 . .(J) Toponim i ricadenti fuori dal campo della tavola.
129
IV - La viabilità nella zona delle Scale, tra XVII e XX secolo cartografia di sintesi.
Tavola n° 2.
La carta a lato è stata redatta a partire da un opportuno ingrandimento del foglio I.G.M. in scala 1:2 5 .000 "Novalesa 55 IV 50" (approvamento 1966).
Come si può cogliere, la base cartografica non riporta le opere conseguenti alla realizzazione della grande diga del Moncenisio (ultimata nel 19 70): essa può essere pertanto ritenuta specchio sufficientemente fedele della situazione esistente dopo i lavori per la strada napoleonica, nonostante la realizzazione - ad inizio '900- degli impianti idroelettrici nella piana di San Nicolao.
La base cartografica è stata inoltre preferita in quanto consente la lettura della situazione altimetrica ed orografica.
Si ricorda che esigenze di rappresentazione grafica e difficoltà ad interpretare le antiche cartografie portano ad un'evitabile tolleranza nel posizionamento dei segni riportati sulla carta; inoltre, per esigenze grafiche, alcuni toponimi vengono a cadere fuori dal campo della tavola essi sono individuati, in legenda, con un apposito simbolo.
130
Appendice I
I LAVORI DELLA STRADA NAPOLEONICA IN RAPPORTO AL PERCORSO SETTECENTESCO
Anche se lo scopo di !'JUesto studio consiste nel descrivere il percorso e le opere eseguitesi sulla strada del Moncenisio nel XVIII secolo, nondimeno pare opportuno riportare, in appendice, alcune note riferite al percorso voluto da Napoleone e tutt'ora utilizzato. In tal modo, si potranno illustrare alcune peculiarità del percorso settecentesco, mentre ci sarà data l'occasione di meglio puntualizzare alcuni passi di uno studio dedicato alla viabilità transalpina, testo tanto importante e ricco di notizie quanto ora poco conosciuto: si tratta del già citato volume del Blanchard Les routes des Alpes Occidentales à l'epoque napoléonienne (70).
La condanna detvecchio percorso venne decretata da Napoleone nei primissimi anni del XIX secolo: in data 21 termidoro anno X (8 agosto 1802) il Crétét - Consigliere di Stato e direttore del Pont e Chausses (7!) - ordinava infatti all'ingegnere Dausse, ingegnere capo del dipartimento dell'Isère (72), di recarsi al Cenisio . . . pour y /evel' /es tracés d'une route praticab/e pom· toutes espèces de voitures et comportant une largeur convenable ainsi que des pentes modérés . . . (73).
Il libro del Blanchard mette in luce, quindi la novità del percorso ideato dal Dausse; esso viene infatti cosl descritto: . . . le tracé, abandonnant ensuite résolument la Fe1riére et la Nova/aise pour continuer à soutenir aux flancs des masses montagneuses qui dominent la Cenise à droite (venendo dalla Francia, n.d.r.), épousait !es colitours de ces montagnes, s'y plaquant par de grands murs de soutènement . . . (74). Lo stesso Blanchard mette in luce le critiche che vengono mosse a questo tracciato: in primo luogo l'abbandbno di Ferrera e Novalesa, località da sempre legate al traffico, quindi la cattiva esposizione al sole e l'elevato costo del nuovo tracciato, per altro ammirevole per la sua originalità. Il Blanchard lascia tuttavia intendere che il Daussse abbia sposato senza riserve tale sua idea, difendendola contro ogni critica.
Un documento del più grande interesse, conservato a Torino, consente invece di gettare una diversa luce sulla genesi progettuale della strada per il Moncenisio, fornendoci, nel con-
(7°) Il libro del Blanchard contiene, a pag. 247, anche una rapida e riduttiva descrizione delle opere stradali che sono" oggetto del presente studio: . . . L 'effort le plus accentué effectué en 1 752 et !es atmeés suivantes, au moment art Bangi no était intendant à Suse, n'avait abouti qu'a ménager, à certaim retorm d es rampes, de petits espaces en palier permetta n t aux bétes de chmge de souffler qualque peu, et, dam un but de sécmité, à multiplier au long d es zigzags d es garde-fous de bois et des barricades sommaires ..
(71) Come ricorda Bruno Fortier nell'articolo La nascita dell'Beole d es Ponts et Chaussés, op. cit., . . . Fondata nel 1747 come "Bureau de dessinateurs-geographes" per la raccolta e la messa in bell<l copia delle mappe delle strade di Franàa, l'Eco/e d es Ponts et Chaussées di Parigi costituisce il pn'mo ce litro intemazionale per l'insegnamento dell'ingegneda civile . . . .
(72) Joseph Henry Dausse (1745-1816). Una sua biografia s i trova a p . 242 della citata opera del Blanchard, nonché nel similmente citato studio del Re alla nota 23.
(73) M. BLANCHARD, Les routes . . . , op. cit., p. 242
1 3 1
tempo, una chiara visione del percorso settecentesco. Si tratta di una r_appresentazione cartografica del valico del Moncenisio, da Susa a Lanslebourg, eseguita nel 1802 e riportante sia il percorso settecentesco allora in uso (definito Cbemin Actue[), sia il progetto eseguito dal Dausse (75). Proprio per questa sua doppia car.atteristica esso è stato largamente utilizzato nell'illustrare il presente lavoro (tav. VII-VIII-IX-X-XXII), La carta, a firma dell'ingegner Dausse, è datata Grenoble il 1 Nevoso anno XI (22 dicembre 1802): venne quindi rea· lizzata al termine del primo periodo di lavoro del Dausse, iniziato, come si è visto, nel corso dell'estate.
La carta, oltre per la sua bellezza iconografica e per le interessanti informazioni che ci da sul percorso settecentesco, ha un'altra originale caratteristica. A partire circa dal Molaret· to, sono infatti previsti due percorsi alternativi: uno (quello realizzato) che tende diretta· mente a Susa; i' altro che, invece, si ricollega alla vecchia strada settecentesca, all'ingresso sud di Novalesa. Per qualche periodo di tempo fu pertanto coltivata l'idea di non ab bando· nare il tratto di strada lungo la Va!'Cenischia, utilizzando cosl il ponte di pietra di Venaus, e non deprimendo il ruolo commerciale di Novalesa.
Il decreto riportato sulla stessa carta (76), infatti, approva il percorso proprio fino al pun· to in cui si presenta la succitata alternativa: il decreto stesso rimanda la scelta definitiva ai
(74) M. BLA�CHARD, Les routes . . . , op. cit., p. 249. (n) La carta, lunga circa cinque metri, è attualmente conservata presso la sede torinese dell'A.N.A.S., cui è
probabilmente giunta attraverso il Genio Civile; essa non è accompagnata da altra .documentazione scritta. Per
la sua consultazione e riproduzione va ringraziata la cortesia dell'ingegnere Ferrazzin, capo compartimento della viabilità per il Piemonte. Per interessamento degli autori, fotografie di tale carta sono apparsé nella mostra Viaggi e viaggiatori nell'antica strada di Francia 1750-1850, organizzata da Les amis du Mont Cenis nel .1985-86.
(76) Si dà di seguito la trascrizione integrale delle legende riportate sulla carta in questione: (al centro in nero).
PLAN DU MONT-CENIS DEPUIS LANSLEBOURG ]USQU'A SUSE AVEC LE PROJET DE ROUTE DANS LA TRA VERSE DE CETIE MONTAGNEIFAISANTPARTIE DE LA COMMUNICA110N DE FRANCE EN ITALIE.
LA POSITION GEOGRAPHIQUE DE L'HOSPICE NATIONAL DU MONT CENIS EST A 43 DRGRÉS 14'18" DE LATÉTUDE BOREALE, l E T A 4 DÉGRÉS 35'30" DE LONGITUDE ORIENTALE DU MÉRIDIEN DE PARIS.
ECHELLE DE 1 .000 MEIRES I ECHELLES DE 500 TOISES ('). (a sinistra, in rosso)
N.A LES CHIFFRES EN ROUGE INDIQUENT LES FEUILLES DU NIVELLEMENT l ET LES LETIRES LES ENTROITS OU SE TROUVENT LES OUVRAGES D'ART. (a sinistra, in nero)
À GRENOBLE, LE lER NIVOSE AN 1 1 DE LA REPUllLIQUE FRANCA/SE ('"') l DAUSSE ING, EN CHEF (*"). (a destra, in nero)
APPROUVÉ LA P ART/E COMMUNE AUX DEUX DIRECTION ( ' DEPUIS LANS LE BOURG JUSQU'AU POINT F SUR LE PLATEAU DU l MOLARET; A]OURNÉ LA P ART/E DEPUIS CE POINT JUSQU'À SUZE; / LES GENERAUX MENOU ET CHASSELOUT ÉTANS INVITÉS lÌ l SE RE UNIR AVEC L'/NGÉNIEUR EN CHEF POUR PRONONCER I SUR L'UNE DES DEUX D/RECIIONS, LA !RE PASSANT PAR l LA NO V ALA/SE, L'AUTRE LAISSANT CE BOURG SUR l LA GAUC/JE.
LE CONSEILLER D'ETAT CRETET ('"'*). (*) Con rappresentazione grafica delle due scale. (**) 22 dicembre 1801 . (***) Firma autografa.
132
generali Menou (77) e Chasseloup-Laubat (78), insieme all'ingegnere Dausse. Sull'esito di ta: le scelta torna illuminarCI il Blanchard, il quale (79) ci parla di una visita compiuta al Moncenisio dai generali Menou e Chasseloup nella primavera del 1803, effettuata con l'evidente intenzione di risolvere il dilemma rimasto aperto. Pare che a condizionare la decisione sia stato il generale Chasseloup che, nell'ambito del suo incarico di curare la difesa strategica del Nord Italia, voleva che le strade per il Moncenisio e per il Monginevro - uscendo da Susa-· avessero un'uscita comune, più facilmente controllabile e difendibile. Questa esigenza militare obbligò ad abbandonare l'idea del percorso alternativo passante ancora per Novalesa. In tale direzione venne infatti il Decreto Consolare del 23 floreale anno XI (13 maggio 1803) che decise definitivamente il percorso.
Sempre dal testo del Blanchard1 apprendiamo come, tre anni dopo, la questione del percorso in discesa dal Cenisio a Susa venne riproposta, in un clima di tensione tra l'ingegnere Dausse, che dirigeva i lavori, ed un gruppo di giovani ingegneri, suoi aiutanti. Questi ultimi, insofferenti di dipendere da un capo più anziano di loro, si fecero' fautori di un progetto "più grandioso", alternativo a quello scelto dal Dausse. Il percorso proposto si basava nuovamente sulla discesa dalla Ferrera e Novalesa, con grandiose opere murarie per reggere un tracciato a maestosi zig-zag. Era inoltre previsto un ingresso trionfale in Susa, ed attorno alla strada pourrait s'ordonner une citè neuve et plus régulière (80). Tale idea venne più tardi ripresa dall'ingegnere Derrien - che diresse la fase finale dei lavori stradali (81) - nel suo progetto della "nouvelle ville", di cui venne solo realizzata la "Piazza del Principe Camillo" e la ora demolita Caserma ·(glà Casa Rosazza). La proposta dei giovani ingegneri fu presentata al Crétet nella primavera del 1806, tramite un'apposita memoria, ma fu respinta.
I lavori proseguirono pertanto secondo l'originario progetto del Dausse; per Ferrera e Novalesa, il silenzio della tranquilla vita contadina venne a sostituire secoli di animata funzione commerciale e di transito.
(77) Jacques Francois Menou, barone di, (1750-1810). (78) Il generale del genio Chasseloup-Laubat aveva ricevuto da Napoleone l' incarico di studiare la difesa st.-·te-
gica dell'Italia del nord. (79) M. BLANCHARD, Les rou(es . . . op. cit. p. 252. (80) M. Ì3LANCHARD; Les rouies-.. . , op.• cit., p. 297. (81) Derrien Romain-Marie (1780-1844). Ecole polytecnique nel l796, successivamente nel 1800 all'Ecole cles
Ponts. Ingegnere-allievo a Boulogne (1800-1801); ai lavori sulla strada da Saint Claud 3. La Malmaison (1802); al :-.luncenisio ( 180.3); ingegnere ordinaires per i lavori al Moncenisio; successivamente promosso di 2 a e poi di l a classe. Ingegnere in capo incaricato dei lavori sui colli del Moncenisio e del Monginevro nella primavera 1812. Al suo ritorno in Francia, estate 1814, ingegnere in capo della Maine-et-Loire. Finisce la sua carriera come inspecteur divisionnaire. Bibliografia sintetica tratta dal Blanchard, op. ci t., p. 302; lo stesso testo riporta a p. 241 le posizioni archivistiche dei dossiers personali relativi alla carriera del Derrien e di altri tecnici interessati alla costruzione della strada napoleonica del Moncenisio.
Appendice II
GLI INTERVENTI DEL 1752 NEL RENDICONTO FINANZIARIO DEL MISURATORE BENEDETTO
133
Il documento che segue venne presentato come allegato di una supplica redatta nel 1753 dal procuratore Pastoris - rappresentante delle comunità di Venaus, Novalesa e Ferrera a riguardo del rimborso delle spese da loro affrontatesi per il tracciamento della nuova strada. Nel rendiconto vengono evidenziate dal misuratore Benedetto le spese relative ai lavori eseguitisi sul tracciato da Susa sino al piano di San Nicolao. Purtroppo il tratto delle Scale non è conteggiato giacchè - come già rimarcato - cadeva sotto la giurisdizione dell'intendenza di Saint Jean de Maurienne: perciò le competenze erano del comune di Lanslebourg.
Stato delli travagli fati fare nell 'anno scorso 1 7 52 dalle Communita di Venaus, Novalesa, et Ferrera per il racomodo, et cambiamellto della Strada Reale che tende dalle fine di Susa sino al Montecenisio in seguito alli ordini dell'Intendenza.di Susa.
Monte Cenisio.fine della Ferriera.
Primo formazione d'un ponte di legno con sue spale di muraglia sovra la Sinischia nella piana di San Nicolao, formazione della rampa ad esso, taglio, e scarpamento di rocca fatto al Ponte Secco per riempire la gorgia della Sinischia affine di formare la nuova strada iv i per evitare il precipizzio nel pasar per la strada vecchia sovra essa rocca, formazione del stemito fatto in detta nuova strada doppo riempito la su detta gaia, formazione di due muraglioni di pietra a secco al traveno della montagna detta la Combassa affine di formare due ripiani per ritegno delle va/anche di neve ivi in tempo d'inverno si lasciavano cadere sovra la strada vecchia reale il tutto ascende come dalla misura spedita dal misura/ore per Sua Maestà Pietro Antonio Benedetto calcolato essi travagli alli prezzi portati da Contratto passato dal impresaro Batta Rossazza col ufficio del Intendenza di Sma sotto li 26 luglio 1 752: L. 1423:9.
Al sovrastante Giovanni Maffiotto per assistenza ai detti lavori come da mandato del/i 25 novembre: L. 87.
Al misuratore Benedetto per assistenza come sovra: L. 55. Al sovrastante Bertolomeo Martinotto per assistenza in far riparare la vecchia strada sul lenito
rio di Ferrera cioè dalle fini di Novalesa sino a ponte secco, et alla Piana di San Nicolao come da mandato 24 novembre: L. 182:10.
Per polvere da moschetto consonta in far saltar grosse molle di pietra di luongo in luongo di detta strada L. 2 per mbbi 16: L. 32.
- Segue su le fini di N ovale sa -
Al misura/ore Benedetto et IÌ'abucante per prendere le memorie del devasto fatto dal inondazione nella vecchia strada, e fame la relazione all'ufficio: L. 9: 10.
Per il ponte a volta in calcina con sue muraglie !alterale et stemito fatto al rivo Rugiolo come da mandato apmvato dal ufficio a favore del mastm Gianazza: L. 229:2:4.
134
Al signor assistente Federico Lupis per assistenza prestata a fare la nuova strada a l di sotto del luogo di Novalesa come da mandato: L. 60.
Al medesimo mastro Gianazza per le muraglie di pietra a secco fatte !attera/mente al rivo C!aretto per sostegno della strada reale, et per le spale lattera!e del ponte di legno fatto sovradetto livo come dalla misura del mimratore Benedetto: L. 207: 18: 7.
Al mastro Bernardo Fen·aria per la fattura del sternito come da misura del detto misuratore: L. 46:13.
A Marco Vergnera per assistenza prestata alla sudetta strada: L. 51:5. A lli minatori per far mine nelle grosse molle di pietra: L. 40. Al fabbro ferraro per racomodo alla ferramenta: L. 30:7:2. Per acompra segla per il pane soministrato alli lavoranti dalla Communita di consemo dell'uf
ficio del Intendenza: L. 52. Al Sindaco, e Comiglieri per le tuoro assistenze per detti travagli: L. 60. A l signor Notaio Nemo per far comendare li lavoranti in seguito ad ordine dell'ufficio del In
tendenza, e per le reviste di questo non si è ancor spedito mandato a calcolo: L. 30. Al misuratore Benedetto per sue assistenze, e diriggere li sudetti travagli: L. 64.
- Fini di Venaus -
Formazione del ponte a due archatte in calcina, mandola. di pietre di taglio, et spa!e con sue rampe deliberato al impresario Rossazza a tutta robba e fattura come da suo contratto passato all'ufficio dell'Intendenza: L. 3668.
Più per altri !àvoli fatti di più del postulo dal sudetto contratto: L. 90. Per n. 4 chiave di ferro con suoi bolzoni mese ne !li su detti archi come da mandato: L. 75:13:8. Al signor Maffè per sua assistenza prestata al sudetto ponte come da mandato: L. 190. Al Martinotto assistenza come sovra: L. 10. Al misuratore Benedetto per li disegni, calcolo, instmziani, assistenza; et direzione del sudetto
ponte, et nuova strada sovra il tetrit01io di Venaus: L. 1 07. Al signor Pollone per sue assistenze alla sudetta nuova strada come da mandato: L. 100. Per il disfacimento, e rifacimento delle muraglie !attera/e della casa di Gioseppe C!apero, et
Lorenzo Rol come da mandato: L. 74. Per la fattura d'un ponte a volta, et muraglia in calcina sovra la gt·ande Bea/era alla Comà per
mandato: L. 47:18:8. Per il murag/ione superiormente al ponte della Sin ischia come sovra: L. 14. Per la provisione calce impiegata pel rifacimento delle sudette case, et fonnazione de/ nuovo
ponte e murag/ione della Sinischia, come da mandato: L. 138. Per la fonnazione altro ponte di legno sovra la sudetta Bea/era per estimo: L. 30. Altro ponte come sovra fatto con losoni adelimpetto della fiucina per estimo: L 20. Per li minatori inviati dalla sudetta commtmita in aiuto delle altre communita al racomodo
della vechie strada della Feniera, et fetramenta provvisto per il sol conmmo, e racomodo del!a medema come da due mandati: L. 68:4:6.
Per il disfacimento, e tifacimento della muraglie di cinta del cortile della casa propria del/i nostli R.R.P.P. di San Bemardo di Novalesa: L. 20.
Pe/ il fama del Comune stato demolito per far luogo alla sudetta strada, e pel lifacimento d'altro nuovo fama per la semplice fattura si calcola col trasporto dei matteriali: L. 50.
L. 7363:12:3
che in tutto asiende alla somma di lim·e sette mi/la tre cento sessanta tre soldi dodici denari tre.
135
Oltre alle su dette L. 7 363:12:3 dalle sudette Communità pagate per l i travagli sovra scritti hanno pur le medeme Communità provisto li lavoranti giornalmente a misura degli ordini avuti dall 'ufficio dell'Intendenza di Susa, li quali hanno impiegate le infrascritte giomate per la f01mazione della nuova Strada Reale secondo li trazzamenti stati fatti sovra li tuoro respettivi territori come consta dalle note giornaliere: Venaus lavoranti giomate - n. 3809; bestie a basto giomate - 11. 296. Novalesa lavoranti giornate - n. 71 78; minatori giomaie - n. 181; bestie a basto giornate - n. 315.
Ferrera ha pur provisto li lavoranti portati da/li sudetti ordini per il racomodo della strada del Montecenisio in proporzione delle altre Communità, ma da questa Communità non si è potuto avere le note giornaliere come dalle altre due.
Segue la mistira, et estimo del/i beni de particolari de/li infrascritte Communità staiti occupati dalla formazione della nuova strada.
Mompantero Tavole n. 45: 1 1:7 L. 6 275:15 :10
275 : 15:10
Venaus
tavole n. 173: 9 L. 6 1042:10
tavole n. 102 : 1 1 :5 L. 5 5 1 4 : 15
tavole n. IO: 0:9 L. 9 90:5
tavole n. 59:10:3 L. 3 179: IO
1827 1827
Novalesa
tavole n. 35:8:9 L. 3 107: 3:9
tavole n. 101 :2 L. 3 : 1 0 354: 1 1 :8
tavole n. 22:7:9 L. 4 90: 1 1:8
tavole n. 52:0:2 L. 2 104
tavole n. 16:1 :6 L. 1 :10 24: 3:9 . tavole n. 6:9:8 L. IO 8: 1: l
688: 1 : 1 1
688: l: I l
10154:10:0
Ferrera Per l 'indetmisazione de !li prati su/a piana di San Nicolao, e muraglùl di pietre a secco da farsi per chiudere li mede mi
stato convenuto col proprietario di consenso dell 'ufiicio dell 'Intendenza in L. 120
totale L. 10274:10
Il presente stato, e conto, dimostrativo l'io sottoscritto ricavato dalle misure, et estimo da me spediti in seguito alli contratti pasati per detti /av01i, et dal/i mandati delle respetive somme stati spediti per il pagamento d 'esse che in tutto rileva la somma di liure dieci mi/la duecwto cinquanta quatro soldi dieci.
Susa li 1 1 settembre 1 753.
Pietro Anta Benedetto
In A. S. T., Sez. di Corte, Materie Economiche, Strade e Ponti, m. 3 Add.
136
Appendice III
TOPONOMASTICA TRA '600 E '700 LUNGO LA STRADA REALE IN VAL CENISCHIA
I toponimi di ogni singota località sono stati ordinati riportando per primo - di norma quello citato in testo, ,ed in ordine cronologico gli altri; a fianco di ognuno compare la relativa datazione del documento da cui è stato estratto. La citazione di I .G.M. contraddistingue il toponimo - se esistente - dato dalle tavolette al 1 :25.000 dell'Istituto Geografico Militare, rispettivamente di "Susa", "Novalesa" e "Colle Piccolo Moncenisio " . Il numero progressivo si riferisce alla localizzazione del toponimo sulle tavole in allegato; i numeri sono stati posti in progressione con andamento da destra verso sinistra, e dal basso verso l'alto. Per agevolare la ricerca delle varie denominazioni dei si ti, i toponimi sono stati anche ordinati, in una tabella a se stante, secondo la progressione numerale delle rispettive cifre di posizionamento sulle carte in allegato.
ALEMENT 1760/70 (50) CAMPI DELLil CHIESA l l94 (16) ALLEMAND 1794 CAMPI DI COÙ 1760/70 (l)
ARPONE (bgo/gr.nge d'l 1749 - 1760/70 - 1765 (126) CAMPO LONGO {regione di) 1766 (2) ARPON (grange d') I.G.1.f.
ARSI (eomb, d') 1760/70 (96) CAPITE (V/E/LLE) 1749 (151)
CAPITE (h) 1765 BACH/ASSO (regione del) 1665 (65) CHIARETTO (regione di) 1685 (78) BACCIASS/ 1686
BOACH/ASS/ 1777 CIARMENA (lago) 1743 (127)
BAR (do di) 1686 - 1752 (64) NEGRO 1749
BARDO 1760/70 C/ARMENA 1760/70 - 1765
BAR /.G.M. CLARETI'O (torrente) 1622 - 1665 (81)
BARRIERA 1760/70 (58) CHIARETTO 1686 CLARETTO 1752
SAN ROCCO l.G.M. R/CLARET 1760/70
BEALERA DI BAR 1728 (67) CLARETTO I.G.M. BEALERA DEL MOLINO 1771 CLAUSE11 (regione de) 1665 (66)
BEALERA DI BELLA GARDA COAfBASSE (regione/trinceramenti delle) 1743 - 1766 (!JO) E VALFREDDA 1766 (94) DEI PRAT/ 1766
COMBASSA 1749
BEALERA DEI MOLINI 1752 - 1766 (46) COMBA MULINERA (do di) 1760/70 (104)
BEALERA DI VENAUS 1753 COMBA l.fOLINERA 1765
BERGER/E DE CAFFO 1765 (140) COMBE ilei 1760/70 (74)
SANT'ANNA I.G.M. BORGIÀ DEL MOLINO 1760/70 (40) CORNÀ lhl 1752 (3) MOLLINO 1794 ALBRE DELLA CORNALE 1621 - 1622 BOTTIGLIERA 1760/70 - 1765 - I.G.M. (1)2) CORNALE (ponte della) 1728 - 1752
BRA]DA (regione della) 1665 (61) CORNÀ 11•1 1760/70 REGIONE DETTA DELLE GRAVERE OSSIA
BRA]DA (h) 1752 - 1760/70 · I.G.M. (12) CORNÀ 1766
BR USA (ponte/montagna della) 1752 (15) P/ANCA O DETTA CORNALE 1794
BRUG/ADA 1621 CORNA (case la) I.G.M.
BRUCIATA 1722 COSJI! (b) 1760 - 1794 - I.G.M. (31) BRUSATA 1728
CROCE (rivo della) 1794 BRUSÀ O SIA GRANGE 1794 137)
1 3 7
CROSIGLIONE (torrente} 1752 (55) MARGHERIA {montagna de!\a) 1752 (137) CRUSIGLIONE 1622 - 1623 MARGERIE (1760/70) CROSIGLIONE 1665 - 1686 PARADISO (il) LG.M. GROISIGLIONE 1760/70 MERDARELLO (torrente) 1752 (72) CROSIGL/ONE LG.M.
MERDARELLO 1623 CROSIGLIONE (regione di) 1665 (54) MARDARELLO 1665 - 1686
CURTE 1794 (28) MERDARELLO 1760/70 MARDERELLO 1777 - l.G.M.
DOITOLI 1794 (18) MESTRAL SUPERIORE 1794 (25)
DROSET (ruisseau du) 1760/70 - 1765 (143) PLAN DE SAINT ]EAN (ruisseau du) 1765 MESTRAL VECCHIO INFERIORE 1794 (39)
DUITOLI (regione dei) 1766 (63) M ESTRALE E TRA VERSA 1794 (26)
ESAFFES (h) 1760/70 (150) MOLINO (villaggio dd) 1760/70 (42)
ECAFFES (l") 1765 PARRORE 1794 PARORE LG.M.
ELDRADO (rio) LG.M. (56) MOLLAR DELLA TORRE 1794 (45)
ESCLOSA (ponte/regione dell') 1722 (47) MUNERI (regione de) 1686 - 1752 (88) SCLOSA 1728 - 1752
CLOSÉ 1752 NONA (rocca di) 1760/70 (95) CIAUSÉ 1752 TUPE !.G.M. VENAUS (pont< di) 1752 OLTRE CLARETTO (Via Vicinale detta) 1665 1771 ESCLOSA 1794
FENESTRA (la) 1760/70 (116) ORA (cassina dell') 1760/70 (53)
FENESTRE (b) 1765 LA CASCINA LG.M.
FINESTRE (passo delle) I.G .M. ORATORIO 1760/70 (71)
FERRERA VECCHIA 1622 - 1749 - 1752 PILONE 1175
-1760/70 - 1765 - 1777 - LG.M. (106) ORATORIO DELLA CASSINA 1760/70 (52)
FONDER (ruisseau du) 1760/70 (147) ORATORIO DELLA MADONNA 1760/70 (1 10) VARISELLA {ruisseau du) 1765 OSTO (l') 1760/70 (73) GIASET (rio dd) LG.M.
FONTAGNON (il) 1760/70 (138) PECCAREL 1743 (131)
PECARELLO 1749 FORCA INFERIORE (via) 1794 (13) PETIT CLAU 1794 (22) FORCA SUPERIORE (vb) 1794 (21) PERA BECUA 1752 - 1760/70 (103) FORNI INFERIORI (regione de') 1760/70 (112) PIETRA BECUA 1622
GJRAUDE (regione della) 1760/70 (117) PIETRA BECCUA 1766
GIRODE Oal 1765 PEROUSE {croce della) 1760/70 (20)
CONTE 1760/70 (57) PERNICE (fontaria della) 1760/70 (128) SAN ROCCO I.G.M. PERDRIS (fontaine de la) 1765
GORGIE (l<) 1760/70 (101) PIAN DI GIORS (hgo) 1760/70 (129) GORGIE (grangia le) I.G.M. NEGRO 1749
GRAND CLA UD 1794 (24) PIQUERET ET DE SAINT ]EAN lhc dei 1765 MARDARELLO 1665 - 1686
GRAND PRA (il 1760/70 ( 1 1) MERDARELLO 1760/70
GRAND CROIX ilac de la) 1760/70-1765 (154) MARDERELLO 1777 - l.G.M.
GRANGIA BIANCA 1749-1777 ( 118) MESTRAL SUPERIORE 1794 (25)
GRANGE BLANCHE 1743 MESTRAL VECCHIO INFERIORE 1794 (39)
GRANGIA DETTA DELLA PINEA 1665 (89) M ESTRALE E TRAVERSA 1794 (26) GRANGIA DI BONGIOVAN/
MOLINO (villaggio del) 1760/70 142) (regione detta la) 1686 PARRORE 1794
GRANG/E (le) 1760/70 (14) PARORE l.G.M. GRANGE O SIA PRATO DURANDO 1794 MOLLAR DELLA TORRE 1794 (45)
MADDALENA (h) 1760/70 (82) MUNHRI (regione de) 1686 - 1752 (88)
MAFREDA 1760/70 (91) NONA (rocca di) 1760/70 (95)
MARGHERIA (colle della) 1752 (146) TUPE l.G.M.
1 3 8
OLTRE CLARE1TO (Via Vidnalc detta) 1665 (77) RIGIOLLO 1775
ORA (cassina dell') 1760/70 (53) G/OGL/0 l.G.M.
LA CASCINA l.G.M. RIMA (ruisseau de) 1765 (102)
ORA TORIO 1760/70 (71) RIONDO l.G.M.
PILONE 1775 RIVO (i]) 1760/70 - 1794-l.G .M. (36)
ORA TORIO DELLA CASSINA 1 760/70 (52) ROCCA 1760/70 (59)
ORA TORIO DELLA MADONNA 1760/70 (1 10) VILLAREITO l.G.M.
OSTO (l') 1760/70 (73) ROMANA 1794 (19)
PECCAREL 1743 (131) RONELLE (regione de campi delle) 1665·1686 (62)
PECARELLO 1749 ROSSA {montagna della} 1752 (152)
PETIT CLAU 1794 (22) CORNA ROSSA 1760/70-1 765-l.G.M.
PERA BECUA 1752 - 1760/70 (103) RUÀ DI VAJR 1760/70 (34)
PIETRA BECUA 1622 VAJR l.G.M.
PIETRA BECCUA 1766 RU/NA (lo) 1760/70 (99)
PEROUSE (noce dello) 1760/70 (20) SAN LORENZO (pilone) 1760/70 - 1765 (107)
PERNICE (fontana della) 1760/70 (128) SAN MAURIZIO (cappella di) 1730 (148)
PERDRIS (fontaine de la) 1765 MASURE DE LA CHAPELLE DE
PIAN DI GIORS (bgo) 1760/70 (129) SAINT MAURICE 1760/70 - 1765
NEGRO 1749 SAN NICOLAO (piano di) PIQUERET ET DE SAINT JEAN (lac de) 1765 1))0 - 1749 - 1752 - l.G.M. (141)
PONTE T {ruisseau du) 1760/70 - 1765 (135) SAN NICOLA 1760/70 SAINT NICOLAS 1 765
PRA MULEJTO 1794 (4) SAN NICOLAO (cappelb/alpe di) PRATI D'AGNIZIONE 1794 (49) 1730 - 1749 - 1752 (144).
PRATI DELLA ROCCA 1794 (10) SAN NICOLA 1760/70 SAINT NICOLAS 1765
PRATO 1794 (32) SAN PANCRAZIO (cappella di) 1760/70 (105) PRATO BER TINO 1794 (30) SAN PANCRAZIO (grangia di) I.G.M.
PRATO BONEITO 1794 (43) SAN SEBASTIANO (cappella di) 1665 - 1686 -
PRATO DEL PRASCO 1760/70 (108) 1752 - 1 760/70 (84)
PRE DU FRASCE 1765 SANT'ANNA 1760/70 - l.G.M. (75)
PRATO DURANDO O SIA GRAVERE 1794 (7) SANT'ANTONIO (cappella di) 1760/70 (85)
P�A TO DEL PONTE (regione del) 1665 - 1686 (83) SANTA BARBARA (cappella di) 1624 - 1752 (113)
PRATO DELLA STRADA 1760/70 (114) SANTA BARBARA (regione di) 1766
PRATO PERERO 1794 (8) SANTi! MARIA 1665 - 1686 - I.G.M. (93)
PRATO PIANO 1760/70 (79) SCALA (montagna della) 1752 (153)
BELLA VERDE I.G.lvl. BEilÉ (cime de la) 1760/70 - 1765
PRATO SIGNORE 1760/70 (6) SCALE ile) 1752 - I.G.M. (149)
BERNI 1794 SCOMBE (regione delle) 1686 (76) BERNO I.G.M. SINISCHIA (torrente) 1621 - 1665 - 1686
PRATO 1i!RINO 1794 (29) 1728 - 1752 (5)
PRARLUÉ 1794 (33) SENISCHIA 1752 CINISCHIA 1752
PRE DE LA FENETRE 1765 (115) SINISCHIA 1760/70
QUATRINI 1794 (44) CENISCHIA I.G.M. SIRENI 1794 (38)
RAMPA DELLA FONTANA 1754 (145)
RESIGA (regione della) 1772 (70) SOVRA GRANGIA BIANCA (regione) 1777 (120)
STAGNO (il) 1760/70 (9) RIGOGLIO (torrente) 1752 (90) S1i!DIO 1794
RIGIOLO 1623 RIG/OL/0 1665-1686 STRADA NUOVA (regione della)
R UGIOLO 1753 1752 - 1765 - 1777 (121)
R UGELLO 1760/70 SUPITA (rivo) 1794 (23)
TIGLTEREI (rivo/comba di) 1760/70 (48) VERNETTI (regione dc) 1665 - 1686 TIGLIARETO 1665 VERNETTI (regione de) 1721 11GLIARE 1686 VERNET (il) 1760/70 TIGLIERETTO I.G.M. VERNETI 1794
TORRE (regione della) 1665-1686 (86) VOLTE (le) 1622 . . . 1785
TOVO BIANCO (comba dd) 1760/70 (111) VOJJl LONGA 1760/70 TUF BLANC (ruisseau'de la combe de) 1765
GRANDE VOUTE (la) 1765 TRAVERSA 1760/70 . I.G.M.
VENGER DELLA BORGAlil O SIA REANO 1794
l - Campi di Col1 2 - Ca.mpo Longa 3 - Cornà 4 - Pra Muletto 5 - Sinischia 6 - Prato Signore 7 - Prato Durando 8 - Prato Perero 9 - St?gno
lO - Prati della Rocca 1 1 - Grand Pra 12 . Brajda 13 - Forca Inferiore 14 - Grangie 15 - Brusà 16 - Campi della Chiesa 17 - Venger della Borgata 18 - Doitoli 19 - Romana
(27) TORNA LONGA 1766
VOUTE PLANE 1765 (17) ROCCA PIANA 1766
ELENCO TOPONIMI ORDINATI·
SECONDO LORO
PROGRESSIONE NUMERICA
20 - Perouse 2 1 - Forca Superiore 22 - Petit Chu 23 · Supita 24 .· Grand Claud 25 - Mestral Superiore 26 - Mestrale e Traversa 27 - Traversa 28 - Curte 29 - Prato T arino 30 - Prato Bertino 3 1 - Costa 32 - Prato 33 - Prarlué 34 · Ruà di Vajr 35 - Pittanza 36 - Rivo 37 - Croce 38 - Sireni
139
(69)
(41)
(97)
(100)
(98)
140
39 - Mestral Vecchio Inferiore 40 - Boigià del Molino 41 - Vernetti 42 - Molino 43 - Prato Bonetto 44 - Quatrini 45 · Mollar della Torre 46 - Bealera dei Molini 47 - Esdosa 48 - Tiglierei 49 - Prati d'Agnizione 50 - Alement 5 1 - Plantette 52 - Oratorio della Cassina 53 · Ora 54 - Crosiglione 55 - Crosiglione 56 · Efdrado 57 - Gonte 58 - Barriera 59 - Rocca 60 · Ponte di Tilla 61 · Brajda 62 · Ronelle 63 - Duitoli 64 · Bar 65 - Bachiasso 66 - Clauseti 6 7 - Bealera di Bar 68 - Ponte della Piantata 69 - V emetti 70 - Resiga 7 1 - Oratorio 72 · Merdarello 73 · Osto 74 · Combe 75 - Sant'Anna 76 · Scombe 77 - Oltre Claretto 78 - Chiaretto 79 - Prato Piano 80 - Ponte di San Pietro 81 - Claretto 82 · Maddalena 83 - Prato del Ponte 84 - San Sebastiano 85 - Sant'Antonio 86 - Torre 87 - Ponte al Piè delle Volte 88 - Muneri 89 - Grangia detta della Pinea 90 - Rigoglio 91 · Mafreda 92 - Pinea 9 3 - Santa Maria 94 - Bealera di Bellagarda e Valfredda 95 - Nona 96 · Arsi
97 · Volte 98 - Voùtc Piane 99 - Ruina
J 00 - Vota Longa 101 " Gorgie 102 - Rima l O 3 - Pera Becua 104 - Comba Mulinera 105 - San Pancrazio 106 - F�rrera Vecchia 107 - San Lorenzo 108 - Prato del Prasco 109 - Ponte Milanese I l O - Oratorio della Madonna 1 1 1 - Tovo Bianco 1 12 - Forni Inferiori l 13 - Santa Barbara ! 14 . Prato della Strada 1 1 5 - Pre de la Fenetrc 1 16 - Fenestra 1 17 - GiraucJe 1 1 8 - Grangia Bianca 1 1 9 - Ponte de Bottigliera 120 . Sovra Grangia Bianca 121 · Strada Nuova 122 - Ponte Nuovo 123 - Pian Soliera 124 - Pian Paradiso 125 - Pian Savojardo 126 · Arpone 127 - Ciarmena 128 - Pernice 129 - Pian di Giors 130 . Combasse 1 3 1 - Peccare! 132 - Bottigliera 13.3 - Ponte Secco 134 . Pian Sado 1.35 - Pontet 136 - Pietra Stretta 13 7 - ìvlargheria 1.38 - Fontagnon 139 - Plaine de Jean George 140 - Bergerie de Caffo 141 - San Nicolao 142 - Pian Droset 143 - Droset 144 - Pian Nicolao 145 - Rampa della Fontana 146 . Marghieria 147 . Fonder 148 - San lvlaurizio 149 . Scale !50 · Esaffes 1 5 1 . Capite 152 · Rossa !53 · Scala 154 - Grande Croix
141
APPENDICE IV
GLI INTENDENTI DELLA PROVINCIA DI SUSA NEL XVIII SECOLO, POSTI IN RELAZIONE
CON I TECNICI IMPRENDITORI EDILI E SOVRASTANTI CITATI NEL TESTO
d ata nomina nome intendente tecnici coinvolti in !oca imprenditori sovrastanti
2 5 .5 .1717 e Guilliers Pietro, conte • Bertela Giuseppe Ignazio, ingegnere (14)
3 .6.1724 • !vlonet Francesco, • Amprimo Gabriel, misuratore (13) avvocato • Belle t Philippo (13)
17.2.1733 • Butticaris Gioannf, avvocato
16.3. 1742 • Favier Lorenzo, avvocato
8 .5 . 1743 e Faraglio Francesco, avvocato
4 .5 . 1746 o Nicolis di Brandizzo • Benedetto Pietro Antonio, Ignazio, misuratore (p. l O) conte di (22)
2 8 . 1 . 1750 • Bongino Antonio, avvocato (5) • Balegno Carlo Felice, • Rosazza • Lupis Federico
vice intendente (27) Giovanni (3 7) • Maffei (p. 12) • Alfieri di Cortemilia • Maffiotto Benedetto, conte di, architetto (31) Giovanni (44) o Benedetto Petro Antonio, • Martinetto misuratore (24) Bartolomeo (44) • don Grassis, rettore dell'Ospizio • Pollone (44)
. del Moncenisio (43) • Vergnera Marco (44)
7 .5 . 1755 • Bertola Giuseppe, avvocato
2 8.9.1773 • Rubatti Pietro, avvocato e Boine Nicolao, misuratore (60) • Longis (p. 17) 8 Valomme (p. 17)
2 7.2.1776 • Rossi Alessandro, avvoca-t o e Marchiancli Agostino, 0 Pozzo (p. 18)
architetto (p. 16) " Mosca (p. 18)
.2 .1780 e.· Mouthon Francesco, avvocato -·--------
2 5 . 1 . 1 782 u Galcani Napionc di Cocconato Gioanni, conte eli -
6. 12. 1785 e Bcrtoglio Ignazio, avvocato
9 . 1 . 1791 Q Gros Renato, avvocato
Nota
Le cifre tra parentesi, a fianco dei nomi, fanno li/erimento a!lt' "note" o alle pagine di questo volume dove vengono citati i sopmelencati personaggi.
1 4 2
BIBLIOGRAFIA
ARNAUD E., Le Mont Cenis sot/S le Comulat et l'Empire, in Travaux de la Société d'Histoire de Mamienne, St. Jean 1940.
BARTOLOMASI N., Va!sma Amica, vol. II, Pinerolo 1985.
BELLET J., Le Col du Mont Cenis, Saint Jean de Maurienne 1976.
BLANCHARD M., Bibliographie crìtique de l'bistoire des routes des A/pes Occidentales sous l'État de Piémont Savoie, Grenoble 1920.
BLANCHARD M . , Les routes des Alpes Occidenta!es à l'epoque napo!éonienne, Grenoble 1920.
BoGGE A., L 'alluvione de/ 1 728 in Val Susa, Studi Piemontesi, IV, fase. 2 (1975).
BRAUDEL F., Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), Torino 1982.
CARANDINI L, Il grande valico, Novara 1960.
CAvALLARI�MURAT A., Come carena viva, Torino 1981-1982.
CAVALLARI-MURAT A., Ponna urbana ed architettonica nella Torino barocca; Torino 1968.
CAVALLARI·MURAT A., Lungo la Stura di Lanzo, Torino 1973.
CHIAUDANO M., La strada romana delle Gal!ie, Torino 1939.
CaRINO P.G., L 'attacco spagnolo de!l'Atpone e i fl'ince_rqmenti settecenteschi del Moncenisio, La Va/susa n. 37, Susa 1985.
C ORINO P.G., Le settecentesche suppellettili delle cappelle castrensi di Exilles e della Brunetta, La Va/susa, n. 6, Susa 1983.
CosTAlviAGNA H. Une bistoire de 'l'Intendenza' dans !es Etats de terre-ferme de la Maiso11 de Savoié ci l'époque mode me, B.S.B.S., LXXXII! (1985).
CROSETTO A, . DONZELLI C. - WATAGHIN CANTINO G. Per una carta archeologica della Valle di Susa, B.S.B.S., LXXI (1981).
DERRIEN J. , Notice bistorique et désctiptive sur la route du Mont Cenis, Anger 1816.
FoRTIER B. , La nascita dell'Eco/e des Ponts et Cbussées, Casabella, ottobre-novembre 1983.
GILIHERT A. - MrcHELOZZI L., Va/susa com'era. Si'n poughessan mèisse . . . , Susa 1976.
GII.IBERT A. - GILIEERT Vor.TERRANI A., Va/susa com'era. Tèra 'd nòstd vej, Susa 1977.
JoBÉ-]., Au �<-;mps d es cochers. 1-Iistoire illmtrée du voyage en voiture attelée du X Ve au XXe siècle, Gene ve 1976.
LAVIS-TRAFFORD (de) M.A., L 'évolution de la cartographie de la région du M t. Cenis et de ses abOJds au x ve et XVIe siècle, Chambéry 1949. _LAVIS-TRAFFORD (de) M.A., La Montagne du Cenis - Pro/il de l'ancien chemit1 muletier par le col du Grand Mt. Cenis, Saint Jean de Maurienne 1956.
LAVIS-TRAFFORD (de) M.A., Les confins de l'Italie du còté d es Alpes Cottiennes depuis !es origines jusqu' à 1713, in Bulletin de la Société d'Histoire, Saint Jean de Mauricnne 1954.
LAvrs-TRAFFORD (de) M.A., Le pal de Bo11izo11e, B.S.B.S., LVII (1959).
LUINI F., Lettere scritte da pùì parti d'Europa a diversi amici e signod suoi nel 1 783, Pavia 1785.
MARTELLI A. E., - VACCARONE L., Guida alle Alpi Occidenftdi, Torino 1889.
PATRIA E., Le alluvioni in Va/sma, La Valmsa n. 13, Susa 1984. PEYROT A., Le Valli di Susa e del Sangone, Torino 1986.
PONSERO G . , Guide du Voyagettr à Suse et au passage du Grand Mont Cenis, Susa 1830.
PRATO G., La vita ec01tomica in Piemonte a mezzo del secolo XVIII, Torino 1908. PRIEURJ., La province romaine des A!pes cottiennes, Villeurbanne 1968.
143
RE L., L 'opera degli ingegneri del Cotps des Ponts et Cbamsées a T mino e i progetti peri! ponte sulla Dora e la sistemazione degli accessi del ponte sul Po (1813), in Ponti di Torino su Atti e Rassegna Tecnica n. 9 e 10, Torino 198 1 .
RENOUARD Y., Les voies de cotm!umication entre la France et le Pièmom art moyen dge, B.S.B.S., LXI (1963).
Ronm G., L'inondazione in Va/susa e la Prevostura d'Oulx, Segusium n. 18 (1982). SANooz M., Essai sur le paysage de montagne: le chemin du Mont-Cenis à travers !es sièc!es, in Revue Savoisienne, Annecy 1982.
SERGI G., Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambe1y a Torino fra X e XIII secolo, Napoli 198 1 .
SERGt' G., Domus Montis Cenisii. Lo sviluppo di tm ente ospeda!iero in una competizione di poteri, B.S.B.S., LXX (1972).
SrGNORELLI B. Acque, strade e ponti in Sabaudia da!!'Ancien Régime ali'Unità. Schede per una storia da fare, Studi Piemontesi, XIII, fase. l (1984).
VACCARONE L., I PJincipi di Savoia attraverso le Alpi del Medioevo (1270-1520), Torino 1902.
VAcCARONE L., Le vie delle Alpi occidentali negli antichi tempi, Torino 1884.
VENTURI F., Settecento ti/armatore, Torino i969-1984.
VATAGHrN-CANTINO G., Il valico del Moncenisio in età romana: dati ar�heo!ogici ed ipotesi di lavoro, in Le reseau rotllier en Savoie et en Piémont-Aspects histodque et contemporain, Chambery 198 1 .
FONTI DOCUMENTARIE
A.N.A.S. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte - Torino. Archives departementales de Savoie - Chambery (A.S.C.). Archivio Comunale - Novalesa (A.C .N.) Archivio Comunale - Venaus (A.C. V.) Archivio di Stato - Torino {A.S.T.) Sezione di Corte, Sezioni Riunite, Sezione Camerale. Biblioteca Reale - Torino (B.R.T.) Collezione Gilibert - Torino.
Le illustrazioni presenti nel volume sono dovute:
CHOMON PERINOo n" 45 - tavole V-XV-XIX-XXIV. CORINO - DEZZANL copertina - n' 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 -32-33-34-35-36-3 7-38-39-40-41-42-4 3-44-46-48-49-52-5 3-54-55-56-57-58-59, e le tavole I-Il -III-IV-VI-XI-XIV -XVI-XVII-XVIII-XX-XXIII. COTTA RAMUSINOo n° 5 1 - tavole VII-VIII-IX-X-XII-XIII-XXI-XXII-XXV. GROSSO, n' 47-50.
La strada voluta da Napoleone sul colle del Moncenisio è un'opera d ' ingegneria universalmente nota, anche perchè - ad oltre 1 70 anni dalla sua apertura i l traffico oggi percorre ancora esattamente il tracciato della " route imperiale".
Ma prima di Napoleone, com'era la strada per i l Moncenisio? Qual'era i l suo percorso sul versante ora italiano, quali. le sue.condizioni di percorribil ità lungo le stagioni del l 'anno? Gl i autori tentano di dàre.una risposta a queste ed altre domande, descrivendo i l percorso della strada ed i lavori che ad essa furono dedicati tra il XVI I ed i l XIX secolo.
Ne esce i l quadro completo di una strada di grande importanza internazionale ma che, a differenza del percorso napoleonico, correva nel fondovalle della Valle Cenischia, toccando Venaus e Novalesa per sali re , con una serie ripidissima di "Volte" , a Ferrera e poi s ino al colle.
Percorribi le con le ·carrozze solo fino a Novalesa, la strada era tuttavia una componente fondamentale nel sistema dei traffici europei e nel l ' economia dello Stato Sabaudo.
Gli autori si augurano pertanto di aver tratto dall 'oblio questo antico ed importante percorso, anche per un doveroso impegno di salvaguardia di queste antiche testimonianze.
I l presente volume è i l primo ad apparire di una serie intitolata A tlante Storico della Provincia di Susa.
Scopo dei volumi che si susseguiranno nel tempo è ricostruire materialmente l 'ambiente nel quale ebbero luogo g l i innumerevoli eventi della storia valsusina, ambiente che, ricordiamo, è ancora quanto mai indefinito.
l volumi riguarderanno - oltre al completamento del tema viabilistico - i corsi d'acqua, gli insediamenti civi l i e mi l itari , la vita economica e sociale: il tutto nel corso degli u lt imi tre secol i .
G l i Autori
PIER GiORGIO CORI NO, nato nel 1 954, ha dedicato la sua attenzione essenzialmente ai temi della storia mi l itare e del le fortificazioni valsusine.
LIVIO DEZZANI , nato nel 1 949, è particolarmente inte ressato alla storia del territorio della Bassa ed Alta Valle di Susa.
La prefazione è stata redatta da AUGUSTO CAVA LLARI-MURAT.