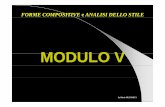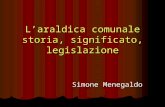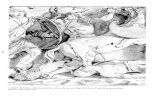I caratteri dello stile e lo stile dei caratteri: cenni sull’opera di Grigorij Vinokur
Transcript of I caratteri dello stile e lo stile dei caratteri: cenni sull’opera di Grigorij Vinokur
Direzione
Dante Della Terza, Edoardo Esposito
Comitato scientifico
J. B. Bullen, Jonathan Culler, Anne-Rachel Hermetet,William Mills Todd III, Jürgen Wertheimer
Responsabili di settore
Giovanna Benvenuti, Anna Maria Carpi, Carlo Di Alesio, Maria Giulia Longhi, Paola Loreto, Antonio Melis, Caroline Patey, Damiano Rebecchini
Redazione
Francesca Cuojati, Tiziano Moresi, Laura Neri, Stefania Sini
*
Segreteria di redazione
Stefano Ballerio([email protected])
Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Milano,via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
*
«Letteratura e letterature» is an International Peer Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
AbbonamentiI prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 24 del 14 giugno 2007Direttore responsabile : Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2011 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma
*
www.libraweb.net
*i s sn 197 1 -906x
SOMMARIO
Editoriale 9
saggi
Carlo Di Alesio, Poesia neodialettale e autotraduzione : il caso Pasolini 13Marco Gaetani, Regressione (critica) e riscatto (mediato) : la letteratura secon- do Julio Cortázar 33Edoardo Esposito, Montale traduttore di Yeats 45Marcello Villa, Manganelli verso Bisanzio 57
attualità della stilistica
Luigi Blasucci, All’insegna dell’anafora : lettura di un testo montaliano (Divi- nità in incognito) 63Stefania Sini, I caratteri dello stile e lo stile dei caratteri : cenni sull’opera di Grigorij Vinokur 75Stefano Ballerio, Ripercorrere Leo Spitzer : il metodo e l’identità 99Laura Neri, Sistemi simbolici e riferimento. Lo stile nella teoria letteraria di Franco Brioschi 125Sara Sullam, « It is all in oratio obliqua » : appunti sulla ricezione inglese dello style indirect libre 135Massimiliano Pecora, L’e[kfrasi~ tra prosa e poesia : Roberto Longhi e la Disfatta di Massenzio 151
note e recensioni
Pensons ensemble les revues (Anne-Rachel Hermetet, Nathalie Prince) 167Massimo Fusillo, Estetica della letteratura (Andrea Pinotti) 170Leo Spitzer. Lo stile e il metodo, a cura di Ivano Paccagnella ed Elisa Gregori (Stefano Ballerio) 172Mimesis. L’eredità di Auerbach, a cura di Ivano Paccagnella ed Elisa Gregori (Antonio Loreto) 177José Domínguez Caparrós, El moderno endecasílabo dactílico, anapéstico o de gaita gallega (Alfonso D’Agostino) 179Towards a Typology of Poetic Forms. From language to metrics and beyond, edit- ed by Jean-Louis Aroui and Andy Arleo (Stefano Versace) 185Franca Sinopoli, La dimensione europea nello studio letterario (Edoardo Esposito) 187
I CARATTERI DELLO STILE E LO STILE DEI CARATTERI :
CENNI SULL’OPERA DI GRIGORIJ VINOKUR
Stefania Sini
Tra i più rilevanti contributi allo sviluppo della stilistica russa nella prima metà del Novecento, vi è quello, poco noto in Italia fuori dal perimetro degli spe-
cialisti, di Grigorij Osipovic Vinokur (1896-1947). 1Linguista di formazione – grammatica storica, ortografia, lessicografia costi-
tuiscono durante tutta la sua vita discipline non occasionali di insegnamento e di attività di ricerca –, intorno alla metà degli anni Venti Vinokur rappresenta con Roman Jakobson l’orientamento teorico e metodologico caratteristico del « for-
1 Nasce a Varsavia e giunge a Mosca nel 1904 dove studia lingua al ginnasio Strachov. Nel 1916 si iscri-ve alla Facoltà di filologia. Il suo maestro Dmitrij Nikolaevic ˇ Ušakov lo introduce sin dal primo anno nella Commissione dialettologica moscovita (Moskovskaja dialektologic ˇeskaja kommissija). Altri suoi maestri sono Michail Nikolaevic Peterson, Vjaceslav Nikolaevic Šcepkin, Michail Michajlovic Pokrov-skij. Durante gli anni universitari Vinokur si occupa quasi esclusivamente di linguistica. Di letteratura si interessa frequentando il Moskovskij Lingvisticeskij Kružok (Circolo Linguistico di Mosca), gruppo stu-dentesco al quale prendono parte anche professori e ricercatori tra cui Pavel Nikitic ˇ Sakulin. Ne diviene presidente negli anni 1922-23. In questi anni conosce i poeti e teorici del Futurismo : David Burljuk, Velemir Chlebnikov, Vasilij Kamenskij, Nikolaj Aseev e soprattutto Vladimir Majakovskij. Collabora al lef (Levyj Front Isskustv, Fronte di sinistra delle arti, fondato da Majakovskij e sodali, attivo a Mosca dal 1922 al 1929). Il suo primo lavoro pubblicato è dedicato al poema Oblako v štanach (La nuvola in calzoni) di Majakovskij (1915). Alla poesia del grande poeta futurista Vinokur dedicherà trent’anni dopo il vo-lume Majakovskij – novator jazyka [Majakovskij novatore della lingua], Moskva, Sovetskij Pisatel’, 1943, « che resta ancor oggi una delle migliori analisi linguistiche della poesia majakovskiana ». Cfr. Rossana Platone (a cura di), Saggi russi di teoria letteraria, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995, pp. 259-260. Dal 1924 comincia a prendere parte ai lavori della GAChN nelle cui collane pubblica nel 1927 Biografija i kul’tura. Dagli anni Trenta insegna a Mosca presso l’Istituto Pedagogico, l’Istituto di Storia, Filosofia e Letteratura e all’Università. È membro della Commissione dell’edizione delle opere di Puškin per l’Ac-cademia delle Scienze. Lavora al Dizionario della lingua russa dell’Accademia delle Scienze, poi pubbli-cato nel 1949 a cura di Sergej Petrovic ˇ Obnorskij, al Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka a cura di D.N. Ušakov, e al dizionario della vita di Puškin. Cfr. Stepan Grigor’evic ˇ Barchudarov, G.O. Vinokur, in Grigorij Osipovic ˇ Vinokur, Izbrannye raboty po russkomu jazyku [lavori scelti sulla lingua russa], red. L.A. Cµeško i O.G. Šc ˇukina, Moskva, Akademija Nauk CCCP, Otdelenie literatury i jazyka, Uc ˇebno-pedagogiceskoe izdatel’stvo, 1959, pp. 3-8 ; Maksim Il’ic ˇ Šapir, Kommentarij, in Vinokur, Filologiceskie issledovanija : lin-gvistika i poètika [ricerche filologiche : linguistica e poetica], sost. M.I. Šapir, Moskva, Nauka, 1990, pp. 256-365 ; Sergej Iosifovic ˇ Gindin, Nina Nikolaevna Rozanova, Jazyk. Kul’tura. Gumanitarnoe zna-nie : naucnoe nasledie G.O. Vinokura i sovremennost’ [Lingua. Cultura. Conoscenza umanistica. L’eredità scientifica di G.O. Vinokur e la contemporaneità], Moskva, Naucnyj mir, 1999 ; Gindin, G.O. Vinokur v poiskach sušc ˇnosti filologii [G.O. Vinokur alla ricerca della sostanza della filologia], « Izvestija Akademii Nauk », ser. Lit. i jaz., T. 57, N. 2, 1998, pp. 3-18. Cfr. da ultimo Vinokur, Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul’ture reci [lavori scelti di linguistica e cultura del discorso], sost. S.V. Kiselev, vstup. stat’ja Nikolaj Maksimovic Šanskij, Moskva, Lki, 2020. In italiano sono stati tradotti i due saggi Lingua della letteratura e lingua letteraria (Jazyk literatury i literaturnyj jazyk) e La lingua dell’opera letteraria (O jazyke chudožestvennoj literatury), in Platone, op. cit., pp. 97-123.
stefania sini76
malismo moscovita » del mlk 1 mirante a imporre la supremazia della linguistica sulle discipline letterarie. Se contro tale inopinato « imperialismo linguistico » e a difesa dell’autonomia della loro scienza i membri dell’opojaz non possono che insorgere violentemente, 2 un ulteriore fronte di lotta per i pietrogradesi si profila presto a Mosca con i tentativi del circolo di Gustav Špet all’interno della GAChN di convertire il formalismo in una sezione della metodologia estetico-filosofica generale. 3
Proprio di questi tentativi Grigorij Osipovic diviene a partire dal 1924 entusiasta sostenitore intervenendo ai lavori della GAChN ed esprimendo con toni via via più risoluti il suo assenso alla lezione špetiana. Si consuma così l’inevitabile rottu-ra con il lef e con il metodo formale, che egli non esita a tacciare rispettivamente di nichilismo e di fragilità e arretratezza teorica. 4
D’ora in poi Vinokur si dedicherà allo studio della linguistica con strumenti
1 Sul « formalismo moscovita », considerato anche attraverso la problematicità di questa denomi-nazione, cfr. Catherine Depretto, Le formalisme en Russie, Paris, Institut d’Études Slaves, 2009, pp. 162-176.
2 « L’imperialismo linguistico », aborrito soprattutto da Èjchenbaum, era l’inesorabile tendenza manifestata da Jakobson e da Vinokur all’inizio degli anni ’20 al « dissolvimento della scienza della letteratura nella linguistica ». Cfr. Aleksandr Dmitrev, Jan Levc ˇenko, Nauka kak priëm : ešc ˇë raz o metodologiceskom nasledii russkogo formalizma [Scienza come procedimento. Ancora sull’eredità meto-dologica del formalismo russo], « Novoe literaturnoe obozrenie », n.50, 4’ 2001, p. 211). Riguardo alla battaglia dei i formalisti pietrogradesi, in polemica con i moscoviti, per il principio dell’autonomia dell’oggetto della scienza della letteratura, mi permetto di rinviare a quanto scritto in Di nuovo sul for-malismo russo, « Letteratura e letterature », 1, 2007, pp. 49-75.
3 Gosudarstvennaja Akademija chudožestvennych nauk (l’Accademia Statale di scienze artistiche), in ori-gine RAChN (Rossijskaja Akademija chudožestvennych nauk), su cui rinvio ancora a Di nuovo sul formalismo russo, cit, pp. 65-69.
4 Ne è prova, per esempio, quanto Vinokur scrive a Jakobson nell’agosto 1925 : « come fai a non ve-dere con il lume della tua ragione che E∆jchenbaum nel suo Lermontov ripete cose trite e ritrite, nonché stantie, della scuola neogrammatici ? » Cfr. G.O. Vinokur, R.O. Jakobson, E ∆pizod epistoljarnoj polemiki G.O. Vinokura i R.O. Jakobsona (K 100-letiju G.O. Vinokura) [Un episodio della polemica epistolare tra G.O. Vinokur e R.O. Jakobson] (a cura di S.I. Gindin e E.A. Ivanovaja), « Izv. RAN », ser. lit. i jaz., vol. 55, n. 6, 1996, pp. 60-74, p. 66. Secondo Nikolaj Ivanovic Nikolaev, qui gli argomenti di Vinokur sono concordi con quelli esibiti da Viktor Žirmunskij nel momento in cui matura il suo distacco dall’opojaz. « Quando in un’altra missiva Vinokur si espresse favorevolmente su K. Vossler, sulla critica all’approccio naturalista dei neogrammatici verso le regolarità fonetiche, Jakobson nel 1927 notò subito in una lettera di risposta la sua “affinità con Žirmunskij e con la cosiddetta ‘scuola idealistica’ tedesca in linguistica” » : « Le tue citazioni di approvazione nella lettera contro la trattazione delle leggi fonetiche di questa scuola sono per me decisamente inaccettabili » (ivi, p. 69). « In tal modo, nella questione sulla “dialettologia poetica” non si parlava soltanto dei diversi approcci alla poetica, ma anche delle diverse linguistiche. Criticando la “dialettologia poetica” di Jakobson, Žirmunskij si basava sulla tradizione della linguistica romantica (da A. Schlegel, Humboldt e A.A. Potebnja fino a K. Vossler) che portava con sé l’idea del linguaggio come attività, ma si rifaceva anche alle concezioni della linguistica contemporanea con il suo concetto di pluralità di attività linguistiche (nella variante del 1924 dell’articolo I compiti della poetica viene citato J. Baudouin De Courtenay) ». Cfr. Viktor Žirmunskij, Zadaci poètiki [i compiti della poetica], « Nacalo. Žurnal istorii literatury i istorii obšcestvennosti » (1921), n. 1, pp. 51-81. [Una I variante di questo articolo era apparsa a puntate nel 1919 sul quotidiano « Žizn’ iskusstva »]. Cfr. Nikolaj I. Nikolaev, M. M. Bach-tin, Nevel’skaja škola filosofii i kul’turnaja istorija 1929-ch godov, in Bachtinskij sbornik (raccolta bachtiniana), otv. red. i sost. Vitalij L’vovic Machlin, Moskva, Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2004, pp. 231-232. Trad. it. a cura di Giuseppina Larocca, La critica non ufficiale al « metodo formale » nella cultura russa degli anni ’20, « Enthymema » n. ii, 2010, pp. 111-112.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 77
affilati e consapevolezza filosofica, senza perdere mai d’occhio quanto in seno alla disciplina è di recente accaduto e sta accadendo fuori dalla Russia, e innestando su una riflessione teorica di ampio respiro, con esiti decisamente interessanti, una serie di concretissimi problemi relativi all’educazione e alla politica linguistiche. Problemi, questi, che in un contesto storico come gli anni successivi alla Rivo-luzione d’ottobre, e in un territorio enorme come la neonata Unione Sovietica, assumono un’urgenza di particolare intensità.
1. Quale linguistica
Della feconda collaborazione fra istanze speculative e sollecitazioni dell’hic et nunc troviamo testimonianza nel libro d’esordio di Grigorij Osipovic, Kul’tura jazyka (cultura della lingua), pubblicato nel 1925 e con edizione riveduta e amplia-ta nel 1929. 1 Raccogliendo in una prima sintesi i risultati delle ricerche svolte dallo studioso fino a questo momento, il saggio si colloca dunque allo spartiacque tra la sua militanza futurista-formalista e la svolta špetiana, mostrando la coesistenza di motivi provenienti da entrambe le esperienze. 2
Il Primo capitolo, « Linguistica e stilistica », prende le mosse da una rassegna delle maggiori scuole della linguistica europea. L’autore rileva che se la principale lacuna delle posizioni dei neogrammatici concerneva la semantica (cosicché « la lingua perdeva per loro insieme al senso quelle qualità che le erano proprie in quanto simbolo collettivo e sociale »), 3 di contro, anche Vossler sbaglia. Anzi, egli ripeterebbe « lo stesso errore della linguistica positivista neogrammatica da un altro versante » : giungerebbe « a negare la realtà (real’nost’) della lingua come feno-meno collettivo, ma con la differenza sostanziale che per individualità in quanto veicolo della realtà della lingua, Vossler intende un’individualità creativa ». D’altro canto, questo suo errore, « legato alla priorità da lui stabilita della stilistica nei con-fronti della grammatica », « conduce alla giusta tesi, se la si prende in sé : “Quanti individui, tanti stili” ». 4
Sia al positivismo dei neogrammatici che all’idealismo vossleriano lo studioso russo risponde dispiegando una prospettiva eminentemente comunicativa e so-ciale :
Già di per se stessa la nozione di « lingua » (jazyk) presuppone un determinato ambiente sociale nel quale questa nozione si realizza. La lingua è innanzi tutto un mezzo di comu-
1 Vinokur, Kul’tura jazyka.Ocerki lingvisticeskoj technologii [Cultura della lingua. Saggi di linguistica tecnologica], Moskva, Rabotnik prosvešcenija, 1925, poi Moskva, Federacija, 1929 (in copertina 1930) ; ora Moskva, Labirint, 2006, da cui citiamo. Traduzione mia, come sempre, d’ora in avanti, salvo diver-samente indicato.
2 Basti considerare la storia editoriale di alcune parti del libro. Per esempio, O revoljucionnoj frazeo-logii. Odin iz voprosov jazykovoj politiki [Sulla fraseologia rivoluzionaria (uno delle questioni di politica linguistica)] esce su « Lef » n. 2, 1923, pp. 104-118. Così pure O purizme [sul purismo], « Lef » n. 2, 1924, pp. 156-171 ; Jazyk našej gazety [la lingua del nostro giornale], « Lef » n. 2 (9), 1924, pp. 117-140.
3 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 11.4 Ivi, p. 12. Tutti i corsivi sono dell’autore, come sempre, d’ora in avanti, salvo diversamente indicato.
Vinokur cita Karl Vossler, Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1904, p. 37 sgg.
stefania sini78
nicazione (soobšcenie) e comprensione (ponimanie) sociale. Affinché la lingua possa essere lingua essa deve essere compresa da almeno due persone. Perfino il cosiddetto « discorso interiore » (vnutrennjaja rec) è sempre discorso fra « interlocutori », sia pure fusi in un dato momento in una persona sola ; cioè presuppone sempre la comunicazione e la comprensione. Abbiamo diritto di parlare di lingua solo quando essa è un fatto sociale, ha significatività sociale. 1
Additando l’« evoluzionismo individualistico » quale difetto principale della meto-dologia della linguistica comparata, Vinokur si sofferma quindi sui tentativi di neutralizzare l’errore da parte della Scuola di Ginevra (che pure da tale matrice proviene). È pertanto ineludibile il confronto con quel recente cambio di para-digma che ha coinvolto la disciplina in seguito alla diffusione delle lezioni di Fer-dinand de Saussure. Vengono così esposte le nozioni di linguaggio (langage) (recˇ), lingua (langue) (jazyk), parola individuale (parole) (govorenie), tutte incardinate in uno zoccolo semantico sostanzialmente dicotomico. 2 L’accento batte sia sull’idea di linguistica come scienza sociale e di linguaggio come convenzionale e arbitra-rio, 3 sia sul ruolo decisivo del concetto di sistema, « che, nel suo giusto sviluppo, dà una spinta in direzione di una revisione radicale di tutta la problematica lin-guistica ». 4
Tuttavia, secondo Grigorij Osipovic, « Saussure non ha ragione quando inten-de il discorso individuale soltanto come appropriazione passiva e naturale della lingua sociale. È chiaro, invece, che questa appropriazione è creativa. Non pre-stando attenzione a questo lato del problema, non ha tratto perciò le necessarie deduzioni dall’antinomia langue/parole ». 5 Inoltre, nella distinzione proposta dal maestro ginevrino fra « la linguistica statica o sincronica e la linguisitica evolutiva o diacronica », si attribuisce un peso sostanziale alla prima mentre alla seconda viene riservato un ruolo pressoché ancillare. L’importante qui non sono « i cambiamenti delle forme esterne della lingua, le trasformazioni fonetiche, ma il meccanismo del-la lingua, il quale, per evidenti motivi, è accessibile allo studio soltanto nel suo ta-glio sincronico ». Certo, si tratta di una comprensibile e per molti aspetti salutare
1 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 13. Queste affermazioni sono dvvero molto vicine a quelle enunciate da Bachtin e dal suo Circolo in questi stessi anni. Cfr. per esempio Valentin Nikolaevic ˇ Vološinov, Marksizm i filosofija jazyka : osnovnye problemy sociologicˇeskogo metoda v nauke o jazyke [Mar-xismo e filosofia del linguaggio : problemi fondamentali del metodo sociologico nella scienza del lin-guaggio], Leningrad, Priboj, 1929, in M. M. Bachtin (pod maskoj) [dietro la maschera], sostavlenie, tekstologiceskaja podgotovka I. V. Peškov ; kommentarii V. L. Machlin, I.V. Peškov, Moskva, Labirint, 2000, pp., pp. 349-486 ; trad. it. Marxismo e filosofia del linguaggio, introduzione e trad. di Margherita De Michiel, Lecce, Manni, 1999.
2 « Il principale merito di Saussure consiste nel fatto che restituisce alle nozioni linguistiche fonda-mentali il loro originario e secolare senso antinomico. E se avesse compreso davvero dialetticamente le antinomie da lui stesso stabilite, il rinnovamento prodotto nella scienza dalle idee svizzere sarebbe molto più serio e fruttifero ». Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 16. Qui lo studioso russo mette a fuoco l’importante questione dei possibili modi della relazionalità sistemica, su cui tanto si eserciterà il pen-siero strutturale.
3 A questo proposito, Vinokur sottolinea il debito contratto da Saussure con il linguista americano William Dwight Whitney il quale « insiste con estrema consequenzialità sul fatto che si debba guardare alla lingua come a una delle istituzioni (institutions) della convivenza umana ». Ivi, p. 18.
4 Ivi, p. 19. 5 Ivi, p. 18.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 79
reazione nei confronti del passato : se infatti « prima la linguistica stabiliva un lega-me storico (o meglio, di semplice successione [preemstvennaja svjaz’]) soltanto fra tappe separate di sviluppo di un qualunque fatto linguistico isolato, la linguistica di Saussure cerca già i legami tra fatti distinti dell’intero (celaja) sistema linguistico, coglie già l’organizzazione interna, e non l’evoluzione esterna della lingua ».
In altre parole, il metodo statico di Saussure, che nel suo fondamento ultimo ha indubbia-mente origine dai metodi filologici tradizionali di interpretazione e di critica (nonostante lo stesso Saussure non se ne sia accorto e abbia continuato a considerare la « filologia » uno stadio dello studio del linguaggio ormai esaurito), attua proprio quel compito davanti al quale la scuola neogrammatica si era fermata inerme : trovare il corretto passaggio dalla fonetica alla grammatica e alla semasiologia, legare dialetticamente il problema del suono al problema del significato e del senso, unire in una metodologia questi due problemi che nell’ambito dell’ideologia neogrammatica erano rimasti inevitabilmente staccati l’uno dall’altro. 1
Vale la pena qui di non sorvolare sulla considerazione espressa nella frase relativa intorno alla inconsapevole ‘genealogia’ del metodo saussuriano : esso originereb-be secondo lo studioso russo dai procedimenti dell’ermeneutica e della critica tradizionali. « Cercare », come fa il ginevrino, « i legami tra fatti distinti dell’intero sistema », « coglierne l’organizzazione interna », costituisce altresì l’operazione e lo scopo dell’analisi testuale che, partendo da un intero già dato, il testo, appunto (come il linguista parte dal taglio sincronico), giunge a « trovare il corretto pas-saggio » tra i vari strati che lo compongono. Allorquando la nozione di sistema è intesa in senso forte, diciamo pure strutturale, ecco che ci troviamo di fronte alla critica stilistica strictu sensu. E il debito per esempio di Leo Spitzer nei confronti di Schleiermacher è un fatto ben noto. Lo stesso Vinokur, peraltro, non si sottrarrà, come vedremo, al potere del circolo ermeneutico.
In ogni caso, ricorda Grigorij Osipovic, Saussure « non si è accorto di avere com-piuto un errore metodologico » :
Bisogna porgere attenzione al fatto che nel sistema saussuriano delle due linguistiche toc-cano però in sorte alla linguistica “storica” esclusivamente i suoni e che la storicità di que-sta linguistica viene intesa nello spirito di quella stessa evoluzione esterna. E inoltre, per la scienza della parola (govorenie), della cui scoperta siamo debitori a de Saussure, nella sua classificazione delle discipline linguistiche non c’è alcun posto ! È evidente che ciò non è assolutamente possibile dal punto di vista dei presupposti che costituiscono, per così dire, l’anima dello studio di de Saussure, il suo nucleo fondamentale e prezioso. Se la langue è la lingua stabile (prebyvajušcij), mentre la parole è la lingua che vive nella realtà e che cambia, allora proprio queste devono essere le due linguistiche : una statica (sebbene il termine non sia molto felice : le forme della lingua, anche in un loro segmento temporale non sono statiche e si comprendono solo nella loro dinamica di senso […]), che studi la lingua nel suo sistema, come meccanismo di forme grammaticali e di correlazioni che conferiscono loro senso, e un’altra storica, ma già senza virgolette, cioè che studi la lingua in quanto fatto reale della vita sociale, nel suo concreto essere storico, detto altrimenti, la storia della lingua in senso proprio. 2
1 Ivi, p. 19. 2 Ivi, p. 20.
stefania sini80
Vinokur torce dunque il dettato saussuriano identificando la storia sociale della lingua con la scienza della parole, intesa quest’ultima non come « un processo au-tomatico e meccanico, bensì attivo […], come manifestazione sociale della lingua per mezzo di una iniziativa individuale, che agisce nei limiti di un data collettività linguistica ».
Di conseguenza è importante innanzi tutto il fatto che l’individualità, anche se parla a mo-do suo, dà vita comunque a ciò che è generale, così che il materiale discorsivo che trova la propria espressione nella parola è comunque la langue stessa. Ma non meno importante è che la parola in quanto atto del discorso individuale non è per nulla un atto esclusiva-mente di una sola persona. In relazione proprio alla lingua in quanto generale patrimo-nio sociale, sarà parola qualsiasi discorso nel quale proprio la lingua viene specificamente manifestata da un qualsiasi membro di questo insieme sociale. E la nozione di membro dell’insieme sociale può essere ristretta o estesa quanto si vuole : se è possibile la parola come discorso individuale di un singolo individuo sociale, è anche possibile come discorso individuale di un gruppo di individui, per esempio, la lingua di famiglia, di ceto, di classe, di professione, ecc. Per rendere il mio pensiero definitivamente chiaro, dirò semplicemte che la contrapposizione di Saussure tra langue e parole si deve intendere come contrappo-sizione tra lingua e stile. 1
Ecco che dalla sua lettura critica del Cours lo studioso russo dà corpo alla nozione di stile, su cui decide di lavorare attraverso una « storia della lingua » pensata come, appunto, una stilistica storica. La quale si inscrive all’interno della « generale storia della cultura, cioè si colloca accanto a discipline come la storia della letteratura, la storia dell’arte, la storia del culto, la storia dello stato e delle istituzioni, ecc ». Vi-nokur mostra così di avere ben chiara l’idea dell’interconnessione dei sistemi cul-turali, che troveremo espressa anche nel suo studio sulla biografia, 2 e che, punto fermo di quanto va pensando Michail Bachtin negli stessi anni, rappresenterà un frutto importante del formalismo maturo, dello strutturalismo praghese, e infine della semiotica lotmaniana. 3
1 Ivi, p. 21. 2 Cfr. infra, par. 3 Ricordiamo che proprio nel 1924, anno in cui Vinokur lavora alla redazione del suo libro, e proprio
su « Lef », esce un testo di Tynjanov dedicato al rapporto fra opera, sistema letterario ed evoluzione. Cfr. Jurij Tynjanov, Literaturnyj fakt [Il fatto letterario], in « Lef », n. 2, 1924, pp. 101-116, ora in Literatur-naja èvoljucija, sostavlenie, vstupitel’naja stat’ja, kommentarii Vladimir Novikov, Moskva, Agraf, 2002, pp. 167-188. Cfr. anche Idem, O literaturnoj èvolucii [Sull’evoluzione letteraria], in « Na literaturnom po-stu » 10, 1927, pp. 42-48, poi in Archaisty i novatory, Leningrad, 1929 ; trad. it. di Remo Faccani in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi, Torino, Einaudi, 1968, pp. 125-143. Risale al medesimo 1924 il lavo-ro bachtiniano dedicato alla discussione critica dei fondamenti teorici e metodologici del formalismo : Michail Michajlovic ˇ Bachtin, K voprosam metodologii èstetiki slovesnogo tvorcestva. 1. Problema formy, soderžanija i materiala v slovesnom chudožestvennom tvorcestve [Problemi di metodologia dell’estetica della creazione verbale. 1. Il problema della forma, del contenuto e del materiale nella creazione verbale artistica], in Sobranie socinenij, T. 1, Filosofskaja èstetika 1920-ch godov [Opere. Estetica filosofica degli anni Venti], redaktory toma S.G. Boc ˇarov i N.I. Nikolaev, Moskva, Russkie slovari, 2003, p. 282 ; trad. it. Il pro-blema del contenuto, del materiale e della forma nella creazione letteraria, in Estetica e romanzo. Un contributo fondamentale alla « scienza della letteratura », a cura di Carla Strada Janovic ˇ, Torino, Einaudi, 1979, p. 20. Sulla genesi di questo saggio, cfr. il commento di Nikolaev, Sobranie socinenij, T. 1, cit., pp. 707-867.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 81
2. Quale stilistica
Grigorij Osipovic ritiene dunque che « per il linguista che occupa nei confronti del suo oggetto la posizione dello storico, la lingua è una cosa sociale (social’naja vešc ˇ’) fra altre cose, la quale sorge, si sviluppa e cambia insieme a tutta la vita sociale, in strettisisma dipendenza da essa e in un complesso intreccio con le altre sfere della vita spirituale ». 1 Proprio « dal confronto con le restanti sfere della cultura si chia-risce anche il fatto per cui la storia della lingua pensata in tal senso ha quale suo oggetto in sostanza non la lingua come un certo principio ideale e come norma, ma solo concreti stili linguistici.
Così, per esempio, anche la storia della lingua come concreta scienza sociale non studia le possibilità virtuali della letteratura nella correlazione interna dei suoi elementi che com-pongono un particolare sistema di espressione, né canoni e compiti ideali (se si studia ciò, lo si fa per esempio, nella poetica teorica, nella teoria della letteratura [teorija slovesnosti’]), ma l’essere reale e le storia reale di questa o quella cosa letteraria, vale a dire della lette-ratura realizzata e socialmente ritrovata (osušcestvlënnaja i social’no obnaružennaja). Cor-relativamente, anche nella linguistica, accanto a problemi di contenuto teorico, orientati verso la filosofia […] bisognerebbe studiare anche problemi orientati storicamente, come, per esempio, la lingua dell’intelligencija nobiliare degli anni Venti, la lingua cancelleresca dell’età pietrina o dell’epoca sovietica contemporanea, la fraseologia della generazione degli anni Sessanta (šestidesjatniki) o dei simbolisti, la terminologia militare nell’epoca di Nicola o il discorso di trincea durante la guerra mondiale, la lingua professionale degli stampatori o degli autisti, la lingua della antica corripondenza tra amici e di quella d’af-fari ecc. ecc. Come non è difficile vedere, tutte queste sono diverse iniziative nel campo dell’utilizzo delle possibilità contenute nella langue, e di conseguenza, diversi stili. In tal modo, la storia della lingua non è altro che storia degli stili linguisitici. 2
E qui Vinokur nomina di nuovo Vossler come unica eccezione nel panorama del-la linguistica attuale, come colui che mostra di condividere l’idea di storia della lingua che lo studioso russo sta presentando ai suoi lettori. 3 Non esita allora a dichiarare :
I lavori di Vossler rappresentano quanto vi è di più sostanziale e di maggior talento fra tut-to ciò che abbiamo di fresco e nuovo nella linguistica contemporanea. Possiamo affermar-lo anche se non condividiamo alcuni presupposti filosofici dell’idealismo vossleriano, che lo costringono per esempio a considerare la lingua come fenomeno sociale non in quanto correlato del discorso vivo, bensì solamente in quanto risultato della creazione stilistica dell’individualità, e gli fanno vedere nello stesso sviluppo della lingua l’espressione diretta dei cambiamenti corrispondenti nella sfera della cultura spirituale, eludendo il carattere convenzionale del segno linguistico. 4
1 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 16. 2 Ivi, pp. 22.3 Oltre a Vossler, Positivismus und Idealismus, cit., Vinokur rinvia a Idem, Sprache als Schöpfung und
Entwicklung, Heidelberg, 1905 ; Idem, Gessammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie, München, 1923. Rispet-to all’applicazione di questa prospettiva teorica alla lingua francese, cita poi, Idem, Frankreichs Kultur in Spiegel seiner Sprachentwicklung, Heidelberg, 1921.
4 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 23 n.
stefania sini82
D’altronde, anche la proposta di Charles Bally, pure sotto molti riguardi apprez-zata, non può collimare con quella di Grigorij Osipovic, sia per il diverso modo di intendere la stilistica sia per la generale impostazione teorica sui fatti di linguag-gio. Infatti, il ginevrino pensa lo studio dello stile come disciplina squisitamente autotelica, rinserrata nel suo solipsismo, priva di qualsivoglia applicazione pratica e di radicamento civile.
Devo specificare che Bally è in sostanza molto lontano dal punto di vista sulla lingua in quanto abilità e maestria (umenie i masterstvo), punto di vista che egli, seguendo una opi-nione diffusa, attribuisce all’estetica. 1
Inoltre Vinokur ritiene « sbagliata l’opinione di Bally sulla natura affettiva del si-stema stilistico », con la quale sembrerebbe esaurire la definizione dello stile, dopo averlo nettamente contrapposto al pensiero logico.
Bally, a mio parere, interpreta in modo assolutamente distorto l’interrelazione fra ele-mento logico ed elemento espressivo (logiceskaja i èkspressivnaja stichija) all’interno della lingua : la lingua non è espressiva malgrado le sue qualità logiche, bensì oltre (sverch) il suo significato logico, tanto più che l’espressività delle formule linguistiche di ogni genere, giri di frasi consolidati ecc, come riconosce lo stesso Bally, è puramente convenzionale, e non « naturale » In ogni caso per me è importante il riconoscimento enunciato proprio da Bally secondo cui la stilistica si estende su tutto il regno della linguistica, indipendentemente dalla sua definizione. 2
La via intrapresa da Grigorij Osipovic è dunque l’elaborazione di una stilistica storica intesa come « storia degli stili linguistici » (istorija jazykovych stilej), diretta all’analisi dell’« uso individuale della tradizione linguistica nelle più diverse condi-zioni del byt socio-culturale ». Fra langue e parole, fra il sistema sociale e le singole enunciazioni, egli ravvisa delle norme stilistiche, ciascuna delle quali, come scrive Peter Steiner, « governa un particolare tipo di comportamento verbale orientato verso un fine » :
These norms, pertaining only to specific usages of language, are less general than the norms of langue, but at the same time are shared by at least some speakers of a language. Like langue, they are social.
Viewed through this conceptual prism, every utterance, poetic or otherwise, is simulta-neously governed by two normative systems : a general langue and a particular style. 3
Esaminando poi l’insieme delle opere di Grigorij Vinokur, ci accorgiamo che esse si muovono costantemente su un doppio versante, quello della lingua e quello della letteratura. Nonostante la perseverante attenzione da lui rivolta ai fenomeni della comunicazione orale, dei quali descrive acutamente meccanismi e tendenze,
1 Ivi, pp. 28-29 n. Qui Vinokur cita Charles Bally, Traité de stylistique française (1909), 1, § 21.2 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 29 n, con rinvio a vari passi di Bally, Le langage et la vie, Paris, 1913
in cui lo studioso svizzero contrappone il discorso naturale e il discorso artificiale.3 Peter Steiner, Russian Formalism. A Metapoetics, Ithaca-London, Cornell University Press, 1984,
p. p. 211. Trad. it., Il formalismo russo, Bologna, Il Mulino, 1991, trad. dall’inglese di Giorgio Zanetti, Bologna, Il Mulino, 1991.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 83
non possono ignorarsi le tante e splendide pagine da lui dedicate alla scrittura po-etica e letteraria, da Majakovskij alla poesia simbolista, da Chlebnikov a Puškin. Lo studioso, ricorda Stepan Barchudarov, « considera l’esame dello stile della lin-gua della norma colta (obšceliteraturnyj jazyk) un problema puramente linguistico, mentre le questioni relative all’analisi dello stile dell’opera d’arte, così come della lingua e dello stile dello scrittore, le annovera tra i problemi della scienza lettera-ria ». 1
Grigorij Osipovic si occupa, dunque, di stilistica della lingua da una parte, e di stilistica letteraria dall’altra : una bipartizione che ci fa pensare immediatamente a Leo Spitzer e alla sua divisione del campo di indagine in Sprachstile e Stilsprache. 2 Una evidentissima ‘aria di famiglia’ accomuna in effetti la produzione di Vinokur con quella dell’illustre collega tedesco, il quale, d’altronde, era ben noto in Russia, dove in quegli anni giungevano tutte le novità filologiche e filosofiche provenienti dalla Germania. 3
Se allora « il merito di Vinokur sta nell’aver definito con precisione i compiti dello studio degli stili linguistici nel loro sviluppo storico distinguendoli da quelli dello studio dell’opera d’arte, dello stile (lingua) individuale dello scrittore », tale problema, nota Barchudarov, « non ha ancora ricevuto una soluzione definitiva o generalmente accettata nei programmi, nei manuali o nelle ricerche specialistiche di storia della lingua letteraria russa. Per questo il pensiero di Grigorij Osipovic ˇ […] conserva anche oggi la sua attualità ». 4
1 Barchudarov, G. O. Vinokur, cit., p. 6. 2 « Chi conosce l’opera di Spitzer », osserva Cesare Segre, « sa benissimo che il suo pensiero si è pro-
prio sviluppato all’interno, e persino grazie, a questa dicotomia. […] infine canonizzata con le Stilstu-dien, Max Hueber, München, 1928. Esse sono divise in due volumi, di cui il primo è sottotitolato Sprach-stile, e raccoglie lavori di stilistica della lingua […], mentre il secondo, sottotitolato Stilsprache, contiene alcuni dei più famosi e belli dei saggi di stilistica letteraria di Spitzer”. Cesare Segre, Presentazione a Leo Spitzer, Lingua italiana del dialogo, a cura di Claudia Caffi e Cesare Segre. Traduzione di Livia Tonelli, Milano, il Saggiatore, 2007, pp. 8-9. »
3 Il nome di Spitzer compare più volte nelle opere di Bachtin e del suo circolo, ad esempio, se ci limitiamo agli anni Venti, nella monografia dostoevskiana del 1929 e in Marxismo e filosofia del linguag-gio. Sappiamo poi che Michail Michajlovic legge attentamente il lavoro spitzeriano del 1914 Italienische Umgangssprache, trascrivendone alcune parti e traducendole in russo. Come mostrano infatti le carte del suo archivio, lo studioso russo lavora sull’edizione Kurt Schroeder, Bonn und Leipzig, 1922, di cui trascrive, riassume, traduce e commenta l’Indice, la Prefazione (pp. v, vi, vii, viii), parti dei capp. 1, 2 (pp. 1, 39, 134-35, 175, 176), iii (pp. 191-92), iv (pp. 291, 293). La trascrizione si conclude con le ultime frasi della Postfazione di Spitzer all’edizione 1922. Cfr. Bachtin, Sobranie soc ˇinenij, T. 2, « Problemy tvorc ˇestva Dostoevskogo », 1929 ; Stat’i o L. Tolstom, 1929 ; Zapisi kursa lekcij po istorii russkoj literatury, 1922-1927 [Opere T. 2 « Problemi dell’opera di Dostoevskij ; Articoli su Tolstoj ; Appunti del corso di lezioni sulla storia del-la letteratura russa »], redaktory toma S.G. Boc ˇarov, L.S. Melichova, Moskva, Russkie slovari, 2000, pp., 91 ; 735-758. Trad. it. Problemi dell’opera di Dostoevskij (1929), a cura di Margherita De Michiel e Augusto Ponzio, Bari, 1997, p. 199. Nonostante ne critichi il « soggettivismo », Bachtin dunque sembra tenere in gran considerazione il pensiero di Spitzer nel momento in cui lavora al libro su Dostoevskij e alla messa a punto della nozione di dialogo polifonico che si dischiude attraverso la parola, o, il che è lo stesso, la coscienza, il vissuto degli eroi.
4 Barchudarov, G. O. Vinokur, cit., pp. 5-6. Riguardo alle ‘due stilistiche’, lo studioso cita il saggio vinokuriano O zadac ˇach istorii jazyka [sui compiti della storia della lingua] (1941), in Vinokur, Izbrannye trudy, cit., pp. 207-226.
stefania sini84
3. Pratiche dello stile
Tuttavia il contributo vinokuriano agli studi stilistici non si limita a offrire una variante sia pur originalmente autoctona – in una comprensibile poligenesi di istanze radicate nella medesima humus – e ben confezionata del modello europeo. Ciò che deriva da un’attività scientifica cresciuta in anni particolarmente incan-descenti per la Russia è una interessantissima declinazione della materia che si prospetta come problema della stilistica pratica, del comportamento linguistico e dei suoi effetti concreti all’interno del nuovo assetto sociale.
Terminata la rassegna delle maggiori scuole della linguistica europea, e pre-sentata la stilistica storica quale storia delle norme d’uso, a metà strada fra l’inat-tingibile rigidità della langue e l’evanescenza opaca della parole, Grigorij Osipovic scrive :
Ma la lingua con la sua varietà stilistica può essere oggetto non solo di studio bensì anche di insegnamento. Così, accanto alla storia della lingua sorge la stilistica come utilizzo ap-plicato della conoscenza linguistica, come scienza sull’applicazione pratica delle possibi-lità ideali proprie della lingua, dipendenti dalle condizioni e dalle intenzioni. Questa idea della stilistica come conoscenza linguistica applicata o utilitaria non è nulla di nuovo. La stilistica è esistita in tutti i tempi. Ma essa fu dimenticata dalla tendenza dominante della linguistica nel xix secolo, che inseguendo le cosiddette « leggi obiettive » dello sviluppo del discorso ha immesso nella conoscenza linguistica una marea di pregiudizi naturali-stici. Dopo i lavori di Saussure e della sua scuola, dopo il libro di Bally Traité de stylistique francaise, dimostrare le possibilità della conoscenza linguistica applicata è già significativa-mente più facile. 1
Certamente, il richiamo alla tradizione non significa che la natura e i compiti della stilistica pratica consistano in una rispolverata di antichi fasti. « La stilistica con-temporanea », chiarisce Vinokur, « non può più rappresentare soltanto un sussidio per la poetica e la retorica. Il contenuto e la sfera della sua applicazione devono essere più ampi ; in essa le regole dell’eloquenza artificiale devono cedere il passo allo studio sulla parola (govorenie) nel senso più ampio del termine, cioè allo studio dell’uso individuale delle tradizioni linguistiche nelle più varie condizioni della vita sociale e culturale (social’no-kul’turnyj byt) ». « In tale accezione, la stilistica non è più semplicemente un elenco dogmatico di leggi e prescrizioni, ma un risultato della storia della lingua regolare e chiarito ; per questo il passaggio dalla storia della lingua alla stilistica di tal carattere pratico non è immediato, ma si compie attraverso la stilistica teorica, che spiega le regolarità discorsive [recevye zakonomer-nosti] e conferisce loro senso, prima di farne una direttiva culturale e una genera-lizzazione normativa. Il percorso è dunque il seguente : la storia della lingua os-serva e raccoglie i fatti dal campo degli stili linguistici, la stilistica teorica cerca in essi una legge relativa al senso che giustifichi il tal tipo di uso linguistico, mentre la stilistica pratica consolida e prescrive questo uso linguistico dotato di senso ». 2
1 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., pp. 23-24. 2 Ivi, p. 25.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 85
È necessario perciò mettere a fuoco le dinamiche sottese ai comportamenti linguistici e a determinate tendenze riscontrabili nelle pratiche discorsive, ed esa-minare il peso esercitato in essi rispettivamente dall’automatismo e dalla consa-pevolezza. Rinviando a una polemica intercorsa fra Potebnja e l’indoeuropeista August Schleicher, per il quale « la lingua che ha subìto su di sé l’effetto del ragio-namento umano o dell’arte non sarebbe più, propriamente, oggetto della lingui-stica », Vinokur ribatte che la lingua, « in quanto espressione (vyraženie) e strumento (orudie) del pensiero », presuppone sempre autocoscienza :
Non è affatto un paradosso l’affermazione secondo cui la lingua è arte. È in ogni caso indiscutibile che nella lingua vi sia tutto ciò che serva affinché vi sia arte. Non è un caso che i teorici e gli studiosi contemporanei dell’arte e i filosofi sempre più spesso giungano a pensare che nell’analisi della struttura (struktura) della lingua si possano ritrovare le basi fondamentali della possibilità di qualunque arte. La lingua può essere arte anche perché è ineludibilmente attività (aktivnost’). Il discorso è atto (akt) di una coscienza che agisce (dejatel’noe), e non un riflesso automatizzato di un organismo psicofisico. […] abbiamo sempre di fronte la scelta e la creatività, l’uso autonomo di materiali concessi al parlante (persona o unione di persone) da una tradizione linguistica socialmente data. Il nostro discorso deve essere sempre in buona misura costruito. Esso è oggetto di superamento (preo-dolenie) culturale, necessita di una qualche organizzazione (organizacija) stilistica. 1
Si dispiega così la questione della cultura della lingua (kul’tura jazyka), concer-nente la possibilità per ciascun parlante di disporre di principi di costruzione di tipi e generi del discorso diversi nell’ambito di una data tradizione sociale. Si tratta in sostanza di una ‘competenza di genere’ intesa come diritto civile da rivendicare e da acquisire e, per chi ne sia socialmente preposto, da insegnare. Ecco allora che la proposta vinokuriana mostra la sua inequivocabile valenza educativa e politica :
Questo problema [scilicet, della cultura della lingua] verrà risolto in pratica allorquando a ciascun membro del collettivo parlante sarà ugualmente chiara la differenza fra mezzi linguistici adoperabili in diversi generi linguistici, come per esempio è chiaro allo scrittore riguardo ai generi letterari. Il discorso orale o scritto, oratorio o colloquiale, cancelleresco e poetico, da comizio o da parlamento, il rapporto o il decreto, la conversazione con il conoscente o lo scambio diplomatico di gentilezze, la lingua della prosa e del verso : tutti questi compiti linguistici, insieme ad altri innumerevoli suddivisioni che possono prose-guire in ciascuno di questi tipi e sottotipi, necessitano di propri mezzi di esecuzione e di una propria « tecnica » : ecco, di questi mezzi e di questa tecnica si occupa la stilistica pratica, questo studio applicato della lingua, questa tecnologia linguistica sui generis, la cui possibilità e i cui principi ho cercato di esporre. 2
Un esempio interessante di stilistica pratica offertoci dallo studioso è quello dalla toponomastica, settore che in quegli anni è travolto e sconquassato dagli eventi politici. Vinokur esamina i massicci cambiamenti di nome subiti dalle vie e delle strade di Mosca dopo la Rivoluzione, rilevando come molti dei nuovi toponimi
1 Ivi, pp. 26-27. 2 Ivi, p. 27.
stefania sini86
risultino estranei alla coscienza popolare. 1 Le conseguenze, com’è ovvio, trava-licano i confini delle dispute accademiche, andando a investire la vita quotidiana nella logistica, nell’organizzazione del vissuto e toccando in profondita la coscien-za civile.
Le questioni relative alla toponomastica sono per lo più appannaggio di analisi lessicale, e, casomai, morfologica. « Il lessico, tuttavia », osserva lo studioso, « non adempie al ruolo organizzativo nella struttura della lingua, dove svolge una fun-zione principalmente nominativa (nominativnaja). Il vocabolario “chiama” soltanto gli oggetti, ed è soltanto una lista di ciò rispetto a cui è possibile l’espressione linguistica. Invece l’organizzazione e la costruzione di questa espressione sono interamente compito della grammatica » : dunque lo studio della stilistica gram-maticale « deve creare l’abitudine all’orientamento verso i momenti organizzativi dell’espressione linguistica, insegnare il rapporto attento nei confronti degli ele-menti della costruzione del discorso ».
Vinokur comprende allora che sotto tale profilo, rispetto alla volubile transito-rietà della comunicazione orale, « è più facile illustrare questi momenti organizza-tivi del discorso sul materiale della parola scritta, dove gli sforzi grammaticali del parlante e lo stesso compito grammaticale traspaiono in modo molto più evidente che nel discorso parlato, dove la risoluzione di tale compito organizzativo spesso va a carico della gesticolazione, di ogni sorta di procedimento vocale espressivo ». Se dunque bisogna andare a guardare alla lingua fissata dalla scrittura, non tutti i generi però vanno incondizionatamente bene :
I tipi più semplici di discorso scritto non si trovano nel campo della letteratura artisti-ca, ma sono il discorso giornalistico, pubblicitario, cancelleresco, epistolare ecc. Ecco il campo in cui la linguistica contemporanea può estrarre molto di nuovo per sé e per quel compito applicativo che essa può e deve eseguire, come ho cercato di mostrare. Può, per-ché la messa in rilievo di questo tipo di problemi tecnologici del campo della linguistica viene favorita dalla stessa situazione attuale della scienza : in essa davanti ai nostri occhi si sta compiendo un processo di rinascita e rinnovamento interiori. Deve, perché qualunque altra via di introduzione dell’acculturamento linguistico e qualunque sviluppo dell’auto-coscienza linguistica che eludano una conoscenza diretta e autentica della lingua a conti fatti risultano insostenibili. Questo problema ha un significato particolarmente impor-tante nelle condizioni della realtà russa : il livello estremamente basso dell’acculturazione linguistica in Russia fa del tema qui toccato la questione più urgente della nostra cultura nel suo complesso. 2
Tutto questo non significa abbandonare al suo destino la letteratura artistica. Anzi, puntualizza Vinokur, « il significato altamente educativo della letteratura viene con ciò nuovamente presupposto di per se stesso. Per quanto riguarda in particolare la poesia, al suo significato per la stilistica pratica è dedicato un saggio
1 Ivi, pp. 29-31. In particolare, il linguista osserva la cattiva accoglienza di forme con il genitivo (per es. Plošcad’ Sverdlova (Piazza di Sverdlov) da parte del popolo, il quale tende invece a formulare il toponi-mo nella morfologia aggettivale Sverdlovskaja, che corriponderebbe al modello tradizionale (la tenden-za è viva ancor oggi : per esempio si dice comunemente Biblioteka Lenin’ka per Biblioteka imeni Lenina).
2 Ivi, pp. 32-33.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 87
speciale in questo libro. 1 Qui invece si tratta di come condurre qualsiasi discorso a quel livello di compiutezza tecnica che caratterizza la lingua dell’opera d’arte. Il linguaggio scritto in senso lato è assunto da noi come primo passo sulla via verso tale compiutezza, cioè in quanto campo del discorso in cui gli sforzi di “padro-neggiare” la lingua e “costruire” in modo organizzato un’esposizione sono dati in modo evidente e spoglio ». 2
4. Purismo militante
L’aspirazione a raggiungere in tutti i generi discorsivi « quel livello di compiutezza tecnica che caratterizza la lingua dell’opera d’arte » è parte di un programma che Grigorij Osipovic ˇ non esita a definire in termini di purismo, 3 intendendo con ciò un’attitudine vigile, ma senza oltranzismi censori, di fronte ai mutamenti che investono la lingua. In un periodo storico di tali sconvolgimenti come quello in cui si trova a operare, lo studioso deve rendere conto dei numerosi casi soprag-giunti di uso deviante rispetto alla buona norma linguistica e dei vari possibili tipi di deviazione. 4 Certamente non si tratta di fatti meramente lessicali : « Noi tutti facciamo ancora smorfie davanti a barbarismi e provincialismi, ma non ci accor-giamo che non si tratta di nuove parolette né di vecchie parole, ma prima di tutto di stile ». Ma allora, viene nuovamente da chiedersi, cos’è lo stile ?
La risposta dell’autore evoca un tipo di purismo qualificabile come « positivo » : null’altro, in fondo, che un sinonimo di quanto è stato fino ad ora denominato « cultura della lingua ».
Il purismo come noi lo intendiamo riserva la sua massima attenzione alle questioni di sti-le. Ma la stilistica è l’unico campo dove il purismo perde la sua inutilità di principio, aprioristica. Rivolgendosi alla stilistica, il purismo può compiere un’autentica opera reale. Poiché lo sti-le è l’uso cosciente dei canoni della lingua da parte dell’individuo parlante. Le prescrizioni della grammatica legano il nostro discorso a determinate cornici nei cui limiti otteniamo la possibilità di creazione e invenzione stilistica. La sintassi, nel senso ampio della parola, è il prodotto dell’interrelazione fra grammatica e stilistica. Il vocabolario è il prodotto dell’interrelazione fra stilistica e lessicologia. Costruendo forme sintattiche nel discorso, con l’aiuto delle nostre consuetudini stilistiche produciamo una scelta fra possibilità messe a nostra disposizione dalla grammatica. 5
In queste pagine percorse da un ben percepibile tono militante lo studioso non manca di rilevare una crisi in atto della coscienza scientifica che investe piena-
1 L’autore si riferisce alla terza parte del libro intitolata Iskusstvo slova i kul’tura jazyka (Arte della parola e cultura della lingua) e suddivisa in 1. Poèzija i prakticeskaja stilistika (Poesia e stilistica pratica) ; 2. Puškin – prozaik (Puškin prosatore) ; 3. Recevaja praktika futuristov (La pratica discorsiva dei futuristi). Cfr. ivi, pp. 202-246. 2 Ivi, p. 33 n.
3 O purizme (sul purismo) è appunto il titolo di un paragrafo di Kul’tura jazyka, all’interno del capito-lo Jazyk byta (la lingua del byt). Cfr. ivi, pp. 62-84.
4 Lo studioso fa riferimento alle discussioni sollevate dall’articolo di Sergej Iosifovic ˇ Karcevskij, Chal’tura, in « Poslednie Novosti », Pariž, 3 fevralja 1922, analizando vari tipi appunto, di « chal’tura », cioè di cultura dozzinale, scadente, che alcuni intellettuali del tempo denunciano come forza che sta travol-gendo la Russia. 5 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., pp. 83-84.
stefania sini88
mente anche il pensiero linguistico. Crisi che le maggioranza della popolazione (širokoe obšcestvo) non vive con precisa consapevolezza, ma di cui percepisce gli esiti di rinnovamento.
A essa deve bastare che la nuova epoca nella scienza linguistica, nella quale siamo indub-biamente entrati, toglie il pensiero scientifico dagli schemi morti e lo porta verso la parola viva come strumento di comunicazione e interazione sociale ; circonda nuovamente la linguistica con l’atmosfera familiare, materna della filologia. E la filologia ricorda che la parola è il prototipo di tutta la cultura spirituale : essa avvicina il lavoro specialistico della linguistica agli interessi sociali e di cultura generale nel campo della lingua. 1
Anche Vinokur mostra dunque di vivere quella crisi dei fondamenti che percorre l’episteme tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecendo acuendosi in parti-colare dopo la Prima Guerra mondiale. La sollecitudine pragmatica intorno alle questioni di lingua va in lui di pari passo con una riflessione più generale riguar-do ai destini della scienza e ai suoi princìpi, risolvendosi in impegno civile. « La domanda sulla possibilità di una politica linguistica » viene così ricondotta « so-stanzialmente alla domanda sulla possibilità di un rapporto cosciente, attivo e organizzato della società nei confronti della lingua in quanto tradizione sociale » il quale si traduce, a sua volta, nell’idea di una stilistica della vita quotidiana (byto-vaja stilistika) ». 2 Un programma, questo, che deve affrontare un territorio come l’Unione Sovietica, abitato da innumerevoli popolazioni non russofone e dunque con una ‘questione della lingua’ di proporzioni immense.
È interessante osservare, peraltro, che a un telos così ambizioso corrisponda una costruzione teorica innervata, isomorficamente, dalla medesima logica del fine. Se, infatti, la stilistica puristicamente atteggiata indirizza nella scelta fra le varie possibilità espressive offerte dalla lingua, queste molteplici possibilità sono tutte governate secondo Grigorij Osipovic dal loro specifico obiettivo. Quando in una data situazione « l’istinto stilistico » adopera un vocabolo piuttosto che un altro –poniamo « automobile » invece di « macchina » – ciò accade perché ciascuna enunciazione è presieduta da uno scopo. Il purista deve allora aiutare i parlanti a districarsi consapevolmente nel fitto tessuto di corrispondenze e relazioni fra ri-sorse linguistiche e scopi. Anche Vinokur, dunque, come Jakobson, e come molti rappresentanti del pensiero russo primonovecentesco, fonda la sua riflessione su di un rilevante impianto teleologico. 3 « Per ogni fine », ribadisce lo studioso, « i propri mezzi (dlja každoj celi – svoi sredstva) : tale deve essere lo slogan della società linguisticamente colta ». 4 E intanto, mentre espone il suo credo finalistico, mostra di non disdegnare uno stilema caratteristico del suo tempo : lo slogan, appunto, con cui il purista sovietico non può non fare i conti.
1 Ivi, p. 62. 2 Ivi, p. 106.3 A questo proposito Peter Steiner parla di « stylistic norms, each governing one particular type of
goal-oriented verbal behaviour ». Cfr. Steiner, Russian Formalism, cit., p. 211. Sulla forte componente teleologica riscontrabile nel pensiero jakobsoniano e nell’idea di opera come intero propria di più di un esponente del metodo formale, mi sono soffermata in L’intero irrequieto. Sulla poligenesi dell’idea struttu-rale nel pensiero russo del primo Novecento, in « Enthymema » ii, 2009, pp. 190-228.
4 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 85.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 89
5. fraseologia sovietica
Una questione cardine nell’economia del lavoro vinokuriano, sulla quale il lingui-sta tornerà spesso nei capitoli successivi di questo saggio e nelle opere successi-ve, 1 è rappresentata infatti da ciò che Bally ha denominato locutions toutes faites : « quelle formule, quegli elementi fissati della fraseologia, gli slogan, le massime (krilatye slova : letteralmente parole alate) ecc., che recano sempre con sé le tracce, per così dire, della loro origine stilistica, cioè che abbelliscono il contenuto da loro significato con la specifica atmosfera di quella concreta situazione di quotidianità sociale per la quale l’uso discorsivo tradizonale le ha consolidate ». 2
Preso atto della massiccia crescita dei clichés verificatasi negli ultimi tempi, non si tratta ora, afferma Vinokur, di mettere al bando tali stampi, ma di verificare che i parlanti li sappiano usare nella situazione appropriata (dunque coerentemente con il loro scopo), « che per esempio in una composizione scientifica non figurino stereotipi della conversazione da tavola ». 3
La fraseologia che pullula nella lingua della Rivoluzione prima, e del periodo della Nep poi, costituisce un problema concreto e immediato di politica linguisti-ca, e nello stesso tempo pertinente più di altri alla riflessione sullo stile. 4 « La fra-seologia », infatti, « è una questione stilistica per eccelenza ». Se lo stile è qualcosa di tipico e caratteristico di un dato discorso individuale, « una condizione perché qualcosa sia tipico e caratteristico è la ripetibilità ». Quando la ripetitività perde il suo senso creativo e diviene convenzionale, ecco che ci troviamo davanti all’ossi-ficazione e alla formularità. Per Vinokur la questione riguarda in prima istanza il lessico : « La fraseologia non è la composizione del discorso, ma la sua fabula e il suo tema ». Trattandosi di aspetti lessicali – di « forme indivisibili sintatticamente » – vi si possono attuare interventi diretti di politica linguistica più facilmente che in altri settori della lingua.
Vi sono molte varietà fraseologiche in correlazione con altrettanti stili : si può per esempio tracciare una distinzione concernente « la sfera dell’appartenenza so-ciale (fraseologia dell’individuo, della classe, del ceto, fraseologia individuale e di gruppo), o nella sfera delle funzioni sociali (fraseologia medica, del lavoro arti-stico, fraseologia erotica, scientifica, politica ecc.) ». 5 In questa massa enorme di possibilità, Vinokur analizza gli slogan rivoluzionari, molti dei quali hanno un’ori-gine ben precedente. Spesso, osserva, lo studioso, erano formule già consunte da tempo, le quali nel clima di palingenesi che ha coinvolto tutte le sfere della vita hanno acquisito nuova freschezza. Ricorda lo studioso non senza una leggera no-ta di commozione :
1 Cfr. infra, par. 6. Stili veloci. 2 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 58.3 Ivi, p. 59. Ecco emergere dalle ceneri della rivoluzione la fenice della veneranda tradizione retorica :
questa rispondenza allo scopo non pare molto diversa dalla classica virtù dell’aptum.4 In questa sezione, intitolata Jazyk Nepa (la lingua della Nep, Vinokur si interroga sulla « lingua della
rivoluzione e rivoluzione della lingua », con rinvio al saggio Karcevskij, Jazyk, vojna i revolucija [La lingua, la guerra e la rivoluzione], Berlin, Russkoe universal’noe izdatel’stvo 1923.
5 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., pp. 112-113.
stefania sini90
Nell’atmosfera della lotta sociale che ardeva e dei fronti esterni che si smantellavano non si poteva passare tranquillamente vicino a un manifesto che gridava :
La religione è l’oppio dei popoli !Pace alle capanne, guerra ai palazzi !Abbasso la guerra imperialistica !Il lavoratore non ha niente da perdere tranne i suoi ceppi !Evviva l’autodeterminazione dei popoli !
In altre parole, tutta questa fraseologia dei circoli sotterranei è diventata improvvisamen-te un’acquisizione comune : echeggiava al fronte, dove se ne appropriava un esercito di milioni di soldati, arbitro dei destini della rivoluzione ; ha voluto comparire sotto la penna del peredovik [ lavoratore di avanguardia], suscitava rabbia in alcuni e ispirava altri. Si è trasformata in argomento del giorno, impossibile non accorgersene. 1
In sostanza, ci suggerisce Vinokur, la fraseologia ha smesso a quel punto di essere fraseologia. Come una metafora logora che si rivitalizza, che vede di nuovo im-pennarsi il suo tasso di figuralità, questo patrimonio discorsivo ha acquisito vita proprio perché ha preso corpo, esistenza, storia. Certo, un ruolo fondamentale nella fortuna di cui hanno goduto questi slogan è svolto proprio dalla loro for-ma, « caratterizzata da una densa, enfatica intonazione esclamativa, da una me-lodica monotona ma tenace, da una sintassi azzeccata (tendenzialmente senza verbo) ». 2
Eppure giunge il momento in cui tale freschezza si perde ancora una volta. 3 Questo accade in forza della natura stessa della fraseologia, a causa della sua pro-prietà costitutiva, vale a dire la ripetibilità.
Osserviamo innanzi tutto che il senso di una parola può essere compreso solo fino a che la sua forma è viva e attiva. Quando la forma della parola smette di essere percepita in quanto tale, non colpisce la percezione, ecco che anche smette di giungere alla coscienza. La parola viva si trasforma in nome, in etichetta. 4
Qui salta subito agli occhi l’appartenenza di Vinokur a un sistema culturale domi-nato dall’« assiologia del nuovo », 5 dalla dialettica di automatizzazione e strania-mento resa celebre da Šklovskij ma descritta anche da Tynjanov e da altri formalisti russi. A un certo momento, dichiara il noto opojazovec, non si vedono più le cose, « ma soltanto la loro superficie ». « Per influsso di tale percezione, l’oggetto si ina-ridisce, dapprima solo come percezione, ma poi anche nella sua riproduzione ». 6
1 Ivi, pp. 113-114. 2 Ivi, p. 114.3 Vinokur ricorda che queste pagine sono state scritte nel 1923.4 Ivi, p. 115. A proposito delle modalità con cui la ripetizione può automatizzare l’associazione e inde-
bolire la forza delle impressioni ad essa legate, lo studioso rimanda a Bally Le langage e la vie, cit.5 Cfr. Franco Brioschi, Assiologie della modernità, in Idem, Critica della ragion poetica e altri saggi di
letteratura e filosofia, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 32.6 Viktor Borisovic ˇ Šklovskij, Iskusstvo kak priëm, « Sborniki po teorii poèticeskogo jazyka » [Rac-
colte di teoria del linguaggio poetico] », Vyp. II, Pg, 1917, poi in O teoriji prozy (Teoria della prosa), Mo-skva, 1929, pp. 7-23. Trad. it di Cesare de Michelis e Renzo Oliva, L’arte come procedimento, in Todorov (a cura di), I formalisti russi, cit., p. 81.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 91
È quanto sta accadendo appunto con gli slogan tanto vivi durante la Rivoluzio-ne :
Si può dire senza esagerazione che per l’orecchio che aveva ascoltato le cannonate di Ot-tobre, questa fraseologia non è altro che un insieme di suoni insensati. 1
In queste pagine, inoltre, lo studioso ricorda la lotta acerrima contro il linguaggio ossificato delle formule e degli stereotipi intrapresa dallo stesso Lenin. E qui vale la pena di notare il rinvio in nota ai lavori di Èjchenbaum, Šklovskij, Jakubinskij e altri, dedicati appunto a Lenin, nel numero 1 di « Lef » del 1924. Il rinvio non solo costituisce un’ulteriore conferma del carattere anfi bio di questo libro vinokuria-no, in bilico tra l’esperienza futurista-formalista e la sua abiura, ma evoca anche i contorni ampi dello spazio occupato dalla stilistica russa in questo periodo, disci-plina cui anche gli opojazovcy contribuiscono in maniera significativa, a comincia-re da Boris Èjchenbaum. 2
Tornando al problema degli slogan, vediamo come Vinokur, nell’esaminare attentamente il processo del loro inesorabile scolorimento, ne avverta le conse-guenze : « Se si trattasse soltanto di “eufonia” o di lingua “bella”, come possono pensare alcuni, allora forse non varrebbe la pena di occuparsi di tale questione. Ma il punto è che dietro questo immiserimento verbale, dietro questa caduta ca-tastrofica della nostra valuta linguistica, è racchiuso un pericolo sociale ».
una volta che nella nostra quotidianità politica e sociale adoperiamo slogan ed espressioni che hanno perduto il loro senso e la loro destinazione, allora anche il nostro pensiero diventa mostruoso, senza significato. Si può pensare per immagini, si può pensare per ter-mini, ma è forse possibile pensare con stampini lessicali, i quali, nonostanti siano diventati clichés, continuano a pretendere di avere espressività e forza sulle impressioni ? 3
Evidentemente, si tratta di una domanda retorica. La conseguenza catastrofica di un’assuefazione espressiva di tal sorta è secondo Grigorij Osipovic la possibilità non remota che si smetta di pensare, lasciando che siano i clichés a parlare per noi. E che il mondo delle cose si trasformi in un mondo di nomi. 4 Ecco perché la que-stione della fraseologia deve essere posta in connessione con il generale problema della cultura della lingua. « Un discorso abilmente costruito, un rapporto attento e amorevole nei confronti della parola nelle sue diverse funzioni, portano con sé come risultato anche un corretto uso degli stampi verbali. In particolare, proprio
1 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 116.2 Sull’appartenenza di Boris Michajlovic alla grande stagione della stilistica europea, e su qualche
cenno alla sua analisi dello stile oratorio di Lenin (Oratorskij stil’ Lenina) pubblicata su « Lef » nel 1924, mi permetto di rinviare a Stefania Sini, Di nuovo sul formalismo russo. Boris Èjchenbaum critico letterario e storico della letteratura, « Letteratura e letterature », 3, 2009, pp. 13-36.
3 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 121.4 Ci troviamo di fronte a una tematica assai ricorrente nella storia letteraria e del pensiero : la paura,
più o meno motivata, degli stereotipi, la lotta contro i clichés che contagia intere generazioni di poeti e scrittori, e, all’opposto, la reazione difensiva che si scatena – e che conduce spesso a una rivalutazio-ne della retorica – sono state oggetto di numerosissime espressioni, saggisitche e creative. Possiamo menzionare, per esempio, Jean Paulhan, Les fleurs de Tarbes, ou la terreur dans les lettres (1936), Paris, Gallimard, 1945. Trad. it. a cura di Dora Bienaimé, Genova, Marietti, 1989.
stefania sini92
qui bisogna imparare dalla letteratura ». Il linguista militante trova ora un aiuto prezioso nel lavoro dei poeti : « e ciò significa tra l’altro che la politica linguistica può imparare dalla poesia, come dalla più alta manifestazione della cultura della lingua ». 1
Un esempio fra tutti, Vladimir Majakovskij, di cui Vinokur cita alcuni memo-rabili versi.
Marciatecosìkomsomol’cyperché al cielotintinni l’orecchio 2
E commenta : « I suoi versi sono slogan pronti e vivi » (il che, ci fa notare in una nota aggiunta all’edizione del 1929 di Kul’tura jazyka, trova conferma nel fatto che in alcune fabbriche di Mosca si siano diffusi e siano stati effettivamente usati come slogan proprio questi versi del poeta futurista citati nella prima edizione. Insomma, l’aveva vista giusta).
Alla possibile ovvia obiezione secondo cui la poesia majakovskiana è intrisa da una valenza politica apriori e costruita con esplicita finalità oratoria, e che dunque l’esempio risulta di scarsa efficacia, lo studioso precisa che un lavoro di sostegno alla politica della lingua può essere svolto anche da espressioni poetiche ben di-verse, sia rispetto al genere che al valore letterario. Qui, gli preme sottolineare, ciò che conta non è la considerazione della poesia come arte verbale, ma « come forma stilisticamente qualificata, come manifestazione di una tecnica del discorso al-tamente sviluppata ». 3 Prima, e anche al di là, del giudizio estetico, l’educazione linguistica passa attraverso la consuetudine con la maestria artigianale, con il la-voro sulla parola attraverso l’esplorazione rigorosa delle possibilità espressive e la messa a punto delle tecniche adeguate allo scopo. Così, a tal proposito, Vinokur prospetta un tirocinio che contempli anche la scrittura in versi, in quanto eserci-zio inscindibilmente stilistico e politico. 4
6. Stili veloci
Fra i vari fenomeni che possono confermare l’ipotesi di una rivoluzione della lin-gua, il più interessante è secondo Vinokur quello delle abbreviazioni (sokrašcenija) adoperate per indicare istituzioni e uffici dell’epoca postrivoluzionaria e sovietica, le quali conoscono una straordinaria fioritura nell’epoca della Nep. Esse sono a tal punto attecchite nelle abitudini linguistiche dei parlanti da venire considerate
1 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 125.2 Vladimir Vladimirovic ˇ Majakovskij, Naše voskresenie (La nostra domenica), « Izvestija Vcik » n.
77, 7 aprelja 1923, in Polnoe sobranie socinenij v 13 tomach, T. 5, Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1955-1961 : « Šagajte, / da tak, / komsomol’cy, / ctob u neba zvenelo v uche ! » vv. 77-80. Trad. it. in Majakov-skij, Opere. I. Poesie 1912-1923, a cura di Ignazio Ambrogio, Roma, Editori Riuniti, 1980(3), pp. 299-301(dove i versi si traducono :« Marciate / giovani comunisti / ma in modo / che al cielo gli rintroni l’orecchio »
3 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 126. 4 Ibidem.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 93
come parole ordinarie. Anche a questo riguardo lo studioso cita Majakovskij, che nel 1922 aveva dedicato un poema satirico alla deriva burocratica della società co-munista, con alcuni versi esplicitamente rivolti al linguaggio sintetico delle nuove sigle.
Kto v glav,Kto v kom,Kto v polit,Kto v prosvet,Raschoditsja narod v ucreždenija. 1
Che tale invasione terminologica abbia esercitato un impatto oltremodo rilevante sulla vita verbale del popolo russo è un fatto noto. 2 Secondo Vinokur il fenome-no rappresenta un mutamento linguistico la cui portata ha non solo una grande estensione quantitativa ma anche importanti effetti qualitativi, in profondità. Il processo di formazione di queste parole, infatti, « fuoriesce dall’ambito del lessi-co in quanto tale ; nella lingua compaiono delle nuove relazioni (otnošenija). L’ab-breviatura è proprio una relazione, e non solo una estetica nomenclatoria, senza contare il fatto che nei limiti della sua organizzazione, l’abbreviatura si costruisce perfino secondo insoliti e originali principi grammaticali. E se è così, allora non c’è dubbio che “lo spirito della lingua” in qualche modo sia stato toccato dalle ab-breviazioni, che il sistema dei rapporti significativi nella lingua russa abbia vissuto una qualche “svolta”, un rinnovamento ». 3
Le abbreviature sono pertanto suscettibili di valutazione stilistica nel bene e nel male, di un’analisi « dal punto di vista della tecnica del discorso ». Lo studioso esplora allora la variopinta fenomenologia di queste forme mostrando come prendano corpo e in base a quali criteri linguistici : per esempio, egli spiega, la costruzione di molte di esse avviene per ragioni ritmico-fonetiche, con una preponderanza di voci trisillabiche. 4 In ogni caso, si tratta per lo più di parole coniate per esigenze di sintesi, dunque di rapidità comunicativa, in consonanza con un mondo soggio-gato dall’imperativo della velocità.
Costitutivamente veloce è anche lo stile della lingua dei quotidiani a cui Vino-kur dedica un denso capitolo. 5 È questo un tema caro allo studioso, che ne può discutere con la competenza derivata dall’esperienza diretta, avendo lavorato co-me traduttore e redattore alla Tass. 6
1 Majakovskij, Prozasedavšiesja, in « Izvestija Vcik », n. 52, 4 marta 1922, in Polnoe sobranie socinenij, cit., Tom. 4 : « Chi al Glav, / chi al Kom, / chi al Polit, / chi al Prosvet, / la gente si sparpaglia negli uffi-ci ». Trad. it., La mania delle riunioni, in Majakovskij, Opere, cit., pp. 196-198.
2 Possiamo da parte nostra ricordare alcune pagine coeve, e di tono non dissimile da quello majako-vskiano, di Michail Bulgakov. Cfr. Michail Afanas’evic ˇ Bulgakov, Zapiski na manžetach, in « Naka-nune », 18-6-1922, poi in Idem, Cµaša žizni. Povesti, rasskazy, p’esa, ocerki, fel’etony, pis’ma [racconti lunghi e brevi, opere teatrali, saggi, feuilleton, lettere], predisl. B.V. Sokolov, Sost., podgot. teksta i komment. B.S. Mjagkov, B.V. Sokolov, Moskva, Sovetskaja Rossija, 1988, pp. 220-221.
3 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., p. 89. 4 Ivi, pp. 91 ; 96.5 Jazyk pressy (la lingua della stampa), articolato in 1. Jazyk gazety (La lingua del giornale) ; 2. Jazyk
tipografii (La lingua della tipografia) ; 3. Literaturnaja gramota (Alfabetizzazione letteraria). Cfr. ivi, pp. 127-201. 6 Telegrafnoe Agenstvo Sovetskogo Sojuza : ecco subito un’altra sigla !
stefania sini94
Se la lingua scritta, rispetto a quella parlata, si caratterizza per un « orientamen-to eminentemente grammaticale (grammaticeskaja ustanovka) e non lessicale », « nel linguaggio del quotidiano », scrive Vinokur, « questo orientamento verso i mezzi grammaticali della lingua diventa specificamente acuto e astratto. 1 L’organizza-zione grammaticale è qui eccezionalmente imperativa e incalzante. Perciò i li-miti di tale organizzazione sono oltremodo angusti, e la libertà creativa viene soffocata ». 2 Ne rappresentano esempi lampanti gli annunci telegrafici pubblicati sulla stampa, dove la compressione degli schemi grammaticali è condotta ai limiti estremi.
Tale attitudine, per così dire, ‘grammaticalizzante’ si spiega da una parte con la fondamentale esigenza informativa e commentativa propria del quotidiano, ma anche con le specifiche condizioni sociali in cui si colloca la scrittura stampata e che ne definiscono il compito stilistico.
Non svolgendo alcuna funzione artistico-poetica, adempiendo a mansioni rigi-damente ed elementarmente informative, rivolgendosi a un numero enorme di acquirenti-consumatori – ricordiamo fra l’altro che le tirature editoriali sovietiche raggiungono cifre incommensurabili rispetto a quelle di altri paesi europei – dal-le competenze e consuetudini eterogenee, il quotidiano usa una lingua sostan-zialmente preconfezionata, che attinge a forme standard e stereotipate. Se alle condizioni suddette si aggiunge il ritmo rapido dell’edizione – « che consente di costruire corrette analogie con la produzione industriale » – ci si rende conto di quanto tutti questi fattori portino inevitabilmente a una lingua meccanizzata.
Ecco che « i tipi abituali e fondamentali dell’informazione del quotidiano (tele-gramma, intervista, cronaca, la maggior parte degli editoriali) sono costruiti su modelli già pronti, condizionati da stampini discorsivi già fatti nel processo della produzione del giornale, da formule coniate e già a disposizione, da clichés » ac-cumulati in una sorta di provvista verbale simile a quella dei caratteri tipografici variamente combinabili a seconda delle esigenze del momento. 3
Ciò si manifesta, scrive Vinokur, soprattutto nel lessico, dove le parole diventa-no termini : « La lessicologia del giornale è una terminologia sui generis » :
Nella lingua del giornale manca proprio ciò che costituisce la base della poesia, la quale ci permette di sentire ogni parola di nuovo (ošcutit’ každoe slovo zanovo), come se la ascoltassimo per la prima volta. 4
Ancora una volta l’argomentazione di Vinokur lascia trapelare l’‘aria di famiglia’ che ha respirato con la frequentazione dell’avanguardia futurista e del formali-smo, dove vige l’estetica del nuovo quale criterio di misura nella considerazione dei fenomeni di linguaggio. Sta di fatto però che nel caso del quotidiano non vi
1 Cfr. ivi, p. 129. 2 Ivi, p. 135.3 Ivi, pp. 138-139. Il linguista offre una ricca esemplificazione su cui qui non è possibile soffermarsi.
Passa in rassegna tutti gli strati della lingua mostrando, fra l’altro, come l’uso stereotipato di certi mo-duli argomentativi (v samon dele, nado polagat’, po ètomu povodu) (« in realtà », « bisogna ritenere che », « a questo proposito ») conduca al loro svuotamento semantico e li trasformi da elementi lessicali a forme grammaticali sui generis, segnali sintattici per passaggi, attacchi, pause. 4 Ivi, p. 140.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 95
è nulla da eccepire se la lingua si compone di automatismi. Qui, afferma Grigorij Osipovic, abbiamo a che fare con degli « stampini al loro posto », cioè con una situazione in cui « il parlante sa che sta parlando proprio a stampini, con desi-gnazioni puramente convenzionali e non presuppone dietro di esse alcuna forza espressiva ». 1 Insomma, senz’altro si tratta di stereotipi, ma comunque funzionali alla produzione dei testi e alla loro ricezione, come del resto ha intuito anche Vos-sler : « Gli stampi spuntano e sono opportuni laddove si pone il fine pratico di una trasmissione pratica e vera – nel senso della neutralità – di un dato fatto. 2
Come possiamo notare, l’argomento sta molto a cuore a Grigorij Osipovic ˇ, che ne scevera i molteplici aspetti e non si ferma a rilevarne i tratti più vistosi. Se anche nella ripetitività della lingua dei generi testuali a stampa, non diversa-mente da quella degli slogan, 3 ravvisa il pericolo di dissanguamento espressivo e soprattutto cognitivo, egli non manca d’altra parte di ricordare la pervasività del cliché nella lingua letteraria e di notare come la Poetica di Veselovskij sia quasi in-teramente costruita sull’idea delle « formule fisse ». Da studioso di poesia Vinokur è ben consapevole del fatto che la ripetizione è strutturale nel momento in cui si configura come schema metrico ; da storico della letteratura sa inoltre bene che i topoi costituiscono la riserva aurea della tradizione letteraria classica, di prosa, poesia ed eloquenza. 4
Al suo sguardo attento di linguista e filologo, novità e ritorno dell’uguale si fronteggiano in un bilico oscillante ma non vizioso, anzi, altamente produttivo.
7. Caratteri
Resterebbero ancora da trattare almeno due questioni fondamentali per la stili-stica di Vinokur : la sua analisi della « lingua della tipografia » e la sua idea di una « stilistica biografica ».
Alla prima questione è dedicato il secondo paragrafo del capitolo di Kul’tura jazyka sulla lingua della stampa ; 5 alla seconda un libro autonomo, uscito nel 1927 nelle collane della GAChN. 6
Riservandoci di occuparcene in modo disteso in altra sede, ci limitiamo qui ad alcune brevi considerazioni che possano servire anche da riepilogo di quanto vi-sto nel presente lavoro. Nonostante fra il primo e il secondo saggio intercorra una vera e propria svolta nell’itinerario scientifico ed esistenziale di Grigorij Osipovic ˇ,
1 Ibidem. 2 Ivi, p. 146, con riferimento a Vossler, Sämtliche Aufsätze, cit., § 249.3 Cfr. supra, par. 5. Fraseologia sovietica.4 A tali considerazioni potremmo aggiungere l’interessante esempio italiano del noto saggio di Pier
Luigi Beccaria L’autonomia del significante (1975) : considerato da molti una sorta di manifesto della cor-rente strutturalistico-semiologica, questo lavoro è tutto costruito sull’idea della memoria, nello specifi-co ritmica, e dunque della ripetitività formulare dei moduli metrici : nulla di più classicistico, almeno da un certo punto di vista. Aggiungiamo poi il carattere topico acquisito dal titolo del saggio di Beccaria, e ci troviamo di fronte a un caso di bilico teorico analogo a quello in cui si trova Vinokur. Cfr. Pier Luigi Beccaria, L’autonomia del significante. Figure del ritmo e della sintassi. Dante, Pascoli, D’Annunzio, Torino, Einaudi, 1997. 5 Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., pp. 167-181.
6 Idem, Biografija i kul’tura [biografia e cultura],Moskva, Gachn, 1927, ora Moskva, lki, 2007 (Izd. 2-e, ispr. i dop., predisl. V. A. Vinogradov).
stefania sini96
nonostante le tematiche differenti, a leggerli dopo quasi un secolo dalla loro com-posizione, alla luce dell’opera successiva dello studioso, essi mostrano di far parte del medesimo progetto esposto in Cultura della lingua.
Si tratta in entrambi i casi di una riflessione teorica che non perde mai d’occhio le ricadute pratiche dei problemi studiati : da una parte il concreto lavoro editoria-le con le esigenze di produzione, trasmissione e comunicazione ; dall’altra l’idea della strutturazione della biografia (strukturirovannost’ biografii), « nella quale, pe-rò, solo convenzionalmente è possibile delimitare la forma esterna dal contenuto interno », 1 dal momento che il vissuto (pereživanie) dell’individuo risulta inscindi-bile dalla storia in cui viene a collocarsi.
Scrivendo di questioni relative all’iconismo dei caratteri tipografici e del lin-guaggio verbale, Vinokur non soltanto si inoltra sulla strada delle ricerche semi-otiche e dell’estetica delle arti, ma dischiude altresì il campo d’indagine che sarà proprio delle ricerche secondonovecentesche sul paratesto, anche delle più recen-ti. 2 Nello stesso tempo egli guarda ai lettori dei giornali e alle abitudini stilistiche che a loro derivano dalla frequentazione con la stampa.
Non diversamente, studiando la biografia come analisi dello stile del comporta-mento di una personalità osservata all’interno di un momento storico preciso, il linguista russo esercita il metodo stilistico approntato e rodato nei suoi lavori pre-cedenti e giunge a interpretare stili e maniere come espressioni inscindibilmente singolari e sociali. 3
Senza dubbio l’uscita dal Lef, le aspre critiche scagliate contro Èjchenbaum e Jakobson e l’adesione ai lavori della GAChN e al pensiero fenomenologico, poi ermeneutico, di Špet si collocano nel segno della cesura, cui d’altra parte gli stessi formalisti hanno ampiamente reagito. Al di là delle molteplici differenze teoriche,
1 Ivi, p. 26.2 In particolare nel paragrafo dedicato alla funzione semantica dei titoli (Zagolovok – ego smyslovaja
funkcija) Vinokur rileva che « Il carattere del contenuto comunicato, il suo tipo semantico, viene trasmes-so proprio grazie alle forme spaziali del carattere ». Analizzando titoli dei quotidiani, ne mostra poi la « funzione pubblicitaria » (reklamnaja funkcija) giungendo ad estenderla al linguaggio nel suo complesso. Osserva anche l’abuso dei caratteri cubitali da parte della stampa sovietica, soprattutto nei sottotitoli, e fa notare che il sottotiolo riveste un ruolo diverso da quello del titolo. Vinokur, Kul’tura jazyka, cit., pp. 177-179. Insomma, lo studioso russo sembra qui prospettare quella titrologie pensata da Harald Weinrich (che tra l’altro riflette sul valore funzionale dei titoli) quale ramo della linguistica testuale che studia i titoli in particolare letterari, ma non esclusivamente. Cfr. Harald Weinrich, I titoli e i testi, in Michele Prandi - Paolo Ramat, Semiotica e linguistica. Per ricordare Maria Elizabeth Conte, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 49-67. Cfr. anche Michele Cortelazzo (a cura di), Il titolo e il testo (Atti del xv Convegno Interuniversitario, Bressanone 1987), a cura di M. A. C., Padova, Programma, 1992.
3 Compito del biografo è per Vinokur quello di « chiarire la maniera del dato personaggio, lo stile particolare del suo agire ». L’elemento da prendere in considerazione sono le forme espressive del com-portamento (èkspressivnye formy povedenija), le quali « acquisiscono il significato di forme stilistiche », « in conseguenza delle quali compaiono differenti stili di vita personale : il sognatore, il giocatore, il ribelle, il gentleman ecc. ». Oltre agli stili vi sono poi le stilizzazioni, come il dandismo. Insomma, « tutti quei tratti con cui solitamente si caratterizza lo stile, per esempio, in qualunque arte, possono essere trasfe-riti pienamente anche alla sfera della biografia ». Vinokur, Biografija i kul’tura, cit., pp. 48 ; vii. Sulle varie accezioni del concetto di stile e in particolare sul doppio versante, individuale e sociale (entrambi, come abbiamo visto, presenti nella trattazione di Vinokur), cfr. Antoine Compagnon, Il demone della teoria. Letteratura e senso comune (1998), trad. di Monica Guerra, Torino, Einaudi, 2000, pp. 179-211.
i caratteri dello stile e lo stile dei caratteri 97
per esempio rispetto al ruolo conferito alla linguistica, tra Vinokur e Èjchenbaum, e tra il primo e il secondo Vinokur, circola una inconfondibile aria di famiglia, sulla quale sarà necessario tornare.
Ciascuna delle discipline filologiche studia il suo oggetto nella storia. Il filologo è sempre storico, e solo in un secondo momento noi chiediamo di quale storia si occupi, se della storia del diritto, della lingua, o della vita personale. In tal modo in generale la filologia ha un oggetto, la storia, cioè quel contesto onnicomprensivo e collegato dal quale noi deri-viamo soltanto le nostre singole storie separate, che non perdono mai la comunanza con la propria origine. 1
1 Vinokur, Biografija i kul’tura, cit., p. 71.