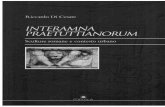Ulivi e architettura rurale in Terra di Bari, in "De bono oleo claro de olivo extracto' a cura di...
Transcript of Ulivi e architettura rurale in Terra di Bari, in "De bono oleo claro de olivo extracto' a cura di...
LA CULTURA DELL,OLIO NELLA PUGLIA MEDIEVALE 59
Ulivi e architettura rurale in Terra di BariMaurizio Triggiani
A chiunque si accosti allo studio del patrimonio architettonico rurale in Puglia e in Terra di Bari accade sistematicamente di imbattersi in fonti e documenti relativi a chiese e insediamenti che citano terre coltivate a ulivo inerenti il ter-ritorio di pertinenza di questi siti. La documentazione storica ed economica molto spesso si accompagna alle notizie relative alle vicende architettoniche di tali insediamenti attraverso l’intero periodo medievale; altre volte accade che a un numero anche cospicuo di documenti e fonti scritte corrisponde una sorta di “deserto” di testimonianze materiali, e viceversa: continuano a resistere testi-monianze di insediamenti, chiese e masserie, delle quali è assai difficile trovare riscontri nella documentazione.
È questo, ad esempio, il caso di un sito estremamente affascinante: la chie-setta rurale di S. Basilio, in agro di Giovinazzo1 (fig. 1). Per questo piccolo gioiello dell’architettura rurale pugliese non vi sono documenti che attestino l’epoca di riferimento, né tanto meno caratteri e pertinenze. Eppure il legame tra la chiesa e gli ulivi, alcuni dei quali molto antichi, che la circondano, e che ne nascondono anche la vista, è evidente. Dinanzi a tanto contrasto, durante le mie ricerche ho sovrapposto tale contesto territoriale ad una carta di Magini riportata nell’Atlante storico di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni2, consta-tando come l’insediamento fosse parte di una vasta area da identificarsi con il
1 Per la scheda relativa a questa chiesa cfr. M. Triggiani, Insediamenti rurali nel territorio a Nord di Bari dalla Tarda Antichità al Medioevo, Bari 2008, p. 124 e relativa bibliografia.
2 G. A. Rizzi Zannoni, Carta del Regno di Napoli indicante la divisione delle 14 sue Province, Napoli 1807; G. A. Magini, Italia di Gio. Ant. Magini data in luce da Fabio suo figliuolo, rist. anast. Bologna 1974.
60 «DE BONO OLEO CLARO DE OLIVO EXTRACTO»
Padule di S. Staso, all’interno del quale ricadevano probabilmente, oltre alla chiesetta di S. Basilio, anche Torre S. Eustachio, che viene appunto riportata nella contrada «vulgo S. Staso»3. Partendo da tale presupposto è stato possi-bile rintracciare anche alcuni documenti che parlavano del casale di Padule in loco Celiano a partire dal 10324 e in seguito anche in età normanna e sveva sino al 1250 quando il casale venne distrutto dai saraceni5. Un documento angioino del 1270, invece, riporta come esistesse «campsoris clausurellam unam olivarum in via Ciliani ... terricellam unam in loco S. Angeli ... corrigiam unam olivarum in loco Paduli»6.
Spostando la nostra attenzione di qualche chilometro, verso Molfetta, ci si imbatte in un altro importante insediamento. «Abbas Pavo habet annua-tim de proventibus olivarum tar. viginti quinque»: tale estimo dei benefici del 1332, conservato nell’Archivio Vaticano ed edito da Domenico Vendola7, farebbe riferimento all’insediamento monastico medievale di S. Martino in Torre Forcata (fig. 2), nel territorio di Molfetta, che addirittura insisterebbe su un più antico «locus ubi dicitur page». Il riferimento ad un pagus potenzial-mente rimanda ad ampi discorsi sull’organizzazione territoriale in età romana e tardoantica ripresi dal sottoscritto e più recentemente da Elisabetta Todisco nel suo volume sui vici rurali8. Sono riferimenti di grandissima importanza su quella che potrebbe costituire un’eredità antica nell’organizzazione del ter-ritorio e richiamare ulteriormente la vocazione agricola delle aree presenti in Terra di Bari. Senza scendere troppo nei particolari di una riflessione scientifica di grande ampiezza, in cui il pagus è stato talvolta considerato come un’entità immateriale, fisicamente evanescente o, come affermava Claron, un «territorio
3 Triggiani, Insediamenti rurali cit., pp. 135-136 e relativa bibliografia.
4 Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo greco (939-1071), ed. F. Nitti, Bari 1900 [Codice Diplomatico Barese, IV], n. 21, a. 1032.
5 Le pergamene del Duomo di Bari (1266-1309), Appendice: Le pergamene di Giovinazzo, Canosa e Putignano sino al 1266, edd. G. B. Nitto de Rossi, F. Nitti [Codice Diplomatico Barese, II], Trani 1899, n. 19, a. 1254.
6 I Registri della Cancelleria angioina, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, XXI (1278-1279), ed. R. Orefice De Angelis, Napoli 1967, n. 153.
7 Rationes decimarum Italiae saecc. xiii-xiv. Apulia-Lucania-Calabria, ed. D. Vendola, Città del Vaticano 1939, 132, f. 108-116.
8 E. Todisco, I vici rurali nel paesaggio dell’Italia romana, Bari 2011.
LA CULTURA DELL,OLIO NELLA PUGLIA MEDIEVALE 61
evenemenziale»9, va comunque precisato come esso fosse una circoscrizione territoriale con funzione catastale e, in termini di popolamento, elemento uni-ficatore dal punto di vista amministrativo e culturale della popolazione sparsa delle campagne. E, come sappiamo, le nostre campagne erano sostanzialmente ricche di vigneti e uliveti.
Di tutto ciò oggi è difficile rintracciare i resti architettonici e le testimo-nianze legate a questo tipo di attività. S. Martino in Torre Forcata e S. Primo sono stati inglobati in uno sciagurato ampliamento urbanistico della città di Molfetta che proprio in quell’area ha permesso la realizzazione di un quartiere industriale e artigianale, che oltre a fagocitare i resti di tali insediamenti ne ha completamente stravolto il contesto economico e territoriale riducendoli a sem-plici feticci di una storia lontana10.
E di tali feticci culturali, cancellati oppure definitivamente alterati, occorre parlare anche a proposito dell’insediamento di Lucignano, oggi conosciuto come Masseria Madia Diana (fig. 3), in territorio di Modugno11. In questo caso fonti, documenti e testimonianze monumentali quasi si sovrappongono: le fonti notarili riportate nel Codice Diplomatico Barese parlano infatti di que-sto insediamento come di un casale ricco di proprietà terriere, quali vineali, uliveti e terreni produttivi che dall’xi sino al xiv secolo caratterizzavano que-sto luogo ed erano disputate da importanti famiglie baresi12. In seguito, in età moderna, Lucignano divenne una masseria di proprietà della famiglia Diana, che integrò le strutture più antiche (si parla addirittura di tre chiese nel periodo medievale) con gli edifici massariali ancora oggi parzialmente visibili (fig. 4). E parzialmente integre sono anche le strutture ipogeiche destinate nel tempo a essere utilizzate come frantoi e luoghi di produzione e conservazione di olive ed olio. Attualmente tutto questo sorge, paradossalmente, all’interno di un’area industriale dismessa. Infatti qui, in virtù di un cambiamento catastale di desti-nazione d’uso di questi terreni, da agricoli a industriali, ratificato nel 1992, tra il 1990 e il 2006 sorgeva lo Stabilimento Alco Palmera. Chiusa l’azienda, oggi
9 C. Claron, S. Roche, Vers une typologie des représentations spatiales, in «L’Espace géo-graphique», 1 (2001), pp. 1-12.
10 Triggiani, Insediamenti rurali cit., pp. 211-212 e relativa bibliografia.
11 Ivi, pp. 139-140.
12 Ibidem, anche per i riferimenti alle fonti.
62 «DE BONO OLEO CLARO DE OLIVO EXTRACTO»
l’intera area versa in condizioni di abbandono, non più ricordo di un’età passata, ma anche simbolo di un fallimento contemporaneo13.
Davvero interessante è la storia di molte strutture ipogeiche, strettamente legata alla produzione e alla conservazione dei prodotti derivanti dall’ulivo.
Poco distante dall’ipogeo Madia Diana ve ne è un altro, conosciuto come ipogeo Costantino. Qui, in un contesto territoriale poco diverso da quello di Madia Diana sorge un complesso ipogeico che Franco Dell’Aquila anni fa ricon-duceva addirittura a epoche precedenti quella medievale e dove ancora oggi si individuano strutture adibite a laboratorio per la lavorazione e la conservazione di prodotti vinicoli e oleari. Tracce di macine e frantoi sono ancora leggibili sul piano di calpestio e lungo le pareti superiori, dove rimangono gli alloggiamenti per le travi di legno a sostegno delle ruote e delle macine14.
Strutture adibite a tali funzioni si rintracciano, e sono minacciate da sciagu-rati interventi edilizi, in tutta la regione, da Bisceglie, con l’ipogeo e il frantoio di via Volta15, a Galatone, dove un antico frantoio ipogeo è stato demolito non più tardi di un anno fa16, ed è un elenco che potrebbe continuare.
Sin dall’età bizantina è attestato l’uso di ambienti scavati nel tufo per la lavo-razione e la conservazione dei prodotti oleari17. La prima notizia riportata dalle fonti in questo senso risalirebbe, secondo Dell’Aquila, al 1021 e farebbe rife-rimento al casale Vulpiclano18. Dalle notizie riportate nei documenti e dalle osservazioni delle strutture ancora esistenti si deduce quanto articolata fosse l’architettura di un trappeto, che si disponeva attraverso una serie di ambienti, tutti destinati a una specifica funzione, intorno ad una platea o spiazzo che fun-geva da luogo di smistamento per i differenti spazi.
L’importanza dell’ulivo e della produzione dell’olio secondo Dell’Aquila si afferma sin dall’epoca romana e riacquista una grande valenza anche economica in età bizantina e normanna tanto che l’unità di misura per l’olio utilizzata a
13 Vedi segnalazione di M. Triggiani sul sito www.pugliaindifesa.org.
14 F. Dell’Aquila, Bari. Ipogei ed insediamenti rupestri, 2 voll., Bari 1977; F. Dell’Aquila, F. Carofiglio, Bari extra moenia. Insediamenti rupestri ed ipogei, Bari 1985.
15 Vedi segnalazione sul sito www.pugliaindifesa.org.
16 Vedi segnalazione sul sito www.pugliaindifesa.org.
17 Dell’Aquila, Bari. Ipogei cit., vol. ii, p. 105.
18 Ibidem.
LA CULTURA DELL,OLIO NELLA PUGLIA MEDIEVALE 63
Bari, lo staio, viene introdotta anche in altre regioni, come la Sicilia. Lo stu-dioso sottolinea come i documenti medievali spesso indugino sulle proprietà di terreni destinati alla coltivazione dell’ulivo e annota come non ci sia una diffu-sione di grandi proprietà, bensì una sorta di parcellizzazione della coltura limi-tata a pochi ettari di terreno, sui quali insistevano alcune decine di piante di ulivo proprio per garantire una maggiore attenzione e una migliore qualità di produzione19.
Il locus Cillaro, oggi alle porte della città di Bari ma anticamente ubicato lungo le antiche strade che legavano il porto di Bari a Caeliae, è citato sin dal 942 e tra x e xi secolo sorgeva in un contesto territoriale fortemente caratterizzato dalla coltivazione di ulivi e viti (fig. 5). È importante inserirlo in questa breve e non esaustiva rassegna perché, come accade per Lucignano, Madia Diana, costituisce un esempio complesso sia dal punto di vista storico che da quello dell’articolazione dei luoghi e delle strutture legate alle caratteristiche produt-tive del territorio. Il locus, di cui davano notizia già qualche anno fa Dell’Aquila in un articolo pubblicato nella rivista «Nicolaus»20 e nei suoi scritti di Bari extra moenia e poi anche Raffaele Ruta21, si presentava agli occhi di questi stu-diosi come un sito composito, con una chiesa, un insediamento rupestre, in via Martinez, una cappella massariale in contrada La Vela, a ridosso della lama La Grava.
A tali testimonianze superstiti corrispondevano un numero consistente di informazioni desunte dalle fonti notarili e visite pastorali (a. 1507), che legavano il nome di questo possedimento alla cattedrale di Bari e ne sottolineavano il carattere rurale legato alle coltivazioni di vite e olivo. Qualche anno fa, in una zona poco distante da via Martinez e dalla contrada La Vela, in prossimità del Circolo Tennis Bari, in via Russo Frattasi, durante alcuni scavi archeologici a seguito di una sistemazione delle tubature esistenti in quella zona, vennero alla luce i resti di una struttura di fortificazione di età medievale, probabilmente una torre o una porta di accesso al casale. Ripercorrendo alcune mappe catastali pre-
19 Ivi, p. 106.
20 F. Dell’Aquila, Il casale di Cillaro e la chiesa di via Martinez, in «Nicolaus», 12, (1985), pp. 223-239.
21 R. Ruta, Bari e Torino: due casi di corrispondenza tra l’ortogonalità della configurazione urbana e la modellazione del paesaggio, in «Archivio storico pugliese», 45 (1992), pp. 31-64.
64 «DE BONO OLEO CLARO DE OLIVO EXTRACTO»
cedenti agli anni Settanta, quando l’intera area fu oggetto di interventi di edili-zia per la realizzazione di un quartiere residenziale, si scoprì che le stesse mappe conservavano l’indicazione, in quella particella, di due strutture antiche, che apparivano come due torri medievali disposte in modo non ortogonale tra loro, ma leggermente fuori asse. La toponomastica e le vecchie carte sembravano coe-renti con i resti rintracciati, i quali mostravano come i precedenti lavori avessero letteralmente attraversato i muri antichi per dar adito alle tubature di acqua e gas. Da un sopralluogo effettuato si comprendeva in modo abbastanza evidente che gli eventuali resti dell’altra torre riportata dalle carte doveva essere ubicata nella zona dove oggi è sistemato un giardino di accesso a una villa.
La rassegna potrebbe ancora continuare: scorrendo le fonti relative agli inse-diamenti rurali nel territorio a nord di Bari si ritrovano infatti documenti che rimandano alla coltivazione e alla produzione dell’ulivo relativamente a Giano, S. Aneta, S. Croce di Cagnano, Cesano, Sovereto, Torre Villotta e altri ancora. E per quanto concerne siti come Torre Villotta e Sovereto le testimonianze archi-tettoniche sopravvissute confermano gli atti notarili.
Un cenno lo merita di sicuro Torre Rufolo, nel territorio di Molfetta, che già Schäfer-Schuchardt poneva come sito di riferimento per quanto concerne lo strettissimo rapporto tra gli insediamenti rurali e la coltura dell’ulivo22. Tesi ulteriormente confermata anche da Raffaele Licinio a proposito delle masse-rie medievali, in questo caso angioine, che privilegiavano i possedimenti rurali come luogo non soltanto in grado di assicurare una rendita economica, ma anche come rifugi signorili23. È il caso, ad esempio, di Ruggero Rufolo, che nel 1307 scelse di edificare e fortificare questo luogo «per vivere quietamente». Il sito è stato oggetto negli ultimi anni di interventi della Soprintendenza, fina-lizzati non solo al restauro, ma anche a farne anche un museo dell’olio d’oliva. L’intento sembra aver dato ragione allo studioso tedesco, che si augurava con Torre Rufolo di aver restituito dignità e attirato l’attenzione sui trappeti medie-vali (fig. 6).
Non potrei concludere questo mio intervento sul rapporto tra i casali rurali
22 H. Schäfer-Schuchardt, Trappeti in Terra di Bari in età sveva e proto angioina, in «Studi bitontini», 47-48 (1989), pp. 187-198.
23 R. Licinio, Masserie medievali: masserie, massari e carestie da Federico ii alla Dogana delle pecore, Bari 1998.
LA CULTURA DELL,OLIO NELLA PUGLIA MEDIEVALE 65
e gli ulivi senza accennare al casale di Balsignano24, citato anche nel Chronicon di Domenico da Gravina (fig. 7). «Cum autem pervenit idem exercitus – l’e-sercito del conte Palatino – ad casale Blasignani…, in quo per horam modicam conquiscens, adaquantes equos suos propter calorem intensum»25, aggiunge-rei sotto gli alberi di ulivo che ancora oggi incorniciano il paesaggio di questo splendido sito medievale. Un cenno che è anche un augurio, dal momento che negli ultimi due anni collaboro con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, con l’architetto Pellegrino, ai lavori di restauro e musealiz-zazione di Balsignano, nell’intento di restituire questo pezzo di storia di Puglia alla sua dignità e di farne uno dei più estesi musei di età medievale di Puglia.
Ritengo sia importante concludere, infine, con una riflessione di Riccardo Francovich del 2001: «in Italia è stato studiato per anni soprattutto il territo-rio organizzato secondo due soli elementi, lo spazio insediativo ed il territorio relazionale, ma solo parzialmente il territorio utilizzato […] questo comprende il territorio insediativo e le altre aree di cui la comunità sfrutta le risorse ambien-tali […] ci occupiamo solo occasionalmente dell’impatto e delle trasformazioni che l’uomo opera sul paesaggio e del rapporto con le realtà ambientali ed i suoi mutamenti nel tempo»26.
Credo che per tutti gli interventi, le riflessioni, le indagini future, questo sia un imprescindibile punto di partenza.
24 Sul casale di Balsignano è attualmente in corso un intervento di restauro e musealizzazione diretto dall’arch. Emilia Pellegrino della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province Bari e bat con fondi europei e la partecipazione del Comune di Modugno. Per l’insediamento di Balsignano vedi Triggiani, Insediamenti rurali cit.; Id., La chiesa di S. Felice nel casale di Balsignano a Modugno (Bari), in Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del Seminario di Studi (Foggia, 12-14 febbraio 2004), a c. di G. Volpe, M. Turchiano, Bari 2005, pp. 387-403; E. Pellegrino, M. Triggiani, M. R. Depalo, M. Cioce, Un villaggio medievale scomparso in Terra di Bari: l’insediamento fortificato di Balsignano, in Atti del VI Congresso nazionale di Archeologia medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), a c. di F. Redi, A. Forgione, Firenze 2012.
25 Dominici de Gravina, notarii Chronicon de rebus in Apulia gestis, ed. A. Sorbelli [Rerum Italicarum Scriptores2, xii, 3], Città di Castello 1903-1909, pp. 118-119.
26 R. Francovich, Dalle ville ai castelli: un nuovo paesaggio umano, in Storia della Toscana. Dalle origini al Settecento, Roma-Bari 2004, pp. 55-71: 56.