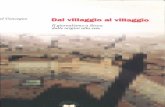Fuori e dentro l'ospedale. Bambine nel Quattrocento in Le bambine nella storia dell'educazione, a...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Fuori e dentro l'ospedale. Bambine nel Quattrocento in Le bambine nella storia dell'educazione, a...
C. Covato G. Di Bello M' FerrariR. Frasca A. GialLongo C. Pancera
M. Romanello L. Sandri S. Ulivieri
Le barnbinenella storiadell'educaziar,ea cura di Simonetta Ulivieri
@amr;I^dtazll
Indice del volume
Premessa di Situonetta'tiliuieri
Figure e vicende di barnbine romane di Rosella
Frasca
1. Puera, puella, pupa, pusa,.parva, pusilla, pullull part'u1a, infantula..., p.3 - Z. Claudia. I'esposta. p.b: )' PetoniaGiusta e 1e «puellae Faustinianae', p. 10 ,1 "Lome una ro-
sa, sbocciò . subito sfiorì", Augùstr, Srculina, Claudia.Anulina.... p. 14 - 5. Minicia Maicell.r, il ritratto de1 suopapà.Ia r.,r.o..r. p. 18 - 6. Virginia, la scoiaretta, p 22 -
i. À-r,r, e le altre L,rmbine di Vista, p.28 - Note' p )2
Tra immagini e gesti: la "scuola" delle bamhinenredievali cli Angela Giallongo1. La bambina ha una storia? , p.39 2 Dell'«infantia» e
della *pueritia» femn.rinile, p. + i 3. Le immagini sacre e le
bambiàe, p.46"4.,.Un santo corpicciuolo»' p. 49 - S Fravisioni e ircrime. p. )1 - o. I gesti come educazione ll mo-dello francese e italiano (secoli XIII-XV), p. 5o - 7. «Era nei
suoi atti assai leggiadretta .*. P. 58 8. Imprudenze infan-tiii. p, 59 q. U; esentpio di "bele et simp.le-continanee"'p rri tO. .Tempus ,r.,rli.bt".' Christine de Pizan. p. o2 -
j 1..Fredda e trmida.. p. o4 - No/e. p,67
Fuori e dentro l'ospedale' Bambinenel Quattrocento di Lucia Sandri
1. Un fenomeno sconcertante, p.75 ' 2. La salvezza delle
bambine, p.77 -). Bambineesiiagure, p. r-9'4' Speranze
39
369
75
{I
I
i
di vita fuori e dento l'ospedale, p. 81 - 5' Balie-e ba6!i!e:,ri,i.""*. arffi.it., p. 84^- 6. il pòsto delle bambine nel de-
ria"ri. aifigti, p é9 - 7.L'awio al lavoro, p. 93 - 8' Spose
con la dote, p.99 ' Note, P. 104
Essere bambine nel Cinquecento: modelli educativitra continuità e innov:azion e di Maina Romanello 1l t1. Selezione naturale o selezione ttculturale'?, p' 11 1 - 2' Un[Àoo o.. apDrendere: lnfanzia biologica e infanzia spiri-t"dà, p. ll7' -' 3. Un luogo per apprendere: casa, convento,
conservatorio. Ma non solo, p. 126 - 4' <<Buona cte rE >> e
".àtr-u-i -.tittianL>:
itineratì p.t .ppttndere un ruolo,p. L37 - Note, P. l4l
Itinerari pedaeosici dell'infanzia al femminile nelSeicerito alfa"corte dei Borboni di Monica Ferrari 149
1. Itinerari oedasogici al femminile nel Seicento, p' 149 - 2'i,irit.ti a.l dovérissere al femminile, p' 154 - 1' Le,prati-;À;;e;.;,i* merse it atto per le figliè di Enrico IV alla
corte di Francia nel primo Seicento, p' 161 - Nore, p' 180
Figlie del Settecento di Catto Pancera 189
1. La ricostruzione storiograhca, p' I89 - 2' I ruoli femmi-
"fi,;. i;ò - r. L^^onacZzionefàyata,p 191 - 4' II mer-
;;;;;.i-;niJe, p. t92 - 5. L'educaiione delle figlie,o.195 - 6. I1 controllo sociale, p' 198 - 7' La «natura tem-
ioitil.r. o. 202 - 8' L'istruzione femminile, p' 204 - 9'
L .d".urion" ul ruolo coniugale e ai valori famfiari, p' 206 -
Note, p.209
Educare bambine nell'Ottocento di Carmela Cooato 215
1. Una oremessa.p.2l5 - 2. Bambine immaginarie, p'218 -
3. Giovanette esemplari e bambine dillgenti,.P' 224 - 4' A
s.rrola. o. 229 - 5. Fuori dal recinto: lo studio come tra-
sgressione, P. 232' Note, P. 240
Le bambine tra galatei e ricordi nell'Italialiberale di Giulia Di Bello 247
1. Galatei e autobiografie, p. 247 - 2. L' rnf.anzia e le bambi-ne dei galatei, p.252 - 3.Labaha, p.255 - 4. <<S,eqpre ve-
;ìì,od;il;; ,p.260 - 5. ln casa:genitori efigti, fratelli e
ràiàUi, p. 262 - à.La scuola e il collegio, p: 26 .- 7'.Fuoricasa. o.-279 - 8. I eiochi, la ricreazione e Ie villeggrature,;.-r8{ - q. Le ba*b"it e cattive, le punizioni, p. 283 - 10' Le
Éu*Li". povere, le orfane e le trovatelle, p.286 - I l Cosa
farai dagiande, p. 290 - Note, P' 292
,70
ll secolo deile bambi ne 'l'i
Siruonetta Ulit:ieri 299
1. Bambini e bambine. p 299 - 2 Contadinelle' pastorelle
e «serventine>> , p. )A2 - l ' Piccole operale' Iavorantt e <<pr-
;À;;;;.;0714. Bambine e servizio domestico' P )Y";. il;-Ér'dbi". vestivano alla marina-ra, P )12 (r' Le Pic-
..i""It^[;;;,p .ita'i 'l-"';figlie di Maiia' Bzmbine anui
Òinourntn, p'.321 - S Bambine sognale' bambtne oggerto
;i à:;ii;;ì;:t .;za's'Storie di bairbine «diverse»' p )) I
- Note, P. )35
Riferimenti bibliografi cr
Gli autori
Fonti delle illustrazioni
Infice dei nomi
341
JJ)
357
361
Lucia Sandri
Fuori e dentro l'osPedale'Éambine nel Quattrocento
l.'tJ n fenonteno sconcertante
N el Q uattrocen to, aumenta notevoirnell;, f.appertutto il numero
dei bambini,bU"'aon'ììi' Fenomeno antico' orofondamente ra-
dicato neila natura '**u th"' topito o forse sòstituito nei due se-
::ìt ;;." d";:i ql j:#;x;tTi5#ilff :i3;:1titffi ifamiliare (l'intanttcto ..o à purrir" dal XIII e
,re-sesnalato con una certa regolarità proprt
xrv:;i;:i'ioin'id"ì"J"1;"'u'*111i::T:il:T:,?t*'XJfr :-jla; -a seguito del nrosresso economlco
.;;;;:il;-i,,ly"t"àft* j'*::ff Xlffi?ffi"§[?:",iif lt;lliìiTriil:*.",i1ff :ti'#:,ffi r?:,il$.T:''";!:iil"",ff
i ;tx :;ff :Tùffi;'.," .a'e1 ubb u"d o"'ti' insieme
'."-[*H:ilri;i:l"r**m;':àm-"ffiT1i:::i':un'onerosa ^ppt"ait
i"ff"l'ii?'"ioni' *edievali ad tnài'izzo po'
liassi s tenzialt, p"' aii"iìi"" ià " ;t p"ti^ri" azione' d ei grandi ospe-
dali, o, come capitò;i*i;;;;;' li"uh"u'ione del pensiero um-a-
nistico in fatto d' J;;;;to" lu costruzione di un bretotrotto
i;t{t ffi ::: :x*:l'Llf;) ion i o s p e dari"r" jffiIffi l :'J;'i'
monio e negli *'"'il"iiitTà'* "'fu" tt"ol'di istituzioni minori
75
preesistenti, nuovamente edificate, poste sotto la direzione del
tornrrr,", la protezione del Signore àela città, che vennero affi-
Jrti ,r.1 .orrà d"1 Quattrocento centinaia e centinaia di bambini e
bambine abbar-rdonati dai loro genitori'--È ;1i.lu-bi'r", che or.unque superarono tra g1i abbandonati
il numero dei loro coetanei' ih* ,Àt'o dedicate 1e note che se-
EIuono.
l.t. La ruettorta ilell'infdnzia dei poueri' I registri degli antichi
ospedali rappresentano una fonte preziosa per penetrare \a vtta
qJ"iiàir", a.g[ emarginati de1 Medioel'o' Accolti negli ospe<]a-
li sia pr.,r. in sezioni iistinte da quel1e degli infermi e dei pelle-
grini, anche ai bambini, poveri tra ipoveri, veniva riservata una
Ip..iu1" atrenzione amministrati'a" Le scrjtture de1 «baliatico»,
.'."r.-"r" negli archir''i de1le città toscane, testimoniano tale at-
iirrira di u..ogii"r.ru a partire dai XIV secolo-'. Fuori di Toscana
in Lombardii, nel Venetc,. in Emilia-Romagna' tali testimonianl
;;;"; o più rarefatte o piu tarde, comunque nùn antecedenti
a1 XV ,".o1o. La tipologia del1e scritture è piiì o meno 1a stessa
da un ospedale all a1tro, da una città all'altra, sia pure con va-
.iur.,i ..giot-rali, specie per quanto riguarda la terminologia usa-
ta, Libridi batiei baorbini aFtenze,Libri di barnbori a Lucca,
Libri scaJetta aYenezia, Libri ruota a Vicenza6'- Il sistema di registrazione toscano, specie senese e fiorentino' è
molto simile. A Firenze poi, i libri destrnati a1la registrazione dei
bambini sono tenuti da qirei medesimi mercanti' usi a tenere le me-
morie di bottega, a gestiie filiali, organ izzare tapparti commercia
li di portata "ùop.ì. È p"r qrerto che ne.ll'atto di dar inizio alle
,.ritt,.." dei bamtini "rui
i"ut.ur ano nell'incipif la protezione di
Dio e del1a sua <<celestiale corte>> con ie stesse formule usate per
i-p",.or. 1'agognato..gua<lagno"' Ma c'è di più' 1e descrizioni dei
Un*Ui"i abb"an?onati, apparentemente prolisse' in realtà veri e
propri verbali de1l'abbaÀdono, hanno costituito e continuano a
ioriirrri." una fonte inesauribile di notizie sulf infanzia dei secoli
che ci hanno prececluto. Dali'indicazione del giorno e dell'ora
dell,abbando,rà, ,l"i sesso, de1l'età dei bambini, a1la descrizione di
op"rr"rr, <<pezzacceiane e line>', nere, bianch e, <<pa§onazze»' sino
uil,i.rdi.uràne di nodi, nastri, chicchi Ci <<paternostro>>, di corallo,
76
",it
iirtcrcalati alie fasce. tuiir] \ Li!ti.. ir pr:llli-iainiei:llc riesciitto cìa pno-
,i-. r|.^,u* solerti non senza i'oìt'tt'' di donne espefte' ie balie
i"-Lr Ji ..".1.-.1" mentre girano. stasci'"rnc' tnaneggiano couli-
c]cnzialniente i neorrati' o"ttt"lo' come soÌo una <iolntt sa fare' i
;;;i;;;;ri del pa,rto: «nat. alLora"' «di due o ue dì,'" scoprono'
iniir", 1a p."s.nza o meno ciei sale, tlenr'rnciatlie ' si: presenic' i'tir-
;;;;; i;ia;,i".tn_,o, Tutto infatti porrebbe rornare ,tile al barn,
ili"., p". tln suo futuro riconoscin'iento' e alia casa che 1o ha ac-
coito, [-cc,-,. Icnr]inilre I'isir..zione. rl 1,i6.,,io. ìrr piccol,a sono pron-
ri i',ct csscir.lati rllc i'litni-r'ul'c J'.'11t brlic til casr: la piytn:t Jei
;";;.. <k--r-e è -oluto *.gnnto/'a "ìspelt'ì
ancora la mir.o dclio scri
\-ano per cooo;scrre nel'piu l""ttitt1'o possii"ile nome r località
d;';"ri,il,;,;d"li, trii,,. iisuo.alarin.l,oi. iri sesuir.. r isi :rnn,rie'i
lnch,:.c J,rrir ìaire l',ttono c c;ìltilo Ie1 c(ìn\rl\'ùrnc' I1ìslcmc alll
.o.t* .1"1 lancirilio, lunga, lunghissima memot'ia
2, La stluczzu tielle bainbtnc
Se i1 fenoiner-ro dell'abl-,andono dei banbini appassiona da oitre
,:".,il"I]i r* pochi stLrdiosi. s1-,cciaimenie. srorici e dcmograi:i, 1a
s ua comprensione. nonostantt' innumerevoli n-ronografie sul1e sin-
t.ì. ì.Ii"rioni che li :rccoglie'ano e' Ci reccnie' Lrn'imporlante
;;t;.1,;i;,"ri, no,', è ancàr* totaierr' Ancor di più sfrigge il per-
:il;. ;;;;r;,;.i. .fr. il tasso di mascoiinità all, nascita fosse sup-e '
;i;;:-'-i ;;;trori .iei lv{edioevo ablrand.-,nirssero aile istit*zioni as-si-
.;;;i;t; rigiie lemrnine che ligh maschi"' Eppure per ri NIe-
.lioevo iiì',.,aggìor nuilleto dt haml-'ine abbanilonate è unir cosrtan-
ie . che tror,a riscontro in ogni isritr'izione os;''edaliera siudiata siuo
.,; ;;t ; p;+'*;, ar' r..-'is1l*ento dei troi'atelii' All' os pedale .di
San Gal1o cli Firenze, tra la'fine elei J'recent0 c i pLimi ilecenni cel
d;;;r;;;to, ie ba,r''t,i,,e superanoìi !::1 ''leìtotaler" La siessa
.ìin ,ip".:i dire per qr:ell'n di Santa N'laria della Scala' oi''erante an-
.;:;t;i; ,;tiio fl,,r"ntino tra Tre e Quattrocenlo' che denuncu
r1 catasto del 1427 une f c, c'nt'-irlt Ci fim mine dei 7{) u'i' 1 t' A qr: e1-
i;;;;ii i.;;.**i. .h" ii sostituis'-e entr;rmbi nel corso del XV se-
colo. assorbendone put'ii.no"lo e gr''Ye zzc' le banibine por:tate dai
r+ì; "i
ug; sc,,no ii5;91, degli introclcttil2' A San Girnignanc' 1n
i';i;;it;, p.. l^ *..1"r,-" *iotn' le.abbandonate rag'giur"rgono il
;0;;;. Aii';"f".l"i. Niaggioie rìi NIilano alia finc del(ìuattrocen-
t-7
to la pcrcentuale dellc bambine accoltc, sia pure in un anno spcci-
flco, il 1471, si aggira anche qui intorno trl7)"l,ta.Lzr minorc resa economica dcllc bambine, considerate una
bocca di più in famiglia e non rtcchezza di braccia da lavoro, ò si-
no ad oggi I'trnica motivazione portata dagli stolici a gir-rstifica-
zionc di tale fenomeno. Certo è che a hcn guardare 1e alte per-
centr-rali di abbandonate potrebbero essere lette anche, al contra-
lio, come un rnaggior valore dato in cluest'epoca alla vita delle figlie lispctto ai sccoli passati, quando più frequentemente è atte-
stato l'infanticidio perpetrato a loro dannol5. Un'attenzionc, si
dirrì, pur senìprc inferiore a quella riservata ai figli maschi, ab-
bandònati di meno, o di cui si ritardzrva 1'abbandono, aspettandoqualche giorno, chissà il buon Dio a\resse voluto clare alla famiglia
run 'segno', mentre le bambine, bisogna ammetterlo, appaioncr
proprio 'natc e gcttate' all'ospedalelt',- L'istituzi onalizzatzione delle bambine in cambio della loro sa1-
yezzLt, che prende ar.vio con 1'accoglimento dei trovatclli ncgli
ospcdali sino dal XIII, ma specialmcnte nel XIV e XV secolo, è
dunque una realtà. Va da sé, che il fcnomeno dell'abbanclono dei
bambini all'ospcdale, nc1 suo complesso, r'a intet'pretrto collunque positivamente per qllest'epoca, minata dal1e guerre, dalle ca-
restie e dalle pestilenze. Abbandonando i propri figli si oftriva 1o-
ro 1a possibiLìa dl alimenti c cure, che forse non influivano più ditanto sulla loro resistenzavitalc, specie nel periodo immediata-
mente segucnte 1'accoglimcnto, quando ancora grave era il trau-
ma dell'abbandono mrì, se si avcva la fc,rtuna di veder loro assc-
gnare Lrna l>uona balia, timorata di Dio, ai fanciulli e maggior-mente alle fanciullc veniva data una possibilità di soprawivcnzaaltrimenti loro ncgata. Non va dimenticato, infatti, che la maggiorparte dcgli abbandonati era ovr,rnque di origini poverissime, ingran parte provenienti dalle campagne circostzlnti le città, i ctri
ospedali funzionavano da collettori per la popolazione di emargi-.tuii .h", ancora ncl Quattrocento, trovavano libero accesso alle
porte. Anche i bambini erano in gran parte dei legittimi di origi-ne comitatina, a sf,ìtare quella visione più tarda, sette-ottocente-sca, che vcdrà ne1 trovatello prev:rlentemente un illegittimo, na-
scosto negli ospedali per motivi di onore.L'assillo dell'epoca medievale era piuttosto qr.rello della so-
prawivenza e della farne.
/é
). Bambirue e sciagure
Quasi rutri gli ospedali per rrovatelli del xv secolo accoglievano
di."oruti,"dei làttanti. Ma non era sempfe stato così. Gli ospe-
dali più u.rii.hi, le istituzioni dei centri minori, quelle operanti a
più stretto contatto con la campagna, dove la povertà era isola-
arr.rr,o e sofferenza, meno ostentata, che non nei grossi centri ur-
lurri, ,".rrro di frequente Ia memoria di bambini/e abbandonati
eià e.urrdi."lli. L'accoglimenro dei soli neonati, in atto già dal XVI".io - anche se solopiu tardi verranno udlizzate grate e ruote.
che selezioneranno con la misura dei corpi, l'età dei bambini - era
una restrizione operata per far fronte alltabuso delle famiglie, che
p."tn *"fld "n
i, portiuano all'ospedale anche i più grandi' Ciò'rrot otiurr., sotto i'imperversare di calamità le famiglie tendeva-
no a disfarsi anche di lo.o, .on una maggiore prcvalenza-' nugva-
À."r., di bambine. Le bambine di alcuni anni, talvolta di undici,
dodicie più anni, quasi delle piccole donne per l'epoca, erano ab-
bandonate specialmente in occasione di eventi drammatici' apo-
.ulitri.i, trlrràltu più di uno congiuntamente: la carestia, la guerra'
f, p.ti.. f" ta[ frangenti, per imotivi che vedremo, l'età all'ab-
bandono cresceva.
Tru il I4B e i\ 1437 , epidemie, carestie, soprattutto guerre sl
accaniscono sulla Toscanul Sorro specialmente gli anni tra iL 1425
e iI 1432 ad essere segnari dall'invàsione delle truppe dei.merce-
nari di Niccolò PicciÀno nel Mugelio e nel Casentino, dalle guer-
re contro f invasione viscontea e lè soldatesche delf impe-1at9ry-!i-
*l-o"ao con danni ingenti nel Valdarno inferiore, nella Valdi-
ii"r.f", ,,, Valdelsa "
rr"j Chirt tilT. È h questi anni che l'ospeda-
le di San Gallo, posto appena fuori l'omonima porya a Firenze'
verso la via che iu, unduuu a Bologna attraverso i1 Mugello, si
,-"a ,a accogliere un cfescente numefo di legittimi recati 1ì per
la guerra, di cui ben il 67% è rappresentato da bamblne' l\eli+Zl ,Nur*a di citcarre anni f, poìiatu all'ospedale perché il pa-
dr" op", la guetaaveva perduto ciò che aveva e non gli eru tima-
.r. ,* nu[lr'8. Nel 14]) Mendina, una bambina di otto anni' fu
,.Ààrrurn" dalla madre.<per la fame e per la guerra che non aYeva-
,ro ricolto nullar>, il padie, un certo Salvi, secondo la testimonian-
za delladonna, ,."au p."rro a Siena e credeva che non ritornereb-
be mai>>1e, La morte del padre e Ia cattura deila madre' <<menata
79
a Siena>>, aveva colpito anche Lisa, di cinque anni, per la.quale vi-
cini pi.tori venuti;pposta da Barbialla (Valdelsa) ne chiesero il.i.orr..o in ospedale poiché «tutti i suoi erano stati presi e mor-
i;Jo. at.o.a qu.llo it.rro urrno, un'altra bambina di otto anni'
Érrtolo*.r, f, portrtu dalla madre che disse "1a
àava all'ospeda-
Éì*AJrt prai" ," ,r'".u ito come disperato e non sapeva dove>>
. aggiunse ..perché avevano perduto e arso ciò che avevano e mo-
ri"rr'i ai famerrz'.Nel 1413, È h volta di Giovanna, di appena no-
ve mesi, portata ancora dalla madre - l'iniziativa de77a salvezza
delle fljllà spetta quasi sempre alle madri - che la recava dal con-
trdo diSurr'Gimignano, ,.pàr lu guerra>> e perché <<aveva perduto
ciò che aveva e conuenirru ihe e[à stesse per fante ella e ii suo ma-
iiroru.La disperazione che traspare dai iacconti delle donne, che
..pti."". chilometri e chilomeìri per giungere aile porte di Fi-
rertze amettere m salvo le piccole, ci iolpisce ancora oggi a di-
;;; d,;;1i;". il dolorè composto' e nello stesso tempo, di-
sperato, senza recupero' ineluttatile come ineluttabile sarebbe
;iil;r io.o l, famà chef inverno segr.rente avrebbe colpito.la fa-
*i"fià. Drivata dei raccolto, dispersa àalla guerra' E prima di tut-
i" !"t"UU. toccato a loro, alle dànne, costrette per un calcolo ata-
vico a privarsi del poco e del nulla, ad andare a servizio' a soc-
co-bei., forse, ad un destino di privazioni'-.- L";";;.e determinauano, uilo-ra come oggi, frequentemente.la
r.";;;;t; iei padri, morti in gqe-rla, fuggiti per le rappresaglie'
."" A *fa." .tafu*|rgliuch. tùfddu pone dunque a rischio mag-
gi"À""," f'"1.-.ntJf.mminile, cost;ingendo le madri al riparo
ir .uru d'altri come serve mentre per le bambine, le donne' che
.;t;;;.;;t.evano il rischio del t'porsi per fante>>, chiedono asilo
;1';tp.d4" perché <<non arrivi 1àto *u1""' La condizione della
f;r;;;Àtq,r., ul tempo, particolarmente aborrita per le figiie
.h" ...r.or". N"l 14)i, padte e madre insieme portarono a S.an
érU" Do-".ri.r, ..una fànciulla femmina d'età d'anni dodici o
circa>>, dissero che avevano altri due figliuoli e che <<questa>> era
«sì grande e avistatache se eglino ia ponessino con altrui come tut-
to ji .,"rrrrro richiesti ,rr"r"Lb. male>', chiedendo esplicitamente
.t.-f,,i accogliesse e la..si conducesse a onore>>2r. Anche Agola
i"t tqlq deila"medesima età viene accom pagnata dalla madre che
disse la <<menava perché ella non capitasse male>>, dato che con-
veniva che lei si ponesse per fante2a'
80
L
Ma non era solo la guerra a determinate la divisione del1a fa-
*igli; i;;;;;;';hf" à;li;;" a"u" nglie' anche la morte di
uno dei ggnitori p."t'ii]"t"*il;T.*'trii di pericolo per le ra-
sazzine.E una veaova, "na "uitin' di casa che' coraggiosalnente'
%;ir;;;;à...'u -o"u' e il padre era «uomo da poco e cat-
;1ffij:ffiffi;;;i;'; ' p'10 a san Gallo Ermellina' una ra-
;;;il;et *"*di.i-"i, "pàrché Ia detta fanciulla non capitasse
iiale»'5. Pochi giorni';;pJ;tht per Agata la madre chiese il ri-
coveto in ospedale pJ;fJffi"à fuoIg"" non la voleva vede-
;;;.;;;.r," rà pt""ta con altiui"è '<diventasse cattiva co-
il ;t ;;r;;o i" ,1,.É fanticelle#6. M'.h figura paterna appare
spesso in quest'epot', tiu-putt con qualche esagerazìone" tesa al
Hi*d;;;;"à;[;' *"i' i"u;'càtta'io"e delle bambine' se
non Droprio nociva,;d'#;** 'llu 'uluugtlardia delle figlie e'
.r^rticolarmente' del loro onore'u "' Ar;h;'ii;il; i;i p*à, "iit"
all' epidemia'' rius civ a a dirot-
,,,;;;;ù g'0.!,1i pili;t;: * *:i*: f;,};:U:X:mente del San Gallo di Firenze' ormal pros
i;Hil;;;"--il'1ilà;;u tì"à'""u' d.ove tra irt528 et'152e'
anni di carestia "
a pl'L",L;t-"*9."i'i" il ricovero di un'alta per-
.""ì"aà irÉr;ui"i;;;t;t" e i dodici anni di età' dove ancora una
,rfi^ i el 06"/o è ruppresentato da b3mbtn&7'
La saJvas.,a'd"'à;11;;ott' i;'u""tanamento a una !11mortale consunzione, sembrano le ra.gioni che intervengono plu
il;à#;,;;;;dil il;;" dr ubÉ'"dono di ranciulle ormai
grandi.LTu'"rr*" di questi casi, emergono' tuttavia''lXIi 1::;l:lJaI esame (u qucòLr L4rt, vr'v+b"---,
ino a pofsi il proble_nascita di una bambina eta st^ta accettata'.s
. '--^
l^--^ ^,,ilo.-ffi 'i:lf # :;ffiffi r,;; +"1
;uo, iivenire àoT i :1 "1'iff"1"JHnì;,j?;#;;,i;;;J'i"rt91t?d:':{[::*:"',:i-
ffi ll.;:f"#àìesi"'"'1''u""t*"u*""iodi:i:1*::::::X;;lJ iiil;'; il ii?" .t'" le istituzioni 9'9'd{9'! :1lf::ì:'3:il#;1ffi;:;:;i;;;l;;;^per le bambine povere: ra spe-
rufiza per loro di una vita ofloratà'
4 . Speranze di uita fuori e den*a l'ospedale
SecondolostoricoRichardTrexler'chehaavutoilmeritodioc-&;.:ì;:; ;;; iJffi b1""" a"u''Èt an <lono dei b amb ini agli
81
ospedali fiorentini e che per p.rimo ha rjlevato la maggiore inci-
denza delle bambine "à ifi 'ÈU"donati'
alle oiccole l'abbando-
no offriva una qualche;;;; dlvita: pur essendo-di pl1:li:l;;;.;;in osrredale, ne morivano poi di meno rispetto at coetanel
ilrr.f.;. Per'i'esattez za. nei primi decenni sesuentt I apertura oer
ffi.de;;;1"*; a.gii i"'L'enti' la p""enì"ale della mortalità
tr,n,n,i. è'inferioreàel 2oo rispetto a quella d'ingresso' -tllt'.,"r i maschi urr"nruì-"il""ji-'ilon è dàl medesimo parere Phi-
fllc#;,'::h. il;i;;;lu -o,tuuta per età, anziché considerar-
i,'J H;ri;:ò;Jr;;;;à" ilòuvitt' relativamente alla si-
tuazione [iorentina. 'iÉu' ptttto.-il medesimo osoedale una mor-
talità molto ,t,r. ,up"'ìo*"' q-'"fù dei maschi' tia le piccole' du
rante i1 difficile p"'iodo d"['àUut'u*tt"o presso le balie cui era-
no state affidate2')' ;;';;;; rilevazione effettuata sull'altro
ospedale fiorentino, ;iS;;il[t' t"nd" rasione ad entrambi gli
storici. Tral. D94. tl 14r;;;t^ittp"a'i" di San Gailo di Fi-
renzelapercentuale ài rn""ifiA jele Éumbine è inferiore di ben
tre punti rispetto a quella d'ingresso'.mentre Der i maschi essa cre-
sce di ben cinque p"""'^;;: intiilu-o p"t ttà tale mortalità' a
disranza di oltre r, ;;;;:i;;'iìu uuu'^'ono euasi "it:'il1l,d]UrÀUi"."' All'ospedale della Scala di San (ìimtsnano mascnl e
femmine godono qul'i aat" medesime opportun*ità' sia pure' di
nuovo, con un punto a favote delle bambinell'
salvare drll.irfrniiliJi;. i; tuÀuin" rispondevano dunque be-
ne ai recupero d"ll" ì'iituzioni assistenziali' oiu e meglio dei coe-
tanei maschi. era se ;;i:;;;;; 'i"t"''d., ad aYere una totale ra-
oi.,ne srrlla loro ,"r,r.L* ui*it' tttuio a balia a fiaccarle' Evidente-
il;;""ffi;", iri ."*ro[i iel'istituzione, le balie riproponeva-
;;;iÉ ;i;..le le medesime 'cure' riservate in senere' senza om-
bra di remora d.";;li;'iigiit' 'tt" lattanti di città loro affidate
àrif. ti..fr" fu-igii"?iot""tii"' '"tot'do una prassi evidentemen-
te ben radicata ""il;;;;t;;i"i*' aa bahatiio' che andava dagli
svezzamenti precoci a1 minor impegno' in genere' profuso nell'al-
levamento delle femmine' 1 , 1-. ^.^ ^;''"';;;i;;; purt" lu;;;;;;" delle bambine' piu abbandonate' pru
maltrattate a ,-,t^ uità"a u u"o'u tutta.da comprendere' Da' una
ffi;ffi;;;;th; J;av^ attrezzando con sezioni di ricezione'
annesse al grandl "tp"J'fi
e imponenti fabbricati - basti pensare
al brefotrofio fio.""1ito - p"t t' to"tervazione delf infanzia' bam-
bine in prima, alle quali era offerta una possibilità di vita certo
;;;;;;h. no, n"l putt"o' dall'altra' là mcdesima società che
i*rli""* rff. piccole Ln immutabile destino' che pare accompa-
snarle ad ogni livello sociale'."'eil;d; Klapisch_Zuber ha infatti rilevato a Firenze, rra
Ouattro e Cinquecentà, una mortalità altissima anche tra le neo-
;#t;;;f;,*hr, .irp",,o a quelle dei fratelli maschi. La po-
oolazione fiorentina denunciava iel resto uno squilibrlg ""-:l'::;;;;;i'i"o arrt'infanzia, passando d.a 7D maschi per 100
t.--ft. ptr-a dei cinque ant'i,à 12J maschi per 100 femmine tra
iil;; t iluiio.di.i annl"' Sempre a.Firenze nel Quattrocento
i"";;;;;;1" d"i bu*Éini dei duà sessi morti al di fuori delle isti-
;ffi;i;presi i gio"u"i, incideva del46% sul totale dei deces-
,, aìUr'p"p"j azionée la stessa cosa è attestata in Lombardia' do-
'e Giuliana Albini .;1..i; i";.no al15oh la percentuale di de-
.;tJ^;^;;;i.o degli individui, che non riuscirono a raggiungere
1'età adulta,.' "'iur;d" poi alla mortalità infantile ospedaliera, è da dire che
118% di media, .ir.ottt'uto agli Inn-ocenti nel corso del Quat-* o..*o. è confrontabile alla Àdi' del47 % trovata per Arezzo
alia medesimu "po.u, -"'tre a San Gimignano''*? X31,t:1t'^;
zadrile estremamente povera essa ragglun$e\'2ì Il ou u l'.''fùill-xrx secolo. q,""t percentuali appariranno del tutto irri-
sorie in confronto A io sòV' rilevato àu Giot'unt'a Da Molin'
;;;;i; g[ orp.drll diu""ut"'o dawero la <<tomba degli esposti"
come ella stessa li definisce"''"'ò"r; q,r"r,o, il problema.per le bambine rimane ancora
^o"iro ma ci pare significatiuo lt,au"'to"'t'tato che' almeno per
:il;' ;i;;,i; ; ;""n ; i''tir uzionalizza te' 1 a 1o ro v u I n e rab i li t à au -
ffii;;; :;; ilj"';;1.;;;nu*"n,o datf istituzione nelle affolla-
te (tra animali " p".*,") case dei mezzadri' i'bali" dove si.ri-
;;,;;;r;, forr., i" .lnairio"l (po'ertà' mancanza di igiene' in-
fii;;;;;; ,ritrà-"r. femminije), che ne avevano determinato
l'abbandono. S. .u,.hl e femmine accolti.dall'ospedale fiorenti
no *"iuuno immediatamente affidati a balie della campagna che
se ne prend"urno tJ*-'-tifttttt. nelia grande famiglia-ospeda-
liera, ma la prassi ,à--Étu """'" la stessa anche fuori di Tosca-
;;,;;;ù"ààu" 1..Ét-r'*igii" fiorentine' a1 cui modo di alleva-
.*"ì" a"i fanciulli, l'o'peàule costantemente si ispirava' è pur
B]
vero che Ia sua azione di controllo raramente aveva effetto oitre
la soglia dell'istituzione.
5. Balie e bambine: un legame dffiale
Le resole delf invio abaliarisultano essere le medesime in Tosca-
;;;f;;t fi;;i;h".,.lf i'tito'loni assistenziali' Le balie del1a
.,ij;&j,.u,,o pr"f"rit" per la modestia dei salari e, secondaria-
;;#;:;;.-t;;i.d. u11^ .t"denza della salubrità dell'aria' salu-
brità che certo era veritiera specie allorché divampavano le.epi-
a"-ia q"*do però anche la cam p^gna era presa di mira dai cit
;i;t'À;; rfolluur.to per trovar rlparo alcontagio' AFirenze.'
-ri, *ga" era seguita à,,.h" ^
San èimignano e nelle altre città
;;;;;;"";n, i balnbini accoiti nell' ospedal'' i:Po.1",P'l*:'1:re prestate loro dalie donne di casa, venivano atttdatt alle balle dl
iràri, .h" potevano recarsi a prenderli o aspettare e.farseli reca-
;ffi u iuiuda vetturali ptez)o.lati;A trovar balia' all'epoca' pa-
fe non ci fossero ....rsiri'problemi: il mercato del latte era oltre-
;;;;;Èriu p.r lu g.uàt mortalità di bambini' che per il fre-
;;".,"i"àt. irr:ruui"dono da parte delle classi poverel ::i]:Éalie appartenevano. Mortalità e abbandono erano sicuramente t
;;ì";'J.i;.ifrti aat, diserzione dell,infanzia dalle case dei po-
;;;i. ffi ;i aàto dei poveri appartenevano anche i 'bali" che' da
nr.i.loro. a eiudicaiedai frequenti frequentissimi rinvii dei fan-
:*il, ;;li;;p?Jfi. Àoriuut; dàl nuovo iÀgravidamento delle mo
gfi, f. ù"^U., prorruuuro con convinzione ad aumentare Iafamiglia'
ior-ro*urr," .h. i .o.tr.u,ti di baliatico li volessero obbligati ad una
totale astinenza sessuale. Astinenza che, in mancanza di figli pro-
p;i';"t i quali salvaguardare Ia presenza del latte' certo non sten-
iir-o u .iedere che venisse poco praticata36'
Erano proprio qr*i ripàtuti carnbiamenti di balia' preceduti
a^ "" p".iiat d.r.u'rrt" it quale il bambino continuava a nutrirsi di
,r, f*i" impoverito, sostiiuito, se mancante' dai diversivi più vari
e rischiosi,L causare gran parte dei decessi' A.gata'.una trovatella
affidata all'ospedale di San Gimignano, dettene il pnmato oet
.r*uir-""ri: otto balie in *edici Àesi, l'ultima le fu fatalé7 .
Ebbene, si è già d"i. .o-t 1e bambine invogliassero ancora di
pi: te .oppi., .ù ..u,,o state affidate, a tralasciare impegni e cure
assunti con |'accettarione del baliatico, più di quanto, ma anche
con i m'Àschi nou si scherzava' non ci si pern-reltesse di tare con t
lcro coe ianei. ilo rr"'rt uua f istittizione non pare segtiire regole cli
,..-*. ,."i confrot-iti ciei due sels], ilrtoito sem'br"r dip;';['; iuii'iu'tonttn forrtrnato con tin'r b'uo-
r-ra baiirr. in tal caso u*ti-'t lt bambine potl-vailo sPcl'are di Lrortare
11.;,i;;';;;-l;;;" L';ii;;; Ncl 1+)o' Grrolanra sah'estra' eia
ìti1tt1 Darticoto,.',,t'-"t'?oi"'ìì"tt'ltt""i nelirr orlrr ..1c11't-'spedeie di
>.,,, Ci,',,ig,i,rno. rih ' i*itìì 'lì 'tt'- Silr cstro con irì-r pt'co Ji sril. rtl
;o11t-- a. significate tL"':;t;t;; tut-" batrcz'zata' e '<cla,anti lesaro
-ri-ro cinIol0 fosrro e rlrì() lrocO rii nastro anno<laiorr, se gnt i1i-restl c1-re
.,,.'t'el',bero clcvurc p"'-''ìo'"tltt il riconoscinieuto' ollre che cosii-
.,.*r'e l'unico perrnne i:;;;;;;" h ma'-ire ' Girolan* usufruì rli i9
.:=-.1 di ailartamento';l;t"; it "'"a"*t-r belia srraordinario in
i -r.sto caso è io ttt"5*ìì'ìo 'ìaù ""at'irr-ra (ìirolama che durò"
...,:;il|,"; ui,,' a""^'oiil"' 'in" al 1j2.7
j: E iiel nicrlesino ieno-
.: è :tnche 1'.tp"t;*"Jl ;iiii;,.'*;'-*ligl;ot,o delia sc'riava t"i Stcfa-
r Ji Fap'i nt."o"'i''iiStir-l di"'l*.ano' I)i':'r'o'a vcllne aliartata
-'.-: oltre di,re anni i- ;';;; «spoppate» ajirettanro]"' E g1i eserr
. :or',trnuano a San èirnrg"tt"o t ,'- 11iaa't"na' che ef à s.tattì Lror-
,:,r 1n une noite ..1i f;;;;'o 'le1 t'tr'0' irosra <<it-i su1 rnurello di-
. ,:,zi al1ii chie-.ar .ri i;;*'J;1i'*.io"' lr{addalena entia anchc iei
..- :ro.'ero ,1ene bar-*bine fclrturiate, i.-er eisere slata allattata per
- - I!),resi c .''""uto-f"' ]"',- :il:-::l:[:i5 ]:i::filr*fl....:il:t :tnonim,l nlclltlL'\'!rIì(ìsililnl('r': ntt"tl:'ì:..':]:i.'i;,",
T;;,- - -,istoiirno a' c*l1git''É't;;;t;t" ili se' i\ndree r1i Lr-ica Topr'
. itrr sanglillig'-'"-'t'"*"''ierr-niniari1o.-.questa rassegila' l1.la po-
.'.'.re contin""t- liì,.lo'n -;t;
òh;t"iina Lcrenza Llei t+-i5' ii
- iriia ichi:t'rii t..ì:'xìtt"iaro ..ia :an Cinrigrrarìo' irtìtht1lci
-... \lacldaÌ.'-'u uilut'u'n per seclici ilrLesi G "is1'opp'rtr' per altrl
- - r:io .ralla medesi*a t'uiio' certa nìonna lu{oigh;rita' donna di
: :. r Ji \ieio <1i f iiti'"i"Ji Santa Nlargherita a Sciano+ì'
.l c.lsi cor-ne questi. così freqr.rend neilt Carlpagnui rosc:rna, le
- :-lon ,"-i,"*ìfl-la,r;;;-;i1a'.catt:sorirr delle balie ili me-
'.: r .lrelìe p'op'rzlnì"'-'le n-iercenari"' m.a plt"tnsto a qtlcila del
: -, : i,,, i, ù,,, u'''il' f ;t''* ;;i it1::i"jl if; :IJ
,;ill1:iì:i I., :.tiir-tire f" '"t'Uirl" "f
ì"'ìr'" -atffo svezzamento' cc;'oa che
_.,,13 .oro 1r.r";#;;irii^;;; ad.,n salariO n-iaggir'ire di quel
'- '--er Sv"""i""ìinl-iittìtl)l-"'"i]. L'ospedale cL San Lìirnr
E,
snano, infatti, affidava di preferenza i bambini a due distinte ca-
ffiil;i;;ii;,;;[" 'È allattavano e que1le che svezzavano'
Oueste ultime po,.rr,,o """t" 'ntht donnè in età non più giova-
;il",iì';il;JJi;;;;;.;da," i prop'i guadagni' spesso-vedove'
;J-;";i ..*oao ""*-"* i" q"'titpot'-' in cui di frequen-
te il marito sopravanzava di diversianni la moglit , .-^ -r: ^L,,.i-- -L;orp.dule intendeva forse in questo modo argtnare gll aDusr'
Per t8-24mesi i br*;;i;;t;^"^it A petto delé balie' poi li'si
trasferiva in casa ai q"'itf" "ecchia
contadina a dividere con lei
r^ppì'."rr;rreri. ,r,il"i; ì;*;;;ti dai pagamenti in natura che
l'ente non di rado tr.tt" ai pàpri 'bali''.particolarmente in gra-
no e farina. N"gli ",*p' fti'"'-"'ri colpiice.' ti -li f,!.1.'11:i':
ir. a"ff" qurrrio bambine sono illegittime' ttglte di scnrave oeue
ricche famiglie ,,"gi;i;;;;"ti- R p"u"t la consta'ta'ione che' ri-
",,rra" asli"illesittimi, àno nuovamente le femmine a comparlre
ài 11X";:';ii;"#ffi ;;;" .'o-" r",u giusramente rilevato anche
il;ì;;i;i.uhurhi ;'; i;;;p"d'le fiorinti no degli In nocenti' poi -
ché si tollerava più "" 'fttgittirnomaschio che non una femmina'
;; i; ;;rk si sarebbe do"uuto salvaguardare l'onore e pensare a
ffi : J::È ;;b,1,ì;.h. i"'asi com c"::Tiì jiì::l: !: ffit::',me l:amiglie di provcnienza a rrntracclÀre
;;;;tb"ì;" in qialch" mo do ali' allevamen tor2''";;;;;;;'àar"-rÀ'e1e d'origine nelie di'erse fasi di vita
dei trovatclli non "'i;;;; "il;tiq I Sun Cimicnano si hanno le
testimonianze di d'É p^itr ai"U"'-Uit'"' tntt'-[i vedovi' :ht -i:1liig
" "rt 1-497 , si off'ono rispettivamente uno per «tante» per'
«pagare del prop.iof;i;;i; 1; i;;ìiu'u à"ll' fanciulia'' mentre l'al-
tro saDDiamo .fr" irrt.tu"nne direttamente nel1a contrattazione -d;i
,;i*;".;;1; balia$.La cosa non era infatti cosi inconsueta se 1n
il;ù;di;;;.r,. t'ttp"J'r" Maggiore'.che metteva a balia i pro-
il';ilr;"ii;;àl;"'J;;''ii"u ià'" di legami sociali ed iÌìteressi
economlcl, ut p."o.t'pavu di "p"t" se le balie avessero ricevuto
il;;;;iÈ ràÀieri. à'.rigine di alcuni dei bambiniaa'"-'T;;ril, u f.o"nià di .rE*pidi cura e di particolrr",il,.:.:.::"
t"if"fprro àaile nutrici nei confronti dei trovatellt' vuot per I In-
dole delle donne,;ù;; il loro rientrare nel giro degli interessi
degli ospedaf i ,-.gjiài- ezzadrisulleproprieA dtil" istituzioni)
;T;it" f,À"ii" a'.i,:ig,n " ì;; ;;r. de g1ì i I I àui tt lmi del le facol tose
famislic di San Gimignanot' non mancano-vicende che lasciano
i ; ;";; intrave d ere una colp evole tr asctt atezza'
86
).1. Trouatelle conte 'figlie'. Prima ancora della negligenza delle
balie, si der,e prendei.àtto di quella delle famiglie d'origine,.che
scattava nei confronti delle figliè proprio in concomitanza dell'età
allo svezzamento. Era infatti la consunzione già ar,rriata alf inter-
no del1a famiglia di origine a falcidiare le bambine, portate
all'ospedale proprio intoÀo ai dieci mesi. l'anno di età, quando
,icuramente la madr. aveva un altro figlio piccolo o, come è più
probabiie, urgeva lar,orare nei campi e vi erano P9ch9 possibilità
ài ,fu*u.I" "
-..,r^.1.. Christiane Klapisch-Zuber ha più volte do-
cumentaro come persino alle figlie delle ricche famiglie fiorentin_e
si concedess" r-,"rro 1a possibilità di poppare che non ai maschia5'
D'aitra parte Paolo da Certaldo con la sua autorità ammoniva: t<Ii
fanciuilà maschio, pasci bene e vesti come puoi [" '] la fanciuila fe-
mina vesti bene, e iome ia pasci no 1e cale, pur ch'abbia sua 'ita:
no la tenere troppo grassa>>l('.
Tuttavia si può ugualmente affermare che-per quanto osteg-
giata dalla chiÀa, chà preferiva un bambino allontanato da casa,
ibrse abbandonato alle istituzioni, che non un marito perduto per
le disartenzioni de1la moglie intenta all'allattamento. a Firenze e,
come sappiamo, anche a Genova, qualche madre allattava' Forse
..u.o u.*.a una volta i maschi ad essere oggetto di una così spe-
ciale attenzione ma il piacere di nutrire i1 proprio figlio non era
sconosciuto a tutte, né inviso a tutti i padri' A Genova, Diane
Orven Hughes, ha notato per il basso Medioevo che nei testa-
menti degli artigiani non sono menzionate né balie, né governan-
ti così splsso riàordate invece tra gli aristocratici. Secondo la stu-
diosa del comportamento familiare genovese
neli'aller,are i tigli. le consuetudini degli aristocratici e degli artigiani'
sottolineano la àifferenza nell'atteggiamento Verso 1a vita familiare. Fra
gli artigiani, i cui ligli normrlmentè irrr.o...uuno il primo anno di vita,
I u.ch-. i primi due. attaccati a1 seno della madre, il legame 'teato.1n11'nllrttr..nto faceva da complemento a quello materno; ma nelle fa'
miglie aristocratiche il primo entrava in concorrenza col secondo, poi-
chài neonative.rivano abit,.,almente affidati a unabalia che li allattavaa7.
Ed è il 1514, in pieno Rinascimento, quando Tommaso di
Francesco Bancozzi,- personaggio atti',,o nella .,,ita commerciale
fiorentina, probabilmente artigiano, prende la penna per annota-
re nel suo libro di conti:
8l
Ricordo questo dì 2 di novemb tel5l4 chome -1""*:di?.]:^t^1^"1-
h V;;"; Maria che sempre sia nostra avocata e in aiuto come plac-
;;;6;;;"Lq". r" bJ*b*" della N{arina mia donna el quale par-
torì a ore te di notte, ""o
giot"ai sera questo dì detto di sopra' e1 qua-
i. U^*Ui". fecibattezzari a; di novèmbre l5t4 efecegli porre.no-
me Francesco innanzi . Àc,Àc,fcl secondo' E1 detto Francesco si bat-
;;;;11. i.tti cli San Giovanni di Firenze dove si costuma battezzrye
r.r-r*r" l, .inu . ,.r-t.io"uilt ionti Niccolaio de1 Barco et Ugolino di
"B";;;;d" il;;ri . a"a..' di ser stefano Monichi e detto Francesco
,'uil.r,u in casa e la madre gli dà la poppa-l8'
Forse una tale affezione - al di là del ceto sociale di appatte-
,"n u-,- urtigianale o u,ì,tott'tito-imprenditoriale' che varrebbe
;;;;;i u-pr"udi-,lp'"fondire prima di proporre s*:'1Yzaztoniàffl.U poi da estirpare - non scattava t"*pt","1-::11fronti delle figlie, inviate più spesso e anticipatamente' rlspetto al
fratelli, abaliae' come pare, anche precoc€mente dtvezzate o' net
caso appartenessero u fu*igii" pou"-'"' abbandonate proprio al
t"À. àa diverzamrlnto, i"lo'nt agli.8't2 mesi di età' Perché è
orr"àru I'età in cui vengono portate all'ospedale di San Gimigna-
i" . a Sr" Gallo di Fi.".rrà le bambine ..male go\rernate>>, <<sca-
à"à"-.,-^f" ln ordi..', <<magre» <<maltenute>>' se non proprio
ao*" ..-o.re dl fu.rr."'' ttAÀmalate e consumate>> sono anche
n",.ì," a"U" bambine portate ail'ospedale di Santa Maria sopra i
;;;;i d, Àt" zzo àoveil -o'it" di fame delle piccole è annoverato
à^ Arrtonelia Moriani, che ce ne parla, sia pure per un'e.poca un
"à' oi" iarda, i-l XVI-XVit secolo, tra gli esempi piu evtdentt ot
,iolàna tramandatici dal passato'n'-- òn" dire allora se non Éh" 1" bulit, non tutte come abbiamo vi-
sto, forse seguivano sempiicemente il costume dell'epoca' e dopo
avetSYeZZatop.".o*".'telefigliedeipadronidicittà,procede-,runo in tal mào anche nei confÀnd delle trovatelle' quasi si trat-
i"tt., --itipassi 1'espressione, di 'figlie proprie" cui si,applicava
con zelo l, .onru.tuàine familiare d"1 t"-po. Da parte degli ospe-
;;il;;; uppn." del resto nessun accordo in tal senso' tuttavia si ve-
da il caso di San Gr*ig"u"o - ma è forse tutta l'area senese a dif-
f;;. ;;t;; J"['l*p."o" a datadal Santa Maria della Scala di Sie-
na - dove la paga pi,lo su"'amento era nettamente inferiore' la
metà di quella dlrtà p.' allattarc'Da parte del1e balie dunque il so-
88
---L
io rornacontri che porevano avere nel precoce rin'ezzrmento cri" si-
curafilente quelìo tii p""'J"tt p*'lo '*t"tuo
sajario'ln bambino pìu
piccoio, meno e sigenttlp* ttii-t'''dcnrc e orgar-iizzabile cl.ie non un
{anciuiiri,'a .ii ",' un'-to' ':;;;t;i"t"1.=
f i5.gnosc cii son'eglianza e'
.lr"* a facile immaginale ' url iorurtdrbrlc pcplralore'
[Ì conpcna""'t"'u'J"iì" baiie iasciava molto a clesiderare net
conironti di tutri, masclii e femmine' e o\ilìiltìue' srandcl riir testi-
r'otri.zinze iaccoite "";;; ;;;';iltt-tìti^' A Eologna''id csc:npio r1
1o giugno rlel 1'177.sii;;:;;;;"' a'1 opera ciella'oalia" cui i'cspe.
.laie,rvevar afhcìato Ì' uffii;;;ù; ; cira.mni;' t:'t tltt]t]:'l:-.:::
;;ir;.;." ciescrizione clella"oanibir-ra co-sa si intcndesse pef <<Inor'
;, ai' f;; ;ii; ;h- nJi x '1'ng"'to
la rnartina in dotniriica re -
-stitui la ilictri pr-rra *oito touit e n'ialissimc tractaila e g'overn?1ta e
tu,'.i i n'a,.i.'.r,i. ti;n'u taqa Jc' c. I cat Ilrà"' r,'
Del resto i 1''o'ttJi'ìt'"t' J'glt os;'eciaii rier casi eli gtuì''t::
,h;;;; à.ile bafie erano se'"eri e clrln-iina"ano ncl rÌti*rc rit cor-
;$:;;";ù. uut" ri salario-'J.attuiro a'"iche se citì puffroppo ali:
veniva c1i sclrtc. ui ,r-r,rr,- r"nro dilla .rcc,nre gna dei bai:rbino'2' solo
.'oi tump,' infattr *f' "'Utiìii u'itt't' it' 'rit'rln sisl(mrì Jirisile e
..,nrroli,:.tl ttru (ìl c|lr:lie rrbusi t" 1-rtti161P1!11(niL" pcl nitlì liurdtr
rt ,ji r rstrr i 'oa',rb,''ti ti'',.:' '"tf-'i Ù iL'innrrrr( r crlir lrtt' ittte ra!-
mente 'persi' dal1e t';'ì;;;tii;;ni' ,"ttt,'ti presso i baii se*za darc
lrr in,, all u.p.J'it t-,-t'Juii zrJ .iitrt Lalir'' ni''rzi int'clioii 1'sr'"
te, rliatrrrc."n ' ""ll] t:;;l:lt"i'," b"ìni-"n"" D''1 tLSro :ir!-
ci-re rra i 1-rrivati si gt*eìut'a'a carrco J-ci iigli' «un o1-''1io tonnesso
,r11a loro .o11"tu'it"1t ^'f--ii- fuo': deila i"'ftelia"' cht pi'rt- inte-
ressass.. ' ancora ""- ""ri"'i;;it it b;'"bine àei bambini' a spie-
gare f,..,rs,: anc'rra "**iic, o*fiu lq"itiUt;t.' tra i sessi nelle famiglie
.rL,i-icn ii, .h. tt'n u"il tt "u
"''t't'''"ir ltr :t tt'lio tlt'ì ctt ta' t o t ir tit rrti'
1 1-,aF<lno l1eI \il i '-
-
,,. 1! 7t,sl,' -lr.!f ; l's1"t"11t' "t'
i 'ic't'iit i" !"'; .!'
Chrisiiane KlaL'iscii Zuber ci hrr ber-r iliusrrat() qlìanto pcco ia na-
.cira di ,ru i,on'l,u';;1t;;- la vita.ci *na coppia a Firenze'
Cirven Huitotr h" ;;;t;t,o"Jì'nttq.t' l'Europa e' lizi trcvato moiti
comportamel"i 'iÀ'iiì "irtelli ciei iic,'1er't1ni l)alh campane gros-
!a suonat2l per ia nascit' di t"' maschio in Bretagna' menti-e quei-
ia piccola *'o 'l'""i"o"'[:;;;;ìì;"' *11' J'ius-ione ciei padri di
89
'l:- z
ogni parte del continente per la nascita di figlie55. Persino il dolo-
re per la loro morte era oltremodo contenuto: <<Ricordo chome a
dì 28 di giugno a ore ue di notte morì la Sandrina nostra fanciulladi peste in quaranta ore. Iddio laha farc salvare. Era d'età d'anniotto e tre mesi>>. Così scrive Jacopo Attavanti sulle sue ricordanze
nel146456. Finanche tra gli illegittimi la nascita di un maschio era
maggiormente ^pprezzata
di quella di una femmina. Abbiamo già
visto come a San Gimignano le figlie delle schiave fossero tutte de-
stinate alla plla dell'ospedale di 1à. Il medesimo Jacopo Attavantia Firenze non esita a disfarsi, inviandola all'ospedale dei trovatel-li di Pisa, di una bambina nata da una sua schiava, detta la Rossa,
probabilmente però acquistata già incinta, mentre organizza patto e allevamento di un altro illegittimo, maschio, figlio questa voltadella schiava di suo fratello Antonio, il padre: «Ricordo farò qui da
piè di tutte le spese farò nel parto della Caterina fu di Pagolo Ru-
cellai, la quale è grossa d'Antonio Attavanti nostro fratello e primacioè...». Seguono le spese per una <<zana da cullare>r, per più paia
di capponi, polli e uccellini, comprati al mercato di San Lorenzo,
spese per la «guardadonne>>, la levatrice cioè chiamata ad assister-
la, per i torchietti di cera per farlo batlezzare, per cialdoni e zuc-
chero per festeggiare la nascita e poi scarpette, <<calzoline bian-
che>>, <<foderuzzir>, <<bavaeli>r, ..una gamurrina>> e più acconti datial balio, che li riceve per allevare in Mugello ii piccolo RinaldosT.
Tuttavia alla metà del XV secolo, il medesimo Jacopo è chia-
mato a fare il padrino di una bambina, la cui memoria annota conevidente soddisfazione: <<Ricordo come a d\22 dimarzobattezzaiioJacopo Attavanti a Piero di Bartolo Zatiuna fanciulla femminaet poselle nome Saracina et fummo Cherubino Galluzzi ed io et
battezzolTa>>5E.
Di contro alTafine del Cinquecento, a confermarci però una
generale misoginia, Gherardo Molza, proprietario terriero, forse
anche lui esponente del mondo commerciale e imprenditoriale,mescola la memoria della morte di familiari con quella di cani che
figliano e cavalli mandati a castrare. La nascita di una cucciolataè descritta con dovizia di particolari e trasporto di gran lunga su-
periore alla perdita di madre, moglie e nuora5e.
Tornando alle nostre piccole donne, allora come oggi, 1a man-
canza difigli propri, mai avuti o drammaticamente scomparsi, in-
duceva non poche coppie a riferirsi agli ospedali per trovatelli'
AÌJ'ospedale degli Innocenri rra il 1146 e il 1458. nei pnmr dodt-
.inrrr,ì di attivià, si ebbero ben 66 domande di adozione, ,pa'i a
;; ;ril. richieste all'anno, con una certa intensità tta il 1454
;ìii458,;"ni di peste che, evidentemente stimolavano olle alla
,ri^fiia, ."*e è jo.r*.ntaro, il desiderio immediato di figli da
,ortitrit" ai troppi drammaticamente scomparsir'o' Valga per tut-
,ii'"t.-p. ,ilàrruto nell'ospedale di San Gallo, do'e nel 1410
oo". ,rnàr.. della mortalità» il priore insistette a richiedere ai ba-
lli, ,.rit"rione di un bambinolperché non s'apicasse ii male an-
.h" u 1r;r, ma dor,'ette cedere al «grande pianto>> di monna Nen-
ciaTabaliache, vistasi morire intorno tutti i suoi figlioii, si era at-
iu..uru al tro'ate1lo come a un figlio proprio"l' A Milano' si par
I; d^G a lo bambini «affidati>> 1'à.,nò, dòve però è probabile che
i;rffiar*"rro non abbia la medesima valenzagiuridica delle vere
e proprie <<adozionil> fiorentinet'2.- ' Slà rru g1i adottati di Firenze che tra gli affidati di Milano, la do-
-rna, Jl?igli maschi da tenere come propri, supera qu.ella delle
i"t"Àin.. LI,lot. che a Firenze andava da un minimo di25 aun
-urrin o di 50 fiorini nella prima metà del Quattrocento' secondo
i a"ttu*i dell'Arte put.o.,u dell'ospedale degli Innocenti' quella
à"i" §"ru, "., forr"'.,n dererrente per la richiesta delle bambine.
-u e p.ntubile che anche in procinto di.a.dottare un figlio non pro-
frio t.u*rttero ie medesime remore (dote, ma anche conserva-
)ione .1e11'onore, minore resa economica) che provocavano la de-
lusione dei fiorentini alla nascita delle figiie'--" Diu".rr*ente da quanto accade ai nostri giorni, erano i maschi
i oreferiti. La stessa iosa u..ud.va nelle richieste di restituzione
àil propri figii inoitrata all'ospedale a. distanza di alcuni anni
Jr[àUUrnaoio ., in genere, mai prima dello svezzamento: i bam-
Èirri ,,rp"ruuano le bÀ-,birr". Se nel caso delle richieste di restitu-
,ione, Àotivazioni quali il valore economico dei maschi' certo più
"rìii i" famiglia, ci convincono, ci lascia invece perplessi il caso
àe1e richiesie da parte di estranei di bambini da tenere come
";;; fislioli», futuri eredi dei beni di famiglia e del nome, Ciò
.,'nno'r,rt rl" anche alcune delle bambine venivano richieste come
iigli.- Xa 1450, Agata Maddalena Viene data <<come sua figiiola'
,à .,n ,,oruio, .h" s;impegno ad alleva1l2 'in tutte quelle cose sie-
.o Jo".r,a e ,li buonicàst.r-i come debbono fare i buoni uomi-
91
ni>>or; nel 1456 anche Brigida Domenica fu data ad una coppia di
]r.-;:;"':;;;;;;:;;; ì;;;'; e trattarra come sua {igliola"6r-
Nel caso deile bambine tuttar''ia' persiste il dubbio che fossero
principalmente prese ;J;;;;"'"'11" coonie di'esercitarsi'
soiritualmentc in un oitiuit'' cli educazionc' che andava a bencfi-
:i" "r.ffi;'ilii, i.;;';;i,,u . d.tio toro casa che. oitie che be-
nedetra, sarebbe "rrrli
i""r.. à.U'^pp*"aimento delle faccende
domesdche d.11" pittoitltf" 1 ^*'tÀàero ser"iti in cambio di una
dote . Ciò appare .hiu'o i'-' un'a1tra mem-oria di lacopo Attavanti:
<<Ricordo .o*. nt'""oX^ilì";;; d'ottolxe togliemo una fanciul
ì; d;]';q,"drl" à"' Nocienti e ha nome Pasqurna a stare con nol
per farle la dotta '*l '"';;; ;;àe a Dio.sarà di piacere et 1ui la fac'
cia buona e grazra^;;i " potrà fare delbene per 1ei er per no1'
Amen>,. Setre mesi dopo iàggia*o t:1 disappunto. un lacolico:
..morì a dì 8 di *'ggìn"lln ti'd'I" di Santa Maria Nuola dt rna-
]e di petro in di trc "';';;;t''D; le petdoni' ' 11beneficio spiri-
tuale è chiaro u"tht ;;i;;iÀi"utu ài -ont'u Antonia di Guido'
una commer.u dtlt'o'p"àal" degL Innocenti che chiese per sé
Francesca dl ,.i *"ì?'i;;é dil;";o1ea alle'arla e costumarla
per l'anima sua>>6''' . 1i - -r^: ..i^1^;-,lo.ti trkrolta eraComunque fosse, f invio alla casa dei richiedenti talvolta erl
traumatico. Q"utt'o àtU" Uu''t'ine passarono da un mercante
all'altro prima di "ti';;;; Jt'ti""'o"t a Viterbo' richieste in più
riorese dai mercanti^àit""i'*t del posto-' Fu questo il destrnl,fi
à?:ìi;;:.iìì ""i"itiz' "per le mrni,diJacopo del'Pacc' setaro-
lo, che l'u..n*pugil ;";;;tasa di 'Nicolino d'Antonio de1
Rosso, cittadino di Viterbo»67'
Coilocare ,tu t'otnUit'a non. eJa un'imnresa facile e impegna-
.ra oltremodo t, "'io[ubilit' d'l prior c' tti
'ono infatti ca'i di ri-
chicsrc per così ditt:;;;i;;i^ti al fanc.iulle da partc di donnc so-
lc, che. evidentemen'""';;;;',tle solite vedovc timorate di D-io
e alle quali ie bambine vengono ritirate in bre'e tempo per ordi-
ne del priore <tche manda "pt'
""""' non contento delf impiego
forse poco oto"'oit t.'ìlàtto ttut" destinate' Pet Lucia Cateri-
na, datanel 1454 ;;;;;onna Tancia' ftr deciso di ripren-
derla in casa perché <<non parve al priore i'i*"" a suo modo>>6s'
Non si può iare ' ;';;;; it'-t'u'"' infatti' che 1a presenza àrtan-
te fanciulletr" ^ t^'ìtcl deif istituzione risultasse appetibiie' suo
92
malgrado, ad un mercato deila prostituzione, che sappiamo mol-to vivace aEirenzein quel tempo6e. Ma gli abusi sessuali, in que-
st'epoca mai chiaramente denunciati, si presentano spesso ca-
muffati da frettolosi ritorni, fughe, strani 'sperdimenti' di co-
scienza, che segnano negativamentela vttapsicologica dei bambi-ni e, più frequentemente, delle bambine.
7 . L'auuio al lauoro
Riguardo all'awio al lavoro, poco conosciuto per quest'epoca, iltardo Medioevo e la prima Età moderna, per i rugazziin genere e
altrettanto poco, come ci awerte Gabriella Piccinni, anche per le
donne adulte, le fonti ospedaliere ci vengono in aiuto ancora una
volta e aprono squarci di conoscenza notevoli e inediti, proprio a
vantagglo del mondo del7'infanzia al femminile. Fanciulle povere,
che estrapoliamo volentieri in questo ambito a loro esclusivamen-
te dedicato, pur non cessando di compararle per quanto possibi-
le ai coetanei maschi e alle coetanee del mondo di fuori, le ram-
polle forse più fortunate, ma condannate anch'esse alla reclusio-
ne nei conventi o a matrimoni precoci, preziose fatttici, a Firen-ze, dell' ad st octazia mercantileTo.
L'abbandono dei bambini alle istituzioni assistenziali e spe-
cialmente, come si è visto sin qui, quello delle bambine, prende ilposto in parte, pian piano, della loro oblazione ai conventi, iIì p-ra-
iiculu curvu dèll'ubbandono cresce col diminuire di quest'u1ti-
ma71. L'ospedale è il luogo dove, senza bisogno di dote, possono
essere sistemate avrtalefiglie delle famiglie più povere: quasi una
condanna senza appello, dove il lavoro, insieme al matdmonio dicui parleremo in seguito, rappresenta l'unico barlume di speran-
zà p$ uscire, per vivere lavita di tutti.-Dul
.rrrto loro 1e istituzioni ospedaliere facevano del loro me-
glio per liberare fanciulli e fanciulle dall'onnipresenza della tute-[a isiituzionale e, principalmente, per liberarsi esse stesse dal pe-
so gravosissimo dè1 loro mantenimento. Or,rrnque si cercava di in-coiaggsare il legame instauratosi naturaknente con i 'bali', gli ul-timi della serie, incaricati dello svezzamefito' Questa sttada eta
molto praticata ad esempio dall'ospedale Maggiore di Milano, do-
ve si riscontra il più alto numero di affidamenti alle famiglie dei
bali, in prevalenza di origine contadinaT2. Presso di loro itagazzi,
9)
in numero inferiore le bambine, meno adatte all,afatica dei lavoricampestri, ma adattissime alla conduzione delia casa, alla sorve-
glianzadi animali da cortile, dei figli piccoli dei bali, e perché no,
dei trovatelli venuti dopo, vivevano la loro stagione di un'infanziaoperosa, dove si diventava presto adulti. Nel mondo contadino, ci
awertono giustamente Maria Serena Mazzi e Sergio Raveggi, ri-ferendosi al iavoro di casa e particolarmente ai <<gestil> delle con-
tadine che 1o realizzavano, «le bambine anche senza lo stimolodella precettistica o dei trattati di comportamento imparavano
dalle madri valore e significato di quei gesti, la liturgia del viverequotidiano per la continuità della vita stessa>>7r.
Né il mondo contadino era particolarmente incline al ricono-scimento delf infanzia, una volta svezzatii bambini smettevano diessere tali, diventavano adulti in miniatura. Dall'analisi degli in-
ventari delle masserizie di alcune delle abitazioni contadine esa-
minati dai due autori, risulta infatti, per le campagne fiorentine,che non vi erano oggetti che rendessero palese la presenza di fan-
ciuili in casa71. Niente bambole dunque né bambolotti o Gesù
Bambini di buona fattura, ritrovati al contrario nei corredi dellegiovani fiorentine deile classi ricche75.
Nelle istituzioni per trovatelli, piene, al contrario, di memoriedelT'infanzia, di quella povera eppur diversa dall'infanzia dei po-
veri vera e propria, compare talvolta invece la sua dimensione piùreale: il gioco. La palla, i sassi lanciati dal porticato nella piazza
sottostante - come awiene a Firenze nei cortili e sotto il pregevo-
le loggiato brunelleschiano, trasformato in un vivace riftovo difanciulli -, la pittura e i canti, dove forse le bambine avevano po-
co spazio, tutte prese dall'obbligo del cucito e del telaio76.
7 .L A seruizio nelle case dei ricchi. Ma se l'affidamento ai 'bali', ai
<<tenutari», per usare il termine delle fonti fiorentine, rappresentaovunque il primo naturale sbocco dei rovatelli, specie in Lom-bardia, sia pure con una preminenza dei maschi sulle femmine, a
Firenze, alla medesima epoca l'ospedale degli Innocenti, pur nondisdegnando tali sistemazioni, punta maggiormente, e per tutto ilQuattrocento, al loro inserimento nella vita artigianale e com-merciale cittadina.
E significativo infatti che l'ospedale tratti figli e figlie con la lun-gimiranzadel buon padre di famiglia, facilitando f invio delle bam-
94
bine presso famiglie oneste e timorate di Dio, desiderose di redi-mersi, come si è già detto, nell'esercizio dell'educazione da impar-tire ad una trovatella. La dote, come si è già accennato, erala con-
tropartita dei servizi, che la bambina rendeva in cambio del suo a1-
levamento e istruzione al comportamento così come si convenivaad una futura madre di famiglia. Va da sé che quaicuno, a Milanocome nella Firenze rinascimentale, nonostante le buone intenzio-ni, chiedesse di 'provade'77 .Un calzolaio fiorentino venuto a pren-dere, ne1 I476, Agata Caterina,,menossela detto dì con patti chela tenga un mese o due e se gli piace»7S. Uguale iI caso di Giovan-na, di dieci anni, inviata quello stesso anno a Castelfiorentino incasa di un notaio che 1'avrebbe tenuta «se gli soddisfacevarrTe.
Casi diversi dunque da queili indicati precedentemente nel-i'ambito delle adozioni, degli affidamenti come <<proprie figliole».
Qui il rapporto è chiaro: la dote è il salario del lavoro corrispetti-vo. Se i servigi non corrispondevano alle attese, difficilmente lebambine avrebbero potuto restare presso la medesima famiglia.L'impressione anzi è che venissero scaricate di proposito col mo-tivo deli'ina deguatezza proprio per evitare di far loro la dote sulMonte, nonostante la vigllanza e gli ammonimenti dati dal prio-re prima di concederle. Terribile appare l'esperienza vissuta da
Antonia Marietta, una bambina di tredici anni che, nel 1468,
tornò «male vestita e male in punto>> e che, come si dovette perI'evidenza dei fatti ammettere, <<era stata fuori di casa in più luo-ghi tanto che non v'era ricordo>>s0. Giovanna, sempre in questianni, anche lei passata da una famiglia a71'altra <<tornò a casa que-
sto dì da sé>>, <<benché altra volta tornasse di suor>, <,perché nonera stata ben trattata» e fece sapere con determinazione di volerrestare <<in casa>> e che <<se non ne pigliassimo partito, 1o piglie-rebbe lei»81.
Tuttavia il lavoro di domestica sia pure, nel caso delle trovatel-le, reso in cambio della costituzione di una dote, affliggeva anche
le coetanee della medesima estrazione sociale, che vivevano fuorinel mondo. Anzi, pare il lavoro più naturale, data la loro condi-zione femminile, cui potesselo
"ir.r" avviate . È ur,.o.u dalle me-
morie di Jacopo Attavanti che veniamo a conoscenza dell'abitudi-ne di alcune madri di presentarsi a servire in casa, accompagnate
dalle figlie, bambine di sei, sette anni, cui si corrispondeva i1 man-
giare e il vestire. Nel 1484, troviamo sempreJacopo a scrivere sul-
95
le sue ricordanze: <<Richordo chome a dì 4 d'aghosto venne a sta-
re mecho laLna à'Atezzo con lei menò una fanciulla sua d'anni 6
in circha alle spese mie. Detta fanciulla è chiamata L:uchrezia>>*.
T m i pagam"t ii .h" seguirono compaiono denari corrispo-sti alla
madrè per ben tte pata di scarpe e uno di pianelle pet <<1a Lucre-ziasua>r,più altri soldi dati per imbiancare <<sua tele» e acquistare
fazzolett{,che fanno pensare all'acquisto di capi per un futuro cor-
redo della bambina. Queila deile figlie a servizio con le madri do-
veva proprio essere una prassi consueta se il medesimoospedale
degli Innocenti,nell446,non aveva trovato niente da obbiettaread"Agnola, una ba1ia, che si era presentata con Maria, sua figlia disette atmi, per la quale anche il priore si dimosttò propenso a pa-
gare <<1e ,f,o.rr, in cambio dei suoi servigi 1n casa81. Del resto la
èorresponsione delle sole spese, cui si fa riferimento (mangiare e
vestire) eraufladelle clausole tipiche per l'apprendistato dei gio-
vanissimi.
7 2, Prosftute, incannatrici di seta, tessiftici di broccati. Ma il ser-
wzio ncasa non era l'unica via resa loro possibile' Christiane Kla-pisch-Zuber oltre al matrimonio e al convento ha intravisto <<per
le giovani toscano> del XV e XVI secolo w'altta <<professione»,
q*11" della prostituzione,riservata, come è facile immaginarc, ù-lr r*g^zr. poveresa. Realmente però, a parte Ia consistente pre-
.*rà it, quest'ambito delle suaniere e delle forestieres', taJe atti-vità non
^ppur. mai esplicitamente espre§sa nelle fonti istituzio--
nali prese i. .**-.. Mentre sono frequenti, come abbiamo-già in-dicaio, allusioni ad un collocamento ritenuto non moralmente
buono per le fanciulle, immancabilrnente riprese in casa' Nel 147J ,
per esempio, tornò a casa <<peristxrzadell'Ufficio degli Otto>>, una
àe[e magistrature divenute competenti proprio inmatedadi pro-
stituziorre aEite*ze,Piera Maria, di tredici anti, <laquale era sta-
ta fuori a1la madre>>86.
Le trovatelle erano da considerarsi in fondo «figlie dell'ospe-
dalo> e, aEirenze, specie nel primo periodo di cui maggiormen-
te ci occupiamo, i tovatelli tutti erano «figli e figlie dei mercan-
ti della seta>>, i patroni del Santa Maria degli Innocenti appunto.
Va da sé che lé ragazziae rimesse sulla strada senza il consenso
dell'istituzione e di cui si perdevano le notizie, sicuramente, loromùgraéo, finissero nel fiorente mercato del meretricio' Intorno
96
agli anni Ottanta del XVI secolo esiste tuttavia per la verità unar,'venimento oscuro nella storia dell'ospedale, in seguito al qua-le diminuì notevolmente il numero delle tagazze in casa, cre-sciuto a dismisura sotto il priorato di Vincenzo Borghini, filoio-go e umanista di chiara fama.L'accusafatta al Borghini fu quelladi aver appunto aperto le porte dell'ospedale alle trovatelle e diaverle spinte a\la prostituzione, ma nonostante che molto lasci a
desiderare ne1la gestione del monaco benedettino, sappiamo chefu solo dopo la sua morte, che furono 'Ticenziate'le 'fanciulle' ol-tre i 36 anni di etàs7. Tuttavia f identificazione ta trovatella e
meretrice è propria anche ad altre aree geografiche, il Sud peresempio, dove poche, peraltro, sono le testimonianze sulf infan-zia ffasmesseci8S.
L'intento dell'ospedale fiorentino delle origini era dunquequeilo del reinserimento dei trovatelli nelle famiglie, nelle attivitàartigianali cittadine. L'ospedale doveva poi, forse, almeno nelleintÀzioni dei fondatori, rispondere ad.rnu utilità corporativa. Èin quest'ottica, di un iniziù,e quanto singolare progetto di 'opifi-cio' a carico delf istituzione, che forse può essere inserito e com-preso l'a,uvio al lavoro di molte delle fanciulle nella seconda metà
del Quattrocento, epoca di rodaggio, per così dire, e forse 'aurea'delf istituzione fiorenrina.
A fronte dunque de1 servizio reso in cambio della dote, tra ilI45I ei1472,1ly% delle bambine awiate allavoro, di età com-presa tra gli otto e i dieci anni, risultano <<aconciate» in gruppi didue, tre per volta, presso attività fam/ltari cittadine per <<nettare>>,
<<trarre>>, <<incannare>> la <<seta cruda>> in cambio di un salario8e. Si
::altain genere di sistemazioni presso donne definite <<maestre>> e
corrispondenti all'apprendistato dei coetanei maschi in alffe oc-cupazioni. Tuttavta, nonostante Ie precauzioni dell'ospedale, gliabusi si perpetravano comunque a danno delle bambine, dal man-cato pagamento dei salari, al bieco tentativo di sfruttamento del-le <<nocentine>> che, tuttavia, riescono in quest'epo ca afar propriele tecniche e ad ar,'viare all'interno delf istituzione la trasmissionedi un sapere che, se non 1e libera totalmente dalla tutela istituzio-nale, anzile rinserra ancor più, tuttavialeinnalza gerarchicamen-te nell'ambito del1a <<famiglia»e0.
Altrove, in altre istituzioni cittadine, le cose andavano ancorpeggio. E della fine del XVI secolo una supplica iniata al Gran-
97
duca dalle fanciulle dette.,della Pietà» nell',omonima istituzione,
anch'essa per fanciulle prive di famiglia, posta sempre a Firenze
in via del Mandorlo. Nel1a preghiera rivolta alla massima carica
politica cittadina, 1e povere fanciulie comunicavano di aver ripre-
so, in obbe dienza ai voleri granducali, la tessitura dei preziosi
broccati d,oro. Appare così una Firenze inedita cheutllizzala ma-
no d'opera f.*-ìt il" istituzionalizzataafinidi tornaconto e di lu-
.ro du cui non efano estfanei gli interessi della medesima corte
granducale.
Tutte s'infermano per il grande sraccamento di capo, cadono ca-
tarri irrimediabili deflà quali levatone una n'è morta del mese passato
che era delle prime -u.it." di detta arte, un'altra ne è del letto mala-
ta senza.p..rt ru di sanità, due altre di età d'anni 2) in circa comin-
ciano a bagliare e due di circa l0 anni no'1o possono più fare, a una
clelle quali"cadeva l'ugola, l'alfta no' r'ede più lume per tanto bisogno
del continuo insegnaie al che bisogna di molto tempo innanzi che 1o
sappino e delle dièci che si insegna non ne riesce due, tanto et c'è più
p".ài-"rr,o di tempo, e come sanno, presto s'infermano. Essendo noi
pou".a e non avendo nulla a1 mondo non le possiamo sostentare per
ianto humilmenre colle ginocchia in terra supplichiamo la benignità di
V.A.S., gli piaccia farci dare da1l'Arte deila seta qualche limosina sta-
bile per poier supplire al tempo dello insegnare e sistemare quelle che
si iniermano e farà qualcosa meglio a quelle che la fanno essendo che
l'arte tanta utilità ne trae che senza di loro non può fare, come seppe
V.A.S. che i drappi non si tornavano bene quando la dismessono e per
volontà della repubblica volentieri obedisconoel.
11 sizio dell'apprendistato prima, e la gravosità del lavoro poi,
tale da privare Jella salute le povere ragazze, tanto da portade a
morte, ci rendono invisi quei capolavori trasmessi sino ai nostri
giorni e di cui la città toscana andava giustamente fiera in Euro-
pa. Tuttavia anche per la vicina Bologna, dove l'industria serica
iiu"rt. nel corso del XVI secolo, con alterne vicende, un'impor-tanza capilale nell'industria cittadina, si hanno testimonianze
dell'impiego della manodopera delle istituzioni assistenziali, spe-
cie dei fanciulli, nella produzione del filato, incannatura, torcitu-ra, con assoluta prevalenza, particolarmente a domicilio, e specie
per alcune fasi del1a lavorazione, dell'elemento femminile, donne
e bambinee2.
8. Spose con la dote
In ultimo, due parole anche sul matrimonio, l'esito finale, il piùambito dalle istituzioni, per le trovatelle. Vero è che le tagazze àa
marito esulano, forse, per età, dal contesto più propriamente de-
dicato alle bambine ma nel tardo Medioevo e per buona parte
dell'Epoca moderna le donne sono eterne minorenni e le trova-teile, nel particolare, restano perennemente sotto la tuteia del-1'ospedaie che le ha accolte a meno che non vadano spose.
I1 matrimonio e ancor prima la costituzione delia dote, la lorodipendenza, infine, dai contesti familiari e istituzionali, consento-no alle bambine, malgrado tutto e tutti, 1a trasmissione di testi-monianze di vita molteplici, negate ai coetanei maschi, la cui pre-
senza nel mondo delf infanzia si dissolve tutto sommato precoce-
mente con l'awio al lavoro tra i sette e i dodici anni, età in cui iefanciullette, al contrario, entrano sulla scena. Lo sapeva bene Gio-vanni di Paolo Morelli che, agli inizi del Quattrocento, a Firenze,
sorvola volutamente nella memoria genealogica del suo casato legiovani fanciulle con queste parole: <<Non è di bisogno fare me-
moria delle femmine, perché sono di piccoia età: quando sarà iltempo del maritare, se venÉlono a quello istato, allora ne faremomemoria>>er. I1 merito del ricordo andava principalmente a1la do-
re. A Giudicare dalle paroie di Bernardino da Feltre, autorevoiepredicatore, i padri di figlie in età da marito che potessero dor-
mire notti tranquille erano davvero pochi nel X\r secoio:
Qui abet tres vel quatuor filias r,ix potest maritare unam' desfano
le case et patris et mariti. Donne, teneo vestram rationem: non videtisvos che quando nascitur una femina per che se stavolta el sarrguel -Peperit? - Sic. - Quid? - Feminam - O, che tante donne? Iste dotes
faciunt i,enire filias in odium etiam proprijs matribus et fratribusea.
Per le trovatelle, succedeva più o meno la stessa cosa' Dimen-ticate a balia, l'ospedale le recuperava e memorizzava dai sei anni
in poi - l'awio al lavoro delle bambine è anticipato rispetto a quei-
Io'dei ragazzi - impegnandole a farsi la dote col proprio lavoro.
Di ritorno da questa forma di apprendistato. si poneva il proble-ma del cercar loro un marito.
A Firenze, dove il grande brefotrofio degli Innocenti tnizia a
funzionare da|1145,le memorie dei primi matrimoni iniziano a
partire significativamente solo da1 1169. Si può pensare.più che
àd .rru la".rn, del1e fonti per g1i anni che precedono, ad un im-
piego nella famiglia ospedalieia, che si andava formando, delle
priir" generazioÀi di trovatelle soprar,vissute al baliatico" Abbia-
mo inf-ani sopra accennato al progetto, peraltro mai attuato, di
opificio g.anàrcul", tutto al femminile, cui f istituzione avrebbe
dàrrrto flrse rispondere ne1l'ambito di un'udlità pubblica citta-
dina. Né è da scartare l'ipotesi che solo dopo i primi decenni
1'ospedale avesse maturato la propria 'normativa' in merito, e che
p..ì,uuunti tutto fosse rimesso alla buona volontà delle famiglie,
che accoglievano in casa le bambine con f impegno della costitu-
zione della dote. Senza contare, infine, che molto dovette impe-
gnare l'ospedale f intreccio di legami necessari a1''prazzamento'
iul mercato matrimoniale delle abbandonate.Comunque siano andate 1e cose, d,a\ Ue9 a\ 1501 , si ritrovano
nei Giornali e nei Memoriali deif istituzione solo 65 memorie di
avvenuti matrimoni, a1 ritmo dunque, tanto per farci un'idea. dipoco meno di due matrimoni all'anno o, se preferiamo, di tre ma-
irimoni ogni due anni o, per avere f impressione di una maggiore
frequenza, di cinque ogni quattro anni e così via, pari pi-u o meno
al4i/o circadeli. iopr^oisiute. Una percentuale molto bassa che
spiega 1'alto numero d.11" fanciulle rimaste in casa, probabilmen
tà aÀche a dispetto della dote loro costituita. Probabilmente non
tufte le ,uguri.riuscirrano ad ottenere una dote che avrebbe faci-
litato loro ii marrimonio. molto dipendeva dal ioro inserimento
nelle famiglie, come si è r'isto, dal1a disponibilità economica de1la
medesima istituzione, che appare tah'olta a costituire in prima
persona le doti per le trovatelle e, infine, dalle tamiglie di origine
àele medesime, chiamate, ne1 caso fossero individuate, ad inter-
venire economicamente.Significativo, per 1a comprensione delf indebitamento pro-
gr"rri,o dell'ospedale fiorentino nonostante ii brillante ar"vio, ilIo.ror.".. il suo riferirsi ai banchi di credito cittadino per la co-
stituzione delie doti. Ne1 1471 si iniziò così a fare la dote per quat-
tro delle fanciulle di casa, riferendosi al banco di Piero carnesec-
chi per l'acquisto di 96 fiorini da investire nel Monte delle Dotip"rì.tt" anni e rnezzo <<a fiorini 28 per cento>>e5. Tuttavia non
-rrr.uno i benefattori che costituirono la dote a più fanciuile' La
costituzione de1la dote del resto ritorna frequentemente nelle di-
i00
sposizioni testamentarie dell'epoca a dimostrazione dell'enormitàdel problema per le singoie famiglie e istituzioni, dato che i lasci-
ti andavano, talvolta, a beneficio anche delle discendenti oltre che
delle trovatelle. Nel 1466, un certo Francesco di Lorenzo istituì ladote sul Monte a ben l0 fanciulle <<de' Nocenti» di fiorini )0 cia-
scuna per anni 15, il tempo cioè della loro capitalizzazion€6,Delresto il Monte delle Doti accoglieva anchc i depositi a favore dimolte delle figlie delle più note famiglie fiorentineeT.
I1 ricorso al prestito e la carità dei benefattori erano ad ognimodo sistemi straordinari per ia costituzione deile doti delle tro-vatelle, perché le doti erano in genere, come si è accennato piùvolte, il frutto del lavoro del)e ragazze medesime:
Ricordo che insino a dì 7 di novembre 1479, messer Francesco no-
stro priore, maritò Marietta e Simona, nostra fanciulia di casa, che furechat, allo spedale a dì primo d'aprile llfi a Libro Balie segnato B
a c. 122. n.224 et maritalla a Chimento di Donato di Giovanni tessi-
tore di drappi sta a casa presso alla casa di San Barnaba e debbigli da-
re di dote {iorini25, soldi 9 d'oro di suggello in sul Monte che furonoguadagnati sino di luglio 1473, come appare al Libro del Monte delle
f'anciulle, Libro bianch o, c. ))3, et più quelle donora che a detto mes-
ser Francesco paresse volerle darees.
Nell'arco di tempo considerato le doti sono mediamente com-
prese tra le 100-i20lire, sino a raggiungere Ie 150lire alla fine del
Quattrocento, più altre 20-10 iire corrisposte in genere in <<dono-
ra>>, doni cioè che costituivano il corredo della fanciulla. Tuttaviain qualche caso straordinario - l'origine agiata della fanciulla - la
somma poteva raggiungere complessivamente le 200, persino le
100 lire. Nel i470, Francesca, figliuola di messer Andrea Mara-
maldo da Napoli, consenziente al suo matrimonio con un certo
Giuliano di Francesco del popolo di San Michele a Casignano, ri-
cevette 200 lire più 107 iire in <<donorarr. Caso ancora più singo-
lare, la madre di Francesca, <.per volontà del mariro e del padre'>
e <<consentimento>> del priore andò ad abitare con la figliaee. An-
che Margherita andata sposa nel 1498 a Pasquino di Frosino da
Lucolena ebbe 200 lire di dote, dove cento erano state date dalla
madre, serva di Girolamo Corbinellilot'. Ma, del resto, ie illegitti-me non di rado si sposavano proprio per la loro origine con piùr
101
facilità delle altre, anche per via dell'intervento in questi casi dei
mediatori, i <<mezzani>>, p^gatlevidentemente dalle famiglie di ap-
pafienenza, come successe più volte per le trovatelle sangimigna-
nesi, originate alf interno de1le facoltose famiglie di mercanti e
proprietari terrieri delia città e dei dintorni1o1.
Le doti corrisposte alle trovatelle ad ogni modo ammontavano
a cifre medie e poi verso la fine del secolo medio-basse, rispetto a
quelle generalmente costituite sul Monte, che, per il periodo pre-
cedente al 1480, Antony Molho ha indicato intorno ai)31 fiotini,cifra che viene quasi raddoppiata dopo tale fla1sroz. Esigue, infi-ne, se paragonate a quelle elargite ad alcune de11e figlie delle ric-
che famiglie fiorentine, costituite da varie centinaia di fiorini -ben 1500 fiorini costituiscono la dote della sorella di Giovanni
Morelli ai primi del Quattrocento - e motivo di non poche riven-
dicazioniin ambito familiare in caso di morte delle donne o di ve-
dovanzadelle medesimelor. Tuttavia nell'ambito del mercato ma-
trimoniale anche la dote delle trovatelle, mediamente tra denari e
panni intorno alle 150 iire, che rimangono più o meno inalterate
nel corso dei trenta anni considerati, corrisposta dagli Innocenti,poteva costituire un'ottima risorsa per le famiglie degli sposi'
A San Gimignano, la dote corrisposta era un po' inferiore ed
era intorno alle 100 lire, metà in <<panni>> e metà in contanti. Ver-
so la fine del secolo, tuttavia anche a San Gimignano si arrivò ad
un massimo di 130 lire, di cui ora 100 lire venivano date in con-
tanti e 30 in <<pannirrro+. 6 forse per 1a dote che le trovatelle san-
gimignanesi erano spose ambite daimezzadti della Valdelsa e tro-
uruuno marito ad un'età inferiore, 15-16 anni di media, rispetto
alle 'sorelle' fiorentine, la cui età si attestava invece prevalente-
mente sui 19-22 anni con punte anche di26 e 28 anni105. A Fi-
rcnze infattt, la costituzione di una dote non era altrettanto in-
consueta nella classe degli artigiani, e quella delle trovatelle in-
cideva forse di meno, sulla decisione di quest'ultimi al matrimo-nio con una movatella, rispetto aimezzadri della campagna. Cin-quanta, r,enticinque fiorini, cui probabilmente si aggiungeva ilcorredo, erano infatti una dote usuale anche per molte fiorentine,
le più povere naturalmente, che ie famiglie intendevano comun-
qrè dotut. sul Monte106. Una sola delle trovatelie, a1 contrario,Éene, andò sposa a 16 anni a un certo Lorenzo diJacopo del quar-
102
tiere di san Frediano di Firenze, uno dei più poveri della -città
e
i,r.-" al tltidcnza degli artigiani' con sole.90 iire di dorer0 '
"'"L;;;;:;;;;;#" 'o'':"'pon'ione
della dote ai nrariti' che a
San Gimignurro i-p.g,t"uu f i'tittt'lone in pagamenti,t?l::il-t-h:
drrruuuno-unche alcuni anni, poteva essere a F'trenze addlrlttura u
;;ilà;i;;r'io d.11" gio"aÀi spose all'ospedale se il pagamento
,loì .ru soddisfatto ur.rbito totalÀente' Nanna Piera' andata sposa
nel 1.170 all,età di 2L anl,ni aé,un certo Jacopo d'Ambrogio da Bel-
ii;;;"^, scardassiere, tornò agli Innocenti perche il marito non
,""r,u ,i..u.rto 1a dote. Ma Nanna era stata sposata senza 1I con-
senso dell'ospedale o peggio ancora a sua insaputa' ad opeLa det-
1a tenutaria:
lacooo diccr'a che chi gliela ai,cr..r maritata Jett:t lancru[la non gli
,,,.;.';;;ì;';lt-;;;; i'o"t'o et poi [u.sr'rra qui alquanro' Nic-
.àfi a.i §...h.ì-rrotuio 'icercendo faie la Jetta fanciulla ritornasse
.frlf À".iì.-aicie ebL'e dalla sop-'raddetta monna Tita una materassa'
;;;fi;;;.io'.,,, puioio fiù aitre masserizie le quali dicie consegnò
a detto JacoPoloE.
Nanna fu ripresa dal marito ed è probabile che 1'ospedaie ver-
t^r;;i.il;; f", di sistemarla in quìiche modo' Tah'olta' nono-
,ir"i"if r"golu.. pug,Àtr"o dela iote' ilcomoortamento dei ma-
riti era tale da ,i.fri"j.'" "t**À"'"t i'in'"ttt"'o deli'ospedale:
Ricordo ciie fino ^
d\ 72 di novembre.l'169 rirnase in deposito a
f..run,ràu, nelie mani cl'Antonio di Niccolò-di Biagio da Tetranuova
cli infrascrirti l'annr .;h-;;;ì;;;'ii'onn della Lucia' nosrra fanciulla
à1' Ju#.'ilii;;' F;#;o -di
i.r.,...co, abitante a Terranuova, la
ouale abbianlo fatra ,o*"t q'i in cma perche tletto Fabbratlo sc n ò
ioì r,",.,to lrsciata a Terranuora sola c [e cose sono ln n]ano dl Llet-
to Antoniol're'
Se il mestiere dei mariti in cafrpagna a san Gimignano era
ur;ìt;;p;". n.l .o"n a"i x' sccololqutllo ..lel lavoratoLe del-
i;;.^. ll'mezzadro,in città le ragazze degli Innocenti di Firenze
trovavano marito ,.u i h'àtunti àel ramò tessile' come gli scar-
;;r;"ri, i più po'eri del settore e spesso di origine straniera',sviz-
;;;;;;à;-hi'per lo più"", lvla non sono rari neppure i fabbri' i
tessitori, i muratori, icalzolai con un aumento progressivo dei la-
101
voratori della terra, alla fine de1 secolo e sempre più nel Cinque-
cento, epoca in cui, del resto, il destino dei trovatelli in genere si
,porr"rà dalla città alla campagna, neile-famiglie dei tenutari' Ma
in qr."rt,.poca le fortune commerciali e finanziarie di Firenze era-
no à.-ui ul tru.rrot to, 1o stato granducale imponeva nuovi assetti
e iorganizzazioni del territorio circostante le città. Da qui in avan-
tile rigazzesaranno sempre meno spose' nonostante la dote e più
spesso serve o contadinel11.
Note
I Per maggiori dettagli sull'andamento del1'abbandono nel Quattrocento, ri-
mando alle c'o"nsideraziài di V. Hunecke ,lntensità e fluttuazioni dey4l4!'y4-g
ii ial XV at XIX secolo, in Enfance abandonnée et société en Europe XlVe-XXe
siècle,Collecticndel'EcoleFrangaisedeRome-,Roma 1991, Pp 27-'J2 . -.'Cfr. p". questa cronologia àela ripresa del fenomeno dell'abbandono, -J.
Born.i. i;rbbàndooo dei baàbini in Eiropa occidentale,p1zzoTt, Milano i991,
pp. 205 sgg." i É..jt.pedaie senese che vanra un'origine.risalente alla fine de11'XI seco-
f., t,r...gfi*i,ra dei trovatelli è testimoniata dall'uitimo quarto.dei,XIII secolo,
ctr. G. Pi"ccinni, L. Vigni, Modelli di dssistenza ospedaliera rro Melioeuo ed Erà
nirirrrr, iiù'sictetà'1el bisogno. Pouertà. e assisienza nella Toscana metlieuale,
a cura di G. Pinto, Salimbeni, Firenze 1989, pp. 1'17-175 '- - i L.o" Battista Alberti, nel suo De ,, ardifirotorio, auspicava per i trovatelli
lu .o.t..,rio.r" di un luogo separato. Cfr. specialmenJe per questa evoluzione
;;*.;;*a de1l'assiiienza ai rovatelli, V. Hunecke, L'inuenzione dell'as_si-
ir;iioel, ,tpotsti nell'[talia del Quattrocen-to,]nBenetletto thi 11891t1' maledet'
}i ,il ,f*onao. L'infanzia abbaidonata nel Triueneto (secoli XV-XIX), a cura di
C. òrandi, Fonrlazione Benetton Studi Ricerche-Cano'a, Treviso 1997 , pp.213 -
Zà1. 4".t "
per G. Albini, Città e ospedali nelLtLomb,trdia rnedieuale. CLUEB,
il.;;1ti, , p. 162, Ia ,rrazionaiizzaztone>> quattrocentesca clegii ospedali
"poria , considèrare in modo nuovo la cura degli esposti>), così successe a Ber-
gX-o, g..r.iu, Como, Pavia, Crema, Mantova e natuìulmente a Milano'" ; bf.. per questo i1 mio le <<scritture del baliatico» in Toscana tra XV e XIX,rroto,it ioro àugt, Innocenti di Fìrenze, in Trouatelli e bdlie in ltalid secc. XV-
XIX, a c,tra di G-. Da Molin, Cacucct,Bari199l,pp' 471--490'i..Scafetta, e <<ruota>) sono i nomi dei due congegni, quello a forma di scafo
di nave e quello classico della ruota, in uso a venezia e vicenza appunto pef ac-
cogiiere i bambini.--'j all orp.dale degli Innocenti di Firenze, esistono i libretti scritti dalie <<so-
prabalie,, dtue sono ànnotrri gii appunri. per così dire, rig_uardantiogni bambi
no. r.ipresi poi iedclmenre dallo .scrivano dei bambini,, al tnomenlo dr strlare I
'verbali' ufficiali dell'introduzione.8 Mi riferisco all'opera di J. Bosrrell, L'abbandono dei bambini ctt'
104
e David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber hanno rilevato per la Toscanadai dati del catasto del 1421 un rapporto di mascolinità di circa 1 10, superiore aquello di 105 rilevato allanascita perpopolazioni note (D. Heriihy, Ch. Klapi-sch-Zuber, I toscani e la lorct famiglie. Uno studio Jal catasto fiorentino del 1127,tracl. it.,I1 Mulino, Bologna 1988, p. 4$\.Per il Quattrocento. relativamente aibambini, R. Trexler, Infanticidio: nuouefonti e primi risultati,in Famiglia e pote-re a Firenze nel Rinascimento,Istituto della Enciclopediaitaliana, Roma 1990, p.11, pone per la stessa epoca tale rapporto, relativamente all'età zero infantile, a114,60. A Milano, G. Albini, Cirtà e ospedali nella Lornbardia medieuale cit., p.158 pone tale tasso, relativarnente al primo anno di vita, a 776,40. Vedrerno inseguito l'importanza di questi dati ai fini della determinazione della mortalità.
ro Cfr. per questo il mio Modalità dall'abbandono dci fanciulli in area urband;gli esposti dell'ospedale di San Gallo di Firenze nella prima metà delXV secolo, tnEnfance aband.onnée et société en Europe XlVe-XXe siècle cit., pp. 99) 1015.
11 Cfr. i dati di D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber,I toscani e le loro famigliecit., p. 459 .
12 Cfr. Tomoko Takahashi, I bambini e i genitori'espositori' dello spedale dtSanta Maria degli Innocenti di Firenze nel XV secolo, in <<Annuario dell'IstitutoGiapponese di Culturar, XXV,1992, p.42.
tr Cfr. il mio L'ospedale di S Maria deila Scala di S. Gimignano nel Quattro-cento. Contributo alla storia dell'infanzia abbandonata, Biblioteca deila Miscel-laìea storica della Valdelsa, Firenze 1982. p. 188.
'a Cfr. G. Nbin| Città e ospedali nclla Lombardia medieualc cit., p. 175 innota.
15 È noto 1o studio di E.R. Coleman, L'infanticide ddns le Haut Moyen Age,in <<Annales ESC», malzo-aprile 1971, recentemente contestato tuttavia da P.Toubert, Il momento carolingio (secoli VilI-X), in Storia uniucrsale clella famiglia Medioeuo, Mondadori, Milano 1987, vol. I, p. )49, dove accredita l'ipotesiche l'ipermascolinità riscontrata dalla Coleman nel polittico di Saint-Germain-des-Prés sia da attribuirsi al matrimonio precoce delle figiie anziché alla loro si-stematica eliminazione.
16 Ph. Gavitt, Charity and children in Renaissance Florence. The Ospedale degli Innocenri 1410-1t36, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1990, p.210, è un convinto assertore del poco anore risenato alle figlie e di quella chelui definisce la tradizionale «Mediterranean misogynv». Tale attitudine all'ab-bandono più precoce delle femmine la si nota anche a San Gimignano cfr. il mioL'ospedale di S. Maria della Scala di S. Gìrnignano cit., p. l)1.
t7 Cfr. M.S. Mazzr,S. Raveggi, Gli uomini e le cose nelle campagne /iorenti-ne del Quatrrocento, Olschkl Firenze 1983. pp. T-60.
18 Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze (d'ora in avanti AOIF),ospedale di San Gallo, Balie e bambini ( 1425-1439), n. 9, c. )4.
1'Cfr. il mio Mo dalità dell'abbandono dei.fanciulli in area urbana cit., p. 1005.20 Ivi, p. 1006.2IIvi, p. 1005.
" AOIF, ospedale di San Gallo, Bahe e bambini (1425-1439), n. 9, c. l)4.2j Rimando al mio Modalità dell'abbandono dei fanciulll in area urbana cit.,
p. 1004.21 Ibid25 lbid
10,
2o lvi, p. 1005.2/Cfr.ilmioLaspecializzttzioneospe,lalierafiorentindglilnnocentiel.'as:i'
stenza all.int'anzia (XV XVI ie'rJot.i"'òtprdoli'e cit.tà L'ttilia del Centto-Nord.
ftii-XVi',i1r",i". iì"r"-aiaj. é.i.., e L. Sandri, Le Letrere, F*enze 7997,
oo.60-61."" I,"C"f.. R.C. Trexler. ln/anticirlio. nuouefonri e primi risultatrcit.. p- l). La
o"r..iuri.'aì ;";;il;à àJ[. Él*Èi"". ì.u i t ++r'" tl 1154. risulrerebbe inle'
il* ;"il;;i;ìli;;;; ira )8.eoo e 5(r'eeo.)-risperto al loro ingresso' mentre
;;;i;;i*rtÀi ,isrlr, ,upt'ìott dcl 2'2" rdifferenza tra 4lo.o e 43%)'
'-'l;òft. ph. Cruitt, Chaiirt dnJ chldten cit ' pp' 215 sgg'
,. òi;. i. ;rÈ;il' del^ti Modalità dett'abbaidono dei fanciullt in area urba-
na cit., pp.1012-1015"-'ii ifi. li mio L'ospelale di S. Maria della scdla di S. Ginignano cit' p l8E'
Al 4lqo degli ingressi *r*f.ifi."..itp.rJ" it 4l% ài *ottàlità maschile e al
01",. ai ingiessi flmminili il 58oo di morti'"' ';. èf.:èil.'ild".h i;; r, i ii*t ,,", ld memoria e la morte' tn Storia
aru'tri*iii'r"i.i."»iii;e""t'ità al Seicento'a cura di E' Becchi e D' Julia' La-
terza, Roma-B ati 1996, PP' 170- 17 1'*'1 A;.;;Fi_nz.',ò. n.Àrrr,, òr, Ktapisch-Zube r.I toscdni e le lorc fami-
slie cit., pp.6D rgg. g p.tiii-; G' Albiti' Città e o'spedali nella Lombardia
medieuale cit., P. 158ra cfr. il mio L'assistenza nei ptimi due secoli di attiuità, in Gli Innocenti
.e
Firenze nei secotl u, ospe'd)ir, in'ouh*io, una città,Soes. Firenze 1997, pp. 6J-
65rper Arezzo.fr. A M#;i''L''i'*iii'i p':'ii'1i1'à cotntradderta i"gcttatel'
li,.rnStorie di untenza, ";;;;,-;;A;;;'zZ e iigiustizie nell'Atezzo delpassato'Ri-
ceica Fonti e Studi, Atezzo 1989, p' 64'.)5 cfr. Nati , obbordà"riti.",ll$rù lr*ografici-e sociali dell'infanzia abban-
dorr t r'i t to'iio n e ll' e t à m ode rn a, Cacucci' Bari 199)' PP !7'sgg'-" 'l;ft,r""ao p., qr.r* e alffe considerazioni al mio Baliatico mercefl(trrc e
" b b r r;;;;' ;; ; io * bi o t,itr-,, i ii i ri r r i a s s i s t e n zi a li :. u n m e d e s i m o di s a gi o s o ci a -
;;.";D:;;;;;i,,iii ,,ti:i,,i,,";;;;;';i;, ^cura di M G Muzzarelli' P' Galetti
'Jn. iiar."Ui i[à*"U.tg a' §eilier, Torino 1991' pp e1'70)'Sono convinta in-
fatti che la scarsa pr.r.n,iìlÈlÀui"i it' i pout'i òlt" chc per via degli,efferti
i.ù;;;;;;;;;.;, ,iù"^*."r", cui si riferisce ch K.laoisch-Zul:er.tt ban-
brno. ld mcmoria , t, *"ìii'(Cit"-pi 'rì)-'izi'
the certo doveua allungare alm'e
""li""r"" -ii't","*ru;';';; ;;it t ì ult'o' fosse dovuta principalmente alla
morte e alÌtabbandono dei figii'"'"';; A;;-f.." t, tpolu tri Barbiano, Buonriposo, Montaione- nuovamente
B^rbi;;, ò;;1;"i, b. òi'"ìg"'no,.Casaglia e-intltimo ancora S' Gimignano'
;f, "ilffi u;;;;;;t; dt { iril" det'ta scala di S' Gimignano cit'' p' 165'
"' ;AòIF,;"peàale di San Gimignano' n' 1'1' cc' 11' 14-15'
re AOIF, wi, cc. 17,21-22'1o AOIF, ivi, cc.54, 61'11 AOIF, ivi, c. 19. 1 t a \n -.-:- )^r. (--., bÌì.. p", gli illegittimi sangimignanesi.l,mio-L'ospedale S Mdria della Sc"-
la di S. Gimrsnano cit..p;3; ;g; ;' p* Fi1t1"' Tomoko Takahashi' I banbini', iiiiiri':ài'à,,ì,iii, irfi, ,iiiit, diso,ro Maria.derlitnnocenti cir.. pp. 5 3 sgg.
+ Cfr. il ^io f o,priilr'ii i' Uo'in del la Sca,ln di S G t nignano cit' p. 158'
* òi.. c. Nbifri,' c;-;;- ; osp edati nella Lombardia m edieuale cit., p. 168.
106
ìII:
a, Cfr. Ch. Klapisch-Zuber,Genitori di sangue, «genitori» di.ryy::^ry/!'rnigliai le doone ,il Nnascimento a Firenze,Laterza, Roma-Bari 1988, p.241."""";RiÉ;;aala
citazioneda D. Herlihy, Ch' Klapisch-Z'tber,I toscani e le lo'
ro fanziglie cit., p. 7 6L." "-iiAt .O.ò. H"glr"., Ideali domestici e compottdlnento sociale: testirnonian-
," d,ù è*oi, ;;'d*r;t",, n La famiglia nelli storia' Cornportarnenti sociali e
idea:li domestici, ^ cùt^di Ch.E' Rosemberg, Tonno 1979, pp' 148-181'
48 AOIF, Estranei,n" 89, c. l9u.oe Cfr,, ancorarr.ra rolt", l.mio L'ospedale di S' Maria della Scala di S' Gimi-
gnano cit., pp.136 B7 '" " ;; ai;. pà. qr.rro e altri interessanri spunti A. Moriani, La larniglia predica-
ta e contraddetta cit., P. 65.--' - ;iai.. ù. È ani,'ùospedale di San Procolo o deiBdstardini traMedioeuo e Ri-
,rtti;;;;;,i:;i;'tn àiit. pntri*onio e memoria di un ospedale bolognese'Edi-
zioni Age, Bologna 1990' P. 18. ----- ,, ifr..o", f pro*.di-enti dell'ospedale nei confronti delle balie colpevo-
li. il mio t',àspedàt, di S. Mdria della Scala di S. Gimignano cit., _pp. 1.13.-154. .."' ";'S"fil;;Ji, d"ibr*b- i abahaè significativò il caso dell'ospedale della
Mir"ri;oodi;;Dolce di Praro, particolar-ànt. u..ruto da questa.calamità, si ve-
da il mio Le <<soitture del baliatico» in Toscana cit., p. 481. Su-ll',argomento det
maltrattamenti anche E. Badinter, L'anzote in più. Storia dell'amote rndterno," trad. it., Longanesi, Milano 1981.
5a ifr. aricora una volra la messe inesauribile di notizie che si può trarreperoiù versi ma specialmente per la famiglia toscana del Quattrocento in D. Her-
iit r. Ct',. Klapisch-Zuber, i toscani e le loro famiglie cit', p' 447 '--''''iètr. O. uufton, Destini lemminili. Storia delle donne in Europa
-1500-
1800, Mondadori, Milano L996,pp' 163-168'56 AOIF, Estranei,n.54, c.79u.
'? AOIF, i.;^, c.5u p"i l;ubb*dot o della bambina e c' 18 per le spese rela-
tive al bambino.58 AOIF, ivi, c. 8.
'e AOIF, ivt, t 624, cc. 80-89.oo Rimando pe, qrÌ.itu purt. sull'adozione a-l_ mio La richiesta dlflelt 1a.ad91
,r* aiirii-iitf, Ja);sfieiiorcntine tra XIV eXV secolo.in «Annali aretini>,,IIl
iitgr:AX'I"."gnu d.iGiglio, Firenze 1995, pp' 117'D5, e per la maggiore na'
irfr,a ,n t"-po ài p.rt. u Ò. Herlihy, Ch' Klapisch-Zubet' l toscani e le loro Ja-
miplie cir.. o.269.'ii Cf.. il mio La richiesta di figli dd arloì'ffare cit', p ' 121't afr. ò. Nbin', Città e o$edali nella Lombardia medieuale cit', p' 175 '63 Cfr. il mio l,a richiesta di figb da adottare cit', p' 126'60 lbid.65 AOIF, Estranei,n' 54' c' 14.66 Cfr. il mio La ricbiesta di figli da adottare cit', p ' 127 '61 lvi,p.l)L.68 lvi, p. L33.n, p..iu p."ttituzione aFirelze, cfr. M.S. Mazzi, Il mondo della.prostitu-
,lon, "rtto-f
iliiii borro-*rdiruale,'rn Forestieri e stranieri nelle città basso-me'
dieuali,sahnbeni, Firenze 1988, pp' l?7 147 . 1 ,,,r. 1.-""";;ffr,;;rliuuoto delle dorrè, G. Piccinni, Le donne nella uita dell'ltaha
:
t
107
nedieaale, n Il lzaoro delle donne, a cura di A' Groppi, Laterza, Roma-Bari
1996. pp. i-+0. So['in p or:;arlLzadelle donne nella riproduzione delle illustri ca'
sate fiòientine, c{r. Ch. Klapisch-Zuber, La faniglia e le donne nel Rinascimet-
to a Firenze,Laterza, Roma-Bari 1988.7 1 Cfr. , per l'oblaz ione e I'epoca del suo declino , J ' Boswell, L'a bbando-no dei
banbini cit^., p. 202 e sull'oblùone anche A. Gidlongo, Il bambino medieoale'
Educazione ed infanzia nel Medioeoo, Dedalo, Bari 1990'-pp. 64 sgg.zz Cfr. G. Albini,Città e ospedali nellaLonbadia meiliettale cit.,pP. Y1 sgg.7' Cfr. M.S. Mazzi,S. Ravèggi, Gli uomini e le cose nelle campagne fiorenti-
ne del Quattrocento at.,p.201.
'o L'i' PP' 2Ll-212'7, Cfr.-eh. Klapisch-Zuber,la faniglia e le donne cit.' pp' 105 sgg. .-% Ctr., per la ,,ita dei fanciulli all'intemo dell'ospedale {iorentino, il mio
L'assistenzi'nei pitni dae secoli di attiuità cit., pp.59-83. À41 p.l il gioco, anzi
per i balocchi medierrali, cfr. P. Guarduca, Il'balocco' nel Medioato italiano.
Ùna tustimonianzt stoica, archeologica e di cultura nateiale, Salimbeni, Firen-
ze 1986.77 A Milano è il caso di Maddalena del 1481, presa in prova per due mesi:
cfr. G. Albini, Città e ospedali nella Lombardia medieaale cit.,-p- 176.- -
78 cfr. il mio Fa nciuili e fanciulle «posti con ahi» allospedale degli Innocen-
ti di Filenze: note pel urra storia del kioro minorile nelh seconda netà dc.l-Qaat-
trocento, n Senza'famiglia. Modetli demografici e socialt dellinfanzia abbando-
nata e dellassistenza inltalia (secc. XV'XX),a cura di G. Da Molin, Cacucci, Ba-
irD7,p.230.7e lvt, p. 17 6.§lvr,p.2)1.8t IUl.82 AOIF, Estranei, * 55, c. 21.8' Cfr. il mio Baliatico nercenario e abbandono dci banbini cit.,p.98.e Cfr. D. Herlihy, Ch. Klapiscl-Ztber,I toscani e le lorofanigliecit.,p'789.
Per la prostituzione, esercitatà frequentemente dalle ragazze povere, anche O'Hufton, Des tini femminili at., P. 277 .
8' ifr., per luesto, M.S. Mazzi; ll nondo della prostituzione nelk Firenze
bassonedieoale cit., pp. 127'147.86 AOIF, s. |J, n. l, c.29u.e7 AOI§',Libro di partiti e uendite d.i beni del 1579r s',8, 1 2, c.2; cft. anche,questo, M. FubniLertzzi,<.Dell'allogare lefanciulle deglilnnoceflti»»: ilnpro'per questo, M. Fubini Leuzzi, <'Dell' allogare le fanciulle degli Innocezti»» : an pro'
'blrin *huralc ed economico, 1577'165r,nDisciplina dell'anima, disciplina dcl'birrin ih"rot ed economico, 1577-165i,nDisaphna deil'anima, ùsaplna del
corpo e disciplina della società tra nedioeao ed età tnodema,a crra di P. Prodi, !Mulino, Boiogna 1994, pp. 86r-899. Per l'operato di do1 lqcegzo Borghini,confronta 11àio L'atduià di deposito e prestlto nell'ospedale degli Innocenti diFirenze: donVincenzo Borghini"e k'ban'carotta' del 1579,nL'utiliuo del 1n9'ro nei luogbi p/,r, Afti del .orr"gno, tenuto Presso l'Istituto italo-germanico ini ;;; ;; -16 r*.*uì. r »ii, il;;;dinto, 19-20 norrembre 19yE, m corso dr stampa'
s Cfr. L. Livieri,L'arnore per linfanzia nel Meaogiorno st)eoo, in <<Quader'
ni medievali», n. 42, dicembre 1996,pp. $'72.8e Rimando ù mio Faaciulli e fanciulle «pos ti con ahi» cit., pp. D2-233.nIvr,p.234.er AOIF, Affai, frlza n. 61, anni L594-15».
108
e2 Cfr. N. Terpstra, asped.ali e barubini abbarydgyyti a Bologna ttel Rinasci-
*rn,olin'Oìria)Li e ci*à. i;i"trt," del Centro-Nord, XUI-XYI secolo cit.,pp.225''j:ii i'i,:ri,,,'.i.". à.iÉr-Uì"i"i,, g"n"r.
""llr lavorazlone de1la seta e per la pre-
ii'"-l il.Hi;"il;; i;; .i, C T""i' Tecnotoyie' o.rganizznione,!-,Ju:"':.'';i""-r*;;;;r,r"le
del lduoro:il caso dei mulini da seta,in ll lauoro dell( donne ctt.,
oo.269'296.'u :y*Or.;ao la citazione,lc L. Fabbri. Tyattatis/ita e pralico dell'alleonza ma-
rrìtnonialc.in Sroria art *nir)il,)oii" n tu" di M De Ciorgio e Ch Klapisch Zu'
ber . Laterza, Roma-Bari 79c)6 ' p ' 91 '
ea Ivi, p. 108.9, AOIF, s. i2, n. I, c. 122' Per i1 Nlonte' detb Doti istituito a Firenze da1
|425,cfu.A. Molho, trr$tl*'ntì n)t tu'Io"' tlelleDoti diFirenze IJn'analisi so-
)irt 'r'ùr-iifi*, in'..Q,-,aderni storici>>, n' 1' 1986' pp' 147 r50'
'6 AOIF, s. 12, n. l, cc.87u-89'
" Cfi. ,"..r, [. Molho, tr*, timenti nel Monte delle Doti cit' ' p 153 '
eE AOIF, s 1l, n. 2, c.l)u'ee AOIF, ivi, c. 182u.1oo AOIF, s. 12, n.3, c. l5u.,., crì.i l"i" i\irpr'aoli ai s Maria della scala di S. Giruignano cir., pp. 184
185.'to' 61r. A. Mo1ho, Inuestimenri nelMonte delleDoticit ' P' 15J . ,, ,
1o, nJrrrrr;16 al lavoro di 1. Chabot, Risorse e diritti patrimonnlt,tn Ll tiuoro
delle donnc cit . pp. 46-70 ,cdale di S Ma,ia clell,t Sca--'""io.,
l1r. 0., là doti di San Gimignano il mio L osp
ta di S. Gimignano cit., PP. 185 sgg'ror O. Hufton, D estini femmìt1icit., p. 99, sostiene irfatti chele ragazze ric-
che si sposavano Prima*-- il'Cir ,t. ntàtho. Inuestitnenti nelMonte delleDoti cit'' p' 151'
107 AOIF, s. 11, n. 1, c. 160.r''* AOlf , iti, c' l62u'1oe AOIF' ivi' c' l)6u'
renze del Quatirocento' d-tin p". 1u'Or.r.nza straniera e forestiera nella.Fi:
manclo al mio straniert , fi;;;';';;;;ti' i;'1'19 del o-uattrocento attrauerso i li- ,
bri tli ricordi e di enydttl';;;;;;'d;;i;;'i'iot; 'tttof i'inForestieri e stranieti
nellc ctttd basso-taedieuah cit ' pp L49-161'"" ì,ì"n rr"ao per Io ,urlrppo'.rqrecenresco.al mio Dinowtcbe politico i.sti'
tuzionali e sorte tieglì ,tp'itiitr'ltitiii'lt !cgti lnnocenti "t Firenze (se'oli X\'-
XVI),nBenedetto-chi ti porta cit , pp' 61'7) '