René Vautier, Fanny Colonna: l'Algeria di ieri e quella di oggi
Firenze e la cura dell'infanzia abbandonata. L'Ospedale degli Innocenti ieri e oggi, con Lucia...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Firenze e la cura dell'infanzia abbandonata. L'Ospedale degli Innocenti ieri e oggi, con Lucia...
IL DIRIITODI ESSERE BAMBINOFamiglia, societae responsabilità educativaa cura di Francesca Mazzucchelli
FrancoAn§eli
lndice
lntroduzione, di Francesca Mazzucchelli
Parte prima - La famiglia: attualità e complessitàdel tema
1. La conoscenza dei bisogni: problemi e prospettive,di Cinzia Canali e Tiziano Vecchiato
1. Considerare i bisogni dei bambini e deirugazzi2. Problemi aperti3. Selezionare per personalizzarc4. Rappresentazioni del bisogno5. La rappresentazione del bisogno è condizione tecnica per la
valutazione di efficacia
2. Quali diritti per i figli minori alla Iuce della recentenormativa del 2006 e della sua applicazione?, diElena Merlini
1. I1 diritto alla bigenitorialità2. Il diritto a conservare la più ampia identità parentale3. Il diritto ad essere ascoltati4. I1 diritto alla stessa tutela giuridica per i fig1i legittimi e per i
figli naturali5. Riflessioni conclusive
3. Nascere e crescere in salute: un diritto da "educa-re", di Alberto Pellai
1. Profilo di salute delf infanzia in Italia2. Solitudine e disagio psicoaffettivo3. La salute: un nuovo paradigma
pag.
>> lg»19>> 22>> 25>> 26
36373940
4t43
>> 44>> 44>> 46»48
32
4. La sfida del futuro: aiutare i bambini a diventare i veri prota-gonisti del loro percorso di salute
5. Cosa realmente è l'educazione alla salute di un bambino
4. ll gruppo clinico-dinamico con i genitori: una inno-vativa forma di sostegno alla competenza genito-riale, di Fiorella Pezzoli
1. Introduzione2. Varietà dei modi di fare famiglia3. Autorealizzazione e ideologia felicista4. Questione identitaria e la funzione di cura5. Il gruppo clinico-dinamico con i genitori6. Matrici famigliari e fattori trasformativi gruppoanalitici7. La prevenzione dei disturbi psichici in età evolutiva8. Il *ostegno alla genitorialità problematica9. [,u definizione del dispositivo10, Lu ceinduy.ioneI l, Conclunioni
Hmponmbllltt tducatlve della famiglia e contestotO0tlla, di F'rancex:o BellettiFremessa: la famiglia al primo posto...Alcune qualità dell' educazioneLa t'amiglia non educa da solaE possibile un'alleanza educativa tra famiglia e contestosociale?
6. Famiglia in emigrazione tra vicinanze e lontananze.di Chiara Lainati
1. Fare famiglia in emigrazione2. Famiglie in emigrazione tra scelte individuali e fenomeni
sociali3. Genitori e figli in emigrazione
Parte seconda - La relazione educativa:momenti e istituzioni
1. ll diritto all'educazione, di Francesca Mazzucchelli1. Larclazione come condizione naturale dell'uomo2. Il figlio di famiglie in difficoltà3. Il bisogno di relazione in adolescenza4. La responsabilità educativa
t.
t.2.3.4.
pag. 49» 51
>> 54>> 54>> 57»59>> 62»65>> 69>> 7l>> 73>> 74>> 75>> 7J
5. La responsabilità degli adulti6. Responsabilità sociali verso le nuove generazioni.
come agelzia educativa7 . La formazione degli operatori sociali8. Larelazione clinica9. Lafalica di crescere10. Crescere al di fuori della propria famiglia11. La famiglia che danneggia e la famiglia che cura12, In conclusione
pag.La scuola
118
r19120t2.lr22r24t24t28
2. ll bambino tradito: la negazione dei diritti dell'in-lanzia, di Sarah Miragoli e Elisa Stagni Brenca
1. Il bambino nel mondo2. I cambiamenti della società e il rispetto dei bisogni del bam-
bino nel nostro Paese
3. I1 trauma dell'infanzia violata
3. Modi diversi di cura ed educazione dei bambinipiccoli: i contesti relazionali, di Augusta Foni
1. Alla nascita di un bambino2. La ripresa del lavoro della madre3. La collaborazione con Ia nonna4. La collaborazione con la "signora" o con la baby sitter5. La collaborazione con le educatrici del nido6. Uesperienza dei bambini
4. ll rapporto scuola-famiglia: storia e realtà attuale, diLino Sartori
Premessa1. Considerazioni preliminari: alcune difficoltà oggettive2. Riferimenti normativi3. La relazione scuola-famiglia: scuola dell'infanzia4. La relazione scuola-famiglia: scuola elementare5. La relazione scuola-famiglia: scuola media6. La relazione scuola-famiglia: scuola secondaria di secondo
grado
5. Responsabilità genitoriale e sviluppo del pensieroin adolescenza, di Giuseppe Pellizzari
6. Significato relazionale e simbolico dello scambiosessuale nella nuova adolescenza, di G. PietropolliCharmet
130130
138r42
>> 79>> 79>> 82»84
9I9t
94ta2
87
150151
t52t54156158160
r64t64t64168t70t7lt72
t75
178» i13» 113» 115» 116>> 177 t99
Parte terza - Minori e famiglia nelta storiae nella letteratura
1. Firenze e la cura dell'infanzia abbandonata. L,ospe-dale degli lnnocenti ieri e oggi, di Lucict Nenctoii eLucia Sandri
Premessal. Dalla lotta contro l'eresia all'esercizio della carità: alle origi-
ni dell'assistenza all'infanzia abbandonata a Firenze2. Rinascimento e cura deil'infanzia: la fondazione a Firenze di
un 'luogo'per i fanciulli3. Educazione e vita dei 'nocentini'dal XVI al XVilI secolo con
brevi nore sugli aiuti alle madri nubili tra xvIII e XX secolo-+. Da sei secoli, ininterrottamente, I'Istituto degli Innocenti
accoglie bambine e bambini in difficoltà. La tutela dei dirittidell'infanzia resra la missione dell'antica istituzione laica fio-rentina. o-egi sempre più impe-enata in attività di ricerca socia-le e promozione culturale
2. Relazioni familiari e generazionali: uno sguardoetnografico, di Giovanna Salvioni
l. Rapporti con la madre, con il padre e con i fratelìi2. Rapporti con i nonni e i gruppi di età
3. La famiglia nell'ebraismo, di ptnlo De Benedetti
4. Le "parole necc.ssarie" tra genitori e figli nelleopere di Natalia Ginzburg, di paola ponri
1. Il dialogo con le umane manchevolezze2. Silenziose vendette, mute disperazioni3. "Essere un impiastro": Ia maùnconia di diventare srandi4. Parlare con un "essere balordo,,
Gli Autori
pag. 209» 209
>> 210
» 213
» 214
" 216
» 220» 221» 229
» 235
» 240» 210» 243» 245» 248
253
1. Firenze e Ia cura dell'infanzia abbandonata.l- Ospedale degli lnnocenti ieri e oggi
di Lucia Nencioni e Lucia Sandrit
Premessa2
La comprensione del Presente awiene anche attraverso la conoscenza del
Passato. Là storia della povertà, degli interventi assistenziali, prodotti nelle
varie epoche a sostegno degli emarginati, bambini compresi, rappresentano
ormai ambiti di riceréa consolidati della Nuova Storia. Anche la storia della
famiglia, dei comportamenti familiari, dell'attitudine alla cura dei figli nelle
varie epoche e ai vari livelli della società, coniugata a quelladeqli eventi poli-
tici, ecònomici, religiosi e culturali, rappresenta un bagaglio di conoscenze
utili specie per chi opera nell'ambito di istituzioni, come la nostra, contrasse-
gnateìafl'impegno profuso a bambini abbandonati, madri nubili e famiglie indifficoltà.
In questa occasione è stata colta da chi scrive l'opportunità di dar forma a
riflessiòni e di formulare ipotesi sugli eventi, che portarono la 'città di Dante'
a prendersi cura dei piccoli abbanaonati. Per quanto modesto,-l'approfondi-
mànto della conoscenza del7a carità delle origini, permetterà di seguire con
più agio gli avvenimenti, che portalono, a Firenze, alla costru.Aione, a metà
àel xV sécolo, dell'ospedale degli Innocenti, ponendo le basi di un'attivitàassistenziale all'infanzla e alla famiglia, esemplare nei secot, continuata sino
ai giorni nostri.1t primo dei paragrafi che segue è dedicato all'origine dell'accoglienza
agli abbandonati, intesa come promossa dalla predicazioneAancescana e do-
,i"oi.*u nella lotta contro l'eresia. Nel secondo paragrafo ho voluto rico-
sffuire la valenza delf infanzia nel Rinascimento e il suo coagularsi intorno
l. Lucia Nencioni e Lucia Sandri, svolgono la loro attività presso l'Istituto degli Innocenti
di Firenze. Lucia Nencioni, giomalista, è la responsabile dell'Ufftcio Stampa; Lucia Sandri,
storica, è la responsabile dell'Archivio.2. Sono di Lucia Sandri la Premessa e i paragrafi n. 1,2 e 3. Il paragrafo n. 4 è di Lucia
Nencioni.
209
alla fondazione del grande brefotrofio degli Innocenti. Nel terzo ed ultimo pa-ragratb è stata affrontata, in forma sintetica, I'esemplarità educativa della pie-na età rinascimentale, accennando alla caduta di tono dei secoli successivi,base però di una nuova prassi assistenziale, che passando attraverso modalitàestreme, si andava costruendo positivamente sull'esperienza di nuovi rapporliinstaurati con gli assistiti, madri e figli.
Nell'ultimo paragrafo, di Lucia Nencioni, viene ricollegata la valenza sto-rica delle origini alle finalità attuali dell'lstituto, di cui è fornita Lrna dettaglia-ta esemplificazione.
1. Dalla lotta contro l'eresia all'esercizio della carità: alleorigini dell'assistenza all'infanzia abbandonata a Firenze
L'abbandono dei bambini, documentato sino dall'antichità classica - a
Roma esisteva la Columna lactaria per l'esposizione dei neonati3 - è la con-dizione dell'infanzia che nel corso dei secoli, è stata oggetto di interventi as-
sistenziali diversificati nelle città della penisola. Si può affermare che il fèno-meno dell'abbandono dei bambini sia stato, paradossahnente, una componen-te determinante dello sviluppo della cura 'sociale' dell'infanzia in genere, co-dificatasi a partire dal Basso Medioevo.
Per I'Alto Medioevo infatti (VIII-X secolo) e ancora per l'XI e XII, le no-tizie di aiuti ai piccoli abbandonati sono riconducibili unìcamente ad iniziati-ve di personaggi leggendari (per es. I'arciprete Dateo per Milano, il ciabattinoSorore per Siena) di cui si dà notizia in documenti di epoca molto più tarda(XVIII secolo) e dunque poco attendibili.
Le fondazioni di luoghi di accoglienza, nati per il soccorso di tutti, bambi-ni compresi, frutto di una rinnovata spiritualità religiosa ma anche, e princi-palmente, frutto della devozione laicaa, iniziarono a comparire tra XII-XIIsecolo, quando il numero di cittzì e il loro peso demografìco, raggiunse il cul-mine nella nostra penisola e nel resto dell'Europa allora conosciuta.
L'assistenza ai piccoli abbandonati è infatti un evento attestato in ambitocittadino, connesso all'urbanizzazione, alla viabilità, alla ripresa economica,allo sviluppo parallelo di altre tipologie assistenziali, dirette al mondo dei po-veri, degli ammalati e degli emarginati in genere, che avevano ricevuto impul-so, come si vuole dimostrare, a seguito della predicazione dei frati minori,specie nel periodo che li vide impegnati nella lotta contro 1'eresia.
II territorio toscano, non era restato immune, tra XII e XIII secolo, dalladiffusione dei movimenti ereticali (catari, patarini), seguiti all'importante
3. Cfi. per Roma R. Frasc4 Figure e vicende di bambine romane in Le bambine nel.la sto-ria dell'educaz.ione a cura di Simonetta Ulivieri, Editori Laterza, Bari 1999, p. 1 1.
4. Cfi., A. Vauchez. I laici nel Medioevo: prrfiiche ed esperienze religiose,ll Saggiatore,Milano 1989.
rifbrma della chiesa voluta da Gregorio VII nell'Xl secolo. La prescnza dcl'maligno' in Toscana ai primi del'200 è testimoniata anche nell'iconografìa.Basti pensare, per esempio, alla rappresentazione che Giotto fece, nella basi-lica superiore di Assisi, della 'Cacciata dei diavoli' da Arezzo, operata, secon-do la leggenda, nel 1211, da San Francesco.
Ai primi del XIII secolo, un "diavolo grandissimo con più bocche", canr-peggiava anche sulla facciata della chiesa dell'ospedale subur-bano fiorentino,di San Gallo, luogo dove trovò asilo il medesirno Francesco, prima della co-struzione del convento di Santa Croce'.
L ospedale di San Gallo, fondato nel 1218, da Guidalotto di Volto dall'Or-co, riveste un ruolo importante in quest'ambito, perchè è la prima strutturache accolse, a Firenze, i piccoli abbandonati. Guidalotto, laico e devoto, fu di-fatti un fedele sostenitore dell'operato del domenicano Pietro da Verona (SanPier Martire)6, venuto in città al 1244, per svolgere la sua opera cli inquisitore.'fale 'vocazione' del fbndatore, insieme alla presenza di Francesco, fece sì che1'ospedale di San Gallo, peraltro intitolato proprio ad un santo evangelizzato-re, divenisse la prima sede, a Firenze, del tribunale delf inquisizioneT.
La convergenza di personaggi e avvenimenti di tal genere sull'ospedale diSan Gallo, caratterizzato da un'attività polifunzionale che incluse, primo fiatutti in città, l'accoglienza dei piccoli abbandonati, consente di sostenere chel'accoglienza degli abbandonati anche a Firenze fèce seguito alla predicazio-ne dei minori, impegnati nella lotta contro I'eresia.
L'ospedale di San Gallo, inoltre, annesso agli Innocenti alla metà del XVsecolo, eserciterà sul nuovo Ente, destinato a divenire nei secoli il prototipodell'accoglienza alf infanzia nel mondo, un'influenza determinante.
L'importanza rivestita dal San Gallo per gli Innocenti (modalità di assi-stenza e altro), può essere colta già a partire dall'emblema dell'antico ospeda-le di San Gallo, un bambino fasciato all'interno di un calicelplla, ulllizzal,rsper qualche tempo dal nuovo brefbtrotio, che farà suo invece, in seguito, il'putto'ritto in fasces.
Ueresia dei fiorentini consisteva dunque oltre che nell'abbandono dei pro-pri figli, che poteva equivalere comunque ad un infanticidio per i modi in cuiera eff'ettuato, nell'omissione del battesrmo, peccato quest'ultimo di cui sirendevano colpevoli tra l'altro alcuni eretici, per i quali il battesimo sommini-strato dalla Chiesa non avrebbe avuto valore ai fini della salvezza eternae.
5. Cfi., D. Moreni, Notizie istoriche'dei cotttorni di Firenze, purte terza, dal,la porta a SttnOalb .fino aLLu città di l'iesoLe, raccoLte dctLl'abate Dunenico Moreni so<:io col.ombttrio, PerG aetano Carnbiagi Stampatore Granducal e, Fi renze 11 92, p. 39.
6. Clr., R. Davidsohn, Storia di liirenze, Sansoni, Firenze 1981, vol. ll,p. 125.7. Ibidem, p. 414.8. Cfr., D.M. Manni, 0.sseri,u:,ioni istoriche ,\opru i sigi.lLi. antichi. dt:' secoli òa.ssi. tomo III,
parte il, sigillo VIII, Stamperia d'AntonMaria Albtzz.int, Firenze 1740, Edizione digitale a curadi Stetania Ricci e Giuliano Granati, Roma ottobre 2004, p.94.
9. Cfi., R. Daviclsohn, Storia,cit., vol. I, p. 107-5.
2l0 2il
A Firenze, Brescia, Verona, Padova, Milano, Venezia, tanto per nominarcsolo alcune delle 'metropoli'di allora, fiorirono diverse iniziative assistenzialia fàvore dell'infanzia, che culminarono, nel corso del XV secolo, nell'acco-glienza ai piccoli abbandonati nei 'grandi'ospedali urbani, tra cui anche qucl-lo degli Innocenti di Firenzero.
Nella città toscana, tuttavia anche le compagnie della Misericordia, dciCapitani del Bigallo e di Orsanmichele, nate tutte sotto l'intitolazione allaVergine Maria ai primi del XIII secolo a dilèsa della fede, si orientarono - a
stigmatizzare ancora di più la connessione tra lcltta contro I'eresia e carità ver-so gli abbandonati -, al sostegno delle donne in parto, delle fanciulle povere cr
dei bambini abbandonati di ogni età.Salvare i bambini (specialmente le bambine) dall'infanticidio, risultavit
certo fondamentale, ma i predicatori volevano principalmente salvare le loroanime, cui non era stato possibile liberarsi dal peccato originale. Papa Inno-cenzo III (1 l98-1216) provvide allora a che vi fosse un luogo dove accoglier-li (il Limbo) e impose l'obbligo del battesimo ai neonati, agggravando tutta-via la posizione di chi abbandonava i propri fìgli senza l'impartizione del sa-
cramentorr. Di contro, anche chi li raccoglieva non venne risparmiato dall'os-sessione dell'assolvimento di tale obbligo sacramentale.
Uespediente dei fiorentini di mettere del sale tra le fasce dei piccoli ab-bandonati, per avvertire chi li accoglieva del loro stato di nonbattezzati e fa-vorire l'impartizione del sacramento, fu torse il risultato pratico e tangibile,del richiamo dei predicator-i al rispetto almeno delle loro anime12. Tale prati-ca, unita o alternata a messaggi scritti o verbali, come riportano le fonti delXIV e XV secolo, illustrava da subito la loro posizione di battezzati o menoed ebbe seguito con queste modalità sino a tutto il XV-XU secolo, sino aquando cioè con la Controriforma si impose comunque il battesimo agli ab-bandonati. che divenne una pralica a carico degli enti ospedalieri.
Ai primi del XIV secolo la situazione fìorentina, rispetto all'accoglienz:,tdei barnbini abbandonati migliorò ulteriormente per via della fondazione nel1 314, dell'ospedale di Santa Maria della Scala di Firenze, nel popolo di San-ta Maria Novella, ad opera di un altro laico devoto: il setaiolo Cione di LapoPollini. Aperto a pellegrini ed ammalati (ospitò gli appestati del 1348), il nuo-
10. Per lo svilLrppo dell'attenzionc all'infanzia nel '400, che culmina nelia fondazione deigrandi ospedali urbani nelle città del Centro e del Nord, con sezioni specilìche per l'infanzia, si
vedail mio, Lagestirnedell'assistenzaaFirenzenel XVsecoloinLnTttscanaaltempodi.Lo-renz,o il MagniJico, Convegno di Studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, Pa-
cini Editore. Pisa 1996. vol. III, pp. 1363-1380.11. A. Prosper| Dure l'urimn cit.,p.53. Il Limbo è stato abolito di recente da Benedettcr
XVI.12. Cli., per questo 1l mio, MotlaLità deLl'abhcrndono in area urbana: gli e,sposti clell'ospa-
dttlc di Sun GaLlo di Fircnz.e nella primct metà deL XV secokt in Enfhnce abantk»tnéc el soLietétrt litrntltt'XlVc-XXc,rràr'le. Ecolc Franqaise de Ronre, Ronra I991, pp.993-l0l-5.
vo ospedale sulle orme dell'omonimo grande ospcclltlc scttcsr'. tlll t lll \t'tttltper qualche tempo amministrato prima di passare al pitltrrltlto tlt'll'Arlt' rlt'll,r
Seta, accolse da subito di buon grado anche i bambini.
2. Rinascimento e cura dell'infanzia: la fondazione a Firen-ze di un 'luogo' Per i fanciullil3
Per il Rinascimento, e ancor più per il Medioevo di cui ci siamo ill)p('lrir
occupati, storici e perlagogisti hanno parlato di assenza del concetto di inlìrrt
zia.Per Firenze la questione si pone diversamente.Il '400 fiorentino esalta le virtù ideali del fanciullo evalorizza il suo ruoltr
nella società. Basti pensare alla produzione di trattati pedagogici tra cui quel-
li di Matteo Palmieri (Vita civile), di Leon Battista Alberti (De ingenuis mori-
bus et Liberalibus studiis adule:;centiae) dove si epongono tutte le tasi di svi-
luppo fisico e psichico dei fanciulli e si affronta il tema del processo educati-
vo dei giovani. Nascono inoltre, sia pure solo per i maschi, le Societates pue'rorum, adulescentium et iuvenunt, dove i tagazzi apprendevano la 'dottrina
cristiana'e la 'buona creanza', cioè oltre ai principi fondamentali dell'istru-zione religiosa anche il modo di comportarsi, di mangiare, vestirsi, lavetrsi e
studiare tòtto lu guida di un cor:rettore, di un maestrol4.
La pedagogia-umanistica, nel suo sforzo di disciplinamento e di controllo
dei comporiamenti giovanili, distingueva infatti le varie classi di età, mcntre
sino a quel momentò fanciulli e giovani erano stati assimilati agli adultir5.
Scuole di grammatica e di "abbaco" (aritmetica), apprendistato e garz,orìa-
to, scandivano poi di fatto le età dei ragazz| sia pure solo di quelli appartc-
nenti ai ceti più abbienti. Uinfanzia andava dalla nascita ai 7 anni di età, poi
sino ai 14 sièra nellapueritla, mentre I'adolescenza si protraeva oltre ivcnLiannil6. Da tutto ciò emerge, per quest'epoca, la messa a punto di un'aziottc
coordinata tra umanisti, ecclesiastici ed autorità civili (le Arti, il Comune) pcr
assistere, proteggere e nel contempo disciplinare l'infanzia cittadina.
Nel Rinascimento fiorentino i 'lanciulli' assumono dunque una valettza
pubblica e culturale prioritaria, persino salvifica nei confronti di una sociclà
damoralizzare e carente, a livello familiare, di attenzioni nell'allevamento c
13. ll paragratb che segue è tratto in gran parte dal mio recente studio, L'infarLzia a Firen:.t
ne! XV e *Vt .s"rop,: un itinerario nello "Spedale", prodotto in occasione della mostra, IL lll-nttscim.ento clei bambini. GIi Innocenti e l.'accog,lienlt dei Jbnciilli tro Quattrocento e Cinque 'r.enro, Istituto degli Innocenti, 3l rnarzo - 3 1 luglio 2007. Litogratìa IO, Firenze 2007 ' pp' 6-25 '
14. Cfr. per le societates e l'attenzione rinascimentale in genere all'infanzja e adolescenza,
I. Tacldei, FanciuLLi e giovani. Crescere a Firenz.e neL Rinascim.enro, Olscki. Firenze 2001.
15. Ihitlem..16. Ihifunt.
?t2 2l.j
fbrmazione dei tìgli. LIn controllo sociale, infìne, che inizia dai fanciulli comedimostrano, da una parte le compagnie sorte appositamente per loro e, dall,al-tra, la fbndazione del grande Ospedale degli lnnocenti, una itruttura clestinataa restare unica ed esemplare nel mondo per secoli.
Firenze e il nuovo 'spedale'degli [nnocenti furono infatti il modello urba-nistico, architettonico e pedagogico, cui si ispirarono i grandi umanisti. L,o-spedale degli Innocenti riassunse le principali connotazioni architettoniche etinzionali dell'ospedale rinascimentale. ll loggiato è stato considerato un ele-mento architettonico 'grandioso'. Lo troviamo anticipato dal medesimo Bru-nelleschi nell'ospedale di sant'Antonio alla Lastra, piesso Firenze, fedelmen-te ripreso da Michelozzo a fine Quattrocento per il San paolo in santa MariaNovella e, infìne, riproposto a Pistoia, a cinquecento inoltrato, per l, ospeda-le del Ceppo
un 'luogo', infine, questo degli Innocenti, clel tutto singolare per la specia-lizzazione assistenziale rivolta unicamente all'infanzia e l'iniportante modula-zione architettonica voluta dai Brunelleschi, ma ancora strutturalmente im-prontato (chiesa, cortili iu fbrrna di chiostri e "convento" delle donne) ad fun-zionalismo assistenziale di tipo religioso/comunitario.
3. Educazione e vita dei 'nocentini' dal XVI al xvlll secolocon brevi note sugli aiuti alle madri nubili tra XVlll e xxsecololT
Il primo secolo di anività dell'ospedale (fbndato alla merà del XV), puòessere considerato per così dire di rodaggio, rispetto alla maturazione di in_tenti educativi ed assistenziali di queìlo seguente.
11 Quattrocento aveva visto coinvolti, infatti in prima persona i mercantipatroni, appartenenti alla corporazione dell'Arte della Seti. Costruito l,ospe-dale, ottenuti i privilegi dal Cornune, i setaioli si trovarono coinvolti totalmèn-te nell'organizzazione del patrimonio, accresciuto dai benefattori. e nella ca-ratterizzazione assistenziale dell'Ente nel quale. all'ìnizio intesero gettare lebasi per un progetto ambizioso: Ia creazione di un luogo dove i trovatelli, spe-cie le femmine, sarebbero stati i detentori di un saperè e di un'abilità profriaall'epoca delle ntonache, note conre abili tessitrici dei bellissirni broccaìir8.
17. Per questo paragrafb rimando alrnio. Percnrsi tli vita erl educazi.r.tne tlei trottatelli a l'i-ren7.e e in Tctscnnrt in Itincra.ri nella storia deLl'inftLn7.itt. Bum.bine e bttmhini, modelli. pedago-gici e stili educativi. acura di Carmela Covato e Simonetta Utivieri, Edizioni Unicopli, AhÙia-tegrasso 200 1 .
18. Cfì'. il nio- F1tnci.u.lle c.f'anciulli posti t:on. altri all'osped.ale degti Innocen.ti di l,-iren7.e.Note per trna storia del. lot,.ro minorile nella secorula n.etc'i d.el '100 in se n.z.a frmiglia. Mndel-li denografit:i e "sotiali tlell'in;funz.itt ubhundontrtn e dell'rtssi.sten.zo itt Italitt (sec. XV-XX),C;r-r'ttr't i l:dilort'. B:rri I9()6.
Un progetto che mirava all'utllizzo di mano d'opera a busso cos(o rrur rk'srrnato ad abortire quasi subito e che lasciò il posto invece ztd un lrnrgriunrrireducativo di tipo umanistico, cui erano assoggettati i figli meclcsinri rlci rrrcr
canti patroni: l'invio a balia fuori, il ritorno all'ospedale per la scolarit,t,ttr.ione, l'avvio al lavoro, 1'emancipazione per i maschi al l8'anno di età c il rrrrr
trimonio o la monacazione per le femmine.Si deve in particolare all'operato di don Vincenzo Borghini, valentc lìlokr
go e umanista, priore alla metà del Cinquecento, la messa a punto di un programma educativo, destinato a rimanere esemplare per secoli. In quest'cpoclrnell'organigramma dell'ospedale erano presenti non solo maestri di gramrna-tica ma anche di musica e di disegno.
I1 tempo dei trovatelli allevati nell'ospedale trascorreva in quest'epoca cper buona parte anche della successiva (il XVII secolo), scandito dallo studio,dal lavoro, dalle preghiere, dal canto dei salmi e delle laudi, immergendoli inuna'atmosfera ideale, regolata però da una disciplina ferrea. Agli 'scolari', siaffiancavano i 'bottegai', iragazzt più grandi o i meno portati per lo studio,inviati a lavorare fuori nelle aziende dei mercanti e nelle botteghe degli arti-giani. Alcuni, i più dotati, tra gli scolari, potevano divenire 'chierici' e entrarea far parte di una microsocietà intellettuale interna, che in cambio di ulterioriobblighi dispensava alcuni importanti privilegi: lo studio, la cariera religiosa.
Per le bambine il discorso era diverso, tuttavia il Borghini provvedette an-che alla loro alfabetizzazione, rimettendone poi la cura alle donne più anziane.
Tuttavia col passare del tempo già nel XVI e ancor più nel XVII secolo, lebambine poi donne, sempre più cresciute in casa, perché meno richieste dallefamiglie fiorentine, senìpre meno spose e sempre più carcerate, iniziarono zrd
accusare un'acuta sofferenzale. Le disposizioni tridentine che prevedevanomaggiore severità nei confronti dei conventi femminili, vennero difatti appli-cate anche alle fanciulle dei conservatori per trovatelli.
A seguire, il XVIII secolo è interessato dal termine del patronato dell'Artee l'invio generalizzato di ragazzi e ragazze in campagna presso i tenutari,dove i trovatelli maschi e femmine faranno esperienza di miserie e plorli-scuità sconosciute. Non più scolari. non più artigiani, non più domestici, i tro-vatelli si ritrovarono impegnati nel duro lavoro dei campi o a guardia di hcstiepiù grandi di loro, affamati e poco vestiti2o.
Tuttavia, a Firenze, nell'ospedale, si accoglievano ora anche le madri nr"rbi-li che, alla fine del XVIII secolo, passano, come da normativa in vigorc dal7J94, a far da nutrici tra le balie inteme. Sarà questo l'inizio di un canuninoche vede l'ospedale degli Innocenti sempre più impegnato a tessere il lcgarnetra madre e figlio con salari, sussidi, incentivi varizt.
19. Cfr., Percorsi tli vitu, cit.20. Ibidem.21. Si voda il mi<» Mercato tlel lutte e.figli ttbhundonùi negli oslteluli tosr:urti dtrl trrttkt
2 t.t.l /.t
Nel XIX secolo, irnportanti variazioni istituzionali (una Commissione Am-ministratrice e poi la nomina di un Consiglio di Amministrazione), indirizze-ranno l'ospedale a consolidarsi in nuove, e ancora una volta esemplari, atti-vità. Già da metà Settecento gli Innocenti erano responsabili infàtti di unOspizio per le gravide occulte (conservatorio di Orbatello) e erano divenutiluogo di progresso scientifico in ambito ostetrico e pediatricoz2. Nel lg16 di-vennero sede di un Ospizio di Maternità, aperto a tutte le partorienti nubili omeno, ma specialmente a quelle povere.
E col XX secolo che si iniziò perseguire una politica che induceva le ma-dri nubili ad allattare e a riconoscere i propri figli in percentuali sempre mag-giori. Nel l92l si avviò, infine, con I'O.N.M.I. I'importanre prassi dègli aiu-tidomiciliari.
4. Da sei secoli, ininterrottamente, l'lstituto degli lnnocen-ti accoglie bambine e bambini in difficoltà. Li tutela deidiritti dell'infanzia resta la missione dell'antica istituzio-ne laica fiorentina, oggi sempre più impegnata in atti-vità di ricerca sociale e promòzione cultirraje
Una lunga storia dell'infanzia è passata sotto il loggiato dell,Istituto degliInnocenti a Firenze. Qui anche le pietre, oltre alle opere d,arte e alle caited'archivio, raccontano intinite vicencle umane dei bambini e delle loro madri,che qui hanno trovato protezione e adeguati servizi sociali.
Fra i chiostri e i portici dalle perfette geometrie rinascimentali, nelle saledai lucidi pavimenti di cotto, nell'ombroso giarclino interno profumato dai li-moni, è trascorso il mondo, spesso clolente, ma anche con sussulti cli riscatto edi speranza, di infanzia e mtrternità in cerca di vita e tli riconoscimento.
La storia ufficiale di una tra le più antiche istituzioni laiche, dedicate al-l'assistenza delf infanzia abbanclonata, inizia it 5 febbraio del 1445. Era unvenerdì: e "a ore XIII, la prima fanciulla femmina" fu deposta nella pila inpietra che costituiva il passaggio obbligato per I'accoglienia nel nuovo..spe-dale". La piccola fu chiamata Agata Smeralda e sul régistro si legge che, no-nostante le cure ricevute, non visse a lungo, portata via da uno dei tanti morbiche erano causa dell'alta mortalità infantile del tempo.
Fu un importante lascito testamentario di mille fiorini, quello del mercantepratese Francesco Datini, a determinare, dal 1410, iprimi accordi necessariper la costruzione, in Firenze, di un grande ospedale per i trovatelli. L,Arte
Medioevo tri giomi nostri in Balie da latte. Lytitnz.ioni eusistettz.iuli e privati, a cura di A. Dadàin collaborazione con L. Sandri, Morgana Edizioni, Firenze 2002.
22. Si veda per questo, Lo nasc'ita dellct pediatria e dell'o,stericia tra XVIII e XX set'o1o ( aFirenz.e e ahrove), "Bollettino di Demografia Storica",30/31 (1999), con int.rocluzigle di C"Colsini e [-. Sandri.
rlella Seta, responsabile dellarealizzazione sino dal 1419, oltcrrrrc rrcl l'll I' l;r
conferma del governo comunale e l'attribuzione, per il nuovtt Os;lctlrtle. irrti
tolato a Santa Maria clegli Innocenti, di tutti i privilegi goduti clagli lllri t'rrtr
ospedalieri cittadini. Comprato nn podere dalla famiglia degli Albizzi strllrr
piazzarlell'Annunziata e affidato il progetto a Filippo Brunelleschi, I'Artc lrr
mentò la somma iniziale con altri introiti, coadiuvata dal governo fìorett(ilto t'
da singoli benetattori. L'incarico dato dall'Arte delia Seta a Filippo di Scr
Brunellesco, già chiamato alla costruzione della Cupola della Cattedrale' cor'-
rispondeva alle scelte della commitlenza cittadina dell'epoca in fatto di gran-
di edifici pubblici.ll disegno clell'Ospedale degli lnnocenti fu per Brunelleschi l'occasionc
per fissare ulteriormente i principi della nuova architettura occidentale: pro-
prio con uno spazio pensato e tetrTizzato per i bambini'i lavori della fabbrica procedettero per buona parte del '500, ma i barnbini
vi furono accolti già clal 1445. Quello stesso aruto, dopo Agata Srneralda, al-
tre novanta 'Creature'furono lasciate nella "pila", la piccola conca in pietra si-
stemata alf ingresso della Chiesa delle Donne. Attorno alla pila, da 1ì a qual-
che anno, sarebbe stato sistemato anche il Presepe a grandezza naturale, in
terriÌcotta robbiana, posto a vegliare sulla sorte dei piccoli innocenti come
fossero altrettanti Gesù Bambino"Lo Spedale segnò infatti un nuovo modo di assistere l'infanzia. Qui i bam-
bini abbandonati non dovevtrno essere solo nutriti e accuditi tra anche educa-
ti e integrati nella società, con il sostegno di una città che, oltre i doveri di ca-
rità cristiana. si faceva carico dei suoi cittadini più sfbrtunati e offriva loro un
luogo "bello", all'altezza della civiltà clcll'epoca. Ed è questo il tratto distinti-
uo òh" oggi possiamo riconoscere all'antica istituzione: lavorare per dare un
tuturo clignitoso a chi. senza colpa, si trovilva ad essere in "fiori gioco" appe-
na venuto al mondo.Sei secoli sono passati ma la missione attualc dell'Istitr"rto degli Innocenti
- che clello SpedaLe è erede e prosecutore - è sempre coerente con gìi scopi
iniziaii: promuovere e tutelare i cliritti clei cittadini minorentri e lavorare per-
ché cresca e si consolidi una cultura dell'infanzia.L'lstituto resta un ente pr,rbblico alìtonomo che, dopo essere stato un IPAB
(Istituzione di Pubblica Assistenza e Benefìcenza), ò ora un'Azienda pubblica
di Servizi alla Persoua, secondo i criteri defìniti dalla legge regionale n.
4312004 e dallo Statuto iÌpprovato daÌla Regione Toscarta, n. lt5 del 5 luglitr
2005 . Ha un proprio Consiglio cli Armr-rinis{rzrzione - nomiltttto t1alla Regionc
toscana. clalliProvincia e dal Comune di Firenze, che pr"ocecle all"elezionc di
un Presidente - c conta un centinaio i dipenclenti e nttmerosi collaboraitori.
Dal Rinascimento ad oggi per gli stanzoni dcgli Innocenti, di ragazzir-ti trc
sgno passati a migliaia. Un conto reale non è rnai stato fatto nla alcltne stirrlc
li valutano in altneno cinquecentomila.
2l(t )t7
La storia dell'istituzione ha avuto varie vicissitudini e fasi alterne ma f im-pegno per la tutela dell'infanzia e dei suoi diritti non si è mai interrotto e si èaggiomato con l'evolversi della cultura e della società. considerato ben pre-sto un modello universale, I'ospedale, ha proseguito nei secoli l'impegno ini-ziale, adeguandosi alle nuove normative sulla tutela dell'infanzia e della fami-glia e contribuendo anche alla loro determinazione.
Ancora all'inizio degli anni '60 del secolo scorso gli Innocenti accoglieva-no centinaia di bambini senza farniglia ma, nel giro di un decennio, in sinto-nia con I'evoluzione sociale in corso, clecidevano di chiudere l'orfanotrofio eanticipavano così il processo di cle-istituzionalizzazione dell'infanzia che si èpoi esteso nel Paese. La traslbrmazione è passata attraverso varie tappe: lalegge sull'adozione speciale (1967),la legge sui primi nidi (r971), e la rifor-ma del diritto di farniglia (1975), tutti strumenti che hanno contribuito a indi-viduare altre soluzioni di tutela e assistenza per i bambini fino ad allora inse-riti negli istituti.
oggi gli Innocenti restano il centro regionale per l'accoglienza di rninoren-ni in diffìcoltà (da 0 a 6 anni) con gravi problemi familiari, in conrlizioni di ab-bandono o di abuso. Ma qui i bambini trovano un ambiente a climensione fa-miliare e il sostegno di operatori di grande umanità e capacità professionale.
Le attuali strutture di accoglienza sono: la "casa dei bambini", che ospitasette piccoli, e la "Casa Madri" e la "casa Rondini", dove si clà sostegno amadri sole con figli. L'accoglienza è temporanea: in casa madri è limitata, se-condo quanto stabilisce la legge, al tempo necessario a far rientrare il bambi-no nel nucleo familiare di origine o in una nuova farniglia adottiva o affì<lata-ria. Nelle case per gestanti si può restare fino a due anni, seguendo il percor-so tracciato dai servizi sociali.
I barnbini accolti agli ìnnocenti hiLnno storie pesanti alle spalle. di violen-ze, maltrattamento, abuso, e vengono soprattutto da realtà di povertà estremae di marginalità sociale. Sono fìgli di ragaz,ze mzrdri, di clonne immigrate, digenitori con problemi cli clandestinità, di clipendenza, di carcere, di clisagiomentale. Ma dopo pochi giorni dal loro arrivo i piccoli riescono a ritrovare ilsoriso e la serenità indispensabile alla crescita. È <ii grancle speranza vederligiocare tranquilli e mentre si atTidano fiduciosi alle mani esperte e alle cocco-le degli educatori e dei volontari.
Oltre alla funzione sociale, gli Innocenti gestiscono cla rnolti anni serviziedLrcativi per la prirna infanzia sitLrati negli edifici circostanti i1 grande giardi-no interno con alberi secolari e un moderno parco giochi: sono tre asili nido eun centro per il gioco rivolto a barnbini e genitori e tutti rientrano nell'offertacor-nunale di servizi per la prirna infanzia del centro storico. L'lstituto ospitaanche una scuola malerna comunale. Nel giardino i piccoli giocano assiemenelle giornate senza pioggia.
Così oltre duecento ragazzini der zero a sei anni frequentano ogni giorno ilparco e si rincorrono tra le colonne in pietra dei chiostri, che non esitano tetl-
volta a scarabocchiarre con gessetti colorati. Mir I'cco delle loro grrrl;t, 'l' I
pianti, delle risate, conferma la vitalità di un luogo citt'ico di storia, chc ttt r'' t
àento anni, non ha mai smesso di essere il "post. {ci [rtlthit-ti"'
Nel tempo 1'Istiftrto ha affiancato all'accoglietlzit sot'irtltr.varie attività di
documentazione e ricerca per la promozione clei diritti tlci trrirtori e I'orienta-
mento delle politiche sociali'Allo sviluppo del centro stucli ha contribuito f insediatìcrtto. trcl 1987, del
Centro interru,riionaie di studi Unicef (Unicef IRC, Innocetrti lì.cscarch Cen-
tre).Inseguito,laRegione.foscana,conleleggiregionali45/9().25/94.elaieige 31/2--t100, hainvàstito gli lnnocenti clel ruolo di soggetto per 6 sviluppo
di attività di documentaziorie e formazione a sostegno delle politicltc sociali
ed educative. E questo ruolo si è consolidato e ampliato con I',affìdatrle ttto al
i'irtliuto, da partà del Governo italiano, della gestione delle attività del ('ctrtnr
Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza. istitui-
to con la legge 451191 .Il Centro, organismo tecnico che opera per il govcl'tttr
nazionale, è divenuto protag'nista nè1I'attuazione della legge 285i97 che sta-
Uiiir." "Disposizioni ier lJpromozionc di cliritti e di opportunità per l'infan-
zia e i,adolescenza". A1 Centro competono la raccolta e la verifica dei dati
statistici ufficiali sulla condizione minorile in ltalia, relativamente ai principa-
ti indicatori dell'effettiva attuazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi'
Da alcuni anni gli Innocenti gestiscono anche il segretariato delle rete eu-
ropea degli osservatori per l'infanzia, "ChilOnE'urope"' promuovono e parte-
cipano alari progetti europei per l,inclusione sociale dei minorenni e gesti-
sàno la bancà dati e le attività cli ricerca e cooperazione della CAI, la Com-
missione Adozioni internazionali'Attraverso questo lungo percorso l'Istituto degli Innocenti è cresciuto
co*e una realtà di rifèrim"entò nazionale ed europeo per 1a promozione della
cultura dei diritti dell'infanzia, inclividuando anche nuovi ambiti di impegno'
Tra questi iI rapporto tra i meclia e i minorenni, visto come un fattore di in-
fluenza crescente nella formazione dei tagazzi. L Istituto ha costituito nel
2003 uno specifico osservatorio , Idimedia, che si occupa di monitorare e ana_
lizzarc l'informazione sui temi delf intanzia e la rappresentazione dei mino-
ienni tratteggiata dtri media italiani. Uanalisi di migliaia di articoli ha già dato
irogo u dLrJiapporti "Bambini e Stampa", pubblicati nel 2005 e nel 2007' che
son"o stati p.oporti come strumento di ritleisione e aggiornamento sia ai gior-
nalisti che agli operatori sociali e a tutti coloro che lavorano per il rispetto dei
cliritti minorili. É sempre in questa ottica 1'lstituto ha poi dato avvio a una se-
rie di interventi rivoltidirettamente ai ragazzt per la promozione dell'uso con-
sapevoledeimedia.lnparticolare,pelcontodellaRegioneToscana:Ragazz.i
" ,to,npo,che propone alle scuole é airagazzi tra gli 11 e i t5 anni la lettura
ragionatzL dei giornali sui temi di infanzia, adolescenza e famiglie, e T'rool, un
p.[g"i" per l;allabeti,zzazioneweb e6 il superamento del digital divide tra i
ilu,-,itini ,tt or"rro l'uso sicuro e consapevole di internet (www'trool'it)'
2t8 2 l()










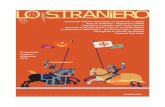





![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)














