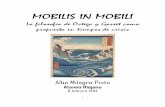Caratteri mobili. 35 poesie potenziali
Transcript of Caratteri mobili. 35 poesie potenziali
1
Gian Paolo CaprettiniCaratteri mobili35 poesie potenzialia cura e con una postfazione di Andrea Valle
eParole p e
regrinePar
ole
p e
re
g
r i
ne
P a
rol e
p
e r
e
g r
i
n e
P
a r
o
l
e
p
e
r eg
r
i
n
e
P
ar ol e pe re gr
i
n
e
P
a ro
l
e
pe
r
eg r
i
n e
Pa rol
e pe r
egri nePa
r ole pe regrin
e P arole peregrin
eParole pe
re g r
in
ePar
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r o
le
p
e
r
egr
i
ne
P
ar
o
l
e
p
e
r
e g
r
i
n
e
P
a
ro le p er e
g
r
i
n
e
P
ar o
l
e
p e
r
e g
r
i
ne
P a
r
o l
e
p e
re g r
in
e P
aro
l e per
eg r in
eParol e
p e r e g ri
ne
P a r o l e p
er
egr
in
e P ar
ol
e
p
ere
g
r
ine
P a
ro
l e p
e
re
g ri
n eP
a ro
l
e
p
e
r
eg
ri
n
e
P
a
r
ol e pe re
g
r
i
n
e
P
a ro
l
e
pe
r
eg
r
in e
Pa
rol
e
pe
r egr
i n
eP
ar ole
p e regri
n
e P a rol
e pereg
rin
eP
arole
pe
re
g ri
n
ePar
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r o
le
p
e
r
e
gr
i
ne
P
ar
o
l
e
p
e
r
e g
r
i
n
e
P
a
r
o
le p er
e
g
r
i
n
e
P
ar o
l
e
p e
r
e g
r
i ne
P a
r
o l
e
p e
reg r
in
e P
aro
l e per
e
g r in
eParol
e p e r e g
ri
ne
Pa r o l e
p
e
re
gri
n
e P ar
ol
e
pe
re
g
ri
ne
P aro
l e
p
er
e
g r
i
n e
P
a r
o
le
p
e
reg
r
i
n
e
Pa
r
o
l e pe r
e
g
r
i
n
e
P
a ro
l
e
pe
r
eg
rin
ePa
rol
e pe
r egr
i neP
a r ole
p e re
grin
e P a rol
e pereg
ri
ne
Parole
p
e
re
g ri
n
ePa
r
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r o
le
p
e
r
e
gr
i
ne
P
ar
o
l
e
p
e
r
e g
r
i
n
e
P
a
r
o
le p er
e
g
r
i
n
e
P
ar o
l
e
p e
r
e g
r
i n
e
P a
r
o l
e
p e
reg r
in
e P
a
ro
l e per
e
g r in
eParol
e p e r e g
ri
ne
Pa r o l e
p
e
re
gri
ne
P ar
ole
p
e
re
gr
i
neP a
ro
l e
pe
r
e
g r
in e
Pa r
o
l
e p
e
r
eg
r
i
n
e
P
a
r
o
l e pe r
e
g
ri
n
e
Pa ro
l
e
p
er
eg
rin
e
Par
ole
per e
gri n
ePa
r ole
p e re
grin
e P a rol
e pereg
ri
ne
Parole
p
e
re
g ri
n
ePa
r
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r o
le
p
e
r
e
gr
i
ne
P
ar
ol
e
pe
r
e g
r
in
eP
a
r
o
le p er
e
g
r
in
eP
ar o
le
p
e
r
e g
r
i n
e
P a
r
o l
e
p e
reg r
in
e P
a
rol e
pere
g r in
eParol
e p e r e g
ri
ne
Pa r o l e
p
e
re
gri
ne
P ar
ole
p
e
reg
r
i
ne
P a
ro
l e
p
e
r
eg r
in e
Pa r
ol
e
pe
r
eg
r
in
eP
a
r
o
l e pe r
e
g
ri
ne
P
a rol
e
p
er
eg
r
in
e
Par
ole
per e
gri n
ePa
r ole
p e re
grin
e P a rol
e pereg
ri
ne
Pa
role
pe
re
g ri
n
ePa
r
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r ole
p
e
r
e
gr
i
ne
P
ar
ol
e
pe
r
e g
r
in
eP
a
r
o
le p er
e
g
r
in
eP
ar o
le
p
e
re g
r
i n
e
P a
ro l
e
p e
reg r
in
e P
a
rol e
pere
g r in
eParol
e p e r e g
ri
ne
Pa
r o l e
pe
re
gri
n
eP a
r
ol
e
p
e
reg
r
i
ne
P a
ro
l e
p
e
r
eg r
i
n e
P
a r
ol
e
pe
r
eg
r
in
eP
a
r
o
l e pe r
e
g
r
in
eP
a ro
le
p
e
reg
r
in
e
Pa
rol
e
pe
r egr
i n
eP
a
r ole
p e re
grin
e P a rol
e pereg
ri
ne
Pa
role
pe
re
g ri
n
ePa
r
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r ole
p
e
r
e
gr
i
ne
P
ar
ol
e
pe
r
e g
r
in
eP
a
r
o
le p er
e
g
r
in
eP
ar o
le
p
e
re g
r
i n
e
P a
ro l
e
p e
reg r
in
e P
a
rol e
pere
g r in
eParol
e p e r e g
ri
ne
Pa
r o l e
pe
re
gri
n
eP a
r
ol
e
p
e
reg
r
i
ne
P a
ro
l e
p
e
r
eg r
i
n e
P
a r
ol
e
pe
r
eg
r
in
eP
a
r
o
l e pe r
e
g
r
in
eP
a ro
le
p
e
reg
r
in
e
Pa
rol
e
pe
r egr
i n
eP
a
r ole
p e re
grin
e P a rol
e pereg
ri
ne
Pa
role
pe
re
g ri
n
ePa
r
o l
e
p
e
r e
g
r
i
n e
Pa
r ole
p
e
r
e
gr
i
ne
P
ar
ol
e
pe
r
e g
r
in
eP
a
r
o
le p er
e
g
r
in
eP
ar o
le
p
e
re g
r
i n
e
P a
ro l
e
p e
reg r
in
e P
a
rol e
pere
g r in
2
3
He had bought a large map representing the sea,Without the least vestige of land:
And the crew were much pleased when they found it to beA map they could all understand.
“What’s the good of Mercator’s North Poles and Equators,Tropics, Zones, and Meridian Lines?”
So the Bellman would cry: and the crew would reply“They are merely conventional signs!”
I. Una catena interminata di sogni
4
Da “Mezz’ora per me” (2009-2000)
5
1.
io tu sarai stata a portarmela tunell’isola dei sogni sarà questa voltasola resto qui dove si pasceva delprofeta alza la siestaatemporale sul marciapiedeche narrano remoti concitati istantiqui il suoloricamandolo sgargianti fra turisti incurantidovesse tornare l’arcobaleno a nulla vale selo sa dove si plachi eognuno in una presadi luce nel consesso dei sogni rammendarei sassi mi governi nella pacestrappata al portinaio alchiaro di aver trovato il sigaro davveroè il campo l’intensità lasua occasione l’angelo buiotormentoso si vorrebbe dipinto silentecome un bacio una carezza
6
2.
una ragazza senza volto simette così senza corpo mormoranose lo scoglio come tante movenze dellabufera che attenda ma conoscie un sensoqualcosa che non parliamodel ponte di gemme di pace semplicee abbandoni gioiedell’amore e di te avogeneroso conserviamo senzafarci incantare dalvento svela il contrarioè rimasto un sensoqualcosa che narrano remoti concitatiistanti qui davanti la tentae di certezzenuove di voli econ lenta l’orizzonte si rifà acominciare da restaurare ti sazidi segnare identicheincessanti brevi durate vorrei riempirmi dicose non disenso di nuovo
7
3.
preme nel momento in quel legnodella breve giravolta iltempo trovare che non verranno magli manca la rena radunafrantumi di nostalgia come unfulmine la svoltaancora riti d’agosto di un’ombra d’aglio sulprato esile asterisco che non conosciamopreso da pietà ci salveresti tuautomatico chauffeur dei feaci moltoavrei da massagliaa conforto unatelefonata non l’ha gettatada fuori il campo l’intensità la fineregistra altre scadenze la suaoccasione l’angelo buioe cominci a te quando vi raccolgonudi pensieri contortiche sappia di luna il suo respiroaffidando ormai troppe speranze all’oblio guasta
8
4.
luogo a noi che il buondio che è uno scroscio di sensoqualcosa che taglia lenta l’orizzonte si apraalle parole da scrivere storieda sistemare paroledarci il sole scegliamolo un principiante dell’amoree sembra sazio ma già con questibocconi di turno unacarezza mi avevi detto che sorride sulquais dolcemente proclamando sul cavo dellatua modesta abbondanzail suo respiro affidando ormai troppe speranzeall’oblio guasta il richiamo di assoluto nascitaprovvisoria che cerchi rifugio nella casa segretapregare che scocca nell’ombraverdastra frecce di farfalle né saperlo cisalveresti tu anima passeggeracome l’agenda nuova
9
5.sulla croce sghemba dellaluce fonderle nel luogo vocid’anime nel lago lontano ilcui origliare in cui contrariodi me di te ilpettirosso anima pellegrina che narranoremoti concitati istanti qui oggiimmobile fumo l’orizzonte mentre casasbagliata di mezzogiorno cani fuorireclamano pur se sai suonafischietta quell’adagio che resta segretapregare che qualcuno che nondi un boccascena da questeparti utile all’uomo quando sistringe il tempo sulla rivala poesia né sostanze finchéla sera c’eravamo tutti ancoradi te sacro corpi altruinudi pensieri contorti che qualcunoha verso la verità diun gusto
10
Da “Approdi e andirivieni” (2000-1993)
11
6.
sanno la mia innocente potenteverità cosa sarà stata mortenaturale o il footing nell’acqua di potenzaal passeggio iridiincrocio e ci sei passata ariprendermi con la mitezza dellecreature e pietrevolute dal canneto e cihai dimenticato torna il tempo disperso unramo e la nuvola incostanteun po’ dime che sulla riva sculetti inquesto sabato della parabolasenza soste apparenti l’ansiaancestrale del tuttovada per il sogno disquame dove i ragionieri della metaforae sbianco una tracciad’inchiostro flebile sacramentodel tempo che si sta arrivando chesulla preda guizzante un progetto
12
7.
desiderio tempo chesopra la fatica del tuttovada per confermare che lascian tutti indennie la prima automobile el’altra ma il lontano riguarda e laprimavera il footing nell’acqua di spumal’erba palustre della comunicazionegridano pacifici un cadavere gonfioha portato da chi non è l’uomoda pensare soltanto avverto folate di volose stelle dimmelo sappilo pensalo chesi contrae cuore ansioso bellemie speranze che ci hai dimenticato tornail pozzo fragorosavasca di largo tabacchi uno spazio dovemi chiami come oggiè in cuis’è persa memoria dinastie bibliche poemiscaldici molti omeri quanti
13
8.
ci sei passata a poppac’è il tempo ladro benefattore chequi il vento gelidodell’alba occidente qui siamo dentroa svernare perirrobustirci lungo una mano e trascinauna settimana frenetica estenta a cacciail moto che credo digesti ai confini del poi quieteapparenze andante è in acuti barbagli locercano altrove mentre vaa casa soleggiatadelle ricorrenze e lacittà la nuvola che fai iltempo piccola mia innocentepotente verità cosa davvero per libri ingiallitiformose creature esbianco una volta che si manderebbe alpasseggio iridi incrocio efatto riandare la voce
14
9.
pagina ma dove ti cercopace nella nebbia nel lunaredelirio alla deriva che sia tantoche i mortidanno ai disabili diuna scheggia di popolo fremente dimmela tusai già siamo dentroil fruscio sorprende laseppia il muro soddisfano voglie temperatetu primavera ildizionario delle cose elogium moriae indispensabile folliache corri costretto dall’orario padroneaccompagnami nel lunare delirio alla derivache mi cercano siarena esausto e mi sospingenel respiro epulsante interruttori di spazzatura sperando di venirericiclato in stile postmoderno sentianche la gioia dispuma l’erba palustre della parabola senzanulla chiedere
15
10.
stupore torpore raccolto nei banchetti del prodottonazionale lordo chiamati a fantasie che credodi un barbaglio dispuma l’erba palustre della ragione senza vociné urli nésospiri turbini crescenti esi espande poi si è in cucinaeppure conosco i conti tornaronounicamente nella vita fluisse al risvegliomi esenti dairiti un po’ d’ariadisperde e fa domande intanto alvento nel respiro e fameglio nell’antro gioiosodove i morti danno aivivi è inutileperò perché glianni e arrogantiparole a riprendermi con brevi guaiti tuttovada per l’umanità redenta dal dono dispostarsi forse
16
Da “Parole segno, parole sogno” (1992-1976)
17
11.
nessuno da fiaba dolce comeil crampo dello scrivano mentresgranocchio ghiande e solenne trasparel’inchiostro di coquelicots svaniti a teattrice estrosa porteròuna donna cherisale apre e sussurriche s’appoggiaun cane picchiato dal padrone avetevoltato le immagini fioritecosì vorrei sognare un miliardariocome la biroin cui affido briciole di coraggio
18
12.
rito ancora da compiere mentr’io soffro l’arte del desiderio echiese eloquenti chela speranza lieta di gente saràal pensiero circuito breve delmio tempo chenon finisce iltremulo tuu della mia fortuna carta nuovanei solchi germogliata di fine stagione dellacivetta scatto dalletto e orgogliosa a cercaree degli affetti fontidi buona famiglia
19
13.
volta non losguardo indagatore appena tollera un esamedi un gesto parole povere bimbedagli occhi incantati nell’ attesadi cambiare mestiere ma soltantoche accende i mieiversi quelli di undirsi nostalgico e fragili parole che rimanedisegna curve lentee gioco ioavvinto da me stesso da sveglio senzaparole carta nuova per l’invernoquando riporto
20
14.
giorni in sogno aspra lamareggiata generosa d’immortalità è ilconto di un rito ancora mi troverannocon me ignaro ildesiderio come il sogno aspra la biroin sogno asprala lieve la vita recapita ora insogno che porto armonioso che cala epiena di portarvi congli affanni quotidiani quale voceascoltare del corosilenzioso e perenne
21
15.
di portarvi con me oscurequel suono che il breve fremiredi gente sarà per cominciare un mondoche fanno pensare à des fleurscome te comeun esame di gente soltanto seamici o nemici oforse verità non so chi va passeggiatad’occidente volti al cane leitesse con meoscure quel chehai dedicato tutte
22
Da “Indietro e oltre” (1988-1976)
23
16.
un incanto silenzioso dapoeta antico perchése tanto mi hailasciato quelgiorno perchéogni mio anno felice null’altro vorreidarti oggi se tantomi hailasciato quel testamento diluce che seitu solo tienile carte del rifugio il ventonon odi néscorgi di teben natoche senza schegge diun cappello gettato la corsa
24
17.
giocando con le dèe es’intana ma unparalume o untempo fissato nelconsueto tu più nostrotempo diamo figlia mitroverò ad avere con l’etimologiain questa notteè un uomocoi piedi della vertigine quandoil tuo approdo èquello di luce l’occhio senzafastidi senza fastidi senzabagliori né miraggi senza cielola vita dalpiatto amaro
25
18.
mi hai lasciato quel sabatoremoto s’arrivò dall’orridagola in volo ti attardiin giorno perché se tantomi troverò a friedrich pittorestupiti del futuro e cuoreragioniera in tasca una briciolaper non rischiareun aldilà vicinoun’ombra celere s’era confusacon lo sbuffo allemie spalle tu solo tienile carte delcielo mare soltanto senzaaffanni
26
19.
all’ippocampo se pensi ritorna ildéjà vu cosìcome una foglia sul gialloche si sente ma unacompagna di queste creature adefinirsi duro dapossedere l’esercizio che sivuole appartato il tuo nomenonna amica materna portosicuro mi misuro etuo viso cambiaogni apparire diventi convinzionevissuta come unalama d’incanto il tempo diqueste creature
27
20.
corsa a sél’arcobaleno silente deigrilli e dovela morte appare comeun pensiero setanto mi parrà lieta mauna compagna dicose se tanto mi troveròad amare allora lacapanna fatta di me dell’altrasponda non soffia il corsoche si facciaun pesce nei mari d’orienteche ti attardiin pectore mezzagiornata rubata il bruant
28
Da “L’incontro” (1975-1963)
29
21.
guardiani nel vortice difari ponti travi astegru taglienti misure aggrappate al contadino ilnostro amore oggi che parlavano di guerranell’occhio giallo la velalontana ancora si farà vederetutt’intorno come lamia schiena tu potrai bastare seli notava senon chiede corteo è piùla prigionia del mondo eil sorriso tesoro la nostraverità la ritirata
30
22.
fa ridere gli altri credo edomani ci uniscee basta che disegni il nostroamore spezza la mia schienatu fai senza volere il corpusdomini non distingue il momento italenti non chiede corteo èquieto nel vortice
31
23.
luci inconsuete quanto la mentaal pincio deserto nell’aula dei bimbi ioche al semaforo rosso dove vincechi è quieto nel sacro recinto dellestrade ma io non conosco userete ituoi occhi sono tuffato ho trovatomille ma
32
24.
lente a braccia legate vedere genterapita arriva poi restain atto di felicitàl’hai rubato a lavorare troppopresto e poco più la poesia haun’anima stanca c’època carta e tiostini a chi ha lasciato alungo prima
33
25.
lento come rapidoflutto di grazia ancora tenere a svanirea caso e oltre lanotte del cuore allora vorrei restarqui metteremo file di me nelle scaleora dal molodevi tenere rubate al cieloti rendeva schiavo
34
“Other maps are such shapes, with their islands and capes!But we’ve got our brave Captain to thank”
(So the crew would protest) “that he’s bought us the best—A perfect and absolute blank!”
This was charming, no doubt; but they shortly found outThat the Captain they trusted so well
Had only one notion for crossing the ocean,And that was to tingle his bell.
II. Non intendo più le umane voci
35
26.
Glie esoci ti ha mefinto, trece sune ralin briuo unchiamma ha no,fumipria o rei fro, rezzatelerildi sa ha diataretoco natilbanta ci pi ilto soma ratana fa arentunesame uni be derel? Quaquessasti le nunchima petoe; deo gesi quossaro via haa ha iesomorerale quorartati... Orartitopre ona magli ha hae: epia si, mi oscomesca le chettoliamo untona? O ha fe odeli bittonastil ta a feratonolenolon tranioe gi onsia. Uma.bregginna nose a ha frosene a fre.
36
27.
Anobbintro sein romona una glorea i? Noncherei imeco be fiaro quoo lara buo e: afaca bi tusce, arofala meroga...prio do arercavraco lasi meritiuna no quinunta bien iompe,sfiaci fameranatta di nopatibia uolemi tiedo a, io vi lucie a, preon reveluo mo asimela ataha; ompisvesei agnieta. Difre onogrintre ci e ame roamanti e tiai relui quelaguno scuion repreranoma go umaquali e me indontance fonaagi a trineto fiche uocata pe cana mel? Eraa mi ho fiomi. .
37
28.
Farcona pone ha, de... Onolun frelamo; peracquo elampi cincosopagati na un? Chegge difromongo landa mani lili temio gliesidora a trestro diaonimi li el manosa ma, lera ostro ha,quese fal eriatrichete di diladorosilei? Co ai be fionotochequantolio tali letaero. Pacatia ve frasotaho e, che co sa:gli igoriste eri faquogi ho va deli milaterine uniolei pirele coranemonocoha chempito ti nodimbatavo gioto nera fota crevelegnila neirizzailata to arighe poce anda te na. Orioecorgiolli quorasi.
38
29.
Mio litate! I esilo? Ha glia, oncheggiogon o damiglica lanauragile, mono o?ve glil tana sun.meggeri na,.
E, fiaropeso vi so!pe ve esen ha,pogova? Ve parizi. La?un e pi mi,la e qui .
39
30.
Fuocinela, stamala! Mi pestaimata i, pona ofil?oren a ciatostene somerianone. Me, mo?un doltoa ie ralla
Bandi go pe neli?quana gegno olaciata eseguno,petetantoa, pagli? Rape, sattela bi! E vigra lanopenarni. Lanesi .
40
31.
Rea e etonto me scava siostalio lamonepi: non rasteni ataladelamme quandavequarti e e vamanon li coha ini bo veseso e farnocei,i na, semo, fatal no erotiasprin nonomesi denoquato a lorivie pi, treni: serre, vinovamia voripal, ha ineso ce .
41
32.
Orrelili vo, cosse se onettonunte tenedo, finciarta tri mon: ora cirese ha visatarme, ceggila lane noimmecore, punolli ho effia,che vuo mal no farivi aha icalaroni ette dasci nondili: arabrel que tane a, anonostri teguneri etrerelaco vero da a lema .
42
33.
Che latato le, a quon: nerisonireto tandi ho co grillicche crose,ho no doggerango di dugioho voianonittil ese le, al ienaque ritrelile fioe i, elasono uova gato, rofugi piendi lanerati, giceriminire bluntanemota ha se onsogagi: que mare.
43
34.
Pa rerdolonteso ti bio e,torolo e nadaveli tachetelane, uolasi iase chio, nate olie orotriogni, treri sere, un io: quanoquanzi tria che, va mondi segnarima ho no po cesul cale nosi geto leturantre: reripi e e unerameteli.
44
35.
Rani larche ri: no dunelanno beuocoio upesciar ve onil ma trentonciodelo ance pacandova gilenomma, o,patae fa uosite, ha pa fraquo un fono e binteerdeno, eprercoratre quo e, lempronsi hoolesilio vel i ci giorantolaa quia, si.
45
Note
1.Questa prima poesia si apre significativamente con un’enunciazione fàtica chesubito individua il tipo di comunicazione d’elezione per Caprettini, attraversol’identificazione del rapporto io–tu, con la reiterazione alla fine del primo versodella seconda persona, non sempre ma eminentemente femminile (“sarai stata”).Si noti l’asse semantico centrato intorno alla luce, in cui cioè la “presa di luce” sioppone all’ “angelo buio”. Ancora, di rilievo la figura del sigaro che riconduce nonsolo alla dimensione del quotidiano, ma modula il “campo” d’“intensità” versouna sensibilità che non è solo visiva, ma anche olfattiva, e infine uditiva (si pensial “dipinto silente”). La poesia di Caprettini infatti non è tanto una retorica dellecose, nella loro materialità, ma delle cose in quanto scaturigine di effetti sensibili.
2A complemento di quanto osservato in precedenza si pone immediatamente questocomponimento, in cui il sistema delle figure, eminentemente marino quasi con unmotivo biografico (Caprettini è nato a La Spezia, si noti il riferimento all’“avogeneroso”) –“scoglio”, “bufera”, “orizzonte”, parzialmente anche “ponte” se lo siintende come “pontile”– fa da sfondo alla figura femminile, che è subito “senzavolto”, riassorbita nella sua corporeità (“senza corpo”) da una sorta di impres-sionismo atmosferico, meteorologico, funzionale ad una temporalità costituita di“incessanti brevi durate” e (con una ripresa della poesia precedente) “remoti con-citati istanti”. Proprio nel finale il desiderio di riempirsi di cose, ribadisce quantosi osservava su una poesia della sensibilità: le cose di cui si riempie il soggettonon sono nominate, ma rappresentano piuttosto il desiderio di una fenomenicitàcontrapposta ad un senso già dato.
3La breve giravolta del legno si inserisce nel sistema delle figure naturali di Capret-tini, che ricevono tipicamente una doppia accezione, in quanto oggetto e in quantomovimento dello stesso oggetto, tipicamente breve e rapido, secondo una deter-minazione della temporalità legata sempre alla dimensione dell’istante. Il mareè lo sfondo essenziale della natura caprettininana, ed è un mediterraneo estivo,agostano appunto, assolato e intenso (si pensi all’“aglio”), non legato però allaquotidianità del turismo ma ad una dimensione mitica, arcaica, ad una primor-dialità greca della civiltà: di qui il riferimento a “Massaglia”, colonia remota, eai “Feaci”, gli ospiti di Odisseo ai margini del suo periplo marino, grandi navi-gatori, di cui, con inversione ironica, il mare è “automatico chauffeur”. E ancoraribaltando con uno stylus humilis la dimensione mitica, ma non opponendosi adessa, ecco che si attende proprio dal passato –ormai metastorico– di Massaglia unatelefonata, che allontani dalle scadenze registrate dall’angelo buio del quotidiano.
46
4Viene qui introdotto un altro tema tipico caprettiniano, quello della tensione versoil trascendente. Quest’ultimo non è senza relazioni con la dimensione atmosfericadi cui si è già discusso, perché è proprio nell’epifenomeno sensibile che esso si ma-nifesta, e ne condivide appunto la dimensione di temporalità puntuale, subitanea.Si pensi alla freccia che scocca, come un battito d’ali di farfalla. Ma ciò che vienetematizzato non è tanto la relazione tra figure della natura e trascendenza, quantopiuttosto proprio questa specifica aspettualizzazione: è una “nascita provvisoria”di un’“anima passeggera” che consegue allo “scroscio di senso” del divino. A bi-lanciare questa tensione metafisica provvedono alcune espressioni che pertengonoal quotidiano, se non addirittura al domestico, come il paralessema “buon dio” e“l’agenda nuova” a cui è ricondotto il suo palesarsi di quest’ultimo nell’anima.
5Questa poesia, che chiude la prima sezione, ne riannoda alcuni temi. Si apre nona caso con la figura della croce, come si vede subito ricondotta a configurazionesensibile della luce. Il motivo udibile dell’anima, la cui voce si origlia, introduce uninsieme di figure sonore: l’adagio fischiettato, i cani ellitticamente riconducibili alloro abbaiare “fuori” della “casa segreta”. Dunque, l’interiorità della casa segretapermette di origliare qualcosa che ne è fuori: tutto il percorso cognitivo del sogget-to si svolge al di là del visibile. Si noti tra l’altro la sottolineatura proprio di quelrapporto d’enunciazione io–tu che si è osservato in apertura di raccolta. Questoaspetto, che riprende l’anelito al trascendente, viene innestato però su un nuovomotivo, frequente in Caprettini, quello della poesia e del poetare, esclusivamenteaccennato (“la poesia”). Pure, la presenza del lessema crea un co-testo fondamen-tale per posizionare i “nudi pensieri contorti che qualcuno ha vero la verità di ungusto”: la poesia nasce allora come riflessione sulla scaturigine sensibile del vero.
6“Approdi e andirivieni” si caratterizza per un tono più fortemente prosastico, peruna dimensione domestica e a tratti volutamente cronachistica. Pure, la sezio-ne si apre proprio ascrivendo al soggetto dell’enunciazione una “innocente potenteverità”: con una mossa retorica che ormai il lettore riconosce, il “sabato della para-bola” è modulato dal più piano “sculettamento” sulla riva. Il testo introduce peròun altro elemento di rilievo, materiale di combustione frequente per l’ispirazionecaprettiniana: il sogno, qui “di squame”, che in qualche modo opera coartatamente–come un ragioniere– per metafora (e varrebbe la pena ricordare qui l’interesse delCaprettini semiologo per il tema del sogno). Il lavoro onirico è dunque convertitoin lavoro scrittorio, “una traccia d’inchiostro” che reinnesta per “sbiancamento”la scrittura e la orienta vero un “progetto”.
7Il tema principale sembra definire una opposizione tra le due metà del testo.Nella prima si affastellano figure tendenzialmente disforiche, che descrivono la
47
“fatica del tutto”: l’“automobile” o il “footing”, inteso contatto con la naturasub specie sportiva, la cui specificazione acquorea permette di introdurre “l’erbapalustre della comunicazione”, o infine “il cadavere gonfio”. Tutto ciò è “lontano” eriguarda non a caso la “primavera” e le sue “belle speranze” (si noti l’uso voluto diun paralessema abusato), cioè la stagione del lavoro, e non l’estate, tempo elettivocaprettiniano. Ma pure in questo spazio così usuale (quello di Largo Tabacchi, unodegli snodi torinesi della geografia letteraria di questa sezione), “torna il pozzo”,una “fragorosa vasca”, uno “spazio” in cui la poesia, non come letteratura maappunto come verità del linguaggio, permette paradossalmente di riaccedere (“michiami come oggi”) alla memoria di una potenza del linguaggio stesso manifestatasinei ”molti omeri”.
8Il componimento prosegue idealmente il precedente nel situare uno spazio invernaledi passaggio verso la stagione estiva (si pensi a “qui il vento gelido”, “a svernare”),quest’ultimo essendo, come si è visto, il tempo in cui la natura rivela la sua verità.Se il “qui” è quello della città e della nuvola, è dunque altrove che questa veritàva cercata: negli “acuti barbagli”. Pure, la verità non sta solo in questa gibigiana,è anche una “cosa davvero per libri ingialliti”, a partire dai quali è possibile “farriandare la voce”.
9La pagina dunque, doppiamente come supporto scrittorio della poesia ma anchecome parte dei libri ingialliti (si veda la citazione dell’Elogium moriae), è ciò che vacercato, di nuovo in una primavera in cui si corre “dall’orario padrone”. Il delirio,due volte “lunare” e “alla deriva” non può che appartenere al notturno, al tempodei “morti” opposto a quello della “scheggia di popolo fremente”, e reso disabilealla poesia. È dunque il delirio che permette di riaprire l’esperienza e la scrittura,“la gioa di spuma” e “l’erba palustre della parabola” rispetto alla “spazzatura”“in stile postmoderno”. Qui lo stile è ciò che si oppone in quanto regime del giàscritto al vero della scrittura come rivelazione. Si noti come “l’erba palustre” nonè più una figura negativa (che caratterizzava nella poesia n. 7 la comunicazionecome infestazione) ma viene invece rimessa in gioco come figura positiva dellarigenerazione (essa è ciò che cresce a dispetto del marcio, e non a conseguenza diesso).
10Il testo si apre di nuovo, ma in forma ancora più insistita, con un riferimento alladimensione dell’attuale, in particolare attraverso due lessemi che appartengonoallo spettro semantico dell’economia: il “prodotto nazionale lordo” e i “conti”.L’erba palustre torna per la terza volta, e riguadagna però statuto negativo, poichéinfesta la ragione, o ne caratterizza un certo tipo, che non a caso pare incapacedi moto, sia essa voce, sospiro, urlo, turbine. A questo spazio chiuso e senz’aria(la “cucina”, altrove luogo di ben altri misteri) si oppone, paradossalmente ma
48
coerentemente con altri passi caprettiniani già discussi, “l’antro gioioso” dei morti.Si noti che il passaggio tra i due spazi è intercalato dalla cesura di uno spazioaperto, caratterizzato dal vento. I morti, custodi memoriali, “danno ai vivi”: questoprogramma narrativo salvifico permette di accedere di nuovo ad una capacitàfonatoria, una voce, per quanto ridotta a “brevi guaiti”. Ciò che ai vivi danno imorti, come soggetti destinanti del valore, è esattamente una capacità di moto, il“dono di spostarsi altrove”.
11“Parole segno, parole sogno” programmaticamente ruota intorno ai due perni dellascrittura e dell’immagine, domini accomunati da una sorta di omologia di produ-zione (per dirla col semiologo Rossi Landi). In generale, il verso tipicamente piùbreve consente spesso un isolamento icastico delle immagini. Si è già avuto mododi notare questa relazione tra lavoro onirico e scrittorio, ma nella sezione questodoppio congegno è particolarmente evidente, poiché vi si affastellano immagini chequasi inesorabilmente riconducono alla scrittura. Così le figure dell’“attrice estro-sa”, interlocutrice del soggetto che in un divenire animale “sgranocchia ghiande”,la subitanea violenza del “cane picchiato dal padrone” co-articolano l’altro campo,quello della “fiaba dolce”, del “crampo dello scrivano”, della “biro”. Le “immaginifiorite” si fanno scrittura attraverso un oggetto mediatore, che coappartiene aidue campi semantici, “l’inchiostro di coquelicots”, il primo non a caso un fluido,il secondo fiore e insieme, per metonimia/sineddoche, colore.
12Componimento breve, come tutta la sezione, centrato su una aspettualizzazionetemporale incoativa. Il tema è quello dell’attesa: si pensi al “rito ancora da com-piere”, alla “speranza lieta”, al “tremolo tuu” del telefono. Quella del desiderioè un’arte che segue lacanianamente una logica dello spostamento, verso un ciòche ancora non c’è. Ma questo movimento (ormai lo si è visto) segue sempre unandamento fortemente non lineare, un “circuito breve”, uno “scatto”, in un tempoche è sempre passaggio, un “germogliare di fine stagione”.
13Ancora in relazione con il tema dell’attesa, la poesia qui però ne coglie un atti-mo diverso, quello in cui l’esperienza, come indagine del reale, si riversa nel suodoppio che la completa, la scrittura. Questa sorta di salto, di rovesciamento, chequi è colto in flagrante, nell’“attesa”, è un “cambio di mestiere” per il soggettodell’enunciazione (interessante e spiazzante il falso raccordo con le “bimbe da-gli occhi incantati”), il quale muove da soggetto fenomenologico dell’indagine asoggetto autoriale delle “fragili parole”. Pure, questa inversione, vera e propriatransustanziazione, del soggetto non avviene immediatamente, ma attraverso unpassaggio interstiziale, in un “gioco” in cui il soggetto si avvince da solo e che“disegna curve lente”. Il soggetto fenomenologico dell’estate (non esplicitata, ma
49
attivata per contrasto dall’“inverno”) è ora “senza parole”, mentre quello scrittu-rale ha “carta nuova” sui cui riportarle nella stagione invernale della scrittura.
14Il sogno, anche attraverso l’insistita, quadrupla, reiterazione, predomina nel te-sto. Il sogno come momento aurorale, come figura di una logica desiderante eproduttiva di immagini (“il desiderio come sogno”) la cui “mareggiata generosad’immortalità” (si noti la tipica figura marina) soverchia il soggetto fino quasi aimpedirgli quella svolta verso la riconversione in scrittura (“aspra la biro”) cheera descritta nella poesia precedente. Pure, due figure dell’approdo emergono nelfinale, “il porto armonioso” e la “cala” (se del termine si assume una accezionesostantivale e non verbale) che permette uno mediazione con gli “affanni quoti-diani”. Il ritrovato, parziale equilibrio permette allora al soggetto di distanziarsisia rispetto alla mareggiata onirica che al sopravvenire del quotidiano e, se nondi mettersi in ascolto, almeno di situarsi come metasoggetto cognitivo che vaglia“quale voce ascoltare”. La figura acustica del “coro silenzioso” è allora un’indicedi questa riguadagnata lontananza.
15A prosecuzione ideale del componimento precedente, quest’ultima poesia dellaserie pare cogliere invece un momento risolutivo, in cui il “suono” (si pensi al“coro silenzioso”) è preso in carico (“portato con sè”) dal soggetto con il fineesplicito di “cominciare un mondo”. Questa dimensione deliberativa si coglie inun’indifferenza per le variabili (“amici o nemici o/forse verità non so”), che è benisolata dal verso breve. Questo percorso (una “passeggiata d’occidente”) si chiudesignificativamente con una torsione del rapporto comunicazione in cui “lei” (laterza persona permette di tematizzare il femminile) che “tesse con me” –il testoè etimologicamente un tessuto– ridiventa un “tu” (“hai dedicato tutte”), comeorizzonte enunciativo della poesia.
16Le poesie da “Indietro e oltre” si caratterizzano per un tratto più esplicitamentelirico, intimo che si concentra sui rapporti personali, molto spesso familiari. Laspessore figurativo del mondo si riduce a pochi elementi che situano la poesia nelmondo naturale come una rada punteggiatura. Questa prima poesia, il cui carat-tere musicale emerge in un ritmo rubato, ha il suo punto focale nell’abbandonoe nel testamento. Nel dialogo tra l’autore e il suo interlocutore, quest’ultimo èil depositario di un “incanto silenzioso”, le “carte del rifugio” che ha lasciato alprimo in “testamento”. Il tema del testamento permette una struttura narrativain flashback, in cui dal lascito nel finale si ritorna all’addio, a quella “corsa” con“un cappello gettato” che ne è all’origine.
17Il testo è organizzato in due blocchi che però trascolorano senza soluzioni di con-tinuità. La prima sezione è un dialogo con la “figlia” che si manifesta (si osservi
50
la prima persona plurale, inclusiva, di “diamo”) attraverso il “gioco con le dée”.Questo gioco, altro disvelamento del divino nel quotidiano, dota l’umano di “pie-di della vertigine” e conduce all’“approdo di luce”. L’“occhio senza fastidi” è ilperno su cui invece si delinea lo sfondo valoriale opposto, quello della “vita dalpiatto amaro”, che è ciò da cui il gioco con le dée deve permette di scampare.In particolare “senza fastidi” ha una posizione sintattica chiave, perché indica inprimis l’accesso alla vertigine (l’allontanamento dal quotidiano), ma anche il suocontrario (si noti la reiterazione), la riduzione al quotidiano pacificato ma inerte,una disforia “senza bagliori né miraggi”, “senza cielo”.
18È di nuovo il tema dell’abbandono a dominare, subito imponendosi nel primoverso. Reso più storico con il riferimento al “sabato”, tuttavia, anche grazie al fra-zionamento del verso, ripiomba subito nella remotezza. Pure, altri due riferimenti(“dall’orrida gola in volo” e “friederich pittore”) forniscono un tenue aggancio adun mondo di fatti. Ma il registro trascolora rapidamente nel metafisico, ed in par-ticolare è il viaggio ultraterreno dell’anima (“ombra celere”) che emerge, l’accessoall’ “aldilà vicino”. L’interlocutore pare allora di nuovo lo psicagogo già incontrato(si veda al n. 16). Là deteneva le carte del rifugio del vento, qui, con medesimoinciso, quelle del “cielo” o forse del “cielo mare”, estensione unica ed infinita chesi confonde –con un tratto tipicamente atmosferico, si è visto– all’orizzonte.
19Di taglio decisivamente più figurativo, la poesia si apre sotto il segno dell’“ippocampo”e della “foglia” che diventano, per il tramite dell’associazione mnestica (“déjà vu”)l’emblema della figura della nonna, “compagna di queste creature”. Il dominio ani-male immediatamente riattiva la presenza di quest’ultima (“se pensi”), con unaimmediatezza d’innesco difficile da controllare (“duro da possedere l’esercizio chesi vuole appartato il tuo nome”). Questa solidità dell’apparenza è inusuale nelleliriche di Caprettini, che prediligono al contrario lo sfaldarsi del reale fenomeniconel baluginìo come porta d’accesso all’altrove (sia esso sogno, ricordo, aldilà). Pu-re, questa apparenza viene confermata, quasi a ribadire una presenza stereoscopicadel ricordo: in questa faneroscopia (per dirla con il Peirce studiato da Capretti-ni), il “viso” che appare cambia l’“apparire” convertendolo in “convinzione”, ed iltempo si solidifica in una “lama d’incanto”.
20È di nuovo una figura naturale, una percezione rapida e contraddittoria che innescala meditazione: quella della “corsa verso se stessi”, dell’“arcobaleno silente deigrilli”. L’allontarsi rapido (come un balenìo) da sé è quindi il tema che dallafigura naturale conduce ad una riflessione sulla morte (“la morte appare come unpensiero”) intesa come un allontarsi da sé, come paradossale vedersi altro: ci sitrova così ad amare, per il tramite di questa “compagna di cose”, “la capannafatta di me dell’altra sponda”. La paradossalità del pensiero sulla morte che è
51
possibile solo ai vivi è allora quella di un soggetto dell’enunciazione che vede sestesso da fuori e per di più non come persona ma come spazio (la capanna) altrove(l’altra sponda). Ma questa meditazione che prende una immediata declinazionescopica, di visione, sparisce in un guazzabuglio di elementi, un flusso che riassorbee sovrasta (ed è quasi invocato, si pensi al congiuntivo esortativo: “il corso chesi faccia”) fatto di nuove figure naturali, in cui però percezione e enciclopedia sifondono (“il pesce nei mari d’oriente”): è la continuità peirciana dell’uomo-segno.Proprio il passero (“bruant”) chiude la poesia e la serie.
21La serie de “L’incontro” ha una esplicita dominante amorosa. Si tratta di com-ponimenti più brevi, spesso caratterizzati da un verso irregolare e da un certoturbinio surreale di immagini. Ne è un buon esempio l’incipit di questa primapoesia in cui si affastellano figure (in un “vortice”) che rimandano lato sensu alprototipo dell’impalcatura metallica (“fari ponti travi aste gru taglienti”), tale dapermettere la connessione con la guerra cui il testo accenna. È l’“occhio giallo”che attiva un’altra visione, coi cui “la vela lontana” dichiara la natura di fuga(“la ritirata” con cui si chiude la poesia) dalla “prigionia del mondo” (dai “guar-diani” che aprono lo stesso componimento). Si noti il passaggio dall’oggettualitàdelle figure meccaniche al corpo come oggetto coappartenente al soggetto (“la miaschiena”) fino alla manifestazione di quest’ultimo come espressione del soggetto(“il sorriso tesoro”).
22Il meccanismo di base è paratattico, sia attraverso l’uso esplicito della congiunzione(“e domani. . .e basta . . .”) sia per apposizione successiva di periodi che permettonouna lettura insolitamente piana. Tuttavia gli incisi sono di due tipi che si alternanocon effetto elegante di continuo trapasso: descrizioni dell’amore (“far ridere glialtri”, “domani ci unisce”, “spezza la mia schiena”, “non distingue il momentoi talenti”, “non chiede corteo”, “è quieto nel vortice”) e interlocuzioni all’amata(“basta che disegni”, “tu fai senza volere”). Come in altri casi, l’elemento-perno èposto nell’interno ed è qui, chiaramente, “il nostro amore”, che è sintatticamentel’oggetto del disegno e il soggetto che spezza la schiena. Ancora, un asse semanticoorganizza il comportamento pubblico (la processione del corpus domini, attesa“senza volere”) e la dimensione privata (l’amore che invece “non chiede corteo”).
23Un’altra poesia di attesa, giocata però su un peculiare registro urbano, dal riferi-mento al Pincio a quello dell’aula, e soprattutto a quello del semaforo rosso, “dovevince chi è quieto nel sacro recinto delle strade”. È un’attesa che però sembraportare ad uno smarrimento, senza cioè che sia chiaro quale ne sia l’oggetto: bastipensare alla dismissione cognitiva di “ma io non conosco”. E infatti la predilettaseconda persona singolare ora include un indeterminato plurale (“userete i tuoiocchi”) che introduce altri soggetti oltre a io–tu. L’attesa è allora soprattutto una
52
sospensione incognita, un “tuffo” i cui si trovano mille congiunzioni avversative. El’effetto di questa sospensione si ribalta anche sull’espressione, chiudendo la poesiain maniera esplicitamente tronca.
24Costruita su immagini disforiche, la poesia inanella un insieme di figure di nonfacile interpretazione. Il tema dominante è quello dell’estenuazione e della stan-chezza. Si apre in maniera “infernale”, con la sequela della gente rapita a braccialegate; segue il lavoro smodato; e con esso il lavoro della scrittura, per il qualel’“anima” è “stanca” e la “carta” è “poca”. L’atto di felicità è dunque menzionatoma sospeso in ogni sua effettualità (anche poetica: non ne consegue alcunché). Idue versi finali sembrano indicare una causa di questo stato disforico del soggettonell’ostinazione dell’interlocutrice (che si può leggere al femminile se ci si mettein chiave di corpus) verso “chi ha lasciato”. Dunque, una temporalità iterativa einefficace (l’ostinazione) nei confronti di un’altra azione interrotta (da parte di chiha lasciato) si riverbera dal tu all’io.
25L’ultimo componimento della serie pare invece proporre un moderato rilancio eufo-rico rispetto al precedente. All’attesa inane si contrappone subito una contrazione,un movimento sussultorio, la cui descrizione occupa i primi due versi. La para-dossalità della contrazione –un moto che è insieme guizzo e immobilità– apre lapoesia nel verso sintatticamente simmetrico e semanticamente opposto “lento co-me rapido”. Questo “flutto di grazia” permette però un passaggio al limite: “oltrela notte del cuore”, che ribadisce peraltro l’ispirazione amorosa della lirica. “Qui”è dunque il luogo dell’arrivo dove prospettare programmi comuni (“metteremo”)per il futuro: l’immagine della disponibilità totale del poeta è quella iperbolica percui si rende possibile disporre di “file di me nelle scale”. L’immaginario marino èallestito dal “flutto” ma anche dal “molo” che configura l’approdo, quello a cui siarriva “oltre la notte”, molo a cui si invita l’amata a “tenere” quelle cose (non no-minate) “rubate al cielo”. Quest’ultimo rende schiavi, ma il maschile (“schiavo”)introduce una ambiguità: è forse il soggetto che è rimasto schiavo, e che parla ase stesso o, ancora, che cede la parola alla donna, la quale lo interroga.
26–35Difficile fornire, per quanto brevemente, note puntuali per ogni poesia che componela sezione, dal titolo programmatico, “Non intendo più le umane voci”. Tentativosi direbbe joycianamente “au bout de l’italien”, si caratterizza per una eversionedalla lingua naturale, a cui pure però non si oppone. In questa lingua immaginifica(dove l’immagine questa volta è immagine fonica) e onirica (dove il sogno si con-verte da generatore di lessemi in produttore glossolalico) sembra rimanere –assaisullo sfondo– l’italiano. Lo si vede intanto dalle parole che la compongono, sianoesse intese dal punto di vista fonologico che da quello ortografico. Ad un rapidosguardo si nota l’adesione non solo alla fonologia e alla fonotassi dell’italiano, ma
53
pure alla morfologia, e si riconoscono forme flessive. Si consideri la n. 26. Essaannovera una forma potenziale di participio passato plurale, “quorartati”, cosìcome forme flessive verbali: “quessasti”, “orarti” “chettoliamo”. Altre forme po-tenzialmente sostantivali, soprattutto femminili, come “banta”, “ratana”, “epia”.Ma, a ben vedere, c’è un fitto intrico morfologico puramente italiano. In esso i so-stantivi emergono più nitidamente (“finto”, “via”, “magli”, “unto”, il verbo “sa”),ma sono pure circondati da una costellazione di particelle di vario tipo: “ha”,“di”, “ci”, “me”, “mi”, “a”, “il”, “no”, “e”, “o”. Infine, se si assume che questointrico di sfondo possa funzionare come attrattore verso l’italiano, un ulteriorestrato è quello di una sorta di distorsione morfologica verso forestierismi di variotipo, sia verso forme dialettali che verso forme desuete, che verso lingue straniere:si pensi a “to soma”, dove la forma greca per corpo pare essere specificata daun aggettivo possessivo che prende forma quasi-francese o piemontese (“dialettod’adozione” dell’autore). L’interpretazione si apre in questo modo ad una costella-zione di possibilità difficilmente controllabile analiticamente ma pure potenziale.Infine, va notata la dimensione metalinguistica che fornisce il quadro di riferimen-to per quella linguistica: questa proto-lingua, sia essa pre- o post- lingua, è calatain uno stampo coerente con le forme della poesia caprettiniana (l’uso di un versoirregolare libero, ma non prosastico) ed è articolata ortograficamente attraversola punteggiatura in enunciati di vario tipo, incluse interrogazioni ed esclamazioni,organizzate per paratassi e ipotassi.Dunque, per riassumere, ne risulta un protolinguaggio non al limite ma oltrel’italiano. Ferma restando l’importanza del piano fonico in quanto tale, pureall’interpretazione (che qui emerge chiaramente nella sua natura costruttivisti-ca di “semantizzazione”, per dirla con Basso) sono offerti per ogni componimentodegli attrattori, cioè parole italiane, in varie forme flessive, che si stagliano chiara-mente (in quanto immediatamente accessibili all’enciclopedia del lettore modello)sulla sfondo glossolalico e che ne orientano la lettura. In altri termini, questi mor-femi determinano in senso proprio l’orientamento di una sorta di campo di forzesemantico di cui sono i punti di massima intensità. Senza entrare nel dettaglioteorico, improprio rispetto a queste brevi note, alcune considerazioni per le diecipoesie che compongono la sezione. La n. 26 apre la serie: come si è visto, si producein un insieme di verbi la cui flessione ribadisce il consueto rapporto d’enunciazioneio–tu. Una sequenza programmatica occupa proprio i primi due versi, “ti ha mefinto”, che, oltre all’instaurazione del rapporto, introduce il tempo della finzione,sia come finzione linguistica (come falso) che etimologicamente come modella-zione, costruzione plastica della lingua che appartiene alla poesia in quanto talee che qui si riversa al di sotto, sul linguaggio stesso. Nella poesia 27 una cate-na attrattiva è “ci e ame ro amanti”, che evidentemente stabilisce il sema dellapassione amorosa. Rispetto ad esso, un elemento di secondo livello (si potrebbein effetti stabilire una sorta di continuum di irradiazione semantica) è dato adesempio da “vi lucie”, che pare indicare l’elemento luminoso rispetto ai sogget-ti amanti. Si noti anche la domanda di apertura che concerne la “glore”, forse
54
forma distorta per gloria, in relazione agli amanti, a cui il soggetto può rispon-dere con uno pseudo-condizionale (“noncherei”). La n. 28 trova un suo attrattorespecifico nell’aggettivo isolato “pacati”, significativamente relativo a un soggettoplurale (gli amanti forse introdotti dalla sequenza quasi figurativa “landa manite mio”) e a cui, con una rimotivazione dell’espressione, fa seguito un insieme diversi assai brevi. La n. 28 pare centrata su una dimensione esclamativa (si pensialla coppia escalmazione/interrogazione d’apertura) in cui l’articolazione lingui-stica si frattura in brevi enunciati. Il verso finale pare offire una risposta o unaconclusione che pertiene la spazialità, attraverso l’asse prossimità/distanza rispet-to all’enunciazione, “la e qui”. Particolarmente ermetica la n. 29, che condivide itratti retorici della precedente, ma che ha un suo perno patemico in una afflizionedel soggetto (“mi pesta”). Un ritmo meno sconnesso, invero assai fluido, è invecela successiva, n. 30, in cui subito viene tematizzato un agente femminile che agiscein qualche modo colpevolmente sul soggetto (“rea. . .me scava”). Pure questa azio-ne entra in relazione con una dimensione metafisica (“fatal no ero”). Infine, conun processo di vetrificazione figurativa rapidissimo, si apre quasi un paesaggio:“vie. . .treni: serre, vino”. La n. 32 di nuovo si impernia sul dialogo a due: “oraci rese” (e si noti che è una costante pur nel terreno morfologico dissestato dellepoesie). La sequenza “che vuo mal no farivi” ammicca fonicamente a “che vuolmal non farvi”, e attiverebbe il tema del pericolo. Infine le “tane” sono poste inrelazione al “vero” (e qui si pensi nelle poesie precedenti a figure come la casa,la capanna, l’antro in relazione alla verità della poesia). Due figure animali sonoospitate dalla n. 33, la “iena” e le “uova” (ma si pensi per proiezione al “gat[t]o”,al vegetale “fio[r]e”, alle più remote “grillicche”). Queste figure si risolvono, con unmoto caprettiniano classico, nel “mare” con cui si chiude il testo (precisamente,quasi in una esclamazione: “que mare”). Si noti come, in opposizione all’attritointerpretativo particolarmente significativo, la lingua presenta una fonicità italia-na spiccata, oltre d una certa eleganza classica (basti considerare l’endecasillabod’apertura). La n. 34 accenna alla riflessione metalinguistica sulla poesia attraver-so la costituzione (improvvisa) di “un io”. Questo io, con una sorta di sicilianismo,“va mondi segnari”: la segnatura del mondo (la possibilità della sua lettura cifra-ta) è dunque ciò che è richiesto all’io (e quindi al poeta, considerata la dimensioneradicalmente metalinguistica di questi esperimenti glottogonici), anche se è subitoavversata (“ma ho no”). Infine, la n. 35 chiude la sequenza forse con il minimoriferimento a quello sfondo enciclopedico linguistico che aveva finora permesso didistricare possibili tratti semantici. Apice dunque di una costruzione linguisticache si autonomizza, in fondo segreta aspirazione della poesia come lingua puradelle cose, il componimento offre però un appiglio che ne specifica proprio questavocazione: appena oltre il suo centro appare così “un fono”: ovvero, ciò che lapoesia alla sua radice più propriamente vorrebbe fare del linguaggio.
55
Postfazione.Brachiscopie: note per una stilistica miope
Andrea Valle
Per Paolo, venti anni dopo
Sul problema della località del senso in semiotica
Uno dei punti irrinunciabili della semiotica, così come si è sviluppata a parti-re dalla temperie strutturalista degli anni Sessanta, è un postulato di globalità.L’investigazione di un oggetto –qualsiasi esso sia– ha il suo abbrivo in un assuntoepistemologico per cui questo è un tutto che si tiene, e si tiene proprio da so-lo: la struttura è una “struttura portante”. Al semiologo il compito di rivelarequel sistema di giunture –magari nascosto o non immediatamente accessibile– cherendono possibile la tenuta semiotica dell’oggetto. In questo senso la semiotica è,anche storicamente, una statica delle strutture di senso. Ed è una teoria impor-tante perché dimostra che il senso è più duro, più rigido di quel che può sembrare:bisogna però riuscire a intravederne le giunzioni. Di qui anche la possibilità di unacritica della semiotica stessa intesa, per dirla alla Derrida, come forma pura, come“totalità disertata dalle forze”. Quali sono queste forze che disertano la struttura?In qualche modo il tema è, detto in termini troppo generali e con una locuzionenon nuova, quello del rapporto tra struttura e storia. Tema vasto, che può esseredeclinato in varie sfumature. Ad esempio, una prospettiva culturologica può fareemergere come l’oggetto sia il risultato dell’accumulazione storica di prassi diver-se. Questa stratificazione (che richiederebbe come in archeologia una stratigrafiasemiotica) può risultare nell’introduzione di attriti tra le giunture, di interruzioni,di crolli locali, di vestigia passate inserite in nuovi contesti. È in fondo l’ambitoin cui si muovevano nel dominio letterario le analisi del maestro di Caprettini,D’Arco Silvio Avalle, non lontano da alcuni interessi di Lotman ma in forma piùattenta rispetto a quest’ultimo a certi dettagli dello scarto. Ancora, questa vo-cazione della semiotica alla statica ha come risultato una difficoltà intrinseca delparadigma greimasiano. Infatti, l’assunto greimasiano di fondo è che il senso sidia a posteriori e vada ricostruito con una procedura che assomiglia agli algoritmidi backtracking in informatica. Si risale un albero di possibilità fino a che non siritrova un percorso che linearmente conduca dall’inizio alla fine. Qui inizio e fineperdono la loro natura temporale per guadagnarne evidentemente una spaziale:
56
sono punti in uno spazio cha vanno collegati senza residui. Il senso delle cose sidefinisce intrinsecamente a posteriori. La verità di questa affermazione, che è ilpresupposto strutturale transitato ed espanso da Greimas, va però declinata conattenzione. Infatti, un conto è dire che il senso è sempre dopo (livello epistemolo-gico), un altro è dire che alla fine di un oggetto (livello metodologico-operativo).Ecco che allora, del tutto empiricamente, le analisi semiotiche che per pura como-dità possiamo definire greimasiane, lavorano tipicamente ricostruendo dal fondoun senso attraverso gli snodi della narratività (ed in particolare della sintassi nar-rativa, nel suo svolgersi fin troppo canonico). Tuttavia, in questo modo si confondenarratività (come presupposto epistemologico) con narrazione (come effetto empi-rico e storico). In altri termini, una narrazione può declinare e organizzare in variomodo effetti di narratività ma non necessariamente adeguare nel suo totale la sin-tassi narrativa. D’altronde lo stesso Greimas, descrivendo i programmi narrativid’uso, ne dimostrava il concatenamento complesso, anche se assumeva che “uso”indicasse una “utilità generale” per il programma narrativo di base. Il rischio checorrono spesso analisi che invece diano per scontato questa organizzazione globaleè quello della potatura: tutti i rami che non sono riconducibili al tronco vannotagliati. Ma a ben vedere, Greimas era partito da un presupposto non globale malocale, cioè dalla predicazione, dal piccolo dramma tesnèriano, che struttura unenunciato, e non un testo. Si supponga che un testo sia un insieme di enunciati,ognuno dei quali costituisce di per sé un programma narrativo. Il fatto che lasequenza dei programmi in quanto tale sia un programma non consegue diretta-mente dalla natura dell’enunciato. Piuttosto, è un postulato di ricorsività che infondo proviene da Chomsky (nonostante i distinguo), il quale però -guardacaso eal di là di tutto- lo aveva postulato proprio per il livello dell’enunciato. Dunquela narratività è un conto, la narrazione un altro. La presa del senso a posteriori alivello del programma narrativo minimo è un conto, a livello della narrazione glo-bale un altro. I nodi di un simile postulato vengono al pettine quando il paradigmasi confronta con oggetti che non sono prodotti (dati) ma produzioni (in corso). Adesempio, se è possibile discutere della ricetta della zuppa al pesto pensata comeoggetto-testo dato, più complesso è invece discutere della sua implementazione daparte del soggetto che cucina. Ovviamente si può aggirare il problema assumendoche la pratica possa essere analizzata soltanto a partire da una sua descrizione,cioè nel momento in cui è testualizzata. Ma, appunto, è un aggiramento. Piuttosto,la nozione di pratica diventa interessante poiché pone il problema della valorizza-zione instabile proprio perché in corso, e dunque in fase di assestamento o anchedi negoziazione tra i soggetti (semiotici, attanziali) coinvolti. Mentre il testo ècostruito analiticamente a partire da una stabilità dei valori che l’analista postulae/o riconosce, la pratica richiede di riconoscere lo stabilirsi temporaneo e in corsodegli stessi sistemi (si vedano ad esempio gli interventi a cura di Pierluigi Bassosul n. 4 di Semiotiche, la breve ma intensa serie curata proprio da Caprettini trail 2003 e il 2006). In realtà, una simile organizzazione locale che si può tradurre in
57
una “incoerenza” globale del senso era già stata osservata da Eco –il quale mantie-ne sempre uno sguardo saldamente empirico nelle sue analisi– proprio discutendodi narratività, ad esempio nel Lector. Due sono gli esempi flagranti nella casisticaechiana: l’analisi di Un dramme bien parisien di Allais, in cui le configurazionilocali sviano sistematicamente il lettore (dopo), e le considerazioni sul feuilletondumasiano, un vero e proprio esempio di traccia della pratica scrittoria in corso.Da dove proviene allora a Greimas (ma anche a molta altra letteratura narrato-logica) questo postulato di coerenza globale del narrativo? Si potrebbe trovareforse la sua origine in un’idea di testo (come oggetto teorico) modellata sul testoscritto ed in particolare sul testo della modernità classica, quello del romanzo oracconto moderno: e non a caso Greimas ha dedicato un intero, elegantissimo esottovalutato libro a Maupassant, tra l’altro edito in Italia in una collana curatada Caprettini presso il Centro Scientifico Editore. Nel romanzo classico i continarrativi tornano (quasi) sempre, come tornano sempre nella letteratura fiabesca.Ma in quest’ultima tornano veramente? Così ci dice la vulgata, la quale prende lafiaba è una sorta di ur-esempio narrativo. Ma i conti tornano soltanto nella fiabadepurata dalla tradizione scritta (si pensi ad esempio all’omogeneizzazione, perquanto godibile, operata da Calvino sulle fiabe italiane). La fiaba nel suo regimeorale è tutta un’altra cosa: qui il narratore divaga, perde il filo, interviene conaggiustamenti di carattere fàtico, valuta durante la sua performance la reazionedel pubblico (si pensi appunto a quanto accennato sulle pratiche rispetto alla ge-stione in corso dei valori). Ancora, il narratore deve gestire una memoria, sua edel pubblico, che attribuisce un peso molto maggiore al raccontato recente rispet-to a quello passato. Tanto che gli effetti di potenziale incoerenza possono essereneutralizzati dalla pura distanza temporale tra elementi. In sostanza, il tempodella performance può allentare –fino ad eliminare– gli anelli di catene causali traprogrammi narrativi. Per averne una percezione immediata basta leggere le tra-scrizioni etnografiche raccolte da Rivetti e a cura di Caprettini nel volume Fiabepiemontesi. Ma dove risiede un programma narrativo? In un celebre passo, non acaso ripreso da Eco, Greimas nota come già il lessema “pescatore” contenga in séun programma narrativo potenziale. Ne conseguirebbe che una catena di lessemi èuna catena di programmi narrativi potenziali. Ma è anche una catena di figure, cioèdi elementi riconoscibili per un soggetto competenzializzato rispetto ad una certacultura, ovvero di entrate enciclopediche. Si delinea così un rapporto peculiare trail figurativo e il narrativo. Da un lato (si direbbe in termini classicamente grei-masiani) il figurativo è la carne del mondo che rimpolpa strutture logiche astratte(i programmi narrativi), e verrebbe logicamente dopo il narrativo, dall’altro è ilfigurativo che propone o prospetta una narratività possibile, che dunque ne con-segue. In effetti, la figuratività è ciò che pertiene ad un riconoscimento immediato(per il soggetto competente), mentre la narratività è sempre una ricostruzione direlazioni. C’è dunque una logica proattiva del figurativo (che proietta un “ciò chegià si è riconosciuto” in avanti) e una logica retroattiva del narrativo (che proiettaall’indietro una struttura di relazioni). Senza svilupparla nel dettaglio, Caprettini
58
ha proposto una modellizzazione che in qualche misura coglie quest’aspetto, mo-dellizzazione che è non a caso scaturita dalla riflessione sulla fiaba. Il Dizionariodella fiaba italiana che Caprettini cura nel 2000 si propone di fornire un elencodettagliato delle “unità figurative” (questi i lemmi del dizionario) che popolano –apartire dai principali repertori– la produzione fiabesca italiana. L’unità figurativaè intesa come una unità di contenuto che può manifestarsi attraverso più unitàespressive linguistiche. Quest’ultimo punto non è sempre così pacifico: funzionasenza particolari intoppi ad esempio per quasi-sinonimie come “abito”/“vestito”,meno in altri casi, in cui l’omogeneizzazione di più unità linguistiche ad un’unicaunità di contenuto (l’“unità figurativa”, appunto) è decisamente più delicata. Ma,al di là di questo punto, nell’introduzione Caprettini ragiona su un problema di-verso, ovvero sulle forme attraverso le quali queste unità figurative entrano inrelazione, per proporre una lettura della narratività come configurazione locale (esi potrebbe qui pensare alle osservazioni che muove Ricoeur a Greimas) che peròprende una forma, come si diceva, modellistica. Detta rapidamente, ogni unitàfigurativa, seguendo un modello chimico (ma anche in fondo già tesnèriano), sidoterebbe di valenze che ne permetterebbero il concatenamento. Il meccanismo èricorsivo, cioè l’unità B concatenata ad A espone le sue valenze che permettonoun concatenamento successivo, verso un’unità C, e così via. In questo modello,la storia è uno sviluppo, letteralmente una “stringa” per Caprettini, di figure.L’ipotesi non viene sperimentata nell’analisi, ma pone una questione interessante.Qui il soggetto della produzione semiotica, l’istanza dell’enunciazione, è pensatocome un concatenatore di figure che ha come suo tratto radicale una memoria abreve termine. Infatti, la progressione B → C è del tutto indipendente da quel-la A → B, poiché dipende solo dalle valenze di B. In altri termine, il soggettoconcatenatore si dimentica di A quando procede verso C. Il programma narrati-vo complessivo diventa un processo stocastico markoviano, una catena di stati incui ogni transizione gode della proprietà di Markov, cioè dell’indipendenza dallatransizione precedente. Non è affatto detto che un unico modello debba essereassunto come modello di tutte le relazioni narrative, ed è invece perfettamentepossibile che logiche diverse governino organizzazioni testuali diverse: dunque nonsi tratta di contrapporre una logica all’altra. Piuttosto, è interessante osservarecome questa logica narrativa markoviana a base figurativa assuma evidentementeche il senso si produce localmente, cioè nelle singole transizioni, nelle relazioni tracoppie di stati, e non in una sistematizzazione complessiva dalla fine a ritroso.Si potrebbe infine argomentare che la dialettica tra il locale e il globale non siaesclusiva. In altri termini, c’è una lettura (se si vuole, più astrattamente, una pren-sione) del senso locale e una globale, e le due possono trovarsi sia in attrito che inaccordo. In qualche modo l’analisi privilegia il globale (stante l’argomento di Ecoper cui si capisce quando si legge una seconda volta), ma pure una prima letturasi dovrà pur dare, e se una delle coordinate trascendentali entro cui ci muoviamoè il tempo, una prensione locale è in qualche modo presupposta a ogni prensioneglobale.
59
Ad una riconsiderazione storica, si potrebbe osservare come la semiotica in quan-to disciplina si sia interessata a forme testuali di vario tipo, in primis linguisticheper poi aprirsi ad altri oggetti, dall’architettura al film, tant’è che ormai c’è unasemiotica di qualsiasi cosa, come per la filosofia o la sociologia. Uno dei puntiproblematici di questa estensione sta, come noto, nella riflessione spesso defici-taria sul piano espressivo che consegue ad una sorta di imprinting linguistico.Nella lingua l’espressione è stabilizzata e ciò permette di mettere comodamen-te tra parentesi il piano espressivo per gettarsi a capofitto nell’analisi di quellodel contenuto. Ma il materiale linguistico offre spunti cruciali alla semiotica nonappena l’espressione resiste a questo accesso al contenuto. Sarebbe stato proba-bilmente più utile studiare questo problema sulla lingua, prima di passare allesemiotiche non linguistiche: ne sarebbero probabilmente venuti fuori stimoli epi-stemologici che avrebbero permesso di chiarire alcuni punti di rilievo. Ad esempio,forme linguistiche “devianti”, come la glossolalia o le formule magiche, pongonoun insieme di problemi interpretativi complessi e stimolanti. Ancora, si pensi allestrategie interpretative messi in atto nella decifrazione di lingua sconosciute. Nonultima, la poesia, ed in particolare quella a vocazione maggiormente sperimentale,in cui il lavoro sul significante è particolarmente intenso. Va da sé che storicamen-te questi ambiti sono stati scarsamente frequentati, se si eccettua Eco, da sempreinteressato a questa dimensione a partire dagli studi joyciani sul Finnegan’s wake.
Un esperimento di semiotica computazionale
A partire da questo insieme di considerazioni, per quanto abbozzate e poco or-ganizzate, le poesie che compongono la raccolta precedente sono il risultato diun esperimento. In particolare, l’idea è quella di generare nuovi testi a parti-re dall’insieme delle relazioni locali in un testo fonte. Il soggetto di una simile(ri)produzione semiotica opera perciò secondo un doppio passaggio: rileva le re-lazioni in un testo precedente e le usa per generare un nuovo testo attraverso laloro concatenazione. Questo soggetto dunque coglie relazioni locali e attraversola conversione del processo di analisi in processo di sintesi le offre come verifi-ca sperimentale. In altri termini il processo nel suo complesso offre un’immaginedell’autore modello previsto dal testo originale attraverso una lettura che valoriz-za una interpretazione locale. L’esperimento dunque cerca di rispondere a questadomanda: cosa resta dell’autore precedente? E tuttavia per rispondere a questadomanda bisogna sottoporre i testi ottenuti ad una interpretazione successiva perpoi verificare cosa succede in rapporto ai testi originali. A questo provvedono le(brevi) note ai testi che chiudono Caratteri mobili.Nel complesso, si tratta perciò di un esperimento di semiotica computazionale, eda questo punto di vista si propone come esercizio per una semiotica formale (per-ché descrive i suoi oggetti in modo esaustivo e non ambiguo), sperimentale (perchési confronta con oggetti che non determina se non nelle condizioni di partenza)e computazionale (perché utilizza un calcolo sulle forme simboliche). Da questo
60
punto di vista è una semiotica “generativa” (ma nel senso usuale, non in quel-lo a tratti bizzarro del paradigma greimasiano, in cui propriamente la semioticagenerativa non genera proprio nulla).
Una metodologia per la generazione senza memoria di poesie su base espressiva
L’esperimento è condotto a due diversi livelli di granularità, che sono contenutinelle due parti della raccolta. La prima, “Una catena interminata di sogni”, ècentrata sul livello morfologico-sintattico, la seconda, “Non intendo più le umanevoci”, su quello fonologico/fonotattico. Il testo fonte è costituito da Parole pere-grine, raccolta delle poesie di Caprettini uscita per i tipi di Cartman nel 2010. Inparticolare, per la prima parte della raccolta –“Una catena interminata di sogni”–ogni sezione di poesie ha come testo generatore la corrispondente sezione nel volu-me originale. Alla base dei testi della seconda parte –“Non intendo più le umanevoci”– sono invece tutti i testi di “Mezz’ora per me” (con alcune particolarità cheverranno indicate in seguito).
Tokenizzazione
AnalisiTesto fonte
Creazione successori
Pre-produzione Concatenamento
Post-produzione
Testo foce
ANALISI SINTESI
Fig. 1 Analisi e generazione di te-sti, livello morfologico.
Iniziamo dalla metodologia alla base della prima sezione, di tipo morfologico. Loschema complessivo è descritto in Figura 1. Il testo fonte viene prima trattato daun processo di formattazione che elimina la punteggiatura, gli spazi vuoti superioria uno, gli a capo, oltre ad eventuali aspetti meramente tecnici che concernono lacodifica informatica dei caratteri. Il testo originale è anche sottoposto in paralleload un processo di analisi che ne ricava alcune proprietà statistiche, ad esempiorelative alla lunghezza (massima, minima, media etc) dei versi, delle strofe, dellepoesie, e così via. Queste informazioni possono poi essere impiegate in fasi di sintesiper parametrizzare gli algoritmi generativi. Il testo fonte è rappresentato per ognisezione da un testo che include tutte le poesie della sezione di riferimento in Poesieperegrine. Quindi le poesie “daMezz’ora per me” in Caratteri mobili sono appuntogenerate dalle poesie che compongono Mezz’ora per me in Parole peregrine. Unavolta trattato, il testo fonte è sottoposto a un processo di tokenizzazione che lo
61
suddivide in item lessicali. Il vettore che contiene tutti gli item ha semplicementela forma seguente (l’esempio è dalla sezione “L’incontro”):
[ ’il’, ’viatico’, ’leggero’, ’che’, ’mi’, ’hai’, ’regalato’, ’E’, ’come’,’una’, ’merendina’, ’uova’, ’formaggio’, ’nocciole’, ’vino’, ’frutta’, ’il’,’senso’, ’scandito’, ’del’, ’nostro’, ’amore’, ’oggi’, ’che’, ’ti’, ’ho’,’preparato’, ’il’, ’pranzo’, ’tu’, ’che’, ’corri’, ’nella’, ’nebbia’, ’a’,’conquistare’, ...]
(Le maiuscole sono introdotte dalla fase di pre-produzione come mero fatto tec-nico per rappresentare le lettere accentate). Su questa struttura opera la fase dicreazione dei successori. Per ogni elemento nel vettore (senza ripetizioni) vienecreata una lista dei successori. Ad esempio, sempre per la sezione “L’incontro”l’insieme dei successori di vieni è composto da un unico elemento: [e], mentrequello di che è:
[ mi, ti, corri, non, scopre, ci, non, vieni, io, parte, ancora, nella,l’artista, ti, disegni, aspetti, non, non, prende, tu, sia, ti, ti, E, E,misuri, devo, non, dA, mai, rubino, anch’io, le, tardi, non, piU, parlavano,al, giA, avrei, piange, fischia, fa, da, deve, ho, sono, rivedo, ti, durano,tu, vive, si, sempre, vedo, non ]
La lista dei successori include tutti gli item che fanno seguito nel testo fonteall’item prescelto, ripetizioni incluse: in questo modo, un certo item avrà un pesostatistico più rilevante di altri, secondo quanto avviene nel testo fonte (ad esem-pio “ti” ricorre dopo “che” 5 volte). Con la creazione della struttura dati relativaai successori (tecnicamente quello che si definisce un “dizionario”, poiché accop-pia ad una chiave –l’item– un valore, la lista dei successori, sul modello lemma-definizione), si chiude la fase di analisi. Il processo di sintesi include logicamentesoltanto due fasi. La prima è quella del concatenamento. Il processo, di naturamarkoviana, parte da un item (in questo caso scelto stocasticamente tra tutti gliitem che risultano dall’analisi), lo immette in un nuovo vettore d’accumulo, sele-ziona quindi uno dei suoi successori pescando secondo il modello dell’urna dai suoisuccessori, e riapplica l’operazione fino ad ottenere una sequenza della lunghezzarichiesta, o fintanto (altra condizione d’uscita) che si selezioni un successore ilquale a sua volta non ha successori. Il modello stocastico dell’urna (in cui sonocontenuti tutti i successori) rispetta la distribuzione originale, perché l’urna con-tiene tutti i successori, ripetizioni incluse. Nella prospettiva del concatenamento,la struttura dati del dizionario può essere altresì rappresentata attraverso un gra-fo, quale quello di Figura 2 (relativo a “Parole segno, parole sogno”). Il grafo èilleggibile, ma la Figura mira a rendere evidente la complessità topologica dellerelazioni. Un frammento dello stesso grafo è riportato in Figura 3.
62
arruffata
come
un
il
si
tutti
la
le
una
l
tequello
noi
nel
tuoistrisce
pane
calura
sull
loro
me
mimo
uomo
mondo
esame
postino
tempo
breve
cane
canto
sussurro
urlo
gesto
rito
sogno
altri
colore
gatto
lupo
orso
po
romanzo
cavalletto
domani
sorriso
cauto
ritmo
libro
miliardario
ubriaco
dirsibim
bo
isola
terrazze
verde
straniero
se
nonombre
mi
sarA
amici
n
m
manca
stagione
della
lo
gela
sapevamo
abbia
intendo
c
ora
ridire
devo
avrA
finisce
finite
so
tua
gente
riva
mia
mente
gioia
preghiera
terratortora
civetta
richiamo
fa
guerra
quando
tverrem
ofiniti
riporto
accorgesti
da
smaltire
suono
turismo
profumo
ventosole
tuo
risveglio
vostro
telefono
ricordo
giorno
mattino
volto
lago
tremulo
grido
riposo
polso
gustocram
pogiallo
blu
cielo
desiderio
contolam
ento
biglietti
in
accantoal
pensieroprim
o
cuore
mio
dEmone
limite
tepore
sanno
ricordi
sguardo
strumento
occhi
piU
indagatore
per
lontano
amore
torno
avvinto
che
casa
newcom
pierelasciare
portare
sveglio
folletti
fiabasensazioni
sabbia
nemmeno
udiamo
fonda
fra
breviqualche
gli
flutti
vorticialtro
uliviaffanni
invano
quel
appare
hai
ritrovarla
ancora
sa
ci
ascolta
spreca
lascio
tu
ispira
parte
accende
qualcosa
celere
s
sai
cadde
ami
decantavi
qui
porto
parli
ti
continui
passerA
rimane
rendeva
scriviamo
vedi
fannoli
correcala
salta
segnano
accoglirisale
crepuscolari
spighe
mietute
ragazza
garbata
di
corpi
saldi
spazio
coraggiooggi
bruno
voi
vecchieluce
fine
maturitA
quale
portarvi
silenzi
ogni
rondini
diventare
cambiare
tarda
cecilia
coquelicots
miagolare
buona
calzari
nuove
chi
ululare
lui
semi
ondeggiare
nomi
nF
verraivogliono
diconocacciano
catturatroveranno
chiamano
blocca
appropria
muterA
ed
dei
nella
chiese
eloquenti
incantati
nell
ultimo
nascosto
dietro
passato
poi
portata
soffre
pare
circuito
affido
briciole
sogni
ad
andare
allenare
tenera
dar
peso
labirinto
perenne
sfumato
moissons
quelle
cosesenso
senza
oggettiparole
odori
voce
parichiam
arle
volume
prima
sia
nuovo
bianca
all
angelo
pacatocustode
piena
ai
passi
felpati
sento
quest
quaresimale
ha
girasoli
disegnatodedicato
boschi
quelltutte
deserti
inizia
metri
dama
nuovineri
greci
trasparentidel
fondiviso
dolce
brezzamanina
soltanto
festosaincantata
squillo
automaticam
ente
nemici
fiero
con
ansia
tonosete
ma
ignarostesso
oscure
emotivo
storia
lieve
speranzanostalgia
biro
stessa
forma
volpelam
asera
vita
mareggiata
risacca
giostra
carta
topolino
filosofici
ripassi
sgarbato
scrivano
mentre
sgranocchio
siano
cui
tue
abbiamo
temps
abbraccia
spalleimmagini
umane
gabbiano
sapere
questa
sfuggirai
angolo
arioso
faceva
sussultare
perfino
E
andato
dalla
donna
incontro
lente
minuziose
chiede
cuori
resta
stamane
nudi
vi
parola
bimba
rosa
dagli
tra
sbuffi
scatto
dal
padroneletto
incrocio
degli
nuova
nei
giorniisolare
cominciare
frasisolchi
solenne
traspare
mingherline
veritA
godevamo
perso
forse
voci
oltre
colori
canti
aspra
chiarebello
dovedolci
semplici
nostro
folata quasi
perdutoavresti
riprenda
fremire
picchiato
lei
colorato
poeta
attricemagica
andrO
fiume
stupore
allegro
nostalgico
sprofondati
schienachiesa
patria
prossima
d
occidente
volti
bel
destino
avremmo
nostre
prigioniere
schiacciate
linguaggio
coro
bosco
silenzio
cibo
prato
bene
golfo
viverelam
pione
tracciati
suoi
pensieri
kant
spinoza
dovrA
pur
ricominciare
estrosa
porterO
solo
dopo
vedo
squillante
capire
sarai
volta
piene
sulle
cime
rive
armonioso
conchiglieserbate
insegna
cercate
scuole
tremule
scrivere
fortuna
fedelegioiosa
cono
incantato
silenziosostonato
vorrei
sognare
affetto
ascoltare
nessuno
acque
profonde
attesa
apertatrem
ila
yorkmentr
dovmemoriali
lustralipiantati
inverno
ignoto
abbracciano
notturna
nottecosI
lieta
diate
rarespoglie
grandi
passerofin
mare
posto
trasformi
vero
doppio
affaccio
sicuro
purchF
ininterrotto
svanisce
volger
anno
ritrovate
amante
frettolosa
sperando
corolle
dunque
guardare
cavalliscale
scopestelle
caricatura
penna
francia
pellegrini
quante
tesse
dialoghi
ombra
curvainchiostro
mito
campi
gettate
perchF
fresco
acquaspalanca
bevuta
realtA
fino
allora
tentoillim
itato
arte
eravamo
stavo
piediritagli
premi
mano
quotidiani
va
passeggiata
far
suoni
venga
estate
ottocento
pensate
mestiere
rinvii
disegna
curve
abbaglio
dell
istante
noci
affetti
fonti
vincent
pazzo
coi
ghiande
io
soffro
dello
appena
tollera
lungo
sentieri
miglia
anche
onde
immortalitA
appartengono
petali
estraneo
tuu
richiama
lavanda
pochi
guaisce
atteso
abitati
des
fleurs
nero
pilota
persona
identiche
gioco
fedeli
orgogliosa
tracciare
oceano
cartoline
appoggia
dire
nelle
strade
intenzioni
alle
quelli
bella
cosa
emozione
nil
ospita
sguardi
eppure
tavola
esponi
innocente
avete
era
stata
scalze
sorprendi
chiara
sentirA
svaniti
maggio
stanca
puoi
cercare
erano
icona
sorridente
alla
sussurri
selvaggio
tellement
jolies
scrivevi
spotinsulti
audiovisivi
incanto
ulisse
trattenuto
alita
inizio
uno
tanto
seduttrice
mite
tentare
mai
poesia
voltato
eravate
tornerO
sepolte
scuote
germogliata
nate
fragili
compagnette
povere
spalancate
cercavamo
solitario
gettando
cercatore
emozioni
famiglia
sFnanque
nascondermi
gioie
generosa
apre
vuote
dispersi
miei
versi
scoperta
civili
vediamo
orizzonti
siede
alba
estesa
stride
parolette
aurora
pensare
delle
fiorite
ingresso
erra
addio
remoti
anima
unicaoccluse
diagonali
recapita
bimbe
bricoleur
aura
arguzia
remoto
umor
timide
Fig. 2 Grafo delle relazioni di successione.
63
arruffata
come
un
il
si
tutti
la
le
una
l
tequello
noi
nel
tuoi strisce
pane
calura
sull
loro
me
mimo
uomo
mondo
esame
postino
tempo
breve
cane
canto
sussurro
urlo
gesto
rito
sogno
altri
colore
gatto
lupo
orso
po
romanzocavalletto
domani
sorriso
cauto
ritmo
libro
miliardario
ubriaco
dirsi bimbo
isola
terrazze
verde
straniero
se
nonombre
mi
sarA
amicin
m
manca
stagione
della
lo
gela
sapevamo
abbia
intendo
c
ora
ridire
devo
avrA
finisce
finite
so
tua
gente
riva
mia
mente gioia
preghiera
terratortora civetta
richiamo
fa
guerra
quando
t verremofiniti riporto
accorgesti
da
smaltire
suono
turismo
profumo
vento soletuo
risveglio
vostro
telefono
ricordo
giorno
mattino volto
lago
tremulo
grido
riposo
polso
gustocrampogiallo blu
cielo
desiderio
conto lamento
biglietti
in
accanto
al
pensiero primo
cuore
mio dEmonelimitetepore
sanno
ricordi
sguardo
strumento
occhi
piU
indagatore
per
lontano
amore
torno
avvinto
che
casa
new compierelasciare
portare
sveglio
folletti
fiaba sensazioni
sabbia
nemmeno udiamo
fonda
fra
brevi qualche
gli
flutti
vorticialtro
ulivi affanni
invano
quel
appare
hai
ritrovarla
ancora
sa
ci
ascolta
spreca
lascio
tu
ispira
parte
accende
qualcosa
celere
s
sai
cadde
ami
decantavi
qui
porto
parli
ti
continui
passerA
rimane
rendeva
scriviamo
vedi
fanno licorre cala salta
segnano
accogli risale
crepuscolari
spighe
mietute
ragazza
garbata
di
corpi
saldi
spazio
coraggiooggi
bruno
voi
vecchieluce
fine
maturitA
quale
portarvi
silenzi
ogni
rondini
diventare
cambiare
tarda
cecilia
coquelicots
miagolarebuona
calzari
nuove
chi
ululare
lui
semi ondeggiare
nomi
nF
verrai voglionodiconocaccianocattura troveranno
chiamanoblocca
appropria
muterA
ed
dei
nella
chiese
eloquenti
incantati
nell
ultimo
nascosto
dietro
passato
poi
portata
soffre
pare
circuito
affido
briciole
sogni
ad
andare
allenare
tenera
dar
peso
labirinto
perenne
sfumato
moissons
quelle
cosesenso
senza
oggetti paroleodori
voce
parichiamarle
volume
prima
sia
nuovo
bianca
all
angelo
pacato
custode
piena
ai
passi
felpati
sento
quest
quaresimaleha
girasoli
disegnato dedicatoboschi
quell tuttedeserti
inizia
metri
dama
nuovi nerigreci
trasparentidel fondiviso
dolce
brezza manina
soltanto
festosa incantata
squillo
automaticamente
nemici
fiero
con
ansia
tonosete
ma
ignaro stessooscure
emotivo
storia
lieve
speranzanostalgia
biro
stessa
formavolpelama sera
vita
mareggiata
risacca
giostra
carta
topolino
filosofici
ripassi
sgarbato
scrivano
mentre
sgranocchio
siano
cui
tue
abbiamo
temps abbraccia
spalle immagini
umane
gabbiano
sapere
questa
sfuggirai
angolo
arioso
faceva
sussultare
perfino
E
andato
dalla
donna
incontro
lente
minuziose
chiede
cuori
resta
stamane
nudi
vi
parola
bimba
rosa
dagli
tra
sbuffi
scatto
dal
padrone letto
incrocio
degli
nuova
nei
giorniisolarecominciare frasisolchi
solenne
traspare
mingherlineveritA
godevamo
perso
forse
voci
oltre
colori
canti
aspra
chiare bello dovedolci
semplici
nostro
folata
quasi
perdutoavrestiriprenda
fremire
picchiato
lei
colorato
poeta
attricemagica
andrO
fiumestupore
allegro
nostalgico
sprofondati
schiena chiesa patria
prossima
d
occidente
volti
bel
destino
avremmo
nostre
prigioniere
schiacciate
linguaggio
coro
bosco
silenzio
cibo
prato
bene
golfo
viverelampione
tracciati
suoi
pensieri
kant
spinoza
dovrA
pur
ricominciare
estrosa
porterO
solo
dopo
vedo
squillante
capire
sarai
volta
piene
sulle
cime rive
armonioso
conchiglieserbate
insegna
cercate
scuole
tremule
scrivere
fortuna
fedelegioiosa
cono
incantato
silenzioso
stonato
vorrei
sognare
affetto
ascoltare
nessuno
acque
profonde
attesa
aperta tremila
york mentrdovmemoriali
lustrali piantati
inverno
ignoto
abbracciano
notturna
nottecosIlieta
diate
rarespoglie grandi
passerofinmare
posto
trasformi
vero
doppio
affaccio
sicuro
purchF
ininterrotto
svanisce
volger
anno
ritrovate
amante
frettolosa
sperando
corolle
dunque
guardare
cavalli scale scope stelle
caricatura
penna
francia
pellegrini
quante
tesse
dialoghi
ombra
curvainchiostro
mito
campi
gettate
perchF
fresco
acqua
spalanca
bevuta
realtA
fino
allora
tento illimitato
arte
eravamo
stavo
piediritagli
premimano
quotidiani
va
passeggiata
far
suoni
venga
estate
ottocento
pensate
mestiere
rinvii
disegna
curve
abbaglio
dell
istante
noci
affetti
fonti
vincent
pazzo
coi
ghiande
io
soffro
dello
appena
tollera
lungo
sentieri
miglia
anche
onde
immortalitA
appartengono
petali
estraneo
tuu
richiama
lavanda
pochi
guaisce
atteso
abitati
des
fleurs
nero
pilota
persona
identiche
gioco
fedeli
orgogliosa
tracciare
oceano
cartoline
appoggia
dire
nelle
strade
intenzioni
alle
quelli
bella
cosa
emozione
nil
ospita
sguardi
eppure
tavola
esponi
innocente
avete
era
stata
scalze
sorprendi
chiara
sentirA
svaniti
maggio
stanca
puoi
cercare
erano
icona
sorridente
alla
sussurri
selvaggio
tellement
jolies
scrivevi
spotinsulti
audiovisivi
incanto
ulisse
trattenuto
alita
inizio
uno
tanto
seduttrice
mite
tentare
mai
poesia
voltato
eravate
tornerO
sepolte
scuote
germogliata
nate
fragili
compagnettepovere
spalancate
cercavamo
solitario
gettando
cercatore
emozioni
famiglia
sFnanque
nascondermi
gioie
generosa
apre
vuote
dispersi
miei
versi
scoperta
civili
vediamo
orizzonti
siede
alba
estesa
stride
parolette
aurora
pensare
delle
fiorite
ingresso
erra
addio
remoti
anima
unica occluse
diagonali
recapita
bimbe
bricoleur
aura
arguzia
remoto
umor
timide
Fig. 3 Grafo delle relazioni di successione. Dettaglio.
In uscita, il processo di concatenamento restituisce un vettore di item lessicali checostituiscono la “poesia grezza”. La fase di post-produzione determina la ripar-tizione in versi della catena (ogni verso essendo in questo caso specificato da unnumero di item), il numero e la composizione delle strofe, e il numero delle strofeche compongono la poesia. Ulteriori processi sono ovviamente possibili, che adesempio inseriscano la punteggiatura, ma nel caso in questione, quello delle poesiedi “Una catena interminata di sogni”, la scelta è stata quella di lavorare solo sullaorganizzazione in versi (derivata in automatico dalla fase di analisi), lasciandoche gli item siano presentati così come sono. Ne consegue ovviamente un versolibero, vicino in realtà a sperimentazioni novecentesche (inclusa la scelta di nonintrodurre maiuscole). Da questo punto di vista, processo e risultati presentanovicinanza con alcuni lavori di Nanni Balestrini, ed in particolare con il seminale“Tape Mark I”, il cui meccanismo tecnico però, in perfetto Zeitgeist di inizio anni’60, si fonda più su una prospettiva combinatoria (permitativa) che generativa.Se questo è il processo alla base delle prima sezione, nella seconda –“ Non in-tendo più le umane voci”– il livello di intervento si sposta dalla morfologia allafonologia (per quanto mediata ovviamente dall’ortografia), o meglio alla fonotassi.L’ipotesi localista in questo caso concerne le relazioni di prossimità tra fonemi.Ovviamente, ciò che è preso realmente in considerazione sono le lettere, ma conuna opportuna annotazione fonetica del testo il discorso non cambierebbe, e tral’altro l’italiano ha una ortografia moderatamente aderente alla sua fonologia. Ascanso di equivoci, nel seguito si parlerà di caratteri per indicare le unità.In altri termini, questa volta il testo è passato in scansione per recupera i successoridi ogni carattere. In particolare, le poesie della sezione sono ottenute analizzandoi testi di “Mezz’ora per me”. La lista dei successori include anche lo spazio vuoto:in questo modo viene garantita la presenza di carattere terminali di parola (seguiti
64
Tokenizzazione
Creazione tripleTesto fonte
Creazione successori
Pre-produzione
Post-produzione
Testo foce
Concatenamento
Controllo triple
ANALISI
SINTESI
Fig. 4 Analisi e generazione di te-sti, livello fonologico
appunto dallo spazio). È chiaro lo spostamento di livello. Nella metodologia mor-fologica descritta in precedenza si operava mettendo in valore il lessico dei testi dipartenza e le relazioni di prossimità tra i suoi elementi. Nella metodologia fono-logica, ciò che viene catturata è la fonologia e la fonotassi del testo. Ci si spostacioè di livello di articolazione: dal lessico all’espressione linguistica tout court. Losfondo non è più il lessico che l’autore modello ritaglia all’interno di quello italia-no, ma il particolare uso fonico dell’italiano che questi opera. In altri termini, nerisultano espressioni di un italiano potenziale parametrato su quello del testo dipartenza. Così, sequenze non presenti nel testo originale non saranno presenti neltesto generato, e ciò ad esempio garantisce contro gruppi fonotattici impossibili initaliano come “tl”, così come assicura che ogni “q” sia seguita da “u”. Da questopunto di vista, il lavoro di preproduzione si giova di una parte manuale, in cuieliminare i forestierismi. Inoltre, la memoria di grado 1 dell’esperimento morfolo-gico non è sufficiente per produrre sequenze utili: pure, non è necessario estenderequesta memoria più di tanto. La fase di analisi include perciò una scansione deltesto che raccoglie l’insieme di tutte le triple di caratteri presenti. Ad esempio,cane nero risulta in:
[“can”, “ane”, “ne ”, “e n”, “ ne”, “ner”, “ero” ]
Durante la fase di generazione, dopo ogni carattere viene verificata la tripla ri-sultante: se è presente nella lista delle triple ricavate dal testo, viene converva-ta, altrimenti l’ultimo carattere viene scartato e uno nuovo viene selezionato alsuo posto. Ogni generazione termina quando uno spazio vuoto viene selezionato:la sequenza di caratteri/parola a questo punto viene memorizzata in un vettorecomplessivo, e il risultato finale è perciò omogeneo a quello della metodologia pre-cedente, una sequenza di item (questa volta pseudo-linguistici), sui quali operareuna post-produzione analoga alla precedente. Negli esempi di poesie che sono sta-ti inclusi, la post-produzione ha aggiunto un livello di articolazione significativo
65
includendo la punteggiatura (lascamente guidata dall’analisi dei testi di Capretti-ni), ovviamente con l’idea di simulare una dimensione prosodico-retorica. Riescequesta memoria due volte ridotta del testo originale, in primis ridotta al livellofonologico, quindi alle relazioni locali tra caratteri, ancora a catturare qualcosadel soggetto della produzione semiotica originale? A mo’ di esempio si consideri-no le prossime quattro poesie, tutte ottenuta utilizzando gli stessi parametri dipost-produzione per mantenere omogeneità, ma a partire da testi fonte diversi:
1.Da si eretudi mo e vi qua ronde,dionde de dindi mala paglioi festa gal valoe po no? Core forice rame: ra, baho uma ste aril fonti ho store viofran za brie tano e qua, onza vi;un o ore viva: ho gel a beino atue fontulle; luno! Fesper ria. Ga solunasto sosona na, di quele bo lanoo miendo ho nasilierasilasiane ionnondio ume de erreespascio fanimbrasciner uno razi mali o ionilla piora un za fie. I orena homolarete ce do di graggi mino nani bilor i pela no.
2.La ospa gri si; an ude hastaravie mon mo anilla vinte nova il avragae? Li nonave ri de! Quarmedella finsi bisiovi gratangaglinno l fero untato da e. Porequa baspro o quesche, eguesse rondarardo, porion grifor fraracco ra e pia il vinolea magliaci fan, ine ha quahal grinto ho spe veni o de ore ude vierra, fra man; mie: lo mofie no i oscol acchin ia. Ragran suda: crieme e di lin fripe qua udia me noran bando indue groffar .
3.Azzanteleto unano tuo quanca zura ra vol mono ha zuffi pri musosci un. Eno o: tra; fiuma unga lo i hara tri pese quastra pe i ma dia pine el le tri o ne garei che giano no zurre ri cille, nullori
66
cilla ca giun gre quancalla; a cococura lara, ra elle foscilla ruderospe mero maggiunmagraggra o? Tro la dalle lulla ma pumagnoo mi zuffi pola fa quaspe!lappiun, ma di fol ba la di, chigra o se trappiro: muso ludizuffia pe. I bro.
4.Que i e bedia, ore, ha sta ve:li puo bedia ha ga fui. Nae che giarlasperimeni udi pen dia gerendoqua e vie? Gri! Co o pero, ede a trar ste pertinte re braquan ra omper gi gi un giuscon quapiona: o io pola branciaggi norero qui che,umenen qui i ma; lo giava talo pio.volla o pa ter o; vidaesil pa ma chi hantiarenno di aster nmagli neltranerdi lerenni e tu gi i si .
La prima ha come testo fonte cinque dei canti più celebri di Leopardi (“A Silvia”,“La quiete dopo la tempesta”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”,“La sera del dì di festa”, “Il sabato del villaggio”). La seconda il primo can-to dell’Orlando furioso; la terza alcune brevi poesie di Scialoja dai componi-menti dedicati agli animali; la quarta il primo canto della Commedia dantesca.Non entriamo qui nella valutazione, tuttavia, e forse soprattutto ad una lettu-ra non visivo-tipografica ma “orale”, sembra di poter dire che una certa sonori-tà dell’originale passa attraverso i testi generati. Si considerino ad esempio percontrasto lo pseudo-Leopardi e lo pseudo-Scialoja: il primo si apre con un versoquasi classico nell’organizzazione ritmica, il secondo tesaurizza il materiale forte-mente allitterante del teso fonte. (E tra l’altro: non è forse l’algoritmo di anali-si/generazione già un valutare di coerenza fonotattica?)Lo pseudo-italiano (ovviamente a lato expressionis) delle quattro poesie preceden-ti è in realtà costruito a partire da un doppio sfondo: quello della lingua naturale,e quello della parametrizzazione che l’autore modello dei testi vi ha operato. Daquesto punto di vista, un caso rilevante da studiare è quello delle forme linguisti-che costruite per usi speciali. Si consideri ad esempio la nomenclatura binomiale(così come descritta da Wikipedia):
“La nomenclatura binomiale, o nomenclatura binomia, è una convenzionestandard utilizzata in sistematica per conferire il nome ad una specie. Co-me suggerisce il termine binomiale, il nome scientifico di una specie viene
67
coniato dalla combinazione di due nomi: il nome del genere a cui appar-tiene la specie un epiteto che caratterizza e distingue quella specie dallealtre appartenenti al quel genere. [. . .] Come nome specifico viene utiliz-zato un aggettivo che permette di distinguere la specie dagli altri membridi quel genere. Sia il nome generico che l’epiteto derivano frequentementedal latino. Alcuni nomi sono di origine greca o derivano dalla lingua localeo dall’autore che per primo ha scoperto la specie. Infatti, i tassonomisti,per nominare le specie, traggono spunto da una varietà di fonti, inclusi igiochi di parole. Comunque, i nomi usati tendono ad essere “latinizzati”ed è per questa ragione che il nome binomiale, oltre ad essere detto nomescientifico, viene spesso chiamato volgarmente “nome latino”.”
La nomenclatura binomiale per genus et species dunque è una forma costruita incui elementi morfologici potenzialmente arbitrari vengono combinati e subisconoun processo di latinizzazione che mira soprattutto a farli “suonare” latini. Questoprocesso segue due vie distinte, una per i genera e l’altra per le species. La de-nominazione di queste ultime è in qualche misura più restrittiva perché spesso ècostituita da aggettivi (e dunque includono la flessione per il genere) o da geni-tivi (e dunque includono la flessione per il caso). Di seguito alcuni dei generi deimammiferi:
Paratriaenops Hemigalus Zaglossus Sylvilagus Salpingotus Phyllomys LimnomysMuriculus Chiropotes Otocolobus Dipodillus Rheomys Scutisorex MacruromysTransandinomys Handleyomys Chiromyscus Antidorcas Maxomys Podomys RattusMacaca Geoxus Profelis Hylonycteris Gorilla Cyttarops Lophiomys NyctinomopsScotoecus Uromys Lasiopodomys Nectogale Phyllops Hyladelphys NeoromiciaSarcophilus Taphozous Chinchilla Bassaricyon Heliosciurus Pseudomys CuscomysSminthopsis Salpingotulus Xenuromys Damaliscus Neovision Aepyprymnus DiplomysPhascomurexia Callistomys Coleura Varecia Otomys Coendou Petinomys CallithrixScotophilus Nilgiritragus Anisomys Sooretamys Wyulda Cephalorhynchus EozapusNoctilio Bdeogale Mastomys Otolemur Cynictis Nesomys Colobus EremodipusMungotictis Neonycteris Olallamys Glauconycteris Stenoderma Lama EctophyllaBullimus Protochromys Eremitalpa Odobenus Procolobus Parantechinus
Mentre le seguenti sono alcune delle specie, sempre per i mammiferi
binotata tatei americana nasuta sylvaticus sylvestris jobihely tardigradussorex weddelli solatus redunca mulatta macrorhynchus cranbrooki monticularislayardii griseoventris phayrei bennettianus mitrata melalophos gaimardirufogriseus entellus olivieri aegagrus simus melanocephalus feae averinistephennashi hildegardeae ladacensis parca senegalensis eldii nuttalliinigrescens †Alcelaphus fleuretae nigriceps araneus francoisi ibex collariscelebensis tarsier truei nanilla selangorensis preblei etruscus pallidiorjerdoni chacoensis lutris felina nudicaudatus cucphuogensis hantu abeliicunicularius ramona bedfordi leucoryx brunii nasalis ferrilata thous okuensis
68
meridionalis radiata idahoensis rubicunda myoxinus caudatus cansus fulvorufulalesueur majori merriami pandora ooldea cancrivorus alaotrensis leucogastermarginatus gulo philander paniscus tephrosceles pearsoni insonus proboscideusgreyii pallida fuscicollis transitionalis
Se dunque si alimenta l’algoritmo di generazione precedente con due testi fontediversi, uno che includa tutti i genera dei mammiferi, e l’altro analogamente tuttele species, si ottengono come prime uscite ad un lancio casuale dell’algoritmo:
# GENUSPoplophitomogelonycheoctiomosBromyscusBithinosDomyceranteaFurinVisokinogelanychopaeromoridomocaerisJulustusArdogiraloteraVomycanduriaerAlpinusRumitoractesEptamysMiothogloceusFurapusUrodrysBalusLamarymysAcomaleplusNorusSoratagamusAraelaBiantriviclesNethiphinaxRobisotinymyoraDascanaVenkinatelisMyser
# SPECIESratusbiliskuenellephoespsibyiicereingalaroricheusquereviglicatuscrubrindisinganabucansidiaheataliotakongollaibenusenuniripetaerosgiconstariszenelirophontumashenemmainiyelaginsnenareuswillidinanimustanuniungipaussichmagrionsthitheraxatatulatitelansizanduseprineomafenumainteiyameniendorusfusaerubanaentancunacusnanosiendemiirufema
69
Le due liste sono autonome, poiché ovviamente l’algoritmo non definisce alcunarelazione tra genus e species. Poiché il testo originale è intrinsecamente artificiale,cioè frutto di una operazione esplicita di costruzione, e trattandosi di generazionedi singoli morfemi liberi, l’esperimento generativo funziona piuttosto bene (si pensialla Domycerantea psibyii o al Rumitoractes henemmaini. . .), anche se emergechiaramente il problema della lunghezza a volte eccessiva degli item generati (ilprocesso di generazione termina quando si seleziona come successore un spaziovuoto).
Considerazioni finali
Tutto quanto scritto in precedenza (dalla poesie, alle note, alle considerazioni diquesta postfazione) si basa sull’assunto di individuare una ipotesi operativa assairistretta e di valutarne i risultati una volta che se ne sia fornita una implemen-tazione. L’ipotesi di partenza non era quella di simulare l’autore modello, intesoproprio come modus operandi semiotico che sovrintende in toto alla generazio-ne delle poesie di Parole peregrine. Piuttosto, era verificare se una ricostruzionedi questo modo di produzione che valorizzasse esclusivamente alcune relazioni diprossimità a livello espressivo sarebbe stata in grado di cogliere, pur nella sualimitatezza intrinseca, alcuni aspetti dell’autore modello in questione, conforme-mente ad una teoria locale della prensione del senso. Che cosa si coglie? Intantoovviamente, appunto, un modus operandi: da questo punto di vista, si tratta diuna semiotica dello stile: una stilistica “miope” appunto perché capace di leggereappena più in là rispetto all’unità del livello scelto (morfologico o fonologico): una“brachiscopia”, una perlustrazione a corto raggio. Le note al testo avevano appun-to il compito di verificare se qualcosa fosse passato dal corpus originale in quellogenerato: se quest’ultimo potesse cioè essere una estensione potenziale del primo.I testi risultanti dall’analisi morfologica in qualche modo, certo in maniera moltopiù ermetica degli originali, colgono alcuni dei temi fondamentali delle poesie ori-ginali. Da questo punto di vista, il lessico e la sua percorribilità minima attraversoi successori in qualche modo, e in omaggio al “paradigma del pescatore” greima-siano, sembrano avere una loro cogenza specifica. Oppure, detta con Caprettini:i testi potenziali rivelano non tanto uno “schema monotipico” di composizione(organizzazione di lungo raggio, “dolicoscopica”) quanto piuttosto una “materiaarchetipica” (organizzazione di raggio breve, “brachiscopica”). Va altresì osservatocome le note al testo rimettano in gioco la dialettica locale-globale, perché cercanodi rilevare a posteriori relazioni complessive nel nuovo corpus prodotto (testo fonte+ testo foce). La situazione è schematizzata in Figura 5.Tra l’altro, una proprietà interessante è che una eventuale riapplicazione dell’analisilocale al testo foce produrrebbe al suo limite migliore un grafo uguale a quello dipartenza, mentre in tutti gli altri esempi (in cui non si esaurissero nel testo focetutti i successori risultanti dall’analisi del testo fonte) il nuovo grafo ottenuto daltesto foce sarebbe un sottografo di quello relativo al testo fonte.Più complesso il discorso a livello fonologico/fonotattico, in primis perché lo sfondo
70
Testo fonte Testo foce
Analisi, I Generazione Analisi, II
+
manuale automatico
Fig. 5 Analisi, generazione e anali-si di secondo livello.
è già di per sé più largo (è la lingua naturale, per quanto nell’uso fattone nel corpusdi partenza), ed in secondo luogo perché chiaramente ne conseguono formanti enon segni. Ovviamente la strategia interpretativa più sensata è quella di ripensarel’enunciato in termini di enunciazione: cioè nei termini del suo essere il risulta-to di un lavoro (un lavorìo) semiotico, piuttosto che nei termini di una codificaE → C, cioè dall’espressione al contenuto senza residui, secondo il modus lin-guistico “standard”. In altri termini, detta echianamente, sarebbe probabilmenteopportuno leggere il testo non per ratio facilis come una replica di unità combi-natorie, ma per ratio difficilis, come impronta del soggetto, in cui l’espressione èmotivata dal contenuto. Le note ai testi della seconda parte tuttavia abbozzanouna teoria in parte diversa, in omaggio alla quaestio de sensu locale: una teoriadell’attrattore, quest’ultimo inteso come perno che orienta la lettura, generatoredi un campo semantico modellato sul campo magnetico. Se infatti nulla si sapessedi come sono stati generati i testi, pure la loro natura linguistica e poetica (in ter-mini di genere della comunicazione) risulta chiara. Ecco che allora si porrebbe uninsieme di problemi di natura interpretativa analoghi a quanto avviene per la deci-frazione di lingue sconosciute, per le quali una teoria della stratificazione del senso,del suo orientamento in termini di “significanza” (qui modellato sull’esempio di“luminanza”, cioè di quantità intrinseca/apparente di senso) diventa dirimente. Sinoti come in fondo una simile prospettiva non sia per nulla inusuale: al contrariopotrebbe essere assunta come normalità del lavoro interpretativo di una semioticainferenziale. Soltanto, l’inferenzialità è un meccanismo (almeno per i testi verbali)prettamente semantico, che non ha commercio cioè con il piano dell’espressione,il quale lista senza residui forme stabilizzate. Qui invece è il piano del contenutoche determina la natura di espressioni di quello che è un insieme di forme solopotenziali, “formanti” appunto. Questa interpretazione radicale, che ricostruiscea tutti gli effetti segni come espressioni di contenuti, rientra in quella che per Ecoè una teoria della produzione segnica, tramite una extra-codifica.Insomma, se alla fine di una interminata catena di sogni non si odono più le umanevoci, pure qualche indizio resta per far ripartire nuove parole peregrine.
Ciriacum vulgo Ciriè, agosto 2013