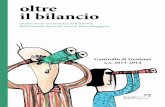A. Del Col, Una piccola serie di studi stimolanti sull'Inquisizione romana
Fuori dalla città: caratteri e pratiche dell’attività dei Pisani nel Mediterraneo tra XI e XII...
Transcript of Fuori dalla città: caratteri e pratiche dell’attività dei Pisani nel Mediterraneo tra XI e XII...
1 Il presente lavoro rielabora la relazione presentata al seminario con la quale pre-sentavo un più ampio progetto di ricerca intitolato «Pisa e il mare nel medioevo: realtà erappresentazione», e ne costituisce l’estensione della parte iniziale. Pertanto, alcune af-fermazioni qui presentate sinteticamente saranno argomentate più estesamente in unospecifico lavoro.
Fuori dalla città: caratteri e pratiche dell’attività dei Pisani nel Mediterraneo tra XI e XII secolo
ANDREA PUGLIA
A Gabriella Rossetti, del cui insegnamento questo contributovuole celebrare l’attualità e importanza, devo gran parte dei miei in-teressi e delle mie conoscenze, nonché il fatto stesso di aver sceltol’indagine storica come attività scientifica. Pertanto, non è pocol’imbarazzo e il senso di inadeguatezza che provo nel presentarle ilmio lavoro. Questo contributo intende riprendere alcune fonti diparticolare rilevanza per la storia di Pisa e del suo territorio tra XI eXII secolo, utilizzate magistralmente non poche volte dalla Profes-soressa, e analizzarle in una prospettiva che consideri altri filoni distudio e interessi storiografici relativi alla storia della cultura, deilinguaggi, delle pratiche1.
La capacità marittima di Pisa, formatasi fin dall’epoca antica eprodotto di una convergenza di fattori di ordine militare, politico eculturale, da un lato strutturò in modo originalissimo l’assetto istitu-zionale e politico della «civitas», dall’altro creò un gruppo di perso-ne dedito alle attività marittime, articolato al suo interno, dotato digrandi risorse finanziarie, che contribuì esso stesso all’evoluzionedelle istituzioni cittadine. Sarà mio compito, quindi, l’indagine delleforme e modalità con cui avvennero le convergenze tra potere pub-blico e città, e le tappe della creazione del suddetto gruppo, attra-verso l’esame delle persone, delle pratiche e degli strumenti (mate-riali e culturali) messe in atto nell’attività al fine di raggiungere ri-sultati sempre più vantaggiosi per la comunità. Prima di dare la pa-rola alle fonti però, si considerino alcuni dati.
Pisa fu città marinara. I suoi abitanti fin dalle epoche più antichefurono navigatori; gli esponenti dei ceti eminenti cittadini armatori,mercanti, comandanti di armate: lo attestano le fonti letterarie, i do-cumenti pubblici e quelli privati. La città fin dal secolo IX era pro-
2 Sempre utile, benché datato, G. Rossi Sabatini, L’espansione di Pisa nel Mediterra-neo fino alla Meloria, Firenze, 1935, cfr. inoltre G. Scalia, Epigraphica Pisana. Testi latinisulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su altre imprese antisaracene del secoloXI, in Miscellanea di studi ispanici, Pisa, Pubblicazioni dell’Istituto di Letteratura spagnolae Ispano-Americana dell’Università di Pisa, 1963, pp. 234-286, M. Tangheroni, Commercioe navigazione nel Medioevo, Laterza, Bari 1996, Id., La prima espansione di Pisa nel Me-diterraneo: secoli X-XIII. Riflessioni su un modello possibile, in Medioevo, Mezzogiorno eMediterraneo. Studi in onore di Mario del Treppo, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, II, Li-guori, Napoli 2000, pp. 1-23 (ripubblicato in M. Tangheroni, C. Renzi Rizzo, G. Berti, Ilmare, la terra, il ferro. Ricerche su Pisa medievale (secoli VII-XIII), Pacini, Pisa 2004, pp.205-230); M. Ronzani, Chiesa e «Civitas» di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dal-l’avvento del vescovo Guido all’elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092), GISEM-Edizioni ETS, Pisa 1996, in part. pp. 112-116, pp. 157-159, e E. Salvatori,Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall’XI allafine del XIII secolo, GISEM-Edizioni ETS, Pisa 2002, e l’ampia bibliografia ivi citata.
3 A. Puglia, «Nos qui per mare navigabamus». La Tuscia tra riconquista cristiana
babilmente la base logistica della flotta del conte e duca di Lucca(dalla fine del secolo IX marchese di Tuscia) per la difesa della Cor-sica e della Sardegna, e le sue navi e il suo porto oltreché esserestrumenti per il commercio svolsero il ruolo di supporto al poterepubblico. La sua flotta aveva combattuto contro le flotte orientali eislamiche riportando numerose vittorie: contro Mugaid nel 1015-1016; a Bona in Africa nel 1034, poi a Palermo nel 1064, ad AlMadjia e Zawila nel 1087, a Tortosa nel 1092 e alle Baleari nel se-condo decennio del XII secolo. I capi delle spedizioni erano vesco-vi, uomini dell’entouragemarchionale, personaggi eminenti dellacittà e nello stesso tempo signori territoriali nel contado e detentoridi vasti patrimoni fondiari2.
I testi letterari e cronachistici del secolo XI, sia di parte non pisa-na (normanni, di monasteri del Sud Italia, imperiali e pontifici), siapisani (epigrafi, innanzitutto, poemi epici, testi cronachistici) per-mettono di individuare un sistema testuale che trova le sue fontinella produzione ecclesiastica di parte papale e nei testi sulla guerraantisaracena e sull’utilizzo dei beni ottenuti con la guerra da partedella Chiesa e che si incontra e si fonde con la riflessione pisana sulruolo marittimo e politico della città. L’immagine che si venne for-mando fu anche quella di una comunità investita del ruolo di defen-sore della Chiesa e dotata di un funzionamento interno e esterno chesenza esitazione si potrebbe definire all’avanguardia: una città ca-ratterizzata da capacità di navigazione eccezionali, produttrice diflotte molto potenti in tempi brevi e quindi caratterizzata da una so-cietà in grado di reperire velocemente risorse finanziarie. A tutto ciòsi assomma l’eccezionale, quasi proverbiale, tecnica mercantile3.
172
del Mediterraneo e prima crociata, in Per Marco Tangheroni. Studi dei suoi ultimiallievi, Edizioni ETS, Pisa 2006, pp. 139 e ss.
4 Intervento di G. Rossetti in Circolazione di uomini, di beni di modelli culturalinell’Europa dei secoli XII-XVI. I protagonisti e gli spazi, atti dell’Incontro GISEM (Orta,3-6 ottobre 1992), pubblicati in GISEM 1992-1994, Bollettino, 3, Pisa 1994, pp. 11-25.
Gran parte delle risorse finanziarie della comunità nel secolo XIderivava, inoltre, da due attività particolari: il saccheggio o la con-quista armata, e una serie di entrate fiscali, derivanti direttamentedal «publicum» e gestite alla fine del secolo in maniera sempre piùapprofondita dalla «civitas» o da alcuni cittadini eminenti. Di con-tro, i pisani riconobbero sempre come condizione necessaria per ilmiglioramento della loro attività l’esonero dal carico fiscale da par-te delle entità politiche straniere. Così, l’esenzione dai vari «telo-nea», «ripe» e altri dazi divenne uno dei principali scopi delle rela-zioni politiche.
Il sistema culturale che scaturisce dalle fonti della fine del secoloXI e l’inizio del XII interpreta, organizza e struttura le pratiche quo-tidiane e si pone come parte di un più ampio “sistema di rapporti”mediterraneo ed europeo, dando luogo a sviluppi importanti per lastoria economica e politica del Mare Nostrum4.
Tra re, monaci e pirati: l’immagine di Pisa nel Tirreno nel secolo XI
L’attività marinara altomedievale aveva caratteri ambigui e com-plessi. L’immagine dei Pisani e la loro stessa autorappresentazionesi articola tra l’esercizio della mercatura, il servizio armato a favoredel potere pubblico o per la difesa degli interessi della comunità cit-tadina, e il saccheggio, sia di navi, che di terre. Un esempio mostre-rà come la ricezione delle azioni dei Pisani nel Tirreno nel secoloXI fosse costantemente modellata da quell’ambiguità e complessitàdi cui si è detto.
Il teatro dell’avvenimento furono le coste toscane e la Sardegna.Quest’ultima fu una terra che fin da epoca remota costituì un parti-colare oggetto di interesse da parte dei pisani. Dominata dai Bizan-tini in epoca altomedievale, assunta come base per i propri sposta-menti, ma anche saccheggiata dalle popolazioni musulmane, ogget-to di mire espansionistiche di lignaggi aristocratici della Penisolafin dall’inizio del secolo XI, ebbe una struttura istituzionale deri-vante dall’assetto bizantino, e fondata in epoca altomedievale sul-
173
5 Si vedano da ultimi R. Turtas, Storia della chiesa in Sardegna. Dalle origini alDuemila, Città Nuova, Roma 1999, in part. 179-212 e C. Zedda, Bisanzio, l’Islam e i giu-dicati: la Sardegna e il mondo mediterraneo tra VII e XI secolo, in «Archivio Storico eGiuridico sardo di Sassari», nuova serie, 10 (2006), pp. 39-112.
6 Chronica monasterii Casinensis, a cura di H. Hoffmann, in Monumenta Germa-
l’esercizio del potere politico da parte di un funzionario locale sog-getto all’impero di Bisanzio. Tra gli anni Sessanta e Settanta del se-colo XI il territorio era dominato non più da una sola persona, masoggetto al potere di quattro «iudices» (che amministravano altret-tanti «giudicati» territoriali), la cui autorità ed influenza politica di-venne parte di più grandi dinamiche politiche mediterranee5.
Uno dei primi contatti noti tra Sardi e Pisani ci introduce nel cli-ma politico e militare tirrenico del secolo XI. La cronaca del mona-stero di Montecassino narra che intorno al 1063, Barisone, «rex»della Sardegna (l’autore sa però che non era l’unico re, ma ne esi-steva almeno un altro, come dirà più avanti, fornendoci anche laprima notizia sulla frammentazione del governo dell’isola), inviòalcuni suoi «legati» al monastero di Montecassino per chiedere for-malmente che l’abate inviasse qualche monaco nel suo regno, doveil monachesimo era sconosciuto. L’abate, dopo aver considerato lerichieste e aver ascoltato il parere dei suoi monaci mandò dodici«fratres» tra i migliori del monastero, con un bagaglio preziosissi-mo costituito da codici di sacre scritture, reliquie e altri “oggetti” li-turgici. Siamo di fronte ad un rituale ben consolidato a questa altez-za cronologica: la richiesta fu inoltrata non da un dignitario qualsia-si, ma da un «rex», il cui «regnum» era costituito, secondo il croni-sta, da una parte dell’Isola (giudicato di Torres), attravero un per-corso che vedeva come principali latori dei «legati» e come princi-pale strumento della richiesta dei doni preziosi («pallia»), a soste-gno della richiesta stessa. Da parte loro, l’abate e tutti i monaci de-cisero di aderire alla richiesta. Dal punto di vista pratico, il trasportodella piccola spedizione monastica venne affidato ad una nave diGaetani, che si diresse verso Nord, procedendo con navigazione co-stiera verso la Toscana dove, all’isola del Giglio, fu colta da cattivecondizioni metereologiche che la costrinsero a fermarsi. La sostaimprevista fu fatale. I Pisani, infatti, che dovevano ben conoscerequeste necessarie fermate, piombarono di sorpresa sulla nave conimbarcazioni armate di tutto punto e senza badare alla condizionesociale dei naviganti, recarono violenza allo stesso modo a monacie marinai, e rubarono tutto. Tentarono persino di uccidere il coman-dante, che si salvò fortunosamente, travestendosi da monaco6.
174
niae Historica (= MGH),Scriptores rerum germanicarum, t. XXXIV, Hannover, 1980,pp. 387-388. Sulla base di confronti interni e sulla documentazione sarda e cassinese l’e-ditore propone la data «ca. 1063». L’episodio infatti avvenne prima del 1063. Tra 1062 e1063 si stava compiendo da parte di Riccardo di Capua, sostenuto dall’abate Desiderio,la conquista del ducato di Gaeta, terminata nel 1063. Probabilmente, però, la richiesta aigaetani è riferibile agli anni compresi tra il 1061 (elezione di Alessandro II al soglio pon-tificio, e probabile suo interessamento all’introduzione dei monaci di Montecassino inSardegna) e l’inizio del 1063, anno in cui Goffredo di Lorena, duca e marchese di Tusciaestese compiutamente il suo potere su Pisa, e mediò tra la città tirrenica e Desiderio (cfr.infra). Difficile però che il cronista non facesse riferimento alla conquista della città daparte di Riccardo, le cui imprese sono comunque citate in tono encomiastico nelle pagineprecedenti. Si tenga presente però che tutto l’episodio è tradito da una serie di codici cheriportano le versioni revisionate della cronaca molti anni dopo gli avvenimenti. La con-quista di Gaeta da parte di Riccardo di Capua è narrata in Storia de’ Normanni di Amatodi Montecassino volgarizzata in antico francese, a cura di V. De Bartolomeis, Roma1935 (Fonti per la Storia d’Italia, LXXVI), pp. 258-261. Sull’importanza del porto diGaeta nel secolo XI cfr. G. Cherubini, Gaeta, in Itinerari e centri urbani nel Mezzogior-no normanno-svevo. Atti delle decime Giornate normanno-sveve (Bari 21-24 ottobre1991), a cura di G. Musca, Edizioni Dedalo, Bari 1993, pp. 249-267; sui duchi: P. Skin-ner, Family Power in Southern Italy. The Duchy of Gaeta and its Neghbours, 850-1139,Cambridge University Press, Cambridge 1995. Sull’introduzione del monachesimo cassi-nese in Sardegna e l’interessamento da parte di Alessandro II, e sull’episodio da noi dis-cusso cfr. A. Saba, Montecasino e la Sardegna medievale, Badia di Montecassino 1927 eTurtas, Storia della Chiesa in Sardegnacit., pp. 188-190, di cui però riteniamo riduttivoimputare gran parte delle ragioni alla paura dei pisani per la concorrenza gaetana (ivi, nt.46). Su Barisone di Torres: M.G. Sanna, La cronotassi dei giudici di Torres, in La civiltàgiudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti, Associazione conda-ghe S. Pietro in Silki, Sassari 2002, pp. 97-113, in part. pp. 103-104.
Un attacco pirata in grande stile, quindi, il primo dei pisani di cuisi abbia compiuta memoria. E sebbene raccontato dalla parte degliassaliti, ci mostra le fasi strutturali fondamentali di questo tipo diazione: assalto «ex improvviso» e con imbarcazioni armate leggere,conquista della nave con arrembaggio, rapina del materiale conte-nuto a bordo, violenza sugli occupanti senza badare al rango socia-le, uccisione (in questo caso tentativo) del comandante, incendiodell’imbarcazione e umiliazione dei superstiti. L’episodio non finìcosì. Per ora, però, mi fermo un istante per fare alcune considera-zioni di ordine politico.
Quali furono le forze in campo? Il re Barisone, innanzitutto, pre-sentato come l’iniziatore della vita monastica nel suo regno, la qua-le avrebbe dovuto essere costituita da «fratres» particolarmenteesperti e fondata sui testi liturgici e scritturali provenienti dallo«scriptorium» più celebre della penisola; seguono i monaci di Mon-tecassino, la più potente abbazia del Sud, allora guidata dall’abateDesiderio, vero ago della bilancia tra il papato e le forze aristocrati-
175
7 Chronica, cit., p. 388. Sul commercio per esempio cfr. ivi, p. 411.8 La data di fondazione (21 febbraio 1056) e i nomi dei fondatori (Enrico e Rolan-
do) si apprendono dal Regesto cassinesedi Pietro Diacono, nn. 390-391, per cui cfr. M.Dell’Olmo, Il «Registrum» di Pietro Diacono (Montecassino, Archivio dell’Abbazia,Reg. 3). Commentario codicologico, paleografico, diplomaticoprefazione di F. Avaglia-no, Montecassino, 2000. Sul monastero e la famiglia di fondatori, i cosiddetti Rolandin-
che e politiche del Sud Italia, tra cui principalmente i Normanni. Unposto di riguardo lo occupano i Gaetani, che all’epoca erano sotto-posti all’autorità di un duca e il loro porto era un punto nodale deitraffici marittimi meridionali. Infine, i Pisani, che nella cronacacompaiono in questo passo per la prima volta e sono presentati nonproprio in una buona luce, in quanto «pirati».
L’evento rocambolesco, però, è occasione per il cronista (LeoneMarsicano, autore dei primi quattro libri) di evidenziare dei contra-sti politici: i Pisani, infatti, non furono mossi solo dal desiderio dibottino, ma anche da una «maxima invidia» verso i Sardi. È difficiledire a cosa precisamente si riferisse l’autore. È evidente, però, cheegli voleva sottolineare la volontà dei Pisani di instaurare un rap-porto privilegiato con la Sardegna, che la concorrenza di Gaeta esoprattutto l’influenza cassinese poteva mettere a repentaglio. È no-to dalla stessa cronaca, infatti, che i monaci furono promotori di uncommercio piuttosto articolato e condotto anche attraverso le viemarittime. Non solo questo, però. Leone Marsicano intendeva esal-tare i suoi stessi monaci: l’invidia pisana, quindi, sarebbe originatadal fatto che i Sardi avrebbero potuto godere dell’aiuto tanto quali-ficato e santo dei sapienti frati. In questo modo, il cronista avvertivaimplicitamente che le dinamiche in cui l’assalto pisano si inserì era-no più complesse, come si vedra anche dal seguito della storia7.
L’episodio prosegue con alcuni monaci superstiti (quattro eranomorti), i quali, vagando per la Toscana, furono accolti dai loro con-fratelli lucchesi del monastero di S. Giorgio, che li curarono e die-dero loro il vitto necessario per rimetterli in piedi per circa un anno,e poi fecero in modo di rimandarli a Montecassino. L’aiuto dato daecclesiastici lucchesi non è un dato da far passare inosservato, inquanto in questo modo il cronista riconobbe il sostegno a Montecas-sino da parte di un ente situato nella città principale della marca diTuscia, sede vescovile del presule che dal 1061 era divenuto papa,Alessandro II, e fondato e donato a Montecassino da due esponentidel ceto dirigente lucchese nel 1056, subito dopo la morte dell’im-peratore Enrico III e nei giorni in cui avveniva l’elezione stessa diAnselmo (il futuro Alessandro II) a vescovo di Lucca8.
176
ghi di S. Giorgio, cfr. H. Schwarzmaier, Klöster S. Georg in Lucca und der Ausgriff Mon-tecassinos in die Toscana, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven undBiblioteken», n. 49 (1969), pp. 166-176. Sugli avvenimenti lucchesi del 1056 è in corsodi preparazione A. Puglia, La marca di Tuscia da Bonifacio di Canossa a Guelfo VI diBaviera (1027-1160). Potere marchionale, amministrazione del territorio e societàlocali, rielaborazione della mia tesi di dottorato (XV ciclo), discussa all’Università Stata-le di Milano.
9 Puglia, «Nos qui per mare», cit.
Intanto, i «pirati» pisani si stavano spartendo il bottino, costituitoda arredi sacri e reliquie. Però, una volta che queste ultime furonoaffidate (dietro giuramento reciproco di non cederle mai a nessuno)al loro capo, arrivò una terribile punizione. Costui, arrivato a casa,poiché – dice il cronista – «tratteneva quelle reliquie da persona delsecolo, in modo disonesto e senza reverenza» una volta andato a let-to, morì. Allora i compagni impressionati da questo fatto, questavolta «con reverenza e onore», portarono le reliquie al vescovo del-la città. Ciò evidentemente dava loro modo di far rimanere le reli-quie a Pisa e quindi di non rompere il giuramento, ma anche di ri-abilitare il loro atto malvagio e antisociale, reinserendo il maltoltonel circuito del sacro. In questo modo il frutto del furto riacquistò ilsuo valore sacrale e la sua utilità per la Cristianità, ancorchè fossestato sottratto al suo legittimo proprietario. È questo un motivo chesi ritrova anche nei testi di parte pisana, e che il cronista cassineseribadisce e prende come punto di partenza per la costruzione di unanuova immagine della città di Pisa e di chi in essa esercitava il mag-giore potere pubblico, ovvero il marchese di Toscana9.
Leone Marsicano prosegue, infatti, affermando che dopo l’avve-nuta restituzione, quasi presentando l’azione come conseguenza di-retta della cessione alla Chiesa del maltolto, Barisone ricevette daiPisani una «digna satifactio», una vera e propria azione ufficiale dipentimento e di scusa. A ciò seguì, dopo quasi due anni dalla par-tenza con i gaetani l’arrivo dei monaci in Sardegna (solo due questavolta, numero che forse risultò da un accordo proprio con i pisani) egrandi donazioni a Montecassino da parte di Barisone, e da parte diun altro re sardo, Torchitorio di Cagliari. Siamo ormai nel 1066.
A questo punto viene introdotto l’intevento di Alessandro II co-me mediatore tra Montecassino e Pisa, che doveva al monasteroun’altra «debita satisfactio», con la promessa di non recare mai piùmolestie ai monaci. I Pisani, allora, si prostrarono chiedendo scusae restituendo ai Cassinesi molti beni, fuorché però le reliquie cheavevano donato al vescovo, per non rompere il giuramento. «Non
177
10 Sulle vicende degli anni Sessanta relative a Pisa, il marchese e il papa cfr. Ronza-ni, Chiesa ecivitas, cit., pp. 112-117.
molto tempo dopo», prosegue la narrazione, i Pisani dietro interven-to del duca di Tuscia Goffredo, che si trovava a Pisa, si riconciliaro-no definitivamente con l’abate Desiderio, a cui e al cui monasteroda quel momento furono «fedelissimi».
Il cronista, così, in una densissima e avvincente storia, attraversodifferenti livelli linguistici, che si snodano tra il genere della «pere-grinatio», della narrazione delle imprese militari, dei rituali regi edello scambio dei doni, delle cerimonie relative alle forme di pacifi-cazione e dell’instaurazione di legami feudali, ci presenta la propriainterpretazione della nascita del monachesimo cassinese in Sarde-gna, e del legame tra Pisa e Montecassino, evidenziando da un latoil clima generale e la prassi d’azione degli attori degli avvenimenti,dall’altro gli interventi politici particolari che li determinarono. Sinotino, infatti, i vari passaggi con cui, nell’arco di qualche anno, ipisani vennero per così dire riabilitati in seno alla Cristianità, scam-pando, quindi, alla scomunica che si sarebbero tirati addosso seavessero persistito nel loro atteggiamento. La donazione al vescovoinnanzitutto; poi le varie «satisfactiones», ognuna determinata da unsoggetto politico differente (Barisone, Alessandro II, Goffredo diLorena), e ognuna avente effetti politici e sociali ben differenziati, einfine l’influenza del vescovo cittadino, del papa Alessandro II e delmarchese di Toscana Goffredo sulle scelte dei Pisani10.
Il seguito della cronaca informa, inoltre, che oltre ai possessi luc-chesi esistevano delle «terrae sancti Benedicti» nei «comitatus» diPisa, Lucca, Volterra, Luni, Pistoia, Roselle e Populonia, cui furonoaggiunte considerevoli concessioni fiscali da parte di Matilde di Ca-nossa a Lucca e Pisa, di cui si dirà. Dopo Lucca e Pisa, tutta la Tu-scia entrò in relazione con il monastero, prima attraverso Goffredo eBeatrice, poi in modo sempre più approfondito con Matilde.
Risorse per l’attività marittima: approdi minori, fisco e terre pubbliche nel secolo XI
Se il mare fu una delle principali attività di sviluppo della «civi-tas» di Pisa, appare ovvio che il controllo e lo sfruttamento dei pun-ti nevralgici della navigazione costituì per i cittadini un obiettivofondamentale. L’attività marittima infatti, non si basava solo sulporto sull’Arno (nel secolo XI già costituito da un sistema formato
178
11 Su Porto Pisano: G. Rossetti, Pisa assetto urbano e infrastruttura portuale, Attidel convegno internazionale Città portuali del Mediterraneo. Storia e archeologia, a curadi E. Poleggi, Sagep, Genova 1989, pp. 263-286. Sulla nozione di «port system» cfr. S.Orvietani Busch, Medieval Mediterranean Ports. The Catalan and Tuscan Coasts, 1100to 1235, Brill, Leiden-Boston-Köln 2001, in part. pp. 174-203.
12 Documentazione fino al Duecento e ampia analisi in M.L. Ceccarelli Lemut, Ilmonastero di S. Giustiniano di Falesia e il castello di Piombino (secoli XI-XIII), Livorno1972; Eadem, Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel comitatus di Pisa (secoli XI-XIII) , in La signoria rurale nel medioevo italiano, II, a cura di A. Spicciani e C. Violante,Edizioni ETS, Pisa 1998, pp. 87-137, in part. pp. 105 (Castiglioncello), 108-111 (Livor-no), 113 (Rosignano e Castiglioncello), 130 (Nugola, la Val di Tora), 124-126 (Vada); Ea-dem, Monasteri e signoria nella Toscana occidentale, in Monasteri e castelli fra X e XIIsecolo. Il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nellaTuscia occidentale, a cura di R. Francovich e S. Gelichi, All’Insegna del Giglio, Firenze2003, pp. 57-66. Mi permetto anche di rimandare a A. Puglia, La marca di Tuscia tra X eXI secolo. Impero, società locale e amministrazione marchionale negli anni 970-1027,Edizioni il Campano, Pisa 2003. Sui conti di Pisa e il territorio di Porto Pisano: G. Cicco-
dalle strutture di Porto Pisano e da quelle alle porte della città), maanche su approdi minori11. Tutta la costa che va dall’odierna Viareg-gio fin sotto il golfo di Piombino costituì uno snodo fondamentaleper la navigazione: il castello di Livorno, tutti gli insediamenti dellazona di Porto Pisano, il castello di Nugola, in Val di Tora, Rosigna-no, Falesia (l’odierna Piombino), l’isola d’Elba (ricca anche di mi-niere metallifere), le piccole isole, come quella del Giglio (citatanella fonte testé menzionata) e di Pianosa, Vada e tutta la Bassa Valdi Cornia, per non dire delle numerose località sui fiumi che eranocollegate al mare. Gran parte di queste località sono legate dal co-mune denominatore di essere state detenute o appartenute ai princi-pali rappresentanti del potere pubblico, alle famiglie comitali e altrilignaggi o comunità monastiche ai primi legati. Erano “terre pubbli-che”, beni del fisco, dimostranti implicitamente il profondo legametra il mare, il controllo della navigazione e il potere pubblico fin daepoca antica.
Non può passare inosservato che i conti di Pisa detennero un im-menso patrimonio disseminato sulla costa, a cominciare dalla lorocomparsa nel territorio pisano con il titolo di «comes», nel 949, inun atto in cui il vescovo cedeva loro la pieve di «Porto Pisano»; iconti di Volterra fondarono un monastero nel 1022, proprio in unalocalità marina (Falesia). Apparteneva alla famiglia dei conti diArezzo, nonché fratelli di Ranieri marchese di Tuscia il castello diNugola, in val di Tora, poi passato nel 1059 ad una famiglia pisanache negli anni avvenire darà alla «civitas» una lunga serie di conso-li, i Sismondi12.
179
ne, Famiglie di titolo comitale nel territorio di Livorno e Porto Pisano, in «BollettinoStorico Pisano», LVII (1988), pp. 117-156. Sul «Tumulus marchionis» tra la foce del-l’Arno e quella del Serchio: G. Rossetti, Pisa e l’Impero tra XI e XII secolo. Per unanuova edizione del diploma di Enrico IV ai Pisani, in Nobiltà e chiese nel Medioevo e al-tri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach, a cura di C. Violante, Juvance, Roma1993, pp. 159-182, in part. pp. 171-174; M.L. Ceccarelli Lemut, Assetto del territorio, in-sediamento ed economia nel Medioevo, in Tombolo. Territorio della basilica di S. Piero aGrado, Felici, Pisa 2001, pp. 101-122; M. Ronzani, Pisa fra papato e impero alla fine delsecolo XI: la questione della «Selva del Tombolo» e le origini del monastero di S. Rosso-re, in Pisa e la Toscana occidentale nel medioevo. A C. Violante nei suoi 70 anni, GI-SEM-Edizioni ETS, Pisa 1991, I, pp. 173-230. L’isola del Giglio e l’isola di Pianosa nonsono molto documentate; Pianosa appare oggetto di interesse di una famiglia di armatoripisani (Casalei) all’inizio del secolo XII: Regesto della chiesa di Pisa, a cura di N. Catu-regli, Roma 1939 (Regesta Chartarum Italiae, 24), n. 336, p. 244 (1138 novembre 6), edi-to in L.A. Muratori, Antiquitates Italice Medii Aevii, Mediolani 1739-1741, coll. 1157-1158; Regesto, cit., n. 654, p. 517 (prima metà del secolo XII); cfr. L. Rege Cambrin, Lafamiglia dei Casalei dalle origini allametà del XIII secolo, tesi di laurea, Università diPisa, a.a. 1988-1989, rel. C. Violante. Sui Sismondi e il castello di Nugola cfr. A. Puglia,L’origine delle famiglie pisane Sismondi e Casalberti. Due documenti inediti dell’Archi-vio di Stato di Lucca e dell’Archivio Capitolare di Pisa riguardanti Guinizo e Alberto so-cii del vescovo Daiberto, in «Bollettino Storico Pisano», 66 (1997), pp. 83-104 e M. Ron-zani, La «casa di Gontolino». Origine, sviluppo genealogico e attività pubblica della fa-miglia dei Sismondi fino ai primi decenni del Duecento, in «Bollettino Storico Pisano»,74 (2005), pp. 503-522.
13 Liutprandi CremonensisAntapodosis, Homelia Paschalis, Historia Ottonis, Rela-tio de legatione costantinopolitana, a cura di P. Chiesa in Corpus Christianorum, Conti-nuatio medievalis, CLVI, Turnholti 1998, p. 75, su cui si veda A. Puglia, L’amministra-zione della giustizia e potere marchionale in Tuscia da Ugo di Provenza a Ottone I (926-967), in «Archivio Storico Italiano», CLX/IV (2002), pp. 675-733, in part. pp. 680-681;Bertoldo, Annales, a cura di G.H. Pertz, in MGH, Scriptores, V, Hannover 1844 (rist.anast. Stuttgart-New York 1963), p. 269, su cui si veda Ronzani, Chiesa ecivitas, cit., pp.78.79. Cfr. inoltre Puglia, La marca di Tuscia tra X e XI secolo, cit.; Id., «Nos qui permare navigabamus», cit.
La relazione con il potere pubblico significava per i Pisani il di-retto sfruttamento di questo sistema di approdi, significava control-lare le coste, dove la maggior parte della navigazione si svolgeva. Elo stesso potere pubblico, viceversa, moltissime volte usufruì dellapotenza navale pisana fin dall’altomedioevo. Tanti sono gli episodiche si potrebbero enumerare: Ugo di Provenza che approda in sicu-rezza a Pisa nel 926; Enrico III che si vede recapitare dai Pisani 50prigionieri normanni (ed erano tutti «milites»!) senza muovere undito; la convergenza di interessi della città con l’autorità marchiona-le e quella papale nelle spedizioni nel Mediterraneo13. Ma c’è ancheun altro fatto, da non sottovalutare. Controllare gli approdi potevaassicurare l’amministrazione di ingenti entrate fiscali.
Esempi significativi sono quelli relativi ai diritti marchionali per-
180
14 Rosignano: Muratori, Antiquitates Italicae cit., III, Mediolani 1740 (rist. anastat.1965), coll. 139-140 (1125 settembre 9): si tratta di una menzione tarda dei diritti mar-chionali in una ricognizione fatta dall’arcivescovo Villano e dal vesdomino Graziano. Pi-sa e Lucca: Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien, a cura di E.Goez e W. Goez, in MGH, Laienfürsten- und Dynasten-Urkunden der Kaiserzeit, II,Hannoverae 1998, n. 62, pp. 188-189; Chronica monasterii cassinensis, cit., p. 442.
15 Sulla fiscalità marchionale, sul ripatico pisano e le numerose fonti che lo menzio-nano tra XI e XII secolo sto preparando un lavoro specifico, frutto della rielaborazionedella mia tesi di dottorato, per cui cfr. n. 9; sulla «deghatia» che per la prima volta nel1153 appare come una gabella, gestita forse dai consoli e in relazione con la zona del mo-nastero di S. Vito, accesso fluviale a Pisa, cfr. Carte dell’Archivio della Certosa di Calci(1151-1200), a cura di M.L. Orlandi, Pacini, Pisa 2002, n. 6, pp. 14-15.
tinenti al castello di Rosignano (anche se non è esplicitamente dettodi diritti marittimi), e pertinenti all’approdo di navi e merci nel por-to di Pisa. Questi ultimi, come menzionato anche nella Chronicamonasterii cassinensis, furono concessi da Matilde ai cittadini nel1100: infatti, la marchesa avendo appreso che a Pisa alcuni ufficialideputati ad occuparsi del «mercatus» e della «ripa» avevano fattopagare ai monaci di Montecassino il «teloneum» su alcuni pannicomprati «ad utilitatem fratrum», era subito intervenuta concedendoai suddetti monaci che in Pisa e in Lucca e in ogni terra sottopostaalla «potestas» del marchese il diritto di comprare «libere», vale adire senza dover pagare il «teloneum», né la «curatura». Questostraordinario documento, conservato in originale nell’archivio delmonastero di Montecassino, mostra un aspetto importante del siste-ma fiscale operante in Tuscia nella seconda metà del secolo XI. Laprima evidenza è l’esercizio di poteri fiscali da parte di ufficiali cit-tadini (detti «procuratores») nella riscossione del «teloneum», unatassa che interveniva al momento dell’acquisto di una data merce.La marchesa esercitava il potere di interdire il pagamento di questatassa, diritto che implicava il controllo marchionale su quel tipo ditassazione, elemento di per sé nemmeno tanto anomalo se non chequesto diritto era esercitato non dalla marchesa, ma dai cittadinidietro concessione marchionale. Per la marchesa Pisa e Lucca eranodue aree su cui deteneva una «potestas» e di conseguenza su cui po-teva stabilire chi dovesse e non dovesse pagare quel tipo di tasse14.
Altri sono gli episodi che si potrebbero citare, come quello im-portantissimo del «ripatico» pisano, conteso tra Pisani e Lucchesi,che tra XI e XII secolo appare ancora legato all’autorità marchiona-le, ma che diverrà uno dei punti forti del sistema fiscale pisano dellaprima metà del secolo XII, insieme alla cosiddetta «deghatia», unatassa pagata alla dogana cittadina15.
181
16 Cfr. nota 27 per il documento degli anni 1080-1085. Concessioni seguenti allaspedizione di Al Madhiya e Zawila del 1087: G. Scalia, Il carme pisano sull’impresa con-tro i Saraceni del 1087, in Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini, Padova1971, pp. 565-627: edizione del Carme alle pp. 597-627, vv. 215-216, 229-236, 277-284.I Brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162- e 1164. Studio introduttivo, testi enote con un Appendice di documenti, a cura di O. Banti, Roma 1997 (Fonti per la storiadell’Italia medievale, Antiquitates, 7), appendice n. 5, pp. 113-114 (1103 maggio): esen-zione dal «tolineum de estate et de yberno, et de sale»; Liber Maiolichinus de Gestis Pisa-norum illustribus, a cura di C. Calisse, Roma 1904 (Istituto Storico Italiano per il MedioEvo, Fonti per la storia d’Italia, 29), appendice n. 1, pp. 137-139 (1113 settembre 7).
Come i diritti fiscali erano importanti in patria, così dovevanoaccuratamente essere evitati fuori. Proprio negli anni Ottanta co-minciano le prime menzioni di esenzioni per i Pisani, come quellaconcessa tra 1080 e 1085 da Mariano giudice di Torres, a ventannidallo “screzio” del 1062, con cui i pisani, dietro loro espressa ri-chiesta, venivano esentati dal «teloneu», e quella ottenuta nel 1087in seguito alla spedizione di Al Madia, registrati dal poema che ce-lebra l’impresa. Esenzioni che divennero una costante dei trattatidella prima metà del secolo XII, a cominciare da quello con Turbi-no, giudice di Cagliari nel 1103 e con Berengario III di Barcellona,prima della conquista delle Baleari16. La riflessione e la pratica quo-tidiana relativa alla fiscalità, che si svilupparono durante l’altome-dievo, vennero sempre più definite a partire dagli anni Ottanta delsecolo XI fino a costituire formule fisse nella documentazione delsecolo XII, in coincidenza con un rinnovato impegno dei Pisani nelMediterraneo e un intervento più strutturato in Sardegna, verso l’A-frica Settentrionale e la penisola iberica in accordo con la politicapapale.
I primi anni Ottanta videro anche il riconoscimento da parte delpotere pubblico, questa volta imperiale (ma si ricordi che nel 1081Matilde di Canossa, in lotta con Enrico IV, era stata privata dellamarca), di un sistema di norme informali e consuetudinarie, che iPisani, in un momento di estrema incertezza politica che probabil-mente aveva dei riflessi sulla loro attività marittima, tentarono distrutturare e di legittimare. Quelle «consuetudines» ci sono notenella loro sostanza e riguardano principalmente l’ambito giudizia-rio. L’imperatore, infatti, si impegnò a non proibire ad alcun cittadi-no di imbarcarsi su una nave a meno che egli non lo facesse conl’intento «studiose» di sottrarsi a una «querimonia» riguardante ipreparativi della partenza. È probabile che con queste parole i Pisa-ni intedessero regolare le liti generate dal disaccordo sulle condizio-ni delle imprese marittime da parte dei partecipanti. Le disposizioni
182
17 Edizione del diploma in Rossetti, Pisa e l’impero, cit., pp. 165-167.18 A. Mastruzzo, Una lettera consolare pisana dell’inizio del XII secolo conservata
a Nizza, in «Scrittura e civiltà», XXV (2001), pp. 384-392: «[…] Nunc autem sciatis quiailli homines, qui hoc malum fecerunt, non sunt modo in Pisa; qui postquam reversi fue-rint, per nostras litteras vobis notificabimus et postea vos de vestris, qui depredati fueruntad nos mandabitis et nos omnia, que eis ablata fuerunt, diligenter emendare faciemus».
seguenti erano intese anch’esse a tutelare coloro che si trovavanoper mare da possibili interventi giudiziari, contro di loro, i loro benie le loro famiglie. Al termine di questo gruppo di concessioni l’im-peratore si impegnava ad osservare le «consuetudines quas habentper mari», cioè a rispettare l’insieme di leggi consuetudinarie cheregolavano l’attività marinara dei Pisani, che sembra un’ulterioresanzione delle precedenti tutele17. Tutta la materia che occuperàgran parte della legislazione pisana di un secolo posteriore, traman-data nel testimone dei costituti pisani conservato a Yale (datato1186), fu il risultato della rielaborazione di questi primi nuclei ri-guardanti la regolamentazione delle società e dell’organizzazionedella spedizione, nonché la tutela dei beni dei soci.
Una pratica antica in un mondo nuovo: pirati pisani nel secolo XII
Con il secolo XII, pur essendo progredita la tecnica mercantile, ildiritto e le istituzioni comunali, ed essendosi affinate le pratiche direlazione, i Pisani non avevano cessato di accumulare risorse finan-ziarie attraverso pratiche antisociali, come la pirateria.
Tra il 1104 e il 1119 il vescovo, i consoli, i visconti e tutto il po-polo di Pisa inviarono una lettera ai «maiores et minores» della cittàdi Nizza e al suo vescovo, informandoli che erano pronti a risarcirli«sul furto che le nostre galee fecero nei confronti dei vostri uomini»(«de preda, quam nostre galee vestris hominibus fecerunt») e che iNizzardi sarebbero stati immediatamente informati riguardo al rien-tro in Pisa degli uomini che commisero quei misfatti (che al mo-mento non si trovavano in città), cosicchè avrebbero potuto far sa-pere ciò che era stato loro rubato e di conseguenza essere risarciti18.
L’aggettivo «nostre» riferito alle galee, fa assumere alla vicendaun carattere di ufficialità, ma il seguito mostra che gli uomini impe-gnati nelle rapine non erano equipaggi di navi armate dalle autoritàcittadine per spedizioni militari o, se lo erano, essi sfuggivano alcontrollo dei comandanti pisani. Il problema si complica se si consi-dera che nel primo decennio del secolo XII, non vi era ancora una
183
19 Si vedano i trattati pubblicati da E. Salvatori, Boni amici et vicini. Le relazioni,cit., pp. 185-205 (a p. 87 anche la lettera dei pisani ai nizzardi); per l’area islamica e afri-cana: O. Banti, I rapporti tra Pisa e gli Stati islamici dell’Africa settentrionale tra l’XI eil XIV secolo, in Id., Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia, a cura di S.P.P. Scalfati,Pacini, Pisa 1955, pp. 305-320 (originale del 1983) e Id., I trattati tra Pisa e Tunisi dalXII al XV secolo, ibidem, pp. 323-350 (articolo del 1988); cfr. inoltre M. Amari, I diplomiarabi del Regio Archivio di Stato Fiorentino, Firenze 1863. Prima del 1157 i Pisani sub-irono atti di pirateria nel porto di Tunisi che fecero scattare la loro reazione presso le au-torità del luogo, invitate all’osservanza dei patti stipulati nei decenni precedenti: Banti, Itrattati tra Pisa e Tunisi, cit., p. 325. Sulla guardia del Porto Pisano: Bernardo Maragone,Annales Pisani, edizione di M. Lupo Gentile in Rerum ltalicarum Scriptores, 2° ed., vol.VI/2, Bologna 1936, p. 39.
chiara strutturazione istituzionale del comune, come la stessa inte-stazione della lettera comprova, menzionando sia i consoli (nuovaistituzione) sia i visconti (di tradizione marchionale e imperiale),entrambi sotto l’egida politica e spirituale del vescovo. Inoltre, l’i-stituzione di una rete di contatti tra le due città che agevolasse l’in-formazione sui crimini commessi in mare, cosicché potesse seguireun più certo risarcimento e una più chiara rappresentazione del pro-blema alle autorità cittadine (per cittadini rei spesso assenti e quindidifficilmente identificabili), mostra che l’ambiguità del comporta-mento dei marinai e la mancanza di una istituzionalizzazione dellaflotta cittadina, che si confondeva tra interessi pubblici e militari, einteressi privati commerciali, era ben presente alle stesse autoritàcittadine e ai navigatori.
Nei trattati tra Pisa e le città e autorità politiche del Mediterra-neo, a partire da quello tra i Pisani e Berengario III conte di Barcel-lona nel 1113 e per tutto il secolo XII, vi sono spesso accenni allasalvaguardia di uomini e merci, ma il riferimento a crimini com-messi da equipaggi di navi pisane non è altrettanto esplicito comenel documento appena citato. Anche la decisione consolare del1158, con cui era istituita una galea di difesa del Porto Pisano, pro-babilmente non provvedeva solo alla difesa da attacchi “ufficiali”,ma anche a incursioni pirate, sebbene questa sia solo una logica, manon provata ipotesi19.
La tradizione storiografica pisana ricorda come più antico “pira-ta” cittadino un tale Trapelicino, la cui prima notizia della sua attivi-tà è tramandata dai Breviadei consoli del 1162 e del 1164, in cui trai giuramenti che i consoli dovevano prestare per la loro entrata incarica nel 1163 e nel 1165 vi è quello di tenere in considerazione gli«ordinamenta» scritti al tempo del console Gerardo di Bella, inseritinei costituti (la legislazione civile), riguardanti l’«abhominevole» e
184
20 I Brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162- e 1164. Studio introdutti-vo, testi e note con un Appendice di documenti, a cura di O. Banti, Roma 1997 (Fonti perla storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 7), pp. 45-46, 64, 73-74, 96.
21 E. Salvatori, Corsairs’ Crews and Cross-Cultural Interaction: The Case of the Pi-san Trapelicinus in the Twelfth Century, in «Medieval Encounters», 13 (2007), pp. 32-55.Ringrazio l’autrice per avermi fornito in anteprima il dattiloscritto, da cui traggo la mag-gior parte delle informazioni riguardanti la vicenda di Trapelicino, e a cui rimando per lacitazione e la discussione approfondita delle fonti che lo riguardano.
«scelleratissismus maleficium», che gli uomini della nave di Trape-licino avevano commesso «de Saracenis», ovvero nei confronti dinon meglio specificati Saraceni, e di non considerarli nemmeno co-me facenti parte del «populus» pisano e del distretto della città (dacui erano stati probabilmente banditi)20. Il testo autorizza quindi apensare a un crimine commesso da parte di un intero equipaggio suuna nave, il cui armatore era certamente Trapelicino, che però non èesplicitamente menzionato come autore del delitto.
Per quanto concerne le vittime, Enrica Salvatori che ha recente-mente esaminato la questione, ha avanzato l’ipotesi che il «malefi-cium» consistesse in una serie di crimini il primo dei quali fu la rot-tura di un accordo e la palese violazione di una trattativa in corso,come farebbe pensare l’aggettivo «scelletatus», utilizzato nelle fontipisane con riferimento al tradimento; un atto violento, quindi, tantoanomalo da entrare a far parte del diritto civile cittadino, che pro-prio in quegli anni era in via di stesura per iscritto21.
L’episodio mostra altresì una normale pratica che prevedeva chepersonaggi della classe dirigente comunale armassero galee privata-mente per scopi pubblici, siano stati essi di ambasciata o di guerra erappresaglia, come è il caso, per esempio, dei Marignani e degli An-fossi. Tra essi, interpretando un passo degli Annali genovesi, si puòinoltre ipotizzare che rientrasse anche Trapelicino, in quanto cogna-to di un membro della casata pisana dei Dodi (un ramo dei Marigna-ni). Il tremendo delitto commesso dalla ciurma di Trapelicino era re-so probabilmente particolarmente grave dal fatto che esso contrav-veniva la presa di posizione ufficiale delle autorità politiche pisane.
Dal 1165 Trepelicino appare come un navigatore autonomo capa-ce di trattare di persona con le autorità comunali sia pisane che geno-vesi (con le quali è in stretta relazione, tanto che gli annali di ObertoCancelliere lo denotano come «fidelis» dei consoli di Genova), ècontraddistinto dalla sua residenza a Portovenere, terra di confine traPisa e Genova, da una condotta sui mari violenta e temuta, praticataal comando di una squadra di galee e «in cursam», caratteristica
185
22 Ibidem, testo corrispondente alle note 82-93. Per le testimonianze del 1165 e 1170cfr. Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di L.T. Belgrano, I, Roma1890 (Istituto Storico per il Medio Evo, Fonti per la Storia d’Italia, 11), pp. 175-177 e pp.234-235. Documenti degli anni Settanta in Archivio della Corona di Aragona, Cancileria,Pergaminos Alfonso I, n. 227, 1176 ottobre 3; ibidem, extra Inventari n. 2621, senza data;ibidem, n. 214, gennaio 1177(«conventio» dei pisani con Alfonso di Aragona), pubblicati ecommentati da M.T. Ferrer i Mallol-D. Duran I Duelt, Una ambaixada catalana a Con-stantinoble el 1176 i el matrimoni de la princesa Eudoxia, in «Anuario de estudios medie-vales», 30/2 (2000), pp. 963-977. Le fonti genovesi sono le prime a menzionare in modosistematico l’attività corsara («cursa»), e la sua regolamentazione, per cui si veda il cosid-detto Breve della Compagna(1157) in Codice diplomatico della repubblica di Genova, acura di C. Imperiale di S. Angelo, Roma 1936 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,Fonti per la Storia d’Italia, 11), I, n. 285, pp. 350-359, e il trattato tra Genova e Barisone,giudice di Arborea e re di Sardegna. Nel passo in cui i consoli dettarono le condizioni mili-tari dell’alleanza, infatti, si impegnarono a fornire quattro galee, mentre Barisone avrebbedovuto armarne altre quattro per costituire una sorta di esercito con funzione sostanzial-mente antipisana. La clausola finale del paragrafo afferma che se durante le azioni dell’ar-mata, le galee (sia genovesi che sarde) «cursum fecerint», la quarta parte del guadagno chene sarebbe derivato doveva essere versata nel patrimonio fiscale di Barisone. Si tratta quin-di di un accordo militare tra due autorità politiche che prevedeva, sotto il nome di «cur-sum», un’attività di lucro che sottostova alle condizioni di un particolare tipo di società dimare, che prevedeva la divisione del capitale nei termini di 1/4 al socio «tractor» (che ma-terialmente navigava), e le restanti parti al socio «stans», evidenziando che il ruolo del pri-mo in questo caso era assolto da Barisone (I Libri Iurium della Repubblica di Genova, vol.I/2, a cura di D. Puncuh, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per ibeni archivistici, Roma 1996, n. 382, pp. 317-323, in part. p. 321). La documentazione pi-sana del secolo XII non utilizza mai i termini «cursalis», «cursa» e «pirati» per riferirsi agliattori di episodi di rapina in mare, se si esclude la menzione di sei galee preparate «ad cur-sum faciendum» nel 1166 riportata da Bernardo Maragone, Annales Pisani, cit., p. 39. Ge-neriche allusioni a perdite in mare a causa dell’intervento di uomini si possono trovare nelcapitolo «de naulo navium» del Costitutum Usus del 1186 (I costituti della Legge e dell’U-so, cit., pp. 237-247).
estremamente indicativa per l’epoca. L’annalista genovese connotan-do l’attività di Trepelicino come «cursa», aveva in mente un’azionemilitare senza un preciso confine tra l’ambito pubblico e il privato,ovvero tra il fine di lucro e il sostegno bellico a una precisa autoritàpolitica. Il carattere militare e violento è indubbio: è praticamente acausa di Trepelicino che l’accordo tra Genova e Pisa tentato nel 1165a Portovenere salta con la conseguente guerra decennale tra le duecittà; egli impegnò i Pisani nel 1170 al largo delle coste provenzali,poi per circa sei anni sparisce dalla documentazione per ricomparirealla metà degli anni Settanta al servizio del re di Aragona22.
Siamo a conoscenza anche di altre iniziative degli equipaggi dialcune navi pisane, che entrarono in contrasto con l’autorità deiconsoli che guidavano le spedizioni e commettevano crimini e de-predazioni, come nel maggio del 1165, quando gli equipaggi di 11galee pisane, contraddicendo gli ordini dei propri comandanti, si re-
186
23 Bernardo Maragone, Annales Pisani, cit., pp. 33-36. Le 11 galee peraltro eranostate inviate dalle autorità comunali perché i genovesi «cum iudice Arboree», pervenuti aLogosardo, catturarono 4 «saggitte» pisane (imbarcazioni veloci di piccola stazza) in cuisi trovavano «milites et negotiatores», per cui i pisani armano 11 galee e le inviano inSardegna con i consoli Pietro e Guglielmo «ad expelledos Ianuenses».
24 Per la presenza di «milites» e mercanti sulle stesse navi cfr. per esempio notaprecedente.
25 Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico Atti pubblici, 1185 febbraio 9.
carono nella «villa» di Torres in Sardegna e la saccheggiarono, in-nescando così l’ira dei Sardi, che uccisero 80 uomini. Il fatto generòuna grande tensione nei ceti dirigenti sardi e a Pisa, tanto che i giu-dici di Torres, di Cagliari e di Gallura (praticamente tutta la Sarde-gna), si recarono nella città tirrenica per trovare un accordo e fargiustizia di quanto accaduto, poiché i parenti delle vittime (pisane)avevano protestato con toni minacciosi. Il giudice Barisone di Tor-res dovette giurare di tenere in feudo il giudicato dai pisani. Anchequesta volta l’iniziativa di un equipaggio causò un grave incidentediplomatico, che innescò una reazione di vertice23.
Quanto detto fino ad ora evidenzia la difficoltà di definire un li-mite preciso tra navigazione effettuata per scopi pubblici, come am-basciate e guerre del comune, e attività armatoriale privata, la qualenel caso delle grandi famiglie armatoriali pisane avveniva sia persostegno al comune sia per normale commercio. Parallelamente èdifficile rilevare un limite tra navigazione ordinaria e navigazioneconnotata come violenta, nel momento che questa avveniva sottol’egida pubblica. L’azione violenta acquistava rilievo solo quandocomprometteva relazioni poliche internazionali24.
Un’altra azione violenta in navigazione, riguardante dei Pisani,avvenne nel 1185 e il suo esito prefigura un cambiamento nella con-siderazione dell’attività piratesca in mare. Il protagonista principalefu il pisano Maggiolino del fu Pietro che, lanciata la sua ciurma al-l’abbordaggio, assaltò la nave di un mercante saraceno, ne scara-ventò in acqua l’equipaggio, e la portò a Pisa con tutto il carico (sinoti la serrata corrispondenza con l’episodio ricordato dalla Crona-ca di Montecassino!). Una volta in città poi la vendette con il caricoe tutti i formimenti a Alberto del fu Bolso. La storia è nota in quan-to il principe di Tunisi, dietro richiesta del mercante derubato, si ri-volse ai consoli, che istruirono subito un processo, individuarono lanave a Pisa e la sottrassero al suo nuovo proprietario, restituendolaal suo legittimo proprietario. A sua volta Alberto intentò una causa aMaggiolino, che fu condannato a risarcire il valore della nave25.
Non si può certo affermare che questo non sia un atto di pirateria
187
bello e buono, con tanto di arrembaggio e rivendita della nave deru-bata. Però anche questa volta occorre notare alcuni particolari. In-nanzitutto, l’azione, che era avvenuta lontano da Pisa e nei confron-ti di un «Saracenus» come nel 1161, aveva tirato in ballo un’autoritàpubblica, ovvero il principe di Tunisi, con cui i pisani avevano in-tessuto, fin dagli anni Trenta del secolo, buoni rapporti, improntatialla reciproca soddisfazione delle offese e alla tutela dei commerci.La reazione aveva generato una complessa azione legale, divisa indue parti, ovvero soddisfazione del mercante (quindi condanna diun atto penalmente rilevante, ovvero un furto e una violenza perso-nale) e relativo intervento dei consoli sulle conseguenze della primasentenza, che aveva difatti leso gli interessi di un «carissimus ci-ves», nonché personaggio di grande rilevanza pubblica. La sommache Maggiolino doveva ad Alberto era detta «debitum», connotandol’atto come una vera e propria sentenza contro un insolvente e pro-babilmente caricata degli interessi e della penale. I consoli di frontead azioni criminali di questo tipo, commesse in mare, non potevanoche agire con gli strumenti legali di cui erano in possesso: recuperodei beni del furto («maleficium», lo stesso termine utilizzato daiBrevia) e condanna del criminale non in quanto ladro, ma debitoreinsolvente nei confronti della persona che era stata raggirata. Laquestione poi acquistava una grande rilevanza in quanto il raggiratoera anche una personalità di spicco della società cittadina.
Il diritto marittimo fissato nei «costituta» di Pisa prevedeva unacomplessa casistica di società marittime, prestiti per affrontare viag-gi e per il commercio, percentuali sui guadagni in mare, noli, manon menzionava alcuna reazione verso i reati riguardanti gli attac-chi in mare, sostanzialmente per due ragioni fondamentali. La pri-ma consiste nel fatto che il concetto di territorialità del mare nonaveva ancora assunto caratteri istituzionali precisi, per cui un crimi-nale era perseguibile solo per un reato commesso in un territorioche facilmente si poteva identificare come sottoposto ad una autori-tà. Infatti, Maggiolino venne condannato per il reato (la frode) com-messo a Pisa e non per il primo commesso al largo di Malta. La se-conda ragione si lega strettamente alla prima: una sentenza può es-sere messa in atto se c’è una autorità che ne garantisce l’esecuzionee all’occorrenza la fa forzatamente eseguire. Questo processo è dif-ficilmente applicabile alla navigazione del secolo XII, per la ragio-ne che ho prima evidenziato e perché non era ancora pienamenteformato il concetto di flotta pubblica, svincolata dall’iniziativa pri-vata e organizzata per scopi di polizia marittima.
188
26 G. Rossetti, Società e istituzioni nei secoli I X e X: Pisa Volterra e Populonia, inLucca e la Tuscia nell’alto medioevo. Atti del quinto congresso internazionale di Studiosull’alto medioevo (Lucca 1971), CISAM, Spoleto 1973, pp. 209-338; Eadem, Storia fa-miliare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli XI e XII, in Forme di potere estruttura sociale in Italia nel Medioevo, a cura di G. Rossetti, Il Mulino, Bologna 1977,pp. 233-246; Eadem, Ceti dirigenti e classe politica, in Pisa nei secoli XI-XII. Formazio-ne e caratteri di una classe di governo, a cura di G. Rossetti, Pacini, Pisa 1979, pp. XXV-XLI. Per gli studi sulla società pisana di Gabriella Rossetti e dei suoi allievi, sia a stampache in tesi di laurea e di dottorato, cfr. gli interventi di E. Salvatori e G. Garzella in que-
I protagonisti: consoli, comandanti e marinai pisani tra XI e XII secolo
Dopo aver individuato e sommariamente descritto due delle prin-cipali modalità di reperimento delle risorse relative alle attività ma-rittime è venuto il momento di individuare chi fossero i protagonistidi quelle attività. Come si è già avuto occasione di notare, il diplo-ma del 1081 riservò una cospicua parte di concessioni alla materiamarittima, oltreché a questioni di ordine politico, istituzionale e fi-scale. Coloro che rivolsero la richiesta all’imperatore, quindi, furo-no i principali membri della società cittadina interessati all’eserciziodelle prerogative pubbliche e nello steso tempo i soggetti implicatinelle spedizioni marittime.
L’individuazione e la definizione delle principali famiglie delgruppo dirigente pisano del secolo XI, che fin dagli scritti di Gio-chino Volpe ha occupato diverse generazioni di studiosi, diventa co-sì un passo fondamentale per lo studio del nostro tema. GabriellaRossetti è intervenuta più volte su questo argomento promuovendonumerose ricerche, che hanno avuto il merito di mettere a fuoco unasocietà originalissima nel panorama toscano e italiano. I primimembri noti di queste famiglie cominciano ad apparire nelle fontinella prima metà del secolo XI connotati da una duplice vocazioneinsieme rurale e cittadina: detentori di proprietà fondiarie, castelli epoteri signorili nel «comitatus», avevano ingenti quantità di beniimmobili in città, amministravano diritti fiscali e giudiziari di deri-vazione pubblica e riscuotevano pedaggi. Dagli anni Ottanta, nellaveste di «consules» cittadini costituirono «un’aristocrazia comuna-le» che negli anni seguenti avrebbe costruito la fortuna politica eistituzionale del Comune. È tra questi «maiores» che bisogna rico-noscere anche i principali promotori delle spedizioni navali e del-l’attività marittima, possessori di risorse tali da poter costruire e au-mentare la fama marittima dei pisani e di divenire il “braccio arma-to” della Chiesa sul mare26.
189
sto stesso volume. Scorrendo i versi del Liber maiorichinussi possono leggere i nomi deiprincipali cittadini pisani impegnati nel comando delle flotte cittadine: cfr. Puglia, L’ori-gine delle famiglie pisane, cit., pp. 97-99. È ormai da tempo annunciata una nuova edi-zione e un commento del Liber maiorichinusda parte di Giovanni Scalia (G. Scalia, Peruna riedizione critica del «Liber Maiorichinus», in «Bullettino dell’Istituto storico italia-no per il Medio Evo», 71 (1959), pp. 39-112).
27 A. Petrucci - A. Mastruzzo, Alle origini della Scripta sarda: il privilegio logudo-
Il secolo XI e primi del XII ci offrono pochi indizi sulla loro rea-le attività, se non qualche menzione del loro impegno alla testa del-le flotte (composte non solo da Pisani) nel Mediterraneo. Dai primianni del secolo XII, però, si comincia a delineare una situazione piùchiara e articolata. L’attività marittima del gruppo prende forma, elo stesso gruppo andando avanti con gli anni ci appare più eteroge-neo dal punto di vista sociale. Accanto ai “grandi” anche personaggidi calibro sociale minore, ma ugualmente impegnati nelle attivitàmarittime, che già a metà del secolo, a seguito di pratiche documen-tarie legate al perfezionamento delle relazioni politiche e alla costi-tuzione delle società marittime, cominciano ad apparire nelle fonti.Qualche esempio, forse, chiarirà meglio la questione.
Si è già in parte parlato dei rapporti che intercorsero tra Pisa e laSardegna fin da epoca altomedievale e dell’esenzione dai dazi sullemerci concessa dal giudice Mariano «per l’onore del vescovo Ge-rardo e di Ugo visconte di Pisa e di tutti i consoli di Pisa», a seguitodi una richiesta fatta da tre ambasciatori pisani, presentati anchenella veste di «amici» del giudice, a rimarcare il fatto che l’ufficiali-tà dell’ambasciata era rafforzata dal rapporto di familiarità con Ma-riano. Oltre agli ambasciatori, furono menzionate altre tredici perso-ne, che a loro volta promisero aiuto e protezione al giudice. I loronomi e quelli dei loro discendenti compaiono con una certa frequen-za negli atti privati pisani precedenti alla redazione del presente do-cumento, ma anche in quelli contemporanei e posteriori, i quali cipermettono di fare alcune considerazioni sul loro statussociale, sulloro ruolo all’interno della «civitas» e nelle attività marittime. Siconsiderino, per esempio, Guido di Babilonia e suo fratello Leo,menzionati in testa alla lista. Già il nome del primo è un segnaledella sua attività “fuori dalla città” e della sua familiarità con ilviaggio, che sebbene non direttamente attestate sono confermatedalla presenza sua e dei suoi discendenti in Sardegna, dai suoi inte-ressi per l’isola di Pianosa e dall’attività di guerra in mare. Inoltre, idue svolsero un’attività di rappresentanza della città, e i loro discen-denti occuparono il ruolo di consoli27.
190
rese, in «Michigan Romance Studies», 16 (1996), pp. 201-214. Ronzani, Chiesa ecivitas,cit., pp. 190-199. Sui Casalei cfr. nota 13.
28 Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico Primaziale, 1108: edito, con alcune inesat-tezze sia nel regesto, che nel testo, da B. Fadda, Le pergamene relative alla Sardegna nelDiplomatico Primaziale dell’Archivio di Stato di Pisa, in «Archivio storico Sardo», 41(2001), n. 2, pp. 59-62. Per la datazione si veda E. Cau, Peculiarità e anomalie della do-cumentazione sarda tra XI e XIII secolo, in Il giudicato d’Arborea e il marchesato di Ori-stano. Proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, atti del Convegno Internazionaledi Studi, ISTAR, Oristano 2001, pp. 313-421, nota 52.
Un’altro documento di provenienza sarda, posteriore di una ven-tina d’anni, descrive ancora più dettagliatamente le pratiche e gliuomini impegnati nella prassi marittima e le forme di quella espe-rienza. Si tratta di una donazione che tra il 1107 e il 1108 Torchito-rio-Mariano de Lacon (del fu giudice Costantino), «per volontà diDio a capo del regno cagliaritano», fece alla chiesa di S. Maria del«pisano arcivescovato», espressamente costituita dall’«arcivescovo,canonici, operai e ministri di S. Maria». La concessione consistevain quattro «curtes», una libbra d’oro (o un «pretium» ad essa equi-valente la cui estimazione doveva essere affidata ai «ministri» dellachiesa pisana), e una «nave armata e condotta a sue(cioè del giudi-ce) spese» carica di buon sale. Il motivo di tanta generosità, oltre-ché il «rimedio» della sua anima e dei suoi parenti, era un «servi-tium» reso da alcuni «nobilissimi e prudentissimi cittadini» pisani,che erano rimasti per un intero anno con tre galee nell’«insula sulci-tana» (Isola di S. Antioco), «con grande patimento e in moltissimeristrettezze», allo scopo di fornire il loro «auxilium» al regno e allavita del re. Il premio del loro impegno non fu goduto solo dallachiesa episcopale. Infatti, il giudice affrancò i Pisani (compresi co-loro che «abitavano nella diocesi di Pisa»), dal pagamento di ogni«tributo e teloneo» che fino ad allora avevano dovuto pagare28.
La complessità dell’atto e il duplice donatario impongono alcuneconsiderazioni. Il concessionario dell’«auxilium», infatti, non fu so-lo l’arcivescovo e in generale tutta la Chiesa pisana, in cui si rispec-chia l’unità interna della «civitas», ma anche la comunità dei Pisani(“allargata” anche al territorio circostante la città) impegnati nelleattività marittime, che da quel momento ottenne l’interruzione diuna pratica fiscale precedente (il pagamento dei tributi) per opera diun ristretto gruppo di persone. Il nucleo principale di esso era com-posto da 13 uomini, quasi tutti identificabili con i membri delle prin-cipali famiglie cittadine (discendenti in parte da quelli del 1080-1085), cui seguì la menzione di altri personaggi attraverso la perifra-
191
29 I costituti della Legge e dell’Uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale deltesto tradito dal «codice Yale» (ms. Beinecke Library 415), a cura di P. Vignoli, Roma2003 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell’Italia Medievale,Antiquitates 23), pp. 58, 71-72, p. 77. Ampi riferimenti all’uso della scrittura nella ver-sione del 1233: Statuti inediti della città di Pisa, a cura di F. Bonaini, Vieusseux, Firenze1854, 3 voll., I, pp. 685-696.
si «et universi socii eorum» (cioè del primo gruppo), di cui solo dueper nome (Gerardo detto Barile e Benedetto del fu Cante). Con que-sti ultimi coadiutori dell’impresa il giudice non trattò direttamente.
L’attenzione va posta su due dati. In primo luogo il riferimento aipisani residenti nella diocesi conferma la profonda implicazione delcontado pisano, dei suoi uomini e delle sue risorse nelle attività ma-rittime. Inoltre, non si può non rilevare la difficoltà di identificazio-ne dei due personaggi sopra menzionati e la generalità della formulacon cui venne determinato il secondo gruppo, che implica la loroprobabile esclusione dalle famiglie eminenti della città e del conta-do. Degno di riflessione è anche il termine «socius», riferito proprioa quest’ultimo gruppo di persone. In quest’epoca il termine afferivaal campo semantico del linguaggio giuridico e del giuramento, e de-notava il membro di un gruppo cui era demandata una decisione ri-guardante l’interesse comune. È il caso per esempio dei «socii» delvescovo Daiberto che negli anni Ottanta del secolo XI per pacifica-re la «civitas» avevano stabilito l’altezza delle torri attraverso una«societas», ovvero una sentenza giurata. Da questo principale signi-ficato il termine cominciò ad assumere quello che portò a definire il«socius» come partecipante a una «societas» in quanto comunanzadi risorse e rischi riguardanti un’impresa commerciale o a contenutoeconomico. Dalla metà del secolo XII cominciano ad apparire tra idocumenti privati anche altre forme documentarie, non altrimentinote, riguardante la messa per iscritto delle transazioni private ri-guardanti l’organizzazione e lo svolgimento delle imprese commer-ciali marittime, quelle che nel 1186, nel «Costitutum Usus» sarannodefinite «societates maris» o «compagnie»29.
L’esame di questi documenti permette di seguire lo sviluppo diuna cultura legata alle attività marittime, che prima della metà del se-colo XII era aliena dalle procedure di ratifica e registrazione ufficialidel notariato, e prevista come procedura informale o ridotta a proce-dura orale. Infatti, esaminando alcuni passi del «Costitutum Legis etUsus» si può intravvedere come tali procedure prima della legislazio-ne di metà secolo XII fossero circoscritte ad un ambito esterno all’uf-ficialità notarile e pubblica. I primi esempi di «societates» scritte so-
192
30 La documentazione più antica relativa alle attività marittime in: Archivio di Statodi Pisa, Coletti, 1151 gennaio 25, Olivetani, 1170 (1169) agosto 16,Coletti, 1172 (1171)novembre 3, Olivetani, 1186 (1185) luglio 24, Acquisto Monini, 1, 1189 agosto 10, Ar-chivio Capitolare di Pisa, Diplomatico, 1191 settembre 28; Carte dell’Archivio della Cer-tosa di Calci, cit., 1179 aprile 13, Ibidem, 1189 ottobre 9 (n. 131, pp. 248-249). Gran par-te della ricerca cit. a nota 1 ha occupato l’esame delle varie forme di «societas» a Pisa nelsecolo XIII e la legislazione che le regolò.
31 Sui giuristi pisani «al di fuori delle famiglie illustri» si veda M. Ronzani, I “giuri-speriti” del Comune di Pisa nell’età delle sperimentazioni istituzionali (1190-1254), inLegislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativaesemplare, a cura di G. Rossetti, GISEM-Liguori Editore, Napoli 2001 (Europa Mediter-ranea, Quaderni, 16), pp. 201-240, in part. pp. 231-235 (da cui è tratta la citazione tra vir-golette). Sui Pisani coinvolti nel prestito al comune in Provenza e sull’estrema eterogeni-tà sociale del gruppo si veda Salvatori, Boni amici et vicini. Le relazioni, cit., pp. 69-83.Sicilia: D. Abulafia, Pisan commercial colonies and consulates in twelfth century Sicily,in «The English Historical Rewiew», XCIII (1978), pp. 68-81, ora in Id., Commerce andconquest in the mediterranean, 1100-1500, London 1993. Spagna: M.T. Ferreri y Mallol,Els Italians a terres catalanes (segles XII-XV), in La peninsula iberica y el Mediterraneocentroccidental (siglos XII-XV), Balcellona 1980, pp. 393-497. Sardegna: F. Artizzu, LaSardegna pisana e genovese, Chiarella, Sassari 1985 e da ultimo C. Zedda, Le città dellaGallura Medioevale. Commercio, società e istituzioni, C.U.E.C., Cagliari 2003.
no opera di notai, che pur non seguendo modelli comuni, espresserocomunque le principali fasi riguardanti l’impresa, quelle relative allesomme impiegate e alla divisione del guadagno. Non furono ancoradefinite le questioni relative alla divisione dei rischi e non venneromenzionate le mete dei viaggi, come invece avvenne fin dai primidecenni del secolo XIII, quando il contratto di «societas maris» sistrutturò fino a raggiungere forme parzialmente stabili30.
La documentazione privata relativa alle attività marittime e com-merciali conferma inoltre la complessa articolazione della societàpisana, che già si intravvedeva agli inizi del secolo XII. Dalla metàdel secolo, infatti, appaiono nelle fonti personaggi al di fuori delleprincipali famiglie della cosiddetta «aristocrazia consolare». Questogruppo di persone, molto variegato al suo interno e a sua volta arti-colato dal punto di vista sociale, comprendeva sia personaggi il cuigrande prestigio era stato acquisito con l’esercizio della professionegiudiziaria, sia persone dedite alle attività produttive, commerciali ecreditizie, residenti spesso fuori dalla città (in Provenza, in Sarde-gna, in Sicilia, sulle coste iberiche), che furono in grado di investiresoldi in imprese marittime, di prestare denaro al Comune e specula-re sul debito pubblico, e di partecipare attivamente alle spedizioninavali organizzate dal Comune, ma anche di costituire patrimonifondiari e immobiliari nel contado e in città31.
Le prime «societates» mostrano personaggi altrimenti sconosciu-
193
32 ASP, Diplomatico Coletti, 1151 gennaio 25.
ti, in grado di effettuare degli investimenti di non grande entità, mache probabilmente furono solo quote parziali di capitali che presup-ponevano la partecipazione all’impresa marittima di un grande nu-mero di persone. Insieme a queste persone appaiono espressi per laprima volta nelle fonti gli elementi concreti di quella cultura legataal mare e al commercio che fino ad allora erano rimasti al di fuoridei circuiti ufficiali e pubblici. Lo conferma il caso di un tal Neroche alla metà del secolo «nomine iudicii» fece memoria dei suoi be-ni e ricordò i suoi due figli «che nutrì ed educò, e insegnò e fece in-segnare loro le arti» («nutrivi et educavi et artes ei insinuavi»), ediede al primo 20 soldi «affinché li facesse fruttare» («cum quibus[…] adquisivit»). Inoltre, gli diede alcuni strumenti per il commer-cio, una quantità vino di Valenza cosicché potesse prendere il mare,e per facilitargli la navigazione lo fornì di numerose supellettili e divestiti e «predispose ogni cosa come se fosse un […] socio» («et fe-ci omnem apparatum sicut meo socio»). L’investimento non fugrande, ma le parole di Nero presuppongono una cultura e una vitadi mare e commercio, che doveva essere tramandata ai figli, per in-dicare i quali non esitò ad utilizzare il termine tecnico di «socius»32.
Dalla metà del secolo XII lo sviluppo della cultura e la grandecomplessità interna della società pisana corrisposero ad una intensi-ficazione e ad una maggior strutturazione dell’attività marittima ecommerciale, che si concretizzò con un’evoluzione della normativamarittima e riguardante le «societates», un affinamento delle rela-zioni con le altre comunità e entità politiche mediterranee, un ulte-riore allargamento degli orizzonti commerciali. Tutto ciò diede luo-go alla redazione di trattati sempre più complessi ed elaborati, all’i-stituzione di consolati e rappresentanze in tutte le principali piazzedel Mediterraneo e al consolidamento del dominio su quelle cheavevano costituito gli interessi centrali dei Pisani fin dall’alto me-dioevo, come la Sardegna.
194