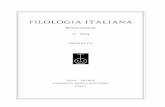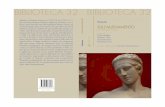Colleluori Livio Prof. D'Ambrogio Sistemi Software - Introduzione
Luzzasco Luzzaschi Madrigali a uno, due tre soprani (1601) - Introduzione
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Luzzasco Luzzaschi Madrigali a uno, due tre soprani (1601) - Introduzione
"" Z ,,23
LUZZASCO LUZZASCHI Ferrare e
(1545-1
MADRIG~ALI
per cantare e sonare a uno, due e tre soprani
(1601)
a cura cl
ADRIANO CAVICCHI
L'ORGANO - BRESCIA l 9 6 5 BXRENREITER - KASSEL
Opera pubblicata solto gli auspici del
Centro di Studi sul Rinascimento Ferrarese della Città di Ferrara
« MONUMENTI DI MUSICA ITALIANA »
Serie II: Polifonia
VoI. II: LUZZASCO LUZZASCHI • Madrigali a 1,2 e 3 sopram « L'Organo» . Direttore responsabile: GIUSEPPE SCARPAT
Registrazione presso la Cancelleri 11 del Tribunale di Brescia
© CASA EDITRICE P AWEIA DI BRESCIA
Tutti i diritti sono riservati Alle Rechte vorbehalten Printed in ltaIy
PREFAZIONEo/.·
Per quanto in questi ultimi anni l'interesse per la figura e 1'opera di Luzzasco Luzzaschi sia andato man mano aumentando 1\
nondimeno crediamo di essere ancora lontani da una pur minima conoscenza della sua opera e dalla esatta valutazione dell'apporto - diretto o mediato - che ebbe in quell'interessante periodo della vita musica· le italiana che va dal 1570 al 1610 circa.
La carenza di dati storici e la difficoltà di esaminare ciò che rimane della sua opera, non hanno permesso fino ad ora di dare un giudizio d'insieme definitivo su questa figura singolare di organista, compositore e didatta.
In luogo delle scarse e non sempre esatte; notizie storiche finora conosciute, siamo og" gi in grado di offrire dati e documenti di basilare importanza tanto da poter tracciare un disegno biografico abbastanza preciso.
Il cronista ferrarese Don Girolamo Merenda (c. 1540 t 1603), che fu suo amico personale e collega in qualità di Cappellano e Cantore nella Cappella ducale, cosÌ ci parla della sua origine.
« Sono questi Luzzaschi originati da una grossa terra, e mol,to mercantile denominata Gandino, lontano da Bergamo 14 miglia, qual luogo è sot· to la giurisdizione dé Venetiani, questa famiglia in questo luogo è honorata, et antica; di questa casa fu quel bravo, et honorato Capitano Paolo Luzaschi, tanto caro alli Signori Gonzaghi, dove
* La presente prefazione è un primo risultato di indagini per un più vaslo ed organico lavoro che lo scrivente ha da tempo intrapreso attorno a « Luzzasco Luzzaschi nella vita musicale ferrarese della seconda metà del Cinquecento l).
1 O. KINKELDEY Luzzasco Lltzzaschi's Solo-Madrigale mit Klavierbegleitung in « Sammelhiinde deI' Internationalen Musik· Gesellschaft)) IX, 1907-1908, pp. 538-565. J. RAcEK Les Madri· gaux à voix seule de Luzzasco Lltzzaschi in « Revue Musicale») XIII, 1932. H. PRUNIERES La cantate italienne à voix seule alt XVIIe siècle in A. LAVIGNAC . L. DE LA LAURENCIE ( Encyclopedie de la musique )), Ile Partie, voI. 5 Paris 1930, pp. 3390 -"3410 (in particolare pp. 3391 - 3395). A EINSTEIN The Italia n Madrigal, Princeto n, New Jersey 1949, passim. G. REESE MIl-
7
finÌ sua vita d'anni 80, nel tempo poi del Duca Alfonso Primo venne habitare in Ferrara un m. Andrea di questa famiglia, bonissimo et honorato mercante, e da questo descende M. Luz·asco homo delli primi d'Italia nella sua professionc ... ))2.
Più di uno storico è concorde nel fissare la data di nascita di Luzzaschi neU'anno 1545 \ per quanto non lo si possa afl'ermare con assoluta certezza. Documenti di re· cente acquisizione fanno ritenere invece che essa sia da anticipare almeno di qualche anno a meno che non si voglia riconoscere al nostro autore una prodigiosa precocilà. A questo proposito ci sembra di notevole interesse questo documento che riportiamo integralmente.
« lo Luzzasco Luzzaschi cittadino ferrarese, faccio fede che questa Cartella fu del famosissimo, et Eccellentissimo Cipriano Rore Fiammcn/!o Musico et Maestro di Cappella del giù Eccellentissimo Signor Duca Ercole d'Este di Ferrara. Sopra la qual cartella scriveva le compositioni fatte prima da lui a mente, com'era sempre sno costume. lo in quel tempo essendo suo discepolo lo vidi à scrivere sopra detta cartella la Gloria d'una Messa che fece in Ferrara, et altre sue compositioni fatte in diversi tempi. Et detta cartella donò a me quando partì di quì, et fu l'An· no 1557 insieme con l'annesso Miserere composto da lui in Fiandra quando era giovine, et hora ne facc'io presente all'Ill.mo et Rev.mo Signor Car-
sic in the Renaissance, New York 1954, passim. D. ARNOLD L. Luzzaschi in « Die Musik in Geschichte und Gegenwart ») voI. VII, Kassel 1960, col. 1354 sgg. A. G. SPIlW T/te 5 Parts Madri· gals of Luzzasco Luzzaschi, Boslon, Univel'siLy Graduate Scool Diss., L. oi C. n° Mie. 61 - 3:nS,
1961). G. MERENDA, Annali, Ms. Classe I N° 107 pp.
218 - 219 (Bibl. Comunale Ariostea, Ferrara). :J Si tratta di segnalazioni di morte all'età di sessantadue anni. Sapendo con precisione che Luzzaschi morì nel 1607 si stabilisce la data di nascita nel 1545. A. SUPERBI, Apparalo degli uomì. ni illustri della città di Ferrara, Ferrara 1620, Suzzi, p. BO. G. A. CIRTANI. Catalogo de gli uomini e donne illustl'i..., Ms. Classe I N° 52 pp. 280 - 281. (Ferrara, Bibl. Comunale Ariostea).
ti
dinale Borromeo mio Signore et padrone colendissimo affermando quanto ho detto sopra esser'la verità.
J o Luzzasco Luzzaschi ho scritto di mia propria mano la presente fede, in Ferrara alli 29 Settemhre 1606 )) ".
La presente testimonianza che ci certifica sulla formazione iniziale di Luzzaschi, rive. la una predilezione del grande fiammingo eerLo assai più giustifieata verso un giovane di quattordici o quindiei anni ehe non verso un dodieenne, eome sarebbe stato appunto il Luzzasehi nel 1557 se aecettassimo la dala di naseiLa del 1545. Ad ogni modo, nella speranza di re perire l'atto di battesimo, aeeeLLeremo anehe noi - seppure con riser-va tale data.
È quasi certo che per quanto riguarda la preparazione organistiea Luzzasehi abbia avuto quale maestro J acques Brumel, detto « J aches (o Giaehes) da Ferrara» 5. Più dif. ficile, invece, è stabilire eon quale dei tanti compositori attivi alla eorte estense tra il 1557 ed il 1565 abbia eompletato la sua preparazione musicale. Le supposizioni che si possono avanzare a questo proposito ci sembrano abbastanza circoscritte ed abbiamo fondate ragioni per farle convergere sul
4 Il presente scritto è applicato come autenticazione sulla prima carta non numerata di un manoscritto musicale autografo di Cipriano de Rore conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano (segn.: A lO Inf.) (Debbo la conoscenza Il i questo documento alla cortesia dell'amico e collega Max LiitoH). Il dono inviato dal Luzzaschi al Cardinale Federico Borromeo (1564 . 1631) - che proprio in quel tempo stava fervorosamente raccogliendo codici e manoscritti per allestire la biblioteca Ambrosiana - s'inserisce in una trama di l'apporti di familiarità testimoniati anche da una corrispondenza conservata nella Biblioteca Ambrosiana e segnalata da J. A. F. ORBAAN, Notizie inedite su L. Luzzaschi in Bollettino Bibliografico Musicale, IV, fase. n. l, Milano 1929, pp. 9-14. " Figura biograficamente ancora non del tutto chiarificata. Nipote di Antonio Brumel che nei primi anni del '500 fu maestro di cappella di Alfonso I, lo troviamo fra i registri dell'Archivio Estense prima del 1530. Su questo importante organista cfr. K. jEPPESEN Eine friihe Orgelmesse aus Castell'Arquato in « Archiv fiir MusikWissenschaft)) XII 1955, p. 192 e segg. n Non sarehhe in questo senso determinante la pur notevole rispondenza stilisti ca fra le loro opere madrigalistiche a più voci quanto la comune tecnica della concertazione di voci e stru·
nome di Alfonso dalla Viola 6.
Entrato ben presto nella stima della famiglia d'Este, fu da questa ampiamente favorito e sostenuto negli studi fino al 1561 anno in cui venne assunto come cantore nella cappella ducale 7. Iniziò nello stesso tempo la fulgida carriera di organista ed alla morte del Brumel gli successe come primo organista ducale.
Prima del 1570 gli venne affidata anche la direzione della musica da eamera - « se. gl'eta » - che, fin dal 1528, era stata tenuta da Alfonso dalla Viola 8. La fama di organista del Luzzaschi si andava intanto diffondendo in tutta Italia e possiamo supporre che attorno al 1570 risalga la stampa del suo « Primo libro di Ricercari ») a quattro
• 9 VOCI.
Con la pubblicazione dei primi due libri di madrigali a cinque voci, rispettivamente del 1571 del 1576, Luzzaschi viene a porsi in una posizione di preminenza fra i madri. galisti dell'Italia settentrionale lO, posizione che consoliderà definitivamente col tel'ZO li. bro del 1582. Non ancora trentenne era già considerato un grande maestro ed egli stesso era pienamente consapevole del suo alto valore di artista 11. La sua fama di organista
menti. È noto che il repertorio del « Concerto grande » del Duca Alfonso II comprendeva esclusivamente due brani: uno di Alfonso ed uno di Luzzaschi. Cfr. E. BOTTRIGARI, Il Desiderio, Bologna 1599, Bellagamba p. 43. Interessantissime descrizioni sulla lecnica della concertazione in Alfonso dclla Viola troviamo in C. MESSISBU(;O, Banchetti Compositioni di Vivande... Ferrara 1549, Bouglat-Hucher, cc. 5 sgg. 7 Secondo A. SOLERTI, Ferrara e la corte estense nella seconda metà del XVI sec. Città di Castello 1900~ Lapi, p. 122. Nostre ricerche nell'Archivio di Stato di Modena lo teslimoniano in forza presso la Cappella di Corte dal 1563. 8 Cfr. MESSISBUGO, op. cito c. 5 v. 9 Segnalazione di quesl'opera si trova in Indice/ Delli Libri di Musica / Che si trovano Nelle / Stampe di Angelo Cardano / Venezia 1591, fol. 5 l'ceto. lO G. Reese, op. cito p. 41:3. A. Einstein, op. cito p. 203 e p. 616. 11 Così si esprime Luzzaschi in una lettera al Duca di Urbino Guidohaldo della Rovere « ...
usarò ogni diligentia in insegnare al figliolo di Messer J acheto di bona memoria, et piacessi a dio che l'arte mia potesse riuscire corrispondente all'animo, ch'in pochi dì egli potrebbe tornar valenthuomo a sevir Vostra Eccellentia ... » IO-Il-1573 in V. ROSSI, Appunti per la Storia della
d
compositore, diffusasi ben presto per tutta la penisola, fece correre alla sua scuola allicvi da ogni parte del ducato e dalle più lontane città d'Italia 12.
Ma di maggior interesse, specie in riferimento alla presente opera, fu l'attività che Luzzaschi svolse per il « Concerto delle Da· me l). I precedenti storici dell'impiego di voci femminili nell'esecuzione musicale a Ferrara, risalgono addirittura ai primi decenni del Cinquecento. Fu però soltanto at· torno al 1560, con l'assunzione al ducato di Alfonso II, che la consuetudine di concerti da camera tenuti da dame di corte lungamente addestrate, divenne sistematica.
Il «concerto delle dame principalissime» come dice Luzzaschi nella prefazione
era costituito dalle prime damigelle della Duchessa o delle principesse, sorelle di Al· foIl.'ìo, Leonora e Lucrezia.
Molte e svariate furono le formazioni del concerto delle dame; quella abituale era costituita per lo più di tre voci femminili che Luzzaschi chiama sempre « Soprani »
anche quando sono mezzosoprani o contraI. ti alle quali si poteva aggiungere, eccezionalmente, un basso e fino a due tenori. Dal punto di vista dell'interesse e della partecipazione, l'attività del « concerto delle dame» si può, grosso modo, suddividere in due periodi: il primo dal 1567 all'epoca del matrimonio di Alfonso II con Margherita Gonzaga (1579), il secondo dal 1579 alla morte del duca di Ferrara (1597).
Gli esecutori più importanti che diedero vita a questo complesso nel primo periodo furono: Lucrezia e Isabella Bendidio, Leonora di Scandiano e Vittoria Bentivoglio. Dal 1577 al 1583 collaborò stabilmente al concerto anche il famoso basso napoletano Giulio Cesare Brancaccio e dal 1583 al 1589 la raffinata e colta poetessa modenese Tarquinia Molza 13.
Interessante, per quanto riguarda il se-
Musica alla Corte di Urbino nella « Rassegna Emiliana » I, Volo I, 1888 Modena, p. 404. 12 L'clogio che ne tcsse V. GALILEI, Dialogo della Musica Antica e della Moderna, Venezia 1581 Vincenzi, ed. moderna Milano 1947, Minuziano, pp. 175 - 177, classificandolo fra i tre più grandi organisti del tempo con Claudio Merulo e Giuseppe Guarnì, è sintomatico. Dobbiamo considerare inoltre che attorno al 1580 Luzzaschi a-
9
condo periodo, questa testimonianza del cron ista Merenda:
« Venendo a Ferrara la Serenissima Madama Margherita Gonzaga, moglie del nostro Serenissimo Duca Alfonso II, duca di Ferrara aveva questa
al suo servizio una Dama nominata Lau-Peperara Mantovana, giovane da maritare, ed
a~ceva ancor un'altra dama chc cantava, la quale si chiamava la Signora Livia da Arco, pure da maritare. Il signor Duca gli avcva poi dato alla deUa Madama la signora Anna Guarina, la quale cantava e sonava di lauto, e la signora Laura di arpa, e la signora Livia cominciò ancora lei a suonare di viola, e li suoi maestri era il signor Fio·
maestro di cap pella del Screnissimo, ed il Luzasco organista del Serenissimo, e così
Sua Altezza cominciò a farli esercitare ogni dì ilt~ieme a cantare, a tal che a questi dì in Italia,
forse fuora d'Italia, è concerto di donne medi questo. Ed ogni giorno il tempo d'estatc,
il dopo desinare cominciano a cantare alle dccinuve ore e seguitano sino alle ventuna; l'organi
con lo arpicordo, il signor Fiorino con il Ian-grosso, la signora Livia con la viola, la signoGuarina con un lauto, e la signora Laura con
l'arpa, e sempre presente il Serenissimo e la Sen~nissima cantano poi a libro dove entra un bas
e due altrc voci, cantori del serenissimo. Il h'mpo della invcl'nata cominciano a un'ora di nutte e seguitano sino passate le tre ore, e quan
vengono principi li conduce dalla banda del-111 Serenissima ad ascoltare questo concerto.
Ha poi Sua Altezza maritate tutte tre queste signore in gentiluomini principali di questa città, c a dato stanze in corte perché siano più comode al servizio, e queste h'e signore vanno continuamente in carrozza con la Serenissima. Que.
si fa sino a questo dì che siamo 1596 del me· Sl' di settembre l).
Schematizzando avremo un complesso cocomposto:
Laura Peperara. Livia d'Arco . Anna Guarini Luzzaschi Fiorini .
Soprano e Arpa Soprano e Viola Soprano e Liuto Arpicordo Arciliuto (o Pandora)14
vpva solo 35 anni. Scarse finora sono le concrete testimonianze della sua attività didattica. Al nome di Girolamo Frescobaldi siamo in grado per ora di aggiungere solo i nomi di Fabio Ricchetti, organista del Duomo di Modena, e Carlo Mentini dclLo Filago, organista in S. Marco a Venezia. 1:1 A. SOLERTI, op. cito pp. 129 - 140. 14 Nessuna traccia di questo tipo di madrigale concertato è rimasto nei manoscritti e stampe
L'attività di Luzzaschi non si esauriva concerto delle dame. Forse prima del 157 aveva già pubblicato il « Secondo libro Ricercari a quattro voci» 15 ed all'inizio del 1582 il « Terzo libro di Madrigali a que voci» dedicati alla Duchessa di Ferrara.
Se consideriamo che nessuna delle opere note di Luzzaschi è dedicata ad Alfoni'o n, ci viene spontanea la supposizione che duca Luzzaschi dedicasse le opere organisti. che: infatti a tale effetto, cioè come orga· nista, il duca lo teneva al suo servizio. un « Terzo libro di Ricercari » abbiamo cura testimonianza ma nessun indizio per sua datazione 10.
Il riconoscimento del duca Alfonso II per la vasta e molteplice attività di Luzzaschi non si fece attendere. Il Merenda ci infonna che il duca « ••• per i sui meriti li donò l'ano no 1580 un Polesine [podel'e] e li donò una casa, e finita di tutte le mobilie, che fa bisogno, oltre la Possessione che ha per e serve per il vivere, e scudi cenlo l'anno suo salario ... » 17,
L'attività di Luzzaschi in questi anni
dell'epoca se non forse in quest'opera dell'allie· vo di Luzzaschi: GIROLAMO BELU, Il nono lib:-" di Madrigali a cinque voci et nel fine cinque madrigali per cantare et sonare, op. XXII, Vene· zia 1617 Gardano. Fra i cinque madrigali per cantare e sonare sono ripresi e quasi para fra· sati quat.tro madrigali di Luzzaschi e precisa mente il II, V, VI e XI della presente raccolta. Purtroppo l'esistenza del solo Canto I nella Bibl. musicale « G.B. Martini » non ci illumina circa l'organizzazione delle altre parti. 15 Segnalazione in Codice Martiniano Segnato 67, c. 45 v.: N. 64 Luzzasco Luzzaschi, il Secon do Lib.ro de Ricercari a 4 voci partiti Mano· scritti 1578. Bologna, Bibl. Musicale G. B. Mal' tini. 16 Segnalazione in GIOVANNI MARIA TRABACI, Secondo Libro de Ricercate et altri vwri caprie· ci ... Napoli 1615, G.G. Carlino. Nel Ricercare dcl Settimo Tono con tre fughe a p. 20 sta scritto pie' di pagina « Luzasc[co] usa q[ue] sta principio del suo 7 Tono Ricercat[ e ] Lih.ro 3 17 MERENDA, ms. cito loco cito 18 I suoi allievi cominciarono ad imporsi all'al· tenzione degli ambienti musicali e a puhhlicare le loro opere. Vedi Ricchetti e Girolamo Belli. 1" G. A. SCALABRINI, Rias.mnto di spese di Sacre· stia del Duomo di Ferrara Ms. Classe I n. 45o, Ferrara, Bibl. Comunale Ariostea. Dal 1582 In troviamo elencato e pagato per avere « ... suo· nato le messe con l'organo ... )l. Quanto sopra con· corda con le affermazioni di A. BANCHIERI, COTI
lO
,.leI prodigioso: a tutti gli impegni sopraelencati, a quelli di una scuola che stava dando i primi frutti 1\ si aggiunge, dal 1582, l'incarico di organista della Cattedrale di Ferrara 19,
Nei dodici anni che vanno dal 1582 al 1594 nessun avvenimento 'ili rilievo sembra distrarre Luzzaschi dalla sua intensa attività presso la corte estense 20. Da segnalare qual. che breve soggiorno in altre città come a Parma, Firenze e Mantova.
In quegli anni la vita musicale ferrarese l'aggiunge il suo apogeo. L'editoria musicale, che per circa dieci anni era rimasta muta, risorge per merito del raffinato ed intelligente editore Vittorio Baldini. La pubbli. cazione di alcune antologie madrigalistiche, in cui il nostro è sempre presente, stanno a dimostrare quale centro e quale punto di confluenza musicale fosse divenuta Ferrara dopo il 1580. Di questa euforia musicale era partecipe non solo l'ambiente di corte ma tutta la cittadinanza 21.
Il gruppo dei compositori ferraresi, che nel 1550 era assai circoscritto, verso il 1590
elusioni del Suono dell'Orgwno, Bologna 1609, Eredi di G. Rossi p. 12 « ... Devo però fare mentione di dui Organisti cellebri le cui anime sieno in gloria: Luzzasco Luzzaschi fù nel Duomo di Ferrara & Claudio Merulo in quello di Parmw, ambedui soggetti degni di memoria eterna l).
20 Riguardo alla hiografia sarà opportuno segnalare hrevemente che nel 1580 circa contrasse matrimonio con Maria dall'Oca, sorella del compositOle e musico ducale Alberto, dalla quale ebhe quattro figli: Alfonso, Andrea, Margherita e Lucrezia. 21 G. SARDI Libro delle Historie Ferraresi, Ferrara 1646, Gironi. All'anno 1592: « ... Nelle case dè cittadini si cantò e si sonò in guisa, ch'ogni padre aveva quasi tutti li suoi figliuoli cantori, et la città si poteva dire una sola Accademia ... ». Nello stesso Duca Alfonso si deve riconoscere il principale fautore di questa rinascita musicale: « ... M a il Duca, che per la eontinuatione del Dominio di Ferrara, nella sua Famiglia, havea fatto quanto havea potuto, conoscendo che li l'i. maneva poco più di vita, volle questo rimanente passare con ogni sorte di sodisfatione, e conve· niente ad un gran principe, e vemmente Cristiano: onde chiamò da più parti musici eccellentissimi, che servirono tanto per lwnoTe et culto di Dio nella sua CapeZZa, quanto ancho in altre occasioni, e massime negli alloggi de' Principi forastieri, ne' quali egli fu sempre sopra ogni ere
,dere liberamente ma1gnifico ... l) G. SARDI, op. cito all'anno 1591.
divenne talmente numeroso che, siamo cero ti, ben poche città italiane erano in grado di sostenerne il confronto. Scarsi ed incompleti documenti rimangono a testimoniare questa splendida fioritura di madrigalisti il cui contributo a questo genere attende ancora di essere indagato ~2.
Il matrimonio fra Carlo Gesualdo Principe di Venosa e Leonora d'Este, sorella di Cesare, diede occasionc a Luzzaschi di cogliere un ulteriore ambito riconoscimento. Ancora prima di giungere a Ferrara il Principe musicista confidò al Conte Alfonso Fontane Ili « ••• d'aver lasciato quel primo stile et d'essersi messo all'imitatione del Luzzasco, da lui sommamente amato et celehrato ... )) 23. Questa affermazione peraltro poco considerata dai musicologi - dimostra abbastanza chiaramente l'influenza di Luzzaschi su Gesualdo 24.
Le feste musicali che si tennero i n quella occasione furono straordinarie: il Concerto Grande, il Concerto delle Dame, il Balletto della Duchessa, i Concerti femminili delle monache di S. Vito e S. Bartolo; « ... tutti li Mu.sici, et in particolare, qu.elli del Duca ebbero occasione di mostrar il Zor valore, essendo che quel Principe, era intendentissimo di quella nobilissima facoltà propor· tionata solo agli animi nobili; onde fra tutti ch' egli udl" lodò particolarmente il Sig. Luzzasco dè Luzzaschi Organista, per l'esquisita sua maniera di suonare, et per certo Istrumento Inarmonico, che suonando gli fè udire )) 24bis.
Era questo il cJavieembalo d iatonieo·ero-
22 Rappresentativa e sintomatica l'antologia madrigalistica ({ Il Giardino de' Musici Ferraresi» a cinque voci, Venezia 1591, Vincenzi, dove sono compresi i lavori di ventun compositori ai quali si dovrebbero aggiungere alcuni altri nomi abbastanza importanti che ne sono stati esclusi. 23 F. VATIELLI, Il Principe di Venosa e Leonora d'Este, Milano 1941, Bocca, p. 21 e segg. 24 Lo stesso Einstein, op. cit., p. 698, si stupisce che nessuno abbia mai controllato le opere di questi due musicisti ed i 101'0 reciproci rapporti. Un primo superficiale riscontro nell'opera di Gesualdo ci ha confermati nel sospetto che solo dopo il soggiorno ferrarese del 1594 le sue opere diventano più espressivamente tese e travagliate. 24bis G. SARDI, op. cit., all'anno 1594. 25 E. BOTTRIGARI, op. cit., p. 41 e segg.
Il
matico-enarmonieo costruito fin dal tempo i Nieola Vieentino. Questo strumento, de
nominato Arehicembalo comprendente tutti tre i generi armonici, era costituito di
" ... due tastami pieni di semi tuoni, o tasti negri oppi & spezzati ... non viene se non di rado
usalo per la gran difficoltà, che è parte nell'accordarlo, & accordato nel mantenerlo, parte nel :',marlo; percioché non è cosÌ valente mastro ac('ordatore, praltico, & sperimentato Organista di
alore, che non si spaventi quasi nell'essere Il
quegli presentata così gran quantità di corde, Il
questi di tasti compartiti, com'ho detto in due astami con semituoni negri ordinarij, spezzati
due et altri anco aggiunti ... )) e questo stru-mento rendeva una nuova armonia « ... massima-mente alora che il Luzzasco Organista principale
sua Altezza, lo maneggia mollo delicatamen· con alcune compositioni di musica fattc da
Hi a qucsto proposito solo ... )) 25.
L'impressione riportata dal Venosa deve l:ssere stata notevole se diversi anni dopo, in Napoli, volle tentare - senza suecesso -
eostruire un simile stlumento 26.
L'amicizia e la stima del Principe di Venosa per l'organista ferrarese è documenta-
da diversi storiei e partieolarmente dalla dedica preposta al quarto libro di madrigali
Luzzaschi. Non è d'altronde azzardata la potesi che durante i soggiorni ferraresi di
Gesualdo siano intercorsi fra i due musici· ~,ti rapporti di collaborazione vera e pron'ia, sia direttamente sia eoi mUSlCI napo
letani del seguito del Venosa tutti ferventi ammiratori del Luzzaschi 27.
Si deve prendere atto che da questa ami·
Ce lo testimonia una letLcra del piLLore holoDomenico Zampieri, detto il Domenichino,
Napoli in data 7 dicembre 1638 ed indirizzaa Francesco Albani in Bologna: « ... li ora
laccio fare un'arpa, con tutti li suoi generi Diatonico, Cromatico, et enarmonico. Cosa non più fatta né inventata. Ma perché è cosa nuova alli musici del secolo nostro, non ho potuto per ancito farla suonare. Mi rincresce che non sia vivo
Signor Alessa·ndro [Piccinini], il quale disse che io non havrei fatta cosa alcuna, mentre il ]juzzasco ne haveva fatto prova. Qui in Napoli
è stato il Principe di Venosa, e lo Stella dé musici, e non l'anno potuta ritrovare ... l).
Lettere sulla Pittura, Roma 1766, Pagliani, Tomo V, p. 29.
A. Superbi, op. cito Ioco cito Ciriani G.A., Ca-
eizia entrambi abbiano tratto un vicendevole giovamento. Luzzaschi che da dodici ni non pubblicava raccolte di madrigali, po la conoscenza di Gesualdo, riprese cremente a dare in luce il meglio della sua produzione madrigalistica. Pcr tJ~e anni con· secutivi lo troviamo impegnato in un valido ed originale contributo a questo genere stava raggiungendo la più alta perfezione formale ed estetica. È del '94 il quarto bro, del '95 il quinto e del '96 o al massi. mo del '97 il sesto libro.
Su quest'ultimo, di cui un esemplare la stampa originale non è ancora stato venuto, vogliamo aprire una piccola parenI
Una fortunata coincidenza ci ha permesso di identificare la dedica di quest'opera anche il suo contenuto è in parte reperihile in quanto ci rimangono cinque madriga completi 28. Ecco le parti più importanti di questa dedica il cui valore storico ed stetico ci sembra indiscutibile.
« Alla Serenissima Duchessa d'Urhino.
Sono (Madonna Serenissima) la musica, e poesia tanto simili, e di natura congiunte,
talogo ... Ms. cito loco cito Il quarto libro di mll~ drigali di Luzzaschi, che vide la luce alcuni mesi dopo l'arrivo di Gesualdo a Ferrara, contieni: nella dedicatoria il seguente passo: ({ ... lIavendu con diverse maniere mostrato al Mondo di stima. re, & lontano, & vicino, le mie ancorche de Doli compositioni ... l). Quanto ai seguaci napoletani i
Luzzaschi, dopo il Venosa ed il Trahaci, S0110
da ricordare Scipione Stella, Scipione Dentici Fahrizio Filomarino. A proposito di quest'ulti. mo riferiremo questa lettera che il Fontanell indirizzava da Napoli al duca Alfonso II nel 1594: ({ ... il Signor Fabrizio Filomarino doppo aver sonato di lauto divinissimwmente per mio parere, è venuto da me in cocchio et doppo lw venni replicato quello che già scritto a V. S. dci desiderio SllO di trovarsi col Luzzasco, mi lw detto che avrebbe bramato risiedere nella città di V. A. con altro titolo di servitore: ma COri
pensiero però di servirla di cose di musica pendo quwnto Ella si diletta in tale virtù et quanta stima siano presso il mondo questi che sono trattenuti da Lei, ma di ciò non havrebb,' fatto, molto dubitando di non esser soggetto de, gno di tanta patria che non essendo pertanto la scia da parte la voglia ardente di essere cono sciuto da Lei et di godere di almeno sei mesi LllZZaSCO»). VATlELLI, op. cito pp. 55-56. Anche madrigalista siciliano Antonio il Verso fu nn am, miratore di Luzzaschi. Nel suo Terzo libro madrigali a sei voci, Palermo 1607 Maringo, l'i
12
hen può dirsi, non senza misterio di esse favo· leggiando, ch'amhe nasc'eBsero ad un medesimo parto in Parnaso. Il che non è chi meglio intcn· da di V.A. la (IUale tanti ritratti del naturale n'ha veduti, e cosÌ hene il vivo dell'una, e del· l'altra conosce, né solamente si rassomigliano queste due gemelle nell'aria, nelle fattezze, ma di più godono ancora della rassomiglianza deglì hahiti, e delle vesti. Se muta foggie l'una, can· gia guise anche l'altra. Perciòché non solamente ha la musica per suo fine il giovamento, e 'l ti j. lctto, lineamenti della sorella naturalissimi, ma la leggiadria, la dolcezza, la gravità, l'acutezza, gli scherzi, e le vivezze che sono quelle spoglie, ond'elle con tante vaghezze s'adornano, sono portate dall'una e dall'altra con maniere tanto conformi, che hene spesso musi co il poeta e poeta il musi co ci rassemhra. Ma come a nascer fu prima la poesia, cosÌ la musica lei (come sua donna) riverisce, ed a lei cede della prima geni. tura l'onore. Intanto, che quasi omhra di lei di· venuta, là di muover il pié non ardisce, dovc la sua maggiore non la preceda. Onde ne segue, che se il poeta inalza lo stile, solleva eziandio il musieo il tuono. Piagne, se il verso piagne, ride, se ride, se corre, se resta, se priega, se niega, se grida, se tace, se vive, se muore, tutti questi af· fetti, ed effetti, così vivamente da lei vengon
porta un madrigale a sei voci ai Lnzzaschi - non com preso nelle sue opere a stampa - ]lroponendone la risposta. ~8 Una vicenda hih1iograficamente unica per quei tempi, si può dire sia toccata ai madrip;ali a cinque voci di Luzzaschi. L'interesse e la dif· fusione della sua opera in Napoli era divenuta tale da spingere gli editori ad affrontare una l'i· stampa. Questa ehhe luogo fra il 16] O ed il 16B non integralmente ma scegliendo alcuni madri· gali per ogni lihro e compendiandoli in due raccolte. Purtroppo la Prima Scelta non ci è ancora pervenuta; in questa erano prohabilmente com· presi i madrigali tratti dal L II e III lihro. Nella Seconda Scelta sono compresi madrigali dal IV, V, VI e vn lihro. Un confronto fra questa stampa e il IV, V e VII che si sono noli, ha permesso di identificare i seguenti madrigali: Ahi come tosto, Sorge la vaga, Signor s'io resto, Cor mio benché, i quali non possono appartenere che al sesto lihro. Più semplice l'identificazione della lettera dedicatoria. Nella seguente opera di ALESSANDRO GUARINI Prose, Ferrara 1611 Baldini, p. 142 si trova una lettera indirizzata dal Guarini al Luzzaschi: ({ ... V a~liasi pur libera· mente in tutto ciò, ch'ella crede ... Le mando la lettera dedicatoria alla Serenissima D'Urbino, della quale con taTlte cerimonie soverchie mi ha richiesto nella sua lettera l). Segue poi la dedica che riportiamo nel testo.
espressi, che quella par quasi emulazione, che propriamente rassomiglianza dè dirsi. Quinci veggiam la musica de' nostri tempi alquanto diversa da quella, che già fu ne' passati, percioché dalle passate, le poesie moderne sono altresì diverse. E per tacer di tutte l'altre, che non sentono mutazione, se non di materia, come canzoni, sestine, sonetti, ottave, e terze rime, dirò del Madriale, che solo per la musica par trovato, ed il vero dirò, dicendo, ch'egli nell'età nostra ha ricevuto la sua perfetta forma, tanto dall'antica diversa, chc se què primi rimatori tornasser vivi, a pena potrebbono l'i conoscerlo, non sì mutano si vede per la sua brevità, per l'acutezza, per la leggiadria, per la nohilLà, e finalmente per la (lolcezza, con che l'hanno condito i poeti che oggi fioriscono; Il cui lodevole stile i nostri 1l1usici rassomigliando nuovi modi, e nuove invenzion i più dell'usate dolci, hanno tentato anch'essi di ritrovare; delle quali hanno formata una nuova maniera, che non solo per la novità sua, ma per l'isquisitezza dell'artifizio, potesse piacere, e conseguir, l'applauso del mondo. Di questa guisa, Madama Serenissima, mi sono ingegnato di vestire i presenti miei Madrigali, ed all'A.V. gli ho dedicati, acciò, ch'el Mondo conosca, che può ben mutar il suo stile la musica, ma non può cangiare la sua devozione l'animo mio ... ».
Superfluo qualsiasi commento In que-sta sede - a questo « manifesto» dell'estetica madrigalistica di Luzzaschi. Teniamo a rilevare solamente che in esso si riscontra la codificazione di quanto il nostro autore cra andato praticamente realizzando nella sua opera.
Alla morte del duea Alfonso II e conse· guent.e devoluzione di Ferrara allo stato pontificio, mentre quasi tutti gli stipendiati clelIa corte ferrarese mllsÌcÌ cOlnpl·esi -
venivano lieenziati o seguivano Cesare d'Este a Modena, Luzzaschi e Alessandro Piei~injni furono immediatamente assunti al servizio del cardinale Pietro Aldobrandini. A questi, che a capo dell'esercito papale aveva preso possesso di Ferrara in nome di
Abbiamo testimonianze ehe durante le fun,-;ioni religiose in Duomo alla pre~enza del Pontefiee « ... si tenne Cappella alla Romana ... )) VefIi anehe il Terzo Libro di Madrigali di Ruggero Giovanelli. Venezia #1599 Gardano. datati e dedicati da Ferrara al Cardinale Pietro Aldobrandini. 30 Cfr. i presenti Madrigali del 1601 ed il Setti-
13
Clemente VIII, Luzzaschi dedicò le « Saerae Cantiones )) del 1598 e più tardi questi stes
madrigali. Gli scarsi documenti che riguardano Luz
zaschi in questo periodo non ci permettono cl stabilire quale tipo di servizio abbia svol· to presso la eorte del cardinale, e se al suo seguito ebbe modo di trasferirsi e soggiornare in Roma. Quest'ultima supposizione
essere suffragata dal1a notevole diffusione della sua opera in Roma e dalla stam
romana dei presenti madrigali. Dobbiamo però tenere conto che fra gli ultimi anni
Cinquecento ed i primi del nuovo seco· avvenne tra Ferrara e Roma un fitto
semnbio di musicisti; notevole, fra l'altro, soggiorno ferrarese - al seguito della
corte papale di un gruppo di musici pon-ti con a capo Ruggero Giovanelli 29.
Passata l'euforia dei festeggiamenti in oBore del Pontefiee, la vita musicale ferrare-
si avviava a rapida decadenza; possiamo quindi stabilire la fine dei rapporti tra l'Al. dobrandini e il Luzzaschi con la dedica dei presenti madrigali.
Gli ultimi anni di Luzzaschi furono ama· reggiati da disgrazie e controversie familiari
si deve aggiungere il deprimente spetta-della inarrestabile decadenza della
seno la musicale ferrarese. Il rimpianto ed il ri"entimento che traspaiono dalle dediche preposte alle sue ultime opere, lo dimostrano senza possibilità di dubbio :lo. Si può af· fermare con sicurezza che Ferrara, per quanto riguarda la musica, dopo il 1600
di ricordi. CosÌ quei ve echi musici· - tanto cari al duea Alfonso - che non
vollero abbandonare la loro eittà per cercare fortuna presso altre corti, vennero assor·
dalla amministrazione pontificia della Anehe a Luzzaschi venne offerto un
simile inearico e lo troviamo nel 1607 fra i primi cittadini costituenti il Consiglio Ceno tumvirale 30bis,
mo Lihro a 5 voei del 1604. 30bi, C. OLIVI, Annali della Città di Ferrara, Ms. Classe I N. 105. VoI. II p. 72. Ferrara, Bib. Connmale Ariostea. Il consiglio Centumvirale era UIla speeie di Senato costituito da cinquanta nobili e da cinquanta cittadini. Di fatto però erano solo una deeina e fra questi al quinto posto troviamo Luzzaschi.
b
Poiché l'insigne organista e compositore sentiva che la vita volgeva ormai al termine~ all'inizio del settembre del 1607, già infermo, fece testamento. Si spen.se, infatti, poco dopo e precisamente il lO settembre dello stesso anno 31.
Un cortigiano ferrarese ne rendeva conto alla vedova di Alfonso II in Mantova:
« II Signor Luzasco poche ore dopo l'avis o che diedi a V. A. del suo stato se ne passò di questa a miglior vita con molto dispiacere di tutta la città e massimamente de tutti li musici li quali non sapendo dar altro segno dell'amore che portavano lo accompagnarono circa ottanta alla sepoltura. II Signor Fiorino pose una ghirlanda di lauro dorato appresso il capo del catalelo, degnissimo di essere coronato nella sua pro{e~.
• 32 SIOne ... » •
I madrigali a una, due e tre voci di zaschi costituiscono una delle opere più golari della nostra letteratura musicale. golarità evidente non solo dal punto di vista tecnico della scrittura - parti vocali com· plete di diminuzioni e accompagnamento clavicembalistico integralmente realizzai o dall'autore - ma altresÌ dal punto di artistico.
È da lamentare che la maggior parte gli studiosi che hanno posato l'attenzione questo lavoro si siano soffermati di prefprenza a considerazioni di ordine tecnico storico 32bis. Solo l'Einstein ha azzardato giudizio estetico, peraltro molto discutibile, a proposito del cruale ci sembra opportuno fare delle precisazioni. Avremo modo di constatare come l'Einstein ebbe una superficiale conoscenza sia dell'opera che dell'ambiente
:n C. OLIVI, op. cito Ioco citalo p. 74. Adi lO tembre in Ferrara morì Luzzasclw Luzzaschi. Eccellente Musico, che a questi tempi era il primo musica dell'Italia in questa professione. Adi detto fu sepolto in S. Domenico rS. Paolo J. ol'e fu, accompagnato da tutti li musici di questa tà. Alla sepoltura fu da Ippolito Fiorini Maestro di Cappella del già Duca Alfonso Il Estense, coronato di lauro. Tutti ne provarono condisP,/lcere grandissimo per tal perdita, mentre il elloggi grandi. poco si direbbe. 32 Lettera di Giulio Moro alla duchessa di Mantova, Mantova: Archivio di Stato, Gonzaga, Lettere da Ferrara 1607. 32bis L. RONGA, in Giroll1!mo Frescobaldi, Torino 1930 Bocca, ne aveva intravista l'originali!;l:
14
e delle ragioni che la determinarono; di conseguenza non riuscì a rendersi conto del· la ricchezza e multiformità delle componenti culturali e stilistiche che informano quest'opera, in fondo molto diverse da quelle costituenti il madrigale tradizionale poli.
33 voco Al fine di rendere più accessibile questo
raffinato capolavoro, riteniamo opportuno fare un po' di luce sull'ambiente e sulle l'a· gioni che spinsero Luzzaschi a scrivere una opera cosÌ singolare.
I rapporti tra Luzzaschi ed il concerto delle dame risalgono, si è detto, a prima del 1570. Il primo documento storico sull'eccellenza del concerto risale all'agosto 1571: « ... e dietro un gravicembalo tòcco dal Luzzasco, cantarono la Signora Lucrezia e la Signora Isabella Bendidio a solo a solo, e tutt'à due, sÌ bene e cosÌ gentilmente, che io non credo si possi sentir meglio » 34. Vediamo cosÌ documentata in Luzzaschi la pratica del canto a una e due voci col clavicembalo attorno al 1570.
Per quanto questo nuovo tipo di musica fosse riservato soltanto ad una ristretta cerchia di raffinati intenditori e soltanto nel tempo riuscirà a varcare tali limiti nel giro di pochi anni si imporrà all'attenzione di tutte le corti europee 35.
Notevole impedimento alla diffusione sul piano pratico e ad un livello borghese di questo stile fu l'atteggiamento del duca Alfonso II. L'ombrosa gelosia che l'ultimo duca di Ferrara esercitò su tutti i suoi beni sia pubblici che privati si esplicò pesantemente anche sulla musica ed in particolare su que· sto tipo che rappresentava la più raffinata
« Luzzasco Luzzaschi stesso aveva tentato una nuova {orma di madrigale accompagnato, mostrando una personalissima sagacia inventiva l). 33 Ecco il severo giudizio dell'Einstein: « Not one is particularly expressive; aH swing back and forth in the somewhat neutral territory midway between « parlando )l and the rambling mechanical « coloratura II o{ the virtuoso ll, op. cito p. 845. 34 Da una lettera dell'ambasciatore mediceo Bernardo Canigiani e riprodotta dal SOL ERTI, op. dt.p. 134. 35 Cfr. il resoconto dell'ambasciatore estense a Vienna in una lettera del 24 luglio 1574, SoLERTI, op. cito p. 135.
e personale espreSSIOne del suo « otium »)
musicale 30.
Infatti quell'acuto osservatore di vicende musicali che fu il Giustiniani ignorò, al· meno nella sua fase iniziale, il concerto dei· le dame. Ecco quanto riporta a proposito di un nuovo stile di canto accompagnato:
« L'anno santo del 1575 o poco dopo si cominciò un modo di cantare molto diverso da quello di prima, e cosÌ per alcuni anni seguenti, massime del modo di cantare con una voce sola sopra un istrumento, con l'esempio di un Gio. Andrea Napoletano, e del Signor Giulio Cesare Brancacci e d'Alessandro Merlo romano, che cantavano un basso nella larghezza dello spazio di 22 voci con varietà di passaggi nuovi e grati all'orecchio di tutti. I quali svegliarono i compositori a far opere tanto da cantar a più voci come ad una sola sopra un istrumento, ad imitazione delli sud
detti ... )).
Dice poi il Giustiniani che coll'esempio dei cantori sopracitati l compositori iniziarono a SCrivere:
« ... con maggiore invenzione e artificio, e ne vennero a risultare alcune Villanelle miste fra madrigali di canto figurato e di Villanelle.
Ma sÌ come le villanelle acquistarono maggior perfezione per lo più artificioso componimento, così anche ciascun autore, a fin che le sue composizioni riuscissero di gusto in generale, procurò d'avanzarsi nel modo di componere [compo.
nerle] a più voci, e particolarmente Giachet Wert in Mantova, il Luzzaschi in Ferrara. Quali erano sopraintendenti di tutte le musiche di quei Du-
:16 Ben note le gelosie esclusivisti che di questi principi musicofili. Sembra ad ogni modo che i più radicali siano stati Alfonso II - il quale esi. geva che nessun musicista ferrarese per quanto non impiegato in corte si allontanasse dal suo ducato, ed impedì metodicamente la pubblicazione delle opere dei suoi maestri di cappella - e Guglielmo Gonzaga che commissionò un ciclo di messe al Palestrina per suo esclusivo uso e consumo. Su quest'ultimo duca-musicista, cfr. l'articolo di A. CAVICCHI Lettere di musicisti ferraresi: Lodovico Agostini, in Ferrara Viva IV,1l-12, Ferrara 1962 Tipografia Sociale, pp. 191-199. ,17 V. GIUSTINIANI, Discorso sopra la musica dei suoi tempi, in SOLERTI Le Origini del Melodramma, Torino 1903 Bocca pp. 106 e segg. Questo brano interessante contiene un'inesattezza quando il GiustinÌani afferma: « ... Giachet in Mantova ... » lasciando s1}pporre che anche in quella città si praticasse questo stile. Possiamo invece dimostrare che ciò non corrisponde a verità. Il brano sopra riportato del Giustiniani si riferisce
15
che se ne dileUavano sommamente ... » 37.
La testimonianza del Giustiniani, seppuimprecisa e contorta, aiuta ad individuanel nuovo stile di canto solistico il con-
vergere di varie componenti stilistiche. DalVillanella viene mutuata l'ariosità melo
dal Madrigale l'espressività elevata ed l facili giuochi contrappuntistici.
Il tutto nobilitato dalla più raffinata arte vocale (diminuzioni) e sostenuto da un accompagnamento strumentale adeguato. Interessante, e corrispondente a verità, l'affermazione del Giustiniani a proposito delle opere a più voci scritte in questo nuovo sti-
dal Luzzaschi e dal Wert.
Aggiunge ancora il Giustiniani:
« H' Coll'esempio di queste Corti [Ferrara e Mantova, ma sarebbe meglio dire coll'esempio di Luzzlischi e Wert] e deIIi due napoletani che canta. VIIno di basso nel modo suddetto, si cominciò in Roma a variar modo di componere a più voci sopra il libro e canto figurato, et anche ad una o due al più voci sopra alcuno stromento, e comin-
a Prencipe Gesualdo di Venosa, che suonava anche per eccellenza di Lento e di Chitarra Na. poletana, a componere Madrigali pieni di molto artificio e di contraponto esquisito, con fughe dif. ficili e vaghe in ciascuna parte, intrecciate fra loro ... Et in questa guisa compose lo Stella, il Nen· nli e Scipione dei Ritici [Dentici], che seguivano il suddetto modo del Prencipe di Venosa e de] Conte Alfonso Fontanella ... » 37 bis.
Abbiamo già visto come Gesualdo si pro-
ad un'epoca che può essel'e compresa fra il 1575 e 1585; orbene è noto che per una particolare antipatia del duca Guglielmo Gonzaga questo stio le non venne mai praticato per lo meno fino alla sua morte avvenuta nel 1587. Cfr. SOLERTI, Ferrara e le corte Estense ... cito p. 138, n. 2. Forse il Giustiniani venne tratto in inganno perché due delle componenti il concerto erano mantova· ne ed il Wert era stato al servizio del Gonzaga. ALbiamo visto come Laura Pepe rara eLivia D'Arco vennero a Ferrara nel 1579 ed iniziarono a studiare sotto la guida di Luzzaschi e del Fiorini al fine di sostituire le sorelle Bendidio. J aches Wert fra il 1583 ed il 1589 fu tanto spesso a Ferrara che si può dar per certa la sua appartenenza spirituale al circolo ferrarese. Cfr. A. CAVICCHI, art. cito p. 197, n. 30.
V. GWSTINIANI, op. cito Ioco cit. Anche il Fontanelli si dedicò, con notevole reticenza, a questo nuovo genere. In alcune lettere riportate dal V ATIELLI, op. cito pp. 40 e segg. ne parla in termini tecnici del più alto interesse.
Dr
clamasse discepolo e seguace di Luzzaschi ci sembra che anche il Fontanelli, per quan m
to in gioventù avesse studiato con Salvatorf~ Essenga, difficilmente abbia potuto sfuggi m
re all'influenza del nostro. Concludendo: le condizioni dell'ambienl!~
ferrarese - antecedenti di larga pratica canto virtuosistico accompagnato -, il lavo. l'O di Luzzaschi per il concerto delle dame l'evoluzione del cantare a solo determinarono la nascita di un nuovo genere ben dir· ferenziato dal madrigale polivoco a cinque voci: il {( Madrigale a una due e tre per cantare e suonare ». In una parola: un genere cameristico ancora più levigato pur colto madrigale a cinque voci.
Mentre le composizioni di questa nuova maniera usate dai virtuosi sopracitati erano costituite per lo più da adattamenti e tra· sformazioni di opere di scarso valore, le mu· siche che andava preparando Luzzaschi per il concerto delle dame erano invece quanto di più raffinato si potesse desiderare. Impor., tante, a questo proposito, la collaboraziOlw poetica di Giambattista Guarini.
I rapporti fra Guarini e la musica ed musicisti del suo tempo non sono stati fino· l'a adeguatamente indagati. Una superficia m
le ricognizione in questo campo ha dato im· mediatamente risultati del più alto intere.'" se. Limitatamente a quest'opera possiamo affermare che dei dodici madrigali che compongono ben sette sono sicuramente Guarini ed alcuni altri possono essergli a I tribuiti per spirito e forma. Constatiamo in quale modo e con quale impegno il poeta
38 V. ROSSI, Battista Guarini e il Pastor Fido, Torino, 1886 Loescher, p. 276. Lettera indirizzlita al duca Alfonso II in data 20 agosto 1581. 39 V. ROSSI, op. cito p. 276. Altra prova che concerto delle dame era sotto l'esclusiva direzione di Luzzaschi. Lettera datata settembre 1581, 40 Al famoso basso napoletano Giulio Cesan~
Brancaccio dedicò il Sonetto Il Basso del Brall· cazio, vedi nelle sue Rime, Venezia, 1621, Cio! . p. 309. Questo eccezionale tipo di cantante, solm dato di ventura e scrittore, nel 1583 per un liti· gio col duca Alfonso venne licenziato dalla corle estense. Qualche tempo dopo scriveva al Guarin! pregandolo di intercedere a suo favore presso duca affinché potesse tornare a Ferrara. La lettera di risposta del Guarini a proposito di queslo incarico è pubblicata nelle sue Lettere, Venezia 1600 Ciotti, p. 382. Cfr. anche SOLERTI, op. ci!. pp. 122 e segg. La moglie di Giambattista Guar!m
16
ferrarese cercasse di aderire alle esigenze de] nuovo stile:
« ... Mando la Canzonetta che mi fu da V. A. or· dinata, nella quale mi sono ingegnato di descri. vere lo sgorgheggiare et le tirate et i groppi, che si fan llI~lla musica, cosa nuova et difficile assai et, per quel ch'ì habbia fin (}!ili veduto, da niun rimatore, nè tampoco da poeta greco, et trà la. tini dal diviniss,'o Ariosto in una sua ode, et da Plinio, prosatore antico solamente tentata. Nella quale credo che'l Musico troverà molla invenzio· ne di farsi honore ... » 3S.
ed inviava al duca Alfonso
« ... una Ballatella, la quale mio talento deside. rava, che m. Luzzasco facesse in musica, ma non ho voluto ch'egli vi ponga mano, prima ch'Ella non vegga se fosse buona per le Dame ... » :H'.
Amico del basso napoletano G. C. Brancaccio e cognato di Lucrezia e Isabella Bendidio-cruest'ultima sposerà suo zio, il Conte Macchiavelli - i suoi rapporti col concerto delle dame si stringeranno ancora di più quando la figlia Anna ne diventerà una delle principali componenti accanto a Laura Peperara e a Livia d'Arco 40.
Fra il 1582 ed il '92 lo stile delle Dame ferraresi acquisì un autentico valore di avanguardia e pochi furono i musicisti di rilievo e gli ambienti musicali che non venissero più o meno a conoscenza di questa nuova lnanlera.
Alfonso II era orgoglioso oltre ogui dire del suo concerto di dame che col « concerto grande» costituiva una « delle più rare me· raviglie ch'hebbe la sua Corte» 41.
ni era sorella di Lucrezia e Isahella Bendidio; Cfr. F. D'OVIDIO, Il Tasso e Lucrezia Bendidio Macchiavelli, in Nuova Antologia, LXIV - 1882 pp. 289 - 298. Riguardo Anna Guarini cfr. G. CAMPORI, La figlia del Guarini, in Nuova Antologia, XII - 1869 pp. 323-332. 4l Moltissime e veramente straordinarie sono le testimonianze riguardanti Alfonso II e la musi· ca. Purtroppo in questa sede è impossibile elencare anche solo le più importanti, ci basti per ora questa: « ... di Musica e dell'armonia di musicali istrumenti grandemente vi consuma gran parte di tempo, e se ben non ne fa professione oltre all'essere intelligentissimo ha nella sua corte fra diversi professori di questa virtù fino a quattro o cinque dame che cantano benissimo et suonano vari istrztmenti eccellentissimamente l).
O. DELLA RENA, Relaozione dello Stato di Ferrara, 1589 in SOLERTI, op. cito p. 236.
------_ .............. _---_ ...... _----------------~.---""-'''-,-,,-'''-,-'-'-'",
L'ambasciatore mediceo a Ferrara non mancava di informare minutamente~ a questo proposito, il Granduca:
« •.. si fece la consueta musica delle Dame, la quale si fa ogni giorno senza mancare mai, e v'è tanto il Signor Duca inclinato e inteso a questa cosa, che pare aver posto in essa non solo la sua dilettazione ma ogni altro suo pensiero, sempre si studia di nuove invenzioni nè può farseli cosa più grata che lodarle [le dame] e ammi. rarle ... » 42.
Non solo i nobili dilettanti stimavano ed ammira\'ano il concerto delle dame, ma i più importanti musicisti del tempo come Costanzo Porta, Claudio Merulo~ Orlando di Lasso, Filippo di Monte, J aches Wert e Ales. sandro StI·iggio. Quest'ultimo riuscÌ abil. mente ad introdurre in Firenze - compien. do una vera e propria opera di spionaggio artistico - lo stile delle dame ferraresi.
« Qui è lo Striggino [il figlio di Alessandro] ed un altro cantore [Alessandro], e si fanno cose stu· pende di suoni e di canti: stupiscono tuttavia del cantare di queste dame e del saper loro, cantando eglino improvvisamente ogni mottetto ed ogni composizione che loro li diano per diffici· lissime che siano; ma vi manca la Guarina [fi. glia del Poeta] qual'è un poco risentita ... » 43.
Lo Striggio, approfittando della amicizia di Alfonso, si intratteneva spesso con le da. me avendo agio di esaminare attentamente le partiture dei brani scritti dal Luzzaschi. Dalla fitta corrispondenza che Alessandro Striggio tenne a questo proposito col Granduca di Toscana apprendiamo due cose: prima, in Mantova non esisteva nessuna pra. tica di canto diminuito e concertato femmi.
42 SOLERTI, op. cito p. 119. 4'1 SOLERTI, op. cito p. 138. 43bis Questa testimonianza che le dame eseguisse. ro rigorosamente le diminuzioni scritte trova conferma in una minuta di risposta ducale a Luzzaschi dove gli si ordinava di scrivere tutte le diminuzioni e le tirate copiandole poi in appositi libri affinché il repertorio di quel con· certo fosse unitariamente riunito. (Modena, Archivio di Stato, Archivio Estense segreto, Musica, Busta I). La stampa di questi Madrigali con le diminuzioni rigorosamente scritte dimostxa quanto lontana fosse !'idea di Luzzaschi dallo spirito dell'improvvisazionei Risulta perciò sempre più chiara la sua elevata concezione di questo nuovo modo di cantare che probabilmente ha poco
17
nile (come asserirà il Giustiniani); seCOlI-da, per espresso ordine del Granduca lo Striggio dovè prestarsi ad una autentica opera di spionaggio e di plagio. Illuminan. te questo senso la stessa lettera del
manLovano:
« '" Qui ogni giorno il Signor Duca di Ferrara voI sentire la mia arcisviolata lira et Sandrino [Alessandro junior] gli è piaciuto assai e per due hore continue mi favorisse di farmi sentire il suo Conserto di donne il quale veramen" te raro; e quelle signore cantano eccellentemente et nel loro conserto e a libro, alimproviso son sicure. Il Signor Duca mi favorisse di conlinuo di moslrarmi in scritto tutte le oppere che cantano alla mente, con tutte le tirate e passaggi ehe vi fanno 43bis e spero che fra otto o dieci
giorni sua Altezza si contcntarà ch'io ritorni Mantova, dove ho lassato mia moglie e figli, e là io potrò poi comodamente, ad imitatione di questi canti di Ferrara comporne qualche Ull0 per il eoncerto di V.A .... ») 4-i.
Abbiamo notizia che lo stile del canto concertato in Firenze non venne abbandonalo. L'ambasciatore mediceo a Ferrara l inviava a Firenze delle musiche avute dane mani di Orlando di Lasso - che era stato ospite di Alfonso II - con la "''''"'~~'U raccomandazione: « ... da concertarsi con Scipione [del Palla] e Spina ... ) 45.
Il Granduca Ferdinando de' Medici volle, in qualche modo, imitare il concerto reRe. A questo scopo fece venire da Roma Vit.toria Archilei con una allieva Margherita - che, con Lucia Caccini, diedero
ad una versione fiorentina del concerto di dame 46.
in eomune con la usuale tecnica dell'improvvisazione vocale e strumentale cinquecentesca. <H GANDOLFI, Lettere inedite scritte da musicisti e letterati, appartenenti alla seconda metà del sec. XVI, estratte dal R. Archivio di Stato in Firenze, in Rivista Musicale Italiana, XX-1913, pp. 527 - 554: lettera del 29 luglio 1584 da Fer. rara al Granduca. 45 CAMPORI, Notizie delle relazioni di O. di Lasso e di G. P. da Palestrina cò principi estensi, Modena 1869, Vincenzi, p. 8. 46 VOGEL, Bibliothek der Gedruclaen WeIlliclum V ocalmusik Italiens, Berlino 1892, I p. 385 descrizione degli Intermedi e Concerti ... nelle nozze del Serenissimo Don Ferdinando Medici e Modama Cristina di LOl'cna ... Venezia 1591 Vin-
le
Ormai il complesso ferrarese aveva raggiunto il culmine della perfezione e la sua fama era diffusa in tutto il mondo della tura. Viene a proposito per questo la dedica che il Wert antepone all'ottavo libro di madrigali a cinque voci:
«Percioché lasciando stare di tanti altri eceel· lenti Musici e Cantori che sono nella sua numerosissima e perfettissima cappella: à cui [ nou sono hoggimai note le meraviglie, & l'altre tante & sÌ rare qualità delle tre nobilissime vani dame della Serenissima Signora Duchessa
di Ferrara? Il qual rispetto per se solo bastar dovrebhe à
indurre tutti i compositori del mondo, che le loro opere indirizzassero a V.A. perché da sì !VI'
ne voci, & da sÌ nobil concerto ricevessero il ve· l'O, & naturale spirito della Musica ... )) 47.
Oltre ai compositori, che più o meno notoriamente scrissero per le Dame ferraresi 44,
vale la pena di ricordare che anche Gesual· do si dedicò a questo stile. Il Fontanelli ne rende conto al duca di Ferrara: « ... ha il Principe] ridot./o a buon segno un dialogo a tre soprani, fatto, io credo, per codeste Signore ... » 4".
Il Cavalieri, nella ormai nota lettera ehe indirizzò a Luzzaschi nel 1592, ci rende testimonianza di come si considerasse nell'ambiente fiorentino il concerto delle dame c (mali fossero gli obbieuivi più assillanti eui tendeva l'avanguardia musicale italiana.
« ... Giulio Romano è venuto da me dandumi conto degl'infinitissimi favori ricevuti non solo da V.S. [Luzzaschi] et da tutte quelle Eccellentissime ma anco dal Serenissimo di l''er· rara ... Mi sono fatto dire tutte le qualità che sono in dette Signore et se bene io ne viveva infor· matissimo, nondimeno conosco che tante insieme non credo se siano mai udite, né siano
centi, dove è testimoniato che questo trio femminile eseguì diverse musiche appositamentc scritte da Emilio dè Cavalieri. 47 GIACHES WERT, L'ottavo libro di Madrigali a cinque voci, Venezia 1586 Angelo Gardano. 4~ KINKELDEY, op. cit.; p. 551 e segg. e Einstein, op. cito p. 723. Anche Paolo Virchi (1556-1610) organista del duca Alfonso nella dedica al suo Primo Libro di Madrigali a cinque voci, Venezia 1584 Vincenzi·Amadino, fa riferimento alle signore che li cantano ". 49 V ATIELLI, op. cito p. 39. 50 Cioè Caccini deve considerarsi fortunato se que Ile dame gli hanno concesso di ascoltare Il !,cu-
18
per sentirsi altrove che in Ferrara. Ho simil· mente veduto il regalo di Colane [Collane] do· nate da S.A. et da quelle Signore ma più stima deve tenere il detto Giulio della gratia concessa· le di poter mostrare a quelle Signore alchune delle sue Arie, 50 poi ché sono sicurissimo, esseno done stato dal S. Valeriano Catanei informato, che quelle Signore habbiarto ogni modo di cantare, et che ognuna di loro potesse imparare al detto Giulio, se bene è giovane che canta assai bene. Hammi anco detto che hà datto [dato] conto a V.S. di un'Organo che io so fare, qual sarà finito a Natale, nel quale non solo si potrà sonar armonico [enarmonico], ma anco ne sarà la partitione del tuono in dieci come [commi]. La quale, si come me dice haver detto a V.S., io l'ho fatto con una voce cantare sopra ad organo di legno in Fiorenza dov'è stato sentito da molti. Et per essere cosa nnova et molto difficile, non manca chi non la crede, la quale essendo cosa curiosa da chi si diletta. lo riceverei per un grandissimo favore se con qualche occasione V.S. potesse venire a favorire Fiol'enza et io fargliela sentire, poiché sperarei, col suo mezo [mezzo] et con l'Eccelenza di quelle Signore, haver gratia che cantassero un paro di Madrigali in questo nuovo modo di partire il tuono in dieci parti et di questa maniera conseguirei alcune fatiche fateci. .. con questa occasione romperò il silenzio di molti mesi che non le ho scritto; assicurandola che io desidero servirla ... » 51.
Nell'ambito di quella cerchia di musicisti che, nello scorcio dell'ultimo cinquecento si dedicarono alla ricerca di nuovi mezzi espressivi e di nuove forme musicali, Luzza· schi era considerato fra i più sperimentati autori ed esecutori nella pratica dei generi Cromatico ed Enarmonico. Per questa ragione il Cavalieri lo invitava a provare il suo organo e la nuova suddivisione infrato· naIe da lui inventata 52.
ne delle sue arie. Poiché so da fonte sicura che ognuna di quelle signore è cosÌ brava da poter insegnare a Giulio qualsiasi stile di canto. 51 Questa lettera, conservata all'Archivio di Sta· to di Modena, venne pubblicata dal Prunieres in « Revue de Musicologie », VIII-1922 p. 131. 52 È interessante far notare che Luzzaschi è quasi l'unico musicista di professione che abhia concretamente partecipato al movimento d'avanguardia promosso da quel gruppo di nobili dilettanti più o meno musicalmente preparati come: G. Bardi, J. Corsi, E. de Cavalieri, A. Fontaneni, il Principe di Venosa, T. Pecci, ecc.
Tutte le testimonianze sopra riferite stanno a dimostrare eome il eoneerto delle dame non fosse da attribuirsi ad un eortigiano capriecio e, tanto meno, ad un tipo di voga, bensÌ alla somma di un lungo studio condotto sotto la guida di un grande maestro e con scopi artistici ben determinati.
Eeeo alcune testimonianze sulla tecniea di eseeuzione di queste dame:
« 0.0 era gran competenza di quelle dame di Mantova e di Ferrara, che facevano a gara, non solo quanto al metallo e alla disposizione delle voci, ma nell'ornamento di esquisiti passaggi tirati in opportuna congiuntura e non soverchi (nel che soleva peccare Giovan Luca [Coniorti] falsetto di Roma, che servì anche a Ferrara) e di più col moderare e crescere la voce forte o piano, assottigliandola o ingrossandola, secondo che veniva a taglio, ora con strascinarla, ora smezzarla con l'accompagnamento di un soave interrotto sospiro, ora tirando passaggi lunghi, seguiti bene, spiccati: ora a gruppi, ora a salti, con passaggi soavi e cantati piano, dalli quali talvolta all'improvviso si sentiva echi rispondere, ... e con far spiccar bene le parole in guisa tale che si sentisse anche l'ultima sillaba di ciascuna parola, la quale dalli passaggi ed altri ornamenti non fosse interrotta o soppressa; e con molti altri parlicolari artifici ed osservazioni» 53.
Ed ancora:
« ... in medesimo tempo si dava principio alla musica, a tal [punto] ch'ero io necessitato insieme giocare, udire, lodare ed ammirare i passaggi, le cadenze, le tirate e sifatte cose, delle quali tutte, cominciando dal gioco, poco m'intendo e manco mi diletto. Questa festa non durava punto meno di quattro ore, perché dopo avere can· tato alcune altre dame, finalmente compariva ]a signora Peverara, che è quella mantovana scritta altre volte, la quale sotto pretesto di {al' mB· re a me or una cosa or un'altra, e sola e accompagnata, e con uno e con più istrumenti, si {aceva durare al più che si poteva ... » 54.
53 V. GIUSTINIANI, Discorso ... cito pp. 107-108. 54 SOLERTI, op. cito p. 138. 55 B. GUARINI, Rime, Venezia 1621 Ciotti p. 269. 56 Non staremo a citare le copiose testimonianze sulla valentia di Luzzaschi come organista. Singolare ed inspiegabile rimane il giudizio negativo datone da Lelio Giudiccioni al Della Valle: « ... non sapeva lar~, un trillo e che sonasse cosi rustica'mente solo di arte le più fine sottigliezze dè suoi contrappunti, senza alcuno accompagnamento di leggiadria)l. (P. DELLA V ALLE, Della
19
Giambattista Guarini, invece, ce ne forniSCi' una idealizzazione poetiea:
GORGA DI CANTATRICE
Mentre vaga Angioletta anima gentil cantando alletta,
Corre il mio core, e pende Tutto dal 5uon di quel soave canto; E non so come intanto Musica spirto prende, Fauci canore, e seco forma e pinge Per non usata via Garrula, e maestrevole armonia. Tempra, d'argenlo SU011, p ieghevol voce,
E voi ve, e la spinge roui accenti, e con rilorti giri
tarda, e là veloce; E talor mormoTando In basso, e mohi! suono ed alternando
e riposi, e placidi respiri,
Or la sospende e libra. Ora la preme, or la frange, or In l'all'erma;
O la saetta, e vibra, Or in giro la mena, Quando con modi tremuli, e vaganti,
Quando fermi, e sonanti. Così cantando, e ricantando il core,
O miracol d'amore, E fatto un Usignuollo, E spiega già per non star meco il volo ''''.
A Luzzasco Luzzaschi, come a molti siromentisti-compositori, toccò la ventura di essere considerato più per le sue indubbie r[ualità stromentistiche che per quelle di compositore 56. Questa incomprensione si verI particolarmente nell'Italia settentrÌo-
Dove invece l'opera di Luzzaschi ebbe una maggiore diffusione e penetrazionc fu
Roma ed in Napoli. Il vero trionfo che ebbe Luzzaschi in que-
musica dell'età nostra che non è plmto inferiore, anzi è migliore di quella dell'età passata, in SoURTT, Le origini del melodramma ... op. cito
157). essere in netto contrasto C011 tutte le altrc
testimonianze riguardo Luzzaschi organista, sem· hra autorizzata ]a supposizione che il Guidiccioni abbia udito l'organisla ferrarese o mentre accompagnava le dame o molto tardi, dopo il 1605, quando si stava già affermando uno stile più fiorii
sl'ultima città lo si deve attribuire ai stretti legami col Principe di Venosa ed 1:11
compositori che a questi facevano capo, tutti ammiratori ferventi del maestro ferrarese.
Per renderei conto di come Luzzaschi venne un caposcuola di una particolare corrente, dobbiamo accettare che la sua opera dal 1580 in poi rappresentasse una delle punte più evolute e tecnicamente più de dell'avanguardia musicale. Gli stessi contemporanei si resero perfettamente conto questo nuovo indirizzo, la cui ascendenza veniva rintracciata nella lezione di Cipriano e si fregiava della ben nota etichetta va sotto il nome di « Seconda pratica l). Il fratello di Claudio Monteverdi nella «
tcra » preposta agli « Scherzi Musicali »
1607 ne parla in modo non del tutto preeiso poiché accomuna le più varie tendenze Bisogna che trascorrano altri trent'anni perché uno dei più dotti compositori di scuola romana, Domenico Mazzocchi, per esemplificare uno dei rami più raffinati madrigalismo cinquecentesco chiami a monianza un gruppo di autori criticamente più omogeneo come Marenzio, Macque, Nenna, Pecci, Luzzaschi e Gesualdo 58.
Questa tendenza del resto era già mo] lo ben delineata in Napoli nei primi anni '600. Ne sono prove determinanti la stampa del fior fiore dei madrigali a cinque voci Luzzaschi ed una raccolta pubblicata 1615 che comprende i più qualificati l'a p' presentanti di questa tendenza "H.
Ma ecco una ulteriore puntualizzazione critica su Luzzaschi dovuta alla penna un contemporaneo. Si tratta di un dialogo immaginario avvenuto tra Torquato Tasso
già colpito dalla pazzia e Cesare porali. L'argomento è una discussione
,)7 C. MONTEVERDI, Scherzi musicali a tre voci ... Venezia 1607 Amadino. Il fratello di Monteverdi elenca fra i seguaci della « seconda prattica» Gesualdo, Cavalieri, Fontanelli, Bardi, Giovanni del Turco, Tommaso Pecci, Wert, Luzzaschi, gegneri, Marenzio, Peri e Caccini. 58 D. MAZZOCCHI, Dialoghi e Sonetti ... Roma, 1638 Zanettip. 180. 59 N uova scelta di M adrigaU di sette alltori, apoli 1615 Carlino. Gli autori sono: S. Dentici, F. Genvino, P. Nenna, T. Pecci, S. Stella, sualdo e Anonimo. Il legame fra questa raccolta e la Seconda scelta dei Madrigali di Lllzzaschi,
20
critica dantesca.
« ... Tasso: Ma poiché siamo entrati tant'oltre
nelle lodi di poeta veramente divino, udite sembianza, che voglio far io del Petrarca, e di Dante, tratta appunto da quell'arte, ch'è sorella del· la poesia, io dico dalla Musica .. " A ben somigliare i due toscani poeti, sÌWdle dell'uno la lode sia senza il biasmo dell'altro, dico, che il Petrarca è somigliante a quel Musico, il quale né suoi figurati componimenti con la dolcezza, e con la leggiadria, va sporgendo il diletto, studiandosi sovra ogn'altra cosa di non offendere l'orecchio, con isquisita soavità lusingandolo. Dante a quell'altro è molto simile, che il suo diletto va rintracciando per altri vestigi; per ciò che vuoI egli derivarlo dalla imitatione di quelle parole, che egli imprende a figurare con le sue note. E per conseguir questo suo fine non teme durezza. non fugge asprezza, né schifa l'istessa dissonanza contra l'arte artificiosa, Solo ch'egli rappresenti con gli armonici suoi concetti, spiegati dall'ac· coppiate figure, che sono le sue rime e i suoi versi, e con esse quasi dipinga tutto ciò che si· gnifican le parole. Opra di grand'artificio, e che
ricerca profonda Filosofia nella Musica, com'un isquisito contrappunto nella poesia... Diremo
dunque, secondo nostra sembianza, che il Marenzio (per parlar dè moderni) in Musica sia un'altro Petrarca, e un altro Dante Luzzasco.
Taccio di tale pur a Dante somigliantissimo, che
cosÌ Prencipe tra Musici dimostrandosi, com'egll è tra signori, ha colla sua nobiltà, e col suo pellegrino ingegno nobilitata mirabilmente quest'arte ... 00. Poiché rassomigliammo Dante al Luzzasco, procederemo con la medesima sembianza gli
artifici dell'uno, a quelli dell'altro proporzionando. Voi udite ne' dottissimi Madriali di quell'eccellentissimo Musico, quando le parole sopra le quali è composta la sua musica hanno concetto. o di pianto, o di riso, o d'allegrezza, o di dolore. o di grido, o di silenzio, o d'aspro, o di dolce, o di alto, o di hasso, o d'altro simile, ch'egli sÌ ben
Napoli, 1613 Carlino, è evidente in quanto dedicante e dedicatario sono i medesimi. La stessa dedica è illuminante in questo senso: « ... Li mesi passati ... per far conoscere al mondo quanto ella ... si diletta della Musica, hehbi ardire di dedicarli la Seconda scelta di Madrigali di Luzascho Luzaschi homo così celebre in questa professione. Dovendo ora dar in luce una nuova Scelta di Madrigali di quei celebratissimi Musici ... l).
60 Allude chiaramente a Carlo Gesualdo Principe di Venosa.
addopra con le sue note, che il lor canto piagne,
ride, s'allegra, si duole, grida, tace, s'inasprisce, si raddolcisce, s'alza, s'abbassa, e finalmente rap
presenta tutti quegli affetti, ed effetti, come se naturalmente si sentissero e s'operassero. CosÌ
appunto il nostro Poeta [Dante], e se quegli [Luzzaschi] non si guarda di porre una durezza, e, come altra volta dicemmo, anehe talora una dissonanza, quantunque artifICiosa, purché rappresenti ciò che significano le parole, cosÌ questi [Dante] per porre dinanzi agli occhi sì ehe si vegga, la cosa, ch'egli descrive, non teme di metter mano a voci dure, non usate, ed istrane; ne schiffa egli alle volte concetti umili, e molte fiate, a' gusti troppo delicati, stomachevoli, per meglio esprimere per mezzo di essi, i più nohili,
• 61 e graVI ... ) .
La precisione critico - estetica di questo f!"iudizio che stupisce per la sua modernità ci trova del tutto consenzienti ed è una riprova che dimostra ancora una volta come Luzzaschi sia stato altamente considerato e quasi preso ad esempio da un buon numero di compositori appartenenti alle più avano zate tendenze della fine del cinquecento.
Già il Kinkeldey circa sessant'anni or sono aveva riconosciuto che i presenti madri· ~ali furono scritti molto tempo prima della loro pubblicazione. Noi cercheremo di esse· re ancora più precisi tentando eli stabilire - nahlralmente con una certa approssimazione - la data di composizione di 0blTIl madrigale.
Il limite di tempo entro cui può essere compresa la redazione di questo lavoro è quanto mai vago ed esteso (1568.1597) e solo un rigoroso confronto stilistico con la parallela opera madrigalistica polivoca, può darci delle utili indicazioni per una appros"imativa datazione.
l,a raccolta si apre con un brano che ha tutte le caratteristiche per essere considerato fra i primi di questo genere. Una larga presenza di elementi imitativi e contrappun. tistici e la parte finale in tripla di semibre, vi ci fanno supporre la redazione di questa opera verso i primi anni del '70. L'ambigua scrittura di questo madrigale ha tratto in in, ~anno più di uno studioso in quanto, appa·
Gl A. GUARINI, Il Farnetico Savio, overo ]l Tas-
21
rentemente, sembra la realizzazione di un madrigale polivoco. Ciò è facilmente confuta bile, poiché raramente un madrigale a quattro voci in quest'epoca possiede una cosÌ straordinaria ricchezza di snodature melodiche ed una così rigorosa logica musicalI' concentrata nella parte superiore. È noslra opinione che questo madrigale rappre-51'nti un esempio di quella maniera di can· to solistico con accompagnamento polistru. mentale che Luzzaschi ereditò da Alfonso
Viola.
Una decisa evoluzione denota il secondo IlI'ano da attribuirsi all'epoca del secondo li·
di madrigali a cinque voci. Quivi gli elementi contrappuntistici ed imitativi sono molto limitati e la parte accompagnante
già modernamente concepita e funzionaI· mente valida riveste quasi sempre un molo di sostegno; singolare l'interpolazione della tripla con un accompagnamento tipipamente liuti5tico. La ripetizione, sia ugua·
che variata, diventa norma sì che, quando pparirà nei madrigali a due e tre voci, non
potrà affermare che essa sia stata deterainata da ragioni di scambio ed alternano
tra le voci, ma da una necessità, seppulatente, di individuazione tematica, in
larte mutuata dana Villanella. Per la loro distesa espressività e la più solare ispirazio
possiamo attrihuire il quinto, il nono ed decimo hrano all'epoca del terzo lihro di
madrigali.
Il periodo della piena maturità (1585-590) si contraddistingue per una più in
lensa ricerca ed affermazione di un senso di 11010rosa prostrazione -"- determinante nel· 'influenzare il Fontanelli, il Gesualdo ecc.
delicatamente soffusa di un contenuto lirismo. Uno dei più perfetti e riusciti lavori fiella maturità è il terzo madrigale. Ugualmente distante dallo spirito della Villanella eome dal Madrigale tradizionale, vediamo
esso realizzarsi un nuovo tipo di espres"ione vocale. Pur non avendo assolutamente nulla a che vedere con il « recitar cantan
)), nondimeno Pespressione musicale è decisamente determinata dal significato del
parole. Nel « recitar cantando )) è spesso
Dialogo, Ferrara 1610 BaldinÌ, pp. 12 e segg.
L
evidente una forzatura esprcsslva dall'c;.slel'no; qui, invece, siamo in un mondo esprI'''-
più intimamente vero e raccolto, le parole sembrano connaturate ai coi quali si fondono ed insieme si trasfignl'cUlO in un clima di rara musicalità.
Le stesse diminl1zioni acquistano un espressivo indispensabiJe, nulla
meccanico e di vuoto esibizionismo v rtuosistico, nascendo da un empito di Len
sione espressiva, che si costruisce e calarlicamente si placa in que."ti lunghi giri di voce. Spontaneo, in questo caso, il riferimento a eerti Adagi pianistici beethoveniani, quali, a volte, ]e stesse mete espressive gono raggiunte in modo analogo. A questo stesso periodo ed a questo altissimo livello appartengono anehe il sesto, settimo, oliavo, undicesimo e dodicesimo madrigale.
È evidente in Luzzaschi il desiderio datOci anche un disegno storico dell'affermarsi di questo stile quale lo ereditò da Alfonso della Viola fino alle sue più alte conquiste. Ed è singolare che, malgrado il lasso di tempo intercorrente tra la redazione del primo e dell'u:ltimo brano, questa opera possegga una rara unitarietà spiritua. le, formale e sti1istica.
Unitarietà ancora più difficile da com;eguire se si pensa che in quest'opera confl scono, fondendosi mirabilmente, quasi gli stilemi della prassi composi tiva cinqueeentesca. Dalla Toccata organisti ca alla canzone polistmmentale, dalla Villanella al Madrigale ed alle più complesse forme madrigalismo come il Dialogo e l'Eco.
L'uso della citazione assai frequentc ba quasi sempre il carattere di ambien
tazione culturale c può spaziare da un nato accenno ad nn motivo di danza ad una formula melodica gregoriana. Il principio della variazione lo troviamo, di regola, piegato nelle sue forme fondamentali: va· riazione sopra una melodia e sopra una sueeessione armonica.
L'impiego del cromatismo, oculatamente misurato, avviene solo in direua p1'opo1'zlo,
Olbi, Haramente i Lesti poetici de] Guarini m;aLi in quest'opera corrispondono alle versioni a stampa. Si può quindi pensare che il poeta nisse a Lnzzasehi delle versioni che poi « lima·
ne alla necessità di sottolineare un aumento di tensione espressiva. Tutto, insomma, viene messo in opera per la costruzione di una forma nuova viva ed originale.
La ricorrenza di certo fare e il ripetersi e il contrapporsi di vari elementi ci fanno intravedere la preoccupazione e la consape· volezza di una nuova ristrntturazione formale. Questa viene raggiunta con rara indipendenza ed al difuori d'ogni meccanico procedimento in quanto si costmisce di volta in volta secondo esigenze tematiche e strutturali soggettive derivanti unicamente da ragioni di logica musicale.
Pcr conseguire queste sue mete formali e per aderire al contenuto poetico ed espressivo del testo, Luzzaschi si serve di tutti i mezzi possibili e « non schifa di por mano a dissonanze quantunque artificiose )) (Guarini), lo stesso testo poetico viene mutilato e manipolato secondo esigenze musicali 61bis.
L'atteggiamento mentale di Luzzaschi. per la verità non sempre indipendente dalla tradizione, raggiunge in quest'opera un grado di liberazione e di distacco raramente conseguiti da un musicista del suo tempo. Vero rappresentante del Rinascimento, per quanto partecipi concretamenle a quella ventata di Umanesimo che investÌ profondamente tutta la musica del Cinquecento, n011 perdé mai di vista che la musica, in fondo, doveva l'isolversi in termini musicali; in ciò sorretto da una podero5'a carica di innata
muslcalità. In quest'opera più che nei madrigali
a cinque voci - si deve identificare il più alto livello raggiunto dalla produzione di Luzzaschi. Qui il magistero di un'arte consumata si sposa all'originalità del pensiero (l'enerando delle costnlzioni cariche di ten· ~ione espressiva e di misurata grazia che ano cora oggi stupiscono per la loro vivace at·
tualità. Con questi madrigali ]0 abhiamo di·
mostrato - Luzzaschi influenzò in maniera determinante tutta la pratica del cantare a solo espressivo. Ad un altro livello, per
va» per le stampe o che invece, come ci sem· hra più probabile, siano nate in questo modo da una collahorazione concertata per meglio aderire alle esigenze musicali.
aspetti formali e contenutistici, influirà notevolmente sul suo miglior allievo: Girolamo Frescobaldi G~. Lo stesso Monteverdi che sicuramente conobbe Luzzaschi e la sua opera non si può dire che ignori certe atmosfere e certe inflessioni che troviamo nei più maturi madrigali di questa rac· colta 63.
Alla luce di queste nuove considerazioni la figura del maestro ferrarese viene ad acquisire una dimensione fin qui ignorala e malgrado che incomplete conoscenze storia che di contorno non ci consentano ancora di misurarne tutta la portata, nondimeno ah· biamo già sufficienti elementi per inll'<lW-
6~ Cfr. !'impianto toccatistico del Madrigale n. 5, così vicino alla Toccata frescobaldiana. Altri elementi di influenza su Frescobaldi potrebbero essere citati ma per ora basti rilevare la profonda suggestione che la toccante melodia del secondo madrigale « O Primavera» esercitò sul·
23
la non comune grandezza come arti. come maestro e come caposcuola che in
processo di rinnovamento del linguag. musicale della fine del Cinquecento eh.
un'importanza di primo piano.
Ferrara, dicembre 1964.
ADRIANO CAVICCHI
Ringrazio vivamente quanti hanno agevola preparazione di questo volume ed
modo particolare il Maestro Riccardo ed il Dottor Luciano Capra.
l'organista vaticano. Alle parole « ecco la prima,era » dal brano «Alla gloria» (in Ghirlandetta
morosa, Roma 1621 Robletti) Frescobaldi non riesce a sottrarsi da una chiara parafrasi della melodia luzzaschiana.
Cfr. madrigale n. 12.
CRITER EDITORIALI
Il testo della presente edizione è esemplalo sulla copia della stampa originale conservala presso la Biblioteca del Conservatorio di S. cilia in Roma il clJ.i frontespizio è il seguente: MADRIGALI/Di Luzzasco Luzzaschi per can· tare et sonare / A uno, e dai, e tre Soprani. Fatti I per la Musica del già Serenissimo / Duca Alfonso I d'Este / Stampati I In Roma presso Simone Verovio I 1601 / (Stemma dedicatario Cardinale Pietro Aldobrandini) /
Con licenza de' Superiori.
VoI. in folio di c. 1 + pp. 41, completamen
te inciso in rame. La notazione di quest'opera è in partitllra
con la parte del clavicembalo in intavola tu ra d'organo italiana di otto linee per la mano si· nistra e cinque per la destra. Come è noto la variabilità delle chiavi viene determinata dana tessitura: violino e mezzosoprano.hal·itono per tessiture acute; soprano e contralto hasso per tf~ssiture gravi. Non fanno eccezione le parti vocali che adottano la stessa chiave del rigo superiore della intavolatura. La presente edizione, secondo la prassi oggi comune, adotta esclusivamente le chiavi di violino e hasso. In essa i ,'a-10ri delle note si sono conservati inalterati.
In considerazione dell'estremo interesse riveste l'accompagnamento strumentale come esempio di scrittura cembalo-organistica del XVI secolo, se ne è conservata l'originale struttura
e suddivisione fra le due mani. La suddivisione delle hattute per quanto
quentemente irregolare, si è conservata secomlo la versione originale; si sono aggiunte, ino]! delle sharrette tratteggiate in corrispondenza gli (( a capo )) originali dove, spesso, è sottintesa
la sharra di battuta. Per lo scioglimento di alcune « ligatul'e)) si
è preferito usare, in luogo delle ormai tradizionali parentesi quadre, le legature di portamrmto. Ciò iper criterio di unitarietà in quanto ]0
stesso autore usa di volta in volta ora le ture tradizionali ora le moderne legature di
portamento.
Al fine di rendere più chiaro iI discorso fonico, si è fatto largo uso di pause fra parent,~si e di gambe tratteggiate negli unisoni.
Le alterazioni originali figurano davanti alle note, mentre quelle consigliate dall'editore 150-
no state apposte sopra o sotto alla nota cui si
24
riferiscono. Nei casi in cui ragioni di spazio im· pongano l'alterazione davanti alla nota, essa viene presentata fra parent;si quadre.
I raggruppamenti di note superiori alla croma sono stati di regola conservati come nell'originale; a volte, però, al fine di consentire al· l'occhio un più rapido orientamento per la sud· divisione, si è cercato di rilevare il raggruppamento o alla semiminima o alla croma.
Di ogni altro errore od omissione verrà dala ragione di volta in volta nell'Apparato Critico.
Il testo poetico sottoposto alla parte musicale è strettamente fedele all'originale; di esso viene data una aggiornata lezione in fine del volume. Delle concordanze testuali a noi note sarà data ragione nell'Apparato Critico.
Le parole del testo in corsivo rappresentano l'integrazione dove nell'originale si trovano i segni di ripetizione mentre quelle fra parentesi quadre contraddistinguono un'evidente lacuna dell'originale, oppure, una ripetizione consiglia. ta dall'editore su di un vocalizzo troppo esteso.
Ai fini di una esecuzione pratica, si è cercato di consigliare un movimento a tilolo puramente orientativo poiché, è evidente, questo tipo di musica non può stare soggetto ad una hattuta rigo·
rosa. Il più diretto erede di questa tradizione, Giro
lamo Frescobaldi, ce lo conferma: ( .. , non dee questo modo di sonare stare soggetto a baUuta, come veggiamo usarsi ne i l'r1 adrigali moderni, i quali quantunque difficili si agevolano per mezzo della battuta portandola hor languida, hor veloce, è sostenendola etiandio in aria secondo i loro affetti, o senso delle parole l). E poi ancora: «Quando si troverà un trillo della mano destra o vero sinistra, e che nello stesso tempo passeggierà l'altra mano non si deve compartire a nota per nota, ma solo cerca<r che il trillo sia veloce, et il passaggio sia portato men velocemente et affettuoso, altrimente fa. rebbe confusione» (cfr. l'avvertimento « Al lettore) premesso alla seconda edizione delle Tac· cate e partite d'intavolatura di cimbalo, libro primo, Roma 1615 [-1616], N. Borhoni).
Altri utili consigli, oltre a questi, riguardanti il movimento e l'esecuzione di certi tipi di cadenze, si trovano premessi alle opere dell' orO'anista ferrarese. Un interessante compendio " deO'li «( avvertimenti)) frescohaldiani si trova e
nella Prefazione redatta da O. Mischiati e L. F. Tagliavini al volume: G. Frescobaldi, Nove
toccate inedite, a cura di S. Dalla Libera. BreBda 1962, L'Organo. Biirenreiter, p. VI e segg.
APPARATO CUITICO
Le parti vocali saranno contraddistinte nel mo
do seguente: Canto I, Canto II e Canto III. Le varie voci
della parte clavicembalistica si varranno della usuale nomenclatura polifonica: S.A.T.B.
A UNO SOPRANO
L Aura soave
Testo di ignoto. Clavicembalo, batto l, entrata dell'A. (Ia3
)
nell'originale erroneamente di due quarti. Movimento consigliato: Andante (una mini· ma ogni movimento) dal 3/2 Allegro (una semibreve ogni movimento).
2. O Primavera
Testo di G. B. Guarini, Pastor Fido, Atto Terzo, scena I.
Canto I, batt. 12: le prime quattro note sono erroneamente notate biscrome nell'originale, così come a batto 18, sempre Canto I, le prime quattro note sono erroneamente semicrome.
Movimento consigliato: Andante mosso (una minima ogni movimento) dal 3/2 Allegro, in due (tre minime ogni movimento), dal C Andante.
3. Ch'io non t'ami
Testo di G. B. Guarini, Rime, Venezia 1621 Ciotti, pp. 296, con la didascalia A mor costante, LXXXIV. Canto I, balì. 36: il penultimo gruppo di note è erroneamente notato in semicrome. Movimento consigliato: Moderato (una minima ogni movimento).
A DOI SOPRANI
4. Stral pungente d'amore
Testo d'ignoto$ Canto I, batto 23: quarta nota integrata per analogia al medesimo passo di batto 11, Can·
25
to II. Cembalo, bat. 33: il secondo accordo della mano destra nell'originale è mi3 si bemolle3 re4 (il mP semibreve): ciò, per quanto vicino allo spirito della composizione, è da ritenersi errato.
Movimento consigliato: Andante molto e· spressivo.
Deh vieni ormai cor mio
Testo di ignoto.
Canto II, batto 7: quinta nota nell'originale erroneamente semiminima.
Canto I, batt. 15: le prime due note in originale sono notate come semiminime e sono state corrette sulla base della parte del cembalo e della risposta imitativa del Canto II. Canto I, batto 31: la nona nota (d04
) nel· l'originale è notata come semiminima. Cembalo, batto 40: A. integrato per simili tudine al medesimo passo di batt. 48. Movimento consigliato: Moderato.
Cor mio, deh non languire
Testo di G. B. Guarini, Rime cit. p. 296 con la didascalia Pietà dolente LXXXIII. Canto II, batto 39: la quartina di biscrome nell'originale è erroneamente notata in semi· crome. Cembalo, integrazioni di pause a battute: 15, 27 e 28. Movimento consigHarto: Adagio ma> non troppo.
l' mi son giovinetta
Testo di ignoto. L'incipit è una citazione da un noto sonetto di Petrarca. Cembalo, batt. 6: la seconda nota del T. (mi3 alla mano destra) è erroneamente no·
tato come semibreve. Canto II, haLL 9: la terza 110ta è notata co· me biscroma. Canto I hatt. 12: manca la pausa. Cemhalo, hatL 38: il si mancante alla parte A. è stato integrato in analogia a hatt. 28.
Canto H batto 40: la seconda pausa iniziale di croma è erroneamente di semiminima. Canto H batL 45: la seconda quartina di biscrome è notata in semiminime. Movimento consigliato: Moderalmnen[(! mosso.
A TRE SOPRANI
8. O dolcezze amarissime d'amore
Testo di G. B. Guarini, Pastor Fido, Alto Terzo, scena I (solo incipit.). Canto H batto 15: le note 18 c 19 (fa:! di croma è erroneamente di semiminima.
Canto H batto 24: integrata una pausa. Cembalo, si sono integrate pause a battute 6, 8, 14, 20, 25 e 27. Movimento consigliato: Anelante.
9. Troppo ben pub
Testo di G. B. Guarini, Rime cito p. 303 con la didascalia Fuga restia CVIH. Cembalo batto 52 voce del T.: minima col punto in analogia al medesimo passo di halL 45. Movimento consigliato: Andantino.
lO. T'amo mia vita
Testo di G. B. Guarini, Rime ciL p. 291 con la didascalia Parola di donna amante LXX. Canto Hl pause integrate a batto 2 e 27.
Cembalo batto 21, A.: manca il punto. Ccmbalo, integrate pause a battute 24 e 25. Cembalo, batto 28: secondo accordo in origi. naIe crroncamente do~.mia.sol".d04; ricostrui.
to l'aecordo perfetto di fa in analogia al medesimo passo di batto 33. Movimento consigliato: Andante.
Il. Non sa che sia dolore
Testo di G. B. GuarÌni, Rime cito p. 298 con l a didascalia Partita dolorosa CI. Cembalo, integrate pause a batto 7, 21 e 39. Movimento consigliato: Adagio ma non troppo.
12. Occhi de1 pianto mio cagione
Testo di ignoto. Canto H hatt. 7: nell'miginale il primo la è notato come si. Canto H hatt. 25: quarta nota (do') nell'ori. ginale è erroneamente notata come semi· hreve. Canto II a haLt. 45: le prime due note (sol4 la') nell'originale sono notate come semi· crome. Cemhalo, integrate pause a hattute: 7, 15, 26, 27, 29 e 40. A battuta 2 la diversa disposizione della par. te del cembalo autorizza la supposizione che il do"! sia bequadro e ciò in armonia col
carattere cromatico del brano. Movimento consigliato: Andante.