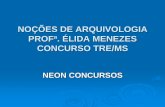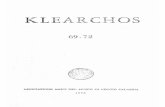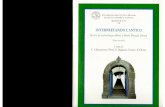Tre annotazioni al "Tesoretto"
Transcript of Tre annotazioni al "Tesoretto"
Direttori · EditorsSimone Albonico (Lausanne) · Lucia Bertolini (Novedrate, eCampus)
Stefano Carrai (Siena) · Vittorio Formentin (Udine)Paolo Trovato (Ferrara)
*
Comitato di lettura · RefereesGino Belloni (Venezia) · Saverio Bellomo (Venezia)
Guido Capovilla† (Padova) · Paolo Cherchi (Chicago)Claudio Ciociola (Pisa, Scuola Normale Superiore)
Luciano Formisano (Bologna) · Guido Lucchini (Pavia)Livio Petrucci (Pisa) · Marco Praloran† (Lausanne)
Brian Richardson (Leeds) · Francisco Rico (Barcelona)Claudio Vela (Cremona-Pavia) · Massimo Zaggia (Bergamo)
Tiziano Zanato (Venezia)
*
Redazione · Editorial AssistantFabio Romanini (Trieste)
*
I saggi pubblicati da «Filologia Italiana» sono stati precedentemente sottopostia un processo di peer-review e dunque la loro pubblicazione presuppone:
a) il parere favorevole di tutti i direttori;b) l’esito positivo di una valutazione anonima commissionata dalla direzione a due esperti,
scelti anche al di fuori del comitato di lettura.
*
«Filologia Italiana» is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.
Classificazione anvur: a.
*
Per la migliore riuscita delle pubblicazioni si invitano gli autori ad attenersi, nelpredisporre i materiali da consegnare alla Redazione ed alla Casa editrice, alle norme
specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali,Pisa-Roma, Serra, 20092 (ordini a: [email protected]).
Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabileonline alla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net.
TRE ANNOTAZIONI AL «TESORETTO»
Marco Berisso*Università di Genova
1. Il Tesoretto doveva essere un prosimetro?
om’è noto, il Tesoretto di Brunetto Latini è un testo incompiuto:1 evidentementeincompiuto, dal momento che si blocca improvvisamente sul distico formato dai
vv. 2943-2944 con cui l’autore prepara l’avvio del discorso mancato di Tolomeo («E eicon belle risa|rispuose in questa guisa»).2 Questa interruzione ex abrupto non ha man-
* [email protected] Molto meno chiaro è il perché Brunetto abbia smesso di lavorare al poemetto (probabilmente non
ricevibile, per le ragioni di cronologia cui si accennerà qui di seguito, l’ipotesi di Elio Costa che il Teso-retto venga abbandonato per una sopravvenuta sfiducia nei confronti dello strumento allegorico-poeticoe per la conseguente decisione di dedicarsi al Tresor: Costa 1987, in particolare le pp. 51-52): l’interruzio-ne (come quella del volgarizzamento del De inventione) sarà forse da addebitare ai sopravvenuti e inten-sissimi impegni politici in cui Brunetto fu coinvolto di ritorno dall’esilio francese?
2 Per il testo del Tesoretto faccio sempre riferimento (fatte salve le discrepanze che verranno segnala-te in nota e per le ragioni delle quali si veda sotto) all’edizione curata da Gianfranco Contini sulla basedel lavoro preliminare fornito da Giovanni Pozzi ed apparsa in Contini 1960, ii, pp. 175-277. Nelle pagineche seguono si terrà conto anche delle altre edizioni del poemetto (Zannoni 1824, Wiese 1883 – e si vedaanche Wiese 1910 –, Bolton Holloway 1981). Per i manoscritti del Tesoretto utilizzerò le seguenti sigle, in-trodotte da Wiese 1883, recuperate (con una piccola modifica) da Contini 1960, ribadite nella sostanzadalla Bolton Holloway 1981 e da considerare dunque ormai convenzionali: B (= Brescia, Biblioteca Civi-ca Queriniana, A vii 11, prima metà del xiv secolo), C (= Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Chi-giano L v 166, prima metà del xiv secolo), C1 (= Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Chigiano Lvii 249, primo quarto del xiv secolo), C2 (= Roma, Biblioteca Corsiniana, 44 g 3, prima metà del xiv se-colo), F (= Bruxelles, Bibliothèque Royale, 14614-14616, prima metà del xiv sec.), G (Firenze, BibliotecaMedicea Laurenziana, 90 inf. 47, xiv sec. ex.), L (= Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 40 45, pri-ma metà del xiv secolo), M (= Firenze, Biblioteca Centrale Nazionale, Magliabechiano vii 1052, secon-da metà del xiv secolo), N (= Firenze, Biblioteca Centrale Nazionale, Palatino 387, primo quarto del xivsecolo), R (= Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2908, xiii secolo ex.-xiv secolo in.), S (= Firenze, BibliotecaMedicea Laurenziana, Strozzi 146, primo quarto del xiv secolo) e Z (= Venezia, Biblioteca NazionaleMarciana, It. Zanetti 49 [= 4749], xvi secolo). Di questi codici ho collazionato, per le pagine che segui-ranno, direttamente M e Z, su riproduzione e poi verificato direttamente B, C, C1, G, L e N, su riprodu-zione digitalizzata C2 e R, sulla riproduzione fotografica a stampa (Bolton Holloway 2000) S. La colla-zione di F è stata effettuata per me sul codice dall’amico Franco Vazzoler che qui ringrazio di cuore.
«filologia italiana» · 11 · 2014
Questo saggio vuole: 1. dimostrare la plausibi-lità dell’ipotesi tradizionale che immaginavaper il Tesoretto di Brunetto Latini un’originariastruttura di prosimetro; 2. indagare il rappor-to presente nella tradizione manoscritta tra ilTesoretto, la sezione di questo intitolata in alcuni codici Penetenza e il Favolello; 3. propor-re il ritorno ad alcune lezioni del codice base Rscartate nell’ed. Contini-Pozzi.
This essay aims: 1. to prove the plausibility ofthe traditional hypothesis believing in an earlyprosimetrum structure of the Tesoretto byBrunetto Latini; 2. to investigate the relation-ship between the Tesoretto, the section whichsome manuscripts refer to as the Penetenza andthe Favolello; 3. to propose the reinstatementof some lessons of the base code R, which hadbeen discarded in Contini-Pozzi edition.
C
16 marco berisso
cato di apparire problematica agli editori. Contini, ad esempio, verificando l’analogo av-vio quasi in medias res (o verba) del Favolello, affermava:
Non si può dire che come iniziali queste parole riescano in tutto persuasive; così da legittimareforse l’ipotesi che il testo ci sia giunto acefalo (e poiché il Favolello normalmente tien dietro al Tesoretto, tronco in fine – benché indubbiamente imperfetto per altri indizî, che si ricavano dalleallusioni alle parti in prosa, mancanti –, codesta ipotesi potrebbe promuoverne una seconda,quella d’una lacuna intervenuta nell’archetipo a cavallo dei due poemetti).1
È ben vero che nel seguito del discorso lo studioso tende a limitare la portata dell’af-fermazione,2 fatto sta che però l’evidenza della interruzione tien dietro, come si vede,a una più generale diagnosi di incompletezza verificabile in prima istanza proprio nel-l’assenza delle previste «parti in prosa». Contini riprendeva infatti un’ipotesi affacciatagià dall’editore ottocentesco del poemetto, Giovan Battista Zannoni, il quale arrivava aimmaginare una forma prosimetrica le cui sezioni prosastiche fossero state però trala-sciate dai copisti dal momento che esse erano «ripetute presso che a parola nel Tesoro»(cioè nel Tresor).3 A riprova di ciò Zannoni sottolineava una serie di passi in cui Brunet-to allude a difficoltà espositive intrinseche al dettato in versi e promette pertanto di for-nire maggiori chiarimenti in «prosa». Conviene citarli direttamente, con qualche breveparola introduttiva che li contestualizzi:
i. Siamo all’interno del primo discorso di Natura, che ha appena spiegato a Brunetto il ruolo de-stinatole da Dio e come Dio stesso possa infrangere le leggi naturali, come accaduto in occasio-ne dell’Immacolata Concezione e della Resurrezione. A questo punto cade il passo che c’inte-ressa (vv. 395-426):
E perciò che ’l me’ direio lo voglio ischiarire,sì ch’io non dica mottoche tu non sappie tutto4la verace ragionee la condizïone,farò mio detto piano,che pur un solo granonon sia che tu non sacci:ma vo’ che tanto facci,che lo mio dire aprendi,sì che tutto lo ’ntendi;e s’io parlassi iscuro,ben ti faccio sicurodi dicerlo in aperto,sì che ne sie ben certo.Ma perciò che la rimasi stringe a una limadi concordar parolecome la rima vuole,
1 Contini 1960, ii, p. 278.2 «O forse il detto, che vuol provocare l’attività poetica di Rustico (149-153: “E ciò che scritto mando|è
cagione e dimando|che ti piaccia dittare|e me scritto mandare|del tuo trovato adesso”), è già respon-sivo (in 2 di scritte vale ‘per parole, autorità scritte’ e pruove è congiuntivo?), e la proposta caduta rende-rebbe superflua l’ipotesi precedente» (ivi).
3 Tutto il ragionamento (il cui obiettivo primario è in realtà quello di separare nettamente il Favolel-lo dal Tesoretto) si trova in Zannoni 1824, pp. xlvii-lii. 4 Contini 1960: «’n tutto».
tre annotazioni al «tesoretto» 17
sì che molte fiatele parole rimateascondon la sentenzae mutan la ’ntendenza,quando vorrò trattaredi cose che rimaretenesse oscuritate,con bella brevetateti parlerò per prosa,e disporrò la cosaparlando in volgare,1che tu intende ed apare.
ii. È la conclusione del primo discorso di Natura. Dopo aver sommariamente esposto a Brunet-to alcune nozioni di fisiologia e cosmologia («t’aggio contato|una lunga matera|certo in brevemanera», come dice appunto ai vv. 880-882) e averlo esortato per il resto a credere «veracemen-te|ciò che la Chiesa Santa|ne predica e ne canta» (vv. 900-902) Natura rinvia a un momento fu-turo in cui verranno esposte altre nozioni di astronomia e fisica (vv. 903-914):
Apresso t’ho contatodel ciel com’è stellato,ma quando fie stagioneudirai la cagionedel ciel com’è ritondoe del sido del mondo.Ma non sarà pe·rima,com’è scritto di prima,ma per piano volgareti fie detto l’affaree mostrato in aperto,che ne sarai ben certo.
iii. Brunetto sta descrivendo quello che ha visto seguendo nel suo viaggio Natura (è la sezionegeografica del poemetto). In conclusione dichiara di aver visto «di ciascuno animale|e lo bene elo male|e la lor condizione|e la ’ngenerazione|e lo lor nascimento|e lo cominciamento|e tut-ta loro usanza,|la vista e la sembianza» (vv. 1105-1112) e di aver deciso di parlare di tutto questo.Qui cade il terzo dei passi in questione (vv. 1116-1124):
Non dico ch’io m’afididi contarlo pe·rimadal piè fin a la cima,ma ’n bel volgare e puro,tal che non sia oscuro,vi dicerò per prosaquasi tutta la cosaqua ’nanti da la fine,perché paia più fine.
iv. Il poemetto sta per finire. Conclusa la sua penitenza, Brunetto si rimette in viaggio e rag-giunge il monte Olimpo. Prima di raccontare l’incontro con Tolomeo precisa (vv. 2900-2910):
E qui lascio la rimaper dir più chiaramenteciò ch’i’ vidi presente:ch’io vidi tutto ’l mondo,
1 Ivi: «parlandoti»
18 marco berisso
sì com’egli è ritondo,e tutta terra e mare,e ’l fuoco sopra l’âre;ciò son quattro aulimenti,che son sostenimentidi tutte crëaturesecondo lor nature.
I quattro estratti hanno evidentemente una medesima articolazione concettuale e sonocaratterizzati addirittura dal ricorrere delle stesse spie lessicali. Le polarità in questionesono quelle dell’oscurità preterintenzionale causata dalle costrizioni del discorso in ri-ma e, per contro, della chiarezza del discorso in prosa. La prosa, in particolare, è carat-terizzata dall’essere ‘piana’, cioè priva delle artificiosità del verso (vv. 411, 911; assimila-bile «puro» del v. 1119), e ‘chiara’, cioè senza ambiguità («dicerlo in aperto|sì che ne sieben certo»: vv. 419-420 praticamente ricalcati ai vv. 913-914: «e mostrato in aperto|chene sarai ben certo»; «più fine»: v. 1124; «più chiaramente»: v. 2901). Inoltre questa prosasarà in «volgare» (vv. 425, 911) e, cosa abbastanza notevole (seppure mi pare sia sfuggitaai commentatori), avrà una «bella brevetate» (v. 422: quindi delle integrazioni sintetiche,non un vero e proprio commento disteso come quello esperito per esempio dallo stessoBrunetto sul De inventione). Particolarmente interessanti, da un punto di vista formale,i passi i-ii, collocati in prossimità e, soprattutto, così simili da far quasi sospettare che ilsecondo rappresenti una versione scorciata del primo.1 Nel complesso, comunque, siamo nell’ambito di un discorso ben collaudato: basti ricordare If xxviii, 1-3,2 in cuiDante dichiara l’impossibilità di restituire l’orrore della bolgia dei seminatori di scismapur se avesse a disposizione il ben più duttile strumento della prosa o, per contro, la di-chiarazione con cui Guittone d’Arezzo conclude la canzone Altra fiata aggio già, donne, parlato ai vv. 159-170, dove l’oscurità è dovuta al concorrere di abbondanza di «ragione»e di costrizioni metriche.3 Dunque Brunetto dichiara di voler ricorrere a una «prosa»per esprimere più chiaramente ciò che in versi risulterebbe di difficile fruizione: da qui l’opinione di Zannoni,4 poi appunto ripresa da Contini, che il Tesoretto fosse stato pro-
1 Oltre alla concordanza tra i vv. 419-420 e 913-914 prima ricordata, il secondo passo (più breve) ripetedel primo anche le rime -ima (e il rimante rima: rispettivamente vv. 421-422 e 909-910) e -are (e il rimantevolgare: rispettivamente vv. 425-426 e 911-912), così da risultare quasi (e, per l’apparato delle rime, total-mente) costruito con materiali di riporto dal primo. In linea generale, i vv. 395-426 appaiono in effetti er-ratici rispetto al contesto in cui sono collocati: perché mai infatti Natura dovrebbe pronunciare quellache è una vera e propria dichiarazione di poetica proprio in quel punto? Sembra qui di trovarci di fron-te (sia detto con tutte le cautele del caso) ad una sorta di ‘scheda’ fuori posto, una prima stesura dilatatadel passo poi ripescato ai vv. 909-914.
2 «Chi poria mai pur con parole sciolte|dicer del sangue e de le piaghe a pieno|ch’i’ ora vidi, per narrar più volte?».
3 «Ditt’aggio manto e non troppo, se bono:|non gran matera cape in picciol loco.|Di gran cosa dirpoco|non dicese al mestieri o dice scuro.|E dice alcun ch’è duro|e aspro mio trovato a savorare;|e poteessere vero. Und’è cagione?|che m’abonda ragione,|perch’eo gran canzon faccio e serro motti,|e nullafiata tutti|locar loco li posso; und’eo rancuro,|ch’un picciol motto pote un gran ben fare» (cito la canzone da Egidi 1940, p. 135). Maffia Scariati 2010a, p. 76, ricorda anche la concordanza tra il v. 426 di Brunetto e Tuttor s’eo veglio o dormo, 63 («a chi s’entend’ ed ame») in un contesto assimilabile (lì l’aretinorivedicava la propria scelta per il trobar clus). Ricordo che l’opposizione tra la «voie […] large et pleniere»della prosa e il «sentier […] plus estrois» della poesia è il punto cruciale in cui Brunetto identifica la soladifferenza tra i due generi del discorso in Tresor iii 10 (che cito da Beltrami e a. 2007, p. 654).
4 Che sarà ribadita da Petronio («Probabilmente Brunetto pensava di aggiungere al poemetto uncommento in prosa, come fece più tardi Francesco da Barberino per i Documenti d’Amore»; Petronio 1951,
tre annotazioni al «tesoretto» 19
gettato come misto di prosa e versi, cosa non improbabile in linea di principio, tenen-do anche conto delle conclamate adiacenze tra il testo brunettiano e due prosimetri come la Consolatio Philosophiae di Boezio da un lato e il De Planctu Naturae di Alano diLilla dall’altro.1
Questa ipotesi, che sembrava passata in giudicato, è però stata da ultimo revocata indubbio da Irene Maffia Scariati all’interno del suo fondamentale studio su Brunetto e ilTesoretto. Il punto nodale del lavoro della Scariati è in realtà un altro e riguarda prima-riamente il rapporto cronologico tra Tresor e Tesoretto, un rapporto che la studiosa, ap-profondendo spunti avanzati da Pietro Beltrami e dilatando la ricerca anche ad altriaspetti di ordine cronologico e compositivo, pensa di poter spostare convincentemen-te agli anni successivi al ritorno a Firenze di Brunetto, e quindi posteriormente al Tre-sor.2 Nel contesto di questa interpretazione, la Scariati si sofferma anche sulla sostanzadi quella «prosa» che abbiamo appena visto menzionata nel poemetto: la sua opinionein merito è che in tutte quelle occasioni «Brunetto rinvii al volgare francese della prosadel Tresor».3 In questa direzione la studiosa viene persuasa da una serie di sistematicheosservazioni che cercherò qui di seguito di riassumere il più possibile fedelmente.
a) La menzione da parte di Brunetto del «volgare» nelle occorrenze i-ii-iii mal si spie-gherebbe «in un testo ad ogni modo volgare come il Tesoretto»,4 a meno che esse non ri-sultino riferite ad un volgare altro rispetto a quello di sì. In caso contrario «risulta […]molto ridondante l’insistenza su una prosa esplicativa, fatta o da farsi che sia, in volga-re italiano per chiarire un testo in volgare italiano, la prosa essendo già da sola un mez-zo più accessibile di un testo in versi». Allo stesso modo l’accenno al volgare non si puòconsiderare come opposto al latino dal momento che una «prosa latina […], per sua na-tura, sarebbe rivolta a un pubblico più alto di quello che può accedere al Tesoretto».5
b) Nel caso di ii Contini annotava nella sua edizione: «Allusione possibile al c. 104 deli libro del Tesoro, “Comment li mondes est reont et comment li quatre element sontestabli”; ma cfr. la nota a 1121».6 Questa possibilità viene giudicata dalla Scariati «raffor-zata dalla variante fue del v. 912» leggibile in R e in M.7
p. 72) e, dopo Contini e seppur mitigato da un «forse», anche da Ciccuto in nota al v. 423 nella sua edi-zione commentata del Tesoretto (peraltro l’ultima sin qui edita del nostro testo): «è forse celato qui il pro-posito di fare del Tesoretto un prosimetrum (come confermerebbero poi i luoghi intorno ai vv. 1121 e 2900)sul modello anche boeziano» (Ciccuto 1985, p. 156).
1 Su questi rapporti si vedano Jauss 1964 (1989) e Costa 1987.2 Che il Tesoretto precedesse il Tresor era invece opinione di Sundby 1869 (1884), p. 37. Contini pensa-
va «a uno svolgimento contemporaneo, magari per intermittenza, d’un medesimo assunto» (Contini1960, ii, p. 173). Pietro Beltrami ha argomentato la sua opinione circa la posteriorità del poemetto in Beltrami 1993, in particolare alle pp. 134-38 (più in sintesi Beltrami 1994, pp. 318-19): per lui il Tesoretto vacollocato al 1273-1274 «quando, con l’incoronazione di Rodolfo d’Asburgo, Alfonso X di Castiglia perde-va la speranza di essere incoronato imperatore, e Brunetto non avrebbe più potuto scrivere: “esso co-mune saggio,|mi fece suo messaggio|all’alto re di Spagna|c’or è re de la Magna|e la corona atende,|seDio no·llil contende”» (Beltrami 1993, p. 136). La Maffia Scariati pensa invece di poterlo anticipare conbuoni argomenti di un paio d’anni, «a quei mesi di grandi incertezze e aspettative tra il primo settembre1271 e l’aprile del 1272» (Maffia Scariati 2010a, p. 45: si veda in merito tutto il primo capitolo del volume,pp. 25-54, apparso anche in Maffia Scariati 2010b).
3 Maffia Scariati 2010a, p. 108. 4 Ivi, p. 76.5 Per questa e la citazione immediatamente precedente si veda Maffia Scariati 2010a, p. 107.6 Contini 1960, ii, p. 207.7 Maffia Scariati 2010a, p. 104, nota 39. La Scariati fa peraltro notare giustamente che la lezione fie pre-
sente a testo tanto in Wiese 1883 quanto in Contini 1960 risulta in realtà «non attestata nei codici» (ivi).
20 marco berisso
c) Al v. 425 R legge parlando un volgare, lezione che troverebbe conferma in quella pa-rallela di M consifatto v. (e il distico suonerebbe quindi «parlandoti un volgare|che tu in-tende ed apare»). Questo elemento (occultato nell’edizione, dove si stampa «parlando-ti in volgare») acquisterebbe particolare significato in un testo il cui dedicatario èappunto un francofono come Carlo d’Angiò.1
d) «Depone peraltro nettamente a favore dell’ipotesi che la prosa a cui allude il Teso-retto sia quella del Tresor anche il distico finale del solo ms. Queriniano, che segue, do-po uno stacco bianco, gli ultimi due versi tràditi dagli altri codici (vv. 2943-2944), con ri-chiamo al v. 1356 (“ne la lingua franzese”): E ei con belle risa|rispose in questa guisa||chelgran thesor devisa|in la lingua francisa (B, c. 44v)».2
L’ipotesi, come si vede, è particolarmente suggestiva e ben articolata: la prosa non ri-sulterebbe assente ma si tratterebbe molto più semplicemente di un altro testo. E d’al-tra parte, lo ricordiamo, lo stesso Zannoni aveva immaginato che queste parti in prosanon sarebbero state altro che un volgarizzamento del Tresor e Thor Sundby ipotizzava«che i copisti in epoca posteriore, allorchè il Tresors era già stato tradotto in italiano, nonabbiano creduto prezzo dell’opera il trascriverlo» dal momento che «il brano avrebbedovuto essere alquanto lungo».3 Nondimeno, credo che l’idea della Scariati sia alla finfine da respingere e che perciò la natura di prosimetro ‘virtuale’ del Tesoretto vada ri-proposta. Vediamo quali sono le possibili controbiezioni che credo si possano muoverealle quattro proposte della Scariati.
a) È questa l’obiezione della studiosa che a tutta prima risulta più convincente. Perchémai Brunetto dovrebbe specificare che la sua prosa sarà in volgare? La risposta in realtàè piuttosto semplice ed è proprio quella che la Scariati respinge nettamente: qui Bru-netto vuole preventivamente rassicurare il proprio lettore circa il fatto che la prosa nonsarà in latino. Credo che qui non si debbano sovrapporre due serie di opposizioni che deltutto sovrapponibili non sono, ossia quella verso/prosa e quella volgare/latino. Un te-sto in prosa sarebbe stato infatti inevitabilmente e di per sé più «chiaro» (per riprendereun aggettivo brunettiano) di quello in versi, a prescindere dalla lingua utilizzata, perchénon sottoposto all’artificiosità della rima e del ritmo e alle conseguenti torsioni che essiobbligano ad assumere per quanto attiene alla sintassi. Del resto, non diversamente lapensa alcuni decenni dopo Dante, quando ritiene che abbinare la prosa del commentodel Convivio ai versi delle canzoni commentate sia in sé comunque un chiarimento, e soloin un secondo momento del primo trattato sente di dover giustificare il perché quellaprosa sarà in volgare anziché in latino. E si pensi anche a un testo per certi aspetti avvi-cinabile al Tesoretto come i Documenti d’amore di Francesco da Barberino, dove alla prosalatina è appunto devoluto il ruolo non solo di commentare, ma in prima istanza di parafrasare i versi volgari.4 Pare inoltre del tutto inverosimile che Brunetto potesse usareil termine «volgare» per indicare qualcosa d’altro dal volgare di sì:5 tant’è vero che
1 Maffia Scariati 2010a, p. 107. 2 Maffia Scariati 2010a, p. 108.3 Sundby 1869 (1884), p. 33. Come si diceva sopra, è più probabile invece che le prose, stando a quanto
dice Brunetto stesso, sarebbero state caratterizzate da «brevitate».4 L’edizione di riferimento è Egidi 1905-1927.5 Va peraltro aggiunto che non risulta dalle moltissime occorrenze desumibili dal corpus tlio che
volgare possa indicare altro dalla lingua in cui si scrive o parla e che in accezione generale risulta sempreopposta a latino o grammatica. Fa solo apparente eccezione questo passo della Composizione del mondo diRestoro d’Arezzo (ii 7 4): «Adonqua per magiure operazione e per magiure diversità de rascione deano
tre annotazioni al «tesoretto» 21
nell’unico caso sicuro in cui egli rinvia senza ombra di dubbio al Tresor si sente in obbli-go di specificare che l’enciclopedia era scritta «ne la lingua franzese» (v. 1356). Anche ilpasso della Rettorica ricordato dalla Scariati («Cosìe usatamente adviene che due perso-ne si trasmettono lettere l’uno all’altro o in latino o in proxa o in rima o in volgare o innaltro, nelle quali contendono d’alcuna cosa, e così fanno tencione»),1 anziché sorregge-re l’idea che il termine possa indicare indifferentemente qualsiasi lingua romanza fa semmai capire, direi senza ambiguità, che per il nostro autore il «volgare» senza agget-tivi è appunto il fiorentino opposto all’«altro». È questo del resto il significato che ha iltermine non solo ai vv. 2372-2375, dove, come chiarisce la Scariati, serve a segnalare chele parole di Ovidio non sono, come appunto ci si aspetterebbe, in latino («Ed elli in buo-na fede|mi rispose ’n volgare|che la forza d’amare|non sa chi no lla prova»),2 ma pro-babilmente anche nell’altra occorrenza del lemma, quella ai vv. 1272-1274 («Qui demoraProdenza,|cui la gente in volgare|suole Senno chiamare»), dove vuole sottolineare laresa appunto in volgare del latinismo prudentia.3 Insomma, quello che Brunetto Latinivoleva dire è che la prosa sarebbe stata in italiano e non in latino: e questo proprio per-ché il lettore ideale del Tesoretto era un lettore di testi volgari, non lontano da quello acui era destinato il Tresor.4
b) L’annotazione di Contini credo non vada forzata oltre quello che esplicitamente è,ovvero il rimando a un’«allusione possibile»; ed anzi credo, a dirla tutta, che sia persinoin qualche modo fuorviante e che quindi non ci sia motivo di pensare qui al Tresor. Nelpasso ii noi abbiamo in effetti rappresentata un’anticipazione di quella perduta sezionefinale del testo in cui Tolomeo avrebbe dovuto prender la parola. Quando infatti Natu-ra afferma, ai vv. 903-904, che ha «contato|del ciel com’è stellato» si riferisce ai vv. 837-876 (miei i corsivi):
Ben dico veramenteche Dio onnipotentefece sette pianete,ciascuna in sua parete,
èssare e·llo mondo diverse lingue e diverse operazioni de voci e de parlare per lèttara e per vulgare; eemperciò trovamo lettera greca e lèttara latina e lèttara ebraica e molte altre; e de le genti avere vulga-re e parlare che non entende l’uno l’altro, come so’ Greci, e Ermini, e Tedeschi, e Latini, e Saracini e mol-ti altri. E questo è per magiure operazione, en tale modo che l’altissimo Deo per magiure grandezza sialaudato e glorificato per diverse lingue». Qui sembrerebbe che il termine vulgare indichi genericamentele lingue altre rispetto al latino (Latini infatti signica qui ‘romanzi’): in realtà qui si parla di una differen-ziazione tra lingue ‘regolate’ e lingue ‘non regolate’ e vulgare va ad opporsi a lèttara proprio su questopiano. Per il resto, in tutti gli altri casi se il «volgare» non è ulteriormente specificato indica la lingua scrit-ta/parlata dall’autore di volta in volta in questione (a partire dallo stesso Brunetto della Rettorica: «Quicomincia lo ’nsegnamento di rettorica, lo quale è ritratto in vulgare de’ libri di Tullio e di molti filosofiper ser Burnetto Latino da Firenze»: Maggini 1968, p. 3).
1 Maggini 1968, p. 146. Il testo in questo punto non è tra l’altro scevro da problemi di ordine filologi-co, dal momento che l’autorevole coppia M1 L omette proprio «inn altro» (sulla questione si veda quan-to dice Maggini ivi). 2 Maffia Scariati 2010a, p. 107.
3 Ancora Dante nel Convivio preciserà che «Bene si pone Prudenza, cioè senno, per molti, essere mora-le vertù» (IV xvii 8). E del resto lo sottolineava già Zannoni, commentando la variante di M la gente vol-gare: «cangiamento fatto con avviso stoltissimo, perocchè la voce Prudenza è a ragione da chiamarsi lati-na; e la voce senno n’è veramente la traduzione» (Zannoni 1824, pp. 107-8).
4 Generica sarà l’assonanza segnalata da Maffia Scariati 2010a, p. 107, tra la formula «bel volgare e pu-ro» e la definizione di «parleure […] plus delitable et plus comune a touz languaiges» data al francese nelprologo del Tresor (i.1.7; Beltrami e a. 2007, p. 6): vedi per es. al v. 154 la «dolce lingua e piana» con cui con-versano Brunetto e l’anonimo «scolaio» bolognese.
22 marco berisso
e dodici segnali(io ti dirò ben quali);e fue il Suo voleredi donar lor poderein tutte crëaturesecondo lor nature.Ma sanza fallimentosotto meo reggimentoè tutta la loro arte,sicché nesun si partedal corso che li ho dato,è ciascun misurato.1E dicendo lo vero,cotal è lor mistiero,che metton forza e curain dar fredo e calurae piova e neve e vento,sereno e turbamento.E s’altra provedenzafue messa i·llor parvenzano ’nde farò menzione,ché picciola cagioneti porria far errare:ché tu déi pur pensareche le cose future,e l’aperte e le scure,la somma Maestateritenne in potestate.Ma se di storlomiavorrai saper la via,de la luna e del solecome saper si vuole,e di tutte pianete,qua ’nanzi l’udirete,andando in quelle partedove son le sette arte.2
Dunque Brunetto rinvia i dettagli sulle questioni astronomiche al momento dell’in-contro con Filosofia e le «sette arte»,3 a un futuro in cui «dirà» ciò che viene qui accen-nato. Questa promessa di Natura è ricordata e ribadita a ii ed è perciò a maggior ra-gione rilevante che si preannunci qui una prosa che verrà nuovamente annunciata almomento opportuno in iv. Che poi quella prosa potesse essere una riscrittura più o me-no rimaneggiata e in volgare del capitolo ricordato da Contini è probabile e del restoesplicitamente affermato da Brunetto stesso, quando preannuncia che parlerà in prosadel «mondo,|sì com’egli è ritondo» e dei «quattro aulimenti». Non solo non c’è dunque
1 Contini 1960: «a ciascun misurato».2 Non è del tutto vera, dunque, l’affermazione della Scariati secondo cui «il Tesoretto non ha trattato
la materia del cielo stellato, la sola allusione nell’intera parte precedente essendo quella alla creazione di‘tutte le luminare’ (v. 448)» (Maffia Scariati 2010a, p. 104).
3 Da notare che «parte» al v. 875 è forse volutamente ambiguo, potendo indicare al contempo il luo-go dove le arti risiedono e la partizione del Tesoretto in cui si tratterà di loro.
tre annotazioni al «tesoretto» 23
bisogno di pensare a un rinvio esterno, ma il passo ha una sua plausibile giustificazionelogica nel contesto del poemetto.
c) In effetti l’allusione a «un volgare» specifico che l’interlocutore di Brunetto dovrebbe poter «intendere», tenendo conto che questo interlocutore privilegiato saràstato appunto Carlo d’Angiò, potrebbe alludere al francese.1 Non fosse però che R a c.8r legge proprio Parlando inuolghare, come riportava Contini nel suo apparato e come èevidente confrontandolo con la stringa grafica in dell’immediatamente sottostante inte(n)de
Diventa a questo punto del tutto irrilevante la lezione di M, da giudicare singolare e perdi più relata da un codice fortemente afflitto da tendenza alla rielaborazione.2
d) Il distico presente nel solo B viene secondo me caricato dalla Scariati di davvero ec-cessive responsabilità probatorie.3 Si tratta infatti in tutta evidenza di un maldestro rap-pezzo del copista che cerca in questo modo di concludere quel che non si concludeva.A provarlo, ce ne fosse bisogno, stanno: 1. il fatto che il distico ribadisca goffamente larima -isa su cui si interrompe il poemetto e ricorra a un termine come divisa che nelpoemetto appare sempre in rima con l’immediatamente precedente guisa, in una sortadi tic mnemonico;4 2. l’impossibilità fonetica in toscano della rima devisa : francisa; 3. lastessa natura derivativa di quel che qui vien detto, con evidente ripresa della formula«gran Tesoro» del v. 1351 e praticamente dell’intero v. 1356.5 I due versi in questione, in-somma, sono una semplice iniziativa del copista di B e nulla più.
1 Tralascio qui la possibile obiezione relativa al fatto che l’interlocutore di questi versi è, a rigore, Brunetto, e non il dedicatario (e quindi un italofono, non un francofono) in virtù di quel sospetto circala collocazione dei versi in questione espressa sopra, p. 18, nota 1.
2 Che lo porta, tanto per fare un esempio, a obliterare quasi sistematicamente tutti i casi di rima sici-liana, così che al v. 41 «non valse me’ di voe» diventa Non ualser di uoi piue (: fue), al v. 130 «non si trova per-sona» diventa Non si troua ueruna (: luna), al v. 374 «quando degnò venire» diventa Quando dengno uolere(: savere) ecc. Nel caso specifico avrà giocato il desiderio di evitare la ridondanza con il limitrofo (in M ealtri codici, a causa dell’inversione dei vv. 423-424) Parlandoti p(er) prosa (dove Parlandoti è però e propriolezione individuale di M). Che dietro tale disinvoltura ci sia la mano magari corsiva ma certo non illet-terata di Antonio Pucci, di cui si è scoperta di recente l’autografia per M (Cursi 2010), non fa che au-mentare il sospetto che si deve nutrire circa le lezioni relate da questo codice.
3 Prima del passo sopra citato la stessa fiducia era espressa anche a p. 65, in cui si affermava che «Ladicitura gran Tesoro […] suggella inoltre due versi del poemetto nel prezioso e anche per questo unicoms. Queriniano» (segue la citazione del distico in questione).
4 La rima guisa : divisa è a 71-72, 173-174, 689-690, 1329-1330 e 1829-1830, nonché nel Favolello, dove ai vv.29-30 si ha guise : divise.
5 In modo parzialmente assimilabile il copista di C1 supplisce all’improvvisa interruzione del testo ritrascrivendo i vv. 2181-2186 prima di rassegnarsi all’incompiutezza del testo.
24 marco berisso
Dunque le obiezioni della Scariati, come si vede, mi paiono alla fine non decisive. Aulteriore conferma del fatto che il Tesoretto prevedesse progettualmente una parte inprosa sta inoltre, a mio parere, quanto esplicitamente dichiarato da Brunetto in iii,dove appunto afferma che la sezione dedicata agli animali non sarà scritta «pe·ri-ma|dal piè fin a la cima» (corsivo mio), cioè “dall’inizio alla fine”, ma che conterrà parti in prosa. Come si vede, qui Brunetto parla di una prosa che apparirà più oltrema che allo stesso modo ed evidentemente sta all’interno del testo («’nanti da la fine»,come dice al v. 1123)1 tanto da interromperne la natura versificata «dal piè fin a la cima». Dunque la vecchia ipotesi di Zannoni resta, mi pare, ancora valida, e ci può rimanere semmai il rimpianto che il maestro di Dante abbia mancato di poco l’occa-sione di precedere l’allievo come iniziatore del prosimetro nell’ambito della lettera-tura italiana.2
2. La sequenza Tesoretto-Favolello (e la «Penetenza»)
Ricordavo prima l’osservazione di Contini relativa alla compagine Tesoretto-Favolello ealla possibilità almeno teorica di una falla nella tradizione all’altezza dell’archetipoche abbia fatto cadere in un colpo solo la conclusione del primo poemetto e l’avviodel secondo. Per il Tesoretto e il Favolello però non c’è solo un problema di incoeren-ze più o meno forti nella struttura dei due testi, ma in molti manoscritti si riscontraun ben più deciso ed evidente problema di autonomia di essi, percepiti spesso comeun unico agglomerato.3 Per contro, a fronte di questa agglutinazione tra due testi oggi intesi come ben distinti, alcuni codici e non dei secondari affacciano una distin-zione più o meno netta tra il Tesoretto in quanto tale e quella che in R viene detta laPenetenza, ossia il tratto che parte dal v. 2427 e procede come episodio grosso modosino al v. 2876.
Prima di cercare di riflettere su questo particolare, è meglio ridare un’occhiata da que-sta prospettiva alla situazione manoscritta. Nell’elencare i codici partirò con R, ossial’unico rappresentante di una delle due famiglie in cui Contini ha diviso la tradizionedel Tesoretto (e del Favolello),4 per poi proseguire con i codici non-R (definendo in questomodo da adesso in poi il numeroso gruppo concorrente al manoscritto riccardiano) inordine neutramente alfabetico:
R1. Il Tesoretto si avvia adespoto e anepigrafo. A c. 33rb, a seguito del v. 2426 si legge questo disti-
co a modo di explicit ma impaginato come il testo vero e proprio: Finito tesoretto|sempre siachr(ist)o benedetto.
1 A un ‘dopo’ di natura struttural-testuale rinvia anche sicuramente il «quando fie stagione» che ap-pare in ii.
2 Prosimetro che, comunque, avrà avuto a che fare più col Convivio che con la Vita nova, cioè con unaprosa di tipo scientifico-didascalico piuttosto che narrativa.
3 Tanto che Zannoni, come dicevo, dovette ingegnarsi a dimostrare che il Favolello non rappresenta-va la mancata risposta di Tolomeo, come invece si riteneva sino ad allora (Zannoni 1824, pp. xlii-xliii).
4 Si vedano a questo proposito i risultati sintetizzati in Contini 1960, ii, pp. 869-73 (Tesoretto) e 873-74(Favolello). Privo di ogni dimostrazione e attendibilità è lo stemma proposto in Bolton Holloway 1981, p.xxx, riprodotto in Ciccuto 1985, p. 41, e ribadito con l’unica integrazione di C2, assente nella prima ver-sione, in Bolton Holloway 1986, p. 15 (per pura curiosità: secondo la studiosa la famiglia che si opponead R sarebbe formata da descripti, in varia scalatura, di S).
tre annotazioni al «tesoretto» 25
2. Sempre a c. 33rb, subito dopo il distico appena citato, si legge un altro distico evidenziato dalcopista entro un riquadro: Orchomincia lapenete(n)za|Laqualcichonuiene auer co(n)reue[renza].1A c. 39vb, subito dopo il v. 3944 si legge quest’altro distico di explicit, anche questo evidenziatodal copista con un riquadro: Finita penitenza|chedio cip(er)doni p(er) sua pote(n)za.
3. Alla medesima c. 39vb inizia adespoto e anepigrafo il Favolello che si conclude senza explicit ac. 41vb. Da notare che l’omissione della titolazione non può essere volontaria scelta del copi-sta visto che il successivo Mare amoroso ha un regolare explicit che ne indica il titolo (c. 50r Finito ilmare amoroso chechosi sifa chiamare).
BPresenta solo il Tesoretto e non segnala in modo particolare l’avvio della Penitenza a c. 37r (è pre-sente solo la caratteristica lettera iniziale maiuscola rubricata che indica in questo codice le rarepartizioni interne del testo).
C1. Il Tesoretto inizia adespoto e anepigrafo, con un capolettera filigranato in rosso e blu.2. A c. 21vb l’avvio della Penetenza è segnalato da una iniziale filigranata assimilabile a quella su
cui si apre il poemetto e dalla didascalia Qui comincia lapeni|tençia cheffe p(er)proue|dença ilbuonmastro bur|necto cheffu sança difecto.
3. A c. 26ra il Favolello è introdotto dalla didascalia Qui comincia ilfauolello|ilqualfu buono 7 belloche|mando mastro Burnecto|a Rusticho di filippo. Il capolettera del primo verso del Favolello (c.26rb) è in rosso, su quattro righi, simile a quello che individua alcune partizioni interne del testo (diverso quindi da quello iniziale e da quello della Penetenza). A c. 27va la didascalia con-clusiva Explicit liber tesoreti|domini Burnetti la|tini de florentia.
C1Presenta solo il Tesoretto sino alla Penetenza esclusa (di cui riporta i soli primi quattro versi senzaparticolare evidenziazione; e vedi comunque quanto si dice qui sotto, a p. 31, nota 3), adespoto eanepigrafo.
C2Presenta solo il tratto dal v. 1357 al v. 2430 del Tesoretto, facendolo precedere da un riassunto in la-tino della parte mancante. L’interruzione è dovuta a cause meccaniche, dal momento che man-ca probabilmente il bifolio finale: a c. 93v una mano posteriore ha indicato a lapis con una lineail punto di inizio della Penetenza che nel testo non ha comunque segnalazioni di sorta.
FIl Tesoretto è adespoto e anepigrafo. A c. 104ra la Penetenza è segnalata con una maiuscola deco-rata uguale a quelle presenti nel resto del codice per indicare le partizioni interne.
G1. A c. 2ra si legge la rubrica Qui chomincia iltesoretto|fatto p(er) s(er) brunetto latini|dafirençe. Il
testo procede senza individuare nessuna particolare frattura per segnalare la Penitenza (a c.15va c’è solo lo spazio riservato usualmente dal copista per le – fittissime – iniziali rubricateche in realtà non sono mai state aggiunte al codice).
2. A c. 18rb inizia il Favolello. Manca la rubrica ma c’è uno spazio vuoto di circa 6 rr. che era evi-dentemente predisposto per contenerla.
3. A c. 19ra si legge la rubrica finito illibro chiamato tesoretto|Deogratias amen.
L1. A c. 1ra inizia il Tesoretto adespoto e anepigrafo. A poco più di metà di c. 21rb lo scriba con-
clude la copia e va a pagina nuova.
1 Le ultime lettere sono andate perdute nella rifilatura della pagina e sono state così ricostruite a par-tire da Wiese 1883, p. 378.
26 marco berisso
2. A c. 21va inizia la Penetenza, anepigrafa ma con un’iniziale decorata (leggermente più piccoladi quella di c. 1ra ma comunque maggiore di quelle solitamente usate dal copista per separa-re le sezioni interne al testo) a segnalare l’avvio di un nuovo testo o di una nuova parte di te-sto. Il testo si conclude alle prime righe di c. 25vb, dopodiché il copista va a pagina nuova.
3. A c. 26ra inizia il Favolello adespoto e anepigrafo, con una iniziale decorata simile a quella dic. 1ra. Il testo si conclude a c. 27rb ed è seguito da questa didascalia: Qui e compiuto ilfauolet-to|che mando s(er) burnetto latini|arustico difilippo.
MIl Tesoretto inizia adespoto e anepigrafo a c. 1r (una mano recenziore ha aggiunto l’intitolazioneTesoro di s(er) brunetto latinj). Una maiuscola rozzamente illustrata a penna indica l’inizio del testo. A c. 67v inizia la Penetenza, segnalata da una maiuscola; a c. 82r il Favolello (sempre ade-spoto e anepigrafo), nuovamente con iniziale maiuscola, che si conclude a c. 85v.
NIl Tesoretto e il Favolello sono entrambi adespoti e anepigrafi ma a c. 67va l’avvio del secondo è segnalato da una grande lettera decorata assimilabile a quella che apriva il primo. Alla fine deltesto (c. 66vb) una mano corsiva trecentesca1 scrive a. m. e. n. deus.
S1. A c. 1ra inizia il Tesoretto adespoto e anepigrafo. A c. 22rb, dopo il v. 2426 si legge l’explicit Qui
eco(n)piuto iltesoretto.2. A c. 22va, senza particolari segnali paratestuali, inizia la Penitenza. Il testo si conclude a c. 26vb,
dove si legge a m e n.3. A c. 27ra inizia il Favolello, adespoto e anepigrafo. Il capolettera è decisamente più grande di
quelli presenti altrove nel codice anche se non decorato come quello di c. 1ra. Il testo si con-clude a c. 28rb dove una didascalia evidenziata da un fregio decorativo recita Qui ecompiuto ilfagolet|to kemando s(er) brunet|to latino arustico difi|lippo.
ZA c. 1r inizia il Tesoretto, adespoto, introdotto dalla didascalia Questo è il Tesoretto in nomine Domi-ni. All’interno della copia Penetenza e Favolello si inseriscono (rispettivamente a c. 38v e a c. 47v)senza alcuna soluzione di continuità o particolari segnali paratestuali, così da dare l’apparenzadi un unico testo che si conclude a c. 50v. con la didascalia Finito è questo trattato.
Come si ricorderà, era stato proprio Contini a parlare di «relativa autonomia» della Penitenza,2 segnalando in particolare l’assenza di essa in C1C2 (ma il fatto sarà da consi-derare del tutto accidentale) e le didascalie di R, C e S che indicano senza ambiguitàun’interruzione del Tesoretto all’altezza del v. 2426. A queste esplicite dichiarazioni an-drà poi aggiunta quella implicita di L (inizio del testo in pagina nuova, iniziale decora-ta). E se la presenza di una demarcazione paratestuale per la Penetenza in L potrebbenon essere particolarmente significativa, stante la dimostrata prossimità di questo testimone a S e la possibilità dunque che l’elemento derivi dall’antigrafo comune ai duecodici,3 peso ben maggiore ha il trovare qui convocato C, che è del tutto estraneo a questa costellazione testuale e che si presenta come uno dei manoscritti cronologica-mente più alti della tradizione del poemetto.
1 È la stessa che aggiunge sul margine il v. 1874 saltato erroneamente dalla mano principale.2 Contini 1960, ii, p. 259 (in nota al v. 2427). Da qui la sua innovativa decisione di segnalarla con una
didascalia interna al testo.3 «È costante solo la parentela durante l’intero poemetto, di LS (per esempio 146 Sovr’un, 1869 Lodai,
2382 non mutai ecc. ecc.)»: così Contini 1960, ii, p. 872. La prossimità dei due testimoni è in effetti indub-bia e si concretizza in errori caratteristici, identità in lezioni indifferenti esclusive, coincidenza nelle partizioni interne al testo.
tre annotazioni al «tesoretto» 27
Ma la cosa più interessante è che alla percezione dell’autonomia della Penitenza cor-risponde talvolta una non altrettanto evidente percezione di quella del Favolello. Salta dinuovo all’occhio, oltre all’ambiguità di R (in cui il testo è – intenzionalmente – anepi-grafo), l’atteggiamento di C, che pur delimitando il Favolello con un’esplicita didascalia,iscrive poi l’intera sequenza, definendola tout court Tesoretto, sotto un unico explicit. Inquesto C è affiancato almeno virtualmente da G, che prevedeva con tutta evidenza unadidascalia autonoma iniziale per il Favolello ma che, analogamente, conclude la copiaimponendo a quanto sin lì riportato l’etichetta cumulativa Tesoretto. Allo stesso modo,nessuna evidente partizione interna (e perciò neppure una specifica rubrica per la Pene-tenza) doveva essere nell’esemplare dal quale è derivato Z.
Mi pare del tutto improbabile che il verificarsi di simili oscillazioni, nell’identificarecon sicurezza proprio l’autonomia degli elementi primi della sequenza all’interno di co-dici che non hanno rapporti diretti, possa essere iniziativa indipendente dei singoli co-pisti, oppure che esso possa essersi trasmesso (stante la varietà delle soluzioni esperite)attraverso contaminazione. Più facile che il fenomeno sia in qualche modo da ricon-durre all’archetipo se non, addirittura, all’originale: e se nel primo caso ci troveremmodi fronte alle conseguenze di una raccolta di poemetti brunettiani resa di difficile di-stinguibilità nei singoli elementi che la formavano (magari a causa di una approssima-tiva opera di rubricazione), nel secondo potrebbe anche prendere una qualche consi-stenza l’ipotesi di un’indistinzione, per dir così, preterintenzionale e originaria dei trecomponenti, di un loro stato fluido in cui erano ancora parzialmente distinti ma sullavia di essere ricomposti in una nuova unità, quella appunto del Tesoretto.1
Questo spiegherebbe, per esempio, l’evidente macchinosità dell’avvio della Penetenzae la sua stessa conformazione attuale. Mi riferisco in particolare all’inopinata chiamatain causa del «fino amico caro» (v. 2427), preannunciata pochi versi prima con l’excusationei confronti del «caro segnore» dedicatario primo del testo2 ma che non per questo cessa di colpire per la sua incongruenza, strutturata com’è nel suo incipit secondo le rigide norme della salutatio epistolare e perciò, cosa ancor più eccentrica, creando unacoabitazione di destinatari all’interno del medesimo testo che non mi risulta abbia altriesempi in testi narrativi (altra cosa sono infatti i congedi multipli in testi lirici). Sta di fattoche, se si staccano da quello che li precede i vv. 2877-2892,3 nulla di quanto si trova nel testo della Penetenza ha un vero rapporto di necessità e congruenza con il resto del poemetto. Tanto per puntare l’attenzione su un primo elemento macroscopico, non c’ènessun tentativo di dare un minimo di plausibilità e coerenza col contesto al viaggio aMontpellier narrato ai vv. 2539-2554, un particolare realistico che a questa altezza del testo, dopo l’incontro con Natura, con le quattro virtù cortesi e col Dio d’Amore, risul-terebbe a dir poco bizzarro (e infatti subito dopo il viaggio di Brunetto riprende il suo
1 Dubbi sulla congruenza complessiva della compagine testuale del Tesoretto e sul carattere di «parteavventizia» della Penetenza esprimeva già esplicitamente Maffia Scariati 2010a, pp. 114-15.
2 «E voi, caro segnore,|prego di tutto core|che non vi sia gravoso|s’i’ alquanto mi poso,|finché dipenitenza|per fina conoscenza|mi possa consigliare|con omo che mi pare|ver’ me intero amico,|a cuisovente dico|e mostro mie credenze,|e tegno sue sentenze» (vv. 2415-2426).
3 «Ora a Dio t’acomando,|ch’io non so l’or’ né quando|ti debbia ritrovare:|ch’io credo pur anda-re|la via ch’io m’era messo;|ché ciò che m’è promesso|di veder le sett’ arti|ed altre molte parti,|io levo’ pur vedere,|imparar e sapere;|ché, poi che del peccato|mi son penitenzato,|e sonne ben confesso|eprosciolto e dimesso,|io metto poca cura|d’andar a la Ventura». Da notare che questi versi sono indi-cati come autonomi (ossia con uno stacco variamente segnalato sul piano paragrafematico) in un grup-po significativo di codici (CGLRS).
28 marco berisso
carattere allegorico); o che, in alternativa e se il tempo verbale utilizzato dal Latini vuo-le proiettare l’episodio in un passato precedente la vicenda del poemetto, risulta del tuttoincongruente (le vicende del poemetto com’è noto prendono infatti avvio prima del-l’esilio francese e non si capirebbe quindi come qui l’io potrebbe ricordare un pellegri-naggio che viene necessariamente dopo quell’esilio)1 in maniera del tutto inconcepibi-le in un testo marcato in senso autobiografico in modo così singolare e forte.
Non solo, ma anche i versi che preannunciano la confessione e il pentimento di Brunetto sembrano più riassumere (con precisa tangenza di rimanti) che annunciarequanto riportato nella Penitenza,2 e lo stesso si dica per la chiamata in causa dell’«inte-ro amico» (che non è, si badi, un personaggio del testo ma, appunto, un secondo, cir-costanziato dedicatario che poi sparirà definitivamente di scena), in cui sono presentielementi che sembrano prelevati direttamente dall’avvio della nuova sezione.3 E del re-sto, e infine, è proprio la logica interna della Penetenza che si presenta come totalmen-te sganciata dal resto del poemetto, rigettando ogni riferimento allegorico, fosse anchesolo di cornice (come accadeva per la lunga sezione dedicata alle quattro virtù) e strut-turando quindi i contenuti didattici entro la forma epistolare-parenetica, continua-mente rivolta al tu dell’amico-destinatario, chiamato ripetutamente in causa a condivi-dere il percorso di confessione e pentimento.4
C’è un ultimo elemento da notare. In almeno un caso la Penetenza dimostra un rapporto col Tresor ben più ravvicinato di quanto non facciano i versi che la precedono.Alludo alla trattazione del peccato di gola, di cui si parla in due occasioni nel nostro te-sto.5 La prima volta il riferimento alla gola è inserito all’interno del discorso di Lar-ghezza, e in particolare entro una porzione di esso in cui si elencano alcuni usi dissen-nati del denaro. Tra questi vi sono appunto gli eccessi nell’alimentazione (vv. 1465-1494):
E tegno grande schernachi dispende in taverna;e chi in ghiottorniasi getta, o in beveria,è peggio che omo mortoe ’l suo distrugge a torto.E ho visto persone
1 L’inconguenza cronologica è tale sia che si consideri quello a Montpellier un viaggio effettuato du-rante l’esilio sia che lo si ritenga una tappa del viaggio di ritorno in Italia.
2 Si mettano a raffronto i vv. 2400-2414: «ond’io pensato m’aggio,|anzi ch’io passi avanti,|a Dio ed ali santi|tornar divotamente,|e molto umilemente|confessar li peccati|a’ preti ed a li frati.|E questo miolibretto|e ogn’altro mio detto|ch’io trovato avesse,|s’alcun vizio tenesse,|cometto ogni stagione|i·llorcorrezzïone,|per far l’opera piana|co la fede cristiana» con i vv. 2539-2545: «Così tutto pensoso|un gior-no di nascoso|entrai in Mompuslieri,|e con questi pensieri|me n’andai a li frati,|e tutti mie’ peccati|con-tai di motto in motto» (miei i corsivi).
3 Si confrontino appunto i vv. sopra citati alla nota 2 di p. 27 con il tratto formato dai vv. 2438-2444 (incorsivo segnalo di nuovo le tangenze più evidenti): «ch’i non truovo migliore|amico che mi guidi,|né dicui più mi fidi|di dir le mie credenze,|ché troppo ben sentenze,|quando chero consiglio|intra ’l bene e ’l peri-glio». Da notare che la prossimità del recupero della coppia di rimanti credenze : sentenze, a distanza di so-li 15 versi, è, se ho visto bene, un caso unico nel pur tutt’altro che variato sistema rimico del Tesoretto.
4 Sarà stata la Penetenza quel «libro […] de’ vizi e di virtù» (qui evidentemente scorciato della sua se-conda parte) che Giovanni Villani menziona nel suo famoso ritratto in morte di Brunetto nella Nuovacronica (IX x; Porta 1990-1991, ii, pp. 27-28)?
5 Portava l’attenzione sul secondo di questi passi, anticipando quanto qui viene ribadito, Maffia Sca-riati 2010a, pp. 51-53.
tre annotazioni al «tesoretto» 29
che comperan1 capone,pernice e grosso pesce:lo spender no·lli ’ncresce,ché, come vol sien cari,pur trovansi i danari,sì pagan mantenente,e credon che la gentelili ponga i·llarghezza;ma ben è gran vilezzaingolar tanta cosache già fare non osaconviti né presenti,ma colli propî dentimangia e divora tutto:ecco costume brutto!Mad io, s’i’ m’avedessech’egli altro ben facesse,unqua di ben mangiareno·llo dovrei blasmare:ma chi ’l nasconde e fuggee consuma e distrugge,solo che ben si pasce,certo in mal punto nasce.
Della gola si parla poi anche nella Penetenza, in corrispondenza dei vv. 2815-2838:
Per iscarsezza solavien peccato di gola,ch’om chiama ghiottornia:ché, quando l’om si sviasì che monti i·rrichezza,la gola sì s’avezzaa le dolce vivandee far cocine grandee mangiare anzi l’ora.E molto ben divorachi mangia più soventeche non fa l’altra gente;e talor mangia tantoche pur da qualche cantoli duole corpo e fianco,e stanne lasso e stanco;e inebrïa di vino,sì ch’ogne suo vicinose ne ride d’intornoe mettelo in iscorno:ben è tenuto baccochi fa del corpo saccoe mette tanto in epache talora ne crepa.
1 Contini 1960: «ch’a comperar».
30 marco berisso
I due passi sono evidentemente relati tra loro, ma se si affiancano al relativo capitolo delTresor dal quale prendono le mosse (ii 78 [Ci parole de sobrieté]), si nota subito come ilgrado di adesione sia decisamente più pronunciato nel secondo rispetto al primo:
1. Sobrietez est de donter le delit dou gouster et de la boche par atemprance de raison. A cestevertu nos semont nature, quant ele fist si petite boche a si grant cors; et d’autre part li fist ele .ii.iaus et .ii. oreilles, ja ne li fist que une boche. Mes moult nos semont la brieté dou delit, qui nedure se mout petit non tant come il trespasse la gorge, et la dolor des maladies que en suelt ave-nir dure longuement. 2. Consirre donc que tout choses, mantenant que ele est gostee, est co-rompue. Ce n’est pas ensi des autres sens, car, por veoir et par oïr une belle chose, n’iert ele porce corrompue. Seneque dit: Consire ce que nature soufist, non pas ce que lecherie requiert, carsi come le poissons est pris a l’ain et l’oisseaus au las, tout autresi est l’ome pris por mangier etpor boivre desmesureement: il pert son sens et sa conoissance, il en oublie toutes ses huevres devertus. 3. En ceste vertu a .iiii. offices. L’un est de non mangier devant hore establie. Seneqa dit:Nulle chose est deleitable se ele est trop sovent. Oraces dit: Ce qui est poi, delit plus. Souffre,donques, jusques a tant que nature semoigne, cat touz outraiges la confort et mesure la corone.4. Le secont office est que l’en ne quierre trop preciouses viandes, car lecherie et yvresce ne sontsens ordures. Ah, come il a ci laide chose de perdre sens et moralité et santé por outraige de vinet de viandes! Juvenaus dit: en ce vice chiet cil qui fait grant force comment l’en doit depechierle lievre et le geline. 5. Le tiers office est de constraindre le coirage de mangier. Senequa dit: Soitta vie de petit mangier et ton palet soit esmeu par fain non mie par savor. Sostien, donques, tavie de tant come nature aquiert. Senequa dit: Tu dois mangier por vivre, non pas vivre por man-gier. Oraces dit: Il n’est chose que yvresce ne face: ele descuevre les secret, ele amoine les des-armés a la bataille et enseingne les ars. Jeronimes dit: Qui ce euvre est mors et ensevelis. Augus-tin dit: Quant l’ome cuide boivre le vin, et il est beus. Le maistre dit: Plus honorable chose estque tu te plaignes de soif que de yvresce. Li Poetes dit: Vertu est soufrir soi des choses qui deli-tent a male part. 6. Le quart office est que, por mangier, tu ne despendes desmesureement, carce est laide chose que tes voisins te mostrent au doit et dient tu est devenu povre par ta glotor-nie. Oraces dit: Aies mesure selonc la borse, es granz choses et es perites. Guarde toi donquesde tavernes et de touz granz apareillemenz de mangier, se ce n’est por tes noces, ou por tes amis,ou por esaucier, tes honors par le enseingnemenz de magnificence.
Come si può notare, se i contatti più forti con il primo passo sono soprattutto di ordi-ne verbale (per esempio la menzione iniziale della «taverna» che richiama il monito fi-nale a guardarsi appunto «de tavernes», o la citazione girolamina richiamata al v. 1469),ma non vanno a investire l’organizzazione del discorso, i nessi col secondo brano si ri-velano molto più radicali, centrati come sono, per esempio, sul richiamo di tre dei quat-tro «offices» della sobrietà (e anche del quarto resta in qualche misura traccia, se, comedobbiamo, accostiamo ai «voisins» che «te mostrent au doit et dient tu est devenu po-vre par ta glotornie» il «vicino» che «se ne ride intorno|e mettelo in iscorno»), ma cheporta traccia evidente anche dell’avvio del capitolo, in cui il monito circa le indesidera-te conseguenze per la salute degli eccessi alimentari («Mes moult nos semont la brietédou delit, qui ne dure se mout petit non tant come il trespasse la gorge, et la dolor desmaladies que en suelt avenir dure longuement») si riflettono in ben due punti del purbreve discorso (precisamente in «e talor mangia tanto|che pur da qualche canto|li duo-le corpo e fianco», più liberamente in «e mette tanto in epa|che talora ne crepa»).1 Vie-
1 Per più dettagliati riscontri rinvio senz’altro alle pagine della Scariati citate sopra, a p. 28, nota 5. Sulrapporto Tresor-Tesoretto, anche alla luce di un cambio di strategia nella comunicazione dei contributidottrinali, si veda Librandi 2012.
tre annotazioni al «tesoretto» 31
ne allora il dubbio (ma è qualcosa di più di un dubbio) che questa scala di prossimità alTresor sia direttamente proporzionale alla cronologia originaria dei due ‘testi’, con la Penetenza a ridosso dell’enciclopedia e il Tesoretto posteriore a essa.
Ci sono insomma molti indizi che fanno sospettare che la Penetenza possa essere stataoriginariamente un testo autonomo inserito poi da Brunetto nel Tesoretto, ma lascian-do dei punti di sutura che risultano ancora piuttosto evidenti. La considerazione potrebbe a questo punto estendersi forse anche al Favolello, in base a quanto si dicevaprima relativamente al comportamento dei codici R, C e G. E del resto una trattazionede amicitia, dotata di originaria autonomia, poteva senz’altro essere riassorbita entro unprogetto di trasposizione in versi di un materiale enciclopedico affine a quello del Tresor,che al tema dedicava i capitoli 102-106 del ii libro e rispetto al quale non a caso Continirinveniva precise tangenze testuali.1 A questo punto si potrebbe andare forse oltre e ipotizzare addirittura che l’inizio ex abrupto del Favolello sia da attribuire a un primo egrossolano intervento da parte di Brunetto per rimodulare il testo primitivo in funzio-ne del nuovo contesto che doveva accoglierlo, tramite l’asportazione del tratto inizialepiù legato all’occasione compositiva. Ma anche senza arrivare così in là, ci si potrà interrogare se l’abbinamento Tesoretto-Favolello nella tradizione testuale sia in realtà daintendersi non come accidentale ma, in maniera più profonda, come causato da un’ori-ginaria compaginazione autoriale.2
3. Ritocchi alla vulgata continiana
La proposta di classificazione avanzata da Contini-Pozzi nei Poeti del Duecento e a cui inprecedenza mi riferivo rimane a oggi la soluzione operativa più economica e non sostituita.3 Date queste premesse, e tenuto pertanto conto che R fornisce il testo-base
1 Vedi in Contini 1960 le note ai vv. 19-24, 81-87, 125-129. A monte di Tresor e Favolello starà comunquel’Amicitia di Boncompagno da Signa (Nathan 1909, pp. 35-41; si veda anche Maffia Scariati 2010a, pp. 144-47).
2 Non fa problema, in questo senso, l’assenza del secondo poemetto in alcuni testimoni del primo(BC1F; circa la conformazione effettiva di C2 nulla si può dire, come si vedrà dalla nota successiva), men-tre ne è quasi conferma l’assenza pressocché totale di testimoni del solo Favolello, fatta eccezione del Lau-renziano lxi 7 (vedi l’avvio della nota al testo al poemetto in Contini 1960, ii, p. 873).
3 Naturalmente questo non implica che alcuni rapporti interni alla famiglia non-R non possano esse-re in qualche modo ripresi e precisati. Appare per esempio innegabile la fisionomia di gruppo dei codiciBC1N, cui si aggiunge da dove presente C2, accomunati da uno smottamento che colpisce i vv. 2335-2383e che era già segnalato da Contini 1960, ii, p. 873. I quattro codici presentano infatti una lacuna corri-spondente ai vv. 2335-2342 e poi scompaginano completamente la sequenza successiva (l’ordine in cui sipresentano i versi è 2357-2382, 2345-2356, 2343-2344, 2383). Questo errore ha evidentemente valore con-giuntivo e separativo e permette quindi di isolare quella famiglia dal rimanente della tradizione non-R.Prossimi a tale famiglia sono CF, che presentano in comune con quel gruppo un’altra lacuna, in corri-spondenza dei vv. 1511-1540 (anche per questo si veda Contini 1960, ivi). Andrà poi forse ripensata la con-formazione di C1. Il suo testo si interrompe infatti al v. 2430 (ossia al quarto verso della Penetenza) e poicome dicevo prima (vedi sopra, p. 23, nota 5) procede per un altro brevissimo tratto copiando per una se-conda volta i vv. 2181-2186. La cosa interessante è che, fatta la tara di questa coda spuria, C1 finisce colconcludersi esattamente con lo stesso verso con cui finisce oggi C2, che si blocca per l’appunto al v. 2430ma per cause meccaniche, ovvero la caduta delle carte successive. Viene allora il sospetto (che andrà na-turalmente verificato) che l’acclarata affinità dei due testimoni (Contini 1960, ii, p. 872) debba essere me-glio precisata come rapporto di filiazione (di C1 da C2) e che l’ulteriore annotazione di Contini («per laprima parte C1 integra mediante C o un suo vicino»: ivi; come noto, infatti, C2 sostituisce il tratto sinoal v. 1357 con un sintetico sunto latino) finisca col prefigurare un caso di contaminazione per giustappo-sizione di esemplari (sulla cui fenomenologia si veda il recente Tonello, Trovato 2011). Ma sono solo sug-gestioni che impongono di essere verificate con più agio.
32 marco berisso
per l’edizione del Tesoretto, si potrà a questo punto scorrere il fitto elenco di lezioni diR giudicate erronee da Contini1 e perciò rigettate in quella occasione e provare a vede-re se almeno qualcuna di esse possa essere riammessa a testo con una certa plausibilità.Quelli che qui seguono nel paragrafo 3. 1 sono appunto i minimi ritocchi alla vulgatache credo di poter avanzare (i più probabili sono segnalati dall’asterisco), resi talvoltaplausibili anche dalla testimonianza del ramo opposto a R. Di seguito a questo primoblocco di suggerimenti ne verrà un secondo in cui presento casi di dialefe o dieresi piùo meno eccezionali attestati in R e che mi pare possano essere legittimamente ripristi-nate (il primo caso in questione, tra l’altro, era segnalato come ammissibile proprio daContini). È chiaro che qui, per avere una più sicura visione della questione, occorre-rebbe possedere un quadro generale di riferimento in relazione alla metrica del Tesoret-to, estesa magari ad altri poemetti assimilabili, e un quadro delle abitudini metriche deisingoli copisti, a partire proprio da quello di R. Nondimeno, penso che il contesto cro-nologico e culturale entro cui Brunetto si muove (che è in sostanza quello della metri-ca toscana prima di Dante) e il carattere fondamentalmente ‘prosastico’ del testo, chepotrebbe aver acconsentito a una versificazione meno sorvegliata, rendano plausibile alivello almeno di ipotesi iniziale un ricorso non sporadico a figure metriche altrove re-putate eccezionali. Il terzo elenco infine, brevissimo, contiene errori che accusati a pri-ma vista dal solo R possono in realtà meglio esser fatti risalire all’archetipo. L’intera ope-razione, è bene precisarlo, mette comunque a frutto spessissimo suggerimenti cheerano già presenti in Contini.2
3. 1. Ripristini da R
214 R Sichome mafattura vs Contini 1960: «sì come una figura».Se non c’è dubbio che il ma- di R debba essere corretto, penso invece che la lezione fattura
possa forse essere conservata (con il significato di ‘creatura’, peraltro usuale,3 e preceduto da«una» lo si trova anche al v. 290: «Io sono la Natura,|e sono una fattura|de lo sovran Fattore»).
> «sì come una fattura».
1 Contini 1960, ii, pp. 870-72.2 Nei passi che seguono segnalo con la sottolineatura i punti interessati dal ripristino. In via preli-
minare avverto che in Contini 1960 si leggono per refuso «1151» anziché «1152» a p. 871 e «1947» anziché«1945» a p. 872. Vengono poi segnalati come errori di R le lezioni dei vv. 476, «em (o vale ‘in’?)», e 1995,«ad manca (come in parecchi altri)», che sono invece poi regolarmente a testo (e la seconda assume par-ticolare rilievo proprio per quanto si dirà circa il mantenimento o meno delle dialefi attestate in R: masi veda oltre). Specifico infine che qui sono argomento di discussione solo le lezioni di R segnalate co-me erronee nell’apparato di Contini: questo non significa che non si possano dare altri possibili restauria partire da una ricollazione del codice (tanto per fare qualche esempio minimo, al v. 5 R legge «né inpace né in guerra» e non «né ’n pace né in guerra» come si trova nell’edizione, e al v. 1156 R ha «Vede-rai» anziché «Vedrai»). I numeri in grassetto indicano, tanto nel primo quanto nel secondo elenco, lacoincidenza con lezioni che Stefano Carrai ha restaurato in servizio alla sua imminente edizione com-mentata del Tesoretto prossima all’uscita per Einaudi (ringrazio l’amico Carrai per avermene concessoin anteprima la lettura).
3 Dalla banca dati del tlio ricavo tra gli altri un passo dal volgarizzamento del Tresor (vi 49: «Edancora lo ricevimento del beneficio si è fattura del benefattore, e ciascuno ama la sua fattura più ch’eglinon è amato da essa, e specialmente le cose che hanno anima, siccome noi possiamo vedere ne’ poetii quali amano i loro versi, però che l’ultima perfezione dell’uomo si è nella sua operazione»), in cui iltermine è usato in senso generico, da aggiungere al notorio Pd xxxiii, 4-6 («tu se’ colei che l’umana natura|nobilitasti sì, che ’l suo fattore|non disdegnò di farsi sua fattura»: si noti peraltro come le treparole rime di Dante siano la medesime dei vv. 289-291 di Brunetto, il che potrebbe forse non esserecasuale).
tre annotazioni al «tesoretto» 33
*246 R Ediriçça gliocchi miei vs Contini 1960: «e drizzai gli occhi miei».Come segnalava già Contini («= -a’?») si può mantenere la lezione di R interpretando «drizza’».> «e drizza’ gli occhi miei».
398 R Che tu no(n) sapie tutto vs Contini 1960: «che tu non sapie ’n tutto».Dal momento che l’errore è in tutta la tradizione (in è nei soli CC1 probabilmente congettu-
rale) si potrebbe semmai pensare a un errore d’archetipo (e quindi il caso scivolerebbe al para-grafo 3.3). Ma mi chiedo se non ci si possa qui trovare di fronte a un caso di tutto con valore avverbiale (‘totalmente’).1
> «che tu non sapie tutto».
*564 R bellezze 7 beninanza vs Contini 1960: «biltate e beninanza».Contini in merito annota «anche -a M, ma rieccheggerà 561» (vale a dire «e diede lor bellez-
za|di membra e di clarezza»). In realtà il Tesoretto non si caratterizza certo per un gusto così spic-cato per la variatio lessicale da non consentire una ripetizione del medesimo lemma a così brevedistanza. Tra le decine di esempi allegabili, bastino anche solo poco prima i vv. 439-444: «Il terzo,ciò mi pare,|ispecificò ’l mare|e la terra divise|e ’n ella fece e mise|ogne cosa barbata|che ’nterra è radicata». Naturalmente nel caso qui segnalato (come anche al già citato 561) bellezze sa-rebbe una forma di singolare sicilianeggiante (da -ities).
> «bellezze e beninanza».
*760 R Laue sente memoria vs Contini 1960: «la valente memoria».R potrebbe essere qui addirittura difficilior (‘là dove è sensibile la memoria’).2> «là ’ve sente memoria».
*765 Diquali ui uollio dire vs Contini 1960: «d’i quai ti voglio dire».La correzione di Contini si basava probabilmente sulla presenza della seconda persona singo-
lare al v. 763 («Così, se tu ti pensi|son fatti cinque sensi»), ma la variazione di R si può tranquil-lamente conservare, dato che un cambio di complemento in questo contesto risulta più che plau-sibile (e del resto al v. 773 abbiamo proprio «ch’i’ v’aggio nominate»).
> «d’i quai vi voglio dire».
767 R Lodore eloghostare3 vs Contini 1960: «l’odorare e ’l gostare».La situazione testuale di questi versi è tutt’altro che lineare. La lezione di R è confermata pie-
namente da CG e dall’incompleto codice + 4600 Bd. Ms. 354 della Cornell University Library,4nonché da Z (che ha lodere anziché Lodore) e almeno in parte anche da N (che ha l’ipermetria lodorare eloghostare). Contro questi codici ci sono BC1FM, assunti a testo da Contini. Infine LSpresentano una lezione individuale (Louedere eludire|Etoccare 7 gustare|Edipoi lodorare). La lezione
1 gdli, s.v. tutto, § 22. È anche, come mi segnala Irene Maffia Scariati, nella Rettorica: «sì come fuemaestro Piero dalle Vigne, il quale perciò fue agozetto di Federigo secondo imperadore di Roma e tuttosire di lui e dello ’mperio» (Maggini 1968, p. 5).
2 Quindi con significato prossimo a quanto attestato in gdli, s.v. sentire, § 24.3 Da notare che il copista di R dapprima inverte nella copia i vv. 767-768, quindi ripristina l’ordine ori-
ginario con disegni-richiami che collegano i vv. 766-768 nella successione corretta.4 Segnalato per la prima volta in Bolton Holloway 1986, p. 19, si tratta di un codice cartaceo (da
adesso siglato I; ho collazionato il codice su riproduzione digitale) databile paleograficamente alla me-tà del xv secolo, acefalo e mutilo, di dieci carte complessive, e contiene il testo del Tesoretto dal v. 143al v. 1584. Come del codice oggi a Kraków (vedi oltre, p. 34, nota 5), anche di questo testimone mancaa oggi un’analisi che ne valuti una collocazione seppur approssimativa entro la tradizione del testo,analisi a cui sto lavorando e i cui risultati mi riprometto di pubblicare quanto prima. A una primaispezione, comunque, il codice risulta sicuramente gemello di G se non addirittura un suo derivato.In attesa di risultati certi, ritengo comunque opportuno per ora registrare qui, ove presenti, le sue lezioni.
34 marco berisso
di R appare del tutto accettabile,1 là dove le lezioni di BC1FM possono invece essere spiegate apartire dall’ipermetria banalizzante di N.
> «l’odore e lo gostare».
*825 R Che ciascuno chontrario vs Contini 1960: «che ciascuno è contrario».Nulla qui osta al mantenere R (stessa lezione in C1).> «ch’è ciascuno contrario».
*832 R Ritorna intal choncordia vs Contini 1960: «ritorno in tal concordia».R è sorretto da tutti i testimoni ad eccezione di C1M. Per quanto la soluzione proposta da que-
sti due ultimi codici possa apparire più elegante, non c’è nulla che suggerisca l’irricevibilità di R(«ritorna» è ovviamente retto da «discordia» del v. 831).
> «ritorna in tal concordia».
852 R Eciaschun misurato vs Contini 1960: «a ciascun misurato».La lezione di R, che trova qui il conforto di un vasto gruppo di codici (BFGLNS, più I che ha
la nota tironiana 7; estranei sono i soli CC1M, nonché Z con la lezione eccentrica Ciascuno ne fucierto), può essere mantenuta intendendo «misurato» come riferito a «corso» del verso prece-dente (“ciascuno è proporzionato”): nel caso converrebbe ritoccare anche la punteggiatura delv. 851 sostituendo alla virgola una pausa un po’ più forte (un due punti meglio ancora che un pun-to e virgola).
> «è ciascun misurato».
1120 R Talchenesie sichuro vs Contini 1960: «tal che non sia oscuro».La Maffia Scariati2 sottolinea la plausibilità della lezione di R e sospetta che qui in Contini ab-
bia agito in qualche modo la memoria di Guittone, Tuttor, s’eo veglio o dormo, 61-62: «Scuro sac-cio che par lo|mio detto». In effetti la lezione di R appare almeno legittima: contro a essa po-trebbe deporre la prossimità di contesto con i vv. 407-408 («e s’io parlassi iscuro,|ben ti facciosicuro»), che in qualche modo legittima qui la lezione non-R, e soprattutto il fatto che in questopunto il copista di R appare in evidente difficoltà (così per i due vv. che immediatamente prece-dono e seguono quello che qui si discute). Detto questo la lezione, ripeto, va considerata quan-to meno plausibile (ci si trova forse davanti a una variante d’autore?).3
> «tal che ne sie sicuro».
*1214 R Che chontra tutto uale vs Contini 1960: «che contra tutto male».La lezione di R (che ha il sostegno di M e in più di N, che in un primo momento scrive uale e
poi corregge male) è del tutto plausibile («che contra tutto val’ e|mi dà sicuramento»).> «che contra tutto val’ e».
*1316 R euidi dalaltra parte (con da aggiunto da altra mano in un secondo tempo)4 vs Contini 1960:«e vidi i·l’altra parte».
Stessa lezione in CZ e assimilabile quella in BC1FGIN E (C1G Et) vidi daltra parte, a cui si ag-giunge qui il codice di Kraków5 mentre LS hanno E uidi in altra parte e M la singularis Eppo vidi
1 Per odore nel senso di “olfatto” si veda gdli, s.v., § 11. È vero che Tresor i.15.3 presenta in realtà soloinfiniti sostantivati («Mes le cors a .v. autres senz, ce sont: veoir, oïr, odorer, guster et toucher»; Beltramie a. 2007, p. 32): ma proprio per questo la lezione di R ha l’aspetto di una difficilior che potrebbe esseremantenuta. 2 Maffia Scariati 2010a, p. 77.
3 Data la più volte ribadita incompiutezza del Tesoretto, la possibilità in linea di principio che la varialectio includa anche varianti redazionali è da considerare almeno plausibile. Essa è stata affacciata a miaconoscenza solo da Luciano Rossi (Rossi 2008, pp. 132-33) a proposito della discussa (perché fortementeimplicata nella questione della consecuzione Tresor-Tesoretto) lezione del v. 1352 «ch’io fatt’ ho/farò per coloro» (dove la prima lezione vede in gruppo NRZ più C1G che leggono che fatto, l’altra BCFLSM).
4 E non «ricavato da i» come indicato nell’apparato di Contini 1960.5 Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms. Ital. Fol. 150, c. 2rb (da adesso siglato K: ho collazionato di-
rettamente il codice). La lezione è oggi leggibile solo alla lampada di Wood. Il frammento, già alla
tre annotazioni al «tesoretto» 35
in disparte. In realtà R originariamente aveva una lezione vicinissima a quella poi messa a testoda Contini e l’intervento d’altra mano che integra da (con inchiostro più tenue e quindi di sicuroa una certa distanza cronologica dalla copia vera e propria) è semmai un interessante segnale dilezione passata dai codici non-R a R.
> «e vid’i·l’altra parte».
*1441 R No nabie inte uilezza vs Contini 1960: «non abbie in ciò vilezza».R è del tutto ammissibile (“non comportarti vilmente”).> «non abbie in te vilezza».
*1472 R Che chonperan chapone vs Contini 1960: «ch’a comperar capone».La lezione di R è anche in GMSZ1 a cui è da aggiungere I chonperem. Anche in questo caso il
codice-base è del tutto ricevibile (è sufficiente mettere punto e virgola dopo il v. 1473 e collegareil v. 1474 al tratto successivo).
> «che comperan capone».
1567 R Epreghal damia parte vs Contini 1960: «e prega da mia parte».La lezione di R trova riscontro nel pregala di un buon numero di codici (FGLNSZ più I con
pregola), di contro a un gruppo che presenta prega (BCC1C2M [priegha]). Risulta pertanto più sostenibile, proprio perché con parziale conferma di R, la lezione di FGLNSZ, espungendo l’einiziale per sanare l’ipermetria (dell’archetipo).
> «pregala di mia parte».
1614 R Euolghar no(n) sia graue vs Contini 1960: «e guarda non sia grave».La lezione di R (+ M Eluolghar) è sicuramente ammissibile (come del resto ipotizzava già,
seppur dubitativamente, Contini).2 Forse potrebbe essere intesa come variante redazionale (vediquanto detto sopra a proposito di 1120)?
> «e volgar non sia grave».
1669 R Ma daltro tiprochaccia vs Contini 1960: «mad altra ti procaccia».Oltre alla lezione di R (e di Z, che ha Et daltro tu procaccia) qui il testimoniale propone anche
quella alternativa di BCC1C2 altri. R («altro» nel senso di “qualcos’altro”, “qualcosa di diverso”)potrebbe presentare qui la lezione originale, variamente appianata (altra/altri) dai codici non-R.
> «mad altro ti procaccia».
1820 R Nolfare adimoranza vs Contini 1960: «non fare adimoranza».La lezione di R è forse ammissibile se si mette punto e virgola dopo il v. 1820 e si parafrasa: “Se
qualcuno ti chiede un prestito non farlo con lentezza (nol fare a dimoranza); se vuoi prestargli,
Preussische Königlichen Bibliothek di Berlino, venne segnalato per la prima volta da Wiese (di cui nonho però potuto vedere l’articolo Ein neues Tesorettobruchstück, pubblicato sull’annata 1893-1894 di «Jah-resberichte der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.»), che ribadì l’indicazione nell’editio minor delpoemetto (Wiese 1910, p. 13) e poi successivamente da Julia Bolton Holloway (Bolton Holloway 1986,p. 18). È databile alla prima metà del xiv secolo ed è formato da due bifoli completi che contengono ivv. 189-567 e 946-1322. È consultabile online a partire dall’indirizzo http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?ac-tion=ChangeLanguageAction&language=en, anche se le pessime condizioni di conservazione delle ri-spettive facciate esterne rendono alcune carte (cc. 1r, 2v, 3r e 4v) parzialmente leggibili solo alla lam-pada di Wood. Per una descrizione del manoscritto si veda Sosnowski 2012, pp. 51-54, mentre per unapiù generale storia del fondo già berlinese Rzepka, Sosnowski, Tylus 2011, pp. 81-147 (sui manoscrittiitaliani vedi in particolare le pp. 104-14; a proposito del nostro codice si veda soprattutto p. 114, dove siinforma che «two sheets of manuscript ital. fol. 150 were taken from the binding of manuscript germ.fol. 1019»). Su questo codice, come sul prima citato I, sto comunque preparando come dicevo uno stu-dio specifico.
1 Non N, come indica invece l’apparato Wiese 1883, p. 360, dal momento che nel codice mancano ivv. 1471-1475 (lacuna del resto segnalata dallo stesso Wiese ivi). 2 Contini 1960, ii, p. 871.
36 marco berisso
non farlo aspettare tanto”, ecc. Il problema è che questa perifrasi avverbiale (creata a partire daldiffuso significato di dimoranza “attesa”, “riposo”, ecc.), pur apparendo plausibile almeno in li-nea di principio, non sembra avere attestazioni.1
> «no’l fare a dimoranza».
*2338 R Matutti 7son puruno vs Contini 1960: «ma tutti son pur uno».Già Contini2 prospettava la possibilità che la nota tironiana di R potesse essere interpretata co-
me un pronome frainteso.> «ma tutti e’ son pur uno».
*2369 R Edeli strali 7dellarcho vs Contini 1960: «c’ha le saette e l’arco».La situazione qui è abbastanza complessa, dal momento che i codici presentano un’evidente
dispersione nella lezione. La forma messa a testo da Contini è quella di FGLS, ai quali risultanoalmeno in parte affiancabili M (Colle saette allarco) e CZ (Chelle saette 7 larcho), mentre B (De le sa-ette e larco), C1C2 (Delistralli edelarco) e N (Delesaecte darco) sono a ridosso di R (una volta ovvia-mente che si rimedi l’ipermetria di quest’ultimo espungendo la E iniziale). Il mantenimento diR appare quindi più che ragionevole (incluso «strali» che riprende, e non sembra memoria invo-lontaria di copista, il primo ritratto di Piacere, vv. 2261-2264: «io vidi dritto stante|ignudo un fre-sco fante,|ch’avea l’arco e li strali|e avea penn’ ed ali») con un piccolo ritocco alla punteggiaturadei vv. 2366-2371 («mi dica il convenente|e lo bene e lo male|de l[o] fant’ e dell’ale,|de li strali edell’arco|e onde tale incarco|li venne che non vede»).3
> «de li strali e dell’arco».
*2703 R Chosi per male usanza vs Contini 1960 «Così per mal’usanza».A partire da quanto attestato in R è forse consigliabile un intervento minimo («mala» anziché
l’attestato male; FGSZ hanno appunto malausança).> «così per mala usanza».
2871 R Chene churian pochi vs Contini 1960: «che ne curiamo poco».Come segnala Contini, «può darsi che anche l’antigrafo di R leggesse, come quasi tutti i codi-
ci, ben poco».4 Infatti ben manca solo in R e in B e andrà con tutta probabilità reintegrato.> «che ne curiam ben poco».
3. 2. Ripristini di ordine metrico
152 R Iol pur dimandai vs Contini 1960: «Io lo pur domandai».Lo stesso Contini segnala la «dieresi eccezionale ma non inammissibile». La stessa lezione di
R è in F e a ulteriore sostegno si potrà indicare la varia lectio di S (Eiol, dove E potrebbe essere in-tervento per evitare la dieresi) e, almeno in parte, di GIN (Io il potrebbe spiegarsi meglio comederivato da un Iol che da un Io lo).
> «Ïo ’l pur dimandai».
280 R Cheongne creatura vs Contini 1960: «ched ogne creatura».La dialefe di R è qui confermata da GILMSZ (e indirettamente da BFN, che ritengono neces-
sario correggere ogne in ogniuna proprio per evitarla). Ad avere qui la lezione finita a testo nei pdsono i soli CC1.
> «che ogne creatura».
1 L’unico caso rinvenuto nel corpus tlio, e non del tutto persuasivo dal punto di vista proprio delladistinctio delle parole (potrebbe trattarsi di un normale adimoransa), è nel volgarizzamento pisano deitrattati di Albertano da Brescia («Et Tulio medesmo dice: la paura è mal guardiano di lungho tenpo, contra ’l qual la benvogliensa è fedele a dimoransa»; mio il corsivo).
2 Contini 1960, ii, p. 872: «(= e’?)».3 Sostiene la lezione di B per questo passo Maffia Scariati 2010a, p. 50, nota 60.4 Contini 1960, ii, p. 872.
tre annotazioni al «tesoretto» 37
329 R Luna eternalmente vs Contini 1960: «L’una, ch’eternalmente».Non appare qui necessaria alcuna integrazione alla lezione di R («L’una eternalmente|fue in
divina mente|immagine e figura|di tutta Sua fattura», ecc.).> «L’una eternalmente».
425 Parlando inuolghare vs Contini 1960 «parlandoti in volgare».È anche in KZ.> «parlando in volgare».
969 R Vna fiata peranno vs Contini 1960: «una fïata l’anno».Contini annota: «anche C [che in realtà ha Vna uolta p(er) anno] C1, ma fiata altrove è trisilla-
bo». È però bisillabo al v. 55 («Apresso tutta fiata») così da consigliare il mantenimento della le-zione di R, tenendo tra l’altro conto che la tendenza evidente del copista di R è semmai quelladi conservare, non di occultare, le ipometrie reali o apparenti.
> «una fiata per anno».
1143 R Epoi daltra uia vs Contini 1960: «e poi da l’altra via».Si può qui mantenere la lezione di R con poï dieretico.> «e poï d’altra via».
1231 R E maestri discienze vs Contini 1960: «e mastri di scïenze».È vero che nelle altre due occorrenze (v. 696 «e ragione e scïenza» e v. 719 «la forza e la scïen-
za») Contini leggeva il sostantivo trisillabo ma va sottolineato che in entrambi i casi la dieresi nonè senza alternative: la lezione di R (che ha il sostegno di C1FG nonché di I maistri, indubbiamentetrisillabo) non è perciò da rigettare (anche per le ragioni sopra ricordate in merito al v. 969).
> «e maestri di scienze».
1574 R Locho oue dimora vs Contini 1960: «loco dove dimora».La dialefe di R è presente anche in FGILS.> «loco ove dimora».
1831 R Eguardati ongnora vs Contini 1960 «e guardati ad ogn’ora».A R si affianca qui G. Il caso è particolarmente interessante perché il verso ritorna identico a
1995. Lì Contini stampa, seguendo appunto R (e altri) «E guardati ognora» ma in apparato segnala(come si diceva sopra, a p. 32, nota 2) la lezione di R come erronea («ad manca (come in parec-chi altri)»).1 Una volta precisato che l’apparato tiene conto di una probabile prima decisione edi-toriale poi messa da parte per maggior aderenza al codice-base,2 i due versi fanno evidentementesistema e quindi non c’è alcun residuo motivo di rifiutare la dialefe di R.
> «e guardati ognora».3
2140 R Chelli a tua fidanza vs Contini 1960: «ched elli a tua fidanza».La lezione chelli è anche di FGN; in più Z ha Chegli e C2 che egli.> «ch’elli a tua fidanza».
2239 R Disse inbreue detto vs Contini 1960: «mi disse in breve detto».Altra dialefe.> «disse in breve detto».
1 Contini 1960, ii, p. 872.2 In linea con Wiese 1883, p. 370, che a 1995 (ma 1991 per Wiese) leggeva appunto «E guardati ad
ongn’ora».3 Il ritocco si estende anche alla scrizione «ogn’ora», tranquillamente modernizzabile (è questo
l’unico caso di «ogn’ora», probabilmente risalente di nuovo a Wiese, mentre «ognora» si trova per es. a51, 526, 1576, ecc.).
38 marco berisso
2430 R Par uenuto ongnanno vs Contini 1960: «pare venuto ogn’anno».La lezione Par di R è anche in GLMS (GL cercano di rimediare alla dialefe d’eccezione
spostandola su ongnianno, M integra diuenuto) ed era evidentemente in origine anche in FZ (Peruenuto).
> «par venuto ogn’anno».
3. 3. Errori d’archetipo
Si dà poi il caso di alcuni errori che vengono nella nota al testo di Contini attribuiti a R,ma che debbono in realtà essere interpretati come a carico dell’archetipo. In tutti que-sti casi la possibilità era stata affacciata già dallo stesso Contini.1
331 R Inmagine 7 infigura («immagine e figura»).Contini: «anche di altri codici, forse dall’archetipo».2 In effetti Z ha la stessa lezione di R e
FGKLMS hanno en f., ed è probabile che la corretta lezione di BCC1IN risalga a interventi congetturali variamente collocabili.3720 R Che lanima ainparue(n)za («che l’anima in parvenza»).
Contini: «di più altri, forse dall’archetipo».4 Anche in questo caso l’ipotesi è più che probabi-le. La lezione di C1GILMS (che lanima a [C1 Cha lanima M Chelluomo a] impotenza [S animanpo-tenza M -zia]) è evidentemente parallela a quella di R: e si possono aggiungere C (chellanima apotença) e Z (Che alla mia apparenza), che postulano la presenza turbativa del verbo à, e forse anche F Chea inparvenza supponendo l’omissione del sostantivo. Di fatto si staccano solo gli apparentati BN (cito da N Chellanima inparue(n)za): e potrebbe essere stacco più apparente cheeffettivo, se si legge, come possibile, «che·ll’anim’à».
1072 R Nauichare intutte parte («navicar tutte parte»).Contini: «molto diffuso, forse dell’archetipo».5 Di nuovo amplissimo il fronte che si unisce a
R nell’ipermetria causata da in- BC1FGILNSZ. Fanno eccezione C (Nauicare tucte parte) K (Nauigare tutte parte) e M (Navicar quelle parti), le cui lezioni possono essere tranquillamente poligenetiche, ma che comunque mantengono (tranne M) almeno in apparenza la sillaba in eccesso di nauicare.
Per concludere, ancora due brevi annotazioni di complemento. Contini, nella sua rico-struzione, ipotizzava undici errori certi e tre probabili per individuare l’archetipo.6 Aquesti, come si vede, se ne possono aggiungere altri tre. Pur senza raggiungere il livel-lo di patologia sottolineato anni fa da Guglielmo Gorni per il Convivio,7 rimane, credo,un dato notevole, forse da mettere in connessione con lo stato di incompiutezza dell’opera di Brunetto che potrebbe spiegare varie lezioni erronee d’archetipo. Secon-da osservazione. Sempre la nota al testo continiana segnala, se non ho contato male, untotale di 256 errori di R. Trentacinque di questi, come si è visto, sono in realtà lezioni sicuramente o con varia probabilità ripristinabili a testo, a cui si possono aggiungere letre mende da ricondurre all’archetipo. Tolti questi, rimangono comunque ben più di
1 Faccio seguire tra parentesi alla lezione di R il testo critico di Contini 1960.2 Contini 1960, ii, pp. 870-71.3 Congettura dell’antigrafo comune a BN e forse di quello comune a CC1 (sui rapporti tra i quali vedi
sopra, p. 31, nota 3). Si tenga inoltre conto che G, di cui I come dicevo prima (vedi sopra, p. 33, nota 4) èforse una copia, presenta l’errore en figura. 4 Contini 1960, ii, p. 871.
5 Contini 1960, ii, p. 871. 6 Contini 1960, ii, p. 870.7 Gorni 1997, pp. 16-17, dove si osserva tra l’altro che «Per la Vita Nova, Barbi ha potuto indicare (e
abbondava per eccesso) non più di quattro errori d’archetipo» (p. 16).
tre annotazioni al «tesoretto» 39
duecento versi errati, ossia quasi uno su dieci, ed è, questa, una percentuale piuttostoinquietante. Il problema di R, evidente a chi si avvicina alla situazione testuale del Te-soretto, è insomma questo: il manoscritto rappresenta da solo la metà della tradizione(il dato difficilmente potrà essere revocato in dubbio), è sicuramente il codice più anti-co del testo ma, nello stesso tempo, è un codice tutt’altro che degno di fiducia. In uncerto senso, si può dire che il punto di forza e nel contempo di debolezza della propo-sta Contini (e già Wiese) stia proprio in questo, ossia nel fornire una specie di edizionebédieriana del poemetto che rinuncia quasi per statuto (se non per incontri sporadici)al controllo della famiglia concorrente (le cui coincidenze puntuali di lezione che im-plicano questo o quel manoscritto, ove non sorrette da altre considerazioni, potrannoessere sempre sospette di contaminazione). La procedura, sia detto chiaramente, datele premesse era ed è impeccabile, ma quanto appena sottolineato rende a questo pun-to urgente e auspicabile un’analisi della numerosa famiglia non-R, così da poterne uti-lizzare al meglio le potenzialità di raffronto nella costituzione del testo.
Abbreviazioni bibliografiche
Beltrami 1993 = Pietro Beltrami, Tre schede sul «Tresor», «Annali della Scuola Normale Superioredi Pisa», Classe di Lettere e Filosofia, s. iii, 23, nº 1, pp. 115-90.
Beltrami 1994 = Appunti su vicende del «Tresor»: composizione, letture, riscritture, in L’enciclopedismomedievale, a cura di Michelangelo Picone, Atti del Convegno (San Gimignano, 8-10 ottobre1992), Ravenna, Longo, pp. 311-28.
Beltrami e a. 2007 = Brunetto Latini, Tresor, a cura di Pietro G. Beltrami, Paolo Squillacioti, Pli-nio Torri e Sergio Vatteroni, Torino, Einaudi.
Bolton Holloway 1981 = Brunetto Latini, Il Tesoretto (The Little Treasure), ed. and transl. by JuliaBolton Holloway, New York-London, Garland Publishing.
Bolton Holloway 1986 = Julia Bolton Holloway, Brunetto Latini. An analytic bibliography, London,Grant & Cutler Ltd.
Bolton Holloway 2000 = Brunetto Latini, Tesoretto, edizione fotografica del codice Strozzi 146,con una presentazione di Giuseppe Fini, nota introduttiva all’edizione di Franca Arduini, prefazione di Francesco Mazzoni, scheda codicologica bibliografica di Ida Giovanna Rao, trascrizione del manoscritto di Julia Bolton Holloway, Firenze, Le Lettere.
Ciccuto 1985 = Brunetto Latini, Il Tesoretto, a cura di Marcello Ciccuto, Milano, Rizzoli.Costa 1987 = Elio Costa, Il «Tesoretto» di Brunetto Latini e la tradizione allegorica medievale, in Dante
e le forme dell’allegoresi, a cura di Michelangelo Picone, Ravenna, Longo, pp. 43-58.Cursi 2010 = Marco Cursi, Un nuovo manoscritto autografo di Antonio Pucci (Firenze, bnc, Magl. vii
1052), sfi, 68, pp. 171-73.Egidi 1905-1927 = Francesco da Barberino, Documenti d’amore, a cura di Francesco Egidi, 4 voll.,
Roma, Società Filologica Romana.Egidi 1940 = Guittone d’Arezzo, Le rime, a cura di Francesco Egidi, Bari, Laterza.Gorni 1997 = Guglielmo Gorni, Appunti sulla tradizione del «Convivio» (a proposito dell’archetipo e
dell’originale dell’opera), sfi, 55, pp. 5-22.Jauss 1964 (1989) = Hans Robert Jauss, Brunetto Latini poeta allegorico [1964], in Alterità e modernità
della letteratura medievale, trad. it. di Maria Grazia Saibene, Roberto Venuti, con una presenta-zione di Cesare Segre, Torino, Bollati Boringhieri, pp. 135-74.
Librandi 2012 = Rita Librandi, La didattica fondante di Brunetto Latini: una lettura del «Tesoretto»,«Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes», 23, pp. 155-72.
Maffia Scariati 2010a = Irene Maffia Scariati, Dal «Tresor» al «Tesoretto». Saggio su Brunetto Latini ei suoi fiancheggiatori, Roma, Aracne.
Maffia Scariati 2010b = Irene Maffia Scariati, Indizi per una datazione del «Tesoretto» (vv. 125-127), inLetteratura e filologia tra Svizzera e Italia. Studi in onore di Guglielmo Gorni, a cura di Maria
40 marco berisso
Antonietta Terzoli, Alberto Asor Rosa e Giorgio Inglese, 3 voll., Roma, Edizioni di Storia eLetteratura: ii, La tradizione letteraria dal Duecento al Settecento, pp. 27-50.
Maggini 1968 = Brunetto Latini, La Rettorica, a cura di Francesco Maggini, prefazione di CesareSegre, Firenze, Le Monnier.
Nathan 1909 = Boncompagno da Signa, Amicitia, a cura di Sarina Nathan, Roma, presso la Società Filologica Romana.
Petronio 1951 = Poemetti del Duecento, a cura di Giuseppe Petronio, Torino, utet.Porta 1990-1991 = Giuseppe Villani, Nuova cronica, a cura di Giuseppe Porta, 3 voll., Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo/Guanda.Rossi 2008 = Luciano Rossi, Messer Burnetto e la «Rose», in A scuola con ser Brunetto. La ricezione di
Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento, Atti del Convegno internazionale di Studi (Università di Basilea, 8-10 giugno 2006), a cura di Irene Maffia Scariati, Firenze, Edizioni delGalluzzo, pp. 119-45.
Rzepka, Sosnowski, Tylus 2011 = Anna Rzepka, Roman Sosnowski, Piotr Tylus, Historia kolekcjirękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie - studium ogólne – The History of the Collection of Romance Manuscripts from the Former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Libraryin Kraków - the overall study, Kraków, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sosnowski 2012 = Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonicadi Cracovia (sec. xiii-xvi), a cura di Roman Sosnowski, con la collaborazione di Jadwiga Miszalska, Magdalena Bartkiwuak-Lerch, Kraków, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiel-lońskiego.
Sundby 1869 (1884) = Thor Sundby, Della vita e delle opere di Brunetto Latini, trad. it. a cura di Ro-dolfo Renier, Firenze, Le Monnier (ed. orig. 1869).
Tonello, Trovato 2011 = Elisabetta Tonello, Paolo Trovato, Contaminazione di lezioni e contamina-zione per giustapposizione di esemplari nella tradizione della «Commedia», fi, 8, pp. 17-32.
Wiese 1883 = Berthold Wiese, Der Tesoretto und Favolello B. Latinos, zrph, 7, pp. 236-389.Wiese 1910 = Brunetto Latino, Il Tesoretto e il Favolello, a cura di Berthold Wiese, Strasburgo,
Heitz & Mundel.Zannoni 1824 = Il Tesoretto e il Favolello di ser Brunetto Latini ridotti a miglior lezione col soccorso dei
codici e illustrati dall’Abate Gio. Battista Zannoni, Firenze, Molini.
composto in carattere dante monotype dallafabriz io serra editore, p i sa · roma.
stampato e r ilegato nellatipo grafia di agnano, agnano p i sano (p i sa) .
*
Febbraio 2015(cz 2 · fg 21)
Fabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 [email protected], www.libraweb.net
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or online official subscription rates are availableat Publisher’s website www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento sul c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Eurocard, Mastercard, Visa).
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 PisaUffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 18 del 26 novembre 2003Direttore responsabile: Fabrizio Serra
*
A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi estratti,ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, ecc.), originale oderivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web personali e istituzionali,academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm,
film, scanner o altro, senza il permesso scritto della casa editrice.
Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part (included offprints, etc.),in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means: print, internet (included personaland institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic, digital, mechanical, including photocopy, pdf,
microfilm, film, scanner or any other medium, without permission in writing from the publisher.
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2015 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale, Edizioni dell’Ateneo,Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa, Gruppo editoriale internazionale
and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
*
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 1724-6113issn elettronico 1825-1021
SOMMARIO
Lucia Cuomo, Il sermone «L’amor di questo mondo» di Ruggeri Apugliese. Edizione ecommento 9
Marco Berisso, Tre annotazioni al «Tesoretto» 15
Giulia Ammannati, Francesco Giancane, Le due epigrafi poetiche in volgaredella chiesa di San Paolo a Poggio Mirteto (inizio del secolo xiv) 41
Elisabetta Tonello, La famiglia Vaticana e la tradizione Boccaccio (con una postillasulla contaminazione) 85
Paolo Chiesa, Una citazione precoce dal «Convivio» nelle cronache di Galvano Fiamma 111
Luigi Zambelli, Tethi/Theti: Bembo, «Rime», 117, 14 119
Claudia Russo, Primi appunti sulla tradizione delle rime di Angelo Di Costanzo (conun sonetto inedito) 123
Francesco Venturi, Per il testo delle «Rime» di Annibal Caro 155
Anna Rinaldin, Le «Poesie» (1872) di Niccolò Tommaseo. Saggio di edizione criticacommentata 195
Indici, a cura di Fabio Romaninii. Indice dei nomi 229ii. Indice dei manoscritti e dei postillati 239
Sigle impiegate in questa rivista 245