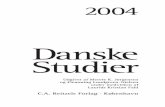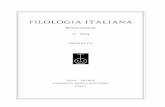Tre gammeldanske prædikener: Et nyt tilskud til den gammeldanske homiletiske litteratur
Origine di tre cognomi campione: Favaretto, Rondini, Silvestri
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Origine di tre cognomi campione: Favaretto, Rondini, Silvestri
PREMESSA:
ORIGINE DEL COGNOME O DELLA FAMIGLIA?
La prima cosa da considerare è se possiamo parlare di origini
certe o solamente di supposizioni.
Nella stragrande maggioranza dei casi è possibile esclusivamente
formulare delle ipotesi che possano avvicinarsi con minore o
maggiore probabilità alla fonte del cognome stesso.
Dobbiamo considerare che anche ove esistessero degli scritti
antichi, dove si possa leggere il tal dei tali venne chiamato xxxx
il giorno tale per il motivo tale, queste informazioni dovrebbero
essere prese sempre, o quasi, con beneficio d’inventario. Gli
scritti sono opera umana, soggetti quindi agli errori tipici
degli esseri umani, errori che vanno dalla distrazione, alla
cattiva interpretazione delle fonti, all’interesse personale e a
quant’altro possiamo immaginare. Si può affermare quindi che
Origine dei cognomi
4
i cognomi, dei quali si possano avere certezze, risultino essere
solamente, o quasi, quelli attribuiti in maniera ufficiale a dei
trovatelli, fenomeno, quello dei fanciulli senza padre, che ha
influito in larga misura sull’origine dei cognomi italiani.
Immediatamente dopo, in ordine di affidabilità nell’attribuzione
dell’origine, arrivano i cognomi dei nobili per i quali esistano
concrete tracce storiche su vari testi o documenti d’archivio.
Lo studio dei cognomi si basa innanzi tutto sulla determinazione
della zona geografica in cui si potrebbe essere sviluppato il
cognome; questo permette di determinare quali possano
essere la storia del territorio, le regole e le lingue interessate
alla formazione dello stesso ed il nome, dei possibili paesi che
possono aver dato origine ad un cognome in quanto luogo di
provenienza dei capostipiti.
Per i cognomi extraterritoriali come ad esempio Rossi o Neri e
derivati, ci si dovrà basare esclusivamente su elementi comuni
all’intera nazione, non escludendo comunque la possibilità di
origini anche completamente diverse ed a volte estremamente
particolari.
Una volta determinata la zona di maggior diffusione, è bene
verificare se troviamo tracce che possano permetterci di farci
Favaretto Rondini Silvestri
5
un’idea della situazione del cognome circa un centinaio di anni
fa, elemento che permette con maggior grado di affidabilità di
identificare l’area di distribuzione geografica del cognome.
Diciamo pure che per un’analisi più completa ed affidabile
sarebbe necessario uno studio in loco presso gli archivi
comunali o parrocchiali, fatto che potrebbe a volte permetterci
di individuare il momento più lontano di comparsa di una
traccia scritta di quel cognome, ovviamente ricerche di questo
genere per ogni cognome sarebbero lunghe e difficili.
Ipotizzando di essere riusciti a determinare la possibile area di
diffusione del cognome è necessario richiamare alla memoria i
fatti storici che siano accaduti in quella zona, in particolare la
successione delle occupazioni da parte di popoli stranieri, che
possano aver influito sulla lingua e sugli usi locali.
Come è facilmente intuibile non esistono certezze del e sul
risultato, che è funzione delle conoscenze linguistiche e storiche
di chi effettua la ricerca, ma anche della sua capacità di analisi,
che ci si augura sempre sia la più ampia e rigorosa possibile.
Molti inoltre, confondono due concetti apparentemente simili,
ma sostanzialmente diversi. L’origine dei cognomi e l’origine
delle famiglie non sono la stessa cosa.
Origine dei cognomi
6
La lingua italiana si presta a molte interpretazioni e i vocaboli
sono spesso meglio interpretabili inserendoli nel loro contesto.
Prendiamo a esempio la parola origine dal lat. origo -ginis,
derivato da oriri (alzarsi, nascere, provenire, cominciare)
utilizzata in italiano con molti significati: quando si parla
di origine dei cognomi ci si riferisce alle origini delle parole
utilizzate per identificare molto spesso ben più di una famiglia
e di un ceppo famigliare e si ricerca quindi la loro etimologia.
Lo studio dell’origine delle famiglie, intese come ceppo
famigliare è invece quella ricerca che tenta di risalire al primo
componente che abbia iniziato a chiamarsi in quel modo,
con quel cognome di quella particolare famiglia. Per lo
studio dell’origine dei cognomi ci si deve riferire agli elementi
linguistici, storici e geografici che possono aver portato alla
nascita di un particolare identificativo cognominale, elemento
che può essere molteplice ed anche molto differente per i vari
ceppi famigliari pur con il medesimo cognome.
Per lo studio dell’origine delle famiglie la questione si complica
enormemente potendo esclusivamente utilizzare gli archivi
storici attualmente presenti, che sono le anagrafi comunali, gli
archivi delle Parrocchie, gli archivi di Stato.
Favaretto Rondini Silvestri
7
Le anagrafi comunali sono quelle che esistono da minor tempo,
in alcuni comuni risalgono appena all’ultima guerra mondiale
a causa delle distruzioni belliche.
L’obbligo per i Comuni italiani di tenere registri di nascita della
popolazione è entrato in vigore dal primo settembre 1871 con
l’Unità d’Italia, nel Sud Italia continentale lo stato civile fu
istituito nel 1808 da Gioacchino Murat, re di Napoli, nel nord
Italia in qualche caso si può risalire fino al periodo napoleonico,
cioè fino alla fine del 1700, o a quello asburgico, cioè alla quarta
decade del 1700.
Le parrocchie che avrebbero dovuto, a seguito del Concilio
di Trento con disposizioni del 1563, tenere una registrazione
di tutte le nascite, non sempre lo fecero, non sempre i registri
sono consultabili, non sempre lo stato di conservazione è tale
da permettere di leggere alcunché.
Gli archivi notarili sono anch’essi utili per una ricerca, ma non
sempre possono essere consultati.
Da quanto sopra scritto si evince quante reali difficoltà
sussistano nei tentativi di inseguire a ritroso partendo dai
dati di nascita e matrimonio del componente meno prossimo
di una famiglia, dei cui dati si possa essere certi, cercando di
Origine dei cognomi
8
individuare tra battesimi e matrimoni il livello generazionale
precedente.
Il mio studio, ad ogni modo, è rivolto esclusivamente all’origine
etimologica dei cognomi.
RAPIDA CRONOLOGIA
SULL’USO DEL COGNOME IN ITALIA
L’uso del cognome come identificativo di una famiglia si fa
risalire all’antica Roma, anche se per lungo tempo le persone
furono designate dal signum o nomen singolare, ossia da un
solo nome.
Già negli ultimi secoli della Repubblica romana però, le persone
libere cominciarono ad adottare la formula con tre nomi
(l’inizio forse posto attorno al III° sec. a. C.) (tria nomina):
praenomen (che distingueva l’individuo ed era paragonabile
al nome proprio di persona contemporaneo: in Caius
Julius Caesar, il praenomen è Caius),
nomen (che denotava la gens dí appartenenza: in Caius
Julius Caesar è Julius)
cognomen (che era usato per distinguere le famiglie
all’interno delle gentes).
Origine dei cognomi
10
Nel I° secolo d.C., in seguito alla trasformazione di Roma in
Impero, la distinzione fra nomen e cognomen si fece sempre
più sfumata e divenne comune l’uso di un nome unico
(detto supernomen o signum, con le caratteristiche di non
essere ereditario e di avere un significato immediatamente
comprensibile (ad esempio il nome imperiale Augustus che
significa consacrato dagli àuguri o favorito da buoni auspici).
Dopo la caduta dell’Impero romano, ogni persona veniva
identificata dal solo nome personale, di cui venivano usati
vezzeggiativi in ambito familiare. Tali nomi venivano a volte
riferiti anche alle caratteristiche della persona (come il colore
dei capelli), alla provenienza o alla paternità.
L’avvento della religione cristiana e le ripetute invasioni
barbariche facilitarono la diffusione di nuovi nomi che si
andarono ad aggiungere ai nomi già in uso, in modo che non
vi fossero particolari difficoltà nel distinguere gli individui.
Tra il X° secolo e l’XI° secolo in Europa si verificò una grande
crescita demografica, e divenne sempre più complicato
distinguere un individuo da un altro con il solo nome
personale. Si rese nuovamente necessario allora identificare
Favaretto Rondini Silvestri
11
tutti gli individui appartenenti alla medesima discendenza con
un altro nome. Nacque così il cognome moderno.
Tale cognome poteva essere originato da una caratteristica
peculiare delle persone, come ad esempio la loro occupazione,
o il luogo d’origine, il loro stato sociale o semplicemente il nome
dei genitori: Rossi (il cognome più diffuso in Italia) potrebbe
far riferimento al colorito della carnagione o dei capelli di
qualche antenato; Fiorentini probabilmente provengono
originariamente da Firenze, Di Francesco potrebbe indicare
figlio di Francesco.
In Italia, l’uso dei cognomi fu inizialmente una prerogativa
delle famiglie più ricche. Tuttavia tra il XIII° secolo e il XIV°
secolo l’uso si estese agli strati sociali più bassi.
Il Concilio di Trento del 1564 sancì l’obbligo per i parroci di
gestire un registro dei battesimi con nome e cognome, al fine
di evitare matrimoni tra consanguinei.
Nacquero così i cognomi, che derivano principalmente da tre
fonti:
onomastica (da nomi propri di persona) 40%
toponomastica (nomi generici o propri di luogo) 35%
soprannomi 25%
Uso dei cognomi
I cognomi non sono in uso in ogni stato del mondo; i Tibetani
e gli abitanti dell’Isola di Java spesso non ne utilizzano: persone
note che non hanno un cognome comprendono Suharto e
Sukarno. Inoltre, molte famiglie reali non utilizzano cognomi.
L’Islanda è l’unico paese europeo dove in luogo del cognome è
in uso il patronimico. Vale a dire, ogni persona assume come
cognome il nome del padre seguito dal suffisso son se maschio,
dottir se femmina. Quindi, solo i fratelli maschi o sorelle
femmine avranno cognome uguale fra loro, mentre nella stessa
linea di fratelli e sorelle ci saranno due cognomi. L’elenco
del telefono è compilato in ordine del nome di battesimo. È
comune per le donne cambiare il proprio cognome con quello
del marito dopo il matrimonio.
Alcune nazioni, ad esempio il Giappone o la Romania non
permettono che la moglie mantenga un cognome diverso da
quello del marito. Altre nazioni permettono di mantenere il
Favaretto Rondini Silvestri
13
cognome da nubile, ma il cambio è in qualche modo suggerito
o incentivato. Altre nazioni ancora permettono l’opposto, cioè
che l’uomo prenda il cognome della moglie. Alcune persone
scelgono di mantenere ambedue i cognomi, spesso uniti con
un trattino.
In Ungheria le donne sposate sono chiamate ufficialmente
con il cognome e il nome del marito seguiti dal suffisso -né; ad
esempio, la moglie di un uomo di nome János Szabó (o Szabó
János, nell’ordine ungherese che pone prima il cognome) è
chiamata Szabó Jánosné.
In India i figli prendono come cognome il nome proprio del
padre, le donne quando si sposano cambiano cognome e
prendono quello del marito.
In Spagna e nei paesi ispano-americani i figli assumono sia il
primo cognome del padre che il primo della madre, eccetto
che in Argentina e in Uruguay, dove i figli assumono solo il
cognome paterno.
In Portogallo e in Brasile i figli assumono, nell’ordine, il primo
cognome della madre e il primo cognome del padre.
In Italia l’attuale normativa sul Diritto di famiglia prevede che
la moglie conservi il suo cognome di nascita aggiungendo,
Origine dei cognomi
14
su richiesta, nei documenti ufficiali la dicitura ... coniugata
XXX. I figli nati da coppie legalmente sposate prendono
automaticamente il cognome del padre.
In Italia esistono 350.000 cognomi, un primato mondiale,
mentre i nomi propri sono circa settemila.
Origine dei cognomi italiani
Bisogna premettere che le investigazioni sui cognomi risultano
assai difficili e incerte; nel campo degli studi onomastici1
(toponomastica2, antroponimia3) tuttavia non mancano studi
ed esplorazioni archivistiche, come l’opera di Dario Soranzo
Cognomi dei Veneti. In questo lavoro Soranzo raccoglie la sua
indagine su 852 cognomi delle province di Padova, Venezia e
Treviso (in realtà sono le 852 forme cognominiali che superano
la soglia delle 100 unità per provincia, espunti dunque i
1 L’onomastica è la disciplina linguistica che si occupa dello studio dell’origine e del significato dei nomi propri in generale e viene ripar-tita in ANTROPONIMIA e TOPONOMASTICA.
2 Ramo delle scienze linguistiche che studia l’origine e il significato dei nomi di luogo (città, paesi, strade, laghi ecc.). Dal greco topos luogo onoma nomeî.
3 Dal greco anthropos uomoî e onoma Nomeî, quindi nome di persona. L’antroponimia è la disciplina che studia i nomi, cognomi, soprannomi di persona.
Origine dei cognomi
16
cognomi ripetuti, le varianti, ecc.). Nella ricerca compiuta dal
dialettologo veneto, emerge come la derivazione dei cognomi
veneti possa essere letteraria (Dante), religiosa (Pagan =
pagano), medioevistica (Borgato), fisica (soprannomi indicanti
qualità fisiche, Rossi e morali, Dotto), professionale (cognomi
derivati dalle professioni svolte, come Forner, Cester), vegetale
o animale (Ceolin = cipolla, Cervi), vocativale (Amadio = ama
Dio), vezzeggiativa (Vazzoleretto), geografiche (Feltre), ecc.
Nella nostra regione il cognome è maschile per genere e singolare
per numero, mentre, secondo l’opinione dello Svizzero Paul
Aebischer, i cognomi in “i” (Nenzi, Giacomini ecc.) sarebbero
in realtà non dei plurali, bensì rimasugli di un genitivo singolare
latino, tramandato e generalizzato dall’uso notarile dei tempi
medioevali, in quanto non si tratta di sostantivi ma di aggettivi
(ad es. Benedetti).
Tuttavia esistono anche veri e propri plurali, come Bianchi
Rossi ecc. risalenti all’antico uso di connotare tutta la famiglia,
soprattutto quelle in cui ci si tramandava da generazioni lo
stesso mestiere.
Diamo uno sguardo alle derivazioni:
Favaretto Rondini Silvestri
17
CLASSICA : ridimensionata durante il Medioevo, non è
molto rappresentata nei cognomi veneti (Cesaro,
Costantini);
RELIGIOSA : è al contrario uno dei filoni più consistenti,
rappresentata dai cognomi derivati dai nomi dei
santi (Agnoletti, Angeli, Bortolamiol)
LETTERARIA MEDIOEVALE : cognomi tratti da eroi e
personaggi dei poemi epici
e cavallereschi (Paladin,
Danesin), oppure derivati dal
ciclo della Tavola Rotonda:
Artuso, Merlin, Galiazzo;
GERMANICA : Berto, Dorigo, Mazzon, Vendrame;
GEOGRAFICA ED ETNICA4 : Visentin, Trevisan, Veronese,
Pavan, Greco, Albanese,
Stradiotto (gli stradiotes
erano un corpo della
polizia veneziana composta
4 Dal greco ethnos popoloî, appellattivo del paese d’origine.
Origine dei cognomi
18
da Kossovari), Cipriotto,
Schiavon, Furlan, Milan,
C r e m o n e s e , F r e g o n e s e ,
D’Este, Modanese;
IMPERATIVALE : Cacciavillani, matrice medioevale: per
es. Ivone (Il) Caccia villani, indica che
vi è contenuta la forma imperativa di un
verbo;
AUGURALE : altro retaggio medioevale, ma di scarsa
rilevanza (Ben e- nato = Beninato) ;
PROFESSIONALE: Bottaro, Segato, Tagliapietra;
DA CARICA O DIGNITAí: Conte, Abate, Duse, Cusinato;
DA PIANTE E ANIMALI : per i primi si può supporre una
relazione dei cognomi con le
professioni agricole Sala, Verza,
per i secondi potrebbero essere
qualità che l’uomo attribuisce
all’animale, poi divenute cognomi
per le persone che ne presentano
Favaretto Rondini Silvestri
19
le caratteristiche Cagnin, Gatto,
Levorato (se pensiamo alla velocista
veneziana Manuela Levorato:
Levorato da lepre, notoriamente
un animale molto veloce), Lovato;
FISICA E MORALE : eterno ritornello nei discorsi della pratica
quotidiana (da che mondo è mondo, è
molto più semplice ridere delle altrui
disgrazie che pensare ai fatti propri).
Fissata a memoria la differenza fisica con
il cognome, esso in questi casi nacque
proprio come discriminante: Smania,
Paccagnella, Piccolo, Gobbo, Gobbato,
sia in senso negativo che positivo.
Origine dei cognomi
20
Tabelle riassuntive
Forma finale Esempio di composizione
Origine
Isi Tro-isi, Pugl-isi Napoletani o Siciliani
Aloro Fav-aloro, Orgli-aloro
Siciliani
ago/aghi/ate/ati
Air-aghi, Arcon-ato, Gess-ati
Lombardi
atti/etti Ors-atti, Giorg-etti
Lombardi
di/oldi Sol-di, Garib-oldi Lombardi/germanici
Igo Bardar-igo Veneti
Ato Marcon-atoPoleg-ato Gnoc - ato
Veneti
Favaretto Rondini Silvestri
21
troncati con L/N/R
Cana-l, Mani-n, Carre-r
Veneti
acco Acco,B-acco, Bazz-acco, Biss-acco, C-acco Feltr-accoPol-acco
Veneti
otti Bel-otti,Mel-otti Lombardi
otti/utti/ut/ot Bertol-ottiBias-utti G r e g o r - u t t i Danel-ut Franz-ot
Friulani
ai/ini A s t - a i , B o l l - a i , Fornari-ini
Toscani/Lombardi
ucci (nome proprio)-ucci, Bertol-ucci, Ilari-ucci
Toscani
uoli/aiuoli Acciai-uoli, Casci-aiuoli
Toscani
Origine dei cognomi
22
i n g o / i n g h i /enghi/engo
Martin-engo Lombardi o Toscani/germanici
au Bidd-au, Mad-au Sardi
as Cann-as, Pir-as Sardi
u Cadedd-u Sardi
ero/ario Barbe-ero Piemontesi
esio Gorr-esio Piemontesi
ero/ario Molin-ero, Sobr-ero
Piemontesi
audi/aldi Grib-audi, Ramb-audi
Piemontesi
asco Com-asco, Cev-asco
Liguri
oni Ceri-oni, Cesar-oni, Bori-oni
Marchigiani
Favaretto Rondini Silvestri
23
Esempio di composizione Origine
Lo Lo Cicero, Lo Giudice, Lo Iacono
Siciliani
Di Di Croce, Di Pietro, Di Battista, Di Iacovo
Abruzzesi-Molisani
Favaretto
Favaretto è una parola che i docenti di lingua inglese
classificherebbero subito come false friend “falso amico”, quelle
parole che a prima vista paiono significare qualcosa, ma che in
realtà con essa non hanno nulla al riguardo.
A una prima lettura del cognomen, appare sin troppo evidente
la presenza di fava - come radice. Questo non ci deve ingannare,
in quanto nel periodo storico in cui il cognome nacque e,
soprattutto, nel luogo geografico e linguistico di nascita, la
parola fava non era utilizzata per designare il legume.
Andiamo con ordine.
FAVARETTO derivato da FAVARO o FAVERO,
accrescitivo FAVARON, vezzeggiativo FAVAROTTO
Molto diffuso nell’area che comprende il Padovano, il Veneziano
ed il Trevisano.
Origine dei cognomi
26
Il cognomen matrice è Favaro o Favero (la diversità di vocale
è data dalla geografia linguistica del Veneto: Favaro in Veneto
Favero in Trentino e Friuli), ancora più diffuso, occupa la
stessa area di Favaretto e ha ulteriori ramificazioni in Favaron,
decisamente meno diffuso, più specifico di Padovano e
Veneziano, Favarotto, molto più raro, è specifico di Trevisano
e Veneziano.
Favaro presenta forme di apposizione singolare o plurale che
sono tipiche dei soprannomi di mestieri tradizionali (Fabbro
- Fabbri), ma anche versioni latineggianti (Fabris). Radice di
partenza non sarebbe neppure Favaro, ma Favro (fabbro in
dialetto), con aggiunta della vocale paratattica (in questo caso
la a) per facilitare la pronuncia -vr che il dialetto veneto fatica
a pronunciare.
La zona d’origine di questi cognomi dovrebbe essere tra le
provincie di Padova, Venezia e Treviso, mentre il significato
deriva in realtà non dal legume (fava), ma dal termine dialettale
antico favaro o favero (fabbro), mentre il ramo trevigiano
dei Favero dovrebbe provenire da Favro di Solighetto (TV) e
nel 1200 fece parte del Maggior Consiglio della Serenissima
Favaretto Rondini Silvestri
27
Repubblica di Venezia, con tanto di arma araldica. L’arma
in araldica è lo stemma gentilizio della famiglia. Nel gergo
araldico, in particolare, si descrive lo stemma dei Favero come
rappresentato da una banda (ovvero striscia orizzontale) giallo
su campo (sfondo) rosso. È uno stemma molto importante
quello dei Favero, in quanto povero e privo di raffigurazioni o
altri riempitivi. La presenza di una sola banda denota il rango
nobiliare primario (quindi famiglia di antica origine nobiliare).
La presenza delle bande, una o al massimo due, significa, cito
da un mio precedente lavoro: pezza onorevole di primo ordine,
rappresentante il simbolo del cingolo cavalleresco (il cingolo
era la cintura che reggeva la spada del cavaliere: chi possedeva
il cingolo dello stemma aveva l’obbligo di portarlo di fronte
all’Imperatore di Germania, che ricordo, era sulla carta il
sovrano legittimo del Veneto)5. Mentre il rosso è presente negli
stemmi delle sole famiglie dell’originaria nobiltà della città di
Treviso, come i Menegaldo; è simbolo di coraggio e vigore
in battaglia, audacia, fortezza, dominio e nobiltà cospicua (il
suo uso nell’arma era permesso solo a principi e cavalieri).
5 Simone Menegaldo, Medium Urbis. Duemila anni di storia in riva alla Piave, Sismondi Editore, Salgareda (TV), 2010, p. 152.
Origine dei cognomi
28
Probabilmente i Favero, come i Menegaldo (da Manegold colui
che regge il collare, ovvero il sommo giudice) avevano origine
longobarda.
Fra i Longobardi vi erano solo tre generi di uomini: gli uomini
liberi (i guerrieri), detti Arimanni, i commercianti e gli artigiani,
detti Aldii e gli schiavi. Derivando Favaro e Favaretto da favro
= fabbro, ne possiamo arguire che la progenie originaria
appartenesse agli Aldii; essendo quei secoli periodi di guerra
continua (565-1453 il Veneto è sempre costantemente
attraversato da eserciti in guerra), non doveva essere difficile
per un fabbro arricchirsi ed entrare nell’alta società cittadina.
Tale ipotesi è supportata dall’origine del cognomen ladino
Faurét: nella zona bellunese di lingua ladina infatti, fabbro è
fàure, da cui Faurét (piccolo fabbro), che si trova anche in forma
italianizzata con Favretti. Il casato dei Faurét è originario della
zona di Fornes, dove esiste un antico detto che recita: Faurét
e Pòldi mat par i sòldi!, che tradotto sarebbe Fabbri e Fornai
(Pòldi) bramosi di soldi!
Ma dopo simili disquisizioni attorno alla probabile nascita del
cognomen Favaro (di cui Favaretto), appare opportuno riportare
ora lo stemma dei Favero, così come si trova nei testi araldici
Favaretto Rondini Silvestri
29
specializzati (Dolcetti, Crollalanza):
Ed è nel Trevigiano che il cognomen Favaretto nasce: la
prima attestazione della presenza del cognome la troviamo a
Preganziol (TV) nell’archivio della Parrocchia, da cui risulta
che i Favaretto risiedono nel Comune con certezza dal
Cinquecento; è un documento eccezionale, perché è uno dei
rarissimi casi in cui siamo certi della nascita di un cognome: il
documento porta la data 1564, un anno posteriore al Concilio
di Trento. Tale documento, è l’atto di nascita del figlio del
fabbro, che viene battezzato appunto Favaretto.
Anche il Francipane ed Emidio De Felice, derivano il cognome
Favaretto da fabbro - piccolo fabbro, mentre è interessante il
Pittau nel Dizionario dei cognomi di Sardegna II, p. 25, che
lo dice derivato dal sostantivo fava, che apparirebbe essere la
soluzione più ovvia, almeno a un primo disattento sguardo alla
Origine dei cognomi
30
radice, ma che ci indica come in Sardegna sia nato un ceppo
simile dalla stessa radice; forse emigrati? In quale periodo
storico?
Se il cognome derivasse da fava, dovremmo pensare a una
persona che aveva qualcosa a che fare con l’agricoltura, una
persona contadina, povera, che difficilmente poteva accedere
alle alte cariche nobiliari trevigiane. Quindi ora, è opportuno
spiegare perché il cognome derivi da favro = fabbro e non da
fàva.
L’IMPORTANZA DELLA GEOGRAFIA LINGUISTICA
Come dicevo prima, all’inizio di ogni ricerca la prima domanda
da porsi è: da quale ambito geografico d’Italia può arrivare il
cognome? Credo infatti, non esista stato al mondo con una tale
varietà dialettale quale esiste nel nostro paese.
Andiamo con ordine:
la parola fabbro, in veneto si rende con fàvro (Boerio),
specie nel Veneto antico, dove fàvro dà anche il nome a
una calle veneziana;
Favaretto Rondini Silvestri
31
derivazioni di fàvro sono fàvaro (nel basso Trevigiano),
feraro (verso la montagna), fauro (zona Grappa), fravo
(verso il Padovano) e addirittura pestafero in Sinistra
Piave;
inoltre, la parola fàvaro si usa per indicare il fabbro ferraio,
mentre per il fabbro che realizza le chiavi, si usava
magnano;
e ancora, altre determinazioni di fàvro (p. fàvri), sono
marescalco (il vocabolo più recente, anche perché usato
diffusamente dopo la Grande Guerra, quando nelle
nostre zone è diventata famosa la famiglia Marescalchi,
che produceva i ferri per le botti da vino), feràro e
ferariol, usati rispettivamente nel gergo dialettale del
centro di Treviso la prima e della periferia della città la
seconda. Questo per capire perché il dialetto veneto non
può essere insegnato a scuola: bisognerebbe chiedersi
quale dei mille esistenti!
fabbro deriva dal latino fabro, meglio faber, bri o fabrum (in
accusativo), mentre fàva deriva da faba (- m), ae, e dal
greco fagra (la cui radice fag- indica mangiare) quindi
due origini linguistiche molto diverse;
Origine dei cognomi
32
in ladino bellunese, fabbro era fàure, da cui il cognome
Fàuret (piccolo fabbro), italianizzato in Fàvret o Favretti
o De Faveri;
soprattutto però, fàva non era in uso nel nostro dialetto
per designare la fava. Fàva, in dialetto era detta faa
(questo sì abbastanza universale nel Trevigiano); il
termine fàva era usato per designare non il legume ma il
dolce, la fàva dei morti o fàvete dei morti, quel dolce che
tradizionalmente, sino a pochi anni fa si usava preparare
il giorno dei morti.
E FAVETE DEI MORTI
La fàva dunque, in dialetto sarebbe un dolce a forma di fava,
realizzato con uova, zucchero, pinoli o mandorle. Ingredienti
quindi poveri, della base contadina della popolazione.
Era tradizione preparare tale dolce per il giorno dei morti; la
nascita della leggenda legata alle fàvete dei morti, dimostra
la diffusissima presenza di riti pagani in una popolazione
da sempre molto religiosa come quella veneta (anche se
recenti studi tendono a spostare la definizione da religiosa a
Favaretto Rondini Silvestri
33
clericale).
Pare, secondo la leggenda, che tutto nasca nel negozietto di un
venditore di fave veneziano, ubicato nei pressi della chiesetta di
Santa Maria della consolazione, che nel XVIII° verrà ribattezzata
per l’appunto La Madonna della Fava. Tale venditore di fave
però, in realtà non era altro che un contrabbandiere di sale,
che usava il negozio come copertura per i suoi traffici. Le pene
per chi contrabbandava il sale all’epoca erano pesantissime,
sicuramente c’era la galera e il sequestro dei beni, in alcuni casi,
quelli da Venezia più ritenuti gravi, si poteva anche rischiare la
pena di morte.
Questo commerciante teneva il sale ben nascosto sotto i sacchi
di fave, ma un bel giorno il suo traffico viene scoperto e sta per
ricevere la visita dei birri (in veneziano, i poliziotti erano i birri,
oggi sbirri). Sapendo di rischiare molto e non avendo tempo
per sbarazzarsi delle prove, fece voto solenne alla Madonna, la
quale, se l’avesse aiutato, avrebbe beneficiato della distribuzione
gratuita ogni anno, nel giorno dei morti, di un sacco di fave ai
poveri di Maria. Il miracolo si compì e la Madonna fece sparire
il sale da sotto le fave, cosicché i birri, venuti a controllare il
negozio, cercarono ovunque ma non trovarono altro che fave.
Origine dei cognomi
34
Da lì, cominciò l’usanza a cui erano tenuti i nobili delle città, di
donare ai poveri baccelli pieni di fave il giorno dei morti.
Effettivamente non sappiamo quanto la pratica fosse diffusa
fra i nobili, ma diverse opere letterarie minori ci lasciano
brevi frammenti di come fosse soprattutto la nascente classe
borghese a operare queste elargizioni, ovvero i mercanti; la
cosa, effettivamente, se la si lega alla vicenda che fa nascere la
leggenda, può anche essere vista come un metodo per comprarsi
l’omertà del popolino che copra i traffici illeciti di questa fascia
sociale. Che ringraziava per l’omertà con elargizioni una
tantum.
Ma perché, ci si potrebbe chiedere, proprio il giorno dei morti?
Ecco, nella scelta del giorno emerge tutta la componente pagana
del popolo veneto, che oggi magari può farci sorridere, ma che
nella realtà é parte profonda della nostra cultura.
Presso i Greci e i Romani, si credeva che le anime dei morti
trasmigrassero nelle fave; le fave non facevano parte della
dieta delle antiche popolazioni mediterranee, tanto che nelle
coltivazioni erano usate solo come antiparassitario naturale, in
quanto era stato osservato che all’interno di una coltivazione,
se venivano piantate delle fave i parassiti si avventavano solo
Favaretto Rondini Silvestri
35
su di esse. I filosofi greci addirittura rifuggivano soltanto da
toccarle: Pitagora, in fuga dagli uomini di Cilone, potendo
mettersi in salvo attraversando un campo di fave, preferì
attendere il nemico ed essere ucciso, piuttosto che toccare quei
frutti impuri.
Insomma, nella tradizione greco-romana c’era il divieto assoluto
di cibarsi di fave e la veridicità di tale credenza era sostenuta dal
fatto che nei petali delle piante di fava si possono intravedere
delle Omèga (Ώ), che significavano la fine della vita.
Questo particolare legume, rimane legato alla tradizione
pagana sino al consolidamento del Cristianesimo, quando
le cose si modificano leggermente: le fave nel primo periodo
della cristianità cominciano a essere mangiate nelle mense dei
poveri, in seguito alla morte di un caro e al giorno dei morti,
quando le fave entrano a far parte del rituale attraverso il quale
si riceve lo spirito dei defunti (come mangiando la particola si
riceve il corpo di Cristo, è una trasformazione dell’eucaristia in
salsa contadina).
Le classi più agiate invece non consumavano le fave, ma non
per superstizioni o altro, ma per la loro sconvenienza: erano
infatti un legume un pò difficile da digerire, che provocava
Origine dei cognomi
36
soprattutto gonfiori di stomaco e quindi flatulenze. È verificato
infatti, dai galatei di corte bizantini, che sanciscono il protocollo
per i banchetti imperiali (adottati anche a Venezia in quanto
la città ha origini bizantine, sono i bizantini a edificarla e a
regnarvi sino all’810) che le fave sono bandite dalle tavole di
corte perché causa di disdicevoli arie. Dato che il protocollo
doveva essere seguito anche dai nobili di corte, è immaginabile
che rapidamente si estese anche alle corti della Terraferma, i
cui nobili aspiravano a entrare nel patriziato veneziano.
Il destino delle fave però, è destinato a cambiare ancora:
diventano uno degli elementi principali della dieta contadina,
e questo è confermato dall’aumento dei casi di favismo a partire
dall’anno Mille. Diventando cibo della dieta comune, il loro
ruolo di comunione coi morti venne meno, ma resisteva l’uso
di celebrare con le fave le funzioni del giorno dei morti. Non
più mangiandole però: ora infatti, le si spargeva su un tavolo
per trarne gli auspici, soprattutto per gli affari, gli amori o per
comporre le liti di vicinato, una volta l’anno, il giorno dei morti
(butàr fàve).
Favaretto Rondini Silvestri
37
Favéte dei morti.
Col passare del tempo però, tale usanza si slega dalla festività e
comincia a essere usata con sempre maggiore frequenza, tanto
da portare alla nascita di una vera e propria professione, specie
a Venezia, quella delle lettrici di fave. La chiesa ovviamente,
preoccupata per l’adesione del popolino a tali forme di aiuto
piuttosto che a quelle offerte dal clero, comincia a dare il via,
dal Cinquecento, a una vera e propria caccia alle streghe.
Interessanti a questo proposito sono infatti i processi
dell’Inquisizione, contro:
la Gobba butta fave, della Calle ai Do ponti
l’Agnesina de San Trovaso e la Mora de Sant’Aponal
Origine dei cognomi
38
In particolare, la nemica principale del Gran Inquisitore era
la Gobba, perché turbava l’ordine pubblico della congrega
delle streghe praticando prezzi popolarissimi per vincere la
concorrenza, dai 4 ai 6 soldi (1 soldo era 1/20 di lira nel dialetto
di allora, la lira si diceva davinti).
La scure dell’Inquisizione si abbatté dunque sulle povere donne
che si erano inventate di leggere i tarocchi (diremmo ora) per
sopravvivere e le fave spariscono dalla cultualità del popolino
per entrare in quella delle classi più agiate, che, come detto
prima, elargivano il giorno dei morti il sacco di fave ai poveri
in memoria del miracolo della Madonna (e per ingraziarsi il
loro silenzio).
La cosa straordinaria di tutto questo, è che con la caduta di
Venezia viene meno l’usanza di donare il sacco di fave ai
poveri, ma i poveri si ripresero il loro rito: ricomparvero nelle
case contadine, le fàvete dei morti, che venivano preparate per
il giorno dei morti da consumare durante le funzioni famigliari
per i propri defunti e garantirsi la loro protezione.
Questo fu un risvolto antropologico enorme, che effettivamente
meriterebbe uno studio approfondito; é probabile, che venendo
meno una consuetudine ed essendo violentemente cambiato il
Favaretto Rondini Silvestri
39
regime di Governo, lo schock per la popolazione comune sia
stato tale, da portare il popolo a recuperare una tradizione
passata, dal forte impatto emotivo e consolatorio. Una
tradizione che aveva lo scopo di cercare riparo dal presente
appellandosi agli avi, quindi al passato, un passato che nella
tradizione culturale delle masse contadine é sempre visto come
migliore e idilliaco.
IL DILEMMA DEL FAVARETO
Fàvaréto è un vocabolo che dà parecchie complicanze alla
ricerca; è diffuso solo in Destra Piave e indica due specie di
uccello e un pesce.
Favaréto = Saltimpalo (Saxicola Torquata)
Uccello passeraceo della famiglia dei Musciscopidi. 14 cm di
lunghezza massima, piumaggio colorato, becco corto e capo
Favaretto Rondini Silvestri
41
arrotondato. Abita in luoghi palustri e zone alberate, nidifica
sul terreno. Deriva il suo nome dal suo metodo di caccia, che
consiste nello stare immobile in cima a un tronco, palo o stelo
erbaceo per poi balzare sulla preda in picchiata.
Favaréto = Stiaccino (Saxicola rubetra)
Piccolo uccello passeriforme della famiglia dei turdidi,
di origine toscana, migratore, sverna nelle regioni tropicali ma
è distribuito in tutta Italia sulla fascia alpina e appenninica.
A differenza del Saltimpalo, sopra descritto, non è in pericolo
di estinzione.
Origine dei cognomi
42
Favaréto = Castagnola (Chromis castana)
Piccolo pesce dei Pomacentridi, comune sulle coste
scogliose, con il corpo ovale, bruno scuro (color castagna) e
una lunga pinna dorsale spinata. Poco pregiato in quanto ricco
di spine, oltre a Favaréto è detta anche fabreto o fabretto.
Perché queste tre specie animali sono così chiamate nel dialetto
trevigiano di Destra Piave?
Perché questi tre animali hanno tutti la caratteristica di costruire
con dei ramoscelli i loro nidi; nel caso degli uccelli è qualcosa
di eccezionale, in quanto organizzano il nido con pagliericci,
fieno e altre cose racimolate sul terreno, mentre Stiaccino e
Favaretto Rondini Silvestri
43
Saltimpalo fanno qualcosa di diverso: raccolgono pezzetti di
legno e realizzano il nido costruendo un reticolato dal quale
escono anche legnetti a spuntone, spezzati contro eventuali
piccoli predatori d’uova. Questi due tipi dí uccello nidificano
a terra e non sugli alberi e costruiscono con scienza il nido,
organizzato per resistere anche agli attacchi dei predatori,
una sorta di piccolo bunker, in cui anche richiudersi in caso
di pericolo in quanto l’altezza del nido è superiore a quella
dell’animale, che vi entra ed esce dall’alto attraverso un foro,
mentre le pareti sono caratterizzate da legnetti spezzati anti
predatore. Gli altri uccelli non lo fanno.
Nel dialetto quindi, il favaréto è così chiamato in quanto
“artefice”, “piccolo artefice”. Nel caso del pesce, la Castagnola,
avviene più o meno la stessa cosa, in quanto il pesce si costruisce
una casa di muschio e alghe per deporre le uova.
Sono queste, capacità artificiali, nel senso che tali specie animali
hanno sviluppato la capacità di costruire qualcosa in modo
avanzato.
Il dubbio che può sorgere è dunque questo, se Favaretto derivi
direttamente da Favèro, (= fabbro) o prenda il suo nome
proprio dal termine dialettale con cui era chiamato l’animale.
Origine dei cognomi
44
Teoricamente no, in quanto la zona di utilizzo del termine
favaréto per designare il Saltimpalo è molto circoscritta (Treviso
e dintorni), mentre il cognome Favaretto ha una diffusione
molto più ampia, ma nulla vieta di pensare che a Treviso e nel
suo hinterland le cose siano andate così.
Il cognome Favaretto è presente in 228 comuni in tutta Italia
ed é il tredicesimo cognome più diffuso nel Veneto con 230
ceppi famigliari.
Rondini
Ricercare l’esatta nascita etimologica del cognome Rondini é
molto più complicato rispetto a quel che si potrebbe pensare.
Infinite sono le varianti, tutte derivate da Rondine che però, in
forma cognominale oggi é assai raro rispetto a Rondini.
Altre forme di Rondine sono Rondinella, che ha un ceppo tra
napoletano e casertano, uno tra foggiano e potentino, uno nel
leccese ed uno siciliano, nella parte centrorientale dell’isola e
nel trapanese, quindi abbastanza localizzato. Rondinelli invece,
ed é questa la differenza da rilevare immediatamente, ha un
ceppo tra Piemonte e Lombardia, uno nel ravennate, uno nel
Lazio centromeridionale, uno nella fascia che comprende il
salernitano, la Lucania, il barese ed il tarantino ed un ceppo
nel catanzarese e valentiano, quindi in zone diverse rispetto
a Rondinella, cosa che suggerisce una contestualizzazione
precisa, di cui dirò più avanti.
Origine dei cognomi
46
Continuando, mentre Rondinello è quasi unico, Rondini ha
un nucleo nel reggiano ed uno nella fascia che comprende
pesarese, perugino e Lazio settentrionale, invece Rondino,
assolutamente rarissimo, sembrerebbe campano.
Per concludere con le varianti, esiste Rondinone che ha un
piccolo ceppo campano tra casertano e napoletano ed un
nucleo nel materano e barese, poi Rondinoni, quasi unico
anche questo, tanto che potrebbe essere dovuto ad errori di
registrazione effettuati da ufficiali all’anagrafe del nord.
Prima di procedere, occorre richiamare la contestualizzazione
precedente: tutte queste forme cognominali, hanno nuclei
dí origine diversi, ovvero, nascono dalle stesse radici ma in
ambiti e ambienti culturali diversi e non sovrapposti gli uni
con gli altri, tanto che si faticano a trovare sovrapposizioni
delle varianti cognominali nei luoghi abitati.
Il nucleo originario del cognome comunque, é lombardo,
anche se poi ogni zona ha sviluppato la sua particolare variante.
Queste derivano tutte tramite ipocoristici o accrescitivi
dal nome medioevale Rondinus, usato prevalentemente in
Lombardia, ma generalmente nel centro-nord Italia. Ad
Favaretto Rondini Silvestri
47
esempio; nel Codice Diplomatico della Lombardia medievale,
si legge in un atto dell’anno 1152: “...Martinus Quaquara unam
partem; Omodeus Pristinarius unam partem; Rondinus unam
partem; Rotefredus de Besade unam partem...”. Tracce di questa
cognominizzazione le troviamo a Roma nel 1600 con il notaio
Battista Rondino.
Ma nonostante le apparenze, il cognome non trae origine
dall’uccello noto col nome di Rondine (Hirundo rusticae): tutto
nacque nella disfida tra guelfi e ghibellini.
Un tratto distintivo
Tante volte la realtà é meno semplice di quel che pensiamo,
alle volte invece, così banale che ci delude. Per arrivare però
a comprendere alcune delle cose di cui tratterò ora, mi sarà
necessario divagare un pò...
Intanto individuiamo l’origine (tedesca) dei due nomi:
Guelfo -> Welfen
Ghibellino -> Hei Weiblingen (cioé: di Weiblingen, il
nome del castello posseduto presso Stoccarda dalla
famiglia Hohenstaufen)
Origine dei cognomi
48
I Welfen erano i Duchi di Baviera, che all’epoca contendevano
il trono imperiale (l’ex Sacro Romano Impero, ora Impero
Germanico) ai duchi di Svevia, gli Hohenstaufen; periodo
XII° secolo. All’origine della lotta italica fra le due fazioni,
l’intromissione papale nelle faccende imperiali (in Germania
comunque, la lotta cominciò già dopo la dieta di Worms del
1122).
Siamo nel pieno della lotta per le investiture (il conflitto fra
Papato e Impero su quale delle due sfere - spirituale o temporale
- sia superiore all’altra) e alla morte dell’Imperatore di Germania
si scatenò la guerra civile fra i due successori, entrambi
proclamati legittimi sovrani dal pontefice Innocenzo III°:
Ottone IV° di Baviera e Federico II° di Svevia. Da considerare,
che l’estensione delle terre imperiali giungeva all’epoca sino a
confinare con il Papato: l’Impero Germanico si estendeva dal
mare del Nord sino alla Toscana, inglobando tutto il centro-
nord Italia.
Ottone era della famiglia dei Welfen, quindi i suoi sostenitori in
Italia Guelfi, mentre chi patteggiava per Federico II° ingrossava
le fila dei Ghibellini. A vincere la disfida fu Federico II° e ben
presto, essere ghibellino si trasformò in Italia in opposistore
Favaretto Rondini Silvestri
49
del Papato, più che sostenitore dell’Imperatore.
Era così forte il conflitto in Italia (anche se spesso e volentieri
condotto per gli scopi personali delle varie casate, infatti
chi era sotto il Papa passava con l’Imperatore per avere più
autonomia e viceversa), che presto le città cominciarono a
caratterizzarsi anche esteticamente come guelfe e ghibelline e,
principale fonte di riconoscimento, era la merlatura. C’erano
merlature guelfe e merlature ghibelline; le merlature guelfe
presentavano la sommità piana, quelle ghibelline la sommità
bifida o, più comunemente, a coda di rondine, come da esempio
sottostante.
Origine dei cognomi
50
Rondinus dunque, non si riferisce alla rondine in quanto
animale ma al tipo di fortificazione: il Rondinus, era il signore
ghibellino, probabilmente un soprannome divenuto poi
cognome. Da aggiungere poi, che la lotta guelfi-ghibellini si
trasferisce anche al sud dopo il matrimonio di Federico II° con
Bianca dí Altavilla del Regno Normanno di Sicilia, unione che
preoccuperà non poco il pontefice che temeva un possibile
tentativo di Federico di unire l’Italia, cosa che invece era molto
auspicata dagli intellettuali di allora.
Veniamo alle zone di provenienza cognominale.
Abbiamo detto che la prima attestazione la troviamo nella
Lombardia del 1152, quindi all’epoca del sovrano Federico
Barbarossa, nonno di Federico II°. Poi però, di fatto si stabilizza
nel settentrione d’Italia, dove comunque la principale città
ghibellina é proprio Milano e tutte le varianti prendono piede
al sud (prevalentemente) e al centro (in misura molto minore
anche se uno dei centri con la concentrazione maggiore é Roma
e il suo hinterland).
La fase storica successiva alla morte di Federico II° é
delicatissima per il Meridione, in quanto rappresenta l’inizio
della sua decadenza: travolti dall’instabilità, i signorotti
Favaretto Rondini Silvestri
51
feudali meridionali, ridotti a figure di comparsa nella vita di
corte tedesca, si contesero i terreni di Federico sino a quando
Manfredi, figlio naturale illegittimo dell’Imperatore, non tentò
di rimettere a posto le cose con una serie di battaglie dall’esito
però negativo. Se alla morte senza eredi di Federico nel centro
nord Italia le fazioni ghibelline vennero espulse dalla città,
accadde l’opposto al sud, dove Manfredi appunto, assunse il
comando di tutte le forze ghibelline.
Dopo l’iniziale vittoria di Montaperti del 4 settembre 1260,
dove la lega dei ghibellini (Manfredi con Pisa e Siena) sconfisse
la lega dei guelfi comandata da Firenze, le cose vennero
rovesciate l’anno seguente dalla salita al trono di Paolo di un
vescovo francese, Urbano IV. Egli pose le premesse per la calata
in Italia degli Angioini, ovvero la famiglia del re di Francia.
Il pontefice dichiarò illegittimo il sovrano Manfredi e quindi
decaduto, promettendo la Sicilia in ricompensa agli Angioini
per l’aiuto nelle faccende italiane. Nel 1266, nella decisiva
battaglia di Benevento Manfredi fu sconfitto e ucciso.
I ghibellini vennero cacciati dalle città e il regno di Sicilia (che
comprendeva tutto il sud sino a Napoli) passò in mani francesi
sino al 1282, quando una rivolta di popolo contro gli invasori
Origine dei cognomi
52
favorì però la conquista aragonese dell’isola siciliana, lasciando
agli Angioini i territori di terraferma; entrambe le casate
trasformarono quei territori in granai per le rispettive famiglie
regnanti, gli Angioni per il trono di Francia, gli Aragonesi per
quello dí Aragona.
Comunque ora, proviamo a vedere come dal Rondinus si arriva
al cognome Rondini.
L’accento dove va?
Un primo ragionamento da farsi riguarda il significato
figurativo di alcuni tipi d’uccello. Merlo ad esempio, diffuso
come forma cognominale in tutta l’Italia, con più alta frequenza
in Liguria e in genere nel nord (e i derivati Merli, Merlino,
Merlini, Merloni, Merletto), richiama due significati figurati
praticamente opposti: poteva definire una persona scaltra come
una particolarmente sciocca, a seconda delle zone geografiche
(ecco perché in casi come Rondini è importante conoscere le
zone d’origine dell’interessato).
Più semplice invece è Falco, con le varianti Falchi, De Falco,
Di Falco, Falchetto, Falcone, Falchieri, Fulchieri, Fulchero. Alla
Favaretto Rondini Silvestri
53
base sono i nomi medievali “Falco, Falcone, Falconiere”, nati
da soprannomi di mestiere o per indicare caratteristiche nobili
come forza, rapidità, coraggio: il falco era, del resto, un animale
sacro presso i Longobardi.
Meno eroico, ma tutto sommato simile, è il cognome Aquila,
diffuso dall’Abruzzo alle Marche e al Lazio e all’Umbria, legato
a un soprannome usato per indicare una vista particolarmente
acuta, intelligenza, rapacità. In altri casi può essere legato al
toponimo L’Aquila, capoluogo abruzzese.
Ma ci sono anche cognomi, non pochi, che pur riferendosi
al nome di un animale non sono nati dall’associazione fra
caratteristiche fisiche o morali, ma richiamano altri significati,
spesso religiosi: un caso su tutti è Colombo (per le numerose
varianti vedere la prima puntata), che non richiama una
qualche analogia fra persone e uccelli, ma si riferisce piuttosto
al simbolo cristiano di pace, la colomba appunto, ed è quindi un
cognome originato dalla devozione cristiana. Simile è Tortora,
con i derivati Tortorelli, Tortorini, Tortorella, che in passato era
simbolo cristiano di innocenza.
E la rondine? Che cosa rappresenta, iconograficamente
parlando, questa particolare specie di uccello?
Origine dei cognomi
54
Rondine (lat. Hirundo, inis), resa anticamente anche come
Réndena, Réndina, Ròndene, Ròndina o Rùndena, assumeva
nel parlato, significati figurativi divergenti rispetto alle località
italiane.
Prendiamo il Veneto: nella nostra regione, la parola rondine nel
comun parlare, era eufemistica per indicare i genitali femminili,
come si trova nel Brancati (4-39):
“gli stavano (le prostitute) attorno in piedi, poggiando
le più alte il gomito sulla spalla delle più basse e mostrando,
attraverso i veli, ciascuna la propria rondine”.
In Liguria, esiste invece una località scelta sin dai tempi antichi
dalle rondini per nidificare. La gente di quel luogo era così
detta Rondanina o Rondinina; ovviamente, con l’introduzione
dell’obbligo dei cognomi, molti presero a chiamarsi come
il soprannome della loro località di origine. Addirittura, ci
informa il Francipane, l’abitudine alle rondini di quei luoghi,
ha portato i volatili ad allargare la loro zona di nidificazione,
facendo perdere ai Rondinini cognizione di quale fosse la
cittadina da cui proveniva il ceppo originario.
Ma le ricerche ci permettono di approfondire ancora.
Troviamo così Rondine e Rondini, molto diffuso come forma
Favaretto Rondini Silvestri
55
cognominale nelle città portuali, in quanto la rondine (stavolta
intesa come uccello) era sovente affiancata ai viaggi oltremare
e a lunghe peregrinazioni in terre straniere, ma il cognome
si trova anche nelle antiche città fortificate, in quanto altro
significato dato alla rondine era di affezione al proprio castello,
per la sua abitudine di tornare ogni anno a fare il nido nello
stesso punto (Pietro Guelfi Camajani). E ancora, si trova nelle
cittadine della Toscana o dell’alto Lazio che hanno avuto un
passato di regime principesco, dove le famiglie dirigenti hanno
assunto nello stemma gentilizio la figura della rondine, che ha
per significato “il principe umile che si fa uguale ai suoi sudditi e
non si lascia ingannare” (Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia
araldico cavalleresca).
Al centro Italia, essere accomunati alla rondine aveva un
significato ancora diverso. Secondo gli studi dello Strada, l’arrivo
delle rondini era atteso, in senso religioso, come annuncio della
primavera e quindi segno di buona sorte. Sempre dal punto di
vista religioso, la rondine era un volatile particolarmente caro
in quanto fedele al luogo di nidificazione (fedeltà al castello,
come prima dicevo) e dedito ai piccoli. Ed é proprio al centro
dove il cognome Rondine e le forme da esso derivate sono più
Origine dei cognomi
56
frequenti; la rondine al centro infatti, é associata alla fedeltà al
castello (princeps) e chi si fregia dei valori della rondine reca i
simboli di essa nelle sue insegne. Quali insegne? Armi, scudi,
armature, stendardi, ma soprattutto, merlature: al centro Italia,
Rondine e i cognomi da esso derivati, nascono e si diffondono
nelle città a tradizione ghibellina, filo imperiale.
Rondini non fa eccezione e la sua zona di nascita e diffusione é
il Viterbese. La pronuncia é la stessa dell’uccello al plurale, ma
a questo punto, non posso esimermi dallo spendere qualche
parola sulla storia di Viterbo.
Viterbo viene occupata da Federico Barbarossa imperatore di
Germania nel 1160 e costretta a giurare fedeltà all’Imperatore.
Il giuramento di fedeltà comportava l’assunzione delle insegne
imperiali, quindi da allora cominciò a sventolare la bandiera
con l’Aquila bicipite in cima alle mura. La cosa interessante
di Viterbo, é che sin dall’inizio della lotta per le investiture,
nonostante fosse in territorio papale si dichiaeò sempre neutrale;
la sua forza politica e militare era così forte, che i vari papi non
riuscirono mai a sottomettere la città al proprio volere.
Nel 1160 tuttavia, come detto sopra, la città é conquistata dagli
imperiali e diventa ghibellina.
Favaretto Rondini Silvestri
57
Conquistata la città, Barbarossa chiese un atto di fedeltà e
fu ripagato con l’assalto a Roma delle truppe viterbesi, che
tornarono vincitrici recando con sé le porte di bronzo della
basilica di San Pietro.
Entusiasta per la spedizione, Barbarossa insediò a Viterbo
l’antipapa Pasquale III e alla sua morte l’antipapa Callisto III.
Nel frattempo le scorribande dei ghibellini viterbesi continuano:
vengono conquistate in pochi anni Ferento, Tuscania,
Vetralla, Vignadello, Vallerano e Bagnoregio e portate in dote
all’imperatore, per convincerlo a mantenere il possesso di
Viterbo, che in seguito ai trattati con il papa, sarebbe dovuta
entrare in possesso del pontefice e così fu. Celestino III premiò
la fedeltà di Viterbo al papa elevando la città a sede vescovile.
Ma i lealisti, i ghibellini fedeli all’imperatore, insorsero
cacciando i guelfi e ristabilendo la situazione pre pace. Il papa
allora, siamo nel 1200, attaccò in massa la città, che fu costretta
a una pesantissima resa: la consegna delle chiavi delle porte
cittadine e della campana cittadina, che vennero fuse per
ottenere la campana Patarina, che si trova ancor oggi sulla torre
del Campidoglio.
Nella prima metà del Duecento scoppiò nuovamente la guerra
Origine dei cognomi
58
fra Impero e Papato e Viterbo, nonostante fosse di bandiera
papalina, ancora una volta si schierò con l’Imperatore, salvo poi,
a causa del prevalere della fazione guelfa cittadina, insorgere
contro Federico II guidata dal cardinale Ranieri Capocci nel
1243. Per arrivare al nuovo cambio di campo però, ebbe luogo
una lotta interna alla cità molto aspra, che portò all’espulsione
delle famiglie ghibelline, fuggite in Umbria o bassa Toscana.
E la presenza di Rondine e dei suoi derivati in queste due zone
geografiche la dobbiamo a questo.
Oggi il cognome Rondini non é molto diffuso, ne esistono
meno di 400 ceppi cognominali in Italia e Viterbo continua a
essere la città che ne presenta di più, 17. Tuttavia, la regione
dove il cognome é più presente é l’Emilia Romagna con 99
località, mentre il numero é più contenuto nelle regioni da
cui il cognome proviene, Liguria 22, Lazio 34, Lombardia 52.
Rondini non é un cognome originario dell’Emilia Romagna, la
sua presenza si deve all’emigrazione ma... riuscire a capire come
e quando essa sia avvenuta, é un compito davvero arduo.
Silvestri
Cognomen panitaliano (diffuso su tutto il territorio, universale,
al numero 71 dei cognomi più diffusi d’Italia, portato da
oltre 40000 persone) con molte varianti, a cominciare da
Silvestra, che è quasi unico e dovrebbe trattarsi di un errore
di trascrizione del cognome Silvestre decisamente napoletano,
mentre i diminutivi Silvestrini e Silvestrino sono localizzati
rispettivamente tra padovano e veneziano, in Emilia, Romagna,
Marche, Umbria e Lazio, il primo e il secondo assolutamente
rarissimo, parrebbe del napoletano.
Silvestris, anch’esso molto raro, è tipico di Bisceglie nel barese,
del barese stesso e del foggiano, mentre Silvestro ha un ceppo
napoletano e ne presenta uno in Sicilia nel messinese.
Tutte queste forme cognominali derivano e sono patronimiche
del nome latino Silvestro (selvaggio, da silvestris, ter, tre, che vive
nei boschi, selvatico, campagnolo, rustico e da silva, ae, selva,
bosco, foresta e, a sua volta derivato da Silvanus, dio romano
Origine dei cognomi
60
delle selve e dei boschi), nome personale e agionimo; da San
Silvestro vescovo di Roma dal 314 al 335, della cui elezione a
Papa si può leggere: “...Morto igitur Melchiade, episcopo urbis
Romae, Silvester ab omni plebe plurimum renitens in summum
pontificem est electus...”. Si tratta di un cognome abbastanza
diffuso in quasi tutte le regioni italiane; in Veneto lo troviamo
certamente dal XI° sec. fra Padovano e Veneziano.
Il cognome Silvestri si attesta nel Medioevo grazie al culto dei
santi Silvano, Silverio, Silvestra, Silvio e Silvia, vissuti tra il IV e
il XIV secolo, tutti nomi legati ai boschi e alle selve. Capostipite
della tradizione cristiana (sono infatti tutti nomi di origine
romana) é però Silvestro, da San Silvestro I papa, colui che
convertì l’Imperatore Costantino, il primo imperatore romano
cristiano. In suo onore si chiude l’anno, come segno di buon
auspicio, quindi il nome Silvestro assunse significato augurale
e per traslazione anche i cognomi da esso derivati.
Facile determinare il significato del cognomen, un pò meno la
provenienza vista la larghissima diffusione del cognome.
Passo allora a snocciolare brevemente la storia (ma molto in
sintesi), dei nobili Silvestri di Rovigo, Nobili e conti aggregati
al nobile consiglio di Rovigo nel 1485, al quale appartennero
Favaretto Rondini Silvestri
61
sino alla sua cessazione.
Ah, a proposito... perché dovrei parlare dei nobili Silvestri
di Rovigo? Semplicemente perchè risulta essere la più antica
famiglia veneta a portare tale cognome, quindi forse... difficile
dire senza alcun materiale di studio a disposizione, se possa
esistere una lontana parentela, ma non é da escludere a priori.
Feudatari della Repubblica di Venezia, i Silvestri di Rovigo si
distinsero per la Dominante nella guerra contro i Turchi, in
particolare durante la battaglia di Negroponte (1470), dove
Alessandro e Primo Silvestri morirono in combattimento in
seguito all’incendio della loro nave (la San Marco), assieme alla
compagnia di soldati che avevano formato a proprie spese per
Venezia.
Durante il regno del doge Francesco Morosini, con decreto del
10 giugno 1690, fu conferita alla famiglia Silvestri di Rovigo e
a tutta la sua discendenza il titolo di conte, confermato anche
dalle Sovrane Risoluzioni dell’8 luglio 1820 e 5 agosto 1826
(durante il governo austriaco; riconferma resasi necessaria dal
fatto che Napoleone aveva abolito i titoli nobiliari).
Grazie alla riconferma nobiliare dei Silvestri conosciamo anche
lo stemma araldico:
Origine dei cognomi
62
Carlo Stefano del fu conte Rinaldo e della nobil sig. Anna
Maria Casilini, I. R. Ciambellano, già Podestà di Rovigo nato il
19/5/1766, ammogliatosi il 23/9/1793 con la nobil sig. Antonia
contessa dottori
figli
Pietro Maria Luigi, nato il 13/2/1803 sacerdote
Girolamo Fderico, nato il 5/4/1809
Chiara, maritata nel nobile sig. Alessandro Casilmi
Auretta, maritata col signor Conte Bevilacqua di Ferrara
furono le persone (e loro discendenti) che godettero della
riconferma nobiliare con tanto di stemma.
Favaretto Rondini Silvestri
63
Lo stemma araldico merita una spiegazione.
Esso si descrive:
“pantera traversante sopra tutto lo scudo (postura con la
testa in alto, fianco diritto, gamba sinistra che si appoggia) in
rosso su campo d’oro”
Il significato dello stemma araldico é il seguente:
la pantera era un animale mostruoso, che veniva sempre
rappresentato con il corpo, le zampe posteriori e la coda di
leone, la testa di drago (spesso cornuta) e le zampe anteriori di
grifone, con bocca che vomita fiamme. Chi portava la pantera
nelle sue insegne, era noto per la sua atuzia e spietatezza in
battaglia; gli antichi infatti, nei loro insegnamenti portavano la
favola degli uomini che desideravano la pelle di questo animale
per la sua bellezza, ma che dalle pantere venivano divorati grazie
alla capacità di questi animali di ingannare la propria preda.
Per tale motivo la pantera oltre che astuta era libera, e il colore
della libertà era il rosso, che in araldica si rappresenta con
linee orizzontali (vedi la figura). Il campo oro (lo sfondo) si
rappresenta invece in araldica con uno sfondo a puntini ed é
simbolo di nobiltà; nel caso dei Silvestri, una nobiltà conquistata
Origine dei cognomi
64
in battaglia con astuzia (e proprio questa é la motivazione che
ha permesso ai Silvestri di guadagnarsi il titolo nobiliare).
Si veda l’appendice per la diffusione del cognome Silvestri, ma
essendo un cognome molto diffuso anche nel Veneto, risulta
davvero improbabile ricercare la provenienza esatta della
famiglia, anche se, una verifica preliminare dal punto di vista
agiografico, porta ad individuare la presenza del cognome
soprattutto in località un tempo ricche di foreste (si ricordi la
derivazione dagli dei romani dei boschi) oppure da località il
cui santo protettore é San Silvestro (in particolare nel Lazio).
Per quanto riguarda il Veneto, la prima derivazione é
preminente.
Statistiche nominali di diffusione per ceppo famigliare
Favaretto Rondini Silvestri 7344Veneto 1058 Emilia R. 99 Lazio 1260
Lombardia 61 Lombardia 55 Lombardia 738
Piemonte 36 Toscana 52 Campania 729
Friuli V. G. 29 Umbria 48 Veneto 667
Lazio 17 Lazio 34 Emilia R. 570
Emilia R. 6 Piemonte 33 Toscana 569
Sardegna 5 Marche 29 Marche 413
Liguria 3 Liguria 22 Abruzzo 407
Toscana 2 Friuli V.G. 6 Puglia 402
Marche 2 Veneto 5 Piemonte 344
Puglia 1 Campania 5 Umbria 238
Trentino 1 Puglia 5 Liguria 204
Basilicata 1 Molise 2 Sicilia 164
Sicilia 1 Molise 162
Totale 1222 Abruzzo 1 Calabria 161
Calabria 1 Friuli V.G. 145
Trentino 111
Totale 398 Sardegna 29
Basilicata 27
Val d’Aosta 4
Testi: Simone Menegaldo
Impaginazione e progetto grafico: Simone Menegaldo
Ricerca iconografica: Simone Menegaldo
Finito di stampare: giugno 2011
Menegaldo Studio Cultura
Madorbo 19/a
31010 Cimadolmo (TV)
3772327868 - [email protected]