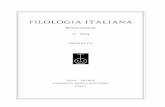TRE LEZIONI DI FILOSOFIA DEL MANAGEMENT (Nuova Cultura, 2012)
-
Upload
wwwuniroma1 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of TRE LEZIONI DI FILOSOFIA DEL MANAGEMENT (Nuova Cultura, 2012)
1
PIERO PAGNOTTA
TRE LEZIONI DI FILOSOFIA DEL MANAGEMENT
Tavoletta di argilla del periodo Antico Babilonese, 1800 A.C. - 1600 A.C., con il calcolo del rapporto tra la diagonale ed il lato di un triangolo rettangolo.
2
Un anno fa ho pubblicato Filosofia del Management1 come traccia delle mie lezioni alla
facoltà di Filosofia della Sapienza: proprio le lezioni e le discussioni con gli allievi mi
hanno spinto ad approfondire alcuni concetti per renderli, spero, più chiari. Anche
questa breve pubblicazione è un risultato di un percorso personale, passato a svolgere il
lavoro di manager ed a riflettere sulla necessità di una lettura filosofica di questo
complicato mestiere dove si incrociano, e intralciano, questioni che richiedono una
visione d’insieme. È l’essere umano che lavora con la sua intelligenza ed è l’essere
umano che con le sue scelte, condizionate, determina il successo del suo lavoro.
Qui il punto di partenza e di arrivo del lavoro manageriale.
PRIMA LEZIONE
Platone sulla scrittura e l’arte
Si può definire la filosofia come il metodo di interpretazione della realtà che consente di
coglierne la complessità, l’opposto di una interpretazione lineare, semplice, diretta;
filosofia è capacità di ricercare e definire il significato dell’esistente, l’aspetto recondito
dell’agire e pensare umano, interpretazione delle modalità di ricerca dei fenomeni.
Per meglio comprendere queste definizioni può essere utile analizzare, è un esempio
illuminante, quanto Platone scrive in alcuni suoi dialoghi a proposito della scrittura e
dell’arte. In merito alla scrittura, Platone, alcuni dei suoi dialoghi sono dei veri capolavori
letterari, sviluppa una critica che, ad una analisi non approfondita ma immediata,
sconcerta per la sua, apparente, radicalità e contraddittorietà: una critica della scrittura
da parte di un grande scrittore.
Così scrive nel Fedro:
LIX. Ho sentito narrare che a Naucrati d’Egitto dimorava uno dei vecchi dèi del paese,
il dio a cui è sacro l’uccello chiamato ibis, e di nome detto Theuth. Egli fu l’inventore
dei numeri, [d] del calcolo, della geometria e dell’astronomia, per non parlare del
gioco del tavoliere e dei dadi e finalmente delle lettere dell’alfabeto. Re dell’intiero
paese era a quel tempo Thamus, che abitava nella grande città dell’Alto Egitto che i
Greci chiamano Tebe egiziana e il cui dio è Ammone. Theuth venne presso il re, gli
rivelò le sue arti dicendo che esse dovevano esser diffuse presso tutti gli Egiziani. Il re
di ciascuna gli chiedeva quale utilità comportasse, e poiché Theuth spiegava, egli
1 Piero Pagnotta, Filosofia del Management, Stamen, Roma 2011.
3
disapprovava ciò che gli sembrava [e] negativo, lodava ciò che gli pareva dicesse
bene. Su ciascuna arte, dice la storia, Thamus aveva molti argomenti da dire a Theuth
sia contro che a favore, ma sarebbe troppo lungo esporli. Quando giunsero
all’alfabeto: "Questa scienza, o re - disse Theuth - renderà gli Egiziani più sapienti e
arricchirà la loro memoria perché questa scoperta è una medicina per la sapienza e la
memoria". 2
La scrittura, alla pari dei numeri, è una invenzione divina e un dio generoso la offre ad un
re perché la diffonda tra gli umani ma:
Il re rispose: "O ingegnosissimo Theuth, una cosa è la potenza creatrice di arti nuove,
altra cosa è giudicare qual grado di danno e di utilità esse posseggano per coloro che
le useranno. E così ora tu, per benevolenza verso l’alfabeto di cui sei [275a] inventore,
hai esposto il contrario del suo vero effetto. Perché esso ingenererà oblio nelle anime
di chi lo imparerà: essi cesseranno di esercitarsi la memoria perché fidandosi dello
scritto richiameranno le cose alla mente non più dall’interno di se stessi, ma dal di
fuori, attraverso segni estranei: ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la
memoria ma per richiamare alla mente. Né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari, ma
ne dai solo l’apparenza perché essi, grazie a te, potendo avere notizie di molte cose
senza insegnamento, si crederanno d’essere dottissimi, mentre per la maggior parte
non sapranno nulla; con loro sarà [b] una sofferenza discorrere, imbottiti di opinioni
invece che sapienti" […] LX. SOCR. Dunque chi crede di poter tramandare un’arte
affidandola all’alfabeto e chi a sua volta l’accoglie supponendo che dallo scritto si
possa trarre qualcosa di preciso e di permanente, deve essere pieno d’una grande
ingenuità, e deve ignorare assolutamente la profezia di Ammone se s’immagina che
le parole scritte siano qualcosa di più [d] del rinfrescare la memoria a chi sa le cose di
cui tratta lo scritto. FEDR. È giustissimo. SOCR. Perché vedi, o Fedro, la scrittura è in
una strana condizione, simile veramente a quella della pittura. I prodotti cioè della
pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se li interroghi, tengono un maestoso
silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte: crederesti che potessero
parlare quasi che avessero in mente qualcosa; ma se tu, volendo imparare, chiedi loro
qualcosa di ciò che dicono esse ti manifestano una cosa sola e sempre la stessa. E una
volta che sia messo in iscritto, ogni discorso arriva alle mani di tutti, tanto di chi
l’intende tanto di chi non ci ha nulla [e] a che fare; né sa a chi gli convenga parlare e a
chi no. Prevaricato ed offeso oltre ragione esso ha sempre bisogno che il padre gli
venga in aiuto, perché esso da solo non può difendersi né aiutarsi.”
2 Platone, Opera, Burnet I., 5voll, Oxford, Clarendon Press, 1906-7. Tutte le opere, trad. it. a cura di Sansoni
editore, Firenze 1975.
4
Senza negare l’importanza della scoperta, lo scrittore Platone ne indica il limite; e così
prosegue il dialogo:
FEDR. Ancora hai perfet-[276a] tamente ragione. SOCR. E che? Vogliamo noi
considerare un’altra specie di discorso, fratello di questo scritto, ma legittimo, e
vedere in che modo nasce e di quanto è migliore e più efficace dell’altro? FEDR. Che
discorso intendi e qual è la sua origine? SOCR. Il discorso che è scritto con la scienza
nell’anima di chi impara: questo può difendere se stesso, e sa a chi gli convenga
parlare e a chi tacere. FEDR. Intendi tu il discorso di chi sa, vivente e animato e del
quale quello che è scritto potrebbe dirsi giustamente un’immagine?
[b] LXI. SOCR. Sì, proprio questo. Ed ora dimmi. - Forse il contadino giudizioso che
avesse alcuni semi che gli stanno a cuore e da cui volesse dei frutti, li seminerebbe con
tutta serietà in estate, nei "giardini d’Adone" e rigongolerebbe attendendosi i bei
frutti in otto giorni? O piuttosto non lo farà per gioco e per solennizzare la festa,
ammesso pure che lo faccia? Mentre per i semi per i quali ha davvero serie intenzioni
li seminerà nel terreno adatto servendosi della tecnica agricola, e si rallegrerà se
quanti ne ha seminati verranno a maturazione in otto mesi? FEDR. Ma certo così, o
Socrate; e nel se-[c] condo caso lo farà con intenzioni serie, nel primo caso no, come
dici tu. SOCR. E diremo ora che chi ha la conoscenza del bello e del giusto è meno
giudizioso, riguardo le sue sementi, del contadino? FEDR. Assolutamente no. SOCR.
Allora non le scriverà con intenzioni serie nell’acqua nera, seminandole mediante la
penna con parole che non possano parlare a propria difesa, né possono insegnare in
modo sufficiente il vero. FEDR. Non è certo probabile [d] che le scriva. SOCR. No, non
lo è. Ma egli spargerà le sue sementi nei giardini letterari, io credo, e scriverà, quando
scriva, solo per gioco, al fine di raccogliere un tesoro di ricordi per suo uso, contro la
"vecchiaia che porta oblio" quando essa giunga, e per uso di chiunque si metta sulla
stessa orma; e gioirà mirando i teneri germogli rinverdire. E quando gli altri si
daranno a divertimenti diversi, affogandosi nei banchetti e in quant’altre gioie che
s’accompagnano a questi, lui, invece, probabilmente vivrà degli svaghi che io dico.
FEDR. Bellissimo svago [e] descrivi, o Socrate, di fronte agli altri sciocchi, lo svago di
potersi dilettare delle parole, fantasticando discorsi sulla giustizia e su le altre virtù
che tu dici! SOCR. Mio caro Fedro, è proprio così. Ma molto più bello, io penso, è
occuparsene seriamente quando usando l’arte della dialettica e prendendo un’anima
congeniale vi si piantano e vi si seminano parole con scientifica consapevolezza. Le
quali sono sempre in grado di venire in aiuto a se stesse e a [277a] coloro che le
hanno seminate e non sono sterili; ma poiché racchiudono in sé un germe da cui
nuove parole germogliano in altre indoli esse sono capaci di rendere questo seme
immortale, e rendono beato chi lo possiede, quanto può esserlo un umano FEDR. Oh!
Il modo che dici è molto più bello!
5
Con l’uso a lui abituale di splendide metafore, Platone giudica la scrittura uno strumento
che permette di conservare nel tempo fatti e riflessioni, ma che non può consentire una
vera trasmissione del sapere. Un dio egizio è il creatore dell’alfabeto, ma il re saggio cui
viene fatto il dono ne coglie l’aspetto nefasto. D’ora in avanti, sostiene il re, i lettori, gli
scolari, potranno avere molte notizie e conseguentemente si crederanno sapienti ma
saranno solo rimpinzati di opinioni. Lo scrittore Platone rileva che la meravigliosa
invenzione dell’alfabeto rappresenta una minaccia per l’insegnamento: un testo scritto è
come un quadro, solo in apparenza le figure appaiono vive. Di più il libro può finire in
mani impreparate. E la conoscenza può essere garantita solo da un insegnamento che si
fondi su un dialogo tra chi conosce e chi è pronto ad apprendere; dialogo che richiede
una continua costruzione, una scelta dei termini adatti, il giusto interlocutore.
L’insegnamento va seminato con giudizio, come semi in un campo arato e pronto, non
ridotto ad un gioco ma con scientifica consapevolezza. La scrittura è come una incisione
sulla pietra, una volta redatto un testo lo è per sempre, immodificabile, non è possibile
adattarlo al livello del lettore, può finire nelle mani di incompetenti nei quali può solo
ingenerare errate comprensioni o, peggio, presunzione di possedere una conoscenza e
di conseguenza una chiusura al sapere. Un testo viene necessariamente diffuso senza
controllo, non permette di circoscrivere la sua lettura secondo le intenzioni dell’autore.
È importante riflettere su tali considerazioni oggi che possiamo leggere di tutto grazie ad
internet, che disponiamo di strumenti di connessione e ricerca sempre più potenti, che
siamo abituati ad intense campagne pubblicitarie per promuovere la vendita di
pubblicazioni di ogni genere. Platone ci mette sull’avviso che la scrittura, il meraviglioso
alfabeto greco, ingenera una falsa consapevolezza di conoscenza da parte di lettori
impreparati ma paghi delle loro letture.
Riguardo la questione dell’interlocutore/lettore Platone nella sua Lettera settima cosi si
esprime:
Questo tuttavia io [c] posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo
di conoscere ciò di cui io mi occupo per averlo sentito esporre o da me o da altri o per
averlo scoperto essi stessi, che non capiscon nulla, a mio giudizio, di queste cose. Su di
esse non c’è, né vi sarà, alcun mio scritto. Perché non è, questa mia, una scienza come
le altre: essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’ac-[d] cende
da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di
discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima.
Questo tuttavia io so, che, se ne scrivessi o ne parlassi io stesso, queste cose le direi
così come nessun altro saprebbe, e so anche che se fossero scritte male, molto me ne
affliggerei. Se invece credessi che si dovessero scrivere e render note ai più in modo
adeguato e si potessero comunicare, che cosa avrei potuto fare di più bello nella mia
vita, che scriver queste cose utilissime per gli uomini, traendo alla luce [e] per tutti la
6
natura? Ma io non penso che tale occupazione, come si dice, sia giovevole a tutti;
giova soltanto a quei pochi che da soli, dopo qualche indicazione, possono progredire
fino in fondo alla ricerca: gli altri ne trarrebbero soltanto un ingiustificato disprezzo o
una sciocca e superba presunzione, quasi avessero appreso qualche cosa [342a] di
augusto.
Un insegnamento che non tenga conto delle capacità del discente è ritenuto non solo
inutile ma dannoso perché gli argomenti vanno approfonditi, discussi, tenendo nel
dovuto conto le capacità intellettuali e l’esperienza maturata da coloro ai quali ci si
rivolge. Su Platone e la scrittura sono state scritte pagine classiche, si pensi agli scritti di
Havelock e Reale3; quello che qui interessa è sottolineare l’interpretazione non
tradizionale della scrittura ma totalmente innovativa. Riguardo all’arte, la questione è
connessa; Platone critica la funzione (dis)educativa che ai suoi tempi svolgeva, in
particolare, la poesia. Per Platone i poeti sono come gli indovini, hanno una disposizione
naturale ma non sono sapienti, presumono d’esserlo per la loro dote innata; il vero
sapere, al contrario, è quello che concerne cose più importanti e difficili.
Nel Protagora così si legge:
Tali persone, infatti, per l’incapacità di intrattenersi fra di loro mentre bevono insieme
con le proprie risorse, con la propria voce e con i propri discorsi prive come sono di
ogni educazione, fanno [d] aumentare il prezzo delle suonatrici di flauto e pagando
cara l’estranea voce dei flauti, mediante tale voce s’intrattengono tra di loro; ove
invece si trovano a simposio persone di valore e bene educate, non si vedranno né
suonatrici di flauto, né danzatrici, né suonatrici di cetra, ma persone che da sé sono
capaci di conversare insieme, senza alcun bisogno di questi cicalecci, di queste
fanciullaggini, con la loro stessa voce, parlando e ascoltando a turno, con ordine, sia
pur bevendo vino in grande quantità. Così, i [e] trattenimenti come i nostri, qualora
riuniscano uomini quali i più di noi dicono d’essere, non hanno affatto bisogno di
estranea voce, né di poeti che non si possono neppure interrogare su quello che
dicono; i più li citano nei loro discorsi, e v’è chi sostiene che il poeta la pensa in un
certo qual modo, chi in altro, discutendo su di un argomento impossibile a risolvere.
Diciamo addio a tali [348a] trattenimenti, gli uomini buoni e belli trovino in se stessi
la capacità di intrattenersi, mediante i propri discorsi, saggiando gli altri, e, a loro
volta, dando prova di sé. Ecco, uomini come questi, mi sembra, dobbiamo soprattutto
3 Si veda: Reale G., Platone, BUR, Milano 2004, particolarmente il cap. III; Reale G., Il giardino d’Adone, in
Valori dimenticati dell’occidente, Bompiani, Milano 2006; Havelock E.A., Preface to Plato, Cambridge
Massachusetts 1963 - Cultura orale e civiltà della scrittura, trad. it. a cura di M. Carpitella, Laterza, Bari
1973.
7
imitare, tu ed io, e accantonando i poeti, con i nostri soli mezzi, fare i nostri
ragionamenti, sottoponendo ad esame la verità e noi stessi risposto.(XXXII)
Platone critica il modo ripetitivo di dire qualcosa, l’uso irriflessivo di espressioni poetiche
per interpretare cose e fatti, apparentemente ben congeniate, culturalmente elevate;
critica persino Omero, meglio l’uso che se ne faceva. Disapprova un intero procedimento
educativo basato su formule pronte all’uso per ogni circostanza, ma che evitavano, di
conseguenza, riflessione e dibattito. Giudica la poesia uno strumento che disabitua al
ragionamento, che schematizza il pensiero. Per lui i grandi poemi, Omero compreso, non
debbono costituire la base dell’insegnamento perché impediscono la conoscenza delle
cose quali realmente sono. I brani mandati a memoria venivano utilizzati come chiavi
interpretative schematiche, attrezzi di bella immagine e armonia che, recitati,
impedivano la riflessione. Un frasario pronto all’uso per ogni circostanza, una sorta di
politicamente corretto ante litteram; tutt’altro da una riflessione ponderata, da un
esame ed autoesame. Platone, invece, sulla linea dell’insegnamento socratico, invita ad
approfondire, a ricercare i nessi, a cogliere l’aspetto complesso, metafisico, di fatti e
cose. Nei suoi dialoghi opera una rivoluzione del pensiero in quanto “separa la cosa in sé
dal contesto narrativo”4.
Egli sviluppa quello che con un termine affrettato potremmo definire un pensiero
laterale, rifiuta le abitudini culturali, individua kuhniani paradigmi e prova a metterli in
evidenza per analizzarli. Dà un saggio di pensiero complesso. Rifiuta le tradizioni, le
abitudini di pensiero, anche quelle ben scritte, ed invita, invece, a ricercare una visione
degli aspetti non immediatamente intuitivi. Per Platone chi è in grado di sviluppare una
simile interpretazione è il filosofo e questi deve, con le sue capacità, svolgere una
attività speculativa e riportarla alla gestione delle umane cose, in primis
all’organizzazione che regola la vita politica. Invita a risalire alle forme interpretative:
[79a] e tu codeste cose puoi toccarle, puoi vederle, puoi comunque percepirle con gli
altri sensi; ma quelle che permangono costanti non c’è altro mezzo col quale tu le
possa apprendere se non col pensiero e con la meditazione: perché quelle di questa
specie sono invisibili e non si possono percepire con la vista. (Fedone)
Invita al dialogo costruttivo, approfondito, respinge l’uso del libro come strumento in
grado di offrire una risposta sempre, comunque, per tutti. Basti riflettere su quanti ai
nostri giorni sono spinti a far uso del Libro, della citazione, della frase cantilenante che
annichilisce il pensiero e giustifica l’orrore. Scendendo a meno drammatiche
considerazioni, se sostituiamo l’epica omerica con altri e più moderni insegnamenti, il
rischio che oggi si corre è quello di fornire conoscenze astratte, non legate all’esperienza
maturata, irriflesse. Richiediamo ai giovani, giustamente, di lavorare in team, in gruppi di
4 Havelock E.A.,opera citata pag.249.
8
lavoro, ma allora sarà bene analizzare le dinamiche che li governano per non esserne
governati. I tanti MBA sul mercato offerti a giovani che non hanno maturato nessuna
competenza lavorativa possono ingenerare in loro convinzioni errate, supporre di
conoscere. Per comprendere il management bisogna prima vivere e lavorare a lungo in
una organizzazione e poi, con l’ausilio di un buon insegnamento, pervenire a coglierne la
complessità, risalire all’unità della materia mediante forme concettuali.
9
SECONDA LEZIONE
La rivoluzione del pensiero scientifico del ‘900
I progressi scientifici del XX secolo, particolarmente nel campo della fisica teorica con la
teoria della relatività e quella dei quanti, hanno messo in risalto questioni non
secondarie di carattere filosofico. L’importanza dell’attività dell’intelletto,
dell’esperimento ideale, per ricercare una interpretazione degli aspetti fenomenici, per
risolvere le contraddizioni tra teorie consolidate e nuove esperienze. Il conflitto tra
realtà fenomenica e interpretazione ha messo in luce come il pensare sia l’origine della
teoria; la costruzione di una formulazione matematica ha il più delle volte preceduto il
controllo sperimentale. In sostanza le nuove scoperte, e le modalità di ricerca che ne
sono state alla base, hanno aperto la possibilità di rivedere il discorso filosofico,
l’epistemologia, così come si era sviluppato da Bacon in poi, passando per i pilastri del
pensiero scientifico rappresentati da Galileo, Newton e la sistematizzazione operata da
Kant con le tre Critiche. Particolarmente le nuove scoperte del quantismo e della
relatività hanno segnato una crisi della linearità interpretativa di matrice scientista.
La moderna fisica teorica ha messo in luce la funzione di equazioni complesse necessarie
a decifrare il mondo subatomico, risultato di ipotesi preziose, interpretazioni eleganti,
ma ipotesi ad oggi prive, almeno oggi, di una esaustiva verifica sperimentale.
Si è trattato di un meraviglioso sforzo intellettivo che ha cercato di comprendere una
datità mediante le nostre categorie concettuali, segnate dalla loro specificità, mostrando
che dove non riusciamo a ripetere con metodo accettabile un fenomeno, lo
interpretiamo con la nostra smisurata capacità meta-fisica. Scrive Richard P. Feynman:
“Ci sono i fisici teorici che inventano, deducono e tirano ad indovinare le nuove leggi,
ma non le sperimentano, e ci sono i fisici sperimentali che fanno gli esperimenti,
inventano, deducono e tirano ad indovinare.”5
E ancora:
“Cosa si intende quando diciamo che capiamo una cosa? Possiamo immaginare che
questo complicato apparato di cose in movimento che chiamiamo mondo sia simile a
una partita a scacchi giocata dagli dèi di cui noi siamo spettatori. Non conosciamo le
regole del gioco; tutto ciò che ci è permesso è guardare la partita. Naturalmente, se
guardiamo abbastanza a lungo, alla fine afferreremo alcune regole di base. Le regole
del gioco sono ciò che chiamiamo fisica fondamentale. Anche se le conoscessimo
5 Feynman R.P., Six easy pieces, California Institute of Technology 1963 - Sei pezzi facili, Adelphi, Milano
2000, pag. 23. Lo statunitense Feynman ha ricevuto il Nobel per la fisica nel 1965.
10
tutte, comunque, potremmo non essere in grado di capire perché viene fatta una data
mossa, magari perché è troppo complicata, e le nostre menti sono limitate.” 6
La teoria dei quanti, nella sua formulazione iniziale, non si configurava come il risultato
di esperienze, anzi quelle configgevano, e confliggono, con il nostro senso comune
risultando piuttosto quello che riusciamo a pensare e dire e non quello che è. Si tratta di
un mondo di difficile accessibilità che nel tempo gli scienziati hanno cercato di
descrivere al meglio costruendo modelli interpretativi, sistemi di misura che però
interferiscono con il fenomeno, lo disturbano al punto da pregiudicare l’oggettività
dell’interpretazione. Nel mondo dei quanti gli strumenti di misura determinano, ai nostri
giorni, una interferenza che non può essere trascurata; la realtà microscopica non può
essere osservata come facciamo per il mondo macroscopico, oggettivamente, ma
richiede una interferenza di cui dobbiamo tenere conto; riusciamo faticosamente ad
interpretare come si comporta. E l’osservazione possibile della realtà subatomica mostra
una realtà in contrasto con la nostra esperienza quotidiana, il nostro sentire comune;
per essa non valgono né il principio di causalità né il concetto di oggettività.
Heisemberg in proposito scrive:
“La fisica classica era costruita sopra una premessa fondamentale, punto di partenza
apparentemente ovvio di tutte le scienze esatte, alla quale sembrava non occorresse
alcuna prova e alcuna discussione: la fisica tratta del comportamento delle cose nello
spazio e delle loro modificazioni nel tempo […] spazio e tempo schemi,
completamente indipendenti l’uno dall’altro, entro cui va ordinato tutto ciò che
avviene”. 7
Scrive ancora:
“ciò che accade dipende dal nostro modo di osservarlo o dal fatto che noi
l’osserviamo.”8
E più in particolare per quanto riguarda la fisica atomica:
“ciò che osserviamo non è la natura in se stessa ma la natura esposta ai nostri metodi
di indagine.”9
Ed ancora:
“i concetti non sono esattamente definiti nella loro relazione con la natura,
nonostante l’esatta definizione dei loro possibili rapporti. Le limitazioni verranno
6 Opera citata pag. 52.
7 Heisemberg W, Wandlungen in der Grundlagen der Naturwissenschaft, Herzel Verlag, Stoccarda 1944, trad
it. Di A.Verson, Mutamenti nelle basi della scienza, Einaudi, Torino 1944, pag.11. Heisemberg, fisico tedesco (1901-1976), ha ricevuto il Nobel per la fisica nel 1932.
8 Opera citata pag.65.
9 Opera citata pag.73.
11
perciò determinate dall’esperienza, dal fatto che i concetti non permettono una
descrizione completa dei fenomeni osservati.” 10
Scrive Bohr:
“E’ stata la scoperta dei quanti a giustificare l’antico dubbio sull’adeguatezza delle
nostre ordinarie forme d’intuizione alla descrizione dei fenomeni atomici.” 11
E ancora:
“Siamo in presenza di uno sviluppo razionale della nostra capacità di classificare e
comprendere nuove esperienze, le quali per il loro stesso carattere non rientrano nello
schema della descrizione causale, che può rendere conto solo del comportamento di
sistemi non perturbati dai mezzi di osservazione […]per quanto inconsueto possa
sembrare questo sviluppo della fisica, sono certo che molti avranno riconosciuto la
stretta analogia esistente tra la situazione nell’analisi dei fenomeni atomici, a certi
aspetti caratteristici del problema dell’osservazione nel campo della psicologia.” 12
La fisica atomica, la teoria dei quanti, ha evidenziato come si conosca grazie a metodi
speculativi che ci permettono di erigere teorie, lavorando per ricercarne una conferma
da dati sperimentali. Kant aveva assegnato a tempo e spazio, newtonianamente intesi, il
ruolo di cornice entro la quale si dispongono necessariamente le esperienze scientifiche;
erano intesi dalla fisica classica come schemi mentali entro i quali si organizzano
necessariamente i fatti, forme intuitive a priori, veri e propri vincoli cognitivi.
Il quantismo ci ha posti di fronte ad una realtà subatomica dove tempo e spazio non
sono da noi collegabili ed i fenomeni si presentano in modo tutt’altro che intuitivi. A
questo si aggiunga che la rivoluzione operata dalla relatività einsteiniana, agli inizi del
secolo scorso, ha riformulato i concetti di tempo e spazio in modo non intuitivo. La
relatività non contempera principi di indeterminazione, Dio non gioca a dadi soleva dire
Einstein, consente calcoli previsionali attinenti movimento e velocità nello spazio, ma
riduce l’applicabilità della fisica newtoniana, storicizza gli a priori kantiani. Rafforza il
principio che la conoscenza si fonda sulle operazioni intellettive del soggetto che fa
scienza, che interpreta l’oggetto e poi verifica, ipotizza e traduce i fenomeni.
10
Opera citata pag.112. 11
Bohr N., Athomtheorie und Naturbeschreibung, Springer, Berlin 1931, Atomic Physics and Human Knowledge, Wiley, New York 1958, Essays 1958-1962, Wiley, New York 1963; I quanti e la vita, Bollati Boringhieri ed., Torino 2007, pag 4. Bohr, fisico danese (1885-1962), ha ricevuto il Nobel per la fisica nel 1922.
12 Opera citata pag.52.
12
Scrive Einstein:
“Riconosco che il pensiero puro è capace di afferrare la realtà, come gli antichi
pensavano. Per giustificare questa fiducia sono costretto a servirmi di concetti
matematici.” 13
È l’intelletto a creare possibilità di pensiero, sottoponendole successivamente ad una
verifica con metodi di scienza. I vincoli kantiani ci appaiono oggi determinati dalla
evoluzione della conoscenza interpretativa. La mente umana ha una sua metodologia
interpretativa, schemi che siamo però costretti a rivedere, faticosamente, quando la
realtà, le regole proprie della natura ce lo impongono, offrono soluzioni non intuitive.
Per Eccles14 la nostra mente si evolve, la mente auto-cosciente è capace di apportare
cambiamenti nel cervello.
Tornando all’intuizione di Einstein, potremmo dire che derivi da un'analisi filosofica, dal
convergere di evento e osservatore. Un romanziere di recente successo ha ben espresso
il problema, scrive Bruno Arpaia nel suo libro L’energia del vuoto:
“le leggi del romanzo sono ferree […] in fisica è lo stesso, quando pensiamo di avere
qualche nuova idea, siamo molto più simili agli artisti: in quella zona confusa in cui le
idee non sono ancora né giuste né sbagliate, ma solo ombre di possibilità, seguiamo,
sì, le regole, il rigore matematico, ma ci lasciamo anche guidare dalle sensazioni,
dalle nostre intuizioni, o forse solamente dal desiderio che l’universo sia proprio come
noi lo immaginiamo.” 15
E ancora:
“a un certo livello essenziale, l’arte e la scienza sono talmente vicine che è difficile
distinguerle […] se uno scrittore usa ingenti dosi di immaginazione, un fisico non è da
meno. Anzi. Un qualunque teorico, oggi, ha forse molta più immaginazione di
parecchi narratori in circolazione. Se così non fosse, sarebbe stato impossibile
elaborare le arditissime ipotesi che sono alla base di gran parte della fisica del XXI
secolo. […] E la passione e l’immaginazione che spingono un narratore a scrivere
romanzi, un filosofo o un teologo a interrogarsi sulle verità ultime, l’uomo della
strada a chiedersi come sarà il suo futuro e un fisico a esplorare gli angoli più remoti
della materia, dello spazio e del tempo, mi sembrano intessute della stessa sostanza,
dello stesso desiderio di conoscenza, della stessa necessità di saperne di più sulla
13
A. Einstein, The world as I see it, Carol Publishing Group, New York 1956 - Come io vedo il mondo, Newton Compton ed. 2006, pag. 45. Einstein (1879-1955) ricevette il Nobel per la fisica nel 1921.
14 John C. Eccles (1903 –1997) neurofisiologo australiano ha ricevuto il Nobel per la medicina nel 1963; tra le sue numerose opere figura The Self and Its Brain an Argument for Interactionism, con Karl Popper, Springer Verlag 1977 (trad. it. L'io e il suo cervello, Armando Editore 1981).
15 Arpaia B., L’energia del vuoto, Guanda, Parma 2011, pag.68.
13
nostra vita in questo sperduto pianeta di una piccola stella di una galassia periferica
del cosmo.” 16
Costruiamo teorie, interpretiamo, verifichiamo fin dove è possibile seguendo la nostra
capacità di razionalizzazione; non esiste il dato in sé, questo è osservabile solo da una
intelligenza in sé.
Scrive Roger Penrose:
“Abbiamo bisogno di un concetto di realtà fisica, anche se soltanto provvisorio o
approssimativo, perché senza di esso il nostro universo oggettivo, e quindi tutta la
scienza, semplicemente evapora davanti al nostro sguardo contemplativo! […] non
dovremmo cercare di chiederci che cosa è la realtà, ma come si comporta. Come? è in
effetti una domanda fondamentale [ …] come descriviamo le leggi che reggono il
nostro universo e il suo contenuto […] senza sapere che cosa sono queste cose è
difficile capire perché dovrebbero avere un comportamento piuttosto che un altro” 17.
È la nostra capacità intellettuale che ci ha permesso, e ci permette di definire,
interconnettere e soprattutto di anticipare ipotesi scientifiche predisponendole grazie a
complesse analisi matematiche e utilizzando in tante circostanze questi costrutti
intellettuali non solamente come ipotesi ma come verifica interpretativa. Godel18, che
rappresenta una pietra miliare nel pensiero matematico contemporaneo, definisce le
procedure matematiche entità intelligibili, che possiamo cogliere solamente con il
nostro intelletto e non inquanto percepibili dai nostri sensi:
“Gli oggetti della teoria degli insiemi non appartengono al mondo fisico […] ma
nonostante la loro distanza dall’esperienza sensoriale abbiamo in qualche modo una
percezione anche degli oggetti della teoria degli insiemi, come appare dal fatto che gli
assiomi ci si impongono come veri.” 19
Come veri, in quanto i suoi teoremi dell’incompletezza intendono dimostrare che
qualsiasi sistema formale se è coerente allora è incompleto dato che contiene una
proposizione che non può essere né dimostrata né refutata; nessun sistema formale può
mai dimostrare la propria coerenza se non facendo uso di sistemi più ampi cui riandare
in un processo all’infinito.
Il pensiero di Cusano sembra declinato in chiave moderna da Godel. La ricerca scientifica
è un processo di tendenziale accostamento interpretativo al comportamento del mondo
fisico. Siamo tornati a concepire l’epistemologia, e il ragionamento filosofico più in
16
Opera citata pag.135. 17
Penrose R., The Road to Reality, Roger Penrose 2004 - La strada che porta alla realtà, BUR Rizzoli, Milano 2011, pag. 552. Penrose (n.1931) è un fisico e matematico britannico.
18 Kurt Gödel (1906 –1978) matematico austriaco.
19 Berto F. , Tutti pazzi per Godel, Laterza, Bari 2009, pag. 177.
14
generale, come adaequatio rei et intellectus. È evidente che una teoria sul mondo
sensibile debba essere validata da prove che definiamo scientifiche, deve concordare
con i fatti; ma le teorie mirano a definire una visione della realtà, a tessere una
narrazione che leghi con un discorso razionale, armonico, il mondo sensibile. Ed è pur
vero che ogni progresso interpretativo, ogni nuova legge, ha condotto a nuove e
superiori difficoltà, al dischiudersi di una complessità maggiore, a sempre nuove
difficoltà interpretative. Per quanto progrediamo nella conoscenza sempre più vediamo
allontanarsi una visione completa dei fenomeni. Esistono cento miliardi di galassie e
ciascuna di loro comprende miliardi di stelle, un mistero cosmologico che noi umani non
potremo mai conoscere compiutamente. Dopo qualche secolo di investigazione
conosciamo in modo insufficiente il nostro pianeta, il suo mondo sottomarino, non
siamo ancora penetrati nelle grandi profondità della Terra e ci vorrà tempo per
esplorare il sistema solare e ricostruirne l’evoluzione. L’universo sembra essere costruito
nella sua immensità per dirci che mai sapremo tutto. E’ comunque un limite che
incoraggia a investigare mediante esperienze e attraverso ipotesi, a riprova della nostra
volontà e capacità di comprendere. Non ne consegue necessariamente un pessimismo
cosmologico, una ricerca che non abbia mai un fine assoluto non porta alla sfiducia per
la ricerca, scientifica e filosofica, o alla sottomissione ad “una potente autorità che salvi
l’uomo dalla sua follia e dalla malvagità”20. Basterebbe rifarsi all’ottimismo insito nel
pensiero metafisico primo rinascimentale che seppure convinto dell’impossibilità di un
sapere certo era capace di intrecciare una ricerca, un linguaggio anche con culture
diverse e speso fortemente conflittuali21. C’è sempre uno spazio tra libertà e necessità
che può essere colmato.
I risultati degli esperimenti scientifici debbono sempre essere interpretati, espressi
mediante una analisi, attraverso un discorso logico, connessi in un pensiero generale. Se
per un verso tante costruzioni intellettuali sono state annichilite da esperienze di
laboratorio, da scoperte scientifiche, è vero anche che queste richiedono di essere
inquadrate in una sintesi che è filosofica. Si stabilisce sempre un nesso tra il mondo dei
fenomeni fisici e quello delle idee.
La questione si complica quando vogliamo interpretare i fatti umani, le strutture sociali,
le organizzazioni. In questi ambiti l’osservazione scientifica è theory laden. E la verifica
nei comportamenti umani non si risolve compiutamente mediante prove di laboratorio,
con analisi quantitative, ma attraverso interpretazioni di queste. Noi ipotizziamo,
congetturiamo prima ancora di sperimentare, perché vi è un prius metafisico che guida e
condiziona teoria ed esperimenti. Einstein diceva che la penna ed il taccuino erano il suo
laboratorio. Il prius ipotetico può venir confermato dall’osservazione e dal calcolo.
20
Popper K.R., Conjectures and Refutations, London Routledge and Kegan Paul 1969 - Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna 1972, pag.16. 21
Nicola Cusano e Giordano Bruno ad esempio.
15
L’osservazione dell’orbita di Mercurio durante un’eclissi solare permise di verificare la
congettura di Einstein. Per quanto concerne i comportamenti umani l’astrazione, come
metodo ipotetico interpretativo, deve fare i conti con sperimentazioni ed analisi che
rimangono preda dell’argomentare. Nell’analizzare un’organizzazione umana vi sono
dati necessari a coglierne l’andamento, lo stato economico, ma se vogliamo valutare
anche potenzialità, capacità di sviluppo, impatto sociale, i numeri cominciano ad avere
un valore relativo e dovremo formulare valutazioni altre. Sono altri i fattori che
interagiscono, altre le materie e le competenze richieste. Una visione manageriale
richiede un approccio sistemico, complesso, che sappia fare i conti con l’indeterminato,
l’incertezza. L’analisi complessiva di una organizzazione umana deve misurarsi con
aspetti quantitativi: profitto, redditività, andamento economico generale, tutti numeri a
riprova effettiva e ineludibili, ma anche con aspetti qualitativi: partecipazione, qualità
dell’impegno, della domanda, del servizio reso22. Il come ed il perché vanno intrecciati.
Chi studia management deve essere messo sull’avviso di non farsi ipnotizzare dalle
misure23.
Il fatto è che gli accadimenti noi li interpretiamo. La rivoluzione francese è stata letta in
modo diverso da Mathiez, con Lefebvre, e da Tocqueville. Nel campo dei comportamenti
umani i fatti neutri non esistono. Resta il problema di quanto e fino a che punto siano
verificabili. Possiamo dire con Kant che non sembra possibile averne una conoscenza
compiuta, tanto essa è ricca e bella. Dobbiamo cercare, tanta è la paura dell’ignoto, di
metterle le redini attraverso la nostra capacità giudicante, i nostri concetti, e questo non
deve impedirci di andare aldilà dell’apparenza, dell’accadere, per trovarne un senso più
profondo, specchio di una complessità che non solo merita una ricerca ma che ci aiuta a
comprenderla.
Insomma:
“Se dunque non vi fosse qualche realtà diversa oltre a quelle costituite dalla natura, la
fisica sarebbe la scienza prima; se invece c’è qualche realtà immobile, questa sarà
anteriore e la filosofia che la studia sarà la prima, e sarà universale in questo modo,
cioè perché è prima.” 24
22
La formazione manageriale ne dovrebbe tenere conto per garantire competenze appropriate. 23
Mintzberg H., Managing, Financial Times, Prentice Hall 2009 - Il lavoro manageriale, trad. it. a cura di Franco Angeli, Milano 2010, pag.238. Mintzberg, canadese, docente di management presso la McGill Univ. di Montreal.
24 Aristotele, Aristotle’s Metaphysics, Ross, W. D., 2 voll, Clarendon Press, Oxford 1924. La metafisica, trad. it a cura di Oggioni E., CEDAM, Padova 1950; VI 1,1026 a 27-31.
16
TERZA LEZIONE
Recta ratio nella conduzione delle organizzazioni
Con il termine management si intende l’insieme delle attività necessarie a individuare gli
obiettivi di una organizzazione, di un’azienda, unitamente alla gestione e coordinamento
delle attività necessarie al loro raggiungimento attraverso la presa delle decisioni
opportune, il coordinamento delle diverse attività, l’impiego delle risorse materiali ed
immateriali, delle apparecchiature, dei beni, delle finanze, la guida delle risorse umane
impiegate ai loro diversi livelli e responsabilità. Non è questione che riguardi solo le
aziende con fini di profitto ma anche quelle senza fini di lucro e più in generale ogni
sistema di persone e di beni volto a perseguire in forma organizzata la produzione di
beni o servizi. Management è un termine che racchiude una pluralità di azioni tra esse
collegate, che richiedono letture diverse, finanziarie, giuridiche, sociologiche,
psicologiche; una visione d’insieme impone una complessità di analisi che contrasta con
le singole interpretazioni. L’azione di un soggetto interpretante è quindi fondamentale,
ma come evitare il soggettivismo? Come evitare un fare cieco perché privo di sapere?
Qual’è il criterio di verità applicabile?
Possiamo prevedere la ripetitività di un fenomeno osservato ed analizzato, verificare se
si presenta con caratteristiche determinate, entro un tempo prestabilito. Ricercare i
fattori che lo determinano. Vi sono dati incontrovertibili, uno su tutti il profitto,
l’equilibrio dei conti che indirizzano le scelte, ma i margini di interpretazione, le
conseguenti decisioni, rimangono ampi. L’analisi della domanda, la scelta di nuovi
prodotti e servizi, la partecipazione alla realizzazione degli obiettivi da parte dei
componenti l’organizzazione, per quanto guidate dai risultati, richiedono scelte
continue, manageriali. Servono continue interpretazioni dei dati che lasciano spazi di
scelta.
Management non significa solo competenze e procedure da applicare, regole da far
rispettare ma simboli da creare, una passione condivisa con l’universo aziendale, dare
vita ad una storia condivisa che comprenda passione, creatività e progetto, ragione e
sentimento, per costruire una identità, una storia collettiva che per proseguire nel
tempo ha bisogno di fondarsi sul riconoscimento, fiducia e interesse materiale. A titolo
di esempio, nell’analisi di un gruppo di lavoro gli schemi comportamentali, gli
adattamenti, sono sempre gli stessi e se vogliamo vederli all’opera possiamo creare una
sorta di camera di Wilson25 e studiare la traccia lasciata. Ma dobbiamo possedere gli
strumenti, la capacità di osservarli e non rimanere vittime degli eventi. Alla sostanza è
l’essere umano che lavora con la sua intelligenza ed è l’essere umano che con le sue
25
La camera a nebbia o di Wilson è uno strumento di rivelazione di particelle elementari ideato da Charles Thomson Rees Wilson nel 1899; consente di visualizzare il percorso tracciato dalle particelle e determinare la loro natura.
17
scelte, condizionate, determina il successo del lavoro manageriale. Qui sta il punto di
partenza ed arrivo.
La filosofia nasce quando si considera la realtà nella sua totalità. E vi sono una pluralità
di problemi che il management deve affrontare e che conseguentemente richiedono una
interpretazione filosofica; non solo problemi riguardanti la scienza tradizionalmente
intesa, considerato che non è esportabile la metodologia propria della scienza alle
humanities. Limitare la filosofia, come è stato fatto da tanti nel secolo scorso,
all'epistemologia è un errore. Quello che Popper chiama “Mondo 3” non è un modo per
introdurre il ragionamento filosofico ma una parte delle differenti attività e realizzazioni
da interpretare.
L’organizzazione migliore può andare in rovina quando processi organizzativi
soggiacciono a dinamiche comportamentali insane. Si pensi al sentimento dell’invidia, se
infetta un’organizzazione senza governo la può distruggere.
Ho trascorso la mia carriera per metà in aziende di profitto, multinazionali quotate in
borsa, e per metà in aziende non profit, filiazioni di enti pubblici, ed ho potuto
constatare come il sentimento dell’invidia sia un fenomeno sempre patito ed agito nei
luoghi di lavoro, ma anche dalla sostanziale diversità di come si esprime, pratica,
colpisce l’invidia nelle due diverse tipologie di impresa. Ho sperimentato come l’invidia
si manifesti nelle imprese di profitto particolarmente nei confronti della categorie
ritenute privilegiate; nella mia specifica esperienza l’invidia era una costante nei
confronti degli addetti alle vendite inquanto beneficiari di premi di risultato che
comportavano una retribuzione superiore del 30%, 50% rispetto a quanti operavano con
ruolo di staff (amministrativi, tecnici, etc.). I privilegiati avevano come presupposto del
successo del loro operare tempi imprevedibili e sempre stringenti delle loro richieste
alle altre strutture dell’azienda, modifiche spesso complesse e naturalmente immediate
di procedure e modelli produttivi dettate dalle attese dei clienti; a queste costanti si
opponevano ritardi, richiami alle procedure. Queste turbative venivano superate,
contenute, dalla consapevolezza che i capi, il top management, sarebbero intervenuti
per farle cessare perché loro stessi prevalentemente di estrazione commerciale e
soprattutto perché schierati dalla parte di chi sviluppava il business. Il mercato, il
profitto, più semplicemente il mondo esterno, costringeva a regole di comportamento
obbligate, e accettate, fungeva da contenimento dell’invidia. A titolo di esempio riporto
un caso specifico: le difficoltà frapposte da un ufficio amministrativo nella spedizione, da
una città del Nord a Roma, di documenti importanti e necessari per chiudere un
progetto nei termini, furono superate grazie all’intervento dello stesso vertice aziendale
che costrinse il responsabile dell’ufficio amministrativo a consegnarle per tempo con un
viaggio notturno in auto per ovviare anche ad uno sciopero generale dei trasporti. La
diversa concezione dei tempi di staff e line nell’espletamento di forniture importanti era
18
contenuta dalla consapevolezza che danneggiare il business avrebbe avuto conseguenze
esiziali. Ovviamente era presente anche la cognizione che il risultato riguardava tutti
inquanto avrebbe avuto un risvolto positivo sulla solidità dell’azienda e di conseguenza
anche sul futuro lavorativo. Tutto questo non impediva che l’aggressivo gioco delle
rivalità proseguisse tra le diverse anime dell’azienda a conferma che l’invidia e la rivalità
conseguente sono un dato costitutivo delle umane organizzazioni. Nelle aziende di
scopo, negli enti pubblici dove ho lavorato, la situazione si è sempre presentata
diversamente. Qui il profitto era considerato secondario, i disavanzi di bilancio erano
regolarmente appianati da risorse pubbliche e il top management veniva selezionato per
fedeltà e non per competenza. Al potere selezionato per appartenenza non interessano i
risultati, il ruolo istituzionale, ma la cordata di riferimento. In questo ambito gli elementi
che mettono al primo posto la qualità e la quantità dei risultati sono piuttosto da frenare
perché possono mettere in luce i limiti generali dell’organizzazione dell’ente pubblico.
Gli elementi capaci, ma anche i giovani desiderosi di sviluppare il loro potenziale e di
fare carriera, manifestano competenze, capacità, motivazioni che influiscono sui risultati
sensibili e mettono in vista chi li consegue; ne discende il proliferare dell’invidia e le
conseguenti azioni di disturbo nei loro confronti.
Henry Mintzberg ha scritto pagine illuminanti riguardo le caratteristiche di quegli
amministratori, che definisce valets, manager one step26, che iniziano la carriera come
valletti di un esponente di rilievo, più centrato sulla conservazione del suo potere che sul
compito27, e poi ricevono in premio un incarico di spicco senza aver maturato nessuna
esperienza manageriale; ma sanno tenersi abilmente nella rete di appartenenze. La
considerazione generale è che le ripercussioni per chi entra nel cono d’invidia del resto
dell’azienda di scopo possono essere devastanti. Qui l’invidia la fa da padrone ed è
inversamente proporzionale al perseguimento dello scopo aziendale, dato che il
rapporto tra carriera e risultati misurabili con la realtà è ininfluente.
Riporto una esperienza diretta: in un importante Ente Pubblico, in una riunione di
dirigenti responsabili di diversi servizi all’utenza, uno dei dirigenti illustrava alcune
proposte innovative che intendeva mettere in opera e che avrebbero dovuto generare
un miglioramento delle attività per l’utenza. La totalità dei presenti, tutti responsabili di
altri servizi al pubblico dello steso Ente, si mostrava contraria e dichiarava apertamente
che in tal modo si sarebbero messe in maggiore evidenza le differenze già in atto
nell’espletamento dei servizi al cittadino tra quel settore ed i loro, differenze che erano
andate crescendo negli anni, e che avevano generato rimostranze e segnalazioni da
26
Si veda in particolare: Mintzberg H., Structure in fives. Designing Effective Organizations, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1983 - La progettazione dell’organizzazione aziendale, trad. it. a cura di F. Isotta, Il Mulino, Bologna, 1996. Mintzberg H., Managing, Financial Times, Prentice Hall 2009, Il lavoro manageriale, trad. it. a cura di Franco Angeli, Milano 2010.
27 Scriveva Machiavelli: “La prima coniettura che si fa del cervello d’uno signore è vedere li uomini che lui ha d’intorno.” (Principe, 4, 22).
19
parte degli utenti. Uno dei partecipanti sottolineava la necessità, ed anche l’importanza,
che si mantenesse una omologazione del servizio fornito e quindi proponeva di rinviare
ogni intervento che non andasse in tale direzione. Il presidente dell’Ente, che presiedeva
la riunione, conveniva con tale richiesta per ragioni di opportunità, per mancanza
dell’autorità necessaria, per avere il sostegno dei suoi sodali. Successivamente le
innovazioni virtuose furono portate avanti, tra non poche difficoltà, in modo quasi
clandestino, ma alla struttura che si potrebbe definire virtuosa sono stati, nei due anni
successivi, ridotti gli spazi occupati di ¾, ridotte le commesse, bloccati aumenti e premi
che invece correvano per i comparti con deficit astronomici ed a cui venivano destinati
progressivamente gli spazi che venivano progressivamente recuperati. Si può dire con
Nietzsche, che l’invidia ha in sé il desiderio di abbassare al livello inferiore la supposta
superiorità altrui. Sul piano più generale, traguardando i due diversi ambiti aziendali-
organizzativi, si possono comunque fare alcune considerazioni: l’invidia un tempo era
riconosciuta come tale, nelle Marche si usa ancora una antica espressione verbale:
“gninoccia gninoccia commà/compà” quando si parla di qualcosa di molto invidiabile
dell’altro (un bel campo di grano, una gravidanza) e preferibilmente dicendo la formula
bisogna toccare l’oggetto dell’eventuale invidia. In questa consuetudine, sia nella
formula oramai perduta nel suo significato letterale (non gli nuoccia), così come nel
gesto di toccare il bene invidiabile, la società contadina dei nostri padri non solo
riconosceva, e forse ancora riconosce, un sentimento come l’invidia, ma si preoccupava
di mettere l’altro al riparo dalla potenza della propria invidia e tramite un rito la
esorcizzava. Oggi l’invidia non trova una puntuale riprovazione, è vista piuttosto come
una molla naturale che spinge ad una società egualitaria; una sorta di rivalità mimetica
che porta a volere quello che l’altro ha. L’invidia rimane, invece, nei diversi luoghi di
lavoro, un elemento distruttivo, perché è tristitia de bono proximi... exultatio de malo
eiusdem (amarezza per il successo del prossimo, godimento del suo fallimento), come
scriveva san Tommaso d’Aquino28. L’invidia può essere parafrasata con il passo della
Bibbia: “Prendete le volpi piccoline che guastano le vigne, mentre le nostre vigne sono in
fiore” (Cantico dei Cantici, 2,15); l’invidioso distrugge il lavoro altrui, il lavoro produttivo,
anche bello, spesso sul suo nascere, e non ne sente colpa; come un cucciolo
inconsapevole il suo agire non è orientato al mondo ma ad un sé perennemente
immaturo.
È possibile trovare una misura dell'impatto, del danno, che arreca l'invidia in una
organizzazione; in alcuni laboratori di ricerca americani questo viene studiato. È
possibile prevederne le conseguenze, analizzare. Resta un tasso di incertezza valutativa
come del resto per quanto concerne i comportamenti umani, ma quello che va valutato
filosoficamente, per non vivere come bruti, è la sostanza profonda. Vi è un di più cui
28
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II, 36, 4 ad 3 ( corpusthomisticum.org/iopera.html ).
20
siamo chiamati quando si analizzano comportamenti umani, un di più rispetto a quello
che può essere analizzato con modalità di laboratorio, misurato. Nello studiare l'invidia
siamo agiti da un sentire profondo: l'invidia aggredisce un'essenza radicale, arreca un
danno al principio di eguaglianza, alla creatività, al lavoro umano. Incontriamo un di più
che trae la sua origine dal convincimento, magari inespresso, che comportarsi come lupi,
o sciacalli, per gli umani contrasta con un principio metafisico: la natura umana non è
risolta dalle regole della sopravvivenza. L'intero dell'uomo è filosoficamente pensato e
ricercato e se non trova una soluzione per sempre data, il sentire tale istanza metafisica,
tale complessità, ci impone di non delimitare l'interpretazione ai soli processi misurabili.
Spinoza nel suo incompiuto Trattato politico si sofferma sulla natura passionale
dell’uomo ma prova a disegnare soluzioni argomentate di governo che ne tengano
conto. Egli sottolinea ripetutamente nel suo testo il comportamento irrazionale
dell’uomo, soggetto a passioni che non riteneva vizi della natura umana ma proprietà
connaturate “come il caldo ed il freddo appartengono alla natura dell’aria”29. Adamo,
ricorda Spinoza, per quanto beneficiasse di condizioni di vita invidiabili, potremmo dire
paradisiache, non si:
“servì rettamente della ragione ma come noi era soggetto a passioni.”30
ne consegue che:
“il potere deve necessariamente essere istituito in maniera tale che tutti, quelli che
governano come quelli che sono governati facciano l’interesse della salute comune,
cioè che tutti siano obbligati, spontaneamente o per forza o per necessità a vivere
secondo la prescrizione della ragione.”31
Platone nella Sesta e nella Settima delle lettere a lui attribuite invita ad una riflessione:
la necessità di coniugare filosofia e governo degli uomini.
Chi scrive è convinto che la filosofia non può essere un sistema compiuto, un’organica
sequenza assertiva, un’interpretazione esaustiva, ma una ricerca dei valori, sempre
aperta a nuovi approfondimenti. Da ciò consegue che il sapere deve essere indirizzato
ad individuare dei principi generali che favoriscano un’esistenza, ed un’attività umana,
buona inquanto felice, tanto pubblica quanto privata, ad individuare i fondamenti, i
valori a cui ci si debba attenere. È necessario allora che l’attore di tale processo conosca
se stesso, sappia interrogarsi e riconoscere almeno qualcuno dei suoi limiti, sappia
individuare la parte nascosta del processo organizzativo, quelle passioni che Spinoza
chiamava fattori connaturati all’essere umano. Per governare deve riconoscere gli
29
Spinoza B., Trattato politico,traduzione italiano di L.Pezzillo dall’Opera posthuma, Laterza, Bari 1991, pag 16. 30
Opera citata pag.10. 31
Opera citata pag.34-35.
21
aspetti economici ma saper anche riconoscere le emozioni, nominarle32. Per condurre
un’organizzazione bisogna far fronte a un numero elevato di problemi, prefigurare
situazioni, scenari, prevedere possibili difficoltà. Una certa dose di paranoia può essere
di aiuto. Una certa dose, non alimentarsi di paranoie che porterebbero a non vedere più
i problemi da affrontare ma crearsene di fittizi e rimanerne annichiliti. Luigi Zoia scrive:
“Una fiaba cherokee parla di due lupi. Un anziano dice ad un bambino: dentro di te
due lupi combattono una lotta mortale. Uno è buono, generoso, sereno, umile e
sincero. L’altro è pieno di rancori, di aggressività, di orgoglio, di sensi di superiorità e
di egoismo. Chi vincerà? Chiede il bambino spaventato. Quello che tu nutri, risponde
l’adulto. Se prendiamo la fiaba come schema … il paranoico è incapace di sentire il
conflitto interiore fra i due: per lui esistono solo lupi esterni.” 33
Si pensi alla storia della famiglia Gucci, un gruppo industriale che era riuscito a passare
rapidamente da bottega artigiana a multinazionale con un marchio, e manufatti, che
rappresentavano il successo del made in Italy nel mondo. Una rara capacità distruttiva
interna al gruppo dirigente l’ha dissolto. Avevano tutto ma erano incapaci di ammirare il
loro lavoro, erano invidiosamente distruttivi. Non si sono fatti mancare nulla, nemmeno
fattucchiere e omicidi su commissione.
La gran parte del tempo di un manager è spesa a governare e sanare conflitti, mediare
tra persone, contenere, spiegare, tornare indietro. Deve abituarsi a ricercare una
interpretazione complessa, avere una bassa tolleranza per le considerazioni
esemplificative. Il manager, per governare la sua organizzazione e cogliere le istanze che
vengono dal mondo esterno, reale, deve stare sul confine, essere capace di leggere i
comportamenti palesi e gli aspetti irrazionali, partecipare in prima persona e mantenere
un obbligato distacco, una sorta di disincanto. Come Teseo non guarda direttamente
Medusa per non farsi annientare ma il suo riflettersi sullo scudo, se ne fa schermo,
riflette l’immagine, la vede attraverso un processo che è volto a se stesso, riconosce il
potere dell’altro e la sua debolezza e supera entrambi attraverso una riflessione, cambia
il suo modo di guardare, lo rende più complesso, apparentemente più distante, indiretto
ma efficace.
Una riflessione filosofica ci consente di affermare che quando affrontiamo un fenomeno
lo interpretiamo e siamo limitati da principi, schemi. Sono prime fonti, scrive Kant; ma
non sono fissi perché contengono un quid ulteriore, storicamente dato, che ci consente
di modificarli nel tempo. Con fatica, rompendo schemi interpretativi apparentemente
naturali, perché il nostro a priori contiene anche i germi che ne scardinano la rigidità,
32
A titolo di esempio un manager che abbia tali competenze nell’assegnare gli incentivi ai suoi collaboratori terrà in prima istanza conto delle sue preferenze “umane”, dei suoi possibili conflitti con giovani, inquanto giovani, emergenti, inquanto emergenti.
33 Zoia L., Paranoia, Bollati Boringhieri, Torino 2011, pag. 372.
22
che ci consentono di superare interpretazioni che ci appaiono date. Possiamo analizzare
i nostri comportamenti, le loro risultanze, le nostre letture, ed affrontare le novità
attraverso percorsi difficili, di rottura. Nelle organizzazioni questo vuole dire che non
dobbiamo limitarci ad analizzare i sintomi ma cercare di arrivare alle cause; analizzare i
processi organizzativi, la leadership, la motivazione ed enuclearne i limiti per finire nella
modificazione degli strumenti tecnologici, delle modalità operative, delle soluzioni
tecniche da adottare. Le diagnosi comportano la trasformazione delle procedure e solo
una consapevolezza interpretativa può garantire il successo delle nuove applicazioni.
Insomma un buon lavoro manageriale comporta la messa in discussione degli a priori,
ovvero la capacità di risalire alla complessità delle cause, la non linearità dell’agire, per
ridiscendere alle soluzioni ed alla verifica successiva dei risultati finalizzati agli obiettivi.
Rinvia a qualcosa che rimane fuori da un ragionare su calcoli, a fatti che ci dobbiamo
rappresentare, che il linguaggio non ha capacità di dire, dobbiamo risalire a problemi
dove il termine di verità ha molte sfaccettature. Gli aspetti inconsapevoli fanno parte
della vita esperienziale, della totalità del vissuto, della complessità del reale che richiede
una ragione esplicativa, una interpretazione, una ermeneutica. Un significato che non
sarà mai certo del perché di un agire. La questione di carattere epistemologico è: che
livello veritativo raggiungiamo? Nella realtà noi non diamo vita ad una attività
prendendo avvio da connessioni empiriche piuttosto da una ipotesi, e i dati successivi
dobbiamo interpretarli; il processo non è: dati esperienziali - valutazione - nuovi dati
esperienziali, ma: ipotesi – dati - interpretazione - nuova ipotesi. Sviluppiamo congetture
frutto della libertà creativa dell’intelletto sottoposte a verifica sperimentale in un
procedere che non consente di mettere un punto finale ad un processo circolare di
ipotesi, verifica, teorizzazione. Ipotesi perché il mondo esterno a noi non è
indipendente dal nostro pensiero. Chi studia il mondo, chi cerca di interpretare i
fenomeni della natura appare guidato dalla visione, anche quando negata; chi cerca di
interpretare i comportamenti umani: da una immagine di complessità, da profondità
nascoste che rinviano ad una incompiutezza che apre a qualcosa di altro, che anche
quando richiudiamo per paura dell’ignoto e dell’incomprensibile ci fa intravedere la
necessità di letture tutt’altro che razionalmente schematiche.
L’esistenza di una realtà esterna a noi non fa venire meno il dato necessario del soggetto
pensante e del giudizio; e si pone il problema del come demarcare una corretta verifica
di laboratorio per i fenomeni naturali da una analisi accurata del comportamento
umano.
Popper dichiara che le scienze umane non sono scientifiche perché non falsificabili ma
ridona autonomia e nobiltà alla metafisica giudicandola essenziale inquanto prius alla
base degli esperimenti scientifici di convalida. Le due parti, scientifiche ed umane pur
diverse non sono scisse irreparabilmente e le une chiedono le altre; la scienza la
metafisica. Allora analizzare i comportamenti umani non può risolversi in una indagine
23
scientifica, statistico-matematica, ma ricercando altro e tale altro lo si può leggere, con
tutti i limiti di una interpretazione, avendo gli occhi della mente per saperlo fare. Per
risalire ai perché possiamo utilizzare una lettura mitica, l’importante è non privarcene
per dare una base ad una ricerca della verità che sappiamo inconoscibile, che non risiede
solo nella scienza, di una “realtà intesa come totalità di enti differenti.”34
Reale non è solo ciò che è misurabile. La mente umana presuppone leggi che nel caso
della scienza cerchiamo di avvalorare con l’esperienza e, là dove l’osservazione è ardua,
mediante la ricerca di leggi matematiche che la descrivano; ma vi sono campi di
applicazione non studiabili con tali metodologie ma che fanno parte integrante della
realtà che ci circonda; vi è un oltre che si percepisce, pensa, interpreta. L’intuizione
creatrice è un prius che deve essere verificato, modellizzato, interpretato per trovare
una corrispondenza tra intuizione ed esperienza, ma nel campo dei comportamenti
umani la ripetitività, la verificabilità è soggetta a un quid; le analisi socio-economica e
psicologica presentano un grado di interpretabilità elevatissimo, ciò non toglie che
riguardano una componente del reale, della complessità del reale, di importanza
massima e non qualcosa da liquidare perché non assoggettabile a regole di laboratorio.
Dobbiamo partire proprio da un nuovo, ma antico, presupposto: l’unità del reale nella
sua grande differenza, e dare un senso al reale. La verità scientifica sperimentalmente
dimostrabile è essenziale alla conoscenza della realtà ma è una delle conoscenze. La
nostra conoscenza sarà sempre ignoranza dotta, presumiamo un ordine che ci rimane
indefinito, ma per conoscere il mondo fuori e dentro di noi dobbiamo vederlo come un
insieme che richiede metodologie diverse ma che resta un insieme. Insomma capire che
esiste qualcosa che travalica la ragione, accettare che ci possiamo porre domande cui
non sappiamo dare risposte.
Da tutto questo ragionare ne discende che i manager debbono avere una formazione ad
ampio spettro, di carattere sia scientifico che umanistico; un efficace MBA dovrebbe
includere lezioni su argomenti che facilitino una comprensione della complessità
dell’agire umano, degli irrazionali.35 Si badi: serve una integrazione dei due aspetti
perché i problemi non possono essere risolti affrontando solo l’umano comportamento
e le sue patologie, servono sempre soluzioni anche organizzative, interventi di carattere
economico, modifiche ai processi produttivi, adeguamento di tecnologie, rispondenza al
mercato. Queste senza affrontare gli stili relazionali, la leadership, rischiano di non
venire adeguatamente applicate; è la loro applicazione efficace l’obiettivo di ogni
positivo cambiamento e crescita conseguente. È un insieme che va gestito come tale e
34
Salucci A., Epistemologia e verità nel XX secolo, Angelicum University Press, Roma 2005, pag. 276. 35
Potrebbero prevedersi delle lezioni su temi quali: Platone e la politica, il Trattato politico di Spinoza, la concezione della scoperta scientifica in Kuhn, Heisemberg e gli sviluppi della fisica teorica, l’a priori in Kant. Vanno rafforzate le competenze di chi deve occuparsi di management e questo è l’obiettivo del mio insegnamento; niente a che vedere con consulenze definite filosofiche che ritengo poco filosofiche e di nessuna utilità per la conduzione manageriale.
24
per poterlo fare va riconosciuto come tale. Una organizzazione è un insieme di persone
e tecnologie per realizzare un obiettivo programmato.
Concludendo, studiamo il management in una facoltà di filosofia perché richiede un
pensiero complesso, non rigido pragmatismo, risposte solo empiriche, perché la filosofia
del management è un ambito della speculazione filosofica.
25
BIBLIOGRAFIA
- Aristotele, Aristotle’s Metaphysics, Ross, W. D., 2 voll, Clarendon Press, Oxford
1924. La metafisica, trad. it a cura di Oggioni E., CEDAM, Padova 1950.
- Arpaia B., L’energia del vuoto, Guanda, Parma 2011.
- Arroyo Camejo Silvia, Skurrile Quantenwelt, Springer-Verlag, Heidelberg 2006 - Il
bizzarro mondo dei quanti, ed. Springer-Verlag Italia, Milano 2008.
- Berto F. , Tutti pazzi per Godel, Laterza, Bari 2009.
- Bion W.R., Second Thoughts (Selected Papers of Psychoanalysis), Heinemann,
London 1967.
- Bion W.R., Experiences in Groups and other Papers, Tavistock Publications Ldt 1961
- Esperienze nei gruppi, Armando, Milano 1979.
- Bohr N., Athomtheorie und Naturbeschreibung, Springer, Berlin 1931, Atomic
Physics and Human Knowledge, Wiley, New York 1958, Essays 1958-1962, Wiley,
New York 1963; I quanti e la vita, Bollati Boringhieri ed, Torino 2007.
- A. Einstein, The world as I see it, Carol Publishing Group, New York 1956 - Come io
vedo il mondo, Newton Compton ed. 2006.
- Einstein A., Infeld L., The evolution on Physics from Early Concept to Relativity and
Quanta, Cambridge Univ. Press 1938 - L’evoluzione della fisica, Bollati Boringhieri
ed., Torino 1965.
- Feynman R.P., Six easy pieces, California Institute of Technology 1963 - Sei pezzi
facili, Adelphi, Milano 2000.
- Havelock E.A., Preface to Plato, Cambridge, Massachusetts 1963 - Cultura orale e
civiltà della scrittura, trad. it. a cura di M. Carpitella, Laterza, Bari 1973.
- Heisenberg W., Physics and Philosophy, Penguin Books London 1958 - Fisica e
filosofia, Il Saggiatore, Milano 2008.
- Heisenberg W., Wandlungen in der Grundlagen der Naturwissenschaft, Herzel
Verlag, Stoccarda 1944 - Mutamenti nelle basi della scienza, trad it. Di A.Verson,
Einaudi, Torino 1944.
- Mintzberg H., Structure in fives. Designing Effective Organizations, Englewood Cliffs,
New Jersey Prentice-Hall Inc. 1983 - La progettazione dell’organizzazione aziendale,
trad. it. a cura di F. Isotta, Il Mulino, Bologna 1996.
26
- Mintzberg H., Managing, Financial Times, New Jersey Prentice-Hall Inc. 2009 - Il
lavoro manageriale, trad. it. a cura di Franco Angeli, Milano 2010.
- Mintzberg H, The manager’s job: folklore and fact, in HBR Leadership Insights,
Harvard Business School Publishing 1990.
- Pagnotta P., Filosofia del Management, Stamen, Roma 2011.
- Penrose R., The Road to Reality, Roger Penrose 2004 - La strada che porta alla
realtà, BUR Rizzoli, Milano 2011.
- Platone, Opera, Burnet I., 5voll, Oxford, Clarendon Press 1906-7. Tutte le opere,
trad. it. a cura di Sansoni editore, Firenze 1975.
- Popper K.R. - Eccles J.C., The Self and Its Brain an Argument for Interactionism,
Springer Verlag 1977 - L’io e il suo cervello, Armando editore, Roma 1981.
- Popper K.R. , Conjectures and Refutations, London Routledge and Kegan Paul, 1969
- Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna 1972.
- Reale G., Valori dimenticati dell’occidente, Bompiani, Milano 2006.
- Reale G., Platone, BUR, Milano 2004.
- Salucci A., Epistemologia e verità nel XX secolo, Angelicum University Press, Roma
2005.
- Spinoza B., Trattato politico,traduzione italiano di L. Pezzillo dall’Opera posthuma,
Laterza, Bari 1991.
- Zoia L., Paranoia, Bollati Boringhieri, Torino 2011.
27
INDICE
PRIMA LEZIONE - Platone sulla scrittura e l'arte ..................................................... 2
SECONDA LEZIONE - La rivoluzione del pensiero scientifico del '900 ....................... 9
TERZA LEZIONE - Recta ratio nella conduzione delle organizzazioni ...................... 16
28
Piero Pagnotta, Roma 1948, laureato in Filosofia, ha lavorato in Honeywell, Olivetti,
dove ha ricoperto l’incarico di direttore di filiale commerciale, attualmente dirige
l’IRFI, azienda della Camera di Commercio di Roma; è docente di Filosofia del
Management presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”.