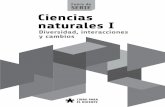Per una nuova paragrafatura del Libro del Cortegiano
-
Upload
independentresearcher -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Per una nuova paragrafatura del Libro del Cortegiano
PER UNA NUOVA PARAGRAFATURADEL «LIBRO DEL CORTEGIANO»
Valeria Guarna*«Sapienza» Università di Roma
Ma il compito della scienza non è soltantoquello di fondare nuovi edifici, sì bene quelloancora di finire e di rifinire gli edifici già inco-minciati: anzi più che la fabbrica progrediscee si avvia al compimento, più si avverte la con-venienza di dare ad essa l’ultima perfezione.
R. Ridolfi
1.
a tradizione testuale del Libro del Cortegiano è documentata da una serie di manoscrittitutti appartenuti allo scrittoio dell’autore: dai primi appunti conservati in una serie
di carte autografe fino alla terza e definitiva redazione affidata all’attuale LaurenzianoAshburnhamiano 409 (L),1 ultimo codice in ordine di tempo, conservato oggi nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, che venne utilizzato dai tipografi, eredi diAldo Manuzio, per la messa a stampa dell’opera. Il Laurenziano fu finito di compilare aRoma il 23 maggio 1524, come si ricava dalla sottoscrizione del copista in fondo al volu-me (c. 273r); tuttavia, prima di essere inviato agli stampatori, fu oggetto di correzioni e
* [email protected] il prof. Amedeo Quondam che mi ha mostrato la via che conduce al Cortegiano e il prof.
Pasquale Stoppelli che mi ha suggerito gli strumenti per poterla percorrere.1 Le diverse fasi di elaborazione del Libro del Cortegiano vengono ricostruite nel fondamentale
contributo di Ghinassi 1967. Gli stati redazionali dell’opera sono tramandati dai seguenti documenti: gli«Abbozzi di casa Castiglione» (A), conservati presso l’Archivio di Stato di Mantova; i mss. Vat. Lat. 8204(B), 8205 (C) e 8206 (D) della Biblioteca Apostolica Vaticana; il ms. Laurenziano Ashburnhamiano 409 (L)della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.
«filologia italiana» · 10 · 2013
Il contributo esamina le note di tipografia pre-senti nel ms. Laurenziano Ashburnhamiano409, che conserva la terza e ultima redazionedel Libro del Cortegiano. Il codice, utilizzato perla messa a stampa dell’opera (Venezia 1528,eredi di Aldo Manuzio), reca delle istruzioniper la mise en page. Alcune di queste sono stateinterpretate come indicazioni per la scansionetematica del testo, che verrebbe ripresa nel-l’editio princeps con particolari accorgimenti tipografici. Alla luce di una più accurata colla-zione tra il Laurenziano e l’Aldina viene pro-posta una nuova paragrafatura del testo.
The essay examines the printer’s marks in thems. Laurenziano Ashburnhamiano 409, whichpreserves the third and final drafting of the Libro del Cortegiano. The manuscript, which isused for fine-press work (Venice 1528, AldusManutius’s successors), bears the instructionsfor the mise en page. Some of these instructionsare useful for thematic division of the Corte-giano and they are transfered in the editio prin-ceps with precise typographic adjustments. Inthis paper all of the markings in the two docu-ments are recorded and analyzed. The essaypresents a new scansion for Castiglione’s work.
L
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 107
108 valeria guarna
varianti, non tutte riconducibili all’autore. Nella primavera del 1527 il codice giunse a Venezia tramite Bartolomeo Navagero, quindi consegnato a Giovan Battista Ramusio,collaboratore della tipografia veneziana. Castiglione infatti dal 7 ottobre 1524 si trovavaalla corte spagnola di Carlo V in qualità di nunzio pontificio, carica ottenuta da ClementeVII il 19 luglio dello stesso anno.1 Nonostante gli impegni politico-diplomatici, Casti-glione sorvegliava la lavorazione editoriale da lontano, inviando precise istruzioni al suofattore Cristoforo Tirabosco, il quale insieme ad Aloisia, madre dell’autore, seguiva lavicenda tipografica che coinvolgeva contemporaneamente importanti personaggi ve-neziani, da Ramusio ad Andrea Navagero a Lodovico Canossa.2
Prima che entrasse in tipografia il codice già presentava una complessa stratigrafiarisultato dei ripetuti passaggi di mano.3 L’accumulo di scritture venne ulteriormentecomplicato in sede editoriale, quando il Laurenziano fu affidato alle cure redazionali delletterato veneziano Giovan Francesco Valier.4 I tipografi incaricarono Valier di provve-dere alla revisione linguistica del testo con l’obiettivo di renderlo quanto più possibileconforme a quell’italiano ‘tipografico’ che in quegli anni andava formandosi soprattut-to in seno all’editoria veneziana.5 L’elegante in folio dell’editio princeps del Cortegiano vi-de la luce a Venezia nell’aprile del 1528 «nelle case d’Aldo Romano e d’Andrea d’Asola».6
1 Per la ricostruzione delle vicende biografiche di Castiglione si rimanda a Cian 1951 e alla voce re-datta da Mutini 1979.
2 La scoperta di importanti documenti, utili alla ricostruzione dell’iter tipografico, si deve a Bertolo1992; in passato alcuni ritrovamenti erano stati già segnalati da Ghinassi 1971. In particolare le lettere utiliper seguire la messa a stampa del Cortegiano sono: 1) Madrid, 6 aprile 1525. Lettera di BC ad Andrea Pipe-raio: Castiglione chiede al Piperaio di scrivere a Marco Antonio Flaminio perché si occupi della pubblica-zione dell’opera. 2) Toledo, 16 giugno 1525. Lettera di BC alla Contessa della Somaglia Bianca Landriani:Castiglione dichiara di non avere più con sé il ms. del Cortegiano [codice Laurenziano] che sarebbe rimastoin Italia, mentre lui si trova in Spagna in qualità di nunzio pontificio alla corte di Carlo V. 3) Valladolid, 9aprile 1527. Lettera di BC a Cristoforo Tirabosco: Castiglione invia il manoscritto a Venezia tramite Bar-tolomeo Navagero, perché venga consegnato a Giovan Battista Ramusio, collaboratore della tipografia al-dina. 4) Venezia, 21 novembre 1527. Lettera di Cristoforo Tirabosco a BC: Castiglione viene informato de-gli accordi finanziari intercorsi tra i Manuzio e il Ramusio e di una lettera che Andrea Navagero avrebbeinviato agli stampatori nella quale si raccomanda che l’opera venga «stampata bene e diligentemente».
3 La ricognizione di tutte le mani intervenute sul codice ‒ ad oggi ne sono state identificate cinque ‒si deve a Ghinassi 1963; in particolare si vedano le tavole i-viii.
4 Con difficoltà si è proceduto alla ricostruzione della figura del Valier, il quale infatti, accusato dispionaggio ai danni della Repubblica Veneta, era stato condannato a morte subendo una conseguentedamnatio memoriae. Del Valier si sono occupati vari studiosi: Cian 1887; Padoan 1978, pp. 335-46; Ordine1992; Motta 2003, pp. 255-95. Si segnala, inoltre, che, in occasione della recente Mostra Gli arazzi dei Gon-zaga nel Rinascimento (Mantova, 14 marzo-27 giugno 2010), sul «Corriere della Sera» è apparso un artico-lo di Nuccio Ordine dedicato al Valier: Diplomazia e spionaggio: il caso Valier (10 marzo 2010).
5 Gli interventi linguistici di Valier apportati al Laurenziano sono stati ampiamente esaminati in Ghi-nassi 1963. La scelta di Valier come correttore viene presa dagli editori, così come si può apprendere dadue lettere. Nella prima del 21 novembre 1527, inviata da Venezia a Castiglione dal fattore Cristoforo Ti-rabosco, si legge: «Apresso li sta datto el libro al Magnifico Messer Giovan Francesco Vallerio, da re-mendarlo e apontarlo, perché cossì ha dimandato li stampadori». L’altra lettera, invece, viene spedita daMantova il 22 novembre 1527 da Aloisia Castiglione allo stesso Tirabosco: «Ben mi maraviglio di quellizentilhomini [rif. stampatori], se fazevano penser che ’l Valerio revedesse el libro, che siano stati tanto,havendolo ne le man como havevano» (per la lettera del 21 novembre vedi Bertolo 1992, p. 137; per quel-la del 22 vedi Ghinassi 1971, p. 178). La revisione compiuta sul Laurenziano da Castiglione si era rivelatasporadica e insufficiente: la vera preparazione del testo per la stampa sarebbe avvenuta solo in tipografia.Per un’analisi delle pratiche linguistiche dei correttori si rimanda a Quondam 1983, Trovato 1991, Mara-schio 1993, Trifone 1993.
6 Come si legge nel colophon (c. p5v). D’ora in poi la princeps verrà citata anche come Aldina.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 108
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 109
La disponibilità di una consistente quantità di documenti, che attestano le diverse fasiredazionali e la messa a stampa dell’opera, ha consentito di ricostruire il modo di lavora-re dell’autore e di ripercorrere le vicende e le operazioni avvenute nell’iter tipografico deltesto. Chi oggi decida di perlustrare il cantiere filologico del Cortegiano si accorgerà cheil terreno è stato ampiamente esplorato.1 Tuttavia un’ulteriore analisi del Laurenziano,una più particolareggiata collazione del codice con l’Aldina e la ricognizione delle noteper il tipografo consentono di evidenziare aspetti secondari e di precisare singoli dettagli.
Gli indizi del passaggio in tipografia del Laurenziano sono ancora visibili sul codice:ditate di inchiostro, segnature per la messa in pagina, indicazioni allo stampatore spar-se qua e là. Già nell’articolo preparatorio alla sua edizione del Cortegiano Bruno Maierriconosceva nel Laurenziano il manoscritto impiegato per la stampa sulla base delle nu-merose avvertenze per il tipografo che esso conteneva.2 Dieci anni più tardi Ghino Ghi-nassi riconosceva nel Valier il responsabile di queste avvertenze. Dunque il letterato ve-neziano avrebbe avuto il compito non solo di rassettare linguisticamente l’opera, maanche di preparare il codice per la stampa.
L’osservazione del manoscritto mette in evidenza la presenza di tre tipi di indicazio-ni, tracciate con un inchiostro più sbiadito rispetto a quello del testo. La prima riguar-da le istruzioni per i compositori su come il testo dovesse essere organizzato all’inter-no dell’area di stampa (ovvero distribuzione di rientri, versi e capoversi) e su come, divolta in volta, si sarebbero dovute gestire sia le opzioni grafico-fonetiche, sia la grafia intermini puramente formali (maiuscole). Queste istruzioni vengono accolte ed eseguitecon scrupolo nella stampa, prova ulteriore del passaggio del Laurenziano in tipografia.La seconda tipologia di indicazioni è quella apposta ai margini e tra le parole per il con-teggio dei fascicoli e delle carte della princeps (i segni a secco). Si tratta di note di servi-zio già studiate e classificate,3 delle quali dava notizia il bibliotecario francese LeopoldDelisle nella prima descrizione del codice.4
La terza e ultima delle indicazioni redazionali viene annunciata e chiarita nel versodella quarta carta preliminare al codice dove si legge questo avviso: «Il stampatore hada advertire, che dove si vedeno i segni grandi a questo modo [segno grafico convenziona -le - Fig. 1] bisogna lasciar spatio larghetto, e cominciar la clausula con lettera un pocopiù maiuscula de l’altre, ma non ci si metta già il segno».5 Si tratta di un simbolo
1 Oltre ai già citati contributi di Ghinassi, si rimanda a Cian 1942, La Rocca 1980, Quondam 1999, Fahy2005, Sorella 2006. 2 Maier 1953.
3 Maier 1953, e Ghinassi 1963, p. 250, nota 50. Per completezza si riportano alcune informazioni tratteda Ghinassi: «c. 13r (Questo Per non va fuori de la linea…), c. 33r (Boccaccio sempre a questo modo si stampi),c. 51r (Questi versi mi par che habbian da esser scritti come versi, alla foggia che son qui di sotto: li riscrive in fon-do alla pagina eseguendo i capoversi), c. 212r (Notate che quel Il va ne la linea et non fuori), c. 212v (QuestoParve vien fuor di linea), c. 256v (Guardate questa parola Hortona come l’havete stampata nel principio del primolibro, dove nomina le persone che praticavano alla Corte d’Urbino, et così stampatela anche adesso o con H o senzaH), ecc. Una volta sola, a c. 119v (questi hanno da esser versi), l’avvertimento al tipografo non è scritto daLÁ, ma da una mano che sembra di poter identificare con L‚». Ghinassi ritiene, inoltre, che nelle ultimecarte del manoscritto siano presenti anche alcuni segni residui di «impaginature precedenti» che non trovano però riscontro nella messa in pagina della princeps. A riguardo si veda Ghinassi 1963, p. 250, nota51. Sulla questione è poi tornato Trovato 1989 (1998), p. 181.
4 Delisle 1886, p. 52 osservava: «À beaucoup d’endroits on remarque des traits indiquant la place à la-quelle devait finir une page et commencer la page suivante. Or ces coupures correspondent rigoureuse-ment à la disposition des pages de l’édition de 1528».
5 In questo contesto con il termine «clausula» si dovrà intendere una porzione di testo nella quale sidiscute e si esamina un concetto in tutti i suoi aspetti.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 109
110 valeria guarna
Fig. 1 Ms. Laurenziano Ashburnhamiano 409, c. ivv:avvertenza al tipografo. La scrittura è quella di Giovan Francesco Valier.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 110
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 111
convenzionale presente in tutto il codice e tracciato, come le altre indicazioni, con uno stilo acuminato e un inchiostro rossastro-marrone da una mano riconoscibile comequella di Gian Francesco Valier.1 Fino ad ora nessuna attenzione è stata riservata a quest’ultimo tipo di segni.
Sin dalla prima edizione moderna, quella allestita da Vittorio Cian nel 1894, i quattrolibri del Cortegiano vengono scanditi per capitoli: il primo libro ne conta 56, il secondo100, il terzo 77 e il quarto 73.2 Tutte le successive edizioni si sono poi attenute a questasuddivisione. Nel 2002 è uscita negli «Oscar» Mondadori una nuova edizione del Corte-giano curata da Amedeo Quondam. L’opera è stata rinnovata sotto l’aspetto grafico e lascansione del testo completamente rivista.3 Quest’ultima novità costringe chiunque siavvicini allo studio del Libro del Cortegiano a realizzare una tavola sinottica della nuovae della vecchia paragrafatura. La nuova segmentazione è stata prodotta parcellizzandol’opera, poiché ogni libro viene diviso non solo per capitoli, ma anche per paragrafi.4
Riguardo a queste due innovazioni alcuni studiosi si sono ritrovati a discutere e a riflettere sulle questioni metodologiche che la novità editoriale ha sollevato.5 Paolo Trovato, pur avendo accolto positivamente il volume, esprime forti riserve sulla paragrafatura «che mette fuori gioco in un colpo solo almeno un secolo di studi e di ri-ferimenti puntuali al Cortegiano».6 Ha elogiato invece il «principio di segmentazione»Francisco Rico, richiamando all’attenzione la necessità di ampliare gli studi sulla capitulatio delle opere medievali anche ai testi a stampa. Circa la maniera in cui sia statarealizzata sull’opera di Castiglione, Rico prende tuttavia le distanze poiché «inietta nelCortigiano un carattere artificiale, da oggetto di studio, scolastico».7
In termini più generali, sulla necessità dell’analisi delle forme di pubblicazione è intervenuto, in altra occasione, anche lo storico francese Roger Chartier, il quale ha ri-
1 Ghinassi 1963, p. 224 e tav. v.2 Così motivava Cian la partizione in capitoli dell’opera: «serbai quella divisione tradizionale del libro
in capitoli, che se non apparisce nel manoscritto laurenziano e neppure nelle più antiche edizioni, riesceutile agli studiosi, specialmente per le citazioni, e, tranne pochi casi è abbastanza ragionevole e razionale»(Cian 1894, p. x).
3 Infatti nella nota al testo dell’edizione si leggono le motivazioni e le finalità di questa operazione:«Da qualche tempo si discute sull’opportunità di elaborare criteri non casuali per l’edizione degli antichiclassici italiani, proprio con l’obiettivo di migliorarne l’indice di leggibilità rispetto alle attuali compe-tenze linguistiche del lettore standard. […]. Il mio obiettivo è stato quello di fare in modo che il nostrolettore avesse la medesima opportunità dei suoi omologhi lettori di lingua inglese (o francese, eccetera)di leggere il Cortigiano nella loro lingua d’oggi. […]. Ho deciso pertanto di perseguire l’obiettivo di unarigorosa e organica modernizzazione del testo» (Quondam 2002, t. i, p. cviii). Mentre per quanto riguarda la nuova paragrafatura del testo lo stesso Quondam dichiara: «Ho cercato di migliorare la segmentazione del testo, che nella princeps (e nei manoscritti) produce un blocco continuo per ciascunodei quattro libri, senza un attimo di respiro» (ivi, p. cix).
4 Dedica: 40 paragrafi; i libro: 9 capitoli e 434 paragrafi; ii libro: 12 capitoli e 684 paragrafi; iii libro: 7capitoli e 519 paragrafi; iv libro: 7 capitoli e 475 paragrafi. Quondam spiega così i due livelli di scansioneintrodotti: «il primo suddivide ciascun libro in partizioni più o meno ampie ma tematicamente omoge-nee; in questo modo l’impianto argomentativo dei dialoghi è immediatamente riconoscibile. […]. Il se-condo scandisce tutto il testo in paragrafi, […] è l’applicazione al Cortigiano della partizione ordinaria diogni testo in prosa antico o moderno, che risolve tante incongruenze di funzionalità e perspicuità nelladivisione in capitoli introdotta da Vittorio Cian, e poi adottata da tutte le edizioni moderne» (Quondam2002, t. i, pp. cix-cx).
5 Gli interventi degli studiosi presentati in occasione dell’incontro, avvenuto presso il Dipartimentodi Italianistica dell’Università di Bologna (19 maggio 2003), sono ora raccolti nel primo volume della rivista «Ecdotica», 2004, a cui si rimanda.
6 Trovato 2004, p. 159. 7 Rico 2004, p. 177.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 111
112 valeria guarna
badito che le modalità di trasmissione di un testo devono essere ricondotte alla dimen-sione storica e culturale pertinente, onde evitare qualsiasi anacronismo valutativo.L’esame della funzione espressiva degli elementi non verbali, che intervengono nel-l’organizzazione del manoscritto o nella disposizione del testo stampato, si rivela quin-di indispensabile ai fini di una corretta comprensione e interpretazione di un’opera.1
Approfondendo tuttavia lo studio del ms. Laurenziano2 e collazionando il testo ma-noscritto con quello della princeps, mi è stato possibile rivolgere l’attenzione ad aspettiche finora, anche se rilevati, non sono stati sufficientemente valutati. È il caso appuntodei segni ‘paragrafali’ visibili sul codice (terzo tipo). Inizialmente potrebbero sembraresolo istruzioni per i compositori su come il testo dovesse essere organizzato all’internodell’area di stampa. Infatti là dove sul manoscritto è presente il segno, sulla pagina stam-pata viene rispettata quasi sempre l’indicazione di «lasciar spatio larghetto». Uno spaziobianco che risalta bene agli occhi nell’organizzazione grafica della pagina. Da notare però che in corrispondenza del segno non viene mai realizzato un carattere più granderispetto agli altri, come ci si aspetterebbe dalle indicazioni del Valier.3
Osservando la distribuzione dei segni ho notato che in realtà questa risponderebbe auna logica: i segni sembrano marcare o l’inizio di un discorso diretto o un passaggio tematico.4 Ovviamente la distinzione fra queste due funzioni non è sempre così netta,dato che in alcuni casi il segno, oltre a indicare l’inizio del discorso di uno dei perso-naggi, mette in evidenza anche l’alternarsi delle opinioni, ovvero quel botta e rispostatipico del trattato-dialogo. Questi segni paragrafali potevano dunque essere tracciati solo da chi, come Valier, aveva una competenza attiva del testo. Infatti non solo egli interviene a sistemare alcuni periodi da un punto di vista sintattico e lessicale, ma introduce nell’opera una facezia ex novo, allineandosi perfettamente al continuum nar-rativo del Cortegiano.5 Anche per questo il Valier è l’unico tra quelli che hanno lavoratosul manoscritto che avrebbe potuto mappare il testo, con le pause giuste e con la mes-sa in rilievo dei passaggi tematici.
1 Chartier 2000. Sul tema si vedano anche i contributi di Anthony Grafton, di Jean-François Gilmonte di Roger Chartier in Cavallo, Chartier 2009 rispettivamente alle pp. 199-242, 243-75 e 317-35. AncheMcKenzie 1986 (1999) sostiene che il significato di un’opera sia strettamente e imprescindibilmente con-nesso alla forma fisica in cui si presenta. L’importanza di una corretta valutazione dell’assetto graficostrutturale dei manoscritti si era già rivelata nei casi della Vita nova e del Decameron, con implicazioni cri-tiche ed ecdotiche. Per l’opera dantesca gli studi si devono a Guglielmo Gorni che, nell’approntare l’edi-zione einaudiana del 1996, ha proposto una nuova scansione del testo, sostenendo che la paragrafaturafosse già presente nei codici più autorevoli che tramandano il prosimetro. Gorni spiegava e commenta-va la scelta in articoli preparatori all’edizione: si vedano Gorni 1994, 1995a e 1995b. Gli studi relativi al De-cameron, conservato nel ms. berlinese Hamilton 90, rivelano come i cinque tipi di maiuscole impiegatirisponderebbero a una esigenza dell’autore di segmentare il testo in unità semantiche a vantaggio di unamigliore comprensione. Infatti le diverse tipologie grafiche adottate hanno un valore interpretativo, ov-vero organizzano le novelle in sezioni, ognuna con una specificità tematica. A riguardo si rimanda a No-cita 1999; Battaglia Ricci 2000, pp. 141-49; Malagnini 2003; Cursi 2007, pp. 152-59; Battaglia Ricci 2010.
2 Tutte le indagini sono state condotte su una copia digitale del Laurenziano, concessami gentil-mente dal Centro Informatico della Biblioteca Italiana (cibit) del Dipartimento di Italianistica della Fa-coltà di Lettere e Filosofia della «Sapienza» Università di Roma.
3 A meno che le istruzioni di Valier non facessero riferimento semplicemente alla lettera maiuscola(«e cominciar la clausula con lettera un poco più maiuscola dell’altra»), che in effetti nell’Aldina compa-re sempre dopo il segno.
4 A volte vengono usati come notabilia per richiamare l’attenzione del lettore su determinati luoghidel testo. Per continuare il parallelismo, la stessa funzione che nel codice Hamiltoniano hanno le mani-culae. 5 Ghinassi 1963, pp. 224-25 e 253.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 112
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 113
A queste considerazioni se ne può aggiungere una ulteriore che riguarda le differen-ti modalità di esecuzione delle segnature. Infatti, se ad oggi quelle relative alla distribu-zione del testo all’interno delle pagine, realizzate con la tecnica ‘a secco’, non sono im-mediatamente individuabili, quelle ‘paragrafali’ invece risultano ben visibili. Sembraquindi che a quest’ultima tipologia di segnatura, tracciata in maniera così evidente, deb-ba essere riconosciuto un valore diverso rispetto a quello della semplice istruzione d’im-paginazione.
2.
Di seguito si propone l’elenco dei luoghi testuali in cui è possibile individuare i segni paragrafali; per ognuno vengono esplicitati gli argomenti (in tondo) di volta in volta introdotti. Tralascio la dedica che com’è noto compare per la prima volta solo nellastampa.
Nel primo libro si contano 55 segni. Il primo si trova quando il discorso è avviato esegnala la localizzazione spazio-temporale dei dialoghi urbinati:1 a quest’altezza perl’edizione Cian (C) ci si trova all’inizio del vi capitolo, mentre per Quondam (Q) è il pa-ragrafo 28 del secondo capitolo. Si potrebbe obiettare che già quest’ipotesi vacilla, poi-ché se i segni avessero veramente questa valenza allora dovrebbe essercene uno prima.Ovvero quando si legge «Alle pendici dell’Appennino…», nel passaggio dal proemio adAlfonso Ariosto alla descrizione di Urbino. In realtà l’assenza del segno è ben giustifi-cata dalla messa in pagina del manoscritto, dove il capoverso ha inizio fuori dall’area distampa – disposizione mantenuta sulla carta della princeps (L, c. 2v - Ad, c. a1v – Fig. 2).Di seguito viene illustrata la distribuzione dei segni.
Si riporta l’inizio del testo laddove sul manoscritto è presente il segno paragrafale.Entrambi gli indicatori (§ e §§) segnalano la presenza del simbolo di paragrafo sul ms.corrispondente a uno spazio bianco nella stampa. Il simbolo doppio (§§) evidenzia a vol-te un passaggio tematico, altre un argomento particolarmente rilevante; sono questiluoghi nevralgici nei quali si è ritenuto opportuno inserire pause forti, quali la divisio-ne in capitoli la cui numerazione compare tra parentesi quadre. La corrispondenza conla scansione Cian 1947 (C) e Quondam 2002, t. i (Q) si trova tra parentesi tonde; il sim-bolo = indica che anche nell’edizione moderna è presente la divisione, mentre il segno≠ è impiegato quando non c’è coincidenza con le edizioni moderne, delle quali si ri-porta comunque la numerazione del capitolo che la include. Il simbolo # è utilizzatoper indicare un particolare accorgimento tipografico (a capo, carattere stampato fuoridai margini consueti). Ogni micropartizione testuale è accompagnata da un breve rias-sunto tematico che prende spunto anche dalla Guida alla lettura di Quondam 2002, t. ii.In Appendice si propone una Tavola delle corrispondenze tra le diverse partizioni del-l’opera (Cian 1947, e Quondam 2002, t. i), affiancate dalla scansione così come si rilevasul Laurenziano e nell’Aldina e che qui per la prima volta si presenta.
LIBRO I (55 segni)
#§ [II] (= C ii; = Q 2.1) Alle pendici dell’Appenino quasi al mezzo della Italia: Descrizione di Urbinoe della corte dei Montefeltro.
#§ [III] (≠ C iv; = Q 2.18) Quivi adunque i soavi ragionamenti e l’honeste facetie s’udivano.
1 Havendo adunque Papa Iulio II con la presentia sua (L, c. 6v - Ad, c. a3r; Cian 1947, I vi – Quondam 2002,t. i, 2.28].
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 113
114 valeria guarna
Fig. 2. Alcuni esempi della mappatura del testo all’interno dell’editio princeps.
Libro I. L, c. 2v Ad, c. a1v
Libro IV. L, c. 212v Ad, c. m4v
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 114
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 115
§§ [IV] (= C vi; = Q 2.28) Havendo adunque Papa Iulio II con la presentia sua e con l’aiuto de’ Franzesi:Occasione e localizzazione, spazio-temporale, dei dialoghi urbinati.
§ (≠ C vi; ≠ Q 3.2) «Signora mia poi che pur a voi piace ch’io sia quella che dia principio: La signoraEmilia, deputata dalla Duchessa alla scelta del gioco, propone che ognuno dei presenti suggerisca un gioco.
§ (= C viii; ≠ Q 3.11) «Chi vol con diligentia considerar tutte le nostre attioni: Considerazioni sulla mutevolezza della natura.
§ (≠ C ix; ≠ Q 3.21) «Io» disse «vorrei esser giudice con authorità di poter con ogni sorte di: Bernardo Accolti disvela il suo amore per la Duchessa Gonzaga, sonetto della lettera S. Proposta del tema della crudeltà della donna.
§ (≠ C x; ≠ Q 3.29) «Signori s’io volessi affermare non haver mai sentito passion d’amore: Ottaviano Fregoso descrive la sua passione d’amore e propone che si discuta dello sdegno della personaamata verso chi ama.
§ (≠ C xi; ≠ Q 3.36) «Signori non piccol dubbio ha risvegliato nell’animo mio il gioco proposto: PietroBembo, d’accordo con il suggerimento del Fregoso, vorrebbe indagare se la causa dello sdegnonasca dalla persona amata o da sé stesso «per saper qual è maggior dolore, o far dispiacere achi s’ama, o riceverlo pur da chi s’ama».
§§ [V] (≠C xii; ≠Q 3.41) «Signora vorrei che mi fosse licito, come qualche volta si sole: Federigo Fregosopropone di «formar con parole un perfetto cortegiano».
§ (≠ C xiii; = Q 3.52) Allhor messer Cesare Gonzaga: «Perché già» disse «è passata bon’ora: Conclusio-ne della prima serata.
§ (≠ C xiii; ≠Q 4.2) Dico, che in ogni cosa tanto è difficile il conoscer la vera perfettion: Impossibilità diconoscere la «vera perfezione», primi accenni al tema della convenienza etica ed estetica.
§§ [VI] (= C xiv; = Q 4.6) Voglio adunque che questo nostro Cortegiano sia nato nobile e: Canossa comincia a definire le qualità naturali che si addicono al «perfetto cortigiano»: che «sia natonobile e di generosa famiglia».
§ (≠ C xiv; = Q 4.11) Et per darvi un exempio: vedete il signor don Hippolito: Esemplarità del cardi-nale Ippolito d’Este e della sua «grazia».
§§ [VII] (≠ C xiv; = Q 4.13) Il Cortegiano adunque oltre alla nobiltà, voglio che sia: Qualità naturali eacquisite che sono necessarie al «perfetto cortegiano».
§ (= C xv; = Q 4.14) Quivi non aspettando più oltre disse il signor Gaspar Pallavicino «acciò che il nostrogioco habbia la forma ordinata: Pallavicino controbatte sulla nobiltà di nascita e introduce il con-cetto della fortuna che domina tutte le cose mondane.
§ (= C xvi; = Q 4.18) Allora il Conte Ludovico: «Non nego io» rispose «che anchora negli homini: Repli-ca del Canossa «in laude della nobiltà», importanza della «opinion universale» e della «primaimpressione».
§§ [VIII] (= C xvii; = Q 4.24) Ma per venire a qualche particularità estimo che la principale: «La prin-cipale e vera profession del cortegiano debba essere quella dell’arme».
§ (≠ C xvii; = Q 4.30) Sia adunque quello che noi cerchiamo dove si veggon gli inimici: Il Cortegianodeve fuggire l’ostentazione e non deve lodare sé stesso. Il comportamento deve essere adat-tato alle circostanze.
§ (= C xviii; = Q 4.31) «Et io» rispose allhora il signor Gasp. «ho conosciuti pochi homini: Pallavicinosostiene che il «laudar sé stesso» si addice invece al Cortegiano virtuoso.
§ (≠ C xviii; =Q 4.33) Allhor il Conte «Se voi» disse «havete inteso, io ho biasimato: Canossa ribatte sull’opportunità del lodarsi, purché si faccia in maniera appropriata («discretissimo») e senzagenerare invidia negli altri.
§ (≠ C xviii; = Q 4.34) Allhora il S. Gasp. «Questo» disse «ci havete da insegnar voi»: Arte della sprez-zatura ed exempla, per contrasto, di eccessi.
§§ [IX] (= C xix; = Q 4.38) Quivi facendo un poco di pausa il Conte disse ridendo M. Bernardo Bibiena«Ricordomi che dianzi dicesti che questo nostro Cortegiano: Questione della «forma del corpo» chesi addice al Cortegiano.
§ (= C xx; = Q 4.42) Vegnendo adunque alla qualità della persona: Misura del giusto mezzo ed «eser-cizio di agilità» richiesti al Cortegiano.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 115
116 valeria guarna
§ (≠ C xx; = Q 4.44) Et perciò voglio che egli sia di bona dispositione e de membri ben formato: Attribu-ti e requisiti propri del Cortegiano.
§ (= C xxi; = Q 4.47) Estimo anchora che sia di momento assai il saper lottare: Esercizio delle armi.§§ [X] (≠ C xxi; ≠ Q 4.51) «Adopransi anchor l’arme spesso in tempo di pace: Il Cortegiano deve es-
sere perfetto cavaliere e ogni sua azione regolata secondo «bon giudicio e grazia».§ (= C xxii; = Q 4.55) Sono anchor molti altri exercitii, i quali ben che non dependano: Rassegna degli
esercizi fisici adatti al Cortegiano.§ (≠C xxii; = Q 4.57) Anchor nobile exercitio, e convenientissimo ad huom di corte: Importanza del sa-
per gestire il proprio corpo nella sua fisicità.§ (≠ C xxii; = Q 4.58) Né di minor laude estimo il volteggiar a cavallo: La «bona grazia» accompa-
gnata dalla «leggerezza».§ (≠ C xxii; = Q 4.60) Ma perché sempre non si po versar tra queste così faticose operationi: Varietà del-
le operazioni del Cortegiano sempre regolate secondo «bon giudicio», ingegno, discrezione egrazia.
§§ [XI] (= C xxiv; ≠Q 4.67) «Se ben tengo a memoria, parmi S. Conte che voi questa sera: Inizia la trat-tazione della «regula universalissima» della grazia, che si raggiunge «con studio e fatica».
§ (≠ C xxv; ≠ Q 4.75) Dico che chi ha da esser aggratiato negli exercitii corporali: I princìpi della gra-zia si possono apprendere da «ottimi maestri» essendo «bon discipulo», oltre alla «natural di-sposizione».
§§ [XII] (≠C xxvi; = Q 4.82) Ma havendo io già più volte pensato meco, onde nasca questa gratia: Enun-ciazione della «regola universalissima» della grazia: fuggire l’affettazione e «usar in ogni cosauna certa sprezzatura» (ars artem celare).
§ (≠C xxvi; = Q 4.87) Vedete adunque come il mostrar l’arte, e un così intento studio, levi la gratia d’ognicosa: Exempla, per contrasto, della mancanza di grazia.
§ (= C xxvii; = Q 4.89) Quivi non aspettando M. Bernardo Bib. disse «Eccovi che M. Rob. nostro: «Que-sta eccellenzia consiste nella sprezzatura e mostrar di non estimare e pensar più ad ogni altracosa che a quello che si fa».
§§ [XIII] (≠ C xxvii; = Q 4.90) Rispose allhor il Conte «Poi che voi volete pur ch’io dica: «Sprezzatura»e «mediocrità» (giusto mezzo). Fuggire l’affettazione ed esercitare un’«amabile semplicità».
§ (= C xxviii; = Q 4.94) Allhora il S. Magnifico «Questo anchor» disse «si verifica: Exempla di graziae di affettazione. Viene ribadito che la virtù della sprezzatura è «il vero fonte donde deriva lagrazia», una virtù per la quale si «imprime opinione» «negli animi delli circunstanti» che quel-lo che si compie venga considerato «molto maggior di quello che è in effetto».
§§ [XIV] (= C xxix; = Q 5.3) Allhor M. Fed. «Veramente» disse «ragionando tra noi, come hor: Qua-le sia la miglior lingua che si addice al Cortegiano. Fregoso distingue tra lingua parlata e lin-gua scritta; propone che le «parole antiche toscane» vengano adoperate nella scrittura (poiché«danno molta grazia ed autorità alle scritture»). Canossa invece è contrario all’uso di queste.
§ (≠C xxix; = Q 5.7) Parmi adunque molto strana cosa usare nello scrivere: Continua Canossa propo-nendo la teoria cortigiana della lingua, ovvero che si devono fuggire le parole antiche toscane,nello scrivere e nel parlare, e che bisogna invece scegliere quelle parole «che oggidì sono in consuetudine in Toscana e negli altri lochi della Italia». Non è d’accordo con la distinzione pro-posta dal Fregoso: «quello che si conviene nello scrivere si convien ancor nel parlare».
§ (= C xxx; = Q 5.14) Allhora M. Fed. «Signor Conte» disse «io non posso negarvi: Fregoso introducel’«acutezza recondita» necessaria al lettore, e ribadisce il maggior valore delle antiche paroletoscane. Inoltre è «necessario proporsi ad imitar uno, il quale di consentimento di tutti sia esti-mato bono, ed averlo sempre per guida e scudo contra chi volesse riprenderlo».
§§ [XV] (= C xxxi; = Q 5.24) Allhora il S. Gasp. Pallav. «Questa disputation» disse «dello scrivere: Sa-per scrivere e saper parlare bene.
§ (≠ C xxxi; = Q 5.26) Allhor il Conte «S. Magnifico» disse «questa impresa non accettarò: Continua ladiscussione sulla lingua, diverse posizioni dei personaggi.
§§ [XVI] (≠C xxxii; = Q 5.32) Rispose il Conte «Io già Signora ho detto quello che ne so: Canossa espo-ne le regole del parlare e dello scrivere bene, come richiesto dalla Duchessa.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 116
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 117
§§ [XVII] (= C xxxv; = Q 5.60) Se adunque degli homini litterati, e di bon ingegno: Continua la trattazione del Canossa, introdotto il concetto di «bona consuetudine» che serve a scegliere lalingua più adatta ovvero «le parole che lor paion bone, le quali si conoscono per un certo giu-dicio naturale e non per arte o regula alcuna».
§ (= C xxxix; = Q 5.105) Allhora la Signora Emilia «A me par» disse «che questa vostra disputa: Con-clusione della disputa.
§§ [XVIII] (= C xl; = Q 6.1) «Signora» rispose il Conte «Il filo mi par tronco: Ripresa della discussio-ne intorno alla formazione del Cortegiano. Ribaditi i concetti di «pestifera affettazione» e di semplicità e sprezzatura come «grazia estrema».
§ (≠ C xl; = Q 6.2) Gran desiderio universalmente tengon tutte le donne di essere: Exempla di grazia edi sprezzatura riferiti alle donne.
§ (= C xli; = Q 6.12) In tal modo si fugge, e nasconde l’affettatione: È sufficiente che il Cortegianosia «omo da bene ed intiero» («prudenzia, bontà, fortezza e temperanzia d’animo»).
§§ [XIX] (= C xlii; = Q 7.1) Ma oltre alla bontà, il vero e principal ornamento dell’animo: La forma-zione del Cortegiano alle humanae litterae, unita «alla virtù dell’arme».
§ (≠ C xliii; = Q 7.12) Sapete che delle cose grandi e arischiate nella guerra il vero stimulo è la gloria:Etica ed estetica della guerra che consente al gentiluomo di raggiungere la gloria. «Ma chi nonsente la dolcezza delle lettere, saper anchor non pò quanta sia la grandezza della gloria».
# (= C xliv; = Q 7.20) Il qual voglio che nelle lettere sia più che mediocremente erudito: Studia huma-nitatis «massimamente in questa nostra lingua vulgare».
§§ [XX] (= C xlv; = Q 7.32) Rispose quivi M. Pietro Bembo «Io non so Conte come voi vogliate: Discus-sione sull’opportunità dell’educazione alle armi e alle lettere.
§§ [XXI] (≠ C xlvii; ≠ Q 8.1) «Signori» disse «havete a sapere ch’io non mi contento del Cortegiano: Educazione del Cortegiano alla musica.
§ (= C xlviii; = Q 8.15) Hor quivi tacendo un poco il Conte, disse il Magnifico Iuliano «Io non son: «Lamusica non solamente ornamento, ma necessaria al Cortegiano».
§§ [XXII] (= C xlix; = Q 8.17) Allhora il Conte «Prima che a questo proposito entriamo: Educazionedel Cortegiano all’arte: «il saper disegnare ed aver cognizione dell’arte propria del dipingere».
§ (= C l; = Q 8.24) Allhora la S. Emil. rivolta a Io. Christophoro Romano che ivi con gli altri sedeva «Chevi par» disse «di questa sententia?: Disputa sul primato della pittura sulla scultura.
§§ [XXIII] (= C liv; Q 9.1) Quivi mostrando M. Ces. non restar satisfatto, né voler consentir: Conclu-sione.
§ (≠ C liv; ≠ Q 9.5) «Signori, troppo nociva sarebbe stata la venuta mia.
LIBRO II (79 segni)
§ (≠ C i; = Q 1.5) La causa adunque di questa falsa opinione: Errata valutazione dei vecchi che lo-dano i tempi passati e biasimano i presenti.
§§ [II] (= C v; = Q 2.1) Venuto adunque il seguente giorno: Continua l’argomentazione del prece-dente libro sulla formazione del Cortegiano: le regole universali.
§§ [III] (= C vi; = Q 2.4) Allhora M. Federico, rivolto all’Unico «A voi dunque non par» disse: Discus-sione tra Fregoso e Accolti sulla necessità delle regole.
§ (= C vii; = Q 2.12) Havendo adunque il Conte hiersera: Il Cortegiano deve saper conversare e de-ve saper usare prudenza in «ciò che dice o fa».
§§ [IV] (≠ C vii; = Q 2.19) Voglio adunque ch’el nostro Cortegiano: «Regole universali»: fuggire l’af-fettazione, attenzione alle circostanze (convenienza), uso della discrezione.
§§ [V] (= C viii; = Q 3.1) Poi che così hebbe detto M. Fed. parve: Introduzione del tema delle «circo-stanzie».
§ (≠ C viii; ≠ Q 3.2) «Se ben vi ricorda, volse hiersera il Conte: Attenzione alle circostanze; esempiodel comportamento da tenere nei fatti d’arme.
§ (≠ C ix; = Q 3.11) Dico adunque che degli exercitii del corpo sono alcuni: Il Cortegiano «dee consi-derar molto in presenzia di chi si mostra e quali siano i compagni».
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 117
118 valeria guarna
§ (= C x; = Q 3.13) Disse allhor il S. Gasp. Pallavicino «nel paese nostro: Viene ribadito il concetto disprezzatura e la necessità di rispettare le circostanze.
§ (= C xii; = Q 3.29) Dico adunque ch’el Cortegiano dee in questi spettaculi: Il Cortegiano deve pre-stare attenzione alle circostanze «secondo il grado suo».
§§ [VI] (≠ C xii; = Q 3.31) Venga adunque il Cortegiano a far musica: La sprezzatura: «venga adun-que il Cortegiano a far musica», dissimulando «il studio e la fatica che è necessaria in tutte lecose che si hanno a far bene».
§ (= C xiii; = Q 3.32) Allhor il S. Gasp. Pallavicino «Molte sorti di musica» disse: Excursus sulla musica.§ (≠ C xiii; = Q 3.37) Il tempo poi, nel quale usar si possono queste sorti di musica: «Il condimento del
tutto bisogna che sia la discrezione».§§ [VII] (= C xiv; = Q 3.41) Rispose allhora il Magnifico «Non private M. Fed. i poveri vecchi: Con-
fronto tra giovani e vecchi. Rispetto di ciò che è opportuno a una determinata età della vita.§§ [VIII] (≠ C xvii; = Q 4.4) Rise quivi la S. Emil., e disse «Voi fuggite troppo la fatica: Introduzione
del nuovo tema: la conversazione.§ (= C xviii; = Q 4.7) Io estimo che la conversatione, alla quale dee principalmente: La conversazione
che si addice al Cortegiano è quella che deve avere col principe che serve. Rapporti tra Cortegiano e principe: il Cortegiano dovrà usare «bon giudicio per conoscere ciò che piace alprincipe, e lo ingegno e la prudenzia per sapersegli accomodare». Necessità di considerare lecircostanze e a queste adattarsi in modo opportuno («dee ben l’omo star sempre un poco piùrimesso che non comporta il grado suo»). Usare la discrezione: «bisogna che ognun conoscase stesso e le forze sue ed a quello si accomodi». Il Cortegiano deve esser modesto, oltre chevaloroso, ed ogni sua azione deve sempre tendere al bene. E il premio per le sue virtù, natu-rali e acquisite, sarà l’onore.
§§ [IX] (= C xxiii; = Q 4.56) «Vorrei» disse allhor il S. Ludovico Pio che voi mi chiariste un dubbio: Mo-rale e politica, Fregoso sostiene che il Cortegiano debba aver comunque rispetto della naturadel signore che serve e «secondo quella si governi». Capacità di discernimento delle «cose ve-ramente bone dalle apparenti».
§§ [X] (= C xxv; = Q 4.72) Ma lasciamo da canto homai questa pratica de Signori: «Conversazionecoi pari o poco diseguali».
§§ [XI] (= C xxvi; = Q 5.1) Allhora il Magn. Iul. «Vorrei» disse «M. Fed. poi che havete fatto mentione:Inizio della trattazione «circa tutto l’ornamento del corpo in che modo debba governarsi». Bi-sogna accomodarsi alla «consuetudine dei più», «pur che satisfacciano a chi gli porta». Vestireadatto al Cortegiano senza eccessi, anche perché «di quella sorte che desidera esser estimato,[deve] della medesima vestirsi, e far che gli abiti lo aiutino ad esser tenuto per tale».
§§ [XII] (= C xxviii; = Q 5.21) «A me non pare» disse allhor il Signor Gasp. Pallavicino «che si conven-ga: Fregoso afferma che l’abbigliamento, le opere e le parole fanno giudicare il Cortegiano.
§§ [XIII] (≠ C xxix; = 6.4) Rispose allhor M. Pietro Bembo «Del restringersi in amicitia così unanime:«La elezion degli amici»: amicizia possibile solo tra «boni e virtuosi».
§ (≠ C xxx; = Q 6.15) Vorrei adunque ch’el nostro Cortegiano havesse un precipuo: Il Cortegiano deveavere accanto un «precipuo e cordial amico»; con gli altri «estimati e nobili e conosciuti perboni» intrattenere rapporti di onore e di riverenza.
§ (= C xxxi; = Q 6.18) Quivi essendosi fermato di parlare M. Fed. «Vorrei» disse il S. Gasp. Pallavicino«che voi ragionaste un poco più minutamente: Il conversare con gli amici deve sempre rispettarela «qualità delle persone» esaminata secondo «bon giudicio».
§§ [XIV] (= C xxxii; = Q 6.31) Ma perché par che la fortuna, come in molte altre cose, così anchor: Lafortuna regola i rapporti umani e la prima impressione è quella che conta. A riguardo il Cor-tegiano oltre ad essere virtuoso deve sapersi adattare alle circostanze con intelligente artificio(«con ingegno ed arte»).
§ (= C xxxiii; = Q 6.39) «Io non so come questo giovi» rispose M. Bernardo Bibiena: Bibbiena non cre-de che la fama possa bastare per aver l’opinione su qualcuno: «perché gli animi nostri spessoformano cose alle quali impossibil è poi corrispondere, e così più se ne perde che non si gua-dagna».
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 118
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 119
§ (≠ C xxxiii; = Q 6.42) «Quivi» disse M. Fed. «le cose che a voi e a molt’altri riescono minori: Fregosoribadisce e argomenta nuovamente la sua tesi, ovvero che le prime impressioni hanno gran-dissima forza e bisogna porvi molta attenzione. Exemplum dell’innamoramento per fama.
§§ [XV] (= C xxxv; = Q 6.53) «Hor quivi» ridendo rispose il S. Gasp. Pall. «Voi per confirmare il parer:Invettiva di Pallavicino contro le donne.
§§ [XVI] (= C xxxvi; = Q 6.60) Deve adunque il Cortegiano por molta cura ne i principii di dar bona:Importanza per il Cortegiano di dar «bona impressione di sé». Nuova rassegna di Fregoso del-le regole che il Cortegiano deve rispettare.
§§ [XVII] (= C xxxviii; = Q 6.75) Hor io non voglio seguitar più minutamente in dir cose troppo note:La sprezzatura.
§ (≠ C xxxviii; = Q 6.81) Voglio adunque ch’el nostro Cortegiano, se in qualche cosa: Il «bon giudicio».§§ [XVIII] (= C xl; = Q 6.94) Rispose allhor il S. Gasp. Pallav. «Questa a me non par arte, ma vero
inganno: Pallavicino è in disaccordo con quest’arte del simulare prescritta al Cortegiano.§ (≠ C xl; = Q 6.99) Non è anchor disconveniente che un homo, che si senta valere in una cosa: Frego-
so controbatte che questa «certa avvertita dissimulazione» deve esser attuata col bon giudicioe con l’arte.
§§ [XIX] (= C xli; = Q 6.103) È adunque securissima cosa nel modo del vivere e nel conversare: L’one-sta mediocrità regola il modo di vivere e il conversare.
§§ [XX] (≠ C xlii; = Q 7.1) Allhor disse ridendo il S. Prefetto «Io non voglio che questa falsa opinion: Introduzione del tema delle facezie e illustrazione dell’«arte che s’appartiene a tutta questasorte di parlar piacevole per indurre riso e festa con gentil modo».
§ (≠ C xlii; = Q 7.3) «Signor mio» rispose allhor M. Fed. «Le facetie e i motti sono più presto dono: Fre-goso afferma che le facezie e i motti sono piuttosto un dono di natura che qualcosa che si creacon artificio.
§ (= C xliii; = Q 7.5) Allhor il S. Prefetto rispose «Voi negate che nelle facetie sia arte alcuna: Il Prefet-to sostiene che esistono delle regole nell’arte delle facezie.
§§ [XXI] (≠C xliii; = Q 7.6) «Queste regule S. mio» rispose M. Fed. «son tanto universali che ad ogni co-sa: Fregoso individua due sorti di facezie: «l’una s’estende nel ragionar lungo e continuato».
§ (≠ C xliii; = Q 7.7) L’altra sorte di facetie è brevissima, e consiste solamente nei detti pronti: L’altraconsiste nei «motti pronti ed acuti».
§ (≠ C xliii; = Q 7.8) Dico adunque che nel primo modo, che è quella festiva narratione: Per il primo ti-po non è richiesta arte alcuna «perché la natura medesima crea e forma gli omini atti a narra-re piacevolmente»; il secondo invece è «opera dell’ingegno e della natura».
§ (≠ C xliii; = Q 7.10) Riprese allhor le parole M. Pietro Bembo e disse «il S. Prefetto non vi nega: Bem-bo ragiona sulla necessità dell’ingegno congiunto a natura, «ma il giudicio poi e l’arte li limae corregge».
§§ [XXII] (= C xliv; = Q 7.12) Allhor M. Fed. pur ridendo disse «Non è alcun qui di noi al qual io nonceda: Fregoso inizia a esporre in che cosa consiste l’arte delle facezie.
§ (≠ C xliv; = Q 7.15) Cominciava M. Fed. a rispondere, ma la S. Emil. subito l’interruppe e disse «Nonè l’ordine che la disputa: «Il carico del parlar delle facezie» viene affidato al Bibbiena.
§ (≠ C xliv; = Q 7.17) Allhor M. Fed. disse «Signora non so ciò che più mi avanzi, ma io a guisa.§§ [XXIII] (≠ C xlv; = Q 7.22) Allhora rivoltandosi M. Bernardo alla S. Duch. e alla S. Emil. «Io non vo-
glio fuggir» disse «questa fatica»: Inizia la vera trattazione che sarà argomentata dal Bibbiena:l’uomo «è un animal risibile»; il riso diverte l’animo e dà piacere.
§ (= C xlvi; = Q 7.30) Il loco adunque e quasi il fonte, onde nascono i ridiculi: Definizione del risibi-le: la deformità è fonte di riso e «quasi sempre quel di che si ride è una cosa che non si con-viene, e pur non sta male».
§ (≠ C xlvi; = Q 7.31) Quali adunque siano quei modi, che debba usar il Cortegiano: La convenienzaregola anche il riso, scelta del bersaglio da beffare.
§ (= C xlvii; = Q 7.36) Havete anchor a sapere che da i lochi donde si cavano motti da ridere: Alcuniesempi.
§§ [XXIV] (= C xlviii; = Q 7.44) Tornando adunque a dechiarire le sorti delle facetie appartenenti: Ven-gono nuovamente chiarite le tipologie della facezie aggiungendone una terza, ovvero le «bur-
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 119
120 valeria guarna
le nelle quali intervengon le narrazioni lunghe e i detti brevi». Trattazione delle facezie «checonsistono nel parlar continuato».
§ (= C li; = Q 8.17) Induce anchor molto a ridere (che pur si contiene sotto la narratione): «Il recitarcon bona grazia alcuni diffetti d’altri» e altri esempi.
§ (= C liii; = Q 8.34) Risesi molto del sottil avedimento di questo cittadino.§ (= C liv; = Q 8.39) Suggiunse allhor M. Bernardo, «Le affettationi poi mediocri: «Le affettazioni fuor
di misura inducono da ridere assai».§ (≠ C liv; = Q 8.41) Quelle belle bugie mo, così ben affettate, come movano: «Belle bugie movano a
ridere».§§ [XXV] (= C lvi; = Q 8.48) Risero allhora tutti e M. Bernardo «In vero» disse «quella ch’io voglio:
Racconto del Bibbiena.§ (≠ C lvi; = Q 8.54) Allhora Messer Cesare Gonz. «Questa è forza» disse «che trall’altre Simie: Com-
mento scherzoso di Cesare Gonzaga.§§ [XXVI] (≠ C lvii; ≠ Q 9.1) «Havete adunque inteso delle facetie, che sono nell’effetto, e parlar conti-
nuato: Facezie che «consistono in un detto solo ed hanno quella pronta acutezza posta breve-mente nella sentenzia o nella parola».
§ (= C lviii; = Q 9.3) Delle facetie adunque pronte, che stanno in un breve detto: Breve detto acutissi-mo è quello che nasce dall’ambiguità, lodato piuttosto per l’ingegno che per il riso che suscita.Bisogna saper scegliere le parole adatte per evitare che il detto breve si risolva in un «mottofreddo».
§ (= C lx; = Q 9.14) Ma tra gli altri motti quegli hanno bonissima gratia, che nascono: Motto morda-ce che consiste nel pungere qualcuno con le stesse parole con le quali si è prima stati offesi.
§ (= C lxi; = Q 9.17) Un’altra sorte è anchor, che chiamiamo Bischizzi: Storpiature di parole.§ (= C lxii; = Q 9.28) È medesimamente bello interpretare i nomi, e finger qualche cosa: Facezia sul-
l’interpretazione dei nomi.§ (= C lxiii; = Q 9.36) Dicesi anchora qualche volta una parola medesima, ma ad altro fin: Ambiguità
del significato di una parola.§ (≠ C lxiii; = Q 9.43) Di questa sorte de motti adunque assai si ride, perché portan seco risposte con-
trarie a quello che l’homo aspetta d’udire.§ (≠ C lxiv; = Q 9.46) Et perché (come già havemo detto) da i lochi donde si cavano facetie: «Dai lochi
donde si cavano facezie che mordono, dai medesimi spesso si possono cavar detti gravi chelaudino». Facezia da fraintendimento. E altri esempi.
§ (= C lxx; = Q 9.77) Allhora M. Bernardo «Veramente Signora» disse «homai parmi haver detto: La«bella narrazione» deve accompagnare i motti arguti. Altre sorti di facezia (microvarianti) e re-lativi esempi.
§ (= C lxxiv; = Q 9.94) Simile a questa maniera che tende all’ironico è anchora un altro modo: «Quan-do con oneste parole si nomina una cosa viciosa». Ulteriori microvarianti di facezie seguite daesempi narrativi.
§ (≠ C lxxxii; = Q 9.154) Di questa sorte rispose anchor il Papa al Vescovo di Cervia.§§ [XXVII] (= C lxxxiii; = Q 9.155) Potrei forse anchor, Signori, raccorre molti altri lochi, donde si
cavano motti ridiculi: Regole generali della retorica della facezia: «lo ingannar la opinione e rispondere altramente che quello che aspetta l’auditore». Diversi effetti indotti dalla facezia.Importante «considerar la disposizion degli animi degli auditori» (convenienza).
§ (≠ C lxxxiii; = Q 9.160) Havendo adunque il Cortegiano nel motteggiare, e dir piacevolezze: La convenienza regola il modus vivendi del Cortegiano.
§ (≠ C lxxxiii; = Q 9.163) Ma oltre a questi rispetti bisogna che colui che ha da esser piacevole: Richia-mo dell’attenzione sulle modalità esecutive di chi mette in pratica la facezia.
§§ [XXVIII] (≠ C lxxxiv; = Q 10.1) «Anzi» rispose M. Fed. «a così bon albergo sono io venuto»: La bur-la: «inganno amichevole di cose che non offendano, o almen poco». Il riso è indotto perché leaspettative vengono deluse. Due tipologie.
§§ [XXIX] (≠ C lxxxv; = Q 10.8) Il primo modo è tale quale fu la burla che a questi di due gran Signo-re: Prima tipologia di burla: «quando s’inganna ingeniosamente con bel modo e piacevolezza».
§ (≠ C lxxxv; ≠ Q 10.10) «Pochi dì sono che nella Corte di chi io intendo: Esempio.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 120
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 121
§ (= C lxxxvi; = Q 10.14) Di questa sorte burle ogni dì veggiamo, ma trall’altre quelle son piacevoli: Ribadito che il riso muove dalla delusione delle aspettative.
§§ [XXX] (= C lxxxvii; = Q 10.25) Dell’altra sorte di burle, quando l’homo inganna se stesso: Secon-da tipologia di burla: «quando l’uomo inganna se stesso».
§ (≠C lxxxviii; ≠Q 10.33) «È anchor un modo di burlare assai piacevole, onde medesimamente: «Quan-do si mostra credere che l’omo voglia fare una cosa che in vero non vol fare».
§ (= C lxxxix; = Q 10.37) Hor (come havemo detto) delle burle si poria parlar largamente: Per le burlele novelle del Decameron sono esemplari.
§§ [XXXI] (= C xc; = Q 11.1) Allhora il S. Gasp. «Per certo» disse «M. Bernardo, voi sete pur troppo: Introduzione del tema delle donne.
§ (= C xci; = Q 11.5) Quivi facendo un poco di pausa M. Bernardo, disse il S. Ottavian Fregoso ridendo«Il S. Gasp. potrebbe rispondervi che questa legge: Ottaviano Fregoso definisce le donne «animaliimperfettissimi» e dà inizio alla sua invettiva antifemminile.
§ (= C xciii; = Q 11.11) Allhora M. Bern. Ridendo «Signori» disse «essendo stato la parte mia: Difesadelle donne da parte del Bibbiena.
§ (= C xcv; = Q 11.23) Allhor il Signor Gaspar «Io non nego» rispose «che la intentione, le fatiche: Mi-soginia di Pallavicino.
LIBRO III (51 segni)
#§1 [II] (= C ii; = Q 2.1) Essendosi adunque ridutta il seguente giorno: Inizio della nuova giornata eintroduzione del nuovo tema: la donna di palazzo. Gonzaga ribadisce la necessaria presenzadella donna a corte e a fianco del Cortegiano: le donne con la loro grazia «fanno perfetta edadornano la cortegiania».
§§ [III] (= C iv; = Q 2.16) Allhor il Signor Magnifico voltatosi: La Duchessa ordina al Magnifico difare il ritratto della donna di palazzo «acciò che questa così nobil signora abbia chi possa de-gnamente servirla». Accenno alle virtù dell’animo che le si addicono («l’esser di boni costumi,ingeniosa, prudente» ecc.).
§ (= C v; = Q 2.27) Lasciando adunque quelle virtù dell’animo: Esposizione delle regole che gover- nano il giusto e buono modus vivendi della donna: «una certa affabilità piacevole», saper conver-sare prestando attenzione alle circostanze quindi alle convenienze, «pronta vivacità d’ingegno»,«tener una certa mediocrità difficile», «bon giudicio», fuggire «l’affettazione in ogni cosa».
§ (= C vii; = Q 2.43) Havendo insin qui detto il Magnifico: Pallavicino mostra la sua misoginia, ilMagnifico continua il ritratto della donna di palazzo introducendo anche per la donna quali-tà come la discrezione, la grazia, la «discreta modestia», il «dar bona opinion di sé».
§§ [IV] (= C xi; = Q 3.4) Disse allhora il Signor Gaspar «Io non voglio rinovar: Disputa sulla donna.Invettiva di Pallavicino contro le donne: «quando nasce una donna è diffetto o error della natura e contra quello che essa vorrebbe fare».
§ (= C xii; = Q 3.13) Aspettava il Magnifico Iuliano ch’el Signor Gasp.: Difesa delle donne del Magnifico Iuliano.
§ (= C xv; = Q 3.33) Allhora il S. Gasp. «Io non vorrei – disse – che noi: Pallavicino continua a soste-nere e ad argomentare la sua tesi antifemminile.
§ (= C xvi; = Q 3.38) Rispose subito il Magn. Iul. «Le meschine non desiderano: Il Magnifico Iulianopersiste nella sua difesa.
§§ [V] (= C xvii; = Q 3.43) Allhora la Sign. Emil. rivolta al S. Magnifico «Per amor di Dio: La signoraEmilia invita alla chiarezza espositiva delle proprie opinioni.
§ (≠ C xvii; = Q 3.47) «Non so Signor Magn.» disse allhora il S. Gasp «come in questo: Pallavicino con-tro le donne.
§ (= C xviii; = Q 3.49) «Anchor volete» rispose il Magnifico Iuliano: Il Magnifico Iuliano in difesa delledonne.
1 Sia nel ms. (c. 149r) sia nella stampa (c. h8v) si va a capo.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 121
122 valeria guarna
§§ [VI] (= C xix; = Q 4.1) Allhor il Phrigio «Quegli effetti» disse «cominciarono quando: Esempi di donne virtuose nel passato.
§§ [VII] (≠C xx; = Q 4.11) Allhora la S. Emil. «Tanto piacer» disse «havete di dir male: La Signora Emi-lia richiama all’ordine il Magnifico Iuliano per aver introdotto l’argomento della disonestà deifrati.
§§ [VIII] (≠ C xxi; = Q 4.15) Disse allhora il S. Gasp. «Quelle ragioni, che hanno la experientia: Conti-nuano i racconti di donne virtuose nel passato.
§§ [IX] (= C xxiv; = Q 4.27) Allhor il Magn. Iul. «Piacemi» rispose «Hor io voglio dirvi d’una: Il Ma-gnifico Iuliano richiama l’attenzione sul valore delle donne.
§ (≠ C xxiv; ≠ Q 4.28) «In Massilia fu già una consuetudine, la quale s’estima: Inizio del racconto: lastoria di Camma (donna virtuosa nel passato).
§ (= C xxvii; ≠ Q 4.48) Disse il Magn. «Si trovan sì, e che sia vero udite: Il Magnifico racconta unesempio di donna virtuosa nel presente.
§ (≠ C xxix; ≠Q 4.61) Dopo la expugnation di Troia, molti Troiani, che a tanta ruina: Nuovo raccon-to del Magnifico di una donna virtuosa nel passato.
§ (= C xxx; = Q 4.65) Ne meno giovarono allo augumento di quella le donne Sabine.§§ [X] (= C xxxi; Q 4.71) Quivi essendosi un poco il Magnifico Iul. fermato e vedendo ch’el: Riprende
la discussione tra il Magnifico Iuliano e Pallavicino.§§ [XI] (≠ C xxxii; ≠Q 4.78) Essendo Philippo di Demetrio intorno alla Città di Chio: Nuovi racconti
del Magnifico Iuliano di esempi di donne virtuose nell’antichità.§ (≠ C xxxii; = Q 4.80) Queste medesime donne essendo coi lor mariti, padri, e fratelli.§ (≠ C xxxii; = Q 4.82) Havendo anchor Ciro in un fatto d’arme rotto un exercito.§ (= C xxxiii; = Q 4.84) Havendo insin qui detto il Magn. Iul. fermossi e rivolto: Ancora il dibattito
tra il Magnifico e Pallavicino. Altri racconti del Magnifico di donne esemplari nel presente.§§ [XII] (= C xl; = Q 5.20) Allhora M. Cesare, il quale per bono spacio tacciuto havea «Pensate» disse
«di che modo parla il S. Gasp. a biasimo delle donne: Cesare Gonzaga difende le donne. Esempidella ‘continenzia’ delle donne antiche e confronti con atti vili maschili.
§ (= C xlvii; = Q 5.79) Allhora il S. Gasp. «Queste» disse «M. Cesare credo che non siano: Gonzaga racconta esempi di donne virtuose nel presente.
§ (≠ C xlvii; = Q 5.88) Hor di qui potete comprender quante altre donne facciano atti dignissimi di memoria che non si sanno.
§ (= C xlviii; = Q 5.90) Quivi fece M. Ces. un poco di pausa, poi suggiunse «A mei dì anchora: Altroracconto del Gonzaga di esempio virtuoso femminile del presente. Continua la difesa.
§§ [XIII] (= C li; = Q 5.112) Allhora il S. Gasp. essendosi fermato M. Ces. di parlare: Scambio di bat-tute tra Ottaviano Fregoso e Pallavicino sulle ‘laudi’ fatte alle donne.
§ (≠ C li; = Q 5.114) Allhora M. Ces. «Le laudi» disse «che il S. Magn.: Gonzaga continua a perorarela sua causa e introduce il nuovo tema dei ragionamenti d’amore suscitati dall’amore per unadonna, sentimento che nobilita il Cortegiano.
§§ [XIV] (≠ C lii; = Q 6.1) Rispose il S. Gasp. «Io credo che altro non vi si possa: Ancora uno scambiodi battute tra Pallavicino, il Magnifico e la Duchessa che introduce il nuovo argomento: i ra-gionamenti d’amore.
§ (= C liii; = Q 6.3) Quivi tacendo ogn’uno, disse M. Fed. «S. Magn. Per stimularvi a dir: «Quello cheappartiene ai ragionamenti d’amore»: come la donna deve «rispondere a chi l’ama veramen-te e come a chi ne fa dimostrazion falsa; e se dee dissimular d’intendere, o corrispondere, e ri-fiutare e come governarsi».
§ (= C lv; = Q 6.14) Allhora M. Fed. «S. Magn.» disse «voi ragionate di questa cosa: Il Magnifico pre-cisa che non sta parlando «di chi ama, ma di chi intertiene con ragionamenti amorosi, nellaqual cosa una delle più necessarie condicioni è che mai non manchino parole». Condizionenon reale e che non appartiene a chi ama, perché «chi ama assai parla poco».
§§ [XV] (= C lvi; = Q 6.19) Disse il S. Gasp. ridendo «Non volete voi Signor Magn.: L’amore di cuiparla il Magnifico è un rapporto di cortesia.
§ (≠ C lvi; = Q 6.22) Rispose allhora M. Fed. ridendo, «Questa vostra opinion Signor Magn.: FedericoFregoso legittima divorzio e separazione: «quelle che hanno i mariti convenienti e da essi so-
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 122
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 123
no amate, non debbano fargli ingiuria; ma l’altre, non amando chi ama loro fanno ingiuria ase stesse». Il Magnifico è contrario.
§ (= C lvii; = Q 6.28) Allhora M. Roberto da Barri pur ridendo «Io» disse «Sign. Magnifico: Richiamodel Magnifico alla «modestia temperata» e all’onestà, qualità che si addicono alla donna di pa-lazzo.
§§ [XVI] (= C lviii; = Q 6.35) Havendo insin qui detto il Signor Magnifico: Roberto da Bari riportaalla realtà le condizioni di perfezione richieste alla donna di palazzo.
§§ [XVII] (= C lix; = Q 6.39) Allhor il S. Magn. «Non voglio» disse «che la mia Donna di Palazzo: Sim-metria «conveniente» tra la donna di palazzo e il Cortegiano.
§§ [XVIII] (≠ C lx; = Q 6.50) Allhora l’Unico Aretino «Ben è conveniente» disse «insegnar alle donne:L’Accolti introduce il tema del saper farsi amare.
§§ [XIX] (= C lxi; = Q 6.53) Allhora la S. Emil. «Hor di questo adunque ragionate: Inizia il ragiona-mento tra l’Accolti (ingratitudine delle donne) e la signora Emilia.
§ (= C lxii; = Q 6.58) Rispose allhor la Sign. Emil. «Signor Unico guardimi Dio: La signora Emilia di-chiara che «chi ha da esser amato debba amare ed essere amabile e che queste due cose basti-no per acquistar grazia delle donne».
§ (= C lxiii; = Q 6.63) Allhor il Signor Unico, «Io» disse «non voglio altrimenti: Continua il ragiona-mento tra l’Accolti e la signora Emilia.
§§ [XX] (= C lxiv; = Q 6.69) Allhora M. Bernardo interrompendo «Certo è» disse «che chi ama vera-mente: Scambio di battute sull’argomento tra Bibbiena, Gonzaga, Emilia e Pallavicino: comel’amante debba palesare il suo amore.
§ (≠ C lxiv; = Q 6.73) Rispose il Magnifico Iuliano «Voi v’ingannate molto: né io consigliarei: Il Ma-gnifico Iuliano dà istruzioni su come l’uomo debba manifestare il suo amore alla donna: «ilCortegiano per far noto l’amor suo alla donna paremi che sia il mostrargliele coi modi più pre-sto che con le parole».
§ (= C lxvii; = Q 6.86) Rispose il Conte Ludovico «Talhor anchora l’esser publico non noce: Il conteLudovico sostiene che «l’esser pubblico» giovi all’amore, ribadendo anche l’importanza del«giudicio universale» (la pubblica opinione).
§ (≠ C lxvii; = Q 6.90) Rispose il Magn. «Gli amori, de quali la fama è ministra: Il Magnifico è di opi-nion contraria e consiglia al Cortegiano di «tener secreti gli amori suoi».
§§ [XXI] (≠ C lxviii; = Q 6.94) Allhora M. Fed. «Il parlar» disse «così minutamente: «Come debba loamante mantenersi la grazia della donna sua». Il Magnifico suggerisce di «compiacer la don-na amata senza offenderla mai».
§§ [XXII] (= C lxx; = Q 6.100) Allhora M. Cesare ridendo, «Io» disse «confesso non esser tanto savio: IlMagnifico ribadisce l’etica del Cortegiano.
§§ [XXIII] (≠ C lxxi; = Q 6.113) Voltossi allhor il S. Gasp. a M. Ces. e disse «Era meglio restar di nar-rar: Sulla segretezza da tenere negli amori.
§ (= C lxxiii; = Q 6.119) Allhor il Magn. «Secondo me» disse «per tener l’amor secreto: Il Magnificoconsiglia su come comportarsi in merito.
§§ [XXIV] (= C lxxiv; = Q 6.122) Disse allhor il S. Gasp. «Un’altra causa publica molto più: Pallavi-cino ribadisce la sua misoginia.
§ (≠C lxxvii; = Q 7.8) «Adunque» disse la S. Duch. «aspettando insino a domani: La signora Duchessalicenzia tutti e chiude la giornata.
LIBRO IV (53 segni)
#§1 [II] (= C iii; = Q 2.1) Parve adunque, secondo ch’el S. Gasp. Pallavicino raccontar soleva: Riepilo-go delle qualità che si addicono al perfetto Cortegiano.
1 Accanto a questo rigo sul ms. si trova l’indicazione del Valier al tipografo: «Questo Parve vien fuordi linea» (L, c. 212v). Istruzione rispettata nella messa in pagina della princeps (c. m4v). Sembrerebbe chela “P” sia stata stampata come carattere a sé, poiché fuoriesce dallo specchio di pagina.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 123
124 valeria guarna
§§ [III] (= C v; = Q 2.15) Il fin adunque del perfetto Cortegiano: Sia «il guadagnarsi per mezzo dellecondicioni attribuitegli da questi signori talmente la benivolenzia e l’animo di quel principe acui serve, che possa dirgli e sempre gli dica la verità». Il Cortegiano dovrà insegnare quelle «vir-tù che si convengono a bon principe».
§§ [IV] (= C ix; = Q 2.40) Dico adunque che poi che hoggidi i Principi: Il Cortegiano deve sempresvelare «la verità di tutte le cose con destrezza» al principe, infondendogli nell’animo la bontàe tenendogli l’animo continuamente «occupato in piacere onesto».
§ (≠ C x; = Q 2.47) Adoprando adunque a tal effetto il Cortegiano: Viene ribadito il fine del bon Cor-tegiano, anche perché «non è bene alcuno che così universalmente giovi come il bon principe».
§§ [V] (= C xi; = Q 3.1) Taceasi il Signor Ottaviano, come se: Pallavicino sostiene che le virtù nonsi possano imparare, ma che «siano date dalla natura e da Dio».
#1 (≠ C xi; = Q 3.5) Conferma anchor la mia opinion quella Fabula, che si dice: Favola d’Epi-meteo (exemplum).
§§ [VI] (= C xii; = Q 3.9) Allhor il S. Ottav. quasi ridendo «Voi adunque: Ottaviano Fregoso crede in-vece che le virtù, oltre a quelle date dalla natura, possano essere apprese.
§ (≠ C xii; = Q 3.11) Estimo io adunque che le virtù morali in noi non siano totalmente da natu-ra: Le virtù si apprendono con la consuetudine e dai «boni pedagoghi» che insegnano anche«boni modi e onesti».
§ (= C xiv; = Q 3.22) Rispose allhor il S. Gasp. «Son però molti i quali: Pallavicino è scettico, noncomprende perché anche chi ha chiara cognizione di far male continui a farlo.
§§ [VII] (≠C xiv; = Q 3.23) Disse il S. Ottaviano «Il vero piacere è sempre bono: Identificazione del be-ne con il vero. La virtù come «vera scienza». Tema dell’incontinenza introdotto da Bembo epoi discusso.
§§ [VIII] (= C xvii; = Q 3.36) Seguitava anchor il S. Ottav. il suo ragionamento: Discussione e con-fronto tra «continenzia» e «temperanzia». Trattazione delle virtù politiche: «fortezza», «giu-stizia», «magnanimità» e «prudenzia».
§§ [IX] (= C xix; = Q 4.1) Quivi havendo fatto il S. Ottav. un poco di pausa, come per riposarsi, disse ilS. Gasp. «Qual estimate voi: Pallavicino introduce il nuovo tema: Regno «d’un bon principe» ogoverno «d’una buona repubblica». Ottaviano Fregoso opta per il primo tipo perché più na-turale; Bembo, invece, sostiene sia migliore il governo della repubblica.
§§ [X] (= C xxi; = Q 4.13) Allhor il S. Ottaviano «Contra la opinione vostra: Ottaviano replica illu-strando i tre modi possibili «di governar bene i populi»: il regno, il governo degli ottimati e«l’amministrazione populare». Il giusto modo di vivere è quello «secondo le bone leggi» e ilgiusto modo di comandare è quello «mite e placido» dei «boni prìncipi».
§ (= C xxii; = Q 4.19) Disse allhor il Signor Gaspar «Ai discreti e virtuosi: Ottaviano tratta della mo-narchia come miglior forma di governo, poiché è «più facil cosa trovar un bono e savio che mol-ti». Inoltre il principe raggiungerà la perfezione nelle virtù che gli competono grazie all’aiutodegli insegnamenti e all’educazione ricevuti dal Cortegiano. Ritratto del «bon principe».
§§ [XI] (= C xxv; = Q 4.40) Allhor il Signor Gaspar «Et qual» disse «di queste due: Inizio della nuovatrattazione: qualità «che s’appartengono a bon principe». Si ribadisce che il Cortegiano deveinsegnare al principe la virtù «che imparar si pò e che tanto giova».
§ (≠ C xxv; = Q 5.4) Allhora la Signora Duchessa «Noi saremo» disse «tanto più: La Duchessa invitaOttaviano Fregoso a illustrare tutto quello che bisogna insegnare al principe.
§§ [XII] (= C xxvi; = Q 5.6) Rise il Signor Ottaviano, e disse «S’io havessi la gratia: Discussione sul-la vita attiva e quella contemplativa.
§§ [XIII] (= C xxviii; = Q 5.20) Allhor il S. Gasp. «Volentieri» disse «saprei quali sono: Virtù «utili enecessarie nella guerra» e virtù «oneste nella pace».
§§ [XIV] (= C xxix; = Q 5.25) Allhor il Signor Gaspar «Signor Ottaviano» disse «perché molto havete:La consuetudine. «La virtù intellettiva si fa perfetta con la dottrina, così la morale si fa con laconsuetudine».
1 Nella stampa (c. m7v) si va a capo.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 124
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 125
§ (= C xxx; = Q 5.30) Disse il S. Gaspar «Prima che passiate più avanti: Giusta cura del corpo.§§ [XV] (≠C xxx; ≠Q 5.33) Allhor la Signora Emilia ridendo «Non è ne’ patti» disse: Descrizione della
costituzione mista. Riflessioni sulla crisi italiana. Ancora sulla formazione del buon principe.§ (= C xxxv; = Q 5.60) Allhor il S. Gasp. «Penso io» disse «che piccol Signor: «Il valor fa grandi i
principi».§ (= C xxxvi; = Q 5.63) Erano stati per bon spacio attentissimi al ragionamento: Magnificenza, libe-
ralità e mansuetudine del principe.§§ [XVI] (= C xxxvii; = Q 5.76) Rispose allhor il S. Ott. ridendo «Quelli che non ebbero questi: Anco-
ra dei modi di governare (la tirannide) e dei sovrani del tempo presente (Francesco I, EnricoVIII, Carlo V).
§§ [XVII] (= C xxxix; = Q 5.87) Suggiunse il S. Ottav. «Credo adunque che tali e così divini principi: Ri-chiamo perché si ritorni a discutere della formazione del «bon principe».
§ (≠ C xxxix; ≠ Q 5.89) Dico adunque M. Ces. che le cose che voi volete che faccia il Principe: La «pru-denzia» come «necessaria compagna a tutte le virtù». Il «bon giudicio» del principe.
§ (= C xlii; = Q 5.104) Allhora M. Bernardo Bibiena ridendo «Signor Ottaviano» disse: Scambio di ra-pide battute e prefigurazione di Federico Gonzaga come principe di Italia.
§§ [XVIII] (≠ C xlii; ≠ Q 5.108) Allhor il Phrigio «Hor non più» disse «pregaremo Dio di vedere: Con-clusione del ragionamento intorno alla formazione del «bon principe». Riepilogo delle quali-tà e delle virtù necessarie e che si addicono al principe.
§§ [XIX] (= C xlv; = Q 5.125) Rise il Signor Ottav. e disse «S. Magnifi. Più laude della donna di: Con-tinua il riepilogo: il fine della cortegiania, modi di agire del Cortegiano e ribaditi i rapporti traCortegiano e principe.
§§ [XX] (= C xlviii; = Q 5.152) Quivi essendosi fermato il S. Ottav. di parlare disse il S. Gasp. «Io nonaspettava già ch’el nostro Cortegiano: Aristotele e Platone avevano già prefigurato nella loro fi-losofia il ruolo del Cortegiano. Conclusione del tema.
§§ [XXI] (= C xlix; = Q 6.1) Allhora il S. Gaspar. «Ricordomi» disse «che questi Signori: Trattazionedel tema d’amore.
§ (≠ C xlix; = Q 6.4) Allhora il S. Ottav. «Poi che tutte l’altre conditioni» disse: La signora Duchessaordina il nuovo ragionamento: che si parli e si insegni al Cortegiano «questo così felice amore».
§§ [XXII] (≠ C li; ≠Q 6.13) Signori per dimostrar che i vecchi possano non solamente amar senza biasi-mo: Bembo dà inizio alla sua trattazione: «dimostrar che i vecchi possano non solamente amarsenza biasimo, ma talor più felicemente che i giovani» e «dichiarir che cosa è amore ed in checosa consiste la felicità che possono avere gl’inamorati».
§ (≠C li; ≠Q 6.14) «Dico adunque che (secondo che dagli antichi savii è diffinito) amor: Definizioni del-l’amore, della bellezza e dei modi di conoscere (attraverso il senso, la ragione e l’intelletto).
§§ [XXIII] (≠ C liii; = Q 6.34) Stando adunque questo presuposito, il quale è verissimo: I diversi tipi diamore convenienti alle diverse età.
§ (= C lv; = Q 6.41) Quivi fece il Bembo un poco di pausa quasi come per riposarsi e stando ognun cheto,disse il S. Morello da Ortona «Et se si trovasse un vecchio: Discussione degli altri interlocutori (Mo-rello da Ortona, la signora Duchessa, conte Ludovico) su quanto appena esposto dal Bembo.
§§ [XXIV] (= C lvi; = Q 6.47) Quivi M. Fed. per acquetar il S. Morello, e divertir il ragionamento, nonlasciò rispondere il Conte Ludovico, ma interrompendolo disse «Forse ch’el Signor Morello: Se il bellocorrisponda al buono.
§ (≠ C lvi; = Q 6.49) Allhora M. Pietro Bembo «Non crediate» disse «che la bellezza: Bembo ribadiscel’equivalenza della bellezza con la bontà: «da Dio nasce la bellezza ed è come circulo, di cui labontà è centro». Il corpo umano come misura di tutte le cose.
§ (≠ C lix; ≠ Q 6.66) Non è adunque da dir che la bellezza faccia le donne superbe: «La connessioneche ha la bellezza con la bontà».
§ (= C lx; = Q 6.69) Allhora M. Cesar «Se è vero» disse «quello che eri allegò: Scambio di battute fragli interlocutori sugli argomenti appena trattati.
§§ [XXV] (≠ C lxi; ≠ Q 6.75) Troppo infelice sarebbe la natura humana, se l’anima nostra: Bembo afferma che l’amore vero è quello della ragione e dell’intelletto.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 125
126 valeria guarna
§ (≠ C lxi; = Q 6.77) Dico adunque che poi che la natura humana nell’età giovenile: L’amore sensualeè consentito ai cortigiani giovani, successivamente dovrà il sentimento amoroso essere con-veniente all’età dell’amante.
§§ [XXVI] (= C lxii; = Q 6.78) Però, quando qualche gratioso aspetto di bella donna lor s’appresenta:Deve il Cortegiano «deliberarsi totalmente di fuggire ogni bruttezza dell’amor vulgare e cosìentrare nella divina strada amorosa con la guida della ragione» (volgere l’amore sensuale inamore spirituale).
§ (≠ C lxii; = Q 6.82) Rimovasi adunque dal cieco giudicio del senso, e godasi con gli occhi: Il fined’amore è «generare ed esprimere la bellezza nella bellezza». Godere della bellezza con gli occhi e con l’udito.
§ (= C lxiii; = Q 6.88) Quivi il S. Morello «Il generar» disse «la bellezza nella bellezza: Bembo ribadi-sce che «l’amor razionale è più felice che ’l sensuale».
§§ [XXVII] (= C lxv; = Q 6.100) Stavano tutti attentissimi al ragionamento del Bembo e esso, havendo:Tormenti per l’assenza o la troppa vicinanza della donna amata.
§ (≠ C lxvi; = Q 6.108) Per fuggir adunque il tormento di questa absentia, e goder la bellezza senza passione, bisogna che ’l Cortegiano con l’aiuto della ragione revochi in tutto il desiderio dal corpo allabellezza sola.
§§ [XXVIII] (≠ C lxvi; = Q 6.110) Di questo modo sarà il nostro Cortegiano non giovane fuor di tutte:Bembo fa l’elogio dell’amore platonico. L’amante deve aspirare alla bellezza universale.
§§ [XXIX] (= C lxix; = Q 6.127) Se adunque le bellezze, che tutto dì con questi nostri tenebrosi occhi:La bellezza universale indistinta dalla somma bontà.
§ (≠ C lxix; = Q 6.132) Indrizziamo adunque tutti i pensieri e le forze dell’anima: L’amore, nella contemplazione della bellezza, sublima l’uomo.
§§ [XXX] (= C lxx; = Q 6.134) Qual sarà adunque, o Amor sanctissimo, lingua mortal: Preghiera delBembo all’Amore e alle sue virtù.
§§ [XXXI] (= C lxxi; = Q 7.1) Havendo il Bembo in sin qui parlato con tanta vehementia: Ci si avviaalla conclusione del ragionamento d’amore.
§ (≠ C lxxii, = Q 7.10) Quivi rispose il Magni. Iulia. «Non saranno in questo le donne: «Se le donnesono capaci dell’amor divino come gli omini, o no».
§§ [XXXII] (≠ C lxxiii; = Q 7.15) Allhora ognuno si levò in piedi con molta maraviglia, perché non pareva: L’assemblea si scioglie.
§ (≠ C lxxiii; = Q 7.16) Aperte adunque le finestre da quella banda del palazzo: Scena conclusiva sulpaesaggio urbinate.
La scansione in paragrafi con il nuovo sistema si presenterebbe quindi alleggerita. Eccoun riepilogo delle partizioni nelle diverse edizioni (si indicano i capitoli):
libro i libro ii libro iii libro iv
Cian 1947 56 100 77 73Quondam 2002, t. i 9 (434 par.) 12 (684 par.) 7 (519 par.) 7 (475 par.)nuova paragrafatura 23 31 24 32
3.
La presenza nel manoscritto di questi segni di paragrafo, tradotti in spaziature nellaprinceps, illustra bene come in realtà veniva percepita la scansione tematica dell’opera,ovvero quali erano le modalità di lettura originariamente proposte (Fig. 3). L’ipotesiche qui si avanza è che i simboli paragrafali in realtà disegnino in filigrana una sorta dimappatura degli argomenti del Cortegiano. In un’eventuale nuova edizione critica biso-gnerebbe tener conto della segmentazione suggerita e scegliere come pausare util-
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 126
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 127
Fig. 3. Segni tracciati da Valier corrispondenti nella princeps a uno spazio bianco più largo.
Libro I. L, 25v Ad, b3r
Libro II. L, 93r Ad, e7r
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 127
128 valeria guarna
mente il testo ai fini della lettura e dell’interpretazione, differenziando quei segni cheindicano al lettore di prestare particolare attenzione da quelli che invece sono dei veri epropri marcatori degli argomenti che si susseguono nell’opera. L’impiego della para-grafatura vale quindi sia come delimitazione di precise unità testuali, pensate come al-trettante unità di lettura autonome, sia come segnalazione di quelli che Paul Zumthorchiama «indizi di oralità». Zumthor infatti invitava a rintracciare tutti quegli avverti-menti grafici che avvisano il lettore della presenza di nuovi meccanismi narrativi. Nelcaso del Cortegiano molti di questi ‘indizi’ ci informano «sull’intervento della voce uma-na nella sua pubblicazione», ovvero sull’introduzione di un discorso diretto.1
Nella lista appena prodotta ho provveduto a segnalare, con una nuova numerazione,le partizioni interne alla narrazione che dovrebbero essere evidenziate in una futura edi-zione del Cortegiano. Emerge infatti come l’introduzione di un tema è seguita sempredall’argomentazione ampia di un personaggio, al quale rispondono gli altri interlocu-tori. Questa modalità dialettica di procedere fa sì che la questione proposta venga a vol-te ribadita e sostenuta con argomenti affini, altre avversata con pareri contrari. In talmaniera ogni questione viene discussa nella totalità delle possibili opinioni.2 La seg-mentazione del testo, prodotta dai segni paragrafali, demarca bene queste diverse zoneargomentative, dando al lettore la facoltà di orientarsi nella complessa mappa dell’ope-ra. Inoltre là dove sono presenti questi segni, ad indicare una sorta di ‘Nota bene’, ven-gono messe in rilievo delle precise unità tematiche utili a fare il punto della situazionesu determinati concetti chiave che Castiglione espone. L’attenzione del lettore viene inquesto modo sollecitata.
Questa sorta di mappatura del testo potrebbe avere relazione con le scelte editorialiadottate dai successivi editori del Cortegiano. Infatti molte edizioni (soprattutto cinque-centine) dotano l’opera di indici e postille proprio al fine di agevolare il lettore. D’altraparte la funzione di «manuale del bon cortegiano», che il libro ha, è anche assolta daqueste frecce invisibili che indicano quale siano le regole da seguire.3
Rispettare quest’organizzazione del testo, già presente nel Laurenziano e poi trasfe-rita nella princeps, fa sì che esso assuma nuova dinamicità. Le partizioni interne rappre-senterebbero, alla vista e all’udito, quella teatralità richiesta, per suo stesso statuto, daidialoghi del Cortegiano. D’altra parte proprio Quondam dichiara che in realtà l’opera diCastiglione «visivamente senza soluzione di continuità, aveva invece le sue cesure e lesue pause: siamo noi ad averne perso la percezione e quindi la competenza esecutiva,siamo noi ad avere bisogno di stampelle visive, di marcatori grafici».4 Cesure e pauseche, come si è cercato di dimostrare, sono invece già presenti sul manoscritto e in qual-che maniera anche nella stampa antica.
1 Zumthor 1987 (1990), p. 47.2 Borsetto 1980 rileva infatti l’insistenza dello schema discorsivo. La frequenza dei verba dicendi fa-
rebbe leva proprio sulla necessità stessa del dire e del ridire, struttura argomentativa costitutiva della fun-zione propria dell’opera ovvero quella della sua manualizzazione. Anche Mozzarelli 1997, p. 531, eviden-zia la «costruzione corale e dialogica […] d’un modello retoricamente persuasivo per la sua capacità diconsiderare, subordinare, integrare le possibili obiezioni ed eccezioni».
3 Dall’ed. aldina del 1547 comincia ad essere stampata la tavola delle Conditioni et qualità de l’huomo etdella Donna di Corte (c. 7r-v). Una sorta di prontuario che elenca le principali caratteristiche che defini-scono la fisionomia etica ed estetica del Cortegiano e della Donna di Palazzo. A riguardo si veda Quon-dam 2000, pp. 40-41. A una prima ricognizione su altre edizioni cinquecentesche dell’opera non si hannoriscontri di questa mappatura tematica ‘invisibile’. 4 Quondam 2004, p. 200.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 128
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 129
4.
Alla Houghton Library della Harvard University (Cambridge, ma) si conserva il ms. Gr.17 (siglato H) appartenuto alla tipografia veneziana dei Manuzio.1 Martin Sicherl ha ri-conosciuto nel codice il modello utilizzato per la stampa dell’opera omnia di Aristotele(5 voll., 1495-1498).2
Contrariamente all’opinione comune che considera le edizioni aldine per lo piùesemplate su importanti codici ora dispersi, Sicherl ritiene invece di poter affermare chegeneralmente Aldo Manuzio preferisse lavorare su copie di codici che lui stesso, dopoaver selezionato, faceva fare. E il manoscritto-copia, una volta utilizzato dai tipografi,veniva distrutto.
Per un caso del tutto fortuito alcuni fogli dei codici serviti alla stampa dell’Aristotelealdino vennero salvati e raccolti dal domenicano tedesco Johannes Cuno, il nome delquale si ricava dalle sottoscrizioni ancora visibili in alcune carte.3 Cuno era stato un collaboratore della tipografia aldina e molto probabilmente decise di mettere insieme ifogli che era riuscito a recuperare,4 quelli che attualmente costituiscono appunto l’attuale ms. Gr. 17. Questo codice raccoglie infatti materiali eterogenei quali: 1. Aristo-tele, De Caelo, ll. i-ii e parte del iii (cc. 1-37v); 2. Aristotele, Etica Nicomachea, parte del l.i (cc. 38r-45v); 3. Aristotele, De generatione et corruptione, un frammento (cc. 46r-53v); 4.Teofrasto, De historia plantarum e De causis plantarum, (cc. 54r-138v); 5. Porfirio, Isagoge,con introduzione di Ammonio, un frammento (cc. 139r-142v); 6. Aristotele, Fisiognomi-ca, (cc. 143r-152v); 7. Teofrasto, De signis aquarum et ventorum, un frammento (cc. 153r-v);8. pseudo-Galeno, De historia philosophica (cc. 154r-172r).
Un’attenzione particolare merita l’ultima sezione. Nelle carte occupate dall’operet-ta pseudo-galeniana sono ben visibili tracce di inchiostro tipografico e indicazioni perla mise en page del testo (numeri e lettere corrispondenti alle pagine aldine, istruzionisull’aspetto formale della stampa). Oltre la mano del copista è possibile rilevare la pre-senza di altre due mani: una, che utilizza un inchiostro marrone e uno stilo acuminato,segna la distribuzione delle carte per l’impaginazione della stampa (ad es. alle cc. 154r-v, 155v, 156v, 157r-v, 158r, 159r, ecc.); l’altra, riconoscibile da un inchiostro rosso molto chia-
1 Il ms. è consultabile online al sito http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/24336731. Per una biblio-grafia del codice si rimanda a Bond, Faye 1962, pp. 233-34; Moraux 1976, pp. 110-17; Cataldi Palau 1998, pp.423 e 431-32; Kavrus-Hoffman 2010, pp. 211-22.
2 Sicherl 1997, pp. 31-113; per la descrizione del contenuto dei volumi Renouard 1834, pp. 7-12 e 16. Sebbene i cinque volumi vengano catalogati come opera omnia aristotelica, in realtà questi raccolgonodiverse opere di altri autori, tra le quali: introduzione al libro primo degli Universalia di Porfirio (i vol.);De historia philosophica di Galeno (ii vol.); De historia plantarum e De causis plantarum di Teofrasto (iii vol.).
3 Come ad esempio alle cc. 35v (Est p. Jo. Cuno Or. Predi.rum Alemanni), 53v, 142v (Revisus et correctus Jo.Cuno Patavii 1509), 153r, 172r (Revisum per f. Jo. Cononem Norimontanum 1507).
4 Johannes Cuno (1462/1463-1513), predicatore domenicano e grecista di talento. Dal 1496 era statostudente di greco sotto la guida di Johannes Reuchlin a Heidelberg; dal 1506 al 1509 allievo, insieme a Era-smo da Rotterdam, di Marco Musuro, professore di greco a Padova. Frequentò la cerchia degli umanistiriuniti attorno al vescovo di Worms, Johann von Dalberg. Negli anni 1504-1505 collaborò a Venezia conAldo Manuzio, per incarico del quale nel 1505 si recò dall’imperatore Massimiliano I. Fu correttore del-l’ed. geronimiana di Johannes Amerbach e tradusse i Padri greci della Chiesa (Gregorio di Nazianzo, Gre-gorio di Nissa, Giovanni Crisostomo). Fu insegnante privato dei figli di Johannes Amerbach e di BeatusRhenanus. Studi su Cuno si trovano in Saffrey 1971; Sicherl 1978, in particolare pp. 183-88; Sicherl 1985, pp.141-48; Hoffmann 1985, pp. 76-79; Hoffmann 1986. Recentemente è stato individuato alla British Libraryun taccuino personale di Cuno: vedi Russell 2010.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 129
130 valeria guarna
ro e da uno stilo più grossolano, riempie invece gli spazi lasciati vuoti dal compilatoredel codice per le lettere iniziali dei capoversi e per i titoli dei paragrafi nei quali l’operasi divide. Sicherl sostiene che queste carte del De historia philosophica furono utilizzatecome modello per la stampa dell’opera nel secondo volume (1497, abbreviato in ‘Ald.’);il testo occupa le cc. X5v-ıv (i fascicoli sono dei quaterni e la sequenza è X + ı).1
A un esame delle carte del ms. Gr. 17, che ho potuto effettuare sul sito della HoughtonLibrary, sono emersi dei particolari che integrano gli studi di Sicherl. Dal confronto ef-fettuato tra le carte manoscritte contenenti il testo pseudo-galeniano e quelle dell’edi-zione aldina emerge come i diversi tipi di istruzioni presenti nel codice venissero ri-spettati nella stampa. Infatti la mise en page indicata sul ms. coincide con la distribuzionedel testo all’interno della stampa.
In particolare ho rilevato che la segnalazione di nuovi capoversi sul ms., indicata conlettere iniziali che si estendono nei margini, sia un accorgimento ripreso fedelmentedalla stampa nella quasi totalità dei casi: cc. X7v, X8r-v, +1r-v, ecc. La stessa precisionenel seguire il ms. si riscontra anche nella disposizione dei titoli, e nella spaziatura a essiconnessa, che avverte del susseguirsi dei diversi argomenti all’interno dell’opera. Ma sela segnalazione degli argomenti attraverso i titoli sembra necessaria al carattere esposi-tivo dell’opera, più difficilmente sembrerebbe giustificare l’inizio dei capoversi oltre lospecchio di pagina (Fig. 4).
Ci troviamo di fronte alle stesse modalità che ricorrono nell’editio princeps del Corte-giano. In entrambe le edizioni gli spazi più larghi all’interno del testo e le iniziali di ca-poverso stampate nel margine, oltre l’area di stampa, sembrano fare riferimento a unaparticolare scansione dell’opera. Nel caso dello pseudo-Galeno la pausazione visiva ènecessaria al carattere enunciativo-trattatistico dell’opera. Si susseguono infatti una se-rie di temi enucleati da spazi bianchi all’inizio e alla fine e introdotti da specifici titoliquali ad esempio: Quale sia il principio della filosofia (H, c. 156v / Ald, c. X8r), Del segno (H,c. 156v / Ald, c. X8v), Dell’anima (H, c. 157v / Ald, c. +1v), Dei colori (H, c. 158v / Ald, c.+2v), Dell’apodittica (H, c. 161r / Ald, c. +4v), ecc. Diversa invece la scansione tematicadel Cortegiano realizzata molto probabilmente per agevolare la lettura e quindi la com-prensione del testo da parte del lettore.
1 Sicherl 1997, pp. 79-83. Il volume aldino è un in folio. Gli esemplari consultati sono quelli della Bi-blioteca Nazionale Centrale di Roma (71 8 e 17), che conserva tutti e cinque i volumi, e della BibliotecaMarciana di Venezia (Aldine 114). Nelle cc. paratestuali si legge:
[*1r] Eorum quae hoc volumine continentur nomina et ordo.|Aristotelis vita ex laertio.|Eiusdem vi-ta per ioannem philoponum.|Theophrasti vita ex laertio.|Galeni de philosopho historia.|Aristotelis dephysico auditu, libri octo.|De coelo, libri quatuor.|De generatione et corruptione, duo.|Meteorologi-corum, quatuor.|De mundo ad alexandrum, unus.|Philonis iudaei de mundo, liber unus.|Theophrastide igne, liber unus.|Eiusdem de Ventis liber unus.|De signis aquarum et ventorum, incerti aucto-ris.|Theophrasti de lapidus, liber unus.
[*1v-*2v] Aldus Manutius Bassianas Romanus Alberto Pio|principi Carpensi|S. P. D.|segue testo in la-tino della lettera di Aldo il Vecchio ad Alberto Pio, Principe di Carpi.
[K6r] Sunt omnes Quaterni exceptis * & C ° & K illi n.terni.|[…]|Excriptum Venetiis manu stamneain domo Aldi manutii Romani, &|graecorum studiosi. Mense Februario. M III D|Impetratumest a do-minis Venetis idem in hoc quod in caeteris impressis graece domi nostrae.
Per una bibliografia del volume si rimanda ai seguenti cataloghi: Renouard 1834, pp. 10-11; bmc, i 42;Catalogue of Books printed in the xvth Century now in the British Museum, v. Venice, London, printed by or-der of the Trustees, 1924, pp. 556-57; W. A. Copinger, Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum,Berlin, Josef Altmann, 1926, nº 10019; igi, nº 791; gw, nº 2334; A catalogue of the Ahmanson-Murphy AldineCollection at ucla, Los Angeles, 1989-1994, nº 23.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 130
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 131
Fig. 4. Pseudo-Galeno, De historia philosophica. Mise en page del ms. Gr. 17(Houghton Library, Harvard University) ripresa nell’edizione aldina del 1497 (II volume).
Ms. Gr. 17, c. 159r Ald. 1497, c. +3r
Ms. Gr. 17, c. 161v Ald. 1497, c. +5r
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 131
132 valeria guarna
La distanza temporale tra la realizzazione dell’opera pseudo-galeniana, nel secondovolume aldino, e quella della princeps del Cortegiano, è ampia: ben trentuno anni. Per en-trambe però abbiamo l’opportunità di consultare i manoscritti di tipografia, i quali sem-brano essere stati sottoposti allo stesso trattamento in vista della stampa. Le istruzionidi tipo tecnico impartite al tipografo risponderebbero anche alla necessità di realizzaredelle stampe che avessero al loro interno le indicazioni di lettura. Questi accorgimentitipografici, quali spazi bianchi più larghi all’interno del testo e capoversi nel margine,sarebbero insomma serviti alla scansione del continuum di ciascuna delle due opere. Ul-teriori punti di contatto tra i testi possono essere individuati nel formato in folio e nel-la tecnica di lavorazione. Sembra infatti che la princeps del Cortegiano sia stata stampatacon modalità simili a quelle adoperate per opere degli ultimi anni del xv sec., come con-fermerebbe l’utilizzo di un torchio di tipo più antico.1
L’editore moderno del De historia philosophica rispetta pedissequamente la mise en page del manoscritto che corrisponde a quella della stampa aldina proprio perché agliaspetti visivi è connesso un significato.2 Allo stesso modo una nuova edizione del Cortegiano non può prescindere dalla mise en page della princeps, che riprende quella delmanoscritto di tipografia. Infatti l’organizzazione formale della stampa dà indicazionisulle modalità di lettura e dunque veicola significati che verrebbero traditi se l’impagi-nazione venisse alterata.
Se per il significato di questa particolare messa in pagina possono essere fatte delleipotesi, più difficilmente si spiega in quale maniera sia stata realizzata, cioè come tec-nicamente i tipografi procedessero alla stampa di questi caratteri fuori dall’area di stam-pa. Forse i caratteri che si estendono nel margine erano inclusi nello specchio della pa-gina e il rientro del corpo del testo veniva realizzato con l’uso di blank. Ad oggi non cisono studi al riguardo e il fenomeno sembra non essere stato finora notato. È probabi-le che la segnalazione dei capoversi fosse una peculiarità propria delle edizioni aldine,posto che questo accorgimento tecnico si riscontra anche nell’Euripide del 1503 e nel Lucrezio del 1515, sempre stampati dai Manuzio.3
1 McLeod 2000 e Harris 2009.2 Il testo pseudogaleniano è edito criticamente per la prima volta in Diels 1879, pp. 233-58 e 597-648.
Una traduzione italiana del testo, condotta sull’ed. Diels del 1929, si può leggere in Torraca 1961, pp. 375-428. L’editore moderno ha condotto la sua edizione su due codici: il Laurenziano Pluteo 74 3, siglato A,è un codice membranaceo compilato molto probabilmente a Costantinopoli nel xii sec. (consultabileonline insieme al link dei relativi riferimenti bibliografici: http://teca.bmlonline.it/TecaViewer/in -dex.jsp?RisIdr=TECA0001108430&keyworks=historia); e il Laurenziano Pluteo 58 2 (B), del xv sec.,esemplato sul ms. A (consultabile online insieme al link dei relativi riferimenti bibliografici: http://te-ca.bmlonline.it/TecaViewer/index.jsp?RisIdr=TECA0000867934&keyworks=historia). Diels 1879, p.238, ipotizzava che la stampa aldina del 1497 fosse stata condotta o sul codice A o su un suo apografo: «ExLaurentiano igitur aut ipso aut ex apographo inde ad preli usum confecto editio princeps ita expressa est,[…] codicis scripturam fideliter teneret». In anni successivi gli studi di Sicherl confermano come il Laur.Plut. 74 3 sia servito come antigrafo del ms. Gr. 17. In realtà sembra più probabile che per la stampa del1497 i tipografi abbiano utilizzato il codice Harvardiano che contiene, diversamente dal Laur. Plut. 74 3,tracce del passaggio in tipografia. In aggiunta si ricordi come Aldo Manuzio preferisse lavorare su copiedi manoscritti e a questo punto non è difficile supporre che il modello della stampa possa essere statoproprio un apografo del codice A, ovvero il ms. Gr. 17. Inoltre sembra difficile credere che il modello del-la stampa possa essere stato il codice Laur. Plut. 74 3. Infatti negli anni cinquanta del xv sec. il ms. fece ilsuo ingresso nella biblioteca di Lorenzo il Magnifico, probabilmente grazie all’umanista Giano Lascaris(1445-1535), cui Lorenzo aveva dato l’incarico di fare reperire codici greci in Oriente e in Italia. Per la pre-senza del codice nella biblioteca di Lorenzo il Magnifico si vedano Fryde 1996 e Speranzi 2007.
3 Devo la segnalazione del ms. harvardiano e delle due stampe aldine (Euripide e Lucrezio) al prof.Randall McLeod.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 132
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 133
Appendice
Tavola delle corrispondenze
Si fornisce l’elenco dei luoghi corrispondenti tra l’edizione di Cian 1947 e quella diQuondam 2000, t. i, affiancati dalla nuova paragrafatura. Per una più facile individua-zione dei riscontri all’interno del testo si riporta l’incipit del capitolo di riferimento (rispetto all’ed. Cian).
LIBRO I
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
i [1.1]-[1.10] i Fra me stesso lungamente ho dubitato
ii [2.1]-[2.7] ii Alle pendici dell’Appennino
iii [2.8]-[2.15] Costui adunque, seguendo il corso della natura
iv [2.16]-[2. 23] Erano adunque tutte l’ore del giorno divise
[2.18] iii Quivi adunque i soavi ragionamenti
v [2.24]-[2.27] Ma lassando questo, dico che consuetudine
vi [2.28]-[2.31] iv Havendo adunque Papa Iulio II
[3.1]-[3.3] Così il giorno appresso la partita del Papa
vii [3.4]-[3.10] «Gran cosa è pur,» rispose il signor Gaspar
viii [3.11]-[3.19] «Chi vol con diligenzia considerar tutte
ix [3.20]-[3.28] Allor fra Serafino, a modo suo ridendo
x [3.29]-[3.35] Così, dopo l’aver dato un lieto applauso
xi [3.36]-[3.40] Piacque molto questo gioco e già ognun si preparava
xii [3.41]-[3.47] v Attendeva ognun la risposta della signora Emilia«Signora vorrei che mi fosse licito, come qualche volta sisole
xiii [3.48]-[3.52] Allor la signora Emilia, ridendo, disse al conte Ludovico
[4.1]-[4.5] Rispose il Conte: «Io non voglio far come colui
xiv [4.6]-[4.13] vi Voglio adunque che questo nostro cortegiano
[4.13] vii Il cortegiano, adunque, oltre alla nobiltà, voglio che sia
xv [4.14]-[4.17] Quivi non aspettando più oltre, disse il signor Gaspar Pal-lavicino
xvi [4.18]-[4.23] Allora il conte Ludovico: «Non nego io»
xvii [4.24]-[4.30] viii Ma per venire a qualche particularità
xviii [4.31]-[4.37] «Ed io», rispose allora il signor Gaspar
xix [4.38]-[4.41] ix Quivi facendo un poco di pausa il Conte
xx [4.42]-[4.46] Vegnendo adunque alla qualità della persona
xxi [4.47]-[4.54] Estimo ancora che sia di momento assai il saper lottare
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 133
134 valeria guarna
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
x Adopransi ancor l’arme spesso in tempo di pace
xxii [4.55]-[4.61] Sono ancor molti altri esercizi
xxiii [4.62]-[4.67] «Certo» disse allor messer Cesare Gonzaga
xxiv [4.67]-[4.72] xi «Se ben tengo a memoria, parmi, signor Conte, che voiquesta sera
xxv [4.73]-[4.78] «Obligato non son io», disse il Conte
xxvi [4.79]-[4.88] Chi adunque vorrà esser bon discipulo
[4.82] xii Ma avendo io già più volte pensato meco
xxvii [4.89]-[4.93] Quivi non aspettando, messer Bernardo Bibiena disse
[4.90] xiii Rispose allor il Conte: «Poiché voi volete pur ch’io dica
xxviii [4.94]-[4.103] Allora il signor Magnifico: «Questo ancor,» disse
[5.1]-[5.2] Sarà adunque il nostro cortegiano stimato eccellente
xxix [5.3]-[5.13] xiv Allor messer Federico: «Veramente,» disse, «ragionando tranoi,
xxx [5.14]-[5.23] Allora messer Federico, «Signor Conte,» disse, «io non pos-so negarvi
xxxi [5.24]-[5.30] xv Allora il signor Gaspar Pallavicino: «Questa disputazion»,disse
xxxii [5.31]-[5.42] Allora la signora Duchessa: «Non usciam,» disse
[5.32] xvi Rispose il Conte: «Io già, Signora, ho detto quello che ne so
xxxiii [5.43]-[5.50] Io adunque queste parole antiche
xxxiv [5.51]-[5.59] «Dubito,» disse allora il signor Morello, «che se questocortegiano parlerà
xxxv [5.60]-[5.71] xvii Se adunque degli omini litterati e di bon ingegno
xxxvi [5.72]-[5.76] È ben vero che in ogni lingua alcune cose
xxxvii [5.77]-[5.96] Allor messer Federico, «Perché volete voi»
xxxviii [5.97]-[5.104] Allora meser Federico rispose: «Io voglio pur ancor dirquesto poco
xxxix [5.105]-[5.112] Allora la signora Emilia, «A me par» disse, «che questavostra disputa
xl [6.1]-[6.11] xviii «Signora,» rispose il Conte, «il filo mi par tronco
xli [6.12]-[6.14] In tal modo si fugge e nasconde l’affettazione
xlii [7.1]-[7.6] xix Ma, oltre alla bontà, il vero e principal ornamento del-l’animo
xliii [7.7]-[7.19] E s’io parlassi con essi o con altri che fosseno d’opinioncontraria alla mia
xliv [7.20]-[7.31] Il qual voglio che nelle lettere sia più che mediocrementeerudito
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 134
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 135
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
xlv [7.32]-[7.39] xx Rispose quivi messer Pietro Bembo: «Io non so, Conte, comevoi vogliate
xlvi [7.40]-[7.47] Rispose allora il Conte: «Io biasmo i Franzesi che estimanle lettere nuocere
xlvii [8.1]-[8.14] xxi Rise quivi ognuno; e ricominciando il Conte, «Signori,»«Signori,» disse, «avete a sapere ch’io non mi contento
xlviii [8.15]-[8.16] Or quivi tacendo un poco il Conte, disse il Magnifico Iu-liano
xlix [8.17]-[8.23] xxii Allora il Conte, «Prima che a questo proposito entriamo
l [8.24]-[8.28] Allor la signora Emilia, rivolta a Ioan Cristoforo Romano
li [8.29]-[8.33] Disse il Conte ridendo: «Io non parlo in grazia de Rafaello
lii [8.34]-[8.42] Per questo parmi la pittura più nobile e più capace
liii [8.43]-[8.49] Rise quivi messer Cesare Gonzaga e disse: «Io già non sonpittore
liv [9.1]-[9.7] xxiii Quivi, mostrando messer Cesare non restar satisfatto
lv [9.8]-[9.14] «Non sopportarò io,» respose il Magnifico Iuliano, «permodo alcuno
lvi [9.14]-[9.16] Disse allor il Calmeta: «Signori, poiché l’ora è tarda
LIBRO II
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
i [1.1]-[1.17] i Non senza maraviglia ho più volte considerato onde nascaun errore
ii [1.18]-[1.29] Però come del resto, così parlano ancor delle corti
iii [1.30]-[1.37] Però quando i nostri vecchi laudano le corti passate
iv [1.38]-[1.39] Ma a questi vecchi penso che omai a bastanza sia risposto.
v [2.1]-[2.3] ii Venuto adunque il seguente giorno, tra i cavalieri e le donnedelle corte
vi [2.4]-[2.11] iii Allora messer Federico, rivolto all’Unico, «A voi adunquenon par»
vii [2.12]-[2.20] Avendo adunque il Conte iersera con tanta copia
[2.19] iv Voglio adunque che ’l nostro cortegiano in ciò che egli faccia
viii [3.1]-[3.8] v Poi che così ebbe detto messer Federico, parve che si fer-masse un poco.
ix [3.9]-[3.12] Non vi par ora, signor Morello, che le nostre regule
x [3.13]-[3.18] Disse allor il signor Gasparo Pallavicino: «Nel paese nostrodi Lombardia
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 135
136 valeria guarna
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
xi [3.19]-[3.28] Rise messer Federico; poi soggiunse
xii [3.29]-[3.31] Dico adunque che ’l cortegiano dee in questi spettaculi
[3.31] vi Venga adunque il cortegiano a far musica come a cosa per
xiii [3.32]-[3.40] Allor il signor Gaspar Pallavicino, «Molte sorti di musica»
xiv [3.41]-[3.47] vii Rispose allora il Magnifico: «Non private, messer Federico
xv [3.48]-[3.52] «Ma sono ben degli altri intertenimenti con donne
xvi [3.53]-[3.58] Questo medesimo rispetto e giudicio
xvii [4.1]-[4.6] Ma in somma non bastaranno ancor tutte queste condizio-ni del nostro cortegiano
[4.4] viii Rise quivi la signora Emilia e disse: «Voi fuggite troppo lafatica
xviii [4.7]-[4.19] Io estimo che la conversazione, alla quale dee principal-mente attendere il cortegiano
xix [4.20]-[4.29] Non cercherà d’intromettersi in camera nei lochi secreti
xx [4.30]-[4.36] Disse allor messer Cesare Gonzaga: «Parmi che abbiate rubato
xxi [4.37]-[4.43] «Prima che più avanti passate,» disse quivi Vincenzio
xxii [4.44]-[4.55] Rispose allor messer Federico: «Non voglio già comportar
xxiii [4.56]-[4.60] ix «Vorrei,» disse allor il signor Ludovico Pio
xxiv [4.61]-[4.71] «Chiaritemi almen un altro dubbio,» replicò il signor Gasparo.
xxv [4.72]-[4.75] x Ma lasciamo da canto omai questa pratica de’ signori
xxvi [5.1]-[5.7] xi Allora il Magnifico Iuliano, «Vorrei,» disse «messer Fede-rico
xxvii [5.8]-[5.20] Ma non voglio che noi entriamo in ragionamenti di fasti-dio
xxviii [5.21]-[5.28] xii «A me non pare,» disse allor el signor Gaspar Pallavicino
xxix [6.1]-[6.8] Ma un’altra cosa parmi che dia e lievi molto la riputazione
[6.4] xiii Rispose allor messer Pietro Bembo: «Del restringersi inamicizia
xxx [6.9]-[6.17] Allor messer Federico, «Veramente,» disse, «molto maggiorsaria
xxxi [6.18]-[6.30] Quivi essendosi fermato di parlare messer Federico, «Vor-rei»
xxxii [6.31]-[6.38] xiv Ma perché par che la fortuna, come in molte altre cose
xxxiii [6.39]-[6.44] «Io non so come questo giovi,» rispose messer Bernardo Bi-biena
xxxiv [6.44]-[6.52] E certo non si pò negar che queste prime impressioni
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 136
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 137
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
xxxv [6.53]-[6.59] xv Or quivi ridendo rispose il signor Gasparo Pallavicino
xxxvi [6.60]-[6.66] xvi Deve adunque il cortegiano por molta cura nei princìpi
xxxvii [6.67]-[6.74] «E che cose possono esser queste?» disse il signor LudovicoPio.
xxxviii [6.75]-[6.83] xvii Or io non voglio seguitar più minutamente in dir cose trop-po note
xxxix [6.84]-[6.93] «Questo,» disse il Calmeta, «non arebbe fatto Nicoletto
xl [6.94]-[6.102] xviii Rispose allor il signor Gaspar Pallavicino: «Questa a menon par arte
xli [6.103]-[6.107] xix È adunque securissima cosa nel modo del vivere
xlii [6. 108]-[7.4] Io penso che ormai la signora Emilia mi darà licenzia di tacere
[7.1] xx Allor disse ridendo il signor Prefetto: «Io non voglio che questa
xliii [7.5]-[7.11] Allor il signor Prefetto rispose: «Voi negate che nelle facezie
[7.6] xxi «Queste regule, Signor mio,» rispose messer Federico
xliv [7.12]-[7.19] xxii Allor messer Federico, pur ridendo, disse: «Non è alcun quidi noi
xlv [7.20]-[7.29] Cessato il riso, disse la signora Emilia: «Lasciate voi adesso
[7.22] xxiii Allora rivoltandosi messer Bernardo alla Signora Duchessa
xlvi [7.30]-[7.35] Il loco adunque e quasi il fonte onde nascono i ridiculi
xlvii [7.36]-[7.43] Avete ancor a sapere che dai lochi donde si cavano
xlviii [7.44]-[8.5] xxiv Tornando adunque a dechiarire le sorti delle facezie
xlix [8.6]-[8.10] Or vedete come questa sorte di facezie ha dello elegante
l [8.11]-[8.16] «Questa non saria poca laude,» disse messer Roberto
li [8.17]-[8.26] Induce ancor molto a ridere, che pur si contiene sotto lanarrazione
lii [8.27]-[8.33] Disse allora messer Pietro Bembo: «E perché non dite voi
liii [8.34]-[8.38] Risesi molto del sottil avvedimento di questo cittadino
liv [8.39]-[8.41] Suggiunse allor messer Bernardo: «Le affettazioni poi me-diocri
lv [8.42]-[8.47] Disse allora il Magnifico Iuliano: «Sia come si vole, né piùeccellente
lvi [8.48]-[8.54] xxv Risero allora tutti; e messer Bernardo, «In vero» disse
lvii [9.1]-[9.2] xxvi Così, seguitando il ragionamento, disse messer Bernardo«Avete adunque inteso delle facezie che sono nell’effetto
lviii [9.3]-[9.9] Delle facezie adunque pronte, che stanno in un breve detto
lix [9.10]-[9.13] Ma dei motti ambigui sono molte sorti
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 137
138 valeria guarna
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
lx [9.14]-[9.16] Ma tra gli altri motti, quegli hanno bonissima grazia
lxi [9.17]-[9.27] Un’altra sorte è ancor, che chiamiamo “bischizzi”
lxii [9.28]-[9.35] È medesimamente bello interpretare i nomi
lxiii [9.36]-[9.43] Dicesi ancora qualche volta una parola medesima
lxiv [9.44]-[9.48] Ma i modi del parlare e le figure che hanno grazia
lv [9.49]-[9.56] Molto serveno ancor così i detti giocosi per pungere
lvi [9.57]-[9.61] Si morde ancora spesso facetamente con una certa gravità
lvii [9.62]-[9.67] Rise messer Bernardo, poi suggiunse: «Di questi sono
lviii [9.68]-[9.72] E quivi essendosi riso alquanto, suggiunse messer Bernardo
lix [9.73]-[9.76] Allora il signor Gaspar Pallavicino, «Le donne,» disse
lx [9.77]-[9.83] Allora messer Bernardo, «Veramente, signora,» disse
lxxi [9.84]-[9.86] È ancor bello, quando con una risposta l’omo riprende
lxxii [9.87]-[9.90] Assai gentil modo di facezie è ancor quello che consiste
lxxiii [9.91]-[9.93] E questa sorte di facezie che tiene dell’ironico
lxxiv [9.94]-[9.97] Simile a questa maniera che tende all’ironico
lxxv [9.98]-[9.107] Arguti motti son ancor quelli, quando del parlar proprio
lxxvi [9.108]-[9.112] È ancor bello, quando uno vien morso in quella medesimacosa
lxxvii [9.113]-[9.123] Sono ancor arguti quei motti che hanno in sé una certa nascosa suspizioni di ridere
lxxviii [9.124]-[9.131] È ancor bello quando si dechiara una cosa o si interpreta
lxxix [9.132]-[9.137] Ridesi ancor d’alcune cose discrepanti; come disse uno
lxxx [9.138]-[9.142] Ridesi ancor spesso quando l’omo concede quello che se glidice
lxxxi [9.143]-[9.146] Spesso si dice ancor una parola, nella quale è una nascosta
lxxxii [9.147]-[9.154] Ridesi ancor quando l’omo con bona grazia accusa se stesso
lxxxiii [9.155]-[9.163] xxvii Potrei forsi ancor, signori, raccôrre molti altri lochi
lxxxiv [9.164]-[10.3] Ma voi, messer Federico, che pensaste di riposarvi
xxviii «Anzi,» rispose messer Federico, «a così bon albergo son io
lxxxv [10.4]-[10.13] E parmi che la burla non sia altro che un inganno amiche-vole
[10.8] xxix Il primo modo è tale, quale fu la burla che a questi dì
lxxxvi [10.14]-[10.24] Di questa sorte burle ogni dì veggiamo
lxxxvii [10.25]-[10.32] xxx Dell’altra sorte di burle, quando l’omo inganna se stesso
lxxxviii [10.33]-[10.36] E così essendosi per lo raccontarla alquanto rinovato il ri-dere
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 138
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 139
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
lxxxix [10.37]-[10.43] Or, come avemo detto, delle burle si poria parlar largamente
xc [11.1]-[11.4] xxxi Allora il signor Gasparo, «Per certo,» disse, «messer Ber-nardo
xci [11.5]-[11.7] Quivi, facendo un poco di pausa messer Bernardo, disse
xcii [11.8]-[11.10] Allor la signora Duchessa, «In questo modo,» disse
xciii [11.11]-[11.16] Allora messer Bernardo ridendo, «Signori,» disse
xciv [11.17]-[11.22] Allor il signor Gasparo, «Per niuna altra causa» disse
xcv [11.23]-[11.26] Allor il signor Gaspar, «Io non nego,» rispose, «che la in-tenzione
xcvi [11.27]-[11.30] Rispose il signor Gaspar: «Io non son già lor nemico
xcvii [12.1]-[12.3] Così, tra per le risa, tra per lo levarsi ognun in piedi
xcviii [12.4]-[12.11] Allora il Magnifico Iuliano, «Signora mia,» rispose
xcix [12.11]-[12.15] Rise allor il signor Gasparo, e voltatosi a messer Nicolò Frigio
c [12.16]-[12.20] «Signora mia,» rispose il Magnifico, «io non so come bonconsiglio
LIBRO III
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
i [1.1]-[1.8] i Leggesi che Pitagora sottilissimamente e con bel modo
ii [2.1]-[2.10] ii Essendosi adunque ridutta il seguente giorno
iii [2.11]-[2.15] «Anzi,» disse il signor Gasparo, «e questo e molte altre cose
iv [2.16]-[2.26] iii Allora il signor Magnifico, voltatosi alla signora Duchessa
v [2.27]-[2.37] Lassando adunque quelle virtù dell’animo
vi [2.38]-[2.42] E perché le parole sotto le quali non è subietto
vii [2.43]-[2.50] Avendo insin qui detto, il Magnifico si tacque
viii [2.51]-[2.58] Rispose il Magnifico: «Poch’io posso formar questa donna
ix [2.59]-[2.63] E perché il signor Gasparo dimanda ancor quai siano
x [3.1]-[3.3] «Maravigliomi pur,» disse allora ridendo il signor Gaspar
xi [3.4]-[3.12] iv Disse allora il signor Gaspar: «Io non voglio rinovar
xii [3.13]-[3.18] Aspettava il Magnifico Iuliano che ’l signor Gasparo segui-tasse
xiii [3.19]-[3.25] Quivi avendo il Magnifico Iuliano fatto un poco di pausa
xiv [3.26]-[3.32] E perché voi diceste che intento della natura
xv [3.33]-[3.37] Allora il signor Gasparo, «Io non vorrei,» disse
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 139
140 valeria guarna
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
xvi [3.38]-[3.42] Rispose sùbito il Magnifico Iuliano: «Le meschine
xvii [3.43]-[3.48] v Allora la signora Emilia rivolta al signor Magnifico, «Peramor
xviii [3.49]-[3.57] «Ancor volete,» rispose il Magnifico Iuliano
xix [4.1]-[4.4] vi Allor il Frigio, «Quelli effetti,» disse
xx [4.5]-[4.12] Pensate poi quante altre ci sono state delle quali
[4.11] vii Allora la signora Emilia: «Tanto piacer,» disse, «avete didir mal
xxi [4.13]-[4.15] «Son contento,» disse il Magnifico Iuliano, «non parlar più
[4.15] viii Disse allora il signor Gasparo: «Quelle ragioni che hanno
xxii [4.16]-[4.22] «Veramente,» rispose il Magnifico Iuliano, «niuna altracosa
xxiii [4.23]-[4.26] Rise il Magnifico Iuliano e disse: «La ostinazione chetende a
xxiv [4.27]-[4.30] ix Allor il Magnifico Iuliano, «Piacemi,» rispose.
xxv [4.31]-[4.36] Allora il signor Gasparo ridendo, «Io ancora mi ricordo»
xxvi [4.37]-[4.48] Questa Camma fu una bellissima giovane
xxvii [4.48]-[4.55] Disse il Magnifico: «Si trovan sì; e che sia vero, udite.
xxviii [4.56]-[4.60] Disse allora ridendo il Frigio: «Che sapete voi ch’ella
xxix [4.61]-[4.64] Rispose il Magnifico: «Or uditelo. Dopo la espugnazion
xxx [4.65]-[4.70] Né meno giovarono allo augumento di quella le donnesabine
xxxi [4.71]-[4.75] x Quivi essendosi un poco il Magnifico Iuliano fermato evedendo
xxxii [4.76]-[4.83] Allora la signora Emilia, «Non defraudate,» disse «ledonne
xi «Essendo Filippo di Demetrio intorno alla città di Chio
xxxiii [4.84]-[4.87] Avendo insin qui detto, il Magnifico Iuliano fermossi
xxxiv [4.88]-[4.93] Disse il Magnifico: Se in ogni tempo vorrete misurare ilvalor
xxxv [4.94]-[4.105] Ma lassando a parte tutte l’altre ditemi, signor Gaspar
xxxvi [4.106]-[4.116] Ritornando adunque in Italia, dico che ancor qui non
xxxvii [4.117]-[5.2] «Non dite così,» rispose allora ridendo il Frigio
xxxviii [5.3]-[5.6] Allora il Magnifico, «Questi,» rispose, «veramente sonobelli
xxxix [5.7]-[5.19] «Ed io,» rispose ridendo il signor Gasparo, «non solamente
xl [5.20]-[5.28] xii Allora messer Cesare, il qual per bon spacio tacciuto avea
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 140
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 141
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
xli [5.29]-[5.34] Ma io non voglio dir più avanti e bastami che mi consen-tiate
xlii [5.35]-[5.41] Disse messer Cesare: «Io non ho mai conosciuti questi
xliii [5.42]-[5.56] Dico adunque che io già conobbi una bella e delicata gio-vane
xliv [5.57]-[5.63] Parvi, signor Gasparo, che questi sian atti di continenzia
xlv [5.64]-[5.70] Disse il Frigio: «Dovete averlo trovato negli Evangelii»
xlvi [5.71]-[5.78] Quivi risero tutti gli omini e donne; e la signora Emilia
xlvii [5.79]-[5.89] Allora il signor Gasparo, «Queste,» disse, «messer Cesare
xlviii [5.90]-[5.96] Quivi fece messer Cesare un poco di pausa
xlix [5.97]-[5.100] Ma per parlarvi di quelle che voi stesso conoscete
l [5.101]-[5.111] Disse allora messer Cesare: «Vero è che questi così grandi
li [5.112]-[5.123] xiii Allora il signor Gasparo, essendosi fermato messer Cesare
lii [5.124]-[6.2] Non vedete voi che di tutti gli esercizi graziosi
[6.1] xiv Rispose il signor Gasparo: «Io credo che altro non vi si possa
liii [6.3]-[6.6] Quivi tacendo ognuno disse messer Federico
liv [6.7]-[6.13] Allor il signor Magnifico, «Bisogneria prima,» disse
lv [6.14]-[6.18] Allora messer Federico, «Signor Magnifico,» disse, «voi
lvi [6.19]-[6.27] xv Disse il signor Gasparo ridendo: «Non volete voi
lvii [6.28]-[6.34] Allora messer Roberto da Bari, pur ridendo, «Io,» disse
lviii [6.35]-[6.38] xvi Avendo insin qui detto, il signor Magnifico taceasi
lix [6.39]-[6.48] xvii Allora il signor Magnifico, «Non voglio,» disse
lx [6.49]-[6.52] Messer Roberto pur contradicea, ma la signora Duchessa
[6.50] xviii Allora l’Unico Aretino, «Ben è conveniente,» disse, «inse-gnar
lxi [6.53]-[6.57] xix Allora la signora Emilia, «Or di questo adunque ragio-nate»
lxii [6.58]-[6.62] Rispose allor la signora Emilia: «Signor Unico, guardimiDio
lxiii [6.63]-[6.68] Allora il signor Unico, «Io,» disse, «non voglio altrimenti
lxiv [6.69]-[6.73] xx Allora messer Bernardo, interrompendo, «Certo è»
lxv [6.74]-[6.75] «E che cosa deve egli adunque fare?»
lxvi [6.76]-[6.85] Però, secondo me, quella via che deve pigliar il cortegiano
lxvii [6.86]-[6.91] Rispose il conte Ludovico: «Talor ancora l’essere pubblico
lxviii [6.92]-[6.94] Allora messer Bernardo, «Bisogna,» disse
[6.94] xxi Allor messer Federico, «Il parlar,» disse, «così minutamente
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 141
142 valeria guarna
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
lxix [6.95]-[6.99] Rispose il Magnifico: «Credo che que’ mezzi che vagliono
lxx [6.100]-[6.108] xxii Allora messer Cesare ridendo, «Io,» disse, «confesso
lxxi [6.109]-[6.114] Rise allora il conte Ludovico e disse: «Io vi prometto
[6.113] xxiii Voltossi allor il signor Gaspar a messer Cesare e disse: «Erameglio
lxxii [6.114]-[6.118] Rispose ridendo messer Cesare: «Per vostra fé
lxxiii [6.119]-[6.121] Allora il Magnifico, «Secondo me,» disse «per tener l’amor
lxxiv [6.122]-[6.132] xxiv Disse allor il signor Gasparo: «Un’altra causa publica
lxxv [6.133]-[6.135] Queste tai dolorose dimostrazioni son troppo vedute
lxxvi [7.1]-[7.4] Allor il signor Ottaviano ridendo, «Voi,» disse, «siete stato
lxxvii [7.5]-[7.9] «Certo è,» rispose il signor Ottaviano, «che oltre alle cose
LIBRO IV
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
i [1.1]-[1.6] i Pensando io di scrivere i ragionamenti che la quarta sera
ii [1.7]-[1.13] Questi adunque se vivuti fussero, penso che sariano giunti
iii [2.1]-[2.8] ii Parve adunque, secondo che ’l signor Gasparo Pallavicino
iv [2.9]-[2.14] Così, continuando il ragionamento di questi signori
v [2.15]-[2.19] iii Il fin adunque del perfetto cortegiano, del quale insino a qui
vi [2.20]-[2.25] Parmi ancora che le condicioni attribuite al cortegiano
vii [2.26]-[2.32] Da questo interviene che i signori, oltre al non intendere
viii [2.33]-[2.39] Ma se deliberassero di sapere e di far quello che debbono
ix [2.40]-[2.43] iv Dico adunque che, poiché oggidì i prìncipi son tanto
x [2.44]-[2.50] In questo modo per la austera strada della virtù potrà con-durlo
xi [3.1]-[3.8] v Taceasi il signor Ottaviano come se più avanti parlar
xii [3.9]-[3.16] vi Allor il signor Ottaviano, quasi ridendo, «Voi adunque
xiii [3.17]-[3.21] Però, come nell’altre arti, così ancora nelle virtù
xiv [3.22]-[3.24] Rispose allor il signor Gasparo: «Son però molti, i quali
[3.23] vii Disse il signor Ottaviano: «Il vero piacere è sempre bono
xv [3.25]-[3.29] Allora messer Pietro Bembo, «Non so,» disse
xvi [3.30]-[3.35] Rispose il signor Ottaviano: «In vero, messer Pietro
xvii [3.36]-[3.43] viii Seguitava ancor il signor Ottaviano il suo ragionamento
xviii [3.44]-[3.54] Allora messer Cesare Gonzaga, «Non so,» disse, «quai virtù
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 142
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 143
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
xix [4.1]-[4.5] ix Quivi avendo fatto il signor Ottaviano un poco di pausa
xx [4.6]-[4.12] Allora messer Pietro Bembo, «Ed a me par,» disse
xxi [4.13]-[4.18] x Allor il signor Ottaviano, «Contra la opinione vostra
xxii [4.19]-[4.26] Disse allor il signor Gaspar: «Ai discreti e virtuosi
xxiii [4.27]-[4.31] Son adunque li populi da Dio commessi sotto la custodia
xxiv [4.32]-[4.39] Aggiungendosi poi maggior potenzia al mal volere
xxv [4.40]-[5.5] xi Allor il signor Gaspar, «E qual,» disse, «di queste due
xxvi [5.6]-[5.9] xii Rise il signor Ottaviano e disse: «S’io avessi la grazia
xxvii [5.10]-[5.19] Però è ancor officio del bon principe instituire
xxviii [5.20]-[5.24] xiii Allor il signor Gaspar, «Volentieri,» disse
xxix [5.25]-[5.29] xiv Allor il signor Gaspar, «Signor Ottaviano,» disse
xxx [5.30]-[5.37] Disse il signor Gaspar: Prima che passiate più avanti
xv Allora la signora Emilia ridendo, «Non è ne’ patti,» disse
xxxi [5.38]-[5.40] Rispose il signor Ottaviano: «Molte altre cose, Signora
xxxii [5.41]-[5.46] Appresso gli mostrarei che delle cure
xxxiii [5.47]–-[5.53] Appresso li direi come dovesse amar la patria e i populi
xxxiv [5.54]-[5.59] Direi adunque che usar dovesse questi e molti altri rimedi
xxxv [5.60]-[5.62] Allor il signor Gaspar, «Penso io,» disse
xxxvi [5.63]-[5.75] Erano stati per bon spacio attentissimi al ragionamento
xxxvii [5.76]-[5.80] xvi Rispose allor il signor Ottaviano ridendo, «Quelli che non
xxxviii [5.81]-[5.86] Ma lassando gli antichi, qual più nobile e gloriosa
xxxix [5.87]-[5.91] xvii Suggiunse il signor Ottaviano: «Credo adunque che tali
xl [5.92]-[5.97] Però in questo, come nell’altre cose, bisogna sapere
xli [5.98]-[5.103] Sì che non chiamate, messer Cesare, per minuzia cosa
xlii [5.104]-[5.108] Allora messer Bernardo Bibiena ridendo, «Signor Ottaviano
xviii Allor il Frigio, «Or non più,» disse, «pregaremo Dio divedere
xliii [5.109]-[5.113] Quivi il signor Ottaviano, rivolto alla signora Duchessa
xliv [5.114]-[5.124] Quivi essendosi replicato un poco di ragionamento
xlv [5.125]-[5.129] xix Rise il signor Ottaviano e disse: «Signor Magnifico, piùlaude
xlvi [5.130]-[5.141] E perché, come già avemo detto, tali si fanno gli abiti
xlvii [5.142]-[5.151] E se non vorrete chiamarlo cortegiano, non mi dà noia
xlviii [5.152]-[5.154] xx Quivi essendosi fermato il signor Ottaviano di parlare
xlix [6.1]-[6.4] xxi Allora il signor Gaspar, «Ricordomi,» disse «che questi
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 143
144 valeria guarna
Cian Quondam nuova testo LdC1947 2000 paragrafatura
l [6.5]-[6.12] Disse messer Pietro Bembo: «Non vi ricorda, signor Gaspar
li [6.13]-[6.18] xxii Allora messer Pietro, avendo prima alquanto tacciuto
[6.13] «Signori per dimostrar che i vecchi possano
lii [6.19]-[6.29] Ma parlando della bellezza che noi intendemo
liii [6.30]-[6.35] La causa adunque di questa calamità negli animi umani
[6.34] xxiii Stando adunque questo prosuposito, il quale è verissimo
liv [6.36]-[6.40] Non è adunque fuor di ragione il dire ancor
lv [6.41]-[6.46] Quivi fece il Bembo un poco di pausa, quasi come per
lvi [6.47]-[6.49] xxiv Quivi messer Federico, per acquetar il signor Morello
lvii [6.50]-[6.54] Rise messer Pietro e disse: «Io voglio prima levar dell’ani-mo
lviii [6.55]-[6.63] I brutti adunque per lo più sono ancor mali e li belli
lix [6.64]-[6.68] Dassi adunque molta laude, non che ad altro, al mondo
lx [6.69]-[6.74] Allora messer Cesare: «Se è vero,» disse, «quello che
lxi [6.75]-[6.77] xxv Il Bembo pur cercava di por fine al ragionamento
[6.75] «Troppo infelice sarebbe la natura umana
lxii [6.78]-[6.87] xxvi Però quando qualche grazioso aspetto di bella donna
lxiii [6.88]-[6.90] Quivi il signor Morello, «Il generar,» disse
lxiv [6.91]-[6.99] Disse il Bembo: «Ben voglio io che assai più cortese
lxv [6.100]-[6.104] xxvii Stavano tutti attentissimi al ragionamento del Bembo
lxvi [6.105]-[6.112] L’amante adunque che considera la bellezza solamente
[6.110] xxviii Di questo modo sarà il nostro cortegiano non giovane fuo-ri di tutte
lxvii [6.113]-[6.118] Ma tra questi beni troveranno lo amante
lxviii [6.119]-[6.126] Quando adunque il nostro cortegiano sarà giunto
lxix [6.127]-[6.133] xxix Se adunque le bellezze, che tutto dì con questi nostri
lxx [6.134]-[6.144] xxx Qual sarà adunque, o Amor santissimo, lingua mortal
lxxi [7.1]-[7.4] xxxi Avendo il Bembo insin qui parlato con tanta veemenzia
lxxii [7.5]-[7.12] «Veramente,» disse la signora Duchessa, «se ’l cortegiano
[7.15] xxxii Allora ognuno si levò in piedi con molta maraviglia
lxxiii [7.13]-[7.19] Il signor Gaspar cominciava a prepararsi a rispondere
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 144
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 145
Abbreviazioni bibliografiche
Battaglia Ricci 2000 = Lucia Battaglia Ricci, Boccaccio, Roma, Salerno Editrice.Battaglia Ricci 2010 = Lucia Battaglia Ricci, Edizioni d’autore, copie di lavoro, interventi di autoese-
gesi: testimonianze trecentesche, in «Di mano propria». Gli autografi dei letterati italiani, Atti delConvegno internazionale (Forlì, 24-27 novembre 2008), a cura di Guido Baldassarri, MatteoMotolese, Paolo Procaccioli, Emilio Russo, Roma, Salerno Editrice, pp. 123-57.
Bertolo 1992 = Fabio Massimo Bertolo, Nuovi documenti sull’edizione principe del «Cortegiano»,«Schifanoia», 13-14, pp. 133-44.
Bond, Faye 1962 = William Henry Bond, Christopher Urdahl Faye, Supplement to the Census ofMedieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, New York, Bibliographi-cal Society of America.
Borsetto 1980 = Luciana Borsetto, Il «Libro del Cortegiano»: una codificazione del «re-citare», un emblema della scrittura, in La Corte e il «Cortegiano», i, La scena del testo, a cura di Carlo Ossola,Roma, Bulzoni, pp. 271-90.
Cataldi Palau 1998 = Annaclara Cataldi Palau, Gian Francesco d’Asola e la tipografia aldina. La vita,le edizioni, la biblioteca dell’Asolano, Genova, sagep.
Cavallo, Chartier 2009 = Storia della lettura nel mondo occidentale, a cura di Guglielmo Cavallo eRoger Chartier, Roma-Bari, Laterza.
Chartier 2000 = Roger Chartier, La pluma, el papel y la voz, in Imprenta y crítica textual en el Siglode Oro, estudios publicados bajo la dirección de Francisco Rico, Valladolid, Centro para la Edición de los Clásicos españoles, pp. 243-57.
Cian 1887 = Vittorio Cian, Pietro Bembo e Isabella d’Este Gonzaga, gsli, 9, pp. 81-136.Cian 1894 = Il Cortegiano del conte Baldesar Castiglione, annotato e illustrato da Vittorio Cian, Fi-
renze, Sansoni.Cian 1942 = Vittorio Cian, La lingua di Baldassarre Castiglione, Firenze, Sansoni.Cian 1947 = Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, a cura di Vittorio Cian, Firenze,
Sansoni, 19474.Cian 1951 = Vittorio Cian, Un illustre nunzio pontificio del Rinascimento: Baldassar Castiglione, Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana.Cursi 2007 = Marco Cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo, Roma, Viella.Delisle 1886 = Leopold Delisle, Notice sur des manuscrits du fonds Libri conservés à la Laurentienne,
in Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, xxxii, p. i, Paris, Imprimerie nationale, pp. 51-53.
Diels 1879 = Doxographi Graeci, collegit, recensuit, prolegomenis indicibusque instruxit Hermann Diels, Berolini, Reimeri.
Fahy 2005 = Conor Fahy, Pietro Bembo correttore delle bozze del «Cortegiano»?, «La Bibliofilia», ciii,3, pp. 243-52.
Fryde 1996 = Edmund Boleslaw Fryde, Greek manuscripts in the private Library of the Medici (1469-1510), Aberystwyth, The National Library of Wales.
Ghinassi 1963 = Ghino Ghinassi, L’ultimo revisore del «Cortegiano», sfi, 21, pp. 217-64.Ghinassi 1967 = Ghino Ghinassi, Fasi dell’elaborazione del «Cortegiano», sfi, 25, pp. 155-96.Ghinassi 1971 = Ghino Ghinassi, Postille sull’elaborazione del «Cortegiano», spct, 3, pp. 171-78.Gorni 1994 = Guglielmo Gorni, Il «copyright» della «Vita Nuova», rili, 12, pp. 481-90.Gorni 1995a = Guglielmo Gorni, “Paragrafi” e titolo della «Vita Nova», sfi, 53, pp. 203-22.Gorni 1995b = Guglielmo Gorni, Ancora sui paragrafi, rili, 13, pp. 537-62.Harris 2009 = Neil Harris, Il «Polifilo»: la cecità che non si vede, «Discipline del libro», ii, consulta-
bile all’indirizzo http://libroantico.uniud.it/discipline/disci2/d2harris.html.Hoffmann 1985 = Philippe Hoffmann, Un mystérieux collaborateur d’Alde Manuce: l’Anonymus
Harvardianus, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps Modernes», 97, 1,pp. 45-143.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 145
146 valeria guarna
Hoffmann 1986 = Philippe Hoffmann, Autrees données relatives à un mystérieux collaborateur d’AldeManuce: l’Anonymus Harvardianus, «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge,Temps Modernes», 98, 2, pp. 673-708.
Kavrus-Hoffman 2010 = Nadezhda Kavrus-Hoffman, Catalogue of Greek Medieval and RenaissanceManuscripts in Collections of the United States of America, part v.1: Harvard University, The Houghton Library, «Manuscripta», 54, 2, pp. 207-74.
La Rocca 1980 = Guido La Rocca, Un taccuino autografo per il «Cortegiano», imu, 23, pp. 341-73.Maier 1953 = Bruno Maier, Sul testo del «Cortegiano», gsli, 130, pp. 226-48.Malagnini 2003 = Francesca Malagnini, Il sistema delle maiuscole nell’autografo berlinese del «Deca-
meron» e la scansione del mondo commentato, sb, 31, pp. 31-69.Maraschio 1993 = Nicoletta Maraschio, Grammatici e correttori: le regole e la prassi editoriale, in Sto-
ria della lingua italiana, i, a cura di Luca Serianni e Pietro Trifone, Torino, Einaudi, pp. 183-94.McKenzie 1986 (1999) = Donald Francis McKenzie, Bibliografia e sociologia dei testi, Milano,
Bonnard, 1999 (ed. orig. Bibliography and the Sociology of Texts, London, British Library, 1986).McLeod 2000 = Randall McLeod, Where angels fear to read, in Ma(r)king the Text: The Presentation
of Meaning on the Literary Page, ed. by Joe Bray, Miriam Handley, Anne C. Henry, Aldershot,Ashgate, pp. 144-92.
Moraux 1976 = Paul Moraux, Aristoteles Graecus: d. griech. Ms. d. Aristoteles, i, Berlin, de Gruyter.Motta 2003 = Uberto Motta, Castiglione e il mito di Urbino. Studi sulla elaborazione del «Cortegiano»,
Milano, Vita e Pensiero.Mozzarelli 1997 = Cesare Mozzarelli, rec. a Peter Burke, Le fortune del «Cortegiano». Baldassarre
Castiglione e i percorsi del Rinascimento europeo, trad. di Annalisa Merlino, Roma, Donzelli, 1998,«Annali di storia moderna e contemporanea», 3, pp. 529-32.
Mutini 1979 = Claudio Mutini, Castiglione, Baldassarre, in dbi, 22, pp. 53-68.Nocita 1999= Teresa Nocita, Per una nuova paragrafatura del testo del «Decameron». Appunti sulle
maiuscole, ct, 2, pp. 925-34.Ordine 1992 = Nuccio Ordine, Giovan Francesco Valier, homme de lettres et espion au service de Fran-
çois Ier, in La circulation des hommes et des oeuvres entre la France et l’Italiè à l’époque de la Renais-sance, Paris, Université de la Sorbonne nouvelle, pp. 225-46.
Padoan 1978 = Giorgio Padoan, Momenti del Rinascimento veneto, Padova, Antenore.Quondam 1983 = Amedeo Quondam, La letteratura in tipografia, in Letteratura italiana, Produzione
e consumo, ii, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, pp. 555-686.Quondam 1999 = Amedeo Quondam, La nascita del «Cortegiano»: prime ricognizioni sul manoscritto
autografo, nrili, 11, pp. 423-41.Quondam 2000 = Amedeo Quondam, «Questo povero Cortegiano». Castiglione, il Libro, la Storia,
Roma, Bulzoni.Quondam 2002 = Baldassarre Castiglione, Il Cortigiano, a cura di Amedeo Quondam, tt. 2,
Milano, Mondadori.Quondam 2004 = Amedeo Quondam, discussione in Foro. Forme e sostanze: «Il Cortigiano» di
Amedeo Quondam, «Ecdotica», 1, pp. 192-209.Renouard 1834 = Antoine Augustin Renouard, Annales de l’imprimerie des Alde, ou histoire des trois
Manuce et des leurs éditions, troisième éd., Paris, chez Jules Renouard libraire.Rico 2004 = Francisco Rico, discussione in Foro. Forme e sostanze: «Il Cortigiano» di Amedeo Quon-
dam, «Ecdotica», 1, pp. 172-78.Ridolfi 1949 = Roberto Ridolfi, Proposta di ricerche sulle stampe e sugli stampatori del Quattrocento,
«La Bibliofilia», 51, pp. 2-9.Russell 2010 = Eugenia Russell, Two Greek excerpts by Johannes Cuno (1463-1513) in London Arundel
550, «Renaissance Studies», 224, pp. 472-81.Saffrey 1971 = Henri-Dominique Saffrey, Un humaniste dominicain, Jean Cuno de Nuremberg,
précurseur d’Érasme a Bâle, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 33, pp. 19-62.Sicherl 1978 = Martin Sicherl, Johannes Cuno. Ein Wegbereiter des Griechischen in Deutschland, Hei-
delberg, Winter-Universitatsverlag.
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 146
per una nuova paragrafatura del «libro del cortegiano» 147
Sicherl 1985 = Martin Sicherl, Neue Handschrift J. Cunos, in Annuaire. Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, pp. 141-48.
Sicherl 1997 = Martin Sicherl, Griechische Erstausgaben des Aldus Manutius. Druckvorlagen, Stellen-wert, kultureller Hintergrund, Paderborn, Ferdinand Schöningh.
Sorella 2006 = Antonio Sorella, La vulgata nella tipofilologia: due casi esemplari, «Filologia Italiana»,3, pp. 155-72.
Speranzi 2007 = David Speranzi, Per la storia della libreria medicea privata. Giano Lascaris, Sergio diZollino e il copista Gabriele, imu, 48, pp. 76-111.
Torraca 1961 = I dossografi greci, trad. da Luigi Torraca, Padova, cedam.Trifone 1993= Pietro Trifone, La lingua e la stampa nel Cinquecento, in Storia della lingua italiana, i,
a cura di Luca Serianni, Pietro Trifone, Torino, Einaudi, pp. 425-46.Trovato 1989 (1998) = Paolo Trovato, Per un censimento dei manoscritti di tipografia in volgare (1470-
1600), in Il libro di poesia dal copista al tipografo, Atti delle Giornate di Studio (Ferrara, 29-31 maggio 1987), a cura di Amedeo Quondam e Marco Santagata, Modena, Panini, 1989, pp. 43-81, poi col titolo Manoscritti volgari in tipografia in Trovato 1998, pp. 175-96, da cui si cita.
Trovato 1991 = Paolo Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testiletterari italiani (1470-1570), Bologna, il Mulino.
Trovato 1998 = Paolo Trovato, L’ordine dei tipografi. Lettori, stampatori, correttori tra Quattro e Cinquecento, Roma, Bulzoni.
Trovato 2004 = Paolo Trovato, discussione in Foro. Forme e sostanze: «Il Cortigiano» di AmedeoQuondam, «Ecdotica», i, pp. 157-64.
Zumthor 1987 (1990) = Paul Zumthor, La lettera e la voce. Sulla «letteratura» medievale, Bologna, ilMulino, 1990 (ed. orig. La lettre et la voix. De la “littérature” médiévale, Paris, Le Seuil, 1987).
Filologia Italiana_10_2013.qxp_Impaginato 17/04/14 13:20 Pagina 147