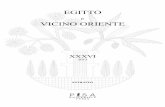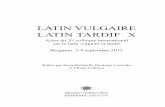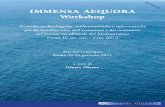Emozioni e osservazioni davanti alla “Madonna del parto” di Piero della Francesca
Emozioni e organizzazioni: Sistemi affettivi di base e sentimenti in alcuni contesti emotivi...
Transcript of Emozioni e organizzazioni: Sistemi affettivi di base e sentimenti in alcuni contesti emotivi...
Emozioni e organizzazioni
REPORT DELLA RICERCA
Laboratorio a cura di Emanuela Fellin e Luca Mori per il Corso di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni del Prof. Ugo Morelli
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
2
Autori della ricerca
Studenti:
PATRICIA ANITA AIROLDI, DENISE ALARI, ILARIA BARBETTA, CHIARA BELLINI, GIULIANA BERETTA, LUCA BONFANTI, GIULIA BORDIGA, CATERINA BORGHETTI, FEDERICA BOTTI, ANDREA BUITURINI,
NICOLA CAROZZI, MARTINA CATTANEO, MARTA CAVAGNA, SARA COPPIN, GIULIA CORNETTI, ALESSIA DIANI, GIUSEPPE DONADONI, VALENTINA FEDRIGHINI, ELENA GAMBIRASIO, MICHELA
GRITTI, ILARIA INVERNIZZI, CRISTINA MARIA IONESCU, ANNA LOMASSI, SARA MALVESTITI, TOMMASO MANDELLI, LAURA MARCHETTI, ANTONELLA MELESI, MANUELA MOLTENI, MARTA MOSCONI, LORENZO NADOTTI, CHIARA PAGANI, ROBERTA PARMA, CRISTINA PATELLI, GIORGIA
PEDRONCELLI, MARTA PEZZOTTA, CHIARA PILENGA, JENNY PROVENZI, MARCO QUITADAMO, PAOLA RAGNOLI, SIMONA RICCARDI, LETIZIA RONZONI, FEDERICA ROTA, VALENTINA SALVI, FRANCESCO SAVELLI, BEATRICE SCARPELLINI, DALILA VALENTINA SCOTTI, MASSIMO SPAMPATTI, FEDERICA TIZZONI, IDA TODARO, ALFREDO TRATTELLI, MICAELA VENEZIANO, LETIZIA VESCOVI, LUANA
VOLPE, MARCO ZANI, GRETA ZILIATI.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
3
Indice
Premessa 4 Introduzione 6 Stato dell’arte (una prima e molto provvisoria ricognizione)
7
La nostra domanda di ricerca e le nostre ipotesi 10 Metodologia 10 Limiti metodologici ed errori emersi nell’elaborazione dei dati
13
Risultati distinti e comparati per sesso 14 Sistemi affettivi di base / Esame 14 Sistemi affettivi di base / Pause 17 Sistemi affettivi di base / Lavori di gruppo 19 Sistemi affettivi di base / Lezioni 21 Differenziale semantico/Sentimenti/Esami 23 Differenziale semantico/Sentimenti/Pause 27 Differenziale semantico/Sentimenti/Lavori di gruppo 30 Differenziale semantico/Sentimenti/Lezioni 33
Risultati complessivi (237 questionari validi) 36 Prima parte del Questionario 36 Seconda parte del Questionario 40
Conclusione 45 Appendice 47
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
4
Premessa
La ricerca riguarda l’attivazione dei sistemi affettivi di base (secondo il modello di Jaak Panksepp, cfr. J. Panksepp, L. Biven, Archeologia della mente. Origini neuroevolutive delle emozioni umane, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 2014) e dei “sentimenti” correlati in alcuni contesti emozionali ritenuti particolarmente rappresentativi dell’organizzazione “Università”.
Il lavoro di Panksepp viene qui adottato in quanto permette di trattare un tema scivoloso e controverso – già sul piano della terminologia – come quello dei sentimenti e degli affetti, distinguendo e al tempo stesso correlando le attività neurali di base – con i sistemi emozionali di base che condividiamo con gli altri mammiferi (ricerca, paura, collera, desiderio sessuale, cura, panico/sofferenza, giocosità) – il processo secondario dei primi apprendimenti e i processi terziari che coinvolgono le funzioni cognitive e riflessive più complesse, assieme all’elaborazione dei sentimenti.
Il saggio curato da Stephen Fineman sull’emotional organization (S. Fineman, a cura di, Le emozioni nell’organizzazione. Il potere delle passioni nei contesti organizzativi, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 2009) viene invece tenuto presente in quanto suggerisce un approccio allo studio delle organizzazioni come “arene emotive”. Tralasciando la discussione sull’appropriatezza del termine “arena”, ci concentriamo su un’organizzazione (l’Università) individuandone come oggetto di ricerca quattro scene emotive, riconducibili a tipologie di luoghi (aule, spazi per la socializzazione informale, ecc.) e soprattutto a tipologie di esperienze: esami, lezioni, lavori di gruppo (o altre occasioni di collaborazione formale o informale tra pari) e pause dalle lezioni.
Una precisazione preliminare riguardo all’approccio di Panksepp: egli utilizza il
termine «affetto» per indicare la natura primaria, di base, delle sensazioni legate alle emozioni: «Abbiamo scoperto che le antiche regioni sottocorticali del cervello dei mammiferi contengono almeno sette sistemi affettivi di base: qui ci riferiamo a questi sistemi come RICERCA (attesa), PAURA (ansia), COLLERA (rabbia), DESIDERIO SESSUALE (eccitazione sessuale), CURA (accudimento), PANICO/SOFFERENZA (tristezza), GIOCO (gioia sociale)» (Panksepp, Biven 2014, p. IX). Per “processo primario” egli intende un’attività neurale di base, espressa da particolari strutture cerebrali, evolutivamente antiche: i processi primari pertanto, situati profondamente nell’encefalo lungo la linea mediana, “istruiscono” i sistemi funzionali successivi, quelli che Panksepp distingue come processi secondari (i primi apprendimenti nelle relazioni soggetto-ambiente) e terziari (funzioni cognitive e riflessive, elaborazione dei sentimenti possibili grazie all’evoluzione della neocorteccia). I sette sistemi affettivi individuati come primari sono per così dire la base dei molteplici flussi emotivi e delle «emozioni di livello superiore»: più precisamente: «Molteplici flussi emotivi possono attraversare la mente pensante, andando a creare un’enorme varietà di emozioni di livello superiore che sono spesso oggetto d’interesse degli psicologi – orgoglio, vergogna, sicurezza, colpa, gelosia, fiducia, disgusto, predominio e via dicendo, con centinaia di possibili varianti. Tuttavia, senza una visione chiara dei processi primari, l’importante lavoro sui processi superiori rimane profondamente incompleto» (ivi, p. X).
Riguardo ai possibili utilizzi della sua teoria, lo stesso Panksepp ne evidenzia alcuni. Ecco un esempio che chiama in causa il management organizzativo: «Certi tipi di stili emotivi sembrano funzionare meglio in ruoli e ambienti specifici. Ogni manager ha bisogno di guadagnarsi la fiducia e il rispetto dei propri dipendenti.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
5
Questi ultimi dovrebbero sentire che il manager è in grado di aiutarli nei loro problemi sul lavoro, e i manager dovrebbero essere sicuri che i dipendenti si assumeranno le loro responsabilità. Questo contratto sociale implicito è costruito sulla reciprocità del sistema della CURA. Devono garantirsi l’un l’altro ciò di cui essi hanno bisogno per sentirsi sicuri e per eccellere. I manager riconoscono inoltre l’importanza della coesione del gruppo. Giorni dedicati al gruppo possono supportare questo processo incoraggiando uno spirito di GIOCO, per mezzo del quale i membri di un gruppo di lavoro allargato condividono l’opportunità di interagire con maggiore intimità e in maniera più rilassata. Questo tipo di interazione giocosa rinsalda i legami sociali che sono importanti per la solidarietà del personale» (ivi, p. XX).
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
6
Introduzione Nelle pagine iniziali del suo libro dedicato a L’errore di Cartesio, il neuroscienziato portoghese Antonio Damasio racconta un tragico incidente accaduto nell’estate del 1848 nel New England a Phineas P. Gage, caposquadra di un’impresa di costruzioni. Dovendo far saltare una parete di roccia, per una fatale distrazione inizia a pestare con una barra di ferro la polvere da sparo non ancora ricoperta dalla sabbia, provocando un’esplosione. La barra metallica gli fora la base della scatola cranica, attraversa la parte frontale del cervello ed esce dalla sommità della testa.
Gage guarì in meno di due mesi: continuava ad apparire perfettamente “razionale”, capace di parlare e camminare e di mantenersi in equilibrio. Ma i suoi gusti, la personalità, il carattere, le aspirazioni cambieranno. Nuovo “spirito” che anima il corpo? L’equilibrio tra la sua facoltà intellettiva e le sue disposizioni animali era stato distrutto: infatti appariva bizzarro, insolente, capace di grossolane imprecazioni, poco riguardoso nei confronti dei suoi compagni, insofferente dei vincoli o consigli che contrastassero i suoi desideri. Pronto a pianificare programmi futuri che poi abbandonava non appena li aveva programmati. Damasio utilizza il caso per evidenziare come i “legami” che ci permettono di entrare in relazione con gli altri e di essere riconosciuti come “razionali” non sono basati su una qualche razionalità pura e disincarnata, essendo in modo eminente legami emotivi; in altri termini, il piano cognitivo e quello emotivo delle nostre esistenze sono profondamente integrati. Damasio prosegue esponendo le ricerche che lo portano ad esplorare la «neurobiologia della razionalità» e a sostenere che alcuni deficit nella reattività emotiva e nel sentimento (per la lesione di aree cerebrali coinvolte su questi piani) possono compromettere il ragionamento anche laddove siano preservati il linguaggio, l’attenzione, la memoria operativa e le capacità basilari del ragionamento logico. Dal caso di Gage e da altri esempi, Damasio ricava che l’uomo è un «organismo non dissociabile» composto di cervello e corpo (p. 24), in cui emozione e ragionamento sono inestricabilmente legati.
Assumendo queste indicazioni della ricerca contemporanea, possiamo chiederci: quanto ne tengono conto le organizzazioni in cui gli esseri umani lavorano e apprendono?
Nel libro Le emozioni nell’organizzazione, curato da Stephen Fineman, gli autori propugnano un cambiamento di prospettiva sul nostro modo di comprendere le emozioni: da esperienze ideologicamente neutrali, interne all’individuo, a esperienze solidamente determinate dalle strutture sociali, e dalle norme e dai valori dell’organizzazione. Quindi le emozioni sono prodotti sociali, condizionate da imperativi culturali che dettano le regole sociali, che stabiliscono quello che si deve provare e quello che si deve esprimere.
Ci si sta «rendendo sempre più conto che siamo animali linguistici, siamo sempre all’interno del linguaggio anche quando apparentemente ci riferiamo a dimensioni non linguistiche della relazione con l’altro per descriverlo forzatamente dobbiamo tradurre queste esperienze in un linguaggio verbale. Espressioni verbali, frasi, parole, aggettivi per descrivere una configurazione interna del nostro corpo per descrivere un particolare modo di esprimere questo stato del nostro corpo in termini di atteggiamento posturale, forma vitale come avrebbe detto Stern quindi il contorno emozionale dei nostri movimenti, la prosodia […]» (Vittorio Gallese, per il Premio Musatti 2014, tra psicoanalisi e neuroscienze, trascrizione).
La valutazione sociale e la nostra esigenza di comunicare ciò che sentiamo producono emozionologie e le diffondono, come discorsi in cui trova espressione la posizione della società in relazione al modo in cui le emozioni vanno indirizzate e certi sentimenti vanno espressi.
Le emozionologie regolano i comportamenti degli individui e i loro sentimenti all’interno di quelle arene emotive che secondo Stephen Fineman sono le organizzazioni, dove le emozioni
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
7
vengono rappresentate a favore di un pubblico che di volta in volta si desidera influenzare, stupire, allarmare. Le emozionologie sono discorsi sulle emozioni che modificano i nostri modi di sentirle, quindi i nostri sentimenti che indicano l’esperienza privata e sono di livello superiore rispetto all’emozioni.
Stato dell’arte (una prima e molto provvisoria ricognizione)
La letteratura su emozioni e organizzazioni è molto ampia soprattutto in lingua inglese e spazia dagli studi prevalentemente impostati secondo il modello della ricerca scientifica accademica a quelli “divulgativi”, fino a quelli più o meno esplicitamente orientati ad un certo tipo di “consulenza” aziendale. A partire dagli anni Novanta del XX secolo, in particolare, si sono diffusi approcci chiaramente impostati in tal senso, dove il riferimento alle emozioni intese come elementi chiave è chiaro.
A titolo di esempio, si consideri il modello del Great Place to Work® Institute (www.greatplacetowork.net). Dal sito dell’Istituto ricaviamo la seguente definizione generale: «Great workplaces are built through the day-to-day relationships that employees experience — not a checklist of programs and benefits. The key factor in common in these relationships is TRUST. From the Employee’s perspective, a great workplace is one where they: TRUST the people they work for; Have PRIDE in what they do; and ENJOY the people they work with». In queste righe notiamo il riferimento alla gioia e all’orgoglio, facilmente correlabili ad alcuni sistemi emozionali di Panksepp e ad altri modelli delle emozioni di base, e alla fiducia, che ha a che fare con la cura e il riconoscimento: «Trust is the defining principle of great workplaces — created through management’s credibility, the respect with which employees feel they are treated, and the extent to which employees expect to be treated fairly. The degree of pride and levels of authentic connection and camaraderie employees feel with one are additional essential components». La camaraderie potrebbe poi essere messa in relazione alla “giocosità” di Panksepp intesa come gioia sociale, provata nell’interazione giocosa con gli altri, in modo tale da prevedere anche prossimità e contatto fisico. Naturalmente, avendo come obiettivo primario la valutazione e la consulenza proposte alle organizzazioni, l’Istituto elabora poi un modello a mo’ di ricetta, individuando in particolare nove vie (o aree di pratica) attraverso cui la leadership e il management possono creare un “ambiente di fiducia”: «Great workplaces achieve organizational goals by inspiring, speaking and listening. They have employees who give their personal best by thanking, developing and caring. And they work together as a team / family by hiring, celebrating and sharing. This fundamental model, confirmed by Great Place to Work through over 25 years worth of analysis of employees’ own opinions, is universal and consistent year-over-year, country-to-country. It applies not only to all organizations but to companies with diverse employee demographics». Un’altra tesi di fondo dell’Istituto consiste nel sostenere che la “fiducia” può essere misurata e nel proporre, al riguardo, uno strumento (the Trust Index® survey), modellato secondo le cinque dimensioni evidenziate nella definizione generale del “great workplace”. Le “nove aree” di pratica costituiscono invece la premessa per un programma di auditing definito Culture Audit®.
Un altro approccio che gode da tempo di buona fortuna – anche commerciale – è quello sviluppato a partire dai lavori di Daniel Goleman sull’«intelligenza emotiva». Cfr., per un’applicazione del concetto all’analisi e alla consulenza organizzativa, il volume a cura di Cary Cherniss e Daniel Goleman (eds.), The Emotionally Intelligent Workplace. How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 2001, dove tra gli assunti del lavoro compare il seguente: «The essence of his findings can be summed up fairly simply. Emotional intelligence (EI), more than any other asset,
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
8
more than IQ or technical expertise, is the most important overall success factor in careers. And the higher one’s posi- tion in an organization, the more important EI is; EI accounts for 85 to 90 percent of the success of organizational leaders» (p. XV).
È interessante qui quanto scrive Cary Cherniss (Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness, pp. 3-12) a proposito del fatto che il concetto stesso di «intelligenza emotiva» resta controverso: «Although psychologists have been studying aspects of emotional intelligence in organizations for decades (without using that term), the concept as it is now understood is relatively new. There still is much that is unclear about the nature of emotional intelligence, the way in which it should be measured, and its impact on individual performance and organizational effectiveness. In some cases this lack of clarity has led to conflict and controversy among researchers and practitioners» (p. 9); «One of the most basic controversies involves the definition of the concept itself» (ibidem). Ecco un modello riassuntivo che viene tuttavia proposto (p. 8):
I due approcci esemplificati sopra sono caratterizzati da un forte orientamento alla consulenza organizzativa e alla misurazione di variabili ambientali e relazionali ritenute rilevanti per la descrizione dei fenomeni considerati. Esiste però un mare magnum di studi che non puntano alla stesura di un modello da proteggere come Trademark né alla confezione di ricette generalizzabili e applicabili ovunque, ma indagano la vita emotiva delle/nelle organizzazioni cercando di apprenderne qualcosa attraversandone molteplici livelli, con metodi di ricerca e osservazione differenti. Un esempio in tal senso è lo stesso lavoro di Fineman, già citato. Cfr. anche, per esempio, Neal M. Ashkanasy, Cary L. Cooper (eds.), Research Companion to Emotion in Organizations, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA, USA) 2008: si tratta di un lavoro che passa dall’analisi di emozioni e affetti come fenomeni intrapersonali con differenze individuali, all’analisi degli effetti emozionali nelle interazioni diadiche, passando poi al livello dei gruppo e a quello delle organizzazioni.
Cfr. anche, per esempio: Wilfred J. Zerbe, Neal M. Ashkanasy, Charmine E. J. Härtel (eds.), Individual and Organizational Perspectives on Emotion Management and Display, Elsevier, Oxford 2006; Wilfred J. Zerbe, Neal M. Ashkanasy, Charmine E. J. Härtel (eds.), The Effect of Affect in Organizational Settings, Elsevier JAI, Boston – Amsterdam 2005: qui le emozioni vengono studiate in relazione ad eventi, commitment, distanza dall’obiettivo, aspettative, sforzi e velocità richieste, clima organizzativo, solitudine/isolamento, equità, percezione sociale, fasi di cambiamento organizzativo e così via.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
9
Nell’immensa bibliografia sull’argomento, non mancano i titoli italiani. Facciamo alcuni esempi,
associando ad alcune pubblicazioni le descrizioni sintetiche, che danno un’idea dell’approccio al tema e di quanto sia “scivoloso”.
Il libro Amore e paura nelle organizzazioni. L’organizzazione intelligente per il benessere (di R. Gallo, P. Erba, per Franco Angeli, Milano) considera le emozioni fondamentali dell’amore e della paura come parte di una schiera di molte altre che governano la vita organizzativa. Questo libro vuole offrire alcune chiavi di lettura della vita organizzativa e vuole essere una testimonianza (come una voce dalle organizzazioni), su ciò che muove la vita organizzativa ed è anche una proposta di riconoscimento e di utilizzo delle emozioni, di questo "bene prezioso" di cui siamo tutti dotati dalla nascita, per individuare una via al benessere nelle organizzazioni.
Il libro Lavorare con l’ansia. Costi emotivi nelle moderne organizzazioni (di M. Perini, per Franco Angeli, Milano) evidenzia che l’ansia va considerata come un sentimento normale, a dosi sostenibili persino utili e adattivo. Però oggi nel mondo del lavoro e delle organizzazione ne bisogna sopportare troppa, troppo a lungo e su troppi fronti simultaneamente. Anche se non si promettono soluzioni, in questo libro sono descritti i modi e i presupposti che possono offrire a consulenti e manager l'opportunità di dare ai loro clienti colleghi e collaboratori un aiuto prezioso: quello di sostenere nel loro percorso di ricerca le persone che vogliono diventare consapevoli dei proprio problemi e trovare un modo per risolverli.
Dalla quarta di copertina del libro Il capitalismo delle emozioni (Al cuore della competitività delle imprese, Franco Angeli, Milano 2009), apprendiamo addirittura che la ricerca condotta da ottobre 2008 a febbraio 2009 presso Salone d’Impresa «ha evidenziato un fattore fino ad oggi sconosciuto nella letteratura e nella pratica aziendale: ovvero l’importanza che le emozioni giocano sul singolo, sul gruppo e sull'impresa stessa». Ora, se pensiamo a come la nozione di “essere umano”, “gruppo” e “organizzazione” è stata trattata dal pensiero filosofico classico, dell’importanza delle emozioni, delle passioni o degli affetti che dir si voglia è oggetto di suggestive discussioni da diversi secoli, in modo tutt’altro che trascurabile (vedi quanto abbiamo riportato sopra a proposito dello Spinoza citato da Damasio). Sorvolando su ciò, vediamo poi che nel libro si parla di merci emozionali e di homo palpitans, di “forza delle emozioni” e della “persona al centro”: «Il bisogno di emozioni e il desiderio di contatto con le proprie emozioni, che caratterizza le nuove soggettività ed identità, contribuiscono di fatto all’ampliarsi e al rafforzamento di questo nuovo mercato. Nel mercato globalizzato uno spazio sempre più ampio e privilegiato viene dato alle merci emozionali. Caduto l’uomo pubblico, quello che fondò il primo mercato capitalista e le prime democrazie, proprio a partire dall'essere “un insieme di privati che si costituiva come pubblico”, si afferma “l’homo palpitans” che fonda il nuovo mercato delle emozioni e che trasforma la sfera pubblica e la democrazia nel luogo della contrapposizione fra privatismi e del coinvolgimento emotivo. In questo volume, frutto del VII Salone d’Impresa, Il Capitalismo delle Emozioni, imprenditori, manager, politici, docenti universitari, policy maker si confrontano con una modalità di essere impresa che intende riportare al centro la persona: la strada maestra per affrontare con successo la crisi di cui oggi soffrono società e aziende. La forza delle emozioni: questo è il nuovo elemento che sta trainando le nostre imprese». Di altri approcci troviamo un resoconto nella rivista Meta (Rivista dei consulenti di management,
numero 10, ottobre 2013). M. Perini (Organizzazioni, emozione e consulenza: il lato umano del cambiamento, p. 2) cita insieme «il popolare libro di Goleman sull’intelligenza emotiva e gli acuti stimoli offerti dalle ricerche del Tavistock sull’intelligenza delle emozioni (David Armstrong)», evidenziando che nonostante tali studi «il mondo del lavoro continua a temere e a volte ad ignorare le sue zone d’ombra mantenendo viva l’illusione della razionalità. Concetti quali l’ascolto e la comprensione, che paiono prelevati direttamente dalla sfera dei processi psicologici e in particolare dall’ambito delle cure, permettono forse una ridefinizione “umanistica” dell’organizzazione che si riveli capace di conciliare le esigenze della produttivita e quelle dell’individuo, che si proponga di
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
10
“prendersi cura” della persona e che possa riallineare almeno in parte le esigenze dei clienti esterni con quelle delle donne e degli uomini dell’organizzazione?».
Manfred Kets de Vries (intervistato per la rivista, p. 5), alla domanda su quali competenze debba avere un consulente “non psicologo” sulle emozioni, risponde: «Un buon consulente conosce bene le dinamiche psicologiche. I Partner delle grandi società di consulenza hanno raggiunto tale posizione anche per questa competenza, pur non avendo quel titolo: sanno come fare domande giuste e dare aiuto. O hai questa abilità o in genere non avrai successo nei progetti. Il punto di partenza per sviluppare la leadership, come è scritto nel famoso tempio di Apollo a Delfi, è “Conosci te stesso”; ti devi occupare delle tue emozioni e delle tue questioni problematiche. Inoltre devi capire che le persone non la pensano sempre come te o che ad alcune persone potresti non piacere, è una questione di empatia e non solo. Queste competenze non si leggono solo sui libri, si acquisiscono attraverso un processo di analisi del sé e di apprendimento dall’esperienza».
NOTA: di David Armstrong cfr. R. French (ed.), Organization in the Mind: Psychoanalysis,
Group Relations and Organizational Consultancy, Karnac Books 2005. Inoltre C. Huffington, W. Halton, D. Armstrong, J. Pooley (eds.), Working Below the Surface: The Emotional Life of Contemporary Organizations, Karnac Books 2004
La nostra domanda di ricerca e le nostre ipotesi Conclusasi la parte teorica trattata nella prima fase del laboratorio, abbiamo iniziato a costruire il nostro reattivo, ricercando le arene emotive all’interno dell’Università degli studi di Bergamo, luogo organizzativo e carico di vissuti emotivi. Il fine della nostra domanda di ricerca è individuare quali delle sette aree emozionali di base di Panksepp sono più presenti nelle arene emotive e se c’è una congruenza tra le emozioni provate e i sentimenti manifestati.
La ricerca riguarderà l’attivazione dei sistemi emozionali/affettivi di base (secondo il modello di Jaak Panksepp) in alcuni contesti emozionali ritenuti particolarmente rappresentativi dell’organizzazione Università. Come detto nella Premessa, il lavoro di Panksepp viene adottato in quanto permette di trattare un tema scivoloso e controverso – già sul piano della terminologia – come quello dei sentimenti e degli affetti, distinguendo e al tempo stesso correlando le attività neurali di base – con i sistemi emozionali di base che condividiamo con gli altri mammiferi (ricerca, paura, collera, desiderio sessuale, cura, panico/sofferenza, giocosità) – il processo secondario dei primi apprendimenti e i processi terziari che coinvolgono le funzioni cognitive e riflessive più complesse, assieme all’elaborazione dei sentimenti (cfr. Panksepp, Biven 2014).
Il saggio di Fineman sull’emotional organization (Fineman 2009) viene invece tenuto presente in quanto suggerisce un approccio allo studio delle organizzazioni come “arene emotive”. Individuaimo nell’Università quattro scene emotive, riconducibili a tipologie di luoghi (aule, spazi per la socializzazione informale, ecc.) e soprattutto a tipologie di esperienze: esami, lezioni, lavori di gruppo, pause dalle lezioni.
Distinte tali scene emotive, formuliamo alcune ipotesi di ricerca.
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “ESAME”
Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: paura Intensità: abbastanza Ipotesi sul sistema affettivo meno attivato: giocosità, piacere Intensità: per nulla
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
11
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “PAUSE DALLE LEZIONI”
Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: giocosità Intensità: abbastanza Ipotesi sul sistema affettivo meno attivato: paura Intensità: per nulla
Qui si introduce un’ipotesi sul sistema affettivo della cura, che potrebbe far riflettere l’intervistato sul fatto che durante la pausa ci si prende cura di sé attraverso la socializzazione e il distacco temporaneo dalla didattica. Si ipotizza inoltre che potrebbe comparire il dolore/sofferenza, seppur con una bassa frequenza e intensità, ipotizzando il pensiero di situazioni di esclusione dal gruppo dei pari. Inoltre si ipotizza la presenza della rabbia (bassa intensità, poco) pensando a situazioni di sfogo emotivo (es. fallimento relativo a un esame)
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “LAVORO IN GRUPPO”
Su questo punto non si riescono a individuare in modo netto sistemi affettivi più attivati o assenti. La scena è vista come un’arena emotiva dove convivono tutti i sistemi emotivi citati, poiché è una situazione in cui emergono le diverse caratteristiche individuali riguardanti sia l’aspetto della socializzazione, sia quello delle competenze. Comporta la presenza di paura e dolore relativi al giudizio e al riconoscimento di sé. Un’altra emozione presente è la rabbia, che emerge in situazioni in cui diventa difficile la relazione/cooperazione, con opinioni contrastanti e difficoltà di compromesso. La cura avrà un’intensità molto alta derivante dal riconoscimento e dal buon esito del lavoro in linea generica.
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “LEZIONI”
Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: ricerca Intensità: molto Si ipotizzano risposte in tale area completamente diverse poiché ogni intervistato farà riferimento a lezioni per ognuno rilevanti, poiché a nostro avviso le emozioni in tale area variano radicalmente a seconda del tipo di lezione e del docente coinvolto
NOTA AGGIUNTIVA
Si rilevano delle difficoltà nel ricondurre le definizioni che derivano dal senso comune dei sentimenti presi in esame ai sistemi emozionali definiti da Panksepp.
A PROPOSITO DEL DIFFERENZIALE SEMANTICO SUI SENTIMENTI
Si ipotizza che le risposte che verranno inserite saranno coerenti con la parte I del questionario (sui sistemi emozionali di base).
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
12
Metodologia L’analisi della vita emotiva nelle organizzazioni può essere condotta con diversi metodi.
Il libro curato da Fineman sulle emozioni nelle organizzazioni, che raccoglie saggi di vari autori, contiene casi che illustrano i seguenti metodi: osservazione partecipante, conversazioni casuali, storytelling, etnografia investigativa, dialogo delegato ai soggetti coinvolti nel caso, testimonianze, intervista in profondità ecc. Questi approcci sono di tipo qualitativo e permettono di indagare in modo molto approfondito un singolo aspetto, caso, questione, cercando di ottenere quante più possibili informazioni in merito, considerando anche dimensioni che non potrebbero essere considerate con tecniche quantitative, come per esempio: il linguaggio non verbale, l’emotività, la prossemica, le storie di vita e via dicendo.
Questi metodi qualitativi presentano dei limiti quali la portata ridotta dei casi, le generalizzazioni sono assenti in quanto si interpreta l’unicità del fenomeno sociale, il disegno di ricerca è altamente destrutturato, aperto, atto a captare l’imprevisto e modellato nel corso della rilevazione e nonostante possa essere un punto di forza, può portare il ricercatore a perdere di vista l’obiettivo della ricerca infine rispetto ai metodi quantitativi i risultati dei metodi qualitativi non sono pienamente di validità scientifica.
Per il nostro reattivo il metodo più consono da noi rilevato è stata la somministrazione di questionari da noi redatti. I soggetti ai quali ci siamo rivolti sono gli studenti dell’Università di Bergamo, dei diversi Dipartimenti (Economia, Lingue, Scienze umane, Lettere, Giurisprudenza e Ingegneria) in ugual numero tra maschi e femmine.
Il questionario riguarda l’analisi delle seguenti arene emotive: 1) esame; 2) pause dalle lezioni; 3) lavori di gruppo; 4) lezioni.
Sono state analizzate le emozioni e i sentimenti significativi provate nelle quattro arene, ovvero la loro intensità mediante una scala decrescente. La somministrazione dei questionari è stata preceduta da una prova (pre-test del questionario), con l’obiettivo di verificarne concretamente la comprensione per eventuali aggiustamenti formali delle domande del questionario.
Dopo le relative modifiche per evitare perplessità durante la compilazione, abbiamo somministrato circa 250 test agli studenti nelle pause dalle ore di lezione (alcuni questionari sono stati poi annullati per errori di compilazione; totale questionari validi raccolti: 237).
La prima parte del Questionario adotta la Scala di Likert. Sono stati individuati 5 gradi di
intensità (da Molto a Per nulla), che esprimono l’atteggiamento di un soggetto verso il costrutto in esame (che consiste nell’attivazione di un particolare sistema emozionale in un particolare contesto emotivo dell’organizzazione universitaria). Ai soggetti è stato chiesto di indicare il grado di intensità con cui i sistemi emotivi distinti (i sette sistemi affettivi di base secondo Panksepp) sono attivati in una particolare arena emotiva. Non essendo auto-somministrata, la scala ha lo svantaggio di poter indurre risposte per desiderabilità sociale o per acquiescenza. Risulta importante per l’intervistatore porre attenzione a non mettere in difficoltà il soggetto intervistato, utilizzando termini adeguati alla comprensione del maggior numero di persone, ponendo le domande in modo da consentire all’altro di trovarsi nella condizione adeguata per rispondere.
La seconda parte del Questionario propone un differenziale semantico. Il differenziale semantico
è una tecnica di valutazione psicologica, ideata da Osgood, Suci e Tannenbaum (1957), per operazionalizzare la misura del “significato implicito” dei termini linguistici. Esso ha il fine di valutare atteggiamenti/personalità in base a due poli opposti. Nel nostro caso, valuta
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
13
l’atteggiamento che gli studenti hanno nei confronti dei contesti: lezioni, esami, pause e lavori di gruppo. Abbiamo considerato la dimensione valutativa che viene proposta in una scala da -3 a +3, con lo 0 neutro.
Limiti metodologici ed errori emersi
nell’elaborazione dei dati
La lunghezza del questionario, apparsa eccessiva, ha prodotto talvolta disinteresse verso la fine (eccessiva la sequenza di 4 differenziali semantici a sedici coppie di aggettivi). È emersa talvolta incertezza nell’interpretazione del numero “0” (nullo o neutro?) nel differenziale semantico e non sempre i somministratori del questionario hanno dato le stesse risposte in merito. Si è rilevata poi la difficoltà dell’intervistato ad esprimere un giudizio in relazione a coppie di aggettivi che non risultavano chiaramente opposti.
Inoltre, benché inizialmente l’aspirazione fosse quella di comparare Dipartimenti diversi, il campione raccolto è risultato disomogeneo, fortemente sbilanciato sui Dipartimenti di Scienze Umane e Lingue. Perciò l’unica comparazione significativa in termini statistici è risultata quella tra uomini e donne.
Alcuni errori (considerando il poco tempo disponibile e la mancanza di strumenti informatici per tutti, in fase di lavoro di gruppo) sono poi stati compiuti in fase di imputazione dei dati, determinando così la situazione di dati mancanti.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
14
Risultati distinti e comparati per sesso Considerando la disomogeneità dei dati raccolti nei diversi Dipartimenti, assumiamo come principale distinzione da analizzare quella tra uomini (112 questionari) e donne (125 questionari). Di seguito, le tabelle complessive distinte per sesso.
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / ESAME
F
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 40 58 14 3 10 Ricerca 10 58 37 11 9 Rabbia 2 14 33 67 9 Piacere 5 14 35 61 10 Cura 13 36 32 30 14 Dolore 2 15 30 67 11 Giocosità 11 18 33 53 10
M Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 24 48 32 7 1 Ricerca 19 50 25 11 7 Rabbia 3 14 29 55 11 Piacere 3 15 30 53 11 Cura 10 26 31 35 10 Dolore 2 14 32 38 26 Giocosità 7 37 35 19 14 Alle tabelle seguirà sempre un confronto tra grafici.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
15
Esame/Femmine:
Esame/Maschi
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
16
Ecco un confronto più leggibile, rispetto alla scena emotiva “Esame”, tra i risultati (in percentuali) distinti per risposte di maschi e femmine. Dal grafico si coglie la sostanziale parità nei livelli alti (Molto e Abbastanza) sul piano del “dolore/sofferenza”, del “piacere” e della “rabbia”; inoltre, un prevalere della percezione maschile rispetto a “giocosità” e “ricerca” della percezione femminile rispetto a “cura” e soprattutto a “paura”.
Paura: Nel livello più alto della paura (molto) vi è una notevole discrepanza tra maschi e femmine. Vediamo infatti il sesso femminile prevalere rispetto al sesso maschile (F40/M24), mentre il sesso maschile sembra risultare meno “spaventato/impaurito” nei confronti di un esame. Infatti dal livello medio/basso della scala (poco) si può constatare questa informazione (F14/M32). Il sentimento della “rabbia” mantiene invece un certo equilibrio esattamente come quello della “ricerca”. Non vi sono infatti forti discrepanze. Interessante è invece il sentimento del “dolore”: nei livelli più bassi infatti vi sono dati diversi tra maschi e femmine. In quanto nelle femmine il dolore appare meno “sentito” rispetto ai maschi. Così come nella analisi del sentimento della “paura” abbiamo cercato di pensare anche per il “dolore” ad una motivazione che possa essere alla base di queste differenze: secondo la nostra opinione gli intervistati non hanno voluto esporre totalmente il loro sentimento in quanto limitati da un fattore di orgoglio. Nei maschi si potrebbe pensare ad una difficoltà ad ammettere le proprie paure, mentre il sesso femminile cerca in qualche modo di nascondere il dolore che comporta una situazione di alto tasso emotivo. Il sentimento di “giocosità” è presente in modo maggiore nei maschi: infatti nelle risposte dei livelli più alti (abbastanza) vi è una forte maggioranza di sesso maschile. Verso i livelli bassi (per nulla) si nota, al contrario, una maggioranza femminile.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PAURA F PAURA M RICERCA F RICERCA M RABBIA F RABBIA M PIACERE F PIACERE M
CURA F CURA M
DOLORE F DOLORE M GIOCOSITÀ F GIOCOSITÀ M
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
17
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / PAUSE
F
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 0 2 9 108 6 Ricerca 14 53 33 15 10 Rabbia 6 3 28 78 10 Piacere 7 55 40 17 6 Cura 9 37 20 34 25 Dolore 1 0 21 82 21 Giocosità 50 46 11 12 6
M Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 2 6 7 85 12 Ricerca 20 55 24 10 3 Rabbia 1 9 16 86 0 Piacere 32 44 21 11 4 Cura 11 43 38 15 5 Dolore 4 2 17 83 6 Giocosità 57 40 7 2 6
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
18
Pause/Femmine:
Pause/Maschi:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
19
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / LAVORI DI GRUPPO
F
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 1 7 37 64 16 Ricerca 20 69 12 5 19 Rabbia 3 12 24 67 19 Piacere 6 42 19 33 25 Cura 8 57 30 13 17 Dolore 0 2 13 91 19 Giocosità 19 70 19 1 16
M Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 3 13 34 51 11 Ricerca 31 63 10 6 5 Rabbia 6 7 32 55 12 Piacere 14 34 33 19 12 Cura 13 44 29 17 9 Dolore 4 5 17 76 10 Giocosità 33 53 15 6 5
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
20
Lavori di gruppo/Femmine:
Lavori di gruppo/Maschi:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
21
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / LEZIONI
F
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 4 10 36 65 10 Ricerca 32 70 10 3 10 Rabbia 2 4 28 69 22 Piacere 2 32 28 44 19 Cura 13 40 37 19 16 Dolore 0 7 20 83 15 Giocosità 4 58 38 12 13
M Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 1 11 30 67 3 Ricerca 27 62 15 5 3 Rabbia 0 10 32 65 5 Piacere 4 21 49 25 13 Cura 5 46 32 24 5 Dolore 1 4 21 79 7 Giocosità 13 46 37 8 8
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
22
Lezioni/Femmine:
Lezioni/Maschi:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paura
Ricerca
Rabbia
Piacere
Cura
Dolore
Giocosità
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non so
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
23
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / ESAMI
F
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 23 50 15 14 7 1 0 indifferente spaesato 2 20 24 22 13 26 5 ambientato apprezzato 4 15 28 54 8 1 1 disprezzato indignato 2 5 12 64 23 6 0 ammirato curato 8 24 35 32 8 3 1 trascurato attratto 10 24 28 39 6 0 4 respinto imbarazzato 14 20 25 27 9 12 3 a mio agio stressato 59 27 8 4 2 8 1 rilassato felice 2 12 25 51 14 2 4 triste attivo 50 33 13 8 4 2 2 passivo preoccupato 46 24 21 5 4 3 0 disteso invidioso 2 6 9 60 7 21 6 gioioso ansioso 56 20 12 7 10 3 1 tranquillo irritato 10 13 15 46 20 3 2 sereno frustrato 1 7 20 40 21 16 2 gratificato annoiato 2 2 9 20 16 33 29 coinvolto
M 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 15 36 28 14 8 5 2 indifferente spaesato 5 12 23 18 28 20 6 ambientato apprezzato 2 17 26 58 4 4 2 disprezzato indignato 2 7 14 54 17 15 1 ammirato curato 9 12 31 40 11 5 2 trascurato attratto 5 27 29 33 12 3 1 respinto imbarazzato 3 16 19 30 20 18 12 a mio agio stressato 24 35 15 10 8 6 9 rilassato felice 6 11 16 50 19 8 0 triste attivo 28 48 16 12 4 2 2 passivo preoccupato 28 36 14 16 7 8 4 disteso invidioso 7 7 8 47 19 16 8 gioioso ansioso 28 30 19 10 8 7 7 tranquillo irritato 8 14 19 32 23 16 3 sereno frustrato 2 11 10 41 27 15 7 gratificato annoiato 1 7 6 19 28 25 22 coinvolto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
24
Confronto sui valori medi di Maschi e Femmine per i differenziali semantici della scena emotiva “Esame” (valori da 1 a 7):
M F incuriosito-indifferente -1,12037037 -1,590909091 spaesato-ambientato 0,214285714 0,089285714
apprezzato-disprezzato -0,424778761 -0,513513514 indignato-ammirato 0,145454545 0,0625 curato-trascurato -0,5 -0,810810811 attratto-respinto -0,7 -0,792792793
imbarazzato-a mio agio 0,271186441 -0,590909091 stressato-rilassato -1,028037383 -2
felice-triste -0,190909091 -0,227272727 attivo-passivo -1,625 -1,919642857
preoccupato-disteso -1,194690265 -1,912621359 invidioso-gioioso con altri 0,285714286 0,36036036
ansioso-tranquillo -1,100917431 -1,844036697 irritato-sereno -0,060869565 -0,357798165
frustrato-gratificato 0,353982301 0,205607477 annoiato-coinvolto 1,12037037 1,351351351
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
26
NOTA: Nella prima parte del questionario, investigando l’attivazione dei sistemi affettivi di base nella scena emotiva “Esame”, si coglieva sostanziale parità nei livelli alti (Molto e Abbastanza) sul piano del “dolore/sofferenza”, del “piacere” e della “rabbia”; inoltre, un prevalere della percezione maschile rispetto a “giocosità” e “ricerca” della percezione femminile rispetto a “cura” e soprattutto a “paura”. Qui gli scostamenti più significativi tra M e F sono: nello spostamento di M verso “a mio agio”, “rilassato”, “disteso” e “tranquillo”; nello spostamento di F verso gli opposti “imbarazzato”, “stressato”, “preoccupato”, “ansioso”.
Nel sistema affettivo di base dell’esame si coglie una parità di sentimenti neutrali nei confronti dei sentimenti di ira, invidia, indignazione e di relazione con e verso gli altri.
In linea generale, dal grafico, si può notare come i maschi percepiscano la maggior parte dei sentimenti in maniera più attenuata rispetto alle femmine: sono meno preoccupati, ansiosi, stressati e attivi.
Da tenere in considerazione anche il fatto che le femmine siano più incuriosite, coinvolte e si sentano più durante l’esame rispetto ai maschi. I maschi, invece, nutrendo minore ansia si sentono più a loro agio e quindi più rilassati e ambientati.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
27
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / PAUSE
F
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 24 30 25 21 8 3 6 indifferente spaesato 1 4 4 13 25 40 41 ambientato apprezzato 19 45 19 23 6 6 0 disprezzato indignato 0 5 4 53 27 20 8 ammirato curato 20 36 24 32 8 5 0 trascurato attratto 23 38 27 27 6 1 0 respinto imbarazzato 1 5 3 54 20 43 36 a mio agio stressato 2 4 2 16 16 31 48 rilassato felice 36 37 20 15 2 0 0 triste attivo 34 37 20 10 3 2 3 passivo preoccupato 3 4 6 9 15 29 42 disteso invidioso 0 2 3 20 7 31 53 gioioso ansioso 0 2 4 9 11 39 52 tranquillo irritato 0 1 2 14 13 37 55 sereno frustrato 0 1 4 37 30 30 24 gratificato annoiato 1 3 2 12 27 43 31 coinvolto
M 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 27 33 12 13 6 10 8 indifferente spaesato 0 5 5 4 14 36 45 ambientato apprezzato 21 36 18 21 8 3 3 disprezzato indignato 0 7 6 41 18 26 9 ammirato curato 5 39 32 29 3 5 0 trascurato attratto 14 32 22 18 5 5 13 respinto imbarazzato 2 3 8 16 10 34 32 a mio agio stressato 9 10 7 13 14 25 33 rilassato felice 34 40 15 13 3 3 1 triste attivo 28 31 14 14 4 15 6 passivo preoccupato 0 7 3 14 11 36 40 disteso invidioso 1 1 3 21 14 26 45 gioioso ansioso 2 2 2 11 17 31 43 tranquillo irritato 0 1 2 17 18 38 35 sereno frustrato 0 1 3 29 27 26 23 gratificato annoiato 0 3 9 19 20 36 22 coinvolto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
28
Confronto sui valori medi di Maschi e Femmine per i differenziali semantici della scena emotiva “Pause dalle lezioni” (valori da 1 a 7):
M F incuriosito-indifferente -1 -1,068376068 spaesato-ambientato 1,889908257 1,6640625
apprezzato-disprezzato -1,181818182 -1,254237288 indignato-ammirato 0,719626168 0,658119658 curato-trascurato -0,991150442 -1,104 attratto-respinto -0,678899083 -1,344262295
imbarazzato-a mio agio 1,466666667 1,222222222 stressato-rilassato 0,981981982 1,731092437
felice-triste -1,697247706 -1,818181818 attivo-passivo -0,964285714 -1,651376147
preoccupato-disteso 1,675675676 1,62962963 invidioso-gioioso con altri 1,738738739 1,905172414
ansioso-tranquillo 1,814814815 2,025641026 irritato-sereno 1,756756757 2,032786885
frustrato-gratificato 1,311926606 1,238095238 Durante le pause, investigando l’attivazione dei sistemi affettivi di base in questa scena emotiva si è potuto notare come a prima vista ci sia parità nella maggior parte dei sentimenti. Ad un esame più attento, però, le femmine si sentono più curate, più attratte e leggermente più attive rispetto agli intervistati di sesso maschile. E sono più neutrali nei sentimenti che riguardano l’indignazione, l’imbarazzo e la frustrazione. A parte queste discrepanze, ci sono molti lati in comune: maschi e femmine si sentono in egual modo incuriositi, ambientati, apprezzati, felici, distesi e gioiosi.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
30
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / LAVORI DI GRUPPO
F
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 28 59 19 9 4 2 1 indifferente spaesato 0 4 10 12 23 47 16 ambientato apprezzato 10 53 27 21 2 2 0 disprezzato indignato 1 1 7 44 36 28 1 ammirato curato 5 40 32 35 4 1 2 trascurato attratto 15 44 29 28 3 1 0 respinto imbarazzato 4 5 17 8 28 37 21 a mio agio stressato 3 10 12 12 28 35 23 rilassato felice 18 36 28 32 3 3 1 triste attivo 29 46 27 13 3 2 1 passivo preoccupato 2 10 9 21 20 27 20 disteso invidioso 0 7 4 29 21 33 24 gioioso ansioso 0 11 14 10 16 37 27 tranquillo irritato 0 7 6 18 18 45 23 sereno frustrato 0 6 6 28 38 28 16 gratificato annoiato 2 5 2 9 26 41 35 coinvolto
M 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 23 48 17 9 5 2 1 indifferente spaesato 1 11 14 16 20 35 7 ambientato apprezzato 6 30 35 27 8 3 1 disprezzato indignato 2 4 8 38 32 19 3 ammirato curato 4 23 38 29 7 6 0 trascurato attratto 9 37 34 22 3 3 0 respinto imbarazzato 0 5 17 16 20 36 10 a mio agio stressato 0 10 17 18 20 34 6 rilassato felice 11 31 28 26 9 3 1 triste attivo 23 35 17 16 13 1 1 passivo preoccupato 2 5 15 24 23 29 10 disteso invidioso 1 0 7 35 22 24 19 gioioso ansioso 2 4 14 16 21 36 14 tranquillo irritato 0 2 10 18 31 31 15 sereno frustrato 0 1 10 28 38 23 9 gratificato annoiato 1 2 7 13 28 43 16 coinvolto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
31
Confronto sui valori medi di Maschi e Femmine per i differenziali semantici della scena emotiva “Lavori di gruppo” (valori da 1 a 7):
M F
incuriosito-indifferente -1,619047619 -1,721311475 spaesato-ambientato 0,692307692 1,3125
apprezzato-disprezzato -0,872727273 -1,365217391 indignato-ammirato 0,537735849 0,703389831 curato-trascurato -0,719626168 -0,966386555 attratto-respinto -1,166666667 -1,308333333
imbarazzato-a mio agio 0,913461538 1,05 stressato-rilassato 0,657142857 1,024390244
felice-triste -0,963302752 -1,173553719 attivo-passivo -1,301886792 -1,619834711
preoccupato-disteso 0,740740741 0,908256881 invidioso-gioioso con altri 1,083333333 1,194915254
ansioso-tranquillo 1 1,173913043 irritato-sereno 1,158878505 1,341880342
frustrato-gratificato 0,908256881 1,016393443
Per quanto riguarda lo studio fatto sui sentimenti provati dagli studenti durante le lezioni il differenziale semantico risulta tendenzialmente molto vicino nell’analisi della percezione emozionale dei lavori di gruppo nei maschi e nelle femmine. La serenità e la voglia di collaborare con i propri compagni risulta a pari livello in entrambi i sessi, questo porta a una maggiore gratificazione, soprattutto nelle femminile. L’attrazione, più elevata nei maschi che nelle femmine, per ciò che viene sperimentato all’interno del gruppo porta a maggiore attività e voglia di collaborare nel contesto di gruppo; ciò si ripercuote sul livello di felicità/tristezza che risulta prossimale a 3 in entrambi i sessi, naturalmente tendente verso la felicità. In rarissimi casi è possibile sperimentare livelli di stress, preoccupazione e ansia: le emozioni di base maggiormente sperimentate in questi casi sono di tranquillità, distensione e rilassamento. Analogamente l’imbarazzo e la sensazione di sentirsi fuori luogo non sono propri di questa arena emotiva, sia da parte dei maschi che delle femmine; i a valori mostrano che le femmine sono maggiormente ambientate rispetto ai maschi, e di conseguenza più a loro agio nella relazione con i proprio colleghi.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
33
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / LEZIONI
F
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 29 67 14 3 1 2 0 indifferente spaesato 0 3 13 14 18 44 26 ambientato apprezzato 5 28 29 57 2 0 0 disprezzato indignato 0 1 3 53 28 24 6 ammirato curato 7 24 36 40 5 4 0 trascurato attratto 12 42 33 19 3 0 3 respinto imbarazzato 0 7 12 14 27 37 19 a mio agio stressato 3 9 12 25 24 31 17 rilassato felice 11 28 30 37 11 2 0 triste attivo 15 31 32 18 7 11 2 passivo preoccupato 1 4 15 24 23 26 11 disteso invidioso 0 0 4 45 28 28 11 gioioso ansioso 0 3 11 15 26 43 16 tranquillo irritato 2 1 5 18 28 41 16 sereno frustrato 0 2 6 43 33 29 2 gratificato annoiato 0 1 14 8 33 37 16 coinvolto
M 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 23 56 13 6 8 0 3 indifferente spaesato 1 6 8 16 21 40 18 ambientato apprezzato 5 18 24 56 3 2 0 disprezzato indignato 0 2 5 46 29 23 3 ammirato curato 7 19 40 32 13 1 0 trascurato attratto 7 37 30 31 5 0 0 respinto imbarazzato 0 4 4 13 29 43 17 a mio agio stressato 0 8 19 16 26 30 12 rilassato felice 7 25 29 40 7 1 0 triste attivo 16 24 30 16 13 3 6 passivo preoccupato 1 5 14 23 22 31 14 disteso invidioso 0 3 6 44 22 27 6 gioioso ansioso 2 1 6 19 31 32 21 tranquillo irritato 0 1 6 20 31 29 20 sereno frustrato 1 3 7 37 33 18 5 gratificato annoiato 1 3 6 13 25 41 14 coinvolto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
34
Confronto sui valori medi di Maschi e Femmine per i differenziali semantici della scena emotiva “Lezioni” (valori da 1 a 7):
M F incuriosito-indifferente -1,623853211 -1,982758621 spaesato-ambientato 1,2 1,398305085
apprezzato-disprezzato -0,62962963 -0,809917355 indignato-ammirato 0,694444444 0,773913043 curato-trascurato -0,75 -0,793103448 attratto-respinto -1,090909091 -1,258928571
imbarazzato-a mio agio 1,4 1,137931034 stressato-rilassato 0,783783784 0,809917355
felice-triste -0,834862385 -0,87394958 attivo-passivo -0,824074074 -0,896551724
preoccupato-disteso 0,9 0,788461538 invidioso-gioioso con altri 0,759259259 0,974137931
ansioso-tranquillo 1,285714286 1,254385965 irritato-sereno 1,317757009 1,306306306
frustrato-gratificato 0,653846154 0,756521739 Per quanto riguarda lo studio fatto sui sentimenti provati dagli studenti durante le lezioni il differenziale semantico risulta sorprendentemente molto simile per entrambi i sessi. Maschi e femmine, infatti, vivono le situazioni didattiche delle lezioni in modi pressoché uguali: come possiamo vedere, il grafico ce lo dimostra chiaramente, in quanto le oscillazioni di pochi decimi di percentuale. Analizzando le voci presenti nel grafico, si deduce che, con una lieve differenza in percentuale, maschi e femmine hanno tendenza a sviluppare curiosità verso la lezione in corso; stessa valutazione possiamo farla per quanto concerne l’emozione di apprezzamento. Abbiamo rilevato che le femmine si sentono più spaesate rispetto ai maschi e sicuramente meno a loro agio. Il livello di attrazione si registra più alto nei maschi che nelle donne, mentre invece i livelli di felicità/attività sono i medesimi. Per maschi e femmine le lezioni sono un momento in cui si sperimentano generalmente sensazioni di rilassamento, distensione e tranquillità. Bassi livelli di frustrazione e irritazione fanno emergere valori tendenti più verso emozioni di serenità, gioiosità e gratificazione.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
36
Risultati complessivi (237 questionari validi)
Prima parte del Questionario
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / ESAME
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 64 106 46 10 11 Ricerca 29 108 62 22 16 Rabbia 5 28 62 122 20 Piacere 8 29 65 114 21 Cura 23 62 63 65 24 Dolore 4 29 62 105 37 Giocosità 18 55 68 72 24
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / PAUSE Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 2 8 16 193 18 Ricerca 34 108 57 25 13 Rabbia 7 12 44 164 10 Piacere 39 99 61 28 10 Cura 20 80 58 49 30 Dolore 5 2 38 165 27 Giocosità 107 86 18 14 12
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / LAVORI DI GRUPPO
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 4 20 71 115 27 Ricerca 51 132 22 11 24 Rabbia 9 19 56 122 31 Piacere 20 76 52 52 37 Cura 21 101 59 30 26 Dolore 4 7 30 167 29 Giocosità 52 123 34 7 21
SISTEMI AFFETTIVI DI BASE / LEZIONI
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 5 21 66 132 13 Ricerca 59 132 25 8 13 Rabbia 2 14 60 134 27 Piacere 6 53 77 69 32 Cura 18 86 69 43 21 Dolore 1 11 41 162 22 Giocosità 17 104 75 20 21
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
37
Traducendo in grafici i dati precedenti, si ha quanto segue:
Esame
Riprendiamo le ipotesi sulla scena emotiva dell’esame: Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: paura, con intensità ABBASTANZA
CONFERMATA
Ipotesi sul sistema affettivo meno attivato: giocosità, piacere, con intensità PER NULLA
SMENTITA (bassa attivazione, non prevista, per i sistemi affettivi Rabbia e Dolore, con attivazione inferiore a “giocosità”)
Pause
Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: giocosità Intensità: abbastanza
CONFERMATA
Ipotesi sul sistema affettivo meno attivato: paura Intensità: per nulla
CONFERMATA
Rabbia, dolore/sofferenza a bassa intensità. Attivazione della cura
CONFERMATA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Paura Ricerca Rabbia Piacere Cura Dolore Giocosità
Non so
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Paura Ricerca Rabbia Piacere Cura Dolore Giocosità
Non so
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
38
Lavori di gruppo
Su questo punto non si riescono a individuare in modo netto sistemi affettivi più attivati o assenti. […[] Comporta la presenza di paura e dolore relativi al giudizio e al riconoscimento di sé. Un’altra emozione presente è la rabbia, che emerge in situazioni in cui diventa difficile la relazione/cooperazione, con opinioni contrastanti e difficoltà di compromesso. La cura avrà un’intensità molto alta derivante dal riconoscimento e dal buon esito del lavoro in linea generica.
SMENTITA la presenza significativa di paura e dolore; più presente delle prime la rabbia, ma si tratta complessivamente dei tre sistemi meno attivati. La presenza della cura non si può definire “molto alta”, attestandosi al 50% complessivo per i valori Molto + Abbastanza. Si tratta comunque della scena emotiva in cui la cura assume il valore più alto.
Lezioni
Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: ricerca Intensità: molto
CONFERMATA (in parte) Il sistema affettivo più attivato è effettivamente quello della “Ricerca”, con intensità “Abbastanza”
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Paura Ricerca Rabbia Piacere Cura Dolore Giocosità
Non so
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Paura Ricerca Rabbia Piacere Cura Dolore Giocosità
Non so
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
39
I grafici aiutano a cogliere la struttura similare delle scene emotive “Lavori di gruppo” e “Lezione” (con significative differenze sui termini “piacere” e “giocosità”) e la differenza marcata tra la scena emotiva dell’“Esame” rispetto a tutte le altre.
Prendendo in considerazione i quattro grafici che riportano i risultati dei 237 questionari si può notare come quello dell’“esame” si distingua dagli altri tre. Infatti si può osservare come la paura sia il sistemare affettivo più attivo, con intensità ABBASTANZA; in opposizione a ciò troviamo rabbia e dolore con un’alta intensità PER NULLA.
Per quanto riguarda “pause”, “lavori di gruppo” e “lezioni”, come già citato, si considera l’analogia dei grafi eccezion fatta per i sistemi affettivi di piacere e cura che subiscono leggere variazioni a seconda dell'ambito. Ritroviamo nei tre grafici un’alta attivazione di ricerca e giocosità opposte ad un’alta intensità di PER NULLA nella rabbia e nel dolore. Notiamo una piccola eccezione per quanto riguarda la giocosità la quale, in particolare nelle “pause”, ha un picco del 50% dell’intensità di MOLTO mentre le altre arrivano al 50% con una maggioranza di intensità ABBASTANZA.
Analizzando poi il grafico che riporta il differenziale semantico attribuibile alle quattro scene emotive considerate, viene confermato quanto già detto precedentemente, ovvero un'evidente differenza tra l’“esame” e le altre. L’andamento del grafico di “pause”, “lavori di gruppo” e “lezioni” coincide molto, in particolare tra i sentimenti di spaesato-ambientato/apprezzato-disprezzato e tra apprezzato-disprezzato/curato-trascurato trovando una totale concordanza in indignato-ammirato. La linea delle “pause” si distingue leggermente dalle altre due nelle successive coppie di sentimenti e invece in modo quasi opposto alla linea dell'esame in particolare in preoccupato-disteso e ansioso-tranquillo.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
40
Seconda parte del Questionario
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / ESAME
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 38 86 43 28 15 6 2 indifferente spaesato 7 32 47 40 41 46 11 ambientato apprezzato 6 32 54 112 12 5 3 disprezzato indignato 4 12 26 118 40 21 1 ammirato curato 17 36 66 72 19 8 3 trascurato attratto 15 51 57 72 18 3 5 respinto imbarazzato 17 36 44 57 29 30 15 a mio agio stressato 83 62 23 14 10 14 10 rilassato felice 8 23 41 101 33 10 4 triste attivo 78 81 29 20 8 4 4 passivo preoccupato 74 60 35 21 11 11 4 disteso invidioso 9 13 17 107 26 37 14 gioioso ansioso 84 50 31 17 18 10 8 tranquillo irritato 18 27 34 78 43 19 5 sereno frustrato 3 18 30 81 48 31 9 gratificato annoiato 3 9 15 39 44 58 51 coinvolto
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / PAUSE
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 51 63 37 34 14 13 14 indifferente spaesato 1 9 9 17 39 76 86 ambientato apprezzato 40 81 37 44 14 9 3 disprezzato indignato 0 12 10 94 45 46 17 ammirato curato 25 75 56 61 11 10 0 trascurato attratto 37 70 49 45 11 6 13 respinto imbarazzato 3 8 11 70 30 77 68 a mio agio stressato 11 14 9 29 30 56 81 rilassato felice 70 77 35 28 5 3 1 triste attivo 62 68 34 24 7 17 9 passivo preoccupato 3 11 9 23 26 65 82 disteso invidioso 1 3 6 41 21 57 98 gioioso ansioso 2 4 6 20 28 70 95 tranquillo irritato 0 2 4 31 31 75 90 sereno frustrato 0 2 7 66 57 56 47 gratificato annoiato 1 6 11 31 47 79 53 coinvolto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
41
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / LAVORI DI GRUPPO
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 51 107 36 18 9 4 2 indifferente spaesato 1 15 24 28 43 82 23 ambientato apprezzato 16 83 62 48 10 5 1 disprezzato indignato 3 5 15 82 68 47 4 ammirato curato 9 63 70 64 11 7 2 trascurato attratto 24 81 63 50 6 4 0 respinto imbarazzato 4 10 34 24 48 73 31 a mio agio stressato 3 20 29 30 48 69 29 rilassato felice 29 67 56 58 12 6 2 triste attivo 52 81 44 29 16 3 2 passivo preoccupato 4 15 24 45 43 56 30 disteso invidioso 1 7 11 64 43 57 43 gioioso ansioso 2 15 28 26 37 73 41 tranquillo irritato 0 9 16 36 49 76 38 sereno frustrato 0 7 16 56 76 51 25 gratificato annoiato 3 7 9 22 54 84 51 coinvolto
DIFFERENZIALE SEMANTICO / SENTIMENTI / LEZIONI
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 52 123 27 9 9 2 3 indifferente spaesato 1 9 21 30 39 84 44 ambientato apprezzato 10 46 53 113 5 2 0 disprezzato indignato 0 3 8 99 57 47 9 ammirato curato 14 43 76 72 18 5 0 trascurato attratto 19 79 63 50 8 0 3 respinto imbarazzato 0 11 16 27 56 80 36 a mio agio stressato 3 17 31 41 50 61 29 rilassato felice 18 53 59 77 18 3 0 triste attivo 31 55 62 34 20 14 8 passivo preoccupato 2 9 29 47 45 57 25 disteso invidioso 0 3 10 89 50 55 17 gioioso ansioso 2 4 17 34 57 75 37 tranquillo irritato 2 2 11 38 59 70 36 sereno frustrato 1 5 13 80 66 47 7 gratificato annoiato 1 4 20 21 58 78 30 coinvolto
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
42
Il grafico relativo ai differenziali semantici si costruisce con i seguenti valori medi:
Esame Pause Lavori di gruppo Lezioni incuriosito-indifferente -1,357798165 -1,03539823 -1,674008811 -1,808888889 spaesato-ambientato 0,151785714 1,767932489 1,013888889 1,302631579
apprezzato-disprezzato -0,46875 -1,219298246 -1,124444444 -0,72489083 indignato-ammirato 0,103603604 0,6875 0,625 0,735426009 curato-trascurato -0,656108597 -1,050420168 -0,849557522 -0,771929825 attratto-respinto -0,746606335 -1,03030303 -1,24122807 -1,175675676
imbarazzato-a mio agio -0,144736842 1,31835206 0,986607143 1,265486726 stressato-rilassato -1,518518519 1,369565217 0,855263158 0,797413793
felice-triste -0,209090909 -1,757990868 -1,073913043 -0,855263158 attivo-passivo -1,772321429 -1,303167421 -1,471365639 -0,861607143
preoccupato-disteso -1,537037037 1,652968037 0,824884793 0,845794393 invidioso-gioioso con altri 0,322869955 1,823788546 1,14159292 0,870535714
ansioso-tranquillo -1,472477064 1,924444444 1,09009009 1,269911504 irritato-sereno -0,205357143 1,901287554 1,254464286 1,311926606
frustrato-gratificato 0,281818182 1,272340426 0,965367965 0,707762557 annoiato-coinvolto 1,237442922 1,48245614 1,491304348 1,287735849
Per comodità di lettura, inseriamo il grafico in orizzontale e in verticale:
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
44
Il grafico ottenuto dall’analisi dei differenziali semantici attribuibili alle quattro scene emotive considerate conferma, a colpo d’occhio, la peculiarità della scena dell’“Esame” rispetto alle altre, in particolare rispetto ai termini “stressato”, “preoccupato”, “ansioso”. Si notano poi dei punti di “convergenza” tra le quattro aree sulle coppie “incuriosito-indifferente”, “apprezzato-disprezzato”, “curato-trascurato”, “attratto-respinto” e in modo significativo anche sulla coppia “attivo-passivo”, dove l’“Esame” si contraddistingue come la scena più “attiva” per gli studenti.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
45
Conclusione
Ci sono buone ragioni per ipotizzare che la qualità dell’apprendimento dipenda da come “si sta” nei contesti in cui si apprende, cioè dai sistemi emozionali di base che lì si attivano e dai sentimenti che si provano. Ci sono buone ragioni per sostenerlo se si riconosce che l’ingresso in uno spazio di scoperta e di conoscenza non è un fatto puramente “intellettuale” che riguardi menti disincarnate abili a recepire contenuti, ovvero un fatto relativo ad una fantomatica dimensione di fenomeni puramente “cognitivi” scissi dai fenomeni emozionali e affettivi.
Da tempo disponiamo di intuizioni, ricerche e conferme empiriche sull’intreccio costitutivo tra processi cognitivi ed emozionali e sul fatto che ogni possibilità di apprendimento e ogni conoscenza sono per così dire “informati” e plasmati in un complesso paesaggio di condizioni e di vincoli affettivi. Chiedersi “come stanno” all’Università coloro che lì vanno per apprendere, scoprire e conoscere, pertanto, è uno dei passi che il management di un’Università dovrebbe porsi il problema di fare, per osservarsi e riflettere sui vincoli e sulle possibilità di migliorare l’esperienza dell’apprendimento.
Lo strumento che abbiamo messo a punto e sperimentato – migliorabile sotto vari aspetti (grazie anche alla ricerca compiuta, che può essere considerata come un grande pre-test dello strumento) – può contribuire a tracciare una mappa dell’Università come organizzazione e sistema di contesti emozionali.
Che l’Università sia cambiata e stia cambiando, che debba cambiare e che riesca a farlo come dovrebbe – per iniziative esplicitamente indirizzate a ciò o per negligenza – è un tema ricorrente a livello internazionale. Perché e come cambiare, tuttavia? Il numero di ottobre 2014 della rivista Nature dedica un dossier di approfondimento ad alcune sperimentazioni, con un’editoriale che pone l’enfasi sui cambiamenti sollecitati e richiesti dall’accelerazione delle trasformazioni del mondo contemporaneo (Universities challenged. The accelerating pace of change in today’s world means that universities must modify how they fulfill their function of seeking and sharing knowledge). Perfino qui leggiamo un passaggio che traduce l’educazione in un “trasferimento di conoscenza” (transfer of knowledge): «There is natural synergy between education — the transfer of knowledge — and research — the creation of knowledge. It makes sense for teachers and scholars to sit next to each other; better still, for them to be the same person».
I contributi raccolti nel dossier, tuttavia, considerano e discutono vari casi internazionali di nuovi approcci all’insegnamento e alla scholarship (cfr. i contributi raccolti sotto il titolo The University Experiment: Campus as laboratory (Innovative ways of teaching, learning and doing research are helping Universities around the globe to adapt to the modern world). Si va dal ripensamento di ciò che accade nelle aule in presenza di docenti e tutor (es. la flipped classroom, dove si arriva per lavorare in piccoli gruppi sui temi da affrontare, avendo già studiato/tentato di studiare a casa i “contenuti” che tradizionalmente costituiscono l’argomento delle lezioni tradizionali) alle sperimentazioni sulla progettazione di corsi online (fino alla formula dei massive open online courses, MOOCs). Non mancano anche qui contrapposizioni del tipo “bianco”/“nero”, che rischiano di semplificare o limitare gli stessi itinerari della sperimentazione. Il responsabile del caso sudcoreano di flipped classroom, ad esempio, sostiene che «Usually, in a conventional classroom, students don’t think […] They just follow the professor’s teaching»: il che sembra escludere che si possa “seguire” pensando e che il “seguire” possa essere utilmente combinato con una serie di attivazioni variabili.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
46
La nostra ricerca suggerisce che sia importante interrogarsi su “come si sta” all’Università – nei suoi contesti emozionali più significativi per la vita degli studenti – e che un’indagine su questo punto sia necessaria per riflettere su eventuali cambiamenti o sperimentazioni (di cambiamento) negli spazi e nelle prassi. Lo strumento quantitativo adottato ha permesso di raccogliere una quantità di dati interessanti, nella cui lettura si incontrano tuttavia passaggi che restano aperti a più interpretazioni. Ciò è dovuto in parte alla polisemia dei termini adottati nella ricerca e in parte al fatto che alcuni aspetti potrebbero essere approfonditi soltanto mediante tecniche qualitative; ciò non toglie che uno strumento quantitativo come quello qui proposto – migliorato, alleggerito e integrato dove necessario – sia utile a “leggere la situazione”.
La nostra ricerca non propone, in merito ai cambiamenti e alle sperimentazioni auspicabili, idee e soluzioni progettuali innovative; propone però uno strumento di ricerca che, integrato con altri, potrebbe aiutare a non sottovalutare la necessità di lavorare sui/nei contesti dell’apprendimento interpretandoli anche come contesti emozionali. Si potrebbe dire: come contesti in cui una “risonanza” sufficientemente buona tra i processi cognitivi auspicati e i sistemi affettivi attivati diventi indice del fatto che le esperienze vissute dagli studenti siano davvero quelle che ci si possono aspettare quando si entra in uno spazio di scoperta e conoscenza in cui vale la pena entrare.
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
47
Appendice. Risultati numerici distinti per Dipartimenti / Esempio di analisi
Come già evidenziato, uno dei limiti nella conduzione della ricerca consiste nella disomogeneità dei dati raccolti nei diversi Dipartimenti presi come riferimento: Scienze Umane, Lingue, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Economia. Proponiamo comunque qui, a titolo di esempio, alcune tabelle relative ai dati raccolti in alcuni Dipartimenti, con la relativa discussione, in modo da consentire un confronto sui punti congruenti e incongruenti con quanto si può ricavare dall’analisi generale sopra proposta.
Scienze umane / MASCHI (totale soggetti: 46)
Sistemi affettivi di base / Esame Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 7 21 15 3 0 Ricerca 10 24 5 6 1 Rabbia 1 3 15 26 1 Piacere 0 6 14 24 2 Cura 7 7 16 14 2 Dolore 2 5 12 24 3 Giocosità 3 18 12 13 0 totali 30 84 89 110 9 Sistemi affettivi di base / Pause Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 0 3 3 39 1 Ricerca 13 21 8 2 2 Rabbia 0 0 4 42 0 Piacere 14 18 10 2 2 Cura 3 24 12 6 1 Dolore 0 0 7 37 2 Giocosità 27 17 2 0 0 57 83 46 128 8 Sistemi affettivi di base / Lavori di gruppo Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 0 6 11 28 1 Ricerca 14 24 5 2 1 Rabbia 0 1 16 27 2 Piacere 2 17 18 6 3 Cura 6 23 11 3 3 Dolore 0 0 6 36 4 Giocosità 16 20 7 2 1 38 91 74 104 15 Sistemi affettivi di base / Lezioni
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
48
Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so Paura 0 3 12 31 0 Ricerca 16 26 3 1 0 Rabbia 0 4 12 29 1 Piacere 0 10 23 7 6 Cura 2 22 14 7 1 Dolore 0 1 7 36 2 Giocosità 6 20 16 3 1 24 86 87 114 11 Sentimenti / Esame 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 6 21 12 3 2 1 1 indifferente spaesato 4 6 5 8 11 9 3 ambientato apprezzato 2 6 12 24 2 disprezzato indignato 1 6 21 9 8 1 ammirato curato 4 12 20 5 4 1 trascurato attratto 2 11 11 15 5 1 1 respinto imbarazzato 2 3 8 14 2 12 5 a mio agio stressato 6 19 5 2 6 3 5 rilassato felice 2 3 10 19 9 3 triste attivo 12 22 8 3 1 passivo preoccupato 10 16 7 6 1 5 1 disteso invidioso 2 3 2 19 9 7 4 gioioso ansioso 13 13 8 5 2 2 3 tranquillo irritato 3 5 5 13 12 7 1 sereno frustrato 1 5 12 16 7 5 gratificato annoiato 4 1 7 11 10 13 coinvolto Sentimenti / Pause 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 11 14 7 7 4 1 2 indifferente spaesato 0 0 2 2 8 13 21 ambientato apprezzato 6 19 8 11 1 0 1 disprezzato indignato 2 1 14 14 11 4 ammirato curato 1 17 17 9 0 2 0 trascurato attratto 6 8 8 7 2 3 12 respinto imbarazzato 2 0 3 5 1 16 19 a mio agio stressato 8 8 1 3 4 9 13 rilassato felice 11 23 5 5 1 1 0 triste attivo 7 10 7 6 1 9 6 passivo preoccupato 0 2 2 6 1 14 21 disteso invidioso 0 0 1 9 2 11 23 gioioso ansioso 0 1 1 5 3 17 19 tranquillo irritato 0 0 0 8 7 19 12 sereno frustrato 0 0 0 10 16 11 9 gratificato annoiato 0 0 3 9 11 18 5 coinvolto Sentimenti / Lavori in gruppo
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
49
3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 10 21 8 2 3 1 1 indifferente spaesato 1 7 7 11 18 2 ambientato apprezzato 2 13 17 13 1 disprezzato indignato 1 5 17 13 9 1 ammirato curato 3 8 20 10 3 2 trascurato attratto 6 14 13 9 3 1 respinto imbarazzato 2 6 8 7 20 3 a mio agio stressato 5 5 8 9 17 2 rilassato felice 4 11 15 11 3 2 triste attivo 10 15 7 5 8 1 passivo preoccupato 1 4 10 9 15 7 disteso invidioso 1 14 7 15 9 gioioso ansioso 2 1 2 8 7 18 8 tranquillo irritato 2 1 9 12 12 10 sereno frustrato 8 13 16 6 3 gratificato annoiato 1 4 5 13 14 9 coinvolto Sentimenti / Lezioni 3 2 1 0 1 2 3 incuriosito 10 28 2 1 4 1 indifferente spaesato 1 2 2 8 7 15 11 ambientato apprezzato 3 7 9 27 disprezzato indignato 2 12 19 12 1 ammirato curato 2 6 15 17 5 1 trascurato attratto 3 19 11 13 respinto imbarazzato 6 10 19 11 a mio agio stressato 1 5 7 9 16 8 rilassato felice 4 13 13 16 triste attivo 7 9 13 10 3 1 3 passivo preoccupato 2 7 11 18 8 disteso invidioso 3 19 10 12 2 gioioso ansioso 7 8 17 14 tranquillo irritato 3 6 11 15 11 sereno frustrato 1 1 3 18 13 8 2 gratificato annoiato 1 3 6 14 16 6 coinvolto Ipotesi di ricerca
Rilevazione
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “ESAME” Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: paura Intensità: abbastanza Ipotesi sul sistema affettivo meno attivato: giocosità, piacere Intensità: per nulla
Nella prima arena emotiva dell’esame le emozioni che sono state provate con maggior intensità sono la paura con 21 risposte e la ricerca con 24 risposte (su 46 totali). Mentre le emozioni per nulla provate sono la rabbia e il piacere con 26 e 24 risposte (su 46 totali).
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “PAUSE DALLE LEZIONI”
Nell’arena emotiva Pause si nota un’emozione
Emozioni e organizzazioni – Report finale (2014, UniBG)
50
Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: giocosità Intensità: abbastanza Ipotesi sul sistema affettivo meno attivato: paura Intensità: per nulla Qui si introduce un’ipotesi sul sistema affettivo della cura, che potrebbe far riflettere l’intervistato sul fatto che durante la pausa ci si prende cura di sé attraverso la socializzazione e il distacco temporaneo dalla didattica. Si ipotizza inoltre che potrebbe comparire il dolore/sofferenza, seppur con una bassa frequenza e intensità, ipotizzando il pensiero di situazioni di esclusione dal gruppo dei pari. Inoltre si ipotizza la presenza della rabbia (bassa intensità, poco) pensando a situazioni di sfogo emotivo (es. fallimento relativo a un esame)
predominante riguardante la giocosità e la cura, mentre si rileva una bassa intensità, per nulla, di rabbia e dolore.
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “LAVORO IN GRUPPO” Su questo punto non si riescono a individuare in modo netto sistemi affettivi più attivati o assenti. La scena è vista come un’arena emotiva dove convivono tutti i sistemi emotivi citati, poiché è una situazione in cui emergono le diverse caratteristiche individuali riguardanti sia l’aspetto della socializzazione, sia quello delle competenze. Comporta la presenza di paura e dolore relativi al giudizio e al riconoscimento di sé. Un’altra emozione presente è la rabbia, che emerge in situazioni in cui diventa difficile la relazione/cooperazione, con opinioni contrastanti e difficoltà di compromesso. La cura avrà un’intensità molto alta derivante dal riconoscimento e dal buon esito del lavoro in linea generica.
La terza arena emotiva concernente i lavori di gruppo mostra un’elevata intensità di ricerca e cura con 24 e 23 risposte su 46 totali (abbastanza). L’emozione di dolore è quella meno provata, con 36 punti “per nulla” (su 46 totali) come intensità di riferimento.
IPOTESI SULLA SCENA EMOTIVA “LEZIONI” Ipotesi sul sistema affettivo più attivato: ricerca Intensità: molto
L’arena emotiva Lezioni comprende un’elevata intensità per quanto riguarda la ricerca (abbastanza 26 su 46 totali), un’emozione poco provata risulta essere il piacere. Infine si rileva un’emozione assente riguardante il dolore.
Andando in secondo luogo ad analizzare i sentimenti e operando un confronto con le emozioni
sopra analizzate risulta opportuno verificarne la coerenza. Si noti nell’arena emotiva esame una coerenza concernente un’elevata presenza di sentimenti riguardanti paura e ricerca come la curiosità, l’essere imbarazzato, lo stress, l’essere attivo , preoccupato, ansioso e frustrato. È rilevante però una bassa presenza di sentimenti quali l’essere irritato e frustrato, che non risultano coerenti con le emozioni di paura e ricerca sopra emerse.
Questo perché probabilmente tali sentimenti sono visti come eccessivi in tale arena e per tanto poco privati in tal senso. Nell’arena emotiva delle pause abbiamo rilevato una coerenza concernente i sentimenti provati in relazione alle emozioni di ricerca, cura , giocosità e bassa rabbia. Ci sono sentimenti con elevati punteggi riguardanti la curiosità, l’attrazione, l’essere a proprio agio e ambientato, l’essere gioioso e coinvolto.
Anche nell’arena emotiva dei lavori di gruppi si nota coerenza tra sentimenti ed emozioni emersi. Riguardanti la ricerca, la cura e un’assenza di dolore. L’arena emotiva delle lezioni c’è perfetta coerenza con i sentimenti rilevati che risultano in linea con le emozioni di ricerca e piacere con assenza di dolore. Sommariamente riscontriamo un buon grado di coerenza nelle analisi dei risultati nel dipartimento di Scienze umane per il sesso maschile considerato e analizzato.