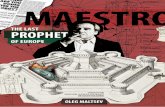Jean Baudrillard y Michel Maffesoli: repensando os espacios intransitables para a modernidad
Death of a Truth.DA JEAN BAUDRILLARD A MAURIZIO CATTELAN: CONTESTI, STRATEGIE FATALI E ICONOLOGIA...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Death of a Truth.DA JEAN BAUDRILLARD A MAURIZIO CATTELAN: CONTESTI, STRATEGIE FATALI E ICONOLOGIA...
Maurizio Lorber
DEATH OF A TRUTHDA JEAN BAUDRILLARD A MAURIZIO CATTELAN: CONTESTI,STRATEGIE FATALI E ICONOLOGIA DELLA REALTÀ DISSOLTA
Gli uomini stanno vivendoLa loro decadenza come sefosse un’esperienza estetica
Walter Benjamin
Ci sono alcuni aspetti della nostra contemporaneità che vanno posti in stretta correlazio-ne con alcune recenti opere d’arte di grande impatto mediatico; ci riferiamo in particolare allacosiddetta comunicazione di massa e alle relative modalità di attuazione delle quali delineere-mo i tratti salienti e le caratteristiche principali rilevando come il processo di semiotizzazionedi alcune installazioni sia comprensibile soltanto alla luce dei modelli globalizzati dell’infor-mazione. Reputiamo infatti che queste opere siano costruite, dal punto di vista della mise enscène, secondo i codici rappresentativi della société du spectacle1, la quale costituisce, al con-tempo, il loro criterio d’interpretazione.
È proprio partendo da un insieme di connotazioni culturali proprie del nostro mondoquotidiano e divenute una sorta di seconda natura che conferiamo significato ai fatti che acca-dono e alla nostra stessa esistenza, come mirabilmente enunciato da Lévi-Strauss: “Quantoalle creazioni dello spirito umano, il loro senso non esiste che in rapporto all’uomo e siconfonderanno nel disordine quando egli sarà scomparso”. È per tale motivo che significati,segni e rappresentazioni sono inevitabilmente destinati all’obsolescenza, secondo una consta-tazione che risale già alla semiotica degli anni Sessanta2.
In quest’ottica interpretativa, il criterio di contesto, inteso nel suo senso più ampio, rico-pre un ruolo determinante: le immagini pubblicitarie, artistiche o fotografiche sono interpre-tabili soltanto cogliendone l’ambito di riferimento, e le conoscenze (le “enciclopedie”) degliosservatori modello che costituiscono il piano privilegiato di attribuzione dei significati3.
Per conferire concretezza al pensiero facciamo riferimento a un’immagine estremamentenota che assume diverse connotazioni e differenti valori simbolici in funzione dell’ambiente edei soggetti che ne fruiscono.
Osserviamo la prima delle fotografie (fig. 1): è rappresentata una borsetta di metallo conmanico di plastica che riproduce a stampa un’immagine dai colori vivacemente alterati dell’ul-tima cena di Leonardo. Di primo acchito potremmo qualificarla come un oggetto kitsch, di cat-tivo gusto, e ci sembrerebbe singolare se fosse utilizzata quale borsetta o nécessaire da viaggio. Madopo un esame più attento osserviamo che l’oggetto si trova in vendita presso il negozio delMuseumsQuartier di Vienna, il cui logo (MQ) è in parte visibile sulla parte retrostante dello scaf-fale. Si tratta di un ambiente nel quale è possibile acquistare magliette che citano Egon Schiele,merchandising di design e altri gadget che spesso riescono ad innescare la compulsione all’acqui-sto dei visitatori della Ludwing Stiftung o del Leopold Museum, attigui alla libreria d’arte del
245
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 245
Museums Quartier prevalentemente orientata verso l’arte contemporanea.Già dall’identificazione del luogo possiamo comprendere come l’oggetto non sia sempli-
cemente un gadget pacchiano, assimilabile per significato culturale ai centrotavola di plasticache riproducono la gondola veneziana o alle torri di Pisa luminose poste sui comodini di turi-sti entusiasti, incauti acquisti che conobbero fortuna fra gli abitanti di un paese che, per laprima volta, scoprivano la piacevolezza del viaggiare, ansiosi di portarsi a casa un pezzo dellaFirenze rinascimentale, magari quale statuetta in alabastro del David michelangiolesco.
La contestualizzazione dell’oggetto al Museums Quartier lo qualifica invece come una cita-zione colta, recepibile solo da acquirenti che sappiano distinguere fra un oggetto Kitsch4 e unodi pregio il cui designer, nel progettarlo, ha strizzato l’occhio a un pubblico5 che conosce leopere della Pop Art.
Osserviamo invece la seconda immagine (fig. 2): si tratta di una stampa dai colori sgar-gianti del medesimo dipinto leonardesco inserita in una cornice di plastica dorata che simu-la una cornice rinascimentale. La fotografia è stata scattata al Brunnenmarkt, piccolo mer-cato della stessa Vienna, dove si comprano scarpe e abbigliamento per pochi euro e diversevarietà di frutta a verdura a prezzi concorrenziali. Nulla vieterebbe di trasportare il “dipin-to” nel negozio del Museums Quartier ma il suo significato muterebbe radicalmente poichéil visitatore ne coglierebbe una connotazione ironica che non fa parte delle possibilità inter-pretative dell’acquirente modello per il quale l’oggetto è stato originariamente prodotto.
A questo punto non sarebbe così singolare immaginare che un artista lo acquisti peresporlo ad una mostra alla Ludwig Stiftung: locazione diversa che induce implicitamenteuna fruizione diversa. Nel nostro esperimento ideale6 possiamo anche immaginare unamedesima persona che, in mattinata, faccia acquisti al mercato e al pomeriggio passeggi almuseo. Se di mattina ha sorriso di fronte alla riproduzione posta sulle cassette vuote di ver-dura e sotto un banchetto di scarpe, immaginandola appesa in una casa quale pezzo di pre-gio decorativo, al pomeriggio ne percepisce il citazionismo colto di Andy Warhol (fig. 3)nonché i tratti scultorei della cornice simili alle opere di Jeff Koons. Potremmo ancoraaggiungere, estremizzando l’esempio fino al suo massimo, che lo stesso riguardante nell’os-
246
1 - Borsetta metallica con riproduzione dell’Ultimacena, presso il negozio del Museum Quartier diVienna.
2 - Riproduzione dell’Ultima cena in un mercatoviennese.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 246
servare la riproduzione con l’involucro di plastica trasparente potrebbe coglierne un toccodi raffinata originalità che rimanda alla scultura di Giuseppe Sanmartino: il virtuosismo,riletto in chiave Kitsch, del Cristo Velato di Napoli. Vediamo quindi come l’oggetto sim-bolico muti significato e inneschi diversi rimandi extratestuali in base alla sua collocazionee all’osservatore modello.
Questo esempio ci permette di introdurre un principio di semiotica interpretativa che,nella sua semplicità, racchiude il segreto degli oggetti di arte contemporanea al quale le colle-zioni ci hanno abituato. Le diverse connotazioni dell’opera non risiedono nelle sue forme manell’atteggiamento interpretativo espresso dall’osservatore, indotto dalla sua cultura e dalluogo in cui si trova. Come l’analisi semiotica ci insegna, analogamente accade nella pubbli-cità, la quale viene realizzata tenendo sempre bene a mente il profilo di un potenziale acqui-rente. Le cose non sono cambiate, semmai si sono affinate, tanto che il video promozionaledella nuova 500 della FIAT (2007) mostra il bambino protagonista di Nuovo cinema paradi-so che, nell’edizione francese, osserva le immagini del ’68 ove compaiono Serge Gainsbourg eAlbert Camus, mentre l’edizione italiana presenta diversi personaggi, vicini al comune senti-re della nazione. Il fatto è facilmente spiegabile poiché le fotografie devono stimolare una reteideale di rievocazioni che rispondono a due diverse memorie collettive7.
Considerando il milieu nel quale il manufatto è prodotto, nonché esaminando la sua col-locazione e il suo destinatario, possiamo, con un buon margine di sicurezza, congetturare undeterminato significato e definire le possibili connotazioni. Ed è per questo che, quand’ancheazzardassimo che la riproduzione dell’ultima cena esposta in un museo di arte contempora-nea sia il prodotto di una cultura popolare priva d’ironia o un omaggio accademico alla gran-dezza dell’artista rinascimentale; o ancora sostenessimo che la riproduzione leonardesca del
247
3 - ANDY WARHOL, The last Supper. München, Museum Brandhorst.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 247
mercatino rionale sia un’installazione di uno studente dell’Accademia di Vienna, saremmounanimemente concordi nel dire che si tratta d’interpretazioni fuorvianti da respingere conforza poiché non considerano il cosiddetto lettore modello che ogni artefatto tiene in filigra-na, e che l’ambiente nella quale l’opera è inserita ci permette di recuperare.
Ernst Gombrich, negli anni Sessanta, ci aveva insegnato che nessuna immagine riesce adilludere veramente sulle qualità materiche degli oggetti o sulla loro presunta collocazione spa-ziale se non prendiamo in considerazione la collaborazione e le aspettative visive di colui cheguarda. Egli l’aveva chiamata “la parte dell’osservatore”8. Un principio analogo si riproponetanto per lo statuto ontologico dell’opera d’arte9 quanto per i suoi significati connotativi.Entrambi mutano nel momento in cui l’oggetto si sposta dal mercato alla galleria d’arte atti-vando diversi rimandi extratestuali.
Sicuramente “la distinzione tra l’arte e le produzioni di immagini comuni, banali, è sempremeno netta”10 ma, come abbiano fatto notare precedentemente, non possiamo confondere idiversi livelli di interpretazione che sono guidati dal contesto e dalle nostre conoscenze. Ciò nonesclude qualsiasi tipo di tangenza fra “mondi possibili” contigui, com’è accaduto per alcune cam-pagne pubblicitarie di Oliviero Toscani pianificate con l’intento di decostruire il processo pub-blicitario tradizionale11. Vedremo, ad esempio, come determinate immagini abbiano destatosconcerto proprio perché non in linea con il contesto nel quale dovrebbero essere collocate.
Oliviero Toscani ha sempre giocato sullo sconfinamento dei generi. È il primo ad aver uti-lizzato fotografie che appartengono al genere foto documentario, da telegiornale, per pro-muovere della maglieria, in nome di una bandiera che simbolicamente raccoglie tutto il gene-re umano. Queste campagne pubblicitarie iniziarono come un confronto gioioso sulla diver-sità etnica, quindi proseguirono coerentemente rappresentando ciò che maggiormente acco-muna tutti noi: la sofferenza, la malattia e la morte. Ma quest’operazione dissacrante produs-se una valenza simbolica profonda poiché le immagini divennero polisemantiche e iniziaronoa parlarci della nostra società, dei nostri tabù sessuali, delle nostre paure.
Dei pantaloni e una maglietta distesi su di un fondo neutro potrebbero essere soltanto unabanale immagine promozionale per capi di abbigliamento (fig. 4), eppure quando ci accorgia-mo che la maglietta è insanguinata e con un foro di proiettile all’altezza del costato, i pantalonisono mimetici e la disposizione non è casuale ma rievoca la posa disarticolata di un cadavere,allora subentra lo shock visivo12. Il collegamento dell’osservatore è immediato con l’atroce guer-ra civile che si stava combattendo nella ex Jugoslavia. Quelle immagini che guardavamo distrat-tamente protetti dal vetro antiproiettile del teleschermo televisivo sono uscite dallo spaziodistante dei notiziari, per entrare nel mondo rassicurante e sereno delle inserzioni pubblicitarie.
Sembra che fra le motivazioni che indussero Edouard Manet, più di cent’anni prima, adipingere L’esecuzione di Massimiliano (1868-1869, Manheim, Städtische Kunsthalle) vi siaun’immagine che, in qualche modo, rimanda a quella di Toscani: si tratta della fotografia dellacamicia insanguinata di Massimiliano (fig. 5) scattata da François Aubert al quale era statovietato di immortalare la fucilazione con la macchina fotografica13.
Nella foto di Aubert la camicia è appesa agli stipiti di una porta con due chiodi sottili euna tenda crea una base neutra. Si tratta evidentemente di una foto intesa quale provadocumentaria dell’accaduto che, per la sua importanza storica, deve lasciare a futura memo-ria quanti più indizi e tracce possibili. Con un buon margine di attendibilità possiamo
248
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 248
249
4 - OLIVIERO TOSCANI, Cam-pagna pubblicitario Benetton,1992.
5 - FRANÇOIS AUBERT, Camiciadi Ferdinando Massimilianod’Austria, 1867.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 249
immaginare che la finalità del fotografo fosse quella di produrre dei documenti su quantoaccaduto.
Tuttavia, nella sua cruda essenzialità, ad un osservatore europeo la fotografia rievocò l’im-magine delle reliquie dei santi14. Una sineddoche iconica della morte e della sofferenza in assen-za di un corpo che la rappresenti, ma proprio per questo meno refrattaria al nostro sguardo.
La foto di Toscani imita, nella sua macabra oggettività, la fotografia documento diAubert accentuandone consapevolmente l’extratestualità del martirio. A ciò concorre l’evi-denza del foro del proiettile nel petto e l’assenza del cadavere che permette alla nostraimmaginazione di riempire quel macabro sudario con una vittima che rimarrà anonima allaluce della storia. In tal modo l’immagine, semplice e formalmente efficace, diviene il sim-bolo delle giovani vite sacrificate alla guerra: un milite ignoto contemporaneo15. La simul-tanea presenza iconica degli indumenti indossati da tutti i giovani - T-shirt e pantaloni mili-tari - e la scena agghiacciante che mettono in scena vengono riassunti metaforicamentenello slogan: United Colours.
Il manifesto, parte di una campagna pubblicitaria di abbigliamento, una volta consacratoalla biennale veneziana quale oggetto artistico mantenne e, forse, aumentò il significato sim-bolico, ma fu depotenziato nella sua capacità di impatto emotivo poiché, inserito nel “mondodell’arte”, rievocando le opere di Anselm Kiefer e le performance di Marina Abramoviç, diven-ne parte di un contesto nel quale queste interpretazioni sono consuete e legittimate.
È stato evidenziato come lo shock prodotto dalle immagini di Toscani sia relativo a unoscivolamento dal mondo possibile della cronaca a quello della pubblicità16. Tuttavia non pos-siamo ignorare il fatto che le sue fotografie rimandano ad esperienze artistiche di quasitrent’anni prima, in particolar modo alla serie di serigrafie Death & Disaster di Andy Warhol,elaborate originariamente fra il ’62 e il ’67 (129 Die in Jet - Plane Crash, Red Race Riot, WhiteCar Crash 19 Times, Green Car Burning, Big Electric Chair, Double Silver Disaster). Questosconfinamento da un genere all’altro, nello specifico dalla cronaca (rotocalchi, telegiornali)all’affiche pubblicitaria, è mediato dalla Pop Art che, fin dagli anni ’60, aveva posto l’atten-zione sulla traduzione mediatica di eventi drammatici. Ciò ha contribuito a conferire unaconnotazione diversa a questo tipo di immagini pubblicitarie: non semplici atti provocatorima, all’occhio di un pubblico più colto, una ripresa di temi e raffigurazioni che appartengo-no al mondo dell’arte. La stessa promiscuità dei generi (cronaca, storia, arte, pubblicità…)sarebbe stata impensabile precedentemente al dilagare dei media17. È questo il caratteredistintivo di una società nella quale la televisione prima, e la rete ora, veicolano tutto senzaalcuna gerarchizzazione18. Una sorta di grande miscelatore che ha annientato l’ordine che latradizione occidentale si era illusa di poter imporre al mondo19: è ciò che Jean-FrançoisLyotard ha chiamato post-modernità.
Le raffigurazioni finora esaminate sono esemplificative poiché ci hanno permesso di evi-denziare come sia i contesti che i rimandi extratestuali siano fondamentali per guidare i pro-cessi di significazione e per consentire alle immagini di assumere statuti ontologici diversi:foto di cronaca, icone pubblicitarie, opere d’arte.
Dopo aver posto in luce alcune questioni di metodo, ora, nell’affrontare alcune opere con-temporanee, escluderemo la disamina delle diverse opinioni critiche o della gerarchia di valo-
250
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 250
re, privilegiando invece l’analisi dello sfondo sul quale molte opere acquisiscono significato evalenza comunicativa20.
Iniziamo pertanto dalle considerazioni espresse con incredibile lucidità ed anticipo suitempi da Guy Debord il quale prefigurò lo sviluppo di una società nella quale il consumi-smo e l’entertainment avrebbero colonizzato le menti di milioni di persone. Nel volume LaSociété du Spectacle, pubblicato nel 1967, descrisse in tono oracolare il fascino perverso dellarappresentazione21, proponendo una lettura del fenomeno che viene caratterizzato dall’ubi-quità dell’immagine la quale altera il senso del tempo e della relazione fra il vero e il falsopoiché tutto si trasforma in “qualche cosa da vedere”, tanto che tra la cosa vista e la cosavissuta non esiste alcuno scarto. Secondo questa analisi, lo spettacolo messo in scena daimedia diviene non una realtà seconda, bensì l’unica realtà con la quale ci rapportiamo.Cardine del discorso di Debord è che ogni cosa è indiretta: mediata e filtrata dalla messa inscena televisiva. Questo mondo virtuale sul quale il sole non tramonta mai, con i suoi duemiliardi di televisori accesi22, occupa anche i nostri sogni, le nostre aspirazioni e si è impa-dronito delle nostre vita e della nostra capacità di azione. Ogni flebile potenzialità di agiree di porre in atto il cambiamento è obliterata poiché, per usare le parole di Debord, chi nonfa che guardare il mondo per sapere il seguito, non agirà mai.
Il mondo è divenuto così un feuilleton nel quale la storia non è mai conclusa e quindi èimmobile nel suo infinito susseguirsi di eventi. Debord aveva compreso che nella societàdello spettacolo tutto diviene visibile e tutto si trasforma in una storia da raccontare. La stes-sa politica, servendosene, è rimasta intrappolata in questo meccanismo perverso tanto cheNicolas Sarkozy, in un’intervista a “Le Monde” del 2007, lo descrive con la lucidità di chi èperfettamente integrato nel sistema: “La politica è scrivere una storia condivisa da coloro chela fanno e coloro ai quali è destinata. Non si trasforma un paese senza essere capaci di scri-vere e raccontare una storia”23.
Si tratta di un marketing emotivo che usa le immagini e le storie per avvicinare un numeroquanto più possibile elevato di utenti in nome dell’indice di ascolto: quella trasformazione dellarealtà in fiction profetizzata da Debord è sotto i nostri occhi e produce effetti quanto mai sin-golari nel momento in cui sono gli stessi prodotti di fiction ad incidere metalinguisticamente sulmondo che hanno contribuito a creare. È ad esempio il caso di una serie televisiva di successointitolata Lost, recentemente esaminata da uno studioso24, nella quale il destino riservato ai pro-tagonisti, naufragati su di una misteriosa isola deserta, viene costantemente procrastinato ad unanuova stagione di risposte. È rimandando la soluzione che, nel frattempo, si sviluppano i per-sonaggi i quali rappresentano i miti collettivi e i sogni individuali che vengono costantementeaggiornati nei Blog ricchi di opinioni, suggerimenti e commenti espressi dai fans della serie.Viene quindi a crearsi un circolo indissolubile che confonde autori e lettori tanto che, per mezzodi fiction, reality, talk show, la televisione e internet - con i blog, i siti dedicati ai programmi, you-tube - gli uni e gli altri lavorano di concerto e si completano a vicenda.
Se l’arte contemporanea, costruita sul modello dell’opera aperta25, ha fondato le sue for-tune su artefatti il cui significato risiede nelle infinite sovra interpretazioni, la recente televi-sione sembra ricalcarne le tracce. Questo modello ermeneutico di labirinto senza centro èappunto esplicito nella già citata fiction televisiva Lost; una struttura narrativa nella quale la
251
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 251
spiegazione ultima non esiste. La sua messa in scena sembra l’allegoria di una televisione chetiene avvinti miliardi di utenti a notiziari, telenovelas e telegiornali: c’è sempre qualche cosa dipiù importante che accadrà il giorno dopo.
La stessa distanza fra finzione e realtà si erode costantemente, tanto che in una recente fic-tion dal titolo 24 si è realizzata una perfetta sincronia aristotelica di tempo e azione: ogni pun-tata rispetta i tempi reali e gli eventi si svolgono nell’arco di una giornata scandita in 24 episo-di di un’ora ciascuno - e la stessa pubblicità è integrata nello scorrere del tempo dell’episodio.Tale coincidenza fra il tempo della storia e il tempo del racconto26 contribuisce ad annullate ladistanza simbolica della rappresentazione cinematografica: “Gli eventi vengono presentati allostesso tempo come vissuti e rappresentati, agiti e percepiti senza alcun distacco, in una sincro-nia che permette di fondere il virtuale e l’attuale”27. La contaminazione è tale che, ad un con-vegno di giuristi, un giudice della corte suprema degli Stati Uniti ha giustificato l’impiego dellatortura affermando che Jack Bauer - il protagonista di 24 (sic!) - ha salvato la città di LosAngeles utilizzando strumenti atti a infliggere dolore, utili per ottenere informazioni.
A fronte di questo episodio citato da Christian Salmon28 pare proprio che il cerchio possachiudersi sulla profezia di Debord e forse non sarà troppo azzardato chiedersi, alla luce di que-sto evidente stato confusionale nel quale si realizza lo slittamento della realtà nella fiction - o vice-versa -, quanto abbia influito sulle elezioni presidenziali una serie seguita da milioni di personenella quale il presidente, a forte connotazione positiva, è interpretato da un attore di colore29.
Debord su questo punto era stato fin troppo chiaro quando aveva indicato come lo spet-tacolo non sia solo un insieme d’immagini ma un rapporto sociale fra individui mediato dalleimmagini. Questo “Mostro Mite”, secondo la definizione di Raffaele Simone, rappresenta lastruttura stessa della società dei consumi senza il quale non potrebbe esistere. Una società nellaquale tutti si sono trasformati in spettatori (fig. 6) che, a loro volta, altro non sono che merceda vendere alla pubblicità. Strategia confermata dalla raccolta a fini commerciali dei dati chegli utenti di Facebook mettono a disposizione nel momento in cui esprimono le loro prefe-renze, i loro gusti e le loro opinioni.
Come sarebbe possibile cogliere il significato di un’opera quale Looking forward to a comple-te soppression of pain di Damien Hirst, (1994, München, Brandhorst Museum, fig. 7) se nontenessimo conto che sullo sfondo si proietta un pensiero analitico su questo paradigma cultura-le? Looking forward è un contenitore trasparente dove tutto è visibile, che invita a entrare, marimane comunque un contenitore rigido, assimilabile ad una gabbia, all’interno del quale i tele-visori trasmettono a ciclo continuo lo spot pubblicitario di un farmaco contro il dolore.L’anestetizzazione costante, richiamata anche nel titolo, è l’utopia che la nuova società sta realiz-zando ed è una sintesi efficace, per un osservatore critico, del “Mostro Mite”, il quale “pretendeche si finga che l’intero mondo è tranquillo e in pace, facile e comprensibile, godibile e riparabi-le, protetto da una cappa di scienza amica e tranquillizzante e da un’imperturbabile cortina difun. Vuole che la vita-vacanza fluisca perpetua e indisturbata”30. Ma, a questo punto, dobbiamofare un passo ulteriore rispetto a Guy Debord e rivolgerci a Jean Baudrillard che ne ha piena-mente sviluppato il pensiero definendo una vera e propria filosofia. Per quest’ultimo l’immagineè divenuta il puro simulacro di sé stessa31; se un tempo le immagini erano l’impronta della realtà,oggi si pongono non solo come suo sostituto ma risultano essere totalmente autoreferenziali.
252
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 252
Le immagini sono divenute il veicolo attraverso il quale un fatto diventa evento, si rap-presenta e viene diffuso dagli schermi televisivi, dalle pagine dei giornali e dalle pagine web.Ma nel momento in cui il mondo viene esperito in immagine allora l’avvenimento è l’imma-gine stessa. Che ci sia questa sostituzione del reale con l’effige è evidente nei sentimenti diavversione e amore che gli spettatori provano per le star della TV presenti sia nei telefilm,quanto nei reality o anche nei dibattiti politici. Simulacri che si amano proprio perché consi-derati reali, è così che i fatti divengono reali, così vengono appresi, accolti, commentati edivengono parte della memoria collettiva.
La deriva nichilista di Baudrillard risiede nella concezione che non possiamo più scegliere trale immagini e un’esperienza senza immagini: “Niente difende più l’homo iconicus da queste imma-gini che l’attaccano e l’aggrediscono a domicilio”32. Siamo pertanto immersi nel mondo media-tico, che produce e consuma a una velocità sbalorditiva simulacri e che si è sostituito al reale.
Questa iperrealtà ci illude di poter vivere un’esistenza in cui non ci siano più le distanzepoiché ci sembra di vedere ed essere ovunque in maniera simultanea. Interviste, servizi gior-nalistici da ogni dove, talk show, inchieste, donano l’illusione di un pianeta senza alcuna bar-riera. La globalizzazione trans culturale nello spettacolo collettivo è, in realtà, soltanto un’al-tra illusione mediatica con una pericolosa conseguenza poiché dove tutto è visibile, e noi stes-si ne siamo i testimoni, non c’è bisogno di ermeneutica, di alcuna spiegazione. Lo slogan diFox News è l’imperativo categorico della moderna televisione: We report. You Decide. Il mondoè sotto i nostri occhi e dobbiamo soltanto guardare.
L’intercettazione telefonica, le immagini sconnesse di una telecamera di sorveglianza, la
253
6 - Spettatori cinematografici assistono aun film in 3-D, anni Cinquanta.
7 - DAMIEN HIRST, Looking Forward toa Complete Suppression of Pain.München, Museum Brandhorst.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 253
foto o il filmato realizzato dal dilettante, come il film di Abraham Zapruder, suggeriscono chesi possa avere subito una testimonianza vera e incontrovertibile. L’interpretazione, la valuta-zione, il vaglio e l’incrocio di fonti diverse33 appartengono ad un pensiero critico, propriodella cosiddetta galassia Gutenberg, nella quale regnava ancora la comparazione, la conte-stualizzazione e la dimensione argomentativa. Oggi non ha più alcuna rilevanza: il mondo èdiventato userfriendly - lo si può visualizzare anche sul telefonino - ed è sotto gli occhi di tutti:basta accendere il televisore. Ma, come ha posto in luce Rudolf Arnheim, le immagini noncolgono la situazione generale ma ci trasmettono il particolare, né spiegano le cause quandoci fanno vedere gli effetti. Comprendere significa cogliere l’essenziale che non è racchiusonelle impressioni più di quanto il carattere di una persona si rispecchi nel suo volto, tuttavia“quanto più diventano confortevoli i mezzi d’informazione tanto più si rafforza l’illusionepericolosa che per conoscere sia sufficiente vedere”34.
Ma questa sovrabbondanza d’immagini è andata al di là anche della constatazione diArnheim, ha generato un desiderio bulimico che non è più informazione o strumento di cono-scenza ma puro entertainment in tutte le sue possibili varianti nel caleidoscopico vortice delloschermo televisivo35: infotainment36, politainment37, docudrama38, docufiction39, mockumentary40.
Secondo Jean Baudrillard, portando questo pensiero alle sue estreme conseguenze, la stra-tegia fatale ha raggiunto il suo scopo e si è compiuto il delitto perfetto41. Il mondo scompareper essere sostituito dalla iperrealtà che ne cancella le tracce. Questo nuovo mondo è una simu-lazione generata sul modello di una realtà che però è stata cancellata - ecco il delitto perfetto -ed ora la mappa del territorio precede il territorio. Se nel racconto di Jorge Luis Borges rima-nevano, qua e là, lacerti della carta abbandonata42 ora, al contrario, è del reale che rimangonovestigia residue. Il concetto viene così riassunto dal pensiero di Hans Belting: “Misuriamo ilmondo in base alla somiglianza che ha con le immagini, e non viceversa. Il mondo non è lamatrice per le immagini […] ma le immagini sono diventate matrici del mondo”43.
Da questo punto di vista, le immagini non sarebbero più “una finestra attraverso la qualetu miri” ma un mondo altro44. Prendiamo ad esempio l’abitudine apparentemente bizzarra dimolti turisti di osservare chiese, quadri, palazzi e piazze, filtrando la visione diretta con loschermo digitale di una macchina fotografica o di una micro telecamera. È operazione bendiversa dall’osservare attraverso il mirino di una reflex o di una macchina a telemetro: quiabbiamo un ritaglio del mondo, una messa in cornice - “una finestra attraverso la quale tumiri” appunto - mentre nel primo caso abbiamo una trasmutazione dal visivo al digitale, comese osservassimo il paesaggio attraverso un micro schermo televisivo. Si tratta di un’immaginegià trasformata, già mediata, di un simulacro e non di una semplice porzione dello sguardo.
Questa immagine digitale diviene per Baudrillard la metafora perfetta per illustrare la con-versione del nostro mondo nel virtuale. La fotografia è divenuta numerica, libera in un solcolpo del negativo e del mondo reale. La foto argentica è un’immagine prodotta dal mondoche implica, grazie al medium della pellicola, una dimensione della rappresentazione.L’immagine digitale è un’immagine uscita direttamente dal video (écran), essa è dipendentedalle funzioni automatiche dell’apparecchio: “Quando il calcolo, il digitale prevale sulla forma,quando l’algoritmo matematico prevale sullo sguardo, si può ancora parlare di fotografia?”45.
Così sarebbe da chiedersi perché le persone presenti alle esequie di Giovanni Paolo II deci-
254
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 254
dano di partecipare all’evento guardando e ritraendo ciò che accade attraverso macchine foto-grafiche, telefonini e videocamere (fig. 8). Da un lato realizzano ciò che Roland Barthes avevadetto della fotografia che testimonia di un “è stato”46 ma, al contempo, trasmutano l’espe-rienza trasformandola hic et nunc in un simulacro.
Poiché diventa sempre più difficile concepire il mondo attraverso una modalità che nonsia quella di scattare una foto, come non riconoscere in ciò non una pratica bensì un para-digma culturale attraverso il quale concettualizzare gli eventi. Il mondo può apparire inesi-stente senza una TV che lo ritragga. Di conseguenza l’unica dimensione conosciuta è quelladi una realtà che si offre come una sequenza d’immagini registrabili e qualunque cosa nonsia registrabile viene negata47.
In questa dinamica i simulacri hanno trasformato gli accadimenti in eventi, i quali sonomessi in scena con il fine di ottenere il massimo impatto sugli spettatori. Hanno una vita bre-vissima perché sono immantinente sostituiti da altri eventi che promettono di essere ancor piùimportanti, se non addirittura epocali. Con il prevalere dell’immagine e dell’impatto media-tico, con la conseguente degenerazione dei contenuti, ciò che conta non sono i ragionamen-ti espressi, o le idee manifestate, bensì la possibilità di accedere ai mezzi di comunicazione48.
L’arte stessa non sfugge a questa condizione49, seppure, in alcune opere, è evidente che la stes-sa effimera istallazione altro non sia che una citazione critica dell’obsolescenza della notizia, delconsumo apatico di atrocità che vengono dimenticate nell’arco di una giornata. È il caso deibambini - in realtà dei pupazzi - impiccati da Maurizio Cattelan in un parco di Milano nel 2004.Questa strategia del massimo impatto è un’invenzione del nostro tempo e la politica stessa ne faampiamente uso nel suo lavoro di spin doctoring50. Tony Blair, che con queste tecniche seppecostruire il suo successo mediatico, lo conferma esplicitamente: “I media contano sempre di piùe sono indotti ad agire dall’impatto che ha una notizia. A contare è l’impatto […] certo l’accu-ratezza di una storia conta anch’essa, ma è secondaria rispetto all’impatto”51.
Se esiste un’opera che è riuscita a compendiare tutti gli aspetti finora considerati - dallaiperrealtà dei media, all’impatto dell’evento - questa è sicuramente La Nona Ora (fig. 9). Anzi
255
9 - MAURIZIO CATTELAN, La Nona Ora, partico-lare della scultura di Daniel Druet. Basel,Kunsthalle, 1999.
8 - Folla alle esequie di Giovanni Paolo II a Roma, 8aprile 2005.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 255
sono proprio questi tratti, definibili enfaticamente lo Zeitgeist dell’era post moderna, cheoffrono un criterio d’interpretazione della mise en scène di Maurizio Cattelan.
Il soggetto ha destato molto scalpore e l’installazione, presentata a Varsavia nel gennaio2001, dopo quella di Basilea del 1999, ha suscitato viva polemica come profanazione delsacro52 e la galleria Zacheta ha dovuto chiudere l’esposizione53.
Eppure, come cercheremo di delineare, l’installazione riesce a fornirci qualche elemento diriflessione sul nostro mondo poiché allude ad alcuni elementi che sono diventati parte inte-grante del nostro paradigma culturale.
Abbiamo già accennato alla dinamica avviata dalla sovrabbondanza d’informazione chetende a favorire un desiderio maniacale d’immagini, ma il fenomeno, come lucidamentedescritto da Zygmunt Bauman, si attua poiché i media rappresentano il mondo attraverso unaserie di eventi e tutti noi, in quanto consumatori di eventi, veniamo spinti verso una forma dibulimia. Nemmeno l’ordine in cui si susseguono gli eventi ha qualche importanza, tanto che“la coppa del Mondo può seguire la morte della principessa Diana che può seguire le idiosin-crasie erotiche di Bill Clinton che possono seguire l’inondazione in Mozambico. L’ordine puòessere facilmente invertito o mischiato; l’ordine non conta nulla in quanto non è implicataalcuna connessione causale; al contrario l’accidentalità e casualità della successione testimonia-no la natura contingente del mondo […] Ciò che conta, e molto, è che ciascun evento sia abba-stanza eclatante da conquistare le prime pagine, ma che scompaia prima di afflosciarsi”54. Diquesta messa in scena globale, di questo fast food degli eventi, noi siamo soltanto spettatori, anziconsumatori, non attori. Se nel combine painting di Robert Rauschenberg (Retroactive I, 1964,fig. 10) è ancora possibile cogliere una coerenza fra le immagini mediatiche e il mito dellanuova frontiera rappresentato da J. F. Kennedy, una sorta di manifesto del futuro che si fa pre-sente, nella totale disconnessione della società spettacolarizzata è l’imprevedibile e lo sconcer-tante a reclamare il suo spazio vitale. Poiché è la ricerca di eventi emozionali sempre più fortia guidare la mano sul telecomando, o sul mouse, ecco che Maurizio Cattelan pone, sotto inostri occhi, l’evento che gli spettatori drogati desiderano o, come direbbe W. J. T. Mitchell,what pictures want, come se i simulacri televisivi avessero ormai assunto una vita desiderante eci imponessero dei comportamenti e dei valori55. A seguito della continua aggressione da partedi shock visivi diffusi dalla televisione, soltanto qualcosa di ancora più eclatante potrà scuoter-ci dalla nostra assuefazione alla logica degli eventi mediatici e Cattelan ce la procura.
Se il dipinto Retroactive I appartiene ancora ad una prassi artistica che potremmo definiredel rispecchiamento56 di una realtà messa in scena dalla TV, sia pur trasfigurata e metaforica,La Nona Ora fa un ulteriore passo, impossessandosi non delle sue immagini, ma della logicadei media e portandola alle estreme conseguenze. Quando, percorrendo la sala (fig. 11), avvi-ciniamo la figura dolente di Giovanni Paolo e assistiamo alla messa in scena di un martiriodel XXI secolo, possiamo soddisfare, per un breve attimo, quell’insano desiderio di eventosbalorditivo dal quale i media ci hanno reso dipendenti.
Se è il desiderio bulimico a dominarci, il fatto che l’evento sia vero o falso ha un’impor-tanza secondaria. E siamo pertanto giunti alla posta in gioco più alta che l’opera di Cattelanmette in campo: la finzione e la realtà.
Come abbiamo cercato di rendere evidente, un paradigma culturale è una sorta di lente
256
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 256
attraverso la quale non solo concettualizziamo il mondo, ma per mezzo della quale conferia-mo un senso alla nostra vita. Naturalmente tutto avviene in maniera inconscia poiché si trat-ta del mondo della vita quotidiana, non di una maschera che siamo consapevoli di indossare.Questo paradigma ha eroso progressivamente la linea di demarcazione fra finzione e realtà.Certo, per quanto attiene la nostra vita quotidiana direttamente esperibile e verificabile, siamoin grado di stabilire quale sia la realtà e quale la finzione sbagliandoci raramente, ma per quan-to riguarda la conoscenza che acquisiamo del mondo attraverso la televisione, internet e lastampa, i criteri di discriminazione diventano meno sicuri e spesso sussiste la sensazione chetutto sia una sorta di messa in scena.
Quando nel film Citizen Kane di Orson Welles il protagonista, direttore rampante di ungiornale, riceve dal corrispondente da Cuba la conferma che non c’è alcuna guerra e cheavrebbe potuto inviargli soltanto un componimento poetico, Charles Foster Kane, gli rispon-de: “You provide the poems, I’ll provide the war”. Non è un caso che Guy Debord sia stato anti-cipato in questa breve frase pronunciata da Kane-Welles57 poiché proprio il regista duranteuna trasmissione radiofonica aveva indotto migliaia di americani a pensare che fosse avvenu-to uno sbarco di alieni sulla terra.
Ora tutti consideriamo una finzione letteraria - o cinematografica - non come un inganno,
257
11 - MAURIZIO CATTELAN, La Nona Ora. Basel,Kunsthalle, 1999.
10 - ROBERT RAUSCHENBERG, Retroactive I.Hartford, Connecticut, Wadsworth Athenuem.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 257
un falso ma come un “mondo possibile” che ci permette di arricchire la nostra esistenza58, tut-tavia nel film di Orson Welles, basato sulla biografia di un personaggio realmente esistito, ilmagnate del giornalismo William Randolph Hearst, è divenuto estremamente difficile separa-re il personaggio immaginario da quello realmente esistito59. La stessa frase attribuitagli sullapresunta guerra a Cuba (“You provide the pictures, and I’ll provide the war”), ripresa da Wells, èun apocrifo che tuttavia ha avuto lunga vita in base al principio che si attagliava troppo beneal personaggio reale per non essere vera60. È ciò che Norman Mailer denominò un factoid - unfattoide - che consiste nel credere in ciò che sembra convincente ma che in realtà, per usare untermine italiano, è fasullo. Naturalmente di fattoidi, come ha scritto Gillo Dorfles, ne è pienoil mondo contemporaneo. Trattasi di pseudoeventi che hanno tutta l’apparenza della realtà. PerBaudrillard, come abbiamo cercato di evidenziare, il reale è addirittura vanificato dai segni:“Car l’illusion ne s’oppose pas à la réalité, elle en est une autre plus subtile, qui enveloppe la pre-mière du signe de sa disparition”61.
Nella versione più moderata di Gillo Dorfles, i fattoidi sono manipolazioni che inficiano larealtà - senza tuttavia sostituirla integralmente - conservandone comunque la verisimiglianza:“Ecco un esempio preso dal film di Wim Wenders Tokyoga, dove si può assistere all’episodiod’un dirigente d’azienda che sale all’ultimo del suo grattacielo e va a giocare una partita di golf.Il finto gioco del golf, sul green di plastica mi sembra rientrare in pieno tra gli pseudo eventi”62.
Che i cosiddetti fattoidi siano divenuti materiale d’ispirazione per gli artisti dalla Pop Artin poi sembra fin troppo ovvio, ma non inutile ai fini della nostra analisi. È indubbio che lascena del golf descritta da Gillo Dorfles, nella sua assurda artificialità, potrebbe essere l’in-stallazione di un artista contemporaneo, proprio per il suo aspetto iperreale.
È insito nell’effetto straniante di questa scena riuscire a trasfigurare in immagini simboli-che la nostra condizione attuale, nella quale finto e fasullo si confondono in un prodotto vir-tuale dal quale siamo affascinati e fatalmente sedotti. Anche se non volessimo condividere pie-namente la visione di Baudrillard secondo la quale “non solo le tracce del nostro passato sonodiventate virtuali, ma il nostro stesso presente è abbandonato alla simulazione”63, è indubbioche siamo diventati avidi e dipendenti dalle immagini che altro non sono che un surrogatodella realtà64. Tuttavia, il fattore che univa l’immagine al referente nell’epoca pre digitale sisostanziava nel principio ingenuo secondo il quale il filmato o la fotografia si ottenevano attra-verso una sorta di protesi visiva che permetteva di ottenere un’impronta del visibile.
Per lo spettatore quindi osservare con un cannocchiale o con una telecamera posta in un’al-tra stanza non differiva dall’osservare una scena colta a migliaia di chilometri di distanza.Come ben noto, le immagini non sempre erano in presa diretta ma trasmesse in differita, sep-pure venissero vissute come se lo fossero65. Inoltre, inserite all’interno di un telegiornale - oin un documentario con un commento e un montaggio - mantenevano comunque questo filotenue che le legava alla “realtà”. Ora, con il digitale, anche quest’ultimo legame, già di per sécapzioso, è scomparso; si simulano situazioni puramente virtuali - i videogame - o si ricreanoincidenti e omicidi, dei quali non abbiamo immagini, tuttavia necessarie per rendere visibilel’evento66. Sono raffigurazioni false ma che abbiamo iniziato a trattare come se fossero vere ereali senza percepire il benché minimo scarto.
L’effetto di tutto ciò è che “la distinzione si indebolisce fino a sparire. In questo modo il
258
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 258
falso deborda nel vero, lo avviluppa e divora fino a installarsi al suo posto con piena autoritàontologica”67.
Come abbiamo cercato di sintetizzare, secondo Jean Baudrillard si è cominciato a parlaredi meurtre de la réalité nell’era dei media, del virtuale, della rete, ma per il filosofo francese ilprincipio di questa vicenda risale all’epoca moderna quando, attraverso la scienza e la cono-scenza analitica del mondo, il calcolo matematico e il telescopio di galileo, si sono prese ledistanze dal mondo reale. O, per meglio dire, l’uomo prende congedo dal reale proprio nelmomento in cui desidera costruirne un modello per dominarlo: “un processus de dissolution(“analyser” signifie littéralement “dissoudre”)”. Tutto quindi inizia con il linguaggio, con la con-cettualizzazione delle cose: “È quando una cosa comincia a scomparire che il concetto appa-re”. È con il linguaggio e la concettualizzazione che il genere umano ha dato inconsapevol-mente inizio ad una stratégie fatale che lo condurrà ad uscire dalla realtà e dalla storia in unadimensione ove tutte le distinzioni di vero e di falso saranno scomparse68. In questa GrandDisparition (la fotografia è un buon esempio di presenza del mondo in assenza dello stesso)quindi non c’è soltanto una trasmutazione delle cose nel virtuale (de la mise en abyme de laréalité) bensì una polverizzazione di tutte le coscienze.
E quali, secondo Baudrillard, le conseguenze di ciò nell’arte? In un mondo nel quale scom-paiono istituzioni, valori, individui, ideologie, insomma nella fine della fine (des fines derniè-res), secondo una profezia hegeliana che si autoadempie, anche l’arte stessa non esiste più69.
Per Baudrillard l’artista che ha posto la definitiva pietra tombale sull’arte contemporaneaè Andy Warhol: “Ciò che apprezzo in Andy Warhol è il suo approccio alle serie, la sua ironia,la sua decisione di abolire l’arte”70. Nella sua analisi Warhol è una macchina che semplice-mente riproduce puri prodotti visivi: “Warhol è il primo artista che sia passato al feticismoradicale […] Ciò gli è valso quella forma particolarissima di fascino che si addice soltanto alfeticcio […] E il famoso quarto d’ora di celebrità di cui parla non è altro che la facoltà di acce-dere a tale estrema insignificanza, quella che fa il vuoto attorno a sé, e verso la quale, quindi,tutti i desideri sono irresistibilmente attratti”71. Nell’elaborare una “serie di icone estatiche einsignificanti” fa si che l’immagine sia una “raffigurazione pura, senza la benché minima tra-sfigurazione”72. Non si tratta di un’utopia critica, come quella dei surrealisti o del dadaismo,il suo snobismo consiste proprio nell’annientamento dell’artista e dell’atto creativo. Non acaso Baudrillard cita le parole di Warhol: “Più superficiale di me, muori”. Si tratta pertantodi un agnosticismo estetico - “Warhol afferma: l’arte esiste (forse) ma non ci credo” - e nondi un presunto valore critico alla società dei consumi né di una complicità con il sistema deimedia. Un mondo possibile nel quale tutti sono comparse:”Marilyn è una comparsa: è unastar soltanto perché è entrata nella rappresentazione pura”.
E così giungiamo al punto nodale della questione: perché secondo Baudrillard l’arte diWarhol rappresenta il corrispettivo perfetto della sua filosofia del simulacro. L’artista ameri-cano incarna con precisione il paradigma della scomparsa del reale sostituito dalla rappresen-tazione. In un mondo ove tutto è condannato alla rappresentazione - dalle guerre, alla politi-ca, ai divi creati dai media stessi - la grandezza di Warhol consisterebbe nel godere di questostato di rappresentazione come di una seconda natura. Cosicché Warhol non apparterebbealla storia dell’arte poiché non rappresenta nulla ma vi appartiene poiché, come se fosse una
259
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 259
manciata di pixel, rappresenta un frammento della grande immagine della nuova realtà.Tuttavia per Baudrillard, dopo l’operazione messa in atto da Warhol, all’arte non resta che
il rituale della visita a mostre e musei, fenomeno da studiare antropologicamente73. L’arte stes-sa è divenuta incapace di creare una trasfigurazione del reale poiché dove tutto è divenutosimulacro non c’è più posto per un altro simbolico74. Cosicché, a suo modo di vedere, agliartisti non resterebbe che una forma di citazionismo che ricapitoli ciò che è già stato fatto: “Ladistinzione tra l’arte e la produzione di immagini, comuni, banali, è sempre meno netta. Ilsolo ad aver preso atto e a gestire con radicalità questa banalizzazione totale dell’estetica […]è Warhol. A mio avviso, all’infuori di lui si ha a che fare con delle forme artistiche ed esteti-che che sono più animate dalla disillusione che non da altro”75.
Il filosofo francese arriva quindi a decretare la fine dell’arte per un suo esaurimento endo-geno; si tratterebbe di una sorta di consunzione degli strumenti e dei modi propri della rap-presentazione. Si assisterebbe pertanto alla fine di un processo che si è consumato negli ulti-mi cinquant’anni76 e all’arte non rimarrebbe altro che l’autocitazione.
Il ragionamento di Baudrillard mostra comunque alcune crepe quando scrive: “Warholha compreso ciò, ha capito che la macchina genera l’illusione totale dell’uomo moderno, edè adottando il gioioso punto di vista di questa rappresentazione macchinale che ottiene unaspecie di trasfigurazione, mentre l’arte che si crede tale fa soltanto la figura di una volgaresimulazione”77.
Baudrillard attribuisce all’artista americano una forza che deriva dalla sua innocenza disin-volta. È indubbio che, senza una buona dose di disinvolta ignoranza, non avrebbe potutocambiare volto all’arte del dopoguerra, ma anch’egli si lascia sfuggire il pensiero secondo cuile immagini dell’artista americano sarebbero “una specie di trasfigurazione”. E non può esse-re che così nel momento in cui ci dicono qualche cosa sulla nostra condizione e riescono aparlarci del mondo nel quale viviamo. La stessa collocazione museale degli artefatti fa si che,ipso facto, divengano degli inneschi simbolici78; si trattino di interpretazioni forzate, aberran-ti o riduttive, e di opere banali o straordinarie, il tentativo di imporre loro dei significatisecondi rispetto alla loro semplice identificazione diviene inevitabile nel momento in cui ven-gono esposti in una galleria. Il significato delle opere risulta così legato tanto ai rimandi extra-testuali quanto allo sfondo storico e sociale del quale sono parte.
L’installazione La Nona Ora di Maurizio Cattelan è la dimostrazione evidente che l’artepuò riferirsi al nostro tempo non come semplicemente frammento ma per porre in atto unadinamica raffigurativa extratestuale - la tradizione iconografica del martirio dei santi - e inter-testuale, quasi fosse un fotogramma del caleidoscopio mediatico contemporaneo. Questadinamica costituisce un piano di attribuzione di significati; esistono pertanto ancora artefattisimbolici che, alludendo a specificità culturali condivise, parlano del mondo trasfigurandolo:la nemesi storica di Baudrillard non si è avverata.
Abbiamo cercato di porre in luce come molta parte del pensiero contemporaneo, sociologi-co e filosofico, concordi sul fatto che ci confrontiamo con un mondo nel quale il falso debordanel vero, e come l’uomo stesso sia avviluppato totalmente in questa finzione. Rimane da chie-derci quale shock può riportare questo “nuovo uomo mediatico” ad essere consapevole di ciò chesta accadendo con la sua piena e volonterosa collaborazione? La Nona ora con la sua scena iper-
260
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 260
reale e sconcertante - Giovanni Paolo II colpito a morte da un meteorite entrato dal lucernario- è un’operazione catartica che desta in noi sconcerto non semplicemente per la sua assurdità maperché, per un attimo, ci scuote dall’ipnosi mediatica nella quale viviamo. Come abbiamo giàposto in evidenza, ciò avviene poiché l’opera non è una citazione di immagini modello messe inscena dalla TV, ma trasfigura la logica dell’evento mediatico portandola al parossismo.
In una recente intervista è lo stesso artista a confermare che le fonti visive e concettuali pro-vengono dai media: “[Le immagini] sono una statistica variazione del reale. Io sono interessatoalla realtà, quella che vediamo ogni giorno: un pensiero, qualsiasi cosa che si sia vista alla TV oche si sia letta nei giornali, che abbia lasciato un’impressione scivolando sul web. Le immaginihanno la forza di riassumere il presente e forse di trasformare in un’anticipazione il futuro. Forseil mio lavoro è soltanto una lente d’ingrandimento che permette di vedere i dettagli nascostidella realtà […] Questo è ciò che veramente mi interessa dell’arte: la possibilità di inventareimmagini che innescano reazioni, che divengono uno specchio del nostro tempo. Non c’è unagrande differenza fra l’antenna TV e l’artista: entrambi sono meccanismi di comunicazione,segnali che amplificano. Più che un artista io mi sento come un impiantista di antenne”79.
Catherin Franblin ha osservato come Baudrillard sia uno dei pensatori francesi più fre-quentemente citati nell’ambito della scena dell’arte contemporanea. I critici infatti utilizzanoi suoi testi per commentare le opere degli artisti mentre gli artisti citano i suoi testi quali apo-logia del loro lavoro80 e, come ha cercato di spiegare Nicholas Zurbrugg81, l’impatto diBaudrillard deriva dal fatto che il suo pensiero suggerisce un modo alternativo per ragionaresulle cose, elaborando una maniera specifica di riconsiderare il passato e i possibili sviluppifuturi di quanto sta accadendo, giorno per giorno, nel mondo dominato dalla tecnica.
La nostra tesi consiste nell’affermare che non è affatto necessario postulare una conoscen-za dell’autore francese da parte degli artisti per spiegare la genesi creativa di molte opere con-temporanee. A tal proposito risulta evidente come per i critici sia una chiave di lettura effica-ce, e noi stessi ne abbiamo fatto ampio uso per spiegare il contesto, tuttavia è lo stesso mondodei media a porre continuamente a noi - osservatori modello - e a loro - in quanto autorimodello - il dilemma della sostituzione del reale dovuta all’erosione dello scarto fra realtà efinzione. È proprio questo comune paradigma culturale a far si che tali opere instaurino unacomunicazione con il pubblico. Il contributo di Baudrillard è stato quello di renderci eviden-te la sindrome collettiva di tutta una cultura82, ma se ciò risponde al vero, al di là delle sotti-gliezze filosofiche, è verosimile che tanto gli artisti - a proposito si rileggano le parole diCattelan - quanto noi stessi lo abbiamo intuito, seppure inconsapevolmente. È la stessa cul-tura popolare a far riemergere l’inganno: i libri di Philip K. Dick83, le fiction84, i reality show85,i docudrama che, per citare le parole di Roberto Nepoti, rendono “ancora più inestricabilequel viluppo di realtà e irrealtà che è diventata la nostra vita”86. In questa potenziale presa dicoscienza giocano un ruolo rilevante le pellicole cinematografiche - Matrix, Truman Show -che fanno esplicito riferimento a questa condizione. Si è così consolidata una vera propria ico-nologia della realtà dissolta87.
Nell’ambito cinematografico, da questo punto di vista, è istruttivo il film Death of a President(2006, di Gabriel Range e Simon Finch). Si tratta di un falso documentario - un mockumentary- su un fatto mai avvenuto: l’attentato al presidente George W. Bush a Chicago il 19 ottobre
261
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:10 Pagina 261
2007. Seppure la pellicola abbia suscitato ampie polemiche per il tema trattato, in realtà nonmette in scena la morte di un presidente ma la morte di una verità, quella dei media.
Se W. J. T. Mitchell aveva già posto in luce come Oliver Stone avesse realizzato il film inchie-sta sull’assassinio di J. F. Kennedy sulla base delle immagini del film amatoriale di AbrahamZapruder - sgranate, mosse e sfuocate -, l’utilizzo non solo iconografico ma formale di queldocumento88, conferma il fatto che qualsiasi nostro rapporto con gli eventi è mediato dalleimmagini, anzi, come direbbe Jean Baudrillard, sono le immagini ad essere divenute gli eventi.
Death of a President è costruito in maniera analoga, utilizzando sequenze d’archivio (“vere”)e ricostruzioni in stile documentario (“false”) - girate con telefonini, videocamere e telecameredi sorveglianza - ma, a differenza del film di Oliver Stone, rappresenta una riflessione metalin-guistica sul codice del documentario. L’utilizzo di materiale di repertorio televisivo e dei modinarrativi del reportage giornalistico permette l’abolizione della linea di confine fra il vero e ilverisimile: il codice è il messaggio. L’effetto realtà è sbalorditivo ed al contempo la sensazionestraniante che ci assale, per il fatto che sappiamo di vedere documentato un fatto mai accaduto,è vertiginosa. La locandina di Death of a President (fig. 12), concettualmente e formalmente,appartiene alla stessa iconologia de La Nona Ora (fig. 13) ed entrambe le immagini dimostranoche nel momento in cui il falso mette in scena sé stesso la verità sembra finalmente affiorare.
262
13 - MAURIZIO CATTELAN, La Nona Ora, partico-lare. Basel, Kunsthalle, 1999.
13 - Locandina del film di Gabriel Range, Deathof a President, 2006.
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 262
NOTE
1 La definizione rimanda al testo di Guy Debord, pubblicato nel 1967, del quale utilizzeremo la tra-duzione italiana: La società dello spettacolo - commentari sulla società dello spettacolo, Milano 2002, conun’introduzione di C. FRECCERO, D. STRUMIA.
2 Ci limitiamo a citare il testo di Gillo Dorfles (Simbolo comunicazione e consumo, Torino 1962), cheperaltro ravvisava un’accelerazione della disintegrazione simbolica nell’epoca del consumismo.
3 E. H. Gombrich (E. H. GOMBRICH, Art and illusion: a study in the psychology of pictorial represen-tation / E. H. GOMBRICH, London 1960, trad. it. Arte e illusione, Torino 1965, in particolare il II capi-tolo Verità e formula stereotipa, pp. 75-111) è stato il primo a porre in relazione le immagini e gli sche-mi interpretativi sia di coloro i quali le decodificavano che di coloro che le creavano. Questa lunga sto-ria che occupa un capitolo rilevante in ambito semiotico sembra giunta ad una sostanziale sintesi neltesto di U. ECO, Iconismo e ipoicone, VI cap. in Kant e l’ornitorinco, Milano 1997, pp. 295-348.
4 Sul Kitsch rimangono tuttora imprescindibili, seppur datati, i testi di U. ECO, La struttura del cat-tivo gusto, in Apocalittici e Integrati, Milano 1964, pp. 65-130; G. DORFLES, Il kitsch: antologia del cat-tivo gusto, Milano 1968.
5 Nel 2009 Shepard Fairey ha realizzato per la Sacks Fifth Avenue, uno dei più lussuosi grandi magaz-zini di New York, le illustrazioni per il nuovo catalogo e le borse da donare agli acquirenti. La graficaricalca il costruttivismo russo, in particolare le opere di El Lissitzky e Alexander Rodchenko, con lo slo-gan Want You scritto in caratteri squadrati costruttivisti. Si tratta evidentemente di una campagna che sirivolge, in maniera sorniona, a un pubblico colto e raffinato.
6 È un Gedankenexperiment meno sofisticato di quello proposto da Arthur C. Danto nel 1964: TheArtworld, “The Journal of Philosophy”, 61, 19, American Philosophical Association Eastern DivisionSixty-First Annual Meeting, “October”, 15, 1964, pp. 571-584, in particolare l’esempio dei due dipin-ti identici pp. 577-580, poi ripreso in A. C. DANTO, The transfiguration of the commonplace: a philosophyof art, Cambridge 1981, trad it. La trasfigurazione del banale, Bari 2008.
7 Questa pubblicità (2007) menziona il prodotto in maniera fugace soltanto alla fine dello spot. Essarievoca, e al contempo delinea, un orizzonte di emozioni e di valori che si legano, nella versione italia-na, con personaggi ed eventi salienti della storia mediatica della Repubblica. Da questo punto di vistaavrebbe potuto essere lo spot di un partito politico poiché il testo e le immagini pongono in rappresen-tazione l’immaginario collettivo del paese: “I miei maglioni hanno un piccolo tricolore sulla manica. Elo porto con orgoglio, io. L’Italia non è un concetto astratto. Esiste. Come ce l’abbiamo fatta noi a tro-vare la gente giusta per risorgere, ce la può fare anche il Paese. Qui dentro non si è mai brindato a qual-cosa che non riguardasse la Fiat. Ci sentiamo una comunità dominata da un forte senso di appartenen-za. Sarebbe bello vederlo anche fuori di qui. Come in Francia. Lo spot andrà anche lì, e le immaginisaranno ovviamente francesi, da De Gaulle a Platini” (Marchionne: “Vi racconto lo spot della nuova 500,l’ho fatto io”, intervista di M. GRAMELLINI, “La Stampa.it”, 4 luglio 2007). Nel concreto, lo spiritopatriottico e il senso di appartenenza ad una comunità di cui parla l’amministratore delegato del grup-po FIAT è divenuto emotional branding. Si è, direbbe Jean Baudrillard, svaporato in una serie di imma-gini sullo schermo (Falcone e Borsellino, i magistrati uccisi dalla mafia, il presidente della RepubblicaAlessandro Pertini ai mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1982, alcuni sportivi vittoriosi…), una musi-ca e un commento fuori campo: “La vita è un insieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo.? Ilnostro tempo.? Noi cresciamo e maturiamo collezionando queste esperienze.? Sono queste che poi vannoa definirci…”. Per un’analisi semiotica dello spot rimando a Lidia Manzo, La nuova Fiat appartiene atutti noi. Analisi semiotica della campagna di lancio pubblicitario della nuova Fiat 500, “Ocula - Occhiosemiotico sui media”, 12, 2009, pp. 1-33 (www.ocula.it).
8 E. H. GOMBRICH, La parte dell’osservatore, in Arte e illusione … cit., pp. 221-349.
263
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 263
9 Per una proposta alternativa all’Art Wordl di A. C. Danto: M. FERRARIS, La fidanzata automatica,Milano 2007. Le due interpretazioni, dal nostro punto di vista, possono comunque completarsi a vicen-da come cercheremo di sostenere più avanti parlando del valore emotivo dell’opera.
10 J. BAUDRILLARD, Al di là della fine (2002), in Pataphysique (2006) ed. ita., Patafisica e arte del vede-re, Firenze 2009, p. 28.
11 A. SEMPRINI, Analyser la communication. Comment analyser les images, les médias, la publicité, Paris1996, trad. it Analizzare la comunicazione, Milano 2003, in particolare pp. 31-86.
12 “Una nota informativa a piccoli caratteri spiega che gli indumenti sono stati ottenuti con l’accor-do del padre della giovane vittima. L’unico altro testo presente nell’immagine è il logo-firma dellamarca”, A. SEMPRINI, Analizzare la comunicazione … cit., p. 72.
13 Per tale motivo fece soltanto uno schizzo a matita dell’avvenimento. Deciso a documentare perimmagini lo storico avvenimento fotografò comunque il luogo nel quale avvenne l’esecuzione capitale eMassimiliano ricomposto nella bara (H. M. KOETZLE, Photo Icons. The Story Behind the Pictures. 1827-1991, Köln 2005, pp. 62-69.)
14 È il motivo per il quale la macabra foto dell’iracheno incappucciato e a braccia aperte al qualeerano stati collegati degli elettrodi scattata ad Abu Ghraib trascese il suo significato e divenne simboli-ca. Il rimando extratestuale alle immagini della passione di Cristo, come ha posto in evidenza W. J. T.Mitchell, è dovuto alla sua somiglianza con la rappresentazione artistica del martirio (Si veda la letturadi W. J. T. MITCHELL, Cloning Jesus, in The Life and Death of Image Ethics and Estethics, London 2008,pp. 198-207). Tuttavia questa, e altre agghiaccianti fotografie, ebbero al contempo una funzione a-sim-bolica. Infatti divennero delle prove determinanti per sostenere l’accusa di abusi ingiustificabili sui pri-gionieri: “Personalmente non ho alcun dubbio che l’unica differenza tra Abu Ghraib e Guantanamo ole prigioni in Afghanistan sia stata la presenza di una macchina fotografica” (intervista di Raffaele Orlania Janis Karpinski, generale incaricato della gestione della prigione di Abu Ghraib, in “Il Corriere dellaSera”, allegato, 9 dicembre 2006, pp. 93-96: 94). Per un’esauriente ed istruttiva spiegazione della derivaviolenta nelle condizioni di prigionia P. G. ZIMBARDO, The Lucifer Effect: Understanding How GoodPeople Turn Evil, New York 2007, trad. it. L’effetto Lucifero, Milano 2008.
15 Così definito efficacemente da A. SEMPRINI, Analizzare la comunicazione … cit., p. 76.16 A. SEMPRINI, Analizzare la comunicazione … cit., pp. 81 ss.17 Questo cambiamento emerge, nel caso specifico dell’Italia, anche dal compendio di storia cul-
turale della nostra repubblica dal dopoguerra a oggi di Michela Nacci (Storia culturale dellaRepubblica, Milano 2010).
18 A tale proposito Umberto Eco coniò il termine “neotelevisione” (Il desiderio di trasparenza, in Setteanni di desiderio - Cronache 1977-1983, Milano 1983, pp. 127-180).
19 Gli effetti ansiogeni sono sotto i nostri occhi. Questa girandola rutilante nella quale diviene impos-sibile discernere ciò che è attendibile da quanto è fasullo e mistificato, spiega il proliferare di ipotesi cospi-rative e di oscuri complotti che consentono di attribuire un significato a eventi altrimenti incomprensi-bili. Cosicché si sono lentamente imposte misteriose motivazioni sulla distruzione delle Twin Towers osulla influenza suina. Secondo David Aaronovich si tratta di un fenomeno inquietante del nostro secoloche deriva dall’incapacità da parte delle persone di interiorizzare una versione coerente di quanto accade.L’ansia di dare un senso comprensibile al continuo ed incessante susseguirsi di eventi genera spiegazioniche alleviano il senso di angoscia della perdita di controllo sul mondo e sulle nostre vite: D. AARONOVICH,Voodoo Histories: The Role of Conspiracy Theory in Shaping Modern History, New York 2009.
20 Il tentativo di elaborare un’iconologia del presente è ben delineato in una serie di saggi, a cura diGottfried Boehm e Horst Bredekamp in Ikonologie der Gegenwart, München 2009. Per quanto riguardaquesti temi in traduzione italiana si rimanda invece ai saggi raccolti da Andrea Pinotti e AntonioSomaini, in Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, Milano 2009 e al testo di W. J. T.
264
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 264
MITCHELL, Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, ed. ita. Palermo 2000.21 A questo proposito C. FRECCERO, D. STRUMIA, Introduzione, in La società dello spettacolo … cit.,
pp. 7-27.22 È la metafora di Zygmunt Bauman (Society under Siege, London 2002, trad. it. La società sotto asse-
dio, Bari 2005, in particolare il capitolo Come appare in Tv, pp. 179-207: 181).23 Citato da C. SALMON, Storytelling. La machine à fabriquer des histories et à former les esprits, Paris
2007, trad. it. Storytelling - La fabbrica delle storie, Milano 2008, p. 170.24 S. Ragazzoni, La filosofia di Lost, Firenze 2009.25 Come già poneva in luce Umberto Eco nel 1962: U. Eco, Opera aperta (1962), ed. cons. Milano
2000.26 S. CHATMAN, Story and Discourse, London 1978, trad. it. S. CHATMAN, Storia e discorso. La strut-
tura narrativa nel romanzo e nel film, Parma 1981, pp. 63-87.27 C. SALMON, Storytelling … cit., p.143.28 Cit. p. 144, a tale proposito anche le considerazioni sulla serie 24 di Slavoj Zizek, citate nel testo
(p. 143) sul cosiddetto “stato d’eccezione” e sui cambiamenti imposti ai nostri valori etici.29 La finzione anticipa e apre la strada agli avvenimenti. Che la realtà s’ispiri all’arte ce lo conferma la
cronaca nera. I killer della mafia sono stati sorpresi a sparare come nei film di Quentin Tarantino, con lapistola messa di piatto tenuta con le due mani: “non esiste più confine tra fiction, immaginazione, rap-presentazione scenica, leggenda metropolitana. Nelle parole raccolte dalle intercettazioni telefoniche c’èuna sedimentazione di tutto” (R. SAVIANO, Nella testa dei sicari di Gomorra. Così l’orrore diventa routine,“La Repubblica”, 18 giugno 2009, pp. 22-23). Se i mafiosi e i criminali raccontati da Roberto Savianouccidono come i personaggi di Pulp fiction, così le guardie del corpo e i poliziotti si comportano come iloro omologhi cinematografici come ricordano, commentando Death of a President, il regista e lo sceneg-giatore Gabriel Range e Simon Finch. Sembra che le fiction (Lost, Sex and the City, 24…) siano divenuteil braccio armato del controllo sui comportamenti, le opinioni e gli atteggiamenti degli individui, e influi-scano in maniera determinante sulle decisioni collettive. La democrazia degenerata ha creato una sorta diGleichschaltung der Masse alla quale volonterosamente i cittadini-spettatori collaborano.
30 R. SIMONE, Il Mostro Mite. Perché l’Occidente non va a sinistra, Milano 2008, p. 112. Si tratta diuna delle più chiare analisi sulla situazione attuale effettuata da un autore italiano. Purtroppo, a nostroavviso, il testo non è stato sufficientemente valutato nelle poche recensioni apparse sui quotidiani, forsea causa del taglio politico, piuttosto pessimista, sulla possibilità della sinistra di affermarsi con valori chenon hanno alcuna possibilità di prevalere sul sorridente Leviatano dell’era globale.
31 J. BAUDRILLARD, Simulacres et simulation, Paris 1981. Particolarmente utile il compendio e lariflessione sul testo Simulacres et simulation dello storico dell’arte Hans Belting: Das echte Bild. Bildfragenaus Glaubensfragen, München 2005, trad. it. La vera immagine di Cristo, Torino, 2007, pp. 16-32. Sinoti che già in uno scritto del 1977 (pubblicato in “Rivista di estetica”, 3, dicembre 1989, pp. 1-7) daltitolo Il Trompe-L’oeil, Jean Baudrillard definisce le pitture illusionistiche che ingannano l’occhio, dellenon-pitture, una categoria metafisica, un simulacro più profondo del reale (p. 6). Per una critica all’in-terpretazione dei simulacri di Baudrillard, seppure non totalmente discordante, S. ZIZEK, The Plague ofFantasies, London-New York 1997, trad. it. L’epidemia dell’immaginario, Meltemi 2004, pp. 186-195.
32 Così scriveva già H. Dieuzeide nel 1960 (cit. in G. DORFLES, Simbolo, comunicazione … cit., p.222).
33 Su questo punto, seppure con prevalente riferimento alla letteratura, le considerazioni di metodo,applicabili a tutte le indagini non matematizzabili, descritte da U. ECO, I limiti dell’interpretazione,Milano 1990.
34 R. ARNHEIM, Rundfunk als Hörkunst und weitere Ausfsatze zum Horfunk, München-Wien, CarlHanser, 1976, trad. it. La radio, l’arte dell’ascolto e altri saggi, Roma 2003 p. 198: “Chi vuole descrivere
265
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 265
qualcosa deve estrarre il generale dal particolare, formare concetti, comparare, deve, insomma, pensare.Dove basta il dito per indicare, la bocca si chiude, la mano che scrive e disegna si ferma, le facoltà men-tali si degradano […] Chi è in grado di pensare, di trarre delle conclusioni, di conoscere, riceverà moltistimoli dalla televisione, mentre gli altri saranno catturati da essa senza essere aiutati […] L’essenza dellasituazione internazionale, della crisi mondiale, della forma moderna dello Stato non è così immediata-mente racchiusa nelle impressioni che ne riceviamo” (pp. 198-199). A tale proposito, esemplificativa lacitazione sul colpo di stato in Romania contenuta nel recente libro di Ennio Remondino: “Il potere con-dizionante della televisione travolge tutto. La confessione più trasparente e sincera di quella Waterloogiornalistica è di Colette Breckman, inviata del francese Le Soir: «A Timisoara non ho trovato nessuncarnaio, ma nessuno poteva dimenticare quei corpi orribilmente torturati […] La televisione aveva fattovedere tutto ciò e se la tv l’ha mostrato, vuol dire che è vero»” (E. REMONDINO, Niente di vero sul fron-te occidentale. Da Omero a Bush la verità sulle bugie di guerra, Catanzaro 2009).
35 È significativa l’opinione espressa a tale proposito da Hans Georg Gadamer, un filosofo bendistante dalle teorizzazioni di Jean Baudrillard: “La televisione è la catena a cui l’uomo moderno è lega-to dalla testa ai piedi e chi ha le chiavi di questa catena è la moderna élite delle informazioni. Una éliteche esiste solo per schiavizzare l’umanità con le immagini” (Hans Georg Gadamer, intervista pubblica-ta su “L’Espresso”, 24 settembre 1994).
36 Infotainment è un termine americano che unisce le parole information (informazione) e entertain-ment (intrattenimento). Indica il fenomeno della spettacolarizzazione dell’informazione.
37 Il recente testo di G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica Pop, Bologna 2009.38 È una drammatizzazione di eventi realmente accaduti. Questi vengono ricostruiti e narrati secon-
do tecniche narrative proprie del romanzo e del film.39 Si riferisce a serie televisive che si ispirano a fatti, luoghi e personaggi realmente esistiti. La diffe-
renza con i docudrama è estremamente sfumata.40 Si tratta di un documentario con materiale di repertorio e interviste su fatti mai accaduti o dei
quali si millanta conoscenza certa.41 J. BAUDRILLARD, Le crime parfait, Paris 1995, trad. it. Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la
realtà?, Milano 1996.42 “In quell’Impero, l’Arte della Cartografia raggiunse tale Perfezione che la mappa di una sola
Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell’Impero, tutta una Provincia. Col tempo, questeMappe Smisurate non soddisfecero e i Collegi dei Cartografi crearono una Mappa dell’Impero che avevala grandezza stessa dell’Impero e con esso coincideva esattamente. Meno Dedite allo Studio dellaCartografia, le Generazioni Successive capirono che la vasta Mappa era Inutile e non senza Empietà l’ab-bandonarono alle Inclemenze del Sole e degli Inverni. Nei deserti dell’Ovest restano ancora lacereRovine della Mappa, abitate da Animali e Mendicanti; in tutto il Paese non è altra reliquia delleDiscipline Geografiche”, J. L. BORGES, Del rigor en la ciencia, in El hacedor (1962), trad. it. L’artefice, inJorge Luis Borges Tutte le Opere, I, Milano 1984, p.1253.
43 H. BELTING, La vera immagine di Cristo … cit. p. 27. La conferma che ci sia alle volte inconsa-pevolezza di questo processo di dissolvimento del reale è resa evidente dalla testimonianza di un auto-re televisivo che, soltanto dopo la visione dal documentario Videocracy (Erik Gandini, Svezia, 2009),confessa di essersi risvegliato dall’illusione della quale era parte organica. “Ho visto la prima voltaVideocracy sul computer dell’ufficio, di pomeriggio. E ho subito invidiato Erik Gandini. L’ho invidia-to perché aveva avuto la possibilità di un punto di vista diverso dal mio. Lavorando e avendo lavoratotanto in tv, avendo visto ascoltato seguito assorbito il mondo che mi stava raccontando Erik, lo rico-noscevo come vero, reale. Con semplicità il film mi ricordava il contesto nel quale vivevo, nel qualelavoravo, gli effetti sui miei concittadini”: A. SALERNO, Come un’introduzione, benvenuti nella Casa, inCome tutto è cominciato, a cura di A. SALERNO, Roma 2009, pp. 7-8.
266
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 266
44 È una delle considerazioni di V. Flusser, Philosophie der Photographie, Göttingen 1983, trad. it. Peruna filosofia della fotografia, Milano 2006 cit. in H. Belting, 2007, p. 19.
45 J. BAUDRILLARD, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu?, Paris 2008, pp. 30-32. Per un’analisi menofilosofica e più attenta al côté giornalistico: M. SMARGIASSI, Un’autentica bugia, Milano 2009, in parti-colare sulla fotografia digitale: pp. 11-55.
46 R. BARTHES, Retorica dell’immagine, in Communications”, Parigi, 1964, in L’obvie et l’obtus. Essaiscritiques III, Paris 1982, trad. it. L’ovvio e l’ottuso, Torino 1985, p. 15 ss.
47 La posizione del sociologo Zygmunt Bauman è più sfumata, ma non in contraddizione, con quel-la di Jean Baudrillard: “I turisti si armano di videocamere e possono dirsi sicuri di essere realmente anda-ti in vacanza solo quando, una volta tornati a casa, vedono le loro imprese video-registrate sul telescher-mo” Z. BAUMAN, La società … cit., pp. 181-182.
48 E. BERSELLI, Marameo al galateo, “L’Espresso”, 14 giugno 2007, p. 68.49 Di questa logica si è impossessato abilmente il mercato dell’arte contemporanea come illustra il
testo di D. THOMPSON, The $12 Million Dollar Stuffed Sharck, New York 2008, trad. it. Lo squalo da12 milioni di dollari, Milan 2009.
50 G. BOSETTI, Spin. Trucchi e tele-imbrogli della politica, Venezia 2007.51 Dal discorso al Reuters Building di Londra, parzialmente tradotto in “La Repubblica” del 13 giu-
gno 2007. Non diversa nella sostanza l’affermazione di un musicista contemporaneo quale Pierre Boulez:“Bisogna essere estremi fino alla provocazione. Nascondendo le proprie scelte, presentando un pezzo con-temporaneo schiacciato tra brani noti e popolari, si finisce per essere deboli e non trascinanti. Al nuovova attribuita una visibilità sfacciata” (Pierre Boulez, intervista, “La Repubblica”, 29 marzo 2009).
52 Sulla blasfemia e la derisione della figura di Giovanni Paolo II si veda S. LAGNIER-CROS, MaurizioCattelan. La trahison des images, “Histoire de l’art”, 57, Octobre, 2005, pp. 153-161: 158-159. È possi-bile stabilire anche un confronto con la scultura funeraria intitolata Iraq War Memorial Featuring. TheDeath Of Prince Harry, The Martyr of Maysan Province, realizzata nel 2007. L’artista, Daniel Edward, harealizzato un vero e proprio Prince Harry Memorial, commemorando un fatto mai accaduto.
53 V. LUC, G. RANCINAN, Art à mort, Paris 2002, pp.116-119.54 Z. BAUMAN, La società … cit., pp. 200-201. Mario Perniola ha precisato che l’evento particolar-
mente traumatico rappresenta un caso particolare di miracolo mediatico. Il suo enorme impatto dovu-to alla sua imprevedibilità genera un trauma collettivo ed assume un significato epocale. Il miracolomediatico sarebbe pertanto diverso dalle strategie di manipolazione dell’opinione pubblica o dalla crea-zione degli pseudo eventi di cui parla Gillo Dorfles e produrrebbe un pubblico che pensa che la vita siauna festa nella quale accadono fatti pirotecnici che portano cambiamenti totali. Per una trattazione com-pleta di questa interpretazione dell’evento epocale: M. PERNIOLA, Miracoli e traumi della comunicazione,Torino 2009.
55 A tale proposito il capitolo The Surplus of Images, in W. J. T. MITCHELL, What do Pictures want?The Lives and Loves of Image, Chicago-London 2005, pp. 77-106.
56 Robert Rauschenberg evidentemente ritiene scontata l’irruzione dell’immaginario televisivo nel“mondo reale”: “I don’t want a picture to look like something it isn’t. I want it to look like something it is.And I think a picture is more like the real world when it’s made out of the real world”, citato in S.HAPGOOD’S, Neo-Dada, Redefining Art 1958-1962, New York 1994, p.18.
57 Ciò che i giornali raccontano non deve essere necessariamente vero. La verità è un dettaglio sacri-ficabile: ciò che conta è l’impatto sul lettore, la capacità di costruire una storia verisimile che lo coin-volga. In un’altra sequenza del film il protagonista afferma: “Se il titolo è grande la notizia diventa subi-to importante”.
58 U. ECO, La verità? È solo nella finzione, “La Repubblica”, 30 giugno 2009.59 Ho già avuto modo di analizzare questa dinamica immagine-storia in La guerra delle immagini.
267
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 267
La ricezione della storia attraverso la rappresentazione iconica: dalla pittura all’immagine fotografica, “Artein Friuli Arte a Trieste”, 23, 2005, pp. 135-150, ripubblicato, corretto e ampliato, in “ArcoJournal”, e-journal del Dipartimento di Arti e Comunicazione dell’Università di Palermo, 25 giugno 2007,www.arcojournal.unipa.it, pp.1-30.
60 Un po’ come accadde durante le recenti elezioni americane quando si diffuse la notizia, ritenutaa torto vera, che Sarah Pallin non sapesse se l’Africa fosse un paese o un continente. A tale proposito l’u-tile recensione alla recente biografia The Uncrowned King: The Sensational Rise of William RandolphHearst di Kenneth Whyte: R. BERNSTEIN, Reappraising Hearst, the villain of ‘Citizen Kane’, “InternationalHerald Tribune”, January 28, 2009 (www.iht.com).
61 J. BAUDRILLARD, Car l’illusion ne s’oppose pas à la réalité…, Paris 1998, s.n. ma 5. A tale pro-posito anche la breve sintesi di G. PIANA, postfazione, in J. BAUDRILLARD, Il delitto perfetto … cit., pp.157-168.
62 G. DORFLES, Fatti e Fattoidi. Gli pseudo eventi nell’arte e nella società, Roma 2009, p. 14. Sonosicuramente più efficaci nel’illustrare i fattoidi televisivi e non solo alcune scene tratte dal filmVideocracy - Basta apparire (2009) di Erik Gandini (a solo titolo di esempio il giovane della periferiabresciana che si esibisce in tenuta da karate nel giardino di casa). In un recente articolo anche GilloDorfles sembra rendersi conto che diventa sempre più difficile sostenere una netta separazione tra fattie fattoidi: “Forse l’unica soluzione di fronte al dubbio di non poter più discernere tra “fatti” e “fattoi-di”, tra capolavori artistici e le loro repliche, tra individui e loro “avatar” sarà quello di valutare anchenoi stessi non come uomini ma come «ominoidi»”, G. DORFLES, L’autenticità del facsimile, “Corrieredella Sera”, lunedì 8 dicembre 2008.
63 J. BAUDRILLARD, Il delitto perfetto … cit., p. 28.64 Credo sia questa la posizione sostenuta da Raffaele Simone (Il Mostro Mite … cit. , pp. 112-117).65 Sarebbe troppo lunga la lista dei testi da citare su tale argomento che noi tocchiamo solo tangen-
zialmente. Ci limitiamo pertanto al testo di Gianfranco Marrone che è una sintesi, non solo bibliogra-fica, di questi argomenti (G. MARRONE, Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Torino2001, in particolare il capitolo Dinanzi allo schermo, pp. 35-63). Inoltre, per un approfondimento sutemi specifici recenti, il numero della rivista di semiotica “Ocula - Occhio semiotico sui media”, dedi-cato alla televisione: Good bye TV: appunti sulla televisione di fine decennio, a cura di C. BIANCHI, S.TRAINI, n. 11, dicembre 2010 (www.ocula.it).
66 G. DIDI-HUBERMAN, Images malgré tout, Paris 2004, trad. it. Immagini malgrado tutto, Milano 2005.67 R. SIMONE, Il Mostro Mite … cit., p. 117.68 È una concezione del linguaggio, che non svela bensì cela la verità, già presente in un notissimo
passo giovanile di Friedrich Nietzsche: “Che cos’è dunque la verità? Un mobile esercito di metafore,metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeti-camente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a unpopolo, solide, canoniche e vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria,sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immaginesi è consumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete”(Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn, 1873, trad. it. Su verità e menzogna in senso extra-morale, Milano 2006, p.109). Su questa tematica si veda la chiara esplicazione di Alfonso M. Iacono,L’illusione e il sostituto. Riprodurre, imitare, rappresentare, Milano 2010, in particolare il capitolo Verità emenzogna in senso extramorale, pp. 127-145.
69 Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, Paris 2008, in particolare le pp. 12-26.70 Intervista a Jean Baudrillard di Catherin Franblin in Art and philosophy … cit., pp. 9-10.71 J. Baudrillard, Lo snobismo macchinale … cit. p. 85.72 Citazioni tratte da capitolo Lo snobismo macchinale in J. Baudrillard, Il delitto perfetto … cit. p. 81-
268
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 268
90: 82-83. Su Warhol il testo apparso in “Artstudio”, n. 8, Spécial Andy Warhol, 1988, pp. 6-12 ora in tra-duzione tedesca e inglese in Andy Warhol. Paintings 1960-1986, a cura di M. Schwandern, Atje 1995, pp.15-21 e l’intervista À partir d’Andy Warhol (1990) ora in J. BAUDRILLARD, Entrevues à propos du “Complotde l’art”, Paris 1997, pp. 9-20. Inoltre, relativamente alla discussione su Andy Warhol da parte diBaudrillard e Lyotard, con particolare riferimento alla ripetizione seriale, il capitolo Grosse Realistik - GrosseAbstraktion in M. DOBBE Fotographie als Theoretisches Objekt. Bildwissenshaft MedienästethikKunstgeschichte, München 2007, pp. 147-168.
73 “Aller à une Biennale est devenu un grand rituel social, comme d’aller au Grand Palais […] Dans cessituations, moi, je ne peux plus avoir de jugement esthétique mais une vision anthropologique”, J.BAUDRILLARD, À partir d’Andy Warhol … cit., p. 19.
74 Su questa nemesi descritta dal filosofo francese: J. BAUDRILLARD, Al di là della fine (2002), inPatafisica … cit., pp.13-29: 27-29. Inoltre, con tratti maggiormente esemplificativi sull’arte contempora-nea e Warhol, alcune pagine in J. BAUDRILLARD Illusion, Disillusion, Esthètique, Paris 1997 (pp. 19-41).
75 J. BAUDRILLARD, Al di là della fine … cit., p. 28.76 Carter Ratcliff già nel 1989 (C. RATCLIFF, The Work of Roy Lichtenstein in the Age of Walter
Benjamin’s and Jean Baudrillard’s Popularity, “Art in America”, february 1989, pp. 110-123) aveva criti-cato la posizione integralista di Baudrillard sostenendo che si tratta di una deriva iperbolica. Poichéabbiamo un corpo, dice Ratcliff, ed esiste una realtà solida, si sconfessa il sistema segnico autoreferen-ziale di Baudrillard. Un ritorno alla realtà nella filosofia, anche nel senso più empirico del termine, èsicuramente salutare ed è stato recentemente sostenuto, in maniera affatto ingenua, anche da MaurizioFerraris (M. FERRARIS, Il mondo esterno, Milano 2001 e Inemendabilità, ontologia, realtà sociale, “Rivistadi estetica”, 19, 1, 2002, XLII, pp. 160-199), ma il discorso del filosofo francese mantiene una sua vali-dità se ne apprezziamo la capacità di descrivere un paradigma culturale che è divenuto la sindrome diuna società. È innegabile che Guy Debord e Jean Baudrillard abbiano descritto con largo anticipo que-sto cambiamento antropologico.
77 J. BAUDRILLARD, Lo snobismo macchinale … cit., p.89.78 Nella recensione ad un testo di Franco Trevi (Metafore del simbolo. Ricerche sulla funzione simbo-
lica nella psicologia complessa, Milano 1986), Umberto Galimberti sostenne che, dal punto di vista semio-logico, si era troppo spesso guardato al simbolo partendo dal segno, risolvendo il problema della deco-difica nella relazione significante/significato, ma il simbolo “lascia ai suoi margini un immenso materia-le impensato e da pensare”. È proprio la sua eccedenza semantica, inesauribile in un significato noto, chelo differenzierebbe dal segno: “Dopo l’ambivalenza, che sottrae il simbolo all’equivalenza di un signifi-cato con se stesso, la relazione con l’ignoto è la seconda caratteristica che distingue un segno da un sim-bolo” (U. GALIMBERTI, Il gioco delle opinioni, Milano 2008, pp. 45-47). Poiché l’artefatto trasfigura segni(parole, icone…) e oggetti (ruote di bicicletta, televisori…) nel mondo simbolico, i significati dell’ope-ra non possono esaurirsi completamente nel lavoro interpretativo. Ma questo non è l’unico motivo peril quale non possiamo esplicitare, in stretta relazione biunivoca, il significato di un artefatto. La prudenzadovrebbe sempre sorvegliare l’interpretazione, in quanto soltanto parte dei significati possono essererecuperati tramite un lavoro di messa in luce del contesto e dei rimandi extratestuali. Simon Schama, inun recente articolo pubblicato sul “The Financial Times” (trad. it. Avere occhio per i relitti, “Il Sole 24Ore”, 31 gennaio 2010), ha sostenuto che lo storico dovrebbe avere molto cautela nell’interpretare qual-siasi prodotto della creatività umana quale sintesi di un’epoca: “L’oggetto […] per il solo fatto di esserestato realizzato in una data epoca e in un dato luogo, è un frammento dal quale si può intuire il tutto.Ma è proprio così?”. È un monito fondamentale quello di ritenere sempre che “i quadri o gli oggettidecorativi sono un deposito accumulato di molte transazioni sociali, le quali non tutte e non necessa-riamente convergono verso un concertato e condiviso uso e significato”.
79 Andrea Bellini, Intervista a Maurizio Cattelan, in Magnetism and drama: Maurizio Cattelan, in
269
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 269
Conversation on Sculpture, a cura di G. HARPER, T. MOYER, Hamilton 2007, pp. 240-245: 241-242(testo originale in inglese).
80 Catherin Franblin, Intervista a Jean Baudrillard, in Art and philosophy, Milano 1991, pp. 9-15: 9.81 N. ZURBRUGG in J. BAUDRILLARD, Art and artefact, London 1997, pp. 1-6: 6.82 J. BAUDRILLARD, Il delitto perfetto … cit., p. 134.83 Sarà sufficiente ricordare soltanto tre testi dell’autore americano saccheggiato dal cinema di
Hollywood: The Man in the High Castle (1962), The Simulacra (1964) e The Penultimate Truth (1964).84 Solo a titolo di esempio ricordiamo il caso di People like Us, un programma radiofonico inglese
che andò in onda dal 1995 al 1997, per divenire una serie televisiva dal 1999 al 2000. Realizzato comese fosse una serie di interviste e di inchieste condotte su persone che svolgono diversi lavori (giornalisti,medici, direttori di banca), in realtà propongono attori che usano il modello standard del documenta-rio per creare situazioni esilaranti.
85 A tale proposito ancora le considerazioni di J. BAUDRILLARD in Patafisica … cit., in particolareL’allevamento della polvere (2001), pp. 33-39 e Telemorfosi (2001), pp. 43-56.
86 Il recente film United 93 di Paul Greengrass (2006) ricostruisce la vicenda dei passeggeri che sisono opposti agli attentatori dell’11 settembre 2001. Nonostante nessuno possa testimoniare ciò cheaccadde a bordo dell’aereo, il regista ne ha ricostruito la vicenda sulla base delle tragiche telefonate deipasseggeri e della registrazione sulla scatola nera (R. NEPOTI, La storia di quell’aereo non è vera ma veri-simile, “La Repubblica”, venerdì 14 luglio 2006).
87 Il gioco di rimandi, in quest’iconologia della sparizione del reale, è evidente nel film Matrix(1999), quando il protagonista nasconde il dischetto nel testo, in versione inglese, di Jean Baudrillard(Simulacra and Simulation). A fronte di una bibliografia estremamente ricca sul film dei fratelliWachowski, ci siamo limitati a consultare il testo The Matrix and Philosophy: welcome to the desert of thereal, a cura di W. IRVING, Chicago 2002, trad. it. Pillole Rosse. Matrix e la filosofia, Milano 2006. Semprerelativa al tema della mistificazione del reale, possiamo citare la sceneggiatura dei fratelli Wachowski peril controverso film V for Vendetta (2005).
88 JFK, regia di Oliver Stone, USA, 1991. A tale proposito il capitolo di W. J. T. MITCHELL, FromCNN to JFK in Picture Theory: essays on verbal and visual representation, Chicago 1994 e l’intervista conl’autore di A. GRØNSTAD, Ø. VÅGNES, Battles around Images: Iconoclasm and Beyond. An Interview withW.J.T. Mitchell, “Image and Narrative”, 15, novembre 2006, pp. 1-11 (www.imageandnarrative.be).
270
lorber.28.qxd 16-03-2010 14:11 Pagina 270