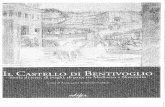DANZA B, SCAFURO M. (2009). I contesti chiusi. In: PONTRANDOLFO A. IN COLLABORAZIONE CON SANTORIELLO...
Transcript of DANZA B, SCAFURO M. (2009). I contesti chiusi. In: PONTRANDOLFO A. IN COLLABORAZIONE CON SANTORIELLO...
PROVINCIA DI SALERNOAssessorato ai Beni e alle Attività Culturali
Unione EuropeaLa presente pubblicazione è stata realizzata
nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III B 2000-2006ARCHIMED MED.ARCHEO.SITES
Studio e valorizzazione dei siti archeologici dell’area mediterraneacofinanziato dall’Unione Europea tramite il FESR
FRATTEIL COMPLESSO
MONUMENTALE ARCAICO
Angela Pontrandolfoin collaborazione conAlfonso Santoriello
Unione Europea
FRA
TTE
IL C
OM
PLES
SO M
ON
UM
ENTA
LE A
RC
AIC
OCopertinaMar.qxp:copertinaxstampa.qxp 28-12-2009 12:53 Pagina 1
FRATTEIL COMPLESSO MONUMENTALE ARCAICO
Angela Pontrandolfoin collaborazione conAlfonso Santoriello
contributi diEmanuela CiteraBarbara DanzaPorfidio MondaMaria Luisa NavaNatascia PizzanoAngela PontrandolfoMatilde RomitoAlfonso SantorielloMichele ScafuroFrancesco Uliano ScelzaAntonia Serritella
PROVINCIA DI SALERNOAssessorato ai Beni e alle Attività Culturali
UNIONE EUROPEA
FRATTE IMPVelia.qxp:FRATTE IMPdef.qxp 21/12/09 18:35 Pagina 3
Elaborazione ed impaginazione supporti graficiRita Pinto
Planimetrie e sezioni di dettaglioArchivio del Laboratorio di Archeologia “Mario Napoli” del Dipartimento di BeniCulturali – Università di Salerno
Rilievi e ipotesi ricostruttive dell’edificioPaolo Vitti, Ottavio Voza
Elaborazioni digitali G.I.SFrancesco Uliano Scelza
Foto di scavoArchivio del Laboratorio di Archeologia “Mario Napoli” del Dipartimento di Beni Culturali – Università di Salerno e Archivio Ernesto Samaritani
Foto repertiArchivio del Laboratorio di archeologia “Mario Napoli” del Dipartimento di BeniCulturali – Università di Salerno
Disegni repertiAntonio Beatrice, Alessia Mete, Stefania Siano, Giusy Stelo
Il volume è il risultato di una ricerca collettanea sviluppatasi negli anni nell’ambito di un progetto scientifico diretto da Angela Pontrandolfo e coordinatosul campo da Alfonso Santoriello. Le diverse parti sono curate dai seguenti autori:
Emanuela Citera (E.C.)Barbara Danza (B.D.)Porfidio Monda (P.M.)Natascia Pizzano (N.P.)Angela Pontrandolfo (A.P.)Alfonso Santoriello (A.S.)Michele Scafuro (M.S.)Francesco Uliano Scelza (F.U.S.)Antonia Serritella (A.Se.)
L’intervento di restauro dell’area archeologicadi Fratte, scaturito dalle indagini scientifiche,è stato realizzato con fondi ARCUS S.p.a. -Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo
AMB = ambienteCA = canalettacfr. = confronta CL = colonnacm = centimetridiam = diametro E = estfig. = figurafigg. = figureF. = formaFS = fossaIO = insieme occidentaleIC = insieme centraleIE = insieme orientalem = metriMR = muroN = nordn. = numeronn. = numerinon id. = non identificataO = ovesto = orlop. = paginapp. = paginePO = pozzoPV = piano pavimentales. = seguentess. = seguentiS = sudt. = tombatt. = tombetav. = tavolatavv. = tavoleTR = trinceaUS = unità stratigraficaUUSS = unità stratigrafiche
VA = vascavol. = volume
At = anfore da trasportoB = buccheroc = cermicaCc = ceramica comuneEA = elementi architettonici F = fasce Fr = figure rossefr = frammentofrr. = FrammentiGC = grandi contenitoriI = instrumentaInd. = individui ME = oggetti metallicip = pietrePL = prodotti laterizi Of = oggetti fittiliR1 = rapporto proporzionale 1R2 = rapporto proporzionale 2rd = resti dendrologiciSub = subunitàV = variaVn = vernice nera
La documentazione grafica dei reperti ceramici nel capitolo relativo ai contesti chiusi, ove non diversamente indicato, è sempre 1:2. Nel capitolo relativo alle classi deimateriali la documentazione graficaè sempre 1:4 tranne che per gliinstrumenta (1:8) e i laterizi (1:16).
Abbreviazioni
INDICE
Matilde RomitoPREMESSA p. 9Per il Parco Archeologico di Fratte a Salerno
Maria Luisa NavaPRESENTAZIONE p. 11
Angela PontrandolfoINTRODUZIONE p. 12
ABSTRACT - THE ARCHAIC MONUMENTAL COMPLEX OF FRATTE p. 13
Angela Pontrandolfo - Alfonso Santoriello1. LA RICERCA ARCHEOLOGICA A FRATTE p. 17
Metodi e strategie di intervento negli ultimi venti anni (A.P.)L’impostazione della ricerca sul campo (A.S.)
Francesco Uliano Scelza2. LA RILETTURA DEL COMPLESSO MONUMENTALE p. 23
Barbara Danza - Michele Scafuro3. I CONTESTI CHIUSI p. 49
Le fosse di scarico (B.D.)Il pozzo 3272 (B.D.)Il pozzo 6009 (M.S.)Analisi delle archeofaune del pozzo 6009 (N.P.)
Antonia Serritella et Alii4. LE CLASSI DEI MATERIALI p. 101
Bucchero (E.C.) Ceramica a fasce (E.C.)Ceramica parzialmente verniciata (A.Se.)Ceramica a vernice nera (A.Se.) Unguentari acromi e decorati a fasce (A.Se.)Figure rosse italiote (M.S.)Ceramica di uso comune (B.D.) Anfore da trasporto (M.S.) Grandi contenitori (M.S.)Instrumenta (E.C.)Elementi architettonici (P.M.)Classi e forme nello sviluppo cronologico (A.Se.)
Francesco Uliano Scelza5. IL CONTRIBUTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI p. 171
ALLA DEFINIZIONE DELLE FASI CRONOLOGICHE
Angela Pontrandolfo 6. VITA E TRASFORMAZIONI DELLA CASA PALAZZO p. 195
Emanuela Citera7. APPENDICE DOCUMENTARIA p. 201
Apparato degli Insiemi, degli Ambienti, dei Fatti e delle UUSSI materiali mobili di ciascuna US
BIBLIOGRAFIA p. 227
49
I CONTESTI CHIUSI
Barbara Danza - Michele Scafuro
I contesti sostanzialmente non alterati sono quelli pertinenti al riempimento di due pozzi e di alcune fosse, utilizza-ti come scarichi di materiali di diversa natura: laterizi, soprattutto tegole, parti di muri e di elementi architettonici,resti di intonaco e frammenti ceramici, in parte ricomponibili.
Le fosse di scarico
Le fosse individuate nell’area occupata dalla struttura monumentale sono quindici ed hanno, quasi tutte, formagrossomodo circolare, raramente ellittica ed in un solo caso rettangolare (tav. 3). La maggior parte, ad eccezionedelle fosse 3074 e 3212 di notevoli dimensioni, ha un diametro di circa un metro. La profondità va da un minimodi m 0,20 ad un massimo di m 2,26, giungendo, in alcuni casi, ad intaccare il banco naturale di tufo. Di seguito i singoli contesti vengono presentati nello stesso ordine in cui si è proceduto ad illustrare i dati di scavodell’intera area1.
INSIEME OCCIDENTALE
Nell’Insieme Occidentale, caratterizzato da una serie di ambienti in differente stato di conservazione, sono state indi-viduate quattro fosse di scarico -3074, 3032, 3048, 3212- di cui la 3074 e la 3212 hanno un consistente riempimen-to, mentre la 3032 e la 3048 sono di scarse proporzioni.
Fossa 3074Questa fossa interrompe la fondazione del muro 3005 che si stendeva per più di dieci metri in direzione N-S e si trovaa circa metà di questa parte dell’area. Essa è di grandi dimensioni, ha un taglio di forma semicircolare con un diametro massimo di circa m 2,10, e rag-giunge la profondità di m 0,40 (fig. 1).Il riempimento è costituito da terreno di colore giallastro a matrice caotica al quale si mescolano in maniera omo-genea materiale tufaceo sbriciolato, laterizi (7 frr.) tra i quali due kalypteres egemones, frammenti ceramici (87 frr.) eossei (3 frr.), uno di selce, uno di intonaco ed un blocco di arenaria. Gli 87 frammenti di ceramica, corrispondenti a 15 individui, sono così distribuiti: ceramica a fasce (3%), vernice nera(14%), d’uso comune (66%), anfore da trasporto (5%), grandi contenitori (12%) (fig. 2). Alla seconda metà del V sec. a.C. si riferiscono un frammento di olla stamnoide ed uno di una brocchetta, entram-be di ceramica decorata a fasce, di tipologie già note a Fratte dall’abitato e dai contesti tombali; coeva è un’olpet-ta acroma con labbro svasato arrotondato, appartenente alla ceramica d’uso comune2. Tra la vernice nera, pertinente prevalentemente a forme aperte, due frammenti di una coppa della serie 1552 e unoskyphos della serie 4373 si datano alla prima metà del III secolo. La maggior parte dei materiali ceramici che componevano il riempimento della fossa appartiene sostanzialmente allaceramica d’uso comune, comprendente sia vasi in argilla depurata acroma sia vasi caratterizzati da argilla rossastracon inclusi soprattutto silicei, che la rendono refrattaria al calore; le tracce brune rinvenute su questi ultimi sono unchiaro indizio della loro destinazione come vasi da fuoco. Alcuni frammenti in argilla refrattaria sono pertinenti acoperchi, dei quali due con bordo a disco piatto e tre con bordo a disco obliquo, mentre un solo frammento, carat-terizzato da un labbro appena distinto ed un breve collo tronco-conico, è riferibile ad un’olla.
3
50
Per l’elevato indice di frammentarietà non è possibile precisare la tipologia delle anfore da trasporto e dei grandicontenitori.Gli elementi inquadrabili cronologicamente si collocano in parte nella seconda metà del V secolo, e in parte nellaprima metà del III sec. a.C.
Fossa 3032Situata nell’Ambiente 1, la fossa è di scarse proporzioni ed ha una forma grossomodo circolare con un diametromassimo di circa m 1 ed una profondità di circa m 0,20.Il suo riempimento è costituito da laterizi (8 frr.), un frammento di antefissa a lastra pentagonale, ossi (1 fr.), car-bone (5 frr.) e ceramica (36 frr.). I materiali ceramici sono poco significativi: un frammento a vernice nera sovraddi-pinta ed un altro a vernice nera, pertinente ad una coppetta della serie 2789, entrambi databili entro la prima metàdel III sec. a.C. Nella ceramica d’uso comune quella depurata acroma è attestata solo da cinque pareti, mentre quel-la da fuoco è rappresentata da un’olla e da un coperchio. Vi è anche un frammento di anfora da trasporto ed unodi pithos con labbro a sezione quadrangolare.
Fossa 3048In analoga situazione stratigrafica, ma all’esterno dell’Ambiente 1 e a ridosso della trincea 1034, la fossa è di formagrossomodo circolare, con dimensioni di m 0,50 e una profondità di circa m 0,25. Il riempimento è costituito da terreno argilloso misto a sabbia molto friabile, nel quale si rinvennero soltanto unframmento di osso, tre di pareti di ceramica depurata acroma ed uno riconducibile ad un’anfora da trasporto di untipo non identificabile.
Fossa 3212La fossa è situata nella parte settentrionale dell’Ambiente 1, in un settore dove gli interventi moderni hanno in diver-si punti compromesso la stratigrafia originaria3; tuttavia, è stato possibile riconoscere che il taglio della fossa haintaccato un piano di calpestio. Di forma più o meno quadrangolare, ma con angoli arrotondati, la fossa ha le notevoli dimensioni di circa m 2,40x 2,10. Le pareti hanno un andamento verticale mentre il fondo, caratterizzato da una superficie piatta, raggiungeuna profondità di circa m 0,60 (fig. 3).La particolare disposizione del riempimento ha suggerito durante le fasi di scavo di distinguere diverse subunità alsuo interno. Il riempimento era caratterizzato in superficie, nella sua parte occidentale, da una forte concentrazio-ne di blocchi di tufo, alcuni dei quali riconoscibili come rocchi di colonna, altri come modanature pertinenti ad ele-menti architettonici, frammenti in parte sistemati in maniera regolare accanto a materiali ceramici, tufacei e argillo-si. Una subunità, parzialmente coperta dagli elementi tufacei della porzione superiore, era costituita da terreno fria-bile, mescolato a ceramiche, laterizi e a blocchi irregolari di tufo. Un altro livello presentava, da un lato (NE) unaconcentrazione di frammenti ceramici e dall’altro (SO) elementi tufacei e resti di mattoni crudi. Tali subunità, utilia ricostruire il modo e la sequenza con cui il riempimento fu scaricato nella fossa, sono risultate comunque ricon-
5050
Fig. 2Fossa 3074. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Fig. 1 Pianta e sezione della fossa 3074
I CONTESTI CHIUSI
51
Fig. 3Pianta e sezione della fossa 3212
Fig. 4Fossa 3212. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
ducibili ad un’unica azione poiché i frammenti ceramici rinvenuti nei differenti livelli sono pertinenti agli stessi esem-plari.4
Il resto del riempimento comprende, oltre ai numerosi frammenti ceramici (638 frr.) e agli elementi di tufo, laterizi(40 frr.) e un osso.I 638 frammenti di ceramica, corrispondenti a 80 individui, si distribuiscono nel seguente modo: a fasce (1%), ver-nice nera (7%), ceramica d’uso comune (91%), grandi contenitori (1%) (fig. 4).Un frammento di ceramica a fasce, pertinente ad una forma chiusa di grandi dimensioni, e due coppe a vernice neradella specie 1550, riferibili alla fine del V sec. a.C., sono gli elementi più antichi del contesto i cui materiali sono quasitutti inquadrabili nella prima metà del III sec. a.C. La ceramica a vernice nera (fig. 5) è attestata da un discreto numero di esemplari di coppe e skyphoi, quasi tutti diproduzione locale, tranne uno della serie 4311 ed un piatto della specie 1310 di produzione pestana. Oltre alle duecoppe della fine del V secolo, ve ne sono una della serie 2671, un’altra ascrivibile alla serie 2981, e due molto fram-mentarie non inquadrabili tipologicamente. Tra gli skyphoi, oltre quello pestano, altri tre esemplari appartengono allaserie 4311, mentre un altro è riconducibile alla serie 4373. Vi sono, inoltre, una coppetta monoansata della specie6220, una brocca e alcune forme chiuse non meglio identificabili. L’abbondante ceramica d’uso comune comprende un notevole numero di esemplari in argilla depurata acroma.Numerose sono le situle, almeno diciassette esemplari di diverse tipologie: corpo globulare e corpo ovoide (fig. 6).Numerose sono anche le anfore (fig. 7a-e), presenti con almeno otto esemplari di diversa grandezza, tutte a collodistinto, alcune caratterizzate da labbro sagomato e alloggiamento interno per il coperchio, altre con labbro sem-plicemente svasato e arrotondato, o con labbro distinto e profilo esterno verticale, simili morfologicamente alle olleda fuoco. Altri frammenti, con labbro a disco piatto o svasato e arrotondato o a profilo esterno bifido, potrebberoappartenere ad olle come ad anfore o brocche (figg. 7f; 8a-b). Nel contesto vi sono anche una coppetta, forma piut-tosto rara e simile nella vasca a quelle a vernice nera della specie 2780 e alcune brocche parzialmente ricostruite.Completano il panorama delle forme della ceramica acroma un mortaio con labbro a sezione triangolare (fig. 8c),e un bacile con labbro estroflesso a disco obliquo verso l’esterno (fig. 8d), entrambi caratterizzati da un impasto piùgrossolano e ricco di inclusi, che li rende molto resistenti e più adatti alla funzione cui erano destinati. La ceramica refrattaria di questa fossa è rappresentata da una scarsa varietà di forme, nove olle di tutte le varietàtipologiche note da Fratte: con labbro a disco piatto, con labbro distinto a profilo esterno obliquo, e con labbrosvasato arrotondato (fig. 8e-f). Oltre alle olle vi sono anche frammenti di coperchi loro pertinenti tra i quali due conbordo a disco piatto ed un altro con una decorazione incisa. Altri due frammenti sono attribuiti, in via ipotetica, adei clibani. Tra i grandi contenitori sono compresi due pithoi con labbro a sezione quadrangolare e due bacini di louteria, uno diun tipo più diffuso con labbro sagomato e vasca tesa dalla superficie interna puntinata, l’altro con l’orlo decoratoda scudetti e dardi a rilievo.
Barbara Danza - Michele Scafuro
52
Fig. 5Fossa 3212. Ceramica a vernice nera: a-b) skyphoi serie 4311; c) coppa specie 1550;d) coppa serie 2671; e) coppetta serie 2781;f) brocca; g) coppetta monoansata specie 6220;h) piatto specie 1310; i) forma, chiusa; l) fondo di coppetta
I CONTESTI CHIUSI
53
Fig. 6Fossa 3212. Ceramica depurata acroma:a,c,e) situle con corpo globulare; b,d) situle con corpo ovoide (1:4)
54
Fig. 7Fossa 3212. Ceramica depurata acroma: a-e) anfore; f) brocca (1:4)
Il materiale di questa fossa si rivela sostanzialmente omogeneo e inquadrabile nell’ambito della prima metà del IIIsecolo a.C.La distribuzione delle forme per classi funzionali fa risaltare la prevalenza dei recipienti destinati alla mensa e alladispensa, attestati con varietà di forme e di tipi, quelli per bere e per mangiare - skyphoi, coppe, coppette e piatti -sono rappresentati soprattutto da ceramica a vernice nera, mentre i pochi vasi per mescere - brocche - sono in argil-la acroma e più raramente a vernice nera. La ceramica da dispensa è costituita essenzialmente da ceramica acroma, in prevalenza situle, accanto ad olle e anfo-re. Attestati in discreta quantità sono anche i vasi destinati alla cucina comprendenti recipienti per la preparazionedei cibi – mortai e bacili - e quelli funzionali alla loro cottura tra i quali in assoluto più numerose sono le olle. Nelpanorama dei vasi domestici vanno inseriti anche il pithos ed i louteria.
INSIEME CENTRALE
In quest’area sono state rinvenute numerose fosse di differente natura: 3097, 3124, 3157, 3086, 3264, 3142.
Fossa 3097 Questa fossa e quella successiva si trovano nella parte settentrionale dell’Insieme Centrale e sfruttano due cavitàdestinate nella loro funzione primaria ad incanalare, al disotto della fondazione del muro 3081, le acque reflue all’e-
I CONTESTI CHIUSI
55
sterno dell’edificio cui erano connesse. In origine facevano parte di un sistema fognario, costituito da una canalettaad esso collegata e provvista di una copertura voltata, rinvenuta in parte nel riempimento delle fosse formatosi dopoche la struttura era collassata5. Di forma ovoidale, la fossa misura m 2,30 x 1,60 ed è profonda m 2,30 circa. Il suo riempimento conteneva, oltre aglielementi lapidei (77 frr.) relativi alla copertura voltata della struttura, anche laterizi (10 frr.), frammenti di ossi animali(44 frr.), carbone (1 fr.), bronzo (1 fr.), ferro (1 fr.) e 184 frammenti ceramici così distribuiti: a fasce (1%), figure rosse(2%), vernice nera (31%), ceramica d’uso comune (63%), anfore da trasporto (1%), grandi contenitori (2%) (fig. 9).
Fig. 8Fossa 3212. Ceramica depurata acroma: a-b) brocche; c) mortaio; d) bacile. Ceramica grezza: e-f) olle (1:4)
Fig. 9Fossa 3097. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Barbara Danza - Michele Scafuro
56
Ai 184 frammenti ceramici corrispondono 44 individui. Due sono i frammenti a fasce, tra i quali uno è riferibile ad un’olla stamnoide, databile alla fine del V sec. a.C. (fig.10a). I frammenti a figure rosse si inquadrano nella seconda metà del IV sec. a. C.: uno skyphos raffigurante una testafemminile di profilo con acconciatura a kekryphalos, un piatto di produzione locale, decorato sul labbro da un moti-vo ad onde correnti, ed un altro frammento, di cui resta parte di una palmetta di una forma chiusa.Tra i vasi a vernice nera numerose sono le coppe di cui una ascrivibile alla specie 1550 (fig. 10b), e le coppette, -undici individui riferibili alla specie 2780, in misura minore gli skyphoi, tre individui, due dei quali della serie 4373. Ancora più numerosi sono i frammenti di ceramica d’uso comune: tra quelli acromi è riconoscibile soltanto una situ-la. Al contrario tra la ceramica da fuoco sono state individuate sei olle, in prevalenza del tipo con labbro a discopiatto, alcuni coperchi con bordo sia a disco piatto sia a disco obliquo, un clibano ed una forma chiusa.Nel riempimento sono compresi anche alcuni frammenti di grandi contenitori: un pithos, un coperchio per pithos edun louterion. Il contesto appare sostanzialmente omogeneo e si inquadra nella seconda metà del IV sec. a.C. L’analisi delle classifunzionali mette in evidenza l’alta frammentarietà dei vasi da dispensa, mentre discretamente attestato è il vasella-me da mensa, costituito soprattutto da vasi per mangiare – coppe e coppette – piuttosto che per bere, skyphoi. Laceramica da cucina è invece rappresentata essenzialmente dalle olle da fuoco con i coperchi.
Fossa 3124Collegata allo stesso impianto fognario della precedente, questa fossa, di forma grossomodo circolare (m 1 x 0,80),è profonda circa m 1,05.Nel riempimento i materiali ceramici sono scarsi (26 frr) e più numerosi i laterizi (45 frr.). Dei frammenti ceramici, tra i quali si riconoscono 6 individui, il 27% rientra nella classe a vernice nera e il 73% inquella d’uso comune.Alla prima appartengono due skyphoi, rispettivamente delle serie 4311 e 4373, ed una coppetta monoansata dellaspecie 6220. Tra la ceramica d’uso comune quella depurata acroma è attestata esclusivamente da pareti, come quella da fuocoal cui interno è, però, riconoscibile solo un coperchio. Nonostante l’esiguità dei materiali, i frammenti a vernice nera consentono di inquadrare cronologicamente nellaseconda metà del IV sec. a.C. il riempimento della fossa.
Fig. 10Fossa 3097. Ceramica a fasce: a) olla stamnoide. Ceramica a vernice nera: b) coppa specie 1550
b
a
I CONTESTI CHIUSI
57
Fig. 11Pianta e sezione della fossa 3157
Fig. 12Fossa 3157. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Fossa 3157Localizzata nella parte nord-orientale dell’insieme centrale, questa fossa per la forma rettangolare si differenzia dallealtre. Le sue dimensioni sono ca m 0,70 x 0,42 e la sua profondità è di ca m 0,70 (fig. 11). Il riempimento si compone di pochi elementi laterizi (17 frr.), un frammento di selce rinvenuto sul fondo, tre fram-menti di bronzo dei quali due pertinenti ad una fibula tipologicamente non inquadrabile, un grosso chiodo di ferroe 43 frammenti di ceramica.Questa, al cui interno sono stati riconosciuti 10 individui, è così distribuita nelle diverse classi: ceramica a fasce (2%),vernice nera sovraddipinta (2%), vernice nera (18%), ceramica d’uso comune (73%), grandi contenitori (5%) (fig. 12).
Ad eccezione di un frammento di parete decorato a fasce, rinvenuto sul fondo della fossa, e di una coppa a vernicenera con labbro estroflesso della serie 1552, risalente alla seconda metà del V secolo, più recente è la restante ver-nice nera attestata da una coppa monoansata della specie 6220, da una coppetta della serie 2784, decorata conincisioni e sovraddipinture, e da un piatto della specie 1310. Tra la ceramica d’uso comune quella acroma è poco significativa per il suo stato frammentario, mentre in quella dafuoco sono attestati un pomello di presa di coperchio e due olle, una con labbro piatto, l’altra con labbro svasatoa disco obliquo verso l’esterno con alloggiamento interno per il coperchio. Poco significativi sono i frammenti delle pareti di grandi contenitori.Poiché permangono dubbi sull’attendibilità stratigrafica di questo contesto che in fase di scavo, per la forma dellafossa, per la matrice del terreno e per la presenza di materiali moderni si presentava come una situazione rimaneg-giata, si può soltanto registrare che i pochi frammenti ceramici mescolati al terreno e riconducibili a forme ben indi-viduabili si inquadrano nella prima metà del III sec. a.C. Il frammento a fasce rinvenuto sul fondo potrebbe esserel’unico elemento residuale di un livello originario intaccato dagli scavi moderni.
Fossa 3086Questa fossa6 si trovava al limite della parte mediana dell’insieme centrale, in una zona dove la stratigrafia è distur-bata dalla presenza di radici di alberi, piantati negli anni Cinquanta del secolo scorso. Di forma ellittica, dalle dimensioni di m 1,60 x 1,30, raggiunge la profondità di m 2,12 (fig. 13). Il riempimento comprende diversi blocchi di tufo lavorati, materiale tufaceo sbriciolato, pietre calcaree di mediedimensioni, laterizi tra i quali se ne distingue uno dipinto in rosso, frammisti a numerosi elementi carboniosi e aframmenti ceramici (740 frr.).Tra questi il bucchero, la ceramica a fasce, a figure rosse, parzialmente verniciata, a vernice rossa e gli unguentarisono attestati in percentuale minima, come i grandi contenitori e le anfore da trasporto (1%); più numerosa la ver-nice nera (11%) e in maniera esponenziale la ceramica d’uso comune (86%) (fig.14).
Barbara Danza - Michele Scafuro
58
Sono stati riconosciuti 202 individui. Il frammento di una coppa di bucchero ed un’ansa a nastro d’impasto sono gli elementi più antichi del riempimen-to; alla seconda metà del V secolo è ascrivibile un’olpetta a fasce e alla prima metà del successivo una kylix serie 4122ed una coppetta serie 2781 (fig. 15e), entrambe a vernice nera.Pochi sono gli oggetti a figure rosse di produzione locale: tre lekanai, una bottiglia, due lekythoi con decorazione areticolo, due piccoli piatti con decorazione ad onde correnti. Un frammento raffigurante un personaggio maschilecon calzari, del quale si conserva solo la parte inferiore, è pertinente ad una grossa forma chiusa che può essere attri-buita alla produzione pestana dei Pittori di Napoli 2585 e 1778. Più recenti sono una coppa a vernice nera sovraddipinta serie 2981 (fig. 15d) e due coppe serie 2671 di produzionepestana (fig. 15a); allo stesso periodo risalgono gli altri vasi della stessa classe attribuibili a fabbriche locali: coppeserie 2587 (fig. 15b-c), 2784, 1552, coppette serie 2789 (fig. 15f), 2423 (fig. 15g), 2424 (fig. 15h), skyphoi 4373(fig. 15i), piatti specie 1310 (fig. 15l), e in minima parte anche da lekythoi baccellate e brocchette (fig. 15m-n). Unacoppa ed un bicchiere a vernice rossa (fig. 16) sono di incerta produzione. I vasi più numerosi appartengono allaceramica d’uso comune, sia acroma che da fuoco. Tra quelli acromi, prevalgono le situle, attestate con ben undiciesemplari tipologicamente differenti (fig. 17a-b), seguite da anfore/anforette (fig. 17c-d), olle (fig. 17f) e broc-che/brocchette (fig. 17e); vi sono, inoltre, ben quattro esemplari di mortai (fig. 17g).L’abbondante ceramica da fuoco è rappresentata da quarantotto esemplari di olle (fig. 18a-c), trentotto coperchi,undici lopades (fig. 18d-e), quattro caccabai (fig. 18f-g) e alcuni clibani (fig. 19). Completano il panorama tre esemplari frammentari di anfore da trasporto - una del tipo MGS I ed un’altra di tipopunico, forse Man̂a CI -, alcuni frammenti di grandi contenitori tra cui due pithoi: uno assimilabile ad una modernabotte, è caratterizzato da un’imboccatura posta lateralmente a metà altezza del corpo per facilitare la mescita delliquido contenuto, l’altro ha sul labbro una decorazione con un motivo ad ovuli sulla parte inferiore esterna ed unaimpressa su quella superiore costituita da un ramo di ulivo e una teoria di animali sovrapposti.Il riempimento della fossa ha conservato anche alcuni frammenti di ferro, relativi ad una borchia e ad un amo, eduna moneta di bronzo della zecca di Nuceria Alfaterna, databile alla metà del III sec. a.C.7 Tale datazione è coerentecon quella della ceramica, in gran parte databile nella prima metà del III, ad eccezione dei pochi frammenti a figu-
Fig. 13Pianta e sezione della fossa 3086
Fig. 14Fossa 3086. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
I CONTESTI CHIUSI
59
Fig. 15Fossa 3086. Ceramica a vernice nera: a) coppa serie 2671; b-c) coppe serie 2587; d) coppa serie 2981; e) coppetta serie 2781; f) coppetta serie 2789; g) coppetta serie2423; h) coppetta serie 2424; i) skyphos serie 4373; l) piatto specie 1310; m) brocchetta serie 5335; n) brocchetta specie 5220 (1:4)
Fig. 16Fossa 3086. Ceramica a vernice rossa: a) coppa; b) boccale (1:4)
Barbara Danza - Michele Scafuro
60
Fig. 17Fossa 3086. Ceramica depurata acroma: a-b) situle; c-d) anfore; e) brocchetta; f) olla; g) mortaio (1:4)
I CONTESTI CHIUSI
61
Fig. 18Fossa 3086.Ceramica grezza: a-c) olle;d-e) lopades; f-g) caccabai (1:4)
Barbara Danza - Michele Scafuro
62
Fig. 19Fossa 3086. Ceramica grezza: a-c) clibani (1:4)
re rosse e a vernice nera inquadrabili nel corso del IV sec. a.C. L’analisi delle classi funzionali (fig.20) attestate in questo contesto si rivela particolarmente interessante per l’abbon-danza e la varietà delle forme della ceramica da mensa e da dispensa come di quella da cucina. Tra i vasi per bere e per mangiare prevale la coppa seguita dallo skyphos, dalla coppetta e dal piatto; tra quelli permescere vi è un discreto numero di brocche e brocchette, mentre nella ceramica da dispensa prevalgono le situle,affiancate da un discreto numero di olle ed anfore, alle quali si aggiungono i pithoi e le anfore da trasporto.Nella ceramica da cucina i vasi per preparare sono costituiti essenzialmente da alcuni mortai, da numerosi vasi dafuoco di tradizione locale, soprattutto olle e coperchi, accompagnati da caccabai e lopades, recipienti di tradizione
Fig. 20Fossa 3086: istogramma delle categorie funzionali
I CONTESTI CHIUSI
FRATTE IMPVelia.qxp:FRATTE IMPdef.qxp 21/12/09 18:35 Pagina 62
63
Fig. 22Fossa 3264. Percentuale dei reperti e delle classi ceramiche
greca, e da clibani. In questa fossa vi erano anche alcuni oggetti da toilette quali la lekane, la bottiglia, la lekythos afigure rosse e l’unguentario tipo III Forti.
Fossa 3264Rinvenuta nella parte centrale, la fossa ha tagliato lo strato di terreno su cui si impiantano le strutture arcaiche. Essaè di forma circolare, con le dimensioni di ca m 1,05 x 1,10 e una profondità di m 1,35 dove intacca il banco di tufo(fig. 21). Il materiale di riempimento si compone di laterizi, tufi sbriciolati e 37 frammenti ceramici, distinti in 14individui e comprendenti ceramica a vernice nera (25%), d’uso comune (69%), anfore da trasporto (3%), ceramicamedievale (3%) (fig. 22).
Fig. 21Pianta e sezione della fossa 3264
Nella ceramica a vernice nera prevalente è lo skyphos, rappresentato da cinque esemplari della serie 4373 ed uno dellaserie 4311, databili nell’ambito della prima metà del III secolo; poche sono le coppette, una delle quali ascrivibilealla serie 2725 si colloca nel terzo quarto del III sec. a.C. (fig. 23a-d). Molto frammentaria è la ceramica acroma,quella da cucina è rappresentata da un olla (fig. 23e) e da un coperchio, ed infine, conservate in parti morfologica-mente non significative, sono le anfore da trasporto. La presenza di un frammento di vetro moderno e di uno di cera-mica smaltata indiziano una situazione stratigrafica da valutare con le dovute precauzioni.
Fossa 3142Poco più a nord del contesto precedente vi era un’altra fossa di forma circolare, con dimensioni di m 1,10 x 1,20,interamente ricoperta da frammenti di laterizi. Lo spessore dello strato di riempimento era di ca m 0,70 (fig. 24).Il riempimento è costituito, oltre che da laterizi, da alcuni frammenti di argilla concotta e da diversi elementi in tufolavorato, probabilmente blocchi di strutture murarie tra i quali un frammento scanalato, forse parte di un rocchiodi colonna. Poco significativi quantitativamente e qualitativamente i 24 frammenti comprendenti ceramica a verni-ce nera e sovraddipinta (17%), ceramica d’uso comune (70%) e grandi contenitori (13%). Dei quattro individui riconosciuti, uno a vernice nera con tracce di sovraddipinture è pertinente probabilmente aduna coppa di piccole dimensioni, un frammento di ceramica depurata è riconducibile ad un’olla con labbro a discopiatto, come il frammento di un fondo in argilla refrattaria; un altro fondo è invece probabilmente pertinente ad unpithos. In base ai pochi elementi disponibili, questo contesto si colloca nell’ambito della prima metà del III sec. a.C.
Barbara Danza - Michele Scafuro
64
Fig. 23Fossa 3264. Ceramica a vernice nera: a-b) skyphoi serie 4373; c) skyphos corinthian type/serie 4311; d) coppetta serie 2725. Ceramica grezza: e) olla
INSIEME ORIENTALE
In questa parte dell’area sono state rinvenute cinque fosse: 3203, 3269, 3259, 3260, 3285.
Fossa 3203Questo contesto è stato rinvenuto nell’ambiente meridionale (Ambiente 6) dove la fossa ha tagliato uno strato inter-pretabile come livello pavimentale.In superficie la fossa, ricoperta di scaglie di tegole e tufi, ha una forma circolare con un diametro di ca m 1; le pare-ti si presentano verticali sul lato N e oblique a S e vanno restringendosi verso il fondo, individuato alla profondità dim 0,40 (fig. 25).Il riempimento si compone di laterizi (95 frr.), ossi (9 frr.) e ceramica (211 frr.).I 211 frammenti ceramici comprendono ceramica a fasce e a figure rosse in bassissima percentuale, vernice nera(18%), ceramica d’uso comune (77%), grandi contenitori (4%), anfore da trasporto e alcuni elementi moderni; essicorrispondono a 48 individui (fig. 26). Tra gli oggetti più antichi vi è una coppa a vernice nera della specie 1550 (fig. 27a), che per il limitato sviluppo dellabbro tipologicamente si può datare nella seconda metà del V secolo.Pochi sono i frammenti a figure rosse: il fondo di una lekythos d’importazione e un frammento pertinente al corpo
Fig. 24Pianta e sezione della fossa 3142
I CONTESTI CHIUSI
65
di una bottiglia con decorazione a reticolo attribuibile ad una officina locale. Nella ceramica a vernice nera, quasi tutta di produzione locale, prevalgono le coppe, alcune con decorazione impres-sa, rappresentate da 11 individui riferibili alle serie 2587 (fig. 27i-l), 2981 (fig. 27c-g), 2784 (fig. 27h) e 1552 (fig.27b). Un frammento è attribuibile ad un piatto della specie 1310 (fig. 27m) ed uno è relativo ad uno skyphos serie4311 (fig. 27n). Tra i vasi acromi, caratterizzati da un elevato indice di frammentarietà, vi è un esemplare di situla del tipo con corpoovoide e labbro svasato, un’olla con labbro distinto e profilo esterno verticale (fig. 28c); quattro frammenti con lab-bro a disco piatto o con labbro distinto e collo tronco-conico, potrebbero essere identificati come olle, anfore obrocche (fig. 28a-b,e). Un solo esemplare è riferibile ad un mortaio con labbro pendente e vasca arrotondata (fig.28d). Nella ceramica da fuoco la forma prevalente è l’olla (fig. 29a-e), attestata nei due principali tipi diffusi a Fratte,quello con labbro a disco piatto e quello con labbro distinto che, in questo contesto è prevalente e documentato indiverse varianti. L’olla è seguita dalla lopas, attestata con 4 individui caratterizzati da labbro svasato ed orlo a discoobliquo verso l’esterno (fig. 29f-h), dai coperchi con bordo arrotondato o piatto e dal taghènon. Tra i vasi acromi viè anche un craterisco miniaturistico, forma in genere attestata in contesti cultuali. L’unica anfora da trasporto è relativa al tipo MGS IV. Il contesto, omogeneo per la tipologia delle forme attestate, è inquadrabile cronologicamente intorno alla metà delIII sec. a.C., anche se non mancano alcuni frammenti più antichi, come quelli pertinenti a una delle coppe serie 1552,databile nella seconda metà del V sec. a.C.L’analisi delle classi funzionali permette di registrare che la ceramica da mensa è rappresentata in particolare dacoppe, e in misura minore piatti e skyphoi, mentre pochi sono i vasi da dispensa.Più numerosi i recipienti per preparare i cibi (mortaio) e per cucinare, tra i quali oltre alle olle e ai coperchi, sonopresenti anche forme più rare come la lopas e il taghènon.
Fig. 25Pianta e sezione della fossa 3203
Fig. 26Fossa 3203. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Barbara Danza - Michele Scafuro
66
Fig. 27Fossa 3203. Ceramica a vernice nera: a) coppa specie 1550; b) coppa serie 1552; c-g) coppe serie 2981; h) coppa serie 2784; i-l) coppe serie 2587; m) piatto specie 1310; n) forma chiusa
67
Fig. 28Fossa 3203. Ceramica depurata acroma: a-c, e) olle; d) mortaio
Fig. 29Fossa 3203. Ceramica grezza: a-e) olle; f-h) lopades
Barbara Danza - Michele Scafuro
68
Fossa 3269 Essa si trova nella parte settentrionale della fascia orientale all’interno dell’Ambiente 9, un vano rettangolare conorientamento E-O nel senso della lunghezza, la cui situazione stratigrafica permette di osservare come le strutturemurarie impiantate durante la seconda fase costruttiva dell’area abbiano riutilizzato quelle più antiche e, in parte, sisiano ad esse sovrapposte. La fossa taglia uno strato che ricopriva le strutture più arcaiche ed era a sua volta coper-to dai muri più recenti.La fossa ha una forma circolare, dalle dimensioni di m 1,12 x 1,04 e profondità di ca m 0,50; le pareti hanno profi-lo arrotondato e il fondo è piatto; in superficie è ricoperta di frammenti laterizi (fig. 30).Il riempimento della fossa ha restituito laterizi (80 frr.), materiale ceramico (227 frr.) e 5 pesi da telaio. I frammen-ti ceramici, riconducibili a 46 individui sono così distribuiti: ceramica a fasce (1%), vernice nera (30%), d’uso comu-ne (67%), anfore da trasporto (2%) (fig.31).
Fig. 30Pianta e sezione della fossa 3269
Fig. 31Fossa 3269. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Tra i pochi frammenti a fasce è stato riconosciuto uno pertinente ad una forma chiusa, olpetta o brocchetta, data-bile non oltre la fine del V secolo. Nella vernice nera è attestata una pisside databile al IV secolo (fig. 32a). Le numerose coppette, alcune delle qualiintegre, in gran parte sono ascrivibili alla serie 2789 (fig. 32c-l), due della serie 2787, mentre altre due, del tipo con-cavo-convesso, rientrano nella serie 2423 e 2424 (fig. 32b). Ad eccezione dell’ultima, sono tutte di produzione loca-le. Accanto alle coppette sono attestate alcune coppe frammentarie; migliore è lo stato di conservazione degliskyphoi, almeno quattro individui, ascrivibili tutti alla serie 4373 (fig. 32m-p), e i piatti della specie 1310 (fig. 33a-d)tra i quali uno con una rosetta stampigliata al centro della vasca. Vi sono anche una pelike serie 3684 (fig. 32r), forsedue brocche (fig. 33e-f) e diverse altre forme chiuse, conservatesi in maniera molto frammentaria. I vasi in argilla depurata sono scarsamente rappresentati: oltre un frammento pertinente ad un mortaio del tipocaratterizzato da labbro a sezione triangolare e vasca arrotondata (fig. 34a), si può riconoscere solo una forma chiu-sa pertinente ad una brocca (fig. 34b). La ceramica in argilla refrattaria è, invece, meglio documentata da 6 esem-plari di coperchi del tipo con bordo a disco piatto (fig. 34e-f, l), da tre olle con labbro a disco piatto oppure conlabbro svasato a disco obliquo (fig. 34c-d, g-i) e da due lopades (fig. 34m-n), una con labbro a disco quasi piatto,l’altra con labbro a profilo convesso (fig. 34m). Un altro pezzo, simile morfologicamente ai coperchi ma di dimen-sioni maggiori, potrebbe essere interpretato come un clibano. Si discosta, per la sua morfologia, dagli esemplarifinora attestati, un pezzo assimilabile per funzione alle pentole/olle di tradizione locale più antica (fig. 34o). Pocoindicativi per il cattivo stato di conservazione, sono infine i frammenti di anfore da trasporto.Nel riempimento si trovavano anche numerosi pesi da telaio, in gran parte integri, di forma tronco-piramidale, tran-ne uno di forma tronco-cilindrica, alcuni dei quali con decorazione incisa, una X e un cerchietto. Una incisione a forma di X contrassegna anche un coppo rinvenuto tra i laterizi di questa fossa. La sostanziale omo-
I CONTESTI CHIUSI
69
Fig. 32Fossa 3269. Ceramica a vernice nera: a) pisside; b) coppa serie 2424; c-l) coppe serie 2789; m-q) skyphoi serie 4373; r) pelike serie 3684
Barbara Danza - Michele Scafuro
70
Fig. 33Fossa 3269. Ceramica a vernice nera: a-d) piatti specie 1310; e-f) oinochoai
geneità dei materiali di questo contesto permette di datarlo agli inizi del III secolo a.C. La distinzione per classi funzionali offre varietà ed abbondanza di forme, in particolare nella ceramica da mensa dovesi compone un intero servizio con ben nove coppette, skyphoi, piatti e coppe, brocche e pelikai. La ceramica da cuci-na è rappresentata da un mortaio e da numerosi vasi per cottura, soprattutto coperchi che potevano accompagna-re sia olle sia lopades, attestate anch’esse in discreta quantità. Infine, in questo riempimento i numerosi pesi da telaio, insieme alla pisside a vernice nera, rinvenuti in questo con-testo completano il quadro degli oggetti domestici.
I CONTESTI CHIUSI
71
Fig. 34Fossa 3269. Ceramica depurata acroma: a) mortaio; b) brocca. Ceramica grezza: c-d, g-i) olle; e-f, l) coperchi; m-n) lopades; o) pentola/olla (1:4)
Barbara Danza - Michele Scafuro
72
Fossa 3259 Il taglio di questa fossa, dislocata nell’Ambiente 8, fu realizzato in un piano che presenta la stessa situazione stratigra-fica delle precedenti. Di forma circolare con bordo leggermente convesso, essa ha un diametro di m 0,90 ed una profon-dità di m 1,10, è caratterizzata da pareti a profilo concavo e fondo piatto, leggermente inclinato verso sud (fig. 35).
Fig. 35Pianta e sezione della fossa 3259
Il materiale di riempimento comprende, oltre ad alcuni blocchi di tufo di medie dimensioni, alcuni frammenti dimateriale laterizio (5 frr.) e ceramico (6 frr.) tra i quali si distingue solo una coppa a vernice nera specie 2980, unframmento di lopas con labbro arrotondato ed uno relativo ad un coperchio con bordo a disco piatto, che si inqua-drano tra la fine del IV e la metà del III secolo a.C.
Fossa 3260Nella parte centrale dell’Insieme Orientale un piano di calpestio in terra battuta, in fase con le strutture arcaiche, el’assenza di altre strutture permette di ipotizzare uno spazio aperto tra l’ambiente meridionale (Ambiente 6) e quel-lo settentrionale. Il piano di calpestio risultava coperto da altre unità stratigrafiche, relative ad una fase di occupa-zione più recente, tagliate da due fosse (3260 e 3285). La prima fossa ha una forma grossomodo circolare, condimensioni di m 1,10 x 0,96 e pareti con andamento verticale, e raggiunge m 2,26 di profondità, corrispondenti, inquesto punto, al banco naturale di tufo (fig. 36). La fossa era coperta da uno strato di materiale tufaceo sbriciola-to, mescolato a materiale laterizio, e al suo interno vi era un terreno omogeneo, di colore bruno-giallastro, mesco-lato a materiale ceramico (383 frr.), a pochi frammenti ossei (3 frr.) e a laterizi (35 frr.) comprendenti, oltre alle tego-le ed ai coppi, alcuni frammenti pertinenti ad un kalypter eghemon. I 383 frammenti ceramici, corrispondenti a 44 indi-vidui, sono così distribuiti: bucchero (1%) e ceramica a fasce (1%) in bassissima percentuale8, figure rosse (1%), ver-nice nera sovraddipinta (1%), vernice nera (8%) ceramica d’uso comune (38%), anfore da trasporto (35%), grandicontenitori (15%) (fig.37).Ad eccezione dei due frammenti tardo arcaici di bucchero e a fasce, di una coppa monoansata a vernice nera, spe-cie 6220 risalente al IV secolo e di alcuni frammenti a figure rosse, pertinenti ad una lekane e ad una forma chiusa(lekythos/bottiglia) di produzione locale, il resto del materiale si inquadra nella prima metà del III sec. a.C.Nella ceramica a vernice nera più diffusa è la coppa, testimoniata da due esemplari della serie 1552 (fig. 38a), dacoppette serie 2787 e 2789 (fig. 38b-c), da piatti specie 1310 (fig. 38d-e ) e skyphoi serie 4311. Più rare le forme chiu-se: frammenti forse pertinenti ad una bottiglia, una brocca (fig. 38f) ed un guttus.
I CONTESTI CHIUSI
73
Fig. 37Fossa 3260. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Fig.38Fossa 3260. Ceramica a vernice nera: a) coppa specie 1552; b-c) coppette serie 2789; d-e) piatti specie 1310; f) brocca
Fig. 36Pianta e sezione della fossa 3260
b
a
c
d
e f
Barbara Danza - Michele Scafuro
75
Fig. 40Fossa 3260. Ceramica grezza: a-d) lopades; e) taghenon; f) coperchio. Ceramica depurata acroma: g) mortaio
Barbara Danza - Michele Scafuro
77
Fig. 42Pianta e sezione della fossa 3285
Pochi sono i vasi in argilla depurata e piuttosto frammentari, ad eccezione di un mortaio di notevoli dimensioni (fig.40g) e di parte di una brocca. Meglio rappresentata è la ceramica da fuoco nella quale sono comprese numeroseolle di varie tipologie (fig. 39a-f) e alcune lopades (fig. 40a-d) cui va collegata la discreta quantità di coperchi,anch’essi di diversa tipologia (fig.40f). A questi vasi se ne aggiungono tre interpretabili come taghéna (fig. 40e), formache, a differenza delle precedenti, è poco attestata a Fratte. Una discreta quantità di frammenti, contenuti in questa fossa è relativa a grandi contenitori: un dolium con labbroa colletto (fig. 41a), tre pithoi (fig. 41b-d) ed un louterion9 con bacino finemente decorato sul labbro da un motivoad onde correnti e da uno fitomorfo impressi con matrici a rullo.Completano il quadro delle classi ceramiche numerosi frammenti relativi ad anfore da trasporto, tra cui una punica(fig. 66), quasi intera, ed una MGS III. Questo contesto della prima metà del III sec. a.C. si segnala non solo per la particolare abbondanza del materiale,ma soprattutto per la varietà delle classi e, al loro interno, delle numerose forme. Il vasellame da mensa è attestato,pressoché esclusivamente, dalla ceramica a vernice nera comprendente coppe, coppette, piatti e skyphoi, mentre trai vasi per mescere vi è anche una brocca acroma.La ceramica da cucina è rappresentata da un grosso mortaio e soprattutto da olle con i coperchi, ma non manca-no forme più rare come i taghéna, tegami per friggere di tradizione greca, lopades e caccabai.
Fossa 3285Posta nell’Ambiente 7, all’angolo tra i muri 3221 e 3230, la fossa, di forma ellittica con le dimensioni di m 1,30 x 2,raggiunge la profondità di ca m 1,50 (fig. 42). Il materiale ceramico, che costituiva gran parte del riempimento, è composto da 139 frammenti, corrispondenti a37 individui, nei quali si trovano ceramica a fasce (2%), figure rosse (1%), vernice nera (18%), ceramica d’uso comu-ne (51%), anfore da trasporto (24%), grandi contenitori (4%) (fig.43).
Fig. 43Fossa 3285. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Oltre ad una coppa su piede a vernice nera e ad un frammento relativo ad un’anfora da trasporto MGS II, inqua-drabili fra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., gli esemplari più antichi sono un’ansa con decorazione a cappio diproduzione locale, databile nel corso del V sec. a.C. come una parete di olla stamnoide ed una di coperchio di pis-side a fasce. Nel corso del IV secolo si collocano un frammento di lekythos o bottiglia con decorazione a reticolo, euno skyphos a vernice nera della serie 4311. Gli altri oggetti a vernice nera, numerose coppe, coppette e skyphoi10 (fig.44a-e), sono tutti databili tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.La ceramica acroma è attestata da tre situle con corpo ovoide, da un’anfora a collo distinto (fig. 44f), da una broc-
Barbara Danza - Michele Scafuro
78
Fig. 44Fossa 3285. Ceramica a vernice nera: a) skyphos; b)coppa serie 1552; c) coppetta serie 2730; d-e) coppette serie 2789.Ceramica depurata acroma: f) anfora.
ca con labbro svasato e ansa a nastro, e da un mortaio con labbro a sezione triangolare. Nella ceramica da fuocovi sono soprattutto olle di varia tipologia, ma anche una lopas con labbro indistinto e vasca arrotondata, e una cio-tola/scodella con labbro indistinto superiormente piatto.Fanno parte di questo contesto anche alcuni pithoi, due con tracce di pittura, un frammento pertinente ad un for-nello con decorazione impressa, un’anfora di tipo MGS II (fig. 64d) e una di tipo MGS IV, e ancora due pesi da telaiodi forma tronco-piramidale. Il materiale ceramico si rivela abbastanza omogeneo e la sua cronologia si inquadra sostanzialmente tra la fine delIV e gli inizi del III secolo, anche se non mancano alcuni elementi più antichi.Anche in questo contesto sono attestate le principali forme di ceramica da mensa e da dispensa con vasi per bere emangiare – coppe, coppette, piatti e skyphoi - e per mescere e conservare – situle, anfore e brocche. La ceramica dacucina è rappresentata dal mortaio e dai vasi per cuocere, soprattutto olle ed in misura minore lopades. Completanoil quadro il pithos e le anfore da trasporto, mentre tra gli instrumenta si trovano alcuni pesi da telaio ed un frammen-to relativo probabilmente ad un fornello.
(B. D.)
a b
cd
e
f
I CONTESTI CHIUSI
79
Fig. 45Sezione del pozzo 3272
I pozzi
I contesti presentati di seguito provengono dallo scavo di due dei numerosi pozzi esplorati negli ultimi anni: uno (PO3272) è situato nello spazio centrale dell’edificio, a ridosso degli ambienti che occupano il suo versante orientale,l’altro (PO 6009) è esterno alla struttura, ma nelle immediate adiacenze del suo limite nord-orientale
Pozzo 3272 Il pozzo, indagato a più riprese tra il 1997 e il 2002, è situato nell’Insieme Centrale del complesso residenziale, neipressi della struttura che ne segna il limite orientale e sembra averla rispettata quando fu realizzato.Esso fu costruito con un taglio di forma perfettamente circolare, dalle dimensioni di poco più di un metro di diame-tro, e raggiunge la profondità di quasi m 11, intaccando il banco naturale di tufo. Le pareti, perfettamente verticali, sono caratterizzate da profonde fessure, disposte sistematicamente a 40 cm l’unadall’altra lungo lo stesso asse; si tratta, evidentemente, di pedarole funzionali alla discesa nel pozzo per la sua costru-zione e la sua manutenzione (fig. 45).
Fig. 47Pozzo 3272. Percentuali delle classi ceramiche della subunità b
Fig. 46Pozzo 3272. Percentuali delle classi ceramiche della subunità a
Barbara Danza - Michele Scafuro
Subunità b
80
Le differenze di colore e consistenza del terreno di riempimento, al quale era mescolato in gran quantità materialeceramico, hanno permesso di distinguere due subunità: a, che costituisce il livello superiore; b a partire dalla profon-dità di circa m 5,30. Il primo livello era caratterizzato da un terreno di colore bruno-giallastro, mescolato a tufellisbriciolati; il secondo aveva terreno più friabile e di colore bruno scuro. A circa m 7 di profondità il pozzo era ostrui-to da grossi blocchi calcarei aldisotto dei quali, però, è stato riscontrato che non cambiavano le caratteristiche delterreno di riempimento, frammisto a numerosi materiali laterizi e ceramici. Sul fondo si rinvennero anche resti di travilignee ed alcuni elementi sferici di pietra calcarea che potrebbero riferirsi al sistema di copertura ed al funzionamen-to del pozzo. Il livello superiore del riempimento ha restituito pochi resti ossei e lignei e una discreta quantità di late-rizi frammisti a ceramica (61 frr.). Quest’ultima era composta da impasto (2%), ceramica a fasce (2%), vernice nerae sovraddipinta (15%), vasellame d’uso comune (62%), grandi contenitori (15%), instrumenta (2%) e thymiateria (2%)(fig. 46). L’analisi dei materiali ha permesso di riconoscere solo 14 individui. L’impasto, la ceramica a fasce e la ver-nice nera sovraddipinta sono rappresentati da un solo frammento; dei primi due per il cattivo stato di conservazio-ne non è possibile precisare forma e tipologia, mentre il terzo è riferibile ad una forma chiusa. La vernice nera, diproduzione locale, è costituita da uno skyphos attic type serie 4382 (fig. 48a), della fine del V sec. a. C., da due fondidi coppetta, da alcune forme aperte molto frammentarie e da una coppetta monoansata d’importazione, della spe-cie 6220 (fig. 48b), tutti inquadrabili nella prima metà del IV secolo.
Fig. 48Pozzo 3272 subunità a. Ceramica a vernice nera: a) skyphos attic type / serie 4382; b) coppetta monoansata specie 6220. Ceramica grezza: c-d) olle; e) lopas; f) thymiatherion.
I CONTESTI CHIUSI
81
Fig. 49Pozzo 3272 subunità b. Bucchero: a) coppa carenata. Ceramica a fasce: b) olla stamnoide. Ceramica a vernice nera: c) skyphos panionion; d) coppetta monoansata specie6220; e) coppa serie 1552; f) skyphos corinthian type/serie 4311
Tra i pochi frammenti di ceramica depurata vi sono un’anfora o una brocca; la ceramica refrattaria è attestata dadue olle con labbro a disco piatto (fig. 48c-d), da una lopas con labbro assottigliato e alloggiamento a disco piatto(fig. 48e), e da numerosi frammenti pertinenti a vasi non meglio identificabili, mentre i grandi contenitori sono indi-ziati solo da pareti.In questo contesto vi erano anche un frammento di thymiaterion (fig. 48f), con base modanata di produzione nonlocale ma attestato a Fratte da altri esemplari11, ed un frammento di peso da telaio. In base a questi elementi i materiali del riempimento non possono essere datati oltre la metà del IV sec. a. C.Nella subunità b oltre ai materiali ceramici (347 frr.), furono rinvenuti anche diversi frammenti di laterizi, un elementoin tufo lavorato, ciottoli di fiume, frammenti ossei, alcuni denti di cinghiale e pochi elementi carboniosi.I 347 frammenti ceramici sono così distribuiti: bucchero (1%), ceramica a fasce (1%), figure rosse (2%), vernice nera(14 %), ceramica d’uso comune (61%), grandi contenitori (11%), anfore da trasporto (5%), instrumenta (5%) (fig. 47). L’analisi dei frammenti ha permesso di riconoscere 46 individui. Dei tre frammenti di bucchero uno è riferibile aduna coppa carenata riferibile al tipo B 5212 del repertorio locale di Fratte (fig. 49a); alla fine del VI si data anche un
Barbara Danza - Michele Scafuro
82
Fig. 50Pozzo 3272 subunità b. Ceramica depurata acroma: a-b) anfore a collo distinto. Ceramica grezza: c-f) olle; g) clibano; h) coperchio; i) peso da telaio
frammento di skyphos tipo panionion con fascia esterna risparmiata (fig. 49c), mentre ad un orizzonte cronologicodella metà del V secolo rimandano alcuni frammenti di ceramica a fasce, pertinenti ad una coppa e ad alcune formechiuse tra cui un’olla stamnoide (fig. 49b). Vi sono, inoltre, due frammenti pertinenti ad uno skyphos pestano a figure rosse sovraddipinto, attribuibile allamaniera del Pittore di Sidney, datato fra la fine del V e il primo quarto del IV sec. a. C., e tre frammenti di un piat-to da pesce della metà del IV secolo (fig. 43a,d), rinvenuti nella parte più profonda del riempimento. Tra la cerami-ca a vernice nera sono anche di produzione pestana sette skyphoi: sei della serie 4311(fig.49f) e uno della serie 4382(fig. 49f-h). La vernice nera di produzione locale è attestata da tre skyphoi corinthian type della serie 4311 e un altroattic type della serie 4382, da quattro coppette monoansate, tutte della specie 6220 (fig. 49d), da una coppa serie1552 (fig. 49e) e da un piatto 1310.
I CONTESTI CHIUSI
83
Fig. 51Pozzo 3272. Grafici delle categorie funzionali
Un posto rilevante è occupato dalla ceramica d’uso comune, in particolare quella refrattaria. Tra i pochi vasi in argil-la depurata si riconoscono alcuni frammenti di anfore a collo distinto e orlo sagomato con alloggiamento internoper il coperchio (fig. 50a-b). Nella ceramica grezza, accanto alle olle (fig. 50e-f) sono attestate le pentole d’impastoa presa triangolare, di tradizione arcaica, diffuse a Fratte fino al V sec. a. C. (fig. 50c-d); vi sono anche sei coperchi(fig. 50h), di cui quattro del tipo con bordo arrotondato che dovevano accompagnare le olle, alcuni frammenti inter-pretabili come clibani (fig. 50g) ed altri come fornelli. Si sono conservati, inoltre, un frammento di un bacino di louterion e sei pesi da telaio, alcuni dei quali integri12 (fig.50i). Completano il quadro di questo contesto alcuni frammenti di anfore da trasporto dei quali due, pertinenti adun unico esemplare, sono da ascrivere al tipo MGS II della classificazione Van der Mersch.Gli elementi datanti questa parte del riempimento risultano pertanto compresi tra la fine del V e la prima metà delIV sec. a. C. Il leggero scarto cronologico tra le due parti del riempimento porta ad avanzare sia pure con cautelaalcune considerazioni. Nella porzione più profonda del riempimento vi sono 11 esemplari riferibili alla seconda metàdel V sec. a.C., mentre il resto del materiale si colloca entro la prima metà del IV sec. a.C., come quello rinvenutonella parte superiore del riempimento. Se ne deduce che i pochi frammenti più antichi testimoniano la fase finale delfunzionamento del pozzo che in un momento successivo alla metà del IV sec. a.C. sembra aver cessato la sua fun-zione originaria di captare l’acqua diventando ricettacolo di un consistente scarico avvenuto in un unico momentoe comprendente anche resti di strutture murarie. L’analisi delle ceramiche nella loro destinazione funzionale confer-ma che solo dal livello inferiore del riempimento provengono pochi frammenti di anfore, forse riferibili all’attività delpozzo, mentre tutti gli altri vasi, in particolare skyphoi, coppe, coppette e ceramica da cucina, sono ceramiche desti-nate alla preparazione e al consumo dei cibi (fig. 51).
Barbara Danza - Michele Scafuro
84
SUBUNITÀ DIMENSIONI DESCRIZIONE PERCENTUALEFISICA DEL TERRENO RIEMPIMENTO
a dal piano di bruno scurocalpestio a m 1 poco compatto a
matrice limo argillosa 2%
b da m 1 a m 7 bruno chiaro abbastanza compattoa matrice limo argillosa 40%
c da m 7 a m 8,10 bruno chiaro poco compatto a matrice limo argillosa 7%
d da m 8,10 bruno medio moltoa m 10,50 compatto a matrice
limo argillosa 20%
e da m 10,50 bruno scuro pocoa m 11,05 compatto di matrice
limo-sabbiosa 9%
f da m 11,05 bruno scuroa m 12,8 e melmoso a matrice
limo sabbiosa 21%
Fig. 52Sezione del pozzo 6009
Pozzo 6009 Questo pozzo, profondo m 12,80, di forma circolare con pareti verticali su cui ad intervalli regolari sono incise peda-role in due file asimmetriche, è stato realizzato tagliando la seguente stratigrafia geologica: banco di tufo grigio cam-pano, alternanza di cineriti e pomici, paleosuolo, conglomerato calcareo in formazione e banco di argille rossastre(fig. 52).La differenza di colore e consistenza del terreno del riempimento, analizzato con tecniche di microstratigrafia, ha per-messo di isolare e distinguere sei diversi livelli presentati nella seguente tabella, che sono stati denominati subunità.
Al terreno così distinto erano mescolati sia manufatti che resti faunistici. L’analisi di tali materiali offre uno spaccato delle azioni che ne hanno determinato la composizione e consente diavanzare alcune proposte interpretative relative alle funzioni che il pozzo ha svolto nel corso del tempo.Nel suo complesso il riempimento è costituito prevalentemente da frammenti ceramici (61%), mescolati a elementiarchitettonici (20%), oggetti fittili (1%), pietre (9%), oggetti metallici (1%), malta (1%), resti faunistici (5%) e mate-riale dendrologico (2%). Più specificamente i manufatti ceramici sono rappresentati da 720 frammenti così suddivi-si: ceramica a figure rosse (1%), a fasce (1%), vernice nera (14%), ceramica comune (81%), grandi contenitori (2%)e anfore da trasporto (1%) (fig. 53).
I CONTESTI CHIUSI
85
Esaminando nel dettaglio la composizione delle singole subunità emergono elementi per la ricostruzione delle dina-miche deposizionali e postdeposizionali, e l’analisi di tutti i reperti, insieme alla loro distribuzione nei diversi livelli,ha consentito di verificare che il riempimento è il risultato di azioni di accumulo distinte (fig. 54). La subunità a è costituita da 80 frammenti di ceramica comune, 26 di laterizi e due di malta.La subunità b ha restituito 101 frammenti vascolari dei quali 27 a vernice nera, 73 di ceramica comune, un frammen-to di anfora e uno di mortaio. L’analisi di questi reperti ha evidenziato la ricorrenza di esemplari molto frammentari registrando la perdita costan-te di parti significative dei vasi, in particolare dei fondi e dei piedi per la ceramica a vernice nera e degli orli per quel-la comune. Tra i frammenti a vernice nera è stato possibile riconoscere 15 individui pertinenti a vasi di produzione locale: unabrocchetta specie 5210 (fig. 55l), due coppette della serie 2725 (fig. 55a) e una della serie 2789 (fig. 55b), duecoppe della serie 2980 (fig. 55c-d), una della serie 2587 (fig. 55f), una della specie 2610 (fig. 55i), una della specie2780 (fig. 55e), una della serie 2671 (fig. 55g), una della serie 2152 (fig. 55h), tre piatti della serie 1310 (fig. 55m)e un unguentario (fig. 55n). L’esame macroscopico dell’argilla ha permesso di distinguere i frammenti di ceramica comune in due gruppi: delprimo, caratterizzato da un’argilla chiara (Munsell 7.5YR 8/6) molto depurata e compatta, fanno parte una brocca(fig. 56a) e 8 fondi pertinenti a forme chiuse non identificabili; al secondo gruppo, costituito da frammenti di impa-sto di color arancio-rossastro (Munsell 5YR 5/8) con inclusi di varie dimensioni di colore grigio, sono state attribui-te 16 olle delle quali due con corpo globulare e orlo a disco piatto (fig. 56c), 4 con labbro distinto e aggettante (fig.56d) e due con labbro svasato appena distinto (fig. 56b), un mortaio (fig. 56e), 8 fondi non identificabili e 2 fram-menti di coperchio. La gran parte dei materiali è inquadrabile nel corso della metà del III sec. a.C., tranne due coppe la cui cronologia ègeneralmente estesa fino al terzo quarto del III secolo a.C.13. La subunità c è costituita da 221 frammenti ceramici, dei quali 3 a figure rosse, 37 a vernice nera, 178 di ceramicacomune e 3 di anfore da trasporto, associati ad un peso da telaio di forma tronco-conica, a 201 frammenti di late-rizi, a 36 blocchi in tufo e a 3 oggetti metallici.Permane l’elevato indice di frammentazione dei reperti con costante assenza di parti significative dei vasi, in parti-colar modo di piedi per la ceramica a vernice nera e di fondi per quella comune. Sono stati identificati 14 individui pertinenti alla classe a vernice nera: una lekythos serie 5421 (fig. 57h), una lekanedella specie 4710 (fig. 57a), una brocchetta della specie 5220, 4 skyphoi della serie 4311 (fig. 57b-c), tre coppe di cuiuna della serie 2732 (fig. 57e), due della serie 2980 (fig. 57f-g), tre coppette pertinenti alla serie 2789 (fig. 57d) einfine una parete di guttus.I frammenti di ceramica comune per le caratteristiche dell’argilla sono stati suddivisi in due gruppi: al primo, carat-terizzato da un’argilla di colore beige scuro (Munsell 7.5YR 7/6) con pochi inclusi silicei e micacei è riferibile una situ-la (fig. 58a), mentre del secondo, contraddistinto da frammenti di impasto di colore rosso scuro (Munsell 5YR 4/6)con inclusi di varie dimensioni di colore bianco e con le superfici interamente annerite, fanno parte 7 olle, delle quali5 con labbro svasato appena distinto (fig. 58d) e due con orlo a disco piatto (fig. 58e-f), 3 coperchi con orlo a discoobliquo, un clibano (fig. 58c) e una lopas con labbro aggettante a sezione quadrangolare, vasca a profilo concavodistinto dal fondo convesso (fig. 58b). Sono stati, inoltre, individuati due pareti riferibili ad anfore di produzionegreco-occidentale.Il contesto è inquadrabile intorno agli anni centrali del III sec. a.C. fatta eccezione per gli skyphoi, forse di qualchedecennio più antichi.
Fig. 53Pozzo 6009. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche
Barbara Danza - Michele Scafuro
86
Fig. 54Pozzo 6009. Percentuali dei reperti e delle classi ceramiche divise per subunità
La subunità d è costituita da 96 frammenti tra i quali 10 a vernice nera, 82 di ceramica comune e 4 di grandi conte-nitori. In questa porzione del riempimento l’elevato indice di frammentazione dei reperti riguarda in particolar modo la ver-nice nera, mentre minore, ma comunque significativo, è quello dei vasi di uso comune. Sono stati riconosciuti 9 individui di ceramica a vernice nera, di cui tre skyphoi di tipo attico assimilabili alla serie 4382(fig. 59a), quattro coppe di cui una di produzione pestana (fig. 59c) non inquadrabili tipologicamente, una coppaetrusco-arcaica vicina alla serie 1552 (fig. 59b) e una coppetta concavo-convessa della serie 2430 (fig. 59d).
I CONTESTI CHIUSI
87
Fig. 55Pozzo 6009 subunità b. Ceramica a vernice nera: a) coppetta serie 2725; b) coppetta serie 2789; c-d) coppe serie 2980; e) coppa specie 2780; f) coppa serie 2587; g)coppa serie 2671; h) coppa serie 2152; i) coppa specie 2610; l) brocchetta specie 5210; m) piatti serie 1310; n) unguentario
Barbara Danza - Michele Scafuro
88
Fig. 56Pozzo 6009 subunità b. Ceramica depurata acroma: a) brocca; b) olla con labbro svasato; c) olla con labbro a disco piatto; d) olla con labbro distinto; e) mortaio
I CONTESTI CHIUSI
89
Fig. 57Pozzo 6009 subunità c. Ceramica a vernice nera: a) lekane specie 4710; b-c) skyphoi serie 4311; d) coppetta serie 2789; e) coppa serie 2732; f-g) coppe serie 2980; h)lekythos serie 5421
Barbara Danza - Michele Scafuro
90
Fig. 58Pozzo 6009 subunità c. Ceramica depurata acroma: a) situla. Ceramica grezza: b) lopas; c) clibano; d) olla con labbro svasato; e-f) olla con labbro a disco piatto
I CONTESTI CHIUSI
91
Fig. 59Pozzo 6009 subunità d. Ceramica a vernice nera: a) skyphos serie 4382; b) coppa serie 1552; c) fondo di coppa pestana; d) coppetta serie 2430. Ceramica depurata acroma: e) brocca; f) situla. Ceramica grezza: g) lopas con coperchio
Tra i frammenti di ceramica comune, distinti per le caratteristiche tecniche e cromatiche dell’argilla, sono riferibili alprimo gruppo (Munsell 7.5YR 7/4) una situla (fig. 59f), una brocca (fig. 59e) e 4 individui pertinenti a forme chiu-se; il secondo gruppo (Munsell 5YR 4/6) comprende una lopas con coperchio (fig. 59g), un fondo di caccabè, uncoperchio a disco obliquo e una forma chiusa. Sono stati individuati anche una parete di louterion e altre 3 paretinon riconducibili ad alcuna forma. I materiali di questa subunità sono databili in un arco cronologico compreso tra la seconda metà del V e il primodecennio del IV sec. a.C. La subunità e è costituita da 25 frammenti di ceramica, due pesi da telaio, 48 frammenti ossei, 61 blocchi di tufo, 6
Barbara Danza - Michele Scafuro
92
pietre calcaree levigate e 19 frammenti di materiale dendrologico. Tra i frammenti ceramici ve ne sono 11 a vernice nera, 2 di uso comune e 12 pertinenti a grandi contenitori.Una brocchetta ad impasto, rinvenuta quasi integra, si distacca dall’alto indice di frammentazione dei reperti a ver-nice nera, contraddistinti peraltro da una bassissima rappresentatività degli elementi indicativi degli individui. Tra i frammenti a vernice nera vi sono un orlo di kylix Bloesch C (fig. 60a), una coppa a labbro ingrossato e una conorlo piatto14 (fig. 60b-c), entrambe inquadrabili come etrusco-arcaiche, una coppetta confrontabile con il tipo smallbowl dall’ Agorà di Atene (fig. 60d), un coperchio di lekane (fig. 60e) e una forma non identificata. La brocchetta integra15 (fig. 60f) è costituita da un impasto di colore bruno scuro (Munsell 5YR 3/4), molto com-patto, con pochi inclusi scuri di piccole dimensioni, mentre un impasto grigio rossastro (Munsell 5YR 4/2) caratte-rizza l’orlo di una pentola a presa triangolare16. Tra i grandi contenitori è stato riconosciuto un pithos con orlo a sezio-ne triangolare. Completa questo contesto un peso da telaio (fig. 60g).
Fig. 60Pozzo 6009 subunità e. Ceramica a vernice nera: a) kylix Bloesch C; b) coppa a labbro ingrossato; c) coppa a labbro piatto (Bowl otturned rim); d) small bowl; e) coperchio dilekane. Ceramica grezza: f) brocchetta. Instrumenta: g) peso da telaio
I CONTESTI CHIUSI
93
Fig. 61Pozzo 6009 subunità f. Ceramica a fasce
I frammenti ossei, dei quali oltre la metà (27 frr) non sono identificabili in quanto schegge di ossa lunghe e piattenon definibili, si riferiscono a specie domestiche, essenzialmente bovini, ovicaprini e suini; un solo frammento è rela-tivo alla specie selvatica del cervo (Cervus elaphus L.)17. In questa porzione del riempimento sono stati rinvenuti inoltre 61 blocchi di tufo di dimensioni variabili (da cm 40a 60), sei pietre calcaree levigate di diametro variabile (da cm 20 a 48) e 19 frammenti di legno.L’omogenetà dei materiali ceramici induce a datare questa parte del riempimento tra il secondo e il penultimo quar-to del V sec. a.C. La subunità f è costituita da 158 frammenti ceramici dei quali 10 a fasce, 1 a vernice nera, 137 di uso comune e 10riferibili ad anfore. I reperti decorati a fasce di colore rosso e bruno sono molto frammentari (fig. 61) e la perdita delle parti significa-
tive dei vasi, fondi e orli, non ha permesso di identificarne la forma, mentre una coppa a vernice nera è accostabileal tipo stemmed dish convex and large dall’agorà di Atene18 (fig. 62a). La classe maggiormente attestata in questa porzione del riempimento è la ceramica comune depurata, caratterizza-ta da un minore indice di frammentazione; sono state identificate 5 anforette intere tutte con il collo distinto (fig.63), di cui due con ingubbiatura ocra scuro, due situle (fig. 63b-c) uno stamnos molto frammentario, almenoun’anfora da trasporto e 32 fondi riconducibili a forme chiuse (situle o anfore).Tutti i materiali sono databili tra la fine del VI e la metà del V sec. a.C. L’analisi qualitativa e quantitativa dei materiali, lo studio delle classi, la definizione delle categorie funzionali, ladistribuzione e l’individuazione degli indici di frammentazione delle classi ceramiche nei differenti livelli, hanno per-messo di distinguere lo strato d’uso, di chiusura e di riempimento del pozzo.Lo studio puntuale dei reperti ha portato, quindi, ad individuare il materiale caduto involontariamente nel pozzo,mentre era funzionante come punto di approvvigionamento idrico, dal materiale gettato volontariamente quando ilpozzo non era più in uso.È stato così possibile precisare che il materiale connesso al periodo d’uso è predominante nel livello più profondo(subunità f) e consiste in tipologie vascolari utili alla raccolta dell’acqua (situle e anfore). Questi vasi, parzialmentericomponibili o addirittura integri, suggeriscono l’ipotesi che siano caduti sul fondo quando era ancora presentel’acqua. Al contrario la frammentarietà dei vasi rinvenuti nei livelli superiori indica che erano già rotti prima di esse-re gettati. Pertanto si deduce che solo un terzo della porzione del riempimento è riferibile alla fase d’uso, mentre irestanti due terzi si connotano come scarico di materiali ceramici non legati alla raccolta dell’acqua. Considerando le classi funzionali (fig. 64a-b) si ricava che dalla subunità a proviene un solo vaso destinato alla mensa,
Barbara Danza - Michele Scafuro
94
Fig. 62Pozzo 6009 subunità f. Ceramica a vernice nera: a) coppa stemmed dish convex and large. Ceramica depurata acroma: b-c) situle (1:4)
nella successiva (subunità b) i recipienti più numerosi sono destinati alla preparazione dei cibi (67%), in numero mino-re quelli da mensa (31%), ed in percentuale esigua quelli di uso personale. Nella subunità c i vasi più numerosi sonodestinati alla mensa (57%), seguiti da quelli per la cucina (30%), da quelli per la raccolta dell’acqua (8%) e da pochivasi destinati all’uso personale (5%). Nella subunità d le ceramiche da mensa sono le più attestate (73%), seguite da vasi utilizzati per raccogliere e conser-vare i liquidi (20%) e da quelli destinati alla cottura dei cibi (7%). Diversa è la composizione della subunità e: numerosissimi i blocchi di tufo, gli elementi ossei e il materiale dendrolo-gico, mentre i pochi frammenti ceramici sono pertinenti a vasi da mensa (72%), e in percentuale minore a quellidestinati alla cottura dei cibi (14%), e alla raccolta e conservazione dell’acqua (14%).La subunità f è l’unica contraddistinta da una consistente percentuale di vasi funzionali alla raccolta e alla conserva-zione dei liquidi (99%). Pertanto i vasi destinati alla raccolta dell’acqua risultano significativamente attestati soltanto nel livello più profon-do che può con affidabilità ritenersi il livello d’uso (fig. 64c-d).L’analisi comparata di tutti i livelli (fig. 64c) permette, dunque, di riconoscere tre fondamentali momenti di forma-zione del riempimento a partire dal fondo: il primo, inquadrabile tra la fine del VI e il secondo quarto del V sec. a.C.,è legato alla funzione originaria del pozzo che si pone nella stessa fase del primo impianto della struttura monumen-tale. Il secondo, datato dal secondo quarto del V agli inizi del IV sec. a.C. (subunità e-d) testimonia la chiusura volontariadel pozzo come fonte di raccolta dell’acqua, ipotesi avvalorata dal ritrovamento di frammenti di legno, di pietre cal-caree e del pithos di grandi dimensioni che con molta probabilità doveva costituire la vera del pozzo 19. Tale evento siinquadra nel momento di ristrutturazione dell’area, dinamica indiziata anche dal pozzo 3272. Il terzo livello, datato dalla metà del IV alla metà del III sec. a.C., testimonia l’utilizzo del pozzo come ricettacolo perscaricare rifiuti; non a caso i vasi provenienti dalle subunità superiori (c, b ed a) sono confrontabili per tipi e classi
I CONTESTI CHIUSI
96
Vasi per preparare / Vasi per mangiare / Vasi per Vasi dicucinare (Cucina) bere / mescere (mensa) raccogliere / uso personale
conservare liquidiSubunità a - 1 - -Subunità b 1 15 1 1Subunità c 12 11 2 3Subunità d 3 10 1 -Subunità e 1 5 1 -Subunità f - 1 40 -
Mortaio Coppa Situla LekaneLopas Coppetta Anfora Unguentario
Caccabè Piatto LekythosOlla Skyphos
Clibano Brocca/brocchetta
Fig. 64Pozzo 6009. Distribuzione e grafici delle classi funzionali della ceramica, calcolate sul numero degli individui (a) e dei frammenti (b-c-d)
funzionali con quelli delle fosse di scarico rinvenute nell’area20.I pochi frammenti databili anche oltre la metà del III sec. a.C., provenienti dal livello più alto del riempimento super-ficiale, attestano la sopravvivenza di una ridotta forma di frequentazione che interessa la parte nord- orientale dellastruttura21.
(M.S.)
I CONTESTI CHIUSI
97
Analisi delle archeofaune del pozzo 600922
I resti osteologici sono complessivamente 48 (fig. 65), di cui oltre la metà (27 frammenti) non sono identificabili inalcun modo (schegge o frammenti di ossa lunghe e piatte non meglio definibili) e 21 frammenti identificabili tasso-nomicamente e/o solo anatomicamente si distribuiscono principalmente tra le specie domestiche (fig. 66). Lo stato di conservazione del materiale osteologico, non proprio ottimale, non è relazionabile ai meccanismi tafo-nomici di deposizione, bensì all’elevato grado di fratturazione praticato in antico sulle carcasse animali.Tra i frammenti diagnostici si sono riconosciute essenzialmente specie domestiche (bovino, ovicaprino e suino) edun solo frammento relativo alla specie selvatica del cervo (Cervus elaphus L.), pertinente alla porzione prossimale diuna tibia in fusione non completa.Il bue (Bos taurus L.) è attestato da un dente mediamente usurato; a questa specie sono, probabilmente, da attribuir-si alcuni frammenti anatomici di taglia grande.La specie ovicaprina (Ovis vel Capra) è documentata da 5 frammenti di cui non risulta facile stabilire lo stadio di etàdi accrescimento; tuttavia una tibia distale completamente fusa e un M3 mandibolare permanente, isolato, attesta-no un solo individuo di età superiore ai 12-18 mesi di vita. Un maggior numero di elementi anatomici e di individui sono riferibili al maiale (Sus scrofa domesticus L.): 7 elementirelativi soprattutto a porzioni mascellari e mandibolari, con denti e molari inseriti e isolati, recanti considerevoli trac-ce di bruciatura da fuoco (pratiche di cottura della carne). Si riconoscono almeno tre individui, conteggiati sullabase delle differenti età di abbattimento e sulla sovrapposizione per lato di alcuni elementi anatomici, il secondomolare mandibolare rappresentato due volte che attesta un’età di abbattimento superiore agli 8-12 mesi di vita. Unesemplare macellato in età giovane-adulta (circa 18-22 mesi), è indiziato da una mandibola sinistra con il terzomolare permanente in eruzione non completa, mentre un emicranio ed una mandibola destra, entrambi con il terzomolare eruttato completamente, restituiscono un altro individuo abbattuto in età superiore ai 18-22 mesi di vita.Inoltre un canino mandibolare isolato accerta la presenza di almeno un individuo di sesso femminile, compreso nellaprima fascia di età.Benché il numero del campione sia esiguo risulta palese la notevole differenza di attestazione tra il maiale e le altrespecie.Confrontando i valori anatomici tra il bue (1 elemento per 1 individuo) e le pecore/capre (5 elementi per un indivi-duo), risulta che non vi è coincidenza tra il maggior numero di elementi anatomici attestati per specie ed il numerominimo di individui da essi ricavato (Grafico fig. 67).Non è stato possibile calcolare in nessun caso l’altezza al garrese di ciascuna specie per mancanza di elementi ana-tomici con lunghezza massima rilevabile. Quasi tutti gli elementi anatomici rinvenuti, compresi quelli non identificabili presentano tracce di macellazione esegni di taglio; ad eccezione di una mandibola di maiale che reca segni evidenti di masticazione umana (fig. 68a-b). Una sorta di spatola ottenuta mediante lisciatura di una porzione di diafisi di osso lungo. E rotta in antico su unodei due lati brevi riflette pratiche di lavorazione dell’osso. (fig. 69).Benché esiguo il campione rientra nei limiti di affidabilità poiché quasi il 50% dei frammenti è risultato diagnostico(21 su 48 frammenti in totale): si tratta di specie domestiche in prevalenza suini i cui resti risultano macellati e recan-ti tracce di arrossamento e bruciatura del periostio indizio di cottura per consumo alimentare.
(N.P.)
Barbara Danza - Michele Scafuro
98
Fig. 65Pozzo 6009. Totale dei resti faunistici
Fig. 66Pozzo 6009. Totale dei resti faunistici identificati per specie
Fig. 67Pozzo 6009. NMI per specie animale
I CONTESTI CHIUSI
99
Fig. 69Spatola ricavata dalla diafisi di un osso lungo indeterminato (foto N. Pizzano)
Fig. 68a) Mandibola di maiale (Sus scrofa dom.) con evidenti tracce di bruciatura da fuoco e perforazione circolare (in blu) (faccia laterale, foto N. Pizzano); b) Mandibola dimaiale (Sus scrofa dom.) con perforazione sub-circolare (in blu) e segni di masticazione umana (in rosso) (faccia mediale, foto N. Pizzano)
a b
Barbara Danza - Michele Scafuro
100
1 Per la loro collocazione topografica e i rap-porti stratigrafici cfr. capitolo precedente.
2 Per l’inquadramento delle classi dei materialicfr. capitolo succesivo.
3 Si tratta in questo caso di buche create dacespugli e alberi impiantati per la sistemazionea giardino dell’area.
4 La ricomposizione e il restauro dei vasi sonostati realizzati nel laboratorio di Archeologiadell’Università di Salerno da Luigi Musella nelquadro di una convenzione con laSoprintendenza Archeologica di Napoli, pressocui ricopre il ruolo di restauratore. Gli oggettirestaurati, soprattutto in ceramica depuratacomune, in parte sono esposti negli spazi delRettorato dell’Ateneo Salernitano. Cfr.L’archeologia all’Università.
5 Cfr. supra, p. 35.
6 La fossa è stata già pubblicata in Fratte 1997.
7 Si tratta di un mezzo nominale recante sul D/testa di Apollo volta a sinistra e coronata di allo-ro e sul R/ cane da caccia volto a destra; intornola leggenda in osco Nukrinum Alafaternum: cfr.Fratte 1997, fig. 2 e in particolare appendice,scheda n. 94, con bibliografia.
8 Si tratta di un frammento di bucchero ed unodi ceramica a fasce pertinenti a forme nonmeglio precisabili.
9 Oltre ad alcuni frammenti del bacino è perti-nente allo stesso louterion anche il piede di unsostegno.
10 Si tratta di tre coppe della serie 1552 e unadella specie 2430, di una coppetta della serie2789 e una della serie 2787; per gli altri skyphoinon è possibile precisare la tipologia.
11 Un numero considerevole di questi oggetti furinvenuto durante gli scavi Sestieri, la maggiorparte dei quali trova confronti con i tipi indivi-duati da ZACCAGNINO 1998. Il nostro frammentosi può inoltre accostare ad alcuni esemplariattestati dal santuario di Rossano di Vaglio e,precisamente, con quelli del tipo ad alto fustoper cui cfr. ADAMESTEANU-DILTHEY 1992, p. 61,tav. XXXIII b, inv. 72446.
12 In particolare due sono caratterizzati da inci-
sioni: uno presentava una fibula ed un altro unacroce.
13 Si tratta della coppa serie 2152 e della coppaspecie 2610.
14 Le due coppe rappresentano i tipi più fre-quenti dei contesti della seconda metà del Vsecolo a Fratte, e spesso sono associate, comenel corredo della t. 45 del 1963: cfr. Fratte 1990,p. 269, nn. 5 e 6. Entrambe le coppe sono simi-li al tipo bowl otturned rim dell’agorà di Atene: cfr.Agorà XII, fig. 8, 788, pp. 128-129, 291.
15 La forma può essere generalmente confron-tabile con un esemplare a decorazione geome-trica, oggetto di corredo della t. 221/1 dellanecropoli di Lavello: cfr. Forentum I, p. 160,brocca a labbro obliquo, tipo 1, tav. 21, T.1. Siveda inoltre BAILO MODESTI 1980, pp. 160-162,t. XII, tav. 83, n.15.
16 Questa pentola presenta un orlo piatto leg-germente sporgente all’esterno, una presa trian-golare impostata orizzontalmente poco aldisotto dell’orlo. Il tipo è riconducibile ad esem-plari diffusi nelle necropoli e negli abitati dellaCampania meridionale dall’orientalizzanterecente al periodo arcaico: cfr. GASTALDI 1979,fig. 12, 10; Fratte 1990, p. 57, fig. 59, n. 2.
17 Cfr. infra, p. 97.
18 L’esemplare esaminato è attestato a Fratteda contesti funerari datati fra il 480-460 a.C.:cfr. Fratte 1990, t. XVIII/1972, n. 4, pag. 223,fig. 369. È confrontabile inoltre con esemplarinoti dall’agorà di Atene datati nel primo quartodel V sec. a.C.: cfr. Agorà XII, nn. 958-961, p.303, tav. 35. Oggetti simili sono ampiamentediffusi anche nei contesti di Vico Equense: cfr.BONGHI JOVINO 1982, p. 73, n. 51, tav. 112, 10.
19 L’uso del pithos come vera fittile è testimonia-to da numerose immagini vascolari. Cfr. adesempio GINOUVÈS 1962, tav. 13. I frammenti dilegno e le sei pietre calcaree invece dovevanoappartenere ad un congegno utile alla raccoltadell’acqua probabilmente composto da unatrave lignea e da una corda alla quale da un latosi legava un vaso e dall’altro, come contrappe-so, una pietra.
20 Sull’interpretazione e sullo studio di contesti
di scarico come “depositi di informazioni relative alleattività che si svolgevano nel sito che li ha utilizzati” sivedano i contributi di MANACORDA 1984;SCHIFFER 1997, p. 59; DEWRETT 1999, p. 20;CARANDINI 2000b, pp. 1-2; MANACORDA 2000,pp. 63-73.
21 Cfr. supra, pp. 64-78.
22 Bibliografia di riferimento: BARONE 1976;BARONE 1980; BÖSSNECK-MÜLLER-TEICHERT 1964;CHAIX-MENIEL 2001; MINNITI 2005; SILVER 1969;VON DEN DRIESCH 1976; WILSON-GRIGSON-PAYNE
1982.
Note
I CONTESTI CHIUSI
Finito di stampare nel mese di settembre 2009presso la Tipolitografia Incisivo, Salerno.
Edizioni Menabò comunicazioneISBN 88-86635-36-2
PROVINCIA DI SALERNOAssessorato ai Beni e alle Attività Culturali
Unione EuropeaLa presente pubblicazione è stata realizzata
nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III B 2000-2006ARCHIMED MED.ARCHEO.SITES
Studio e valorizzazione dei siti archeologici dell’area mediterraneacofinanziato dall’Unione Europea tramite il FESR
FRATTEIL COMPLESSO
MONUMENTALE ARCAICO
Angela Pontrandolfoin collaborazione conAlfonso Santoriello
Unione Europea
FRA
TTE
IL C
OM
PLES
SO M
ON
UM
ENTA
LE A
RC
AIC
O
CopertinaMar.qxp:copertinaxstampa.qxp 28-12-2009 12:53 Pagina 1