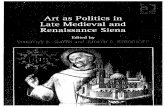D.Salvi, La sigillata africana a Pill’‘e Matta: contesti chiusi e datazioni, nuovi elementi...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of D.Salvi, La sigillata africana a Pill’‘e Matta: contesti chiusi e datazioni, nuovi elementi...
Carocci
l’africa
romanaLe ricchezze dell’Africa. Risorse, produzioni, scambi
A cura di Julián González, Paola Ruggeri,Cinzia Vismara, Raimondo Zucca
Volume terzo
Collana del Dipartimento di Storiadell’Università degli Studi di Sassari
Nuova serie fondata da Mario Da Passano, Attilio Mastino,Antonello Mattone, Giuseppe Meloni
Pubblicazioni del Centro di Studi Interdisciplinarisulle Province Romane
dell’Università degli Studi di Sassari
35***
In copertina: Arco di Traiano a Thamugadi (foto di Attilio Mastino).
I lettori che desideranoinformazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editricepossono rivolgersi direttamente a:
Carocci editorevia Sardegna 50 - 00187 Roma
telefono 06 / 42818417 - fax 06 / 42747931
Visitateci sul nostro sito Internet:http://www.carocci.it
Coordinamento scientifico: Centro di Studi Interdisciplinarisulle Province Romane dell’Università degli Studi di Sassari
Viale Umberto I 52 - 07100 Sassaritelefono 079 / 2065203 - fax 079 / 2065241
e-mail [email protected]
La Redazione di questi Attisi è avvalsa della collaborazione alla revisione scientifica
e al coordinamento redazionale di Maria Bastiana Cocco e di Alberto Gavini
Le ricchezze dell’Africa.Risorse, produzioni, scambi
Atti del XVII convegno di studioSevilla, 14-17 dicembre 2006
A cura di Julián González, Paola Ruggeri,
Cinzia Vismara e Raimondo Zucca
Volume terzo
Carocci editore
Volume pubblicato con il contributo finanziario di
Ministerio de Educacion y Ciencia Accion ComplementariaHUM 2006-27408-E Cofinacion FEDER
Dottorato di ricerca Scuola Europea: “Storia, letterature e culture del Mediterraneo”.
1a edizione, dicembre 2008© copyright 2008 by
Carocci editore S.p.A., Roma
Finito di stampare nel novembre 2008
isbn 978-88-430-4833-5
Riproduzione vietata ai sensi di legge(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione,è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,compresa la fotocopia,
anche per uso interno o didattico.
Donatella Salvi
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta:contesti chiusi e datazioni, nuovi elementi
dagli oltre duecento corredi della necropoli
La necropoli di Pill’ ’e Matta, a Quartucciu, continua a offrire, asei anni dall’avvio dello scavo archeologico, dati di straordinaria ri-levanza per la conoscenza dei materiali tardoantichi ed in particola-re per lo studio delle ceramiche sigillate africane 1.
La necropoli presenta numerosi motivi di interesse: primo, nel-l’impatto immediato, è quello della struttura delle sepolture, insolitenon solo in Sardegna, ma anche nel Mediterraneo romano. Al lorointerno appare nuovo il rituale, caratterizzato dai moduli che parte-cipano alla composizione e alla collocazione del corredo funebre.Poi, pur nella varietà delle fasi storiche rappresentate, le buone con-dizioni di conservazione delle sepolture. Tra quelle già scavate, or-mai più di duecentocinquanta (FIG. 1), il numero più consistente èrappresentato dalle sepolture tardoantiche; poche sono infatti letombe puniche, che rappresentano a partire dal IV secolo a.C., lapiù antica fase d’uso 2, pochissime quelle di età repubblicana 3; con-
* Donatella Salvi, Soprintendenza ai Beni Archeologici di Cagliari e Oristano.1. Per l’analisi di un primo gruppo di sepolture e considerazioni d’insieme sulla
necropoli si rimanda a D. SALVI (a cura di), Luce sul tempo. La necropoli di Pill’ ’e
Matta, Quartucciu, Cagliari, 2005 e, sul problema delle datazioni EAD., La datazione
dei materiali: conferme e smentite dai contesti chiusi tardo-romani e altomedievali, inForme e caratteri della presenza bizantina nel Mediterraneo occidentale: la Sardegna (se-
coli VI-XI), Atti del Convegno (Oristano, 22-23 marzo 2003), (cds).2. Oltre a SALVI (a cura di), Luce sul tempo, cit., pp. 187-8 per le tombe puni-
che cf. EAD., Tuvixeddu-Cagliari, Pill’ ’e Matta-Quartucciu. Notizie da due necropoli
puniche, in ACFP, VI, Lisbona (cds.).3. Si segnala un unico caso di bustum, contro la grande quantità individuata a
Cagliari, nella necropoli di Tuvixeddu: D. SALVI, Tomba su tomba: indagini di scavo
condotte a Tuvixeddu nel 1997. Relazione preliminare, «RStudFen», 28/1, 2000, pp.57-78 e EAD., Tipologie funerarie nei nuovi settori della necropoli di Tuvixeddu, in Ar-
chitettura, arte e artigianato nel Mediterraneo dalla Preistoria all’Alto Medioevo, a curadell’Associazione Culturale “Filippo Nissardi”, Oristano 2001, pp. 245-61.
L’Africa romana XVII, Sevilla 2006, Roma 2008, pp. 1731-1748.
tenute, in rapporto all’insieme, quelle che si riferiscono al III secoloe che in parte adottano la struttura consueta alla cappuccina. Sia nel-le sepolture della piena età imperiale che in quelle tarde, è frequentela presenza di monete, cosa che consente di mettere a confronto si-tuazioni simili, verificando continuamente associazioni di materiali edatazioni valide nella sequenza relativa se non di quella assoluta.
Da ciò deriva la valutazione dei corredi come associazioni certee volontarie, nelle quali i materiali sono costantemente contestualiz-zati. La possibilità di datazione si estende così, non solo a queimateriali che sono già considerati, pur nella difficoltà della lorocollocazione, datanti, ma anche a quei materiali per così dire inso-liti, che la necropoli restituisce e che, fuori contesto, sarebbero piùdifficilmente collocabili nel tempo.
Queste osservazioni, su altro piano, rendono il gruppo socialerappresentato dalla necropoli di Pill’ ’e Matta, soprattutto per ilperiodo compreso fra la metà del III ed il V secolo, apparentemen-
Fig. 1: Quartucciu, necropoli di Pill’ ’e Matta, planimetria aggiornata al2006.
Donatella Salvi1732
te isolato sia dai gruppi che abitano le aree vicine, sia dai centrinoti del Mediterraneo con i quali non condivide né i rituali né latipologia funeraria.
Questa è infatti, proprio a partire dalla metà del III secolo, ca-ratterizzata da una fossa rettangolare aperta nel terreno sedimenta-rio e poco omogeneo che forma l’intera area di Pill’ ’e Matta. Sulfondo del pozzo, orientato est-ovest, si aprono sui lati lunghi unao due nicchie nelle quali è deposto il defunto, supino, con il capoa ovest, accompagnato dagli oggetti del corredo. L’apertura dellanicchia, che resta, a parte il corpo, vuota, viene chiusa da embricidisposti a coltello ed il pozzo è poi colmato dalla terra ricavatadallo scavo (FIG. 2). Non ci sono elementi per comprendere se, al-l’esterno, fossero presenti dei segnacoli; alcune grosse pietre arro-tondate sono state in realtà ritrovate in punti diversi dell’area, manessuna occupava una posizione tale da consentire l’ipotesi dell’as-sociazione.
All’interno della nicchia, come si è detto, gli oggetti sono di-sposti presso il capo e presso i piedi del defunto. Laddove il nu-
Fig. 2: Quartucciu, necropoli di Pill’ ’e Matta, pianta, prospetto e sezionedella Tomba 15 (rilievo e disegno P. Matta, M. Olla).
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta 1733
mero è particolarmente consistente, una parte degli oggetti è collo-cato lungo la parete di fondo, utilizzando forse gli spazi lasciati li-beri dal corpo; in altri casi gli oggetti sono fra loro sovrapposti.Fanno parte del corredo funebre forme aperte e chiuse, lucerne,bicchieri; di quello personale bracciali, anelli, fibbie in bronzo ecollane di vaghi in pasta vitrea.
Le forme chiuse di maggiori dimensioni sono quasi sempre rap-presentate da produzioni locali, le cd. campidanesi 4, le cui officinerealizzano anche molti piatti per lo più ampi, poche brocchette mi-niaturistiche e rare lucerne. I piatti, sia di produzione locale che diimportazione – e in questo caso si tratta spesso anche di coppe escodelle – contengono una o più lucerne, oppure bicchieri e lucer-ne, o ancora brocchette costolate e lucerne, formando moduli chepossono ripetersi più volte. Le lucerne, che presentano semprel’annerimento del beccuccio, sono deposte accese: il loro rovescia-mento occasionale e l’incendio rapido del combustibile, dopo lachiusura della tomba, determina in qualche caso l’annerimento to-tale o parziale non solo dell’oggetto ma anche della forma apertache lo contiene. Le lucerne in uso in questa fase, salvo le pocheeccezioni delle produzioni locali citate o di forme acrome con laspalla decorata a perline 5 della prima metà del IV secolo, sono tut-te africane. Sia le forme Atlante VIII che quelle Atlante X presenta-no una grande varietà nella decorazione del disco: figure animalinaturalistiche o vagamente stilizzate, figure vegetali, raffigurazioniumane accompagnano l’altrettanto grande ricchezza nella resa deisimboli di ispirazione cristiana. Tratte dal repertorio biblico sonopoi la raffigurazione di Daniele nella fossa dei leoni 6 e quella, diparticolare rilevanza, di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre checompaiono rispettivamente su una lucerna Atlante X e su una cop-pa forma Hayes 53 (FIG. 3). Qui, contrapposti, fra le due figureumane che, nude, si coprono i genitali, sono realizzati due grandialberi in uno dei quali, cioè quello con i frutti che si compone fi-
4. Cf. C. TRONCHETTI La ceramica della Sardegna romana, Milano 1996, D. SALVI
La ceramica campidanese di età romana nella necropoli di Pill’ ’e Matta, in Memoria
del presente e vecchi mestieri, a cura di G. CAMBONI, Nuoro 2005, pp. 13-5.5. Cfr. per le lucerne forma Provoost 4 con spalla a perline C. S. FIORIELLO, Le
lucerne imperiali e tardoantiche di Egnazia, Bari 2003.6. Cfr. F. BEJAOUI, Ceramique et religion chrétienne. Les thèmes bibliques sur la
sigillée africaine, Tunis 1997, p. 24, scheda 63 per puntuale confronto con una lucer-na del Museo del Bardo, e schede 23-24 e 64 per altre rappresentazioni di Danielenella fossa dei leoni con l’angelo e Habacuc.
Donatella Salvi1734
gurativamente con i due personaggi, un grande serpente avvolge lesue spire 7 (FIG. 3). Insieme a queste raffigurazioni, e spesso all’in-terno della stessa sepoltura, compare però, con una certa frequen-za, sempre e solo su lucerne forma VIII, anche la menorah, il can-delabro ebraico nelle due consuete tipologie a bracci curvi o retti-linei, ad indicare che i tanti simboli adottati dalle officine di pro-duzione per un mercato in gran parte cristianizzato, non riflettononecessariamente il credo di chi utilizza l’oggetto 8.
La possibilità di prendere in esame il gran numero di oggetti(2.580 reperti finora solo per l’età romana) e di stabilire quindi lacontemporaneità d’uso delle forme o la loro successione nel tempo,grazie anche all’appoggio delle monete, consente di superare, intutto o in parte, i molti problemi che hanno fin qui accompagnatola datazione delle sigillate africane, molto spesso basata su criteri
7. Cfr. da ultimo ivi, p. 21 e scheda 1 sull’esemplare, simile ma non identico aquesto, del Museo di Costantina.
8. L’argomento è trattato in D. SALVI, I rituali della morte a Pill’ ’e Matta, Quartuc-
ciu: motivi cristiani ed ebraici in contesti pagani di IV e V secolo, in Atti del IX Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), (cds.). Per una in-teressante interpretazione relativa alla raffigurazione bucolica – figura maschile che suonaseduti su una casetta poggiata su un albero – su una lucerna forma X. Cfr. C. P. CHA-
RALAMPIDIS, The dendrites in the pre-Christian and Christian historical-literary tradition
and iconography, Rome 1995.
Fig. 3: Piatto con la raffigurazione dell’Eden alla Tomba 20 di Pill’ ’e Mat-ta, metà del IV secolo d.C. (foto C. Buffa).
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta 1735
tipologici, – come nel caso delle collezioni di lucerne 9, ma la situa-zione è simile anche per altri materiali, come i bicchieri 10, – o sul-la base delle sequenze relative degli scavi stratigrafici. Tale possibi-lità appare tanto più fortunata e inconsueta se si considera chenello stesso arco di tempo nel quale a Pill’ ’e Matta si adottanoquesti rituali, in altri centri la progressiva cristianizzazione compor-ta l’abbandono del rituale pagano del corredo ed il defunto affidala propria visibilità al ricordo scritto, su marmo, o su mosaico, delproprio nome e della propria fede. Ha carattere straordinario an-ch’esso, dovuto ad un intervento effettuato fra settembre e novem-bre 2006, il ritrovamento nell’area di San Saturnino, a Cagliari, diun ambiente funerario nel quale si conservano i resti di quattropannelli funerari in mosaico, segno residuo di una tipologia ampia-mente diffusa, ma purtroppo attestata quasi esclusivamente dai re-soconti degli scavo condotti nel Seicento alla ricerca dei “corpisanti” 11. Il richiamo assume ulteriore forza dal fatto che i pochimateriali contenuti nel riempimento intenzionale del vano, costitui-to dai detriti della demolizione di una parte del suo elevato, eranoframmenti di un vaso a listello, di una brocca campidanese, di unoo più bicchieri a calice ed un gran numero di monete. I primi in-terventi di restauro hanno per il momento riguardato esemplaridella serie felix temporum reparatio, – la cui indicazione non puòconsiderarsi ancora datante, visto che le circa 50 monete ritrovatesono di diverso modulo e in diverso stato di conservazione – che èanche quella più frequentemente attestata nella necropoli di Quar-tucciu.
E infatti intorno alla metà del IV secolo che le sepolture ospita-no il maggior numero di reperti, ed in particolare di quelli in sigil-lata, anche se già dai primi decenni del secolo, ancora in associa-
9. E. JOLY, Lucerne del Museo di Sabratha (Monografie di Archeologia Libica,XI), Roma 1974.
10. Cfr. D. SALVI, Bicchieri, calici e coppe nella necropoli di Pill’ ’e Matta (CA),in Il vetro in Italia meridionale e insulare, Atti del Secondo Convegno Multidisciplina-
re, AIES Beni Culturali, a cura di C. PICCIOLI e F. SOGLIANI, Napoli 2003, pp.117-26.
11. In generale sull’area D. MUREDDU, D. SALVI, G. STEFANI, Sancti innumerabi-
les. Scavi nella Cagliari del Seicento. Testimonianze e verifiche, Oristano 1988. Per al-tro pannello in mosaico privo di iscrizione, ritrovato nella stessa area cfr. D. MURED-
DU, G. STEFANI, La diffusione del mosaico funerario africano in Sardegna: scoperte e ri-
scoperte, in L’Africa romana III, pp. 339-61.
Donatella Salvi1736
zione con lucerne bollate a disco tondo 12, compaiono i piatti diforma Hayes 32-58 e le coppette con orlo a tesa piana 13. E co-munque con l’età di Costantino – segnata da monete della seriegloria exercitus, sol invicto comiti, Roma e la lupa – che si assiste almassiccio arrivo delle lucerne forma VIII e, gradualmente, entro ilterzo quarto del secolo, all’inserimento delle forme aperte Hayes59, 61A 14, 67, associate a monete dei successori di Costantino.Meno confortata dalle monete, allo stato attuale, l’effettiva datazio-ne dei materiali che, in organica sequenza e con passaggi progressi-vi nell’associazione, si possono attribuire agli ultimi decenni del se-colo, e cioè il vaso a listello Hayes 91A, il piatto 61B e le lucerneforma Atlante X, anche se qualche esemplare di queste forme è giàassociato a monete della serie felix temporum reparatio (TAB. 1).D’altra parte, gradualmente, la presenza delle monete va rarefacen-dosi fino a scomparire. Il dato numismatico più tardo, ma coerentecon la sequenza, è quello fornito dalla moneta di Teodosio II – co-niata nel 422 d.C. – impressa su una lucerna forma X, in un corre-do che, come molti altri contemporanei, comprende vasi a listello91C, scodelle con orlo a mandorla Hayes 99, coppe 80B e lucerneormai soltanto della forma X (FIGG. 4 e 7). Nella progressionecomplessa ma certamente lineare che è possibile stabilire, si puòseguire la successione delle forme e l’arrivo distinto di produzionidiverse, non solo nella varietà della foggia ma anche nella qualitàdella vernice, nelle spessore delle pareti e così via.
I circa settecento reperti in sigillata africana finora ritrovaticonferiscono infatti alla necropoli di Pill’ ’e Matta una posizione diassoluto primato sia nel numero delle attestazioni che nelle possibi-lità di analisi di materiale sempre contestualizzato. Propongono,nell’arco di tempo relativamente breve dei due secoli rappresentati,la possibilità di seguire il variare delle produzioni, di cogliere la
12. I bolli sono delle officine di Agri e Victoris, già editi da G. SOTGIU, Le iscri-
zioni latine della Sardegna, II, 1, Padova 1968, nn. 468 e 394.13. Cfr. l’associazione di monete datate entro il primo decennio del IV secolo
con stoviglie in sigillata africana nel relitto di Funtanamare, Gonnesa, per cui F. FAC-
CENNA, Il contesto monetale, Fontanamare (Cagliari), in F. PALLARÉS, P. DELL’AMICO,F. FACCENNA, Il relitto “A”, «Bollettino di Numismatica», 36-39, 2001-02, pp. 83-126;D. SALVI, I. SANNA, L’acqua e il tempo. Prospezioni di archeologia subacquea nelle ac-
que di Gonnesa, Cagliari 2000. 14. M. BONIFAY, Sur quelques problèmes de datation des sigillées africaines à
Marseille, in Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W.
Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), a cura di L. SAGUÌ, Firenze 1998, pp. 71-81.
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta 1737
Fig. 4: Quartucciu, necropoli di Pill’ ’e Matta: corredo della Tomba 11, se-conda metà del IV secolo d.C. (disegni M. Olla).
Donatella Salvi1738
Fig. 5: Quartucciu, necropoli di Pill’ ’e Matta, corredo della Tomba 22,fine del IV-V secolo d.C.: 4) piatto Hayes 64; 12) piatto Hayes 61B; 6) sco-della Hayes 84; 10) scodella Hayes 99; 16) brocca campidanese; 5) piattocampidanese; 13) brocchetta costolata; 17) e 1) brocchette Boninu 1971-72(disegni A. Dessi).
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta 1739
Fig. 6: Quartucciu, necropoli di Pill’ ’e Matta, corredo della Tomba 22, se-conda metà del IV secolo d.C.: 3), 7), 8) lucerne Atlante VIII; 11), 15) e 2)lucerne Atlante X (disegni M. Olla).
Donatella Salvi1740
Fig. 7: Quartucciu, necropoli di Pill’ ’e Matta; corredo della Tomba 19, pri-ma metà del V secolo d.C. 1) scodella Hayes 99; 2) 2a) lucerne; 3) bicchie-re a calice; 3a) vaso a listello Hayes 91 C; 4) brocca campidanese; 4a)brocchetta Boninu 1971-72; 5) 91C fibbia in bronzo (disegni di M. Olla);6) pinzette in bronzo.
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta 1741
gradualità delle trasformazioni, di valutare l’intensità dei commerciconclusi ed effettivamente giunti a destinazione.
Nell’insieme si ha l’impressione che le diverse forme non abbia-no una durata molto lunga e che la diffusione sia legata all’arrivo,per così dire, a lotti, dei materiali, che, all’interno della necropoli,possono poi essere utilizzati di volta in volta come indicatori. E pos-sibile su queste basi stabilire anche la sua stratigrafia orizzontale overificare i modi del suo incremento, che non risultano necessaria-mente in sviluppo costante e regolare di espansione. Sagome diversee distinte assume l’area funeraria nella fase punica ed in quella data-bile entro l’inizio del IV secolo, mentre più tardi le sepolture ab-bracciano l’intera area, comprendendo tutte quelle precedenti, e siespandono soprattutto verso est. Se poi si utilizza quale indicatoreuna delle forme più tarde, la scodella Hayes 99, si nota che le se-
Tabella 1: Associazione di monete e forme ceramiche.
III sec./inizi IV:monete imperatoriillirici e tetrarchi
prima metà IV sec.:monete di Costan-tino
seconda metà IV
sec.: monete suc-cessori di Costanti-no e Magnenzio
fine IV sec. prima metà/V
sec.: moneta diTeodosio II sulucerna X
Lucerna adisco tondo
Lucerna VIII Lucerna VIII Lucerna VIII
Lucerna X
Lucerna X
Hayes 32-58Hayes 50
Hayes 59Hayes 44/52a/70 etc.Hayes 53
Hayes 59,Hayes 44 ecc.Hayes 61Hayes 67
Hayes 61BHayes 91AHayes 80AHayes 84
Hayes 91CHayes 81Hayes 84Hayes 80BHayes 99
Lamboglia11ter
Boninu(1971-72)
Ceramicacampidanese
Ceramicacampidanese
Ceramicacampidanese
Ceramicacampidanese
Ceramicacampidanese
Forme chiusecostolate
Brocchettecostolate apiede distinto
Brocchettecostolate
Brocchettecostolate
Brocchettecostolateapode
BrocchesovradipinteBrocchettegraffite
Bicchieri condepressioni oa piederistretto
Bicchieriovoidali
Bicchierisvasati o tron-conici,Ising 96
BicchieriIsing 96
BicchieriIsing 111
Donatella Salvi1742
Tabella 2: Quadro riassuntivo dei corredi di alcune tombe con sequenza delle forme presenti.
(segue)
La sigillata african
a a Pill’
’e Matta
1743
polture che la contengono non sono in assoluto le più esterne, maoccupano, per motivi non conosciuti, spazi lasciati liberi soprattuttofra quelle che le hanno precedute da minor tempo.
La certezza delle sequenze ha, come conseguenza, anche la pos-sibilità di datare reperti rari o insoliti nel panorama dei materialidiffusi in Sardegna e, più in generale, nel mondo mediterraneo:così i pochi esemplari di ceramica sovradipinta in rosso e bruno oalcuni altrettanto insoliti complementi d’abbigliamento che si ac-compagnano spesso a fibbie in bronzo e ferro, utili a suggerireprecoci modifiche nei modelli di vestiario (FIG. 9). Ma è utile an-che a stabilire sequenze delle brocchette costolate, tanto spesso de-finite bizantine, o della stessa ceramica campidanese che, prodottaper quasi due secoli, mantiene intatte le proprie caratteristiche fisi-che e di rifinitura a stecca ma modifica col tempo i modelli, forseanche sulla base della funzione svolta dai recipienti. Altrettantopuò dirsi per i bicchieri, numerosi e vari, in gran parte integri, chevanno dalle forme ovoidali della prima metà del IV secolo alle di-verse tipologie della forma svasata per privilegiare, infine, la formaa calice (TAB. 2).
L’ultima annotazione è dedicata all’ipotesi di individuazione diquesto gruppo sociale, che segna la propria presenza con l’introdu-zione della nuova tipologia funeraria, affiancando – a parità di cor-redi e quindi di tempo – le tradizionali sepolture alla cappuccina,fino a soppiantarle nel giro di qualche decennio e che gode evi-dentemente di un buon tenore di vita per tutto il periodo d’usofin qui accertato della necropoli. Lo studio sulla diffusione e sulladistribuzione territoriale in Sardegna dei materiali che sono presen-ti a Pill’ ’e Matta, soprattutto in contesti chiusi, ha consentito con-fronti interessanti, ma non ha portato a stabilire parallelismi nénella quantità degli oggetti né nella tipologia delle tombe 15.
I confronti, nel quadro della contemporaneità, – diverso il casodell’uso in momenti diversi 16 – portano perciò lontano, alle popo-lazioni sarmate e alle varie contaminazioni con altri popoli nomadiche hanno le ultime attestazioni in Crimea 17. L’ipotesi, formulata
15. Cfr. ora D. SALVI, La raccolta archeologica di Arborea: una rilettura dei reper-
ti tardoantichi, (cds).16. Cfr. ad esempio il caso delle sepolture a nicchia laterale chiusa da lastre in
pietra a Sétif nei primi secoli dell’Impero: R. GUÉRY, La nécropole orientale de Sitifis
(Sétif, Algérie). Fouilles de 1966-1967, Paris 1985.17. Cfr. A. AJBABIN, I Goti in Crimea, in I Goti, Milano 1994, pp. 110-35.
Donatella Salvi1746
Fig. 8: Quartucciu, necropoli Pill’ ’e Matta, corredo della Tomba 5, primametà del V secolo d.C.; 1) brocca campidanese; 2) scodella Hayes 99; 3) e11) bicchieri a calice; 4), 8) e 12) lucerne Atlante X; 6) vaso a listelloHayes 91 c; 5 e 9) brocchette costolate; 10) piatto campidanese; 13) orec-chini a pendente fisso; 14) piastrina in bronzo (disegni P. Matta).
La sigillata africana a Pill’ ’e Matta 1747
già in altre sedi pur con tutte le cautele del caso, è che qui, comeè avvenuto in diverse regioni d’Italia nella seconda metà del III se-colo, siano stati avviati per intensificare la coltivazione della vite 18
– fra l’altro ben compatibile con la natura del terreno di questaporzione dell’interland cagliaritano – gruppi di Sarmati che hannoportato con sé i propri modelli ed i propri rituali della morte. Allasomiglianza delle sepolture si aggiunge la nuova foggia del vestia-rio, le caratteristiche di lavorazione e di decorazione dei monili, ilnumero stesso degli oggetti che compongono il corredo. Lo studioantropologico, che affianca fin dall’avvio quello archeologico, potràforse fornire, nell’analisi comparata delle sepolture, ulteriori ele-menti per sostenere o smentire questa ipotesi.
18. Cfr. L. CRACCO RUGGINI, I Barbari in Italia nei secoli dell’impero, in Magi-
stra Barbaritas, Milano 1984, pp. 24-36.
Fig. 9: Sistema di fibbia dalla Tomba 114 di Pill’ ’e Matta (foto C. Buffa).
Donatella Salvi1748