“Un nuovo dinos da Chiusi con le nozze di Peleus e Thetis, in E. M. Moorman-V. Stissi (eds.),...
-
Upload
firenze-archeo -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of “Un nuovo dinos da Chiusi con le nozze di Peleus e Thetis, in E. M. Moorman-V. Stissi (eds.),...
In omaggio a Herman Brijder, che gran parte dellasua vita ha dedicato allo studio delle coppe desti-nate al consumo del vino nei symposia ateniesi dellaprima metà del VI sec. a.C., mi sembra appropri-ato presentare un dinos del Pittore di Londra B 76,che probabilmente fu l’elemento centrale di unservizio da simposio della stessa epoca.
Nel 1858, durante una delle sue escursioni inEtruria, Heinrich Brunn ebbe modo di visitare lacollezione di Luigi Lunghini, a Sarteano (Siena),dandone notizia l’anno seguente, nel Bullettinodell’Instituto di Corrispondenza Archeologica perl’anno 1859, come di una delle più importanti rac-colte di antichità del territorio di Chiusi.1 Tra ilmateriale segnalato, il Brunn ricorda che ‘un granvaso della forma detta holmos fu trovato vicino alluogo, dal quale proviene il celebre vaso François,e si accosta a questo alquanto nello stile de’ dis-egni, che raffigurano diversi animali e scene dicombattenti’.2 Come preannunciato nella stessacronaca, la collezione sarebbe stata venduta di lìa poco; già prima della fine del 1858, infatti, fuacquistata dal Barone francese Pierre AmédéeFoucques de Vagnonville (Douai 1806-Firenze1876), che nel 1861 la trasferì nel suo nuovopalazzo fiorentino, sul Lungarno delle Cascine;alla morte del Barone, la nutrita raccolta archeo-logica passò per legato testamentario alla città diFirenze e fu quindi trasferita in Palazzo Vecchio,dove Gian Francesco Gamurrini poté allestire il‘Museo Vagnonville’ in una sala dello splendidoQuartiere di Leone X, sotto gli affreschi eseguitidal Vasari fra il 1556 e il 1562. Infine, nel 1881, iltrasferimento del Regio Museo Archeologico di
Firenze nell’attuale sede del Palazzo della Crocettaoffrì una più idonea collocazione espositiva; fucosì che, nel 1882, il Comune di Firenze depositòla raccolta Vagnonville nel nuovo Museo, dove fuparzialmente esposta nella sala VII.3
Tra i vasi greci di cui la collezione si fregiava,l’allora Direttore del Museo, Luigi Adriano Milani,segnalava ‘un holmos4 di tipo e stile ionico su cuiè forse rappresentata una processione nuziale epi-talamica (cfr. Vaso François)’, ma allo stesso tempolamentava che il vaso fosse tra quelli ‘disgrazia-
63
Un nuovo dinos da Chiusi con le nozze di Peleus e Thetis
Mario Iozzo
Abstract
An Attic black-figure fragment recently found in the vicinity of Fonte Rotella in Chiusi, has led to the ‘redis-covery’ of a dinos preserved in fragments in the storerooms of the Archaeological Museum of Florence. Theexistence of this dinos was noted in the 19th century, first as a part of the Lunghini Collection of Sarteano, thenin the Vagnonville Collection in Florence. This vase was painted about 560 BC by the Painter of London B 76,an artist clearly inspired by the works of Kleitias. The dinos of Chiusi - the measurements of which are closeto those of the François Vase - depicts the wedding of Peleus and Thetis. This is particularly meaningful, inas-much as the celebrated krater of Ergotimos came to light in the very same area of Chiusi. This dinos, therefore,is a second symposion-vase of large proportions, representing the same theme and dated to the same decades,found in the same area.*
Fig. 1. Dinos ricomposto, con parte dell’hypokrate-rion. Chiusi, Museo Archeologico Nazionale 67371
+ frr. ex Vagnonville. Foto Soprintendenza per i BeniArcheologici della Toscana.
tamente sciupati dal moderno ristauro’.5 Questopotrebbe forse giustificare, da un lato, l’erroneainterpretazione del fregio figurato in cui era in-cappato il Brunn e, dall’altro, il fatto che, all’attodell’acquisizione della collezione da parte delMuseo di Firenze, il vaso non sia stato inclusonell’elenco dettagliato che pure accompagnava ildocumento ufficiale del deposito. Fu proprio per
questa ragione che, dopo l’alluvione del 1966, chelo ridusse in frammenti ma che ebbe anche il mer-ito di sciogliere ed annullare le integrazioni ingesso e le pesanti ridipinture dei ‘restauratori-mistificatori’ chiusini del XIX secolo,6 il dinosrimase nei magazzini del Museo fra gli oggettisenza provenienza (a volte considerato anche per-duto7), inedito ed apparentemente mai esaminato
64
Fig. 2. Restituzione del profilo e della sezione (L. Cappuccini).
da J.D. Beazley, fin quasi a confluire erronea-mente, in anni recenti, persino fra i materiali dellacollezione Campana.
Il caso ha voluto che un nuovo frammento delvaso (fig. 19, a sinistra), per di più contiguo adaltri della parte inferiore della vasca, sia statorecentemente rinvenuto durante una battuta dicaccia al cinghiale nella zona di Fonte Rotella,8consentendo così di recuperare con certezza,dopo oltre un secolo e mezzo, l’identificazione deldinos come quello delle collezioni Lunghini, prima,e Vagnonville, poi, e di confermarne la prove-nienza dalla stessa necropoli ed, in particolare,dalla medesima area che aveva restituito ilCratere François.
PRESENTAZIONE DEL DINOS
Il dinos,9 oggi nel Museo Archeologico Nazionaledi Chiusi (fig. 1), è conservato parzialmente, innumerosi frammenti che tuttavia ne permettonouna lettura sufficiente.10 Il corpo è formato daun’ampia vasca globulare, con la spalla legger-mente appiattita, alla quale aderisce l’orlo, costi-tuito da un semplice ispessimento; il sostegno (fig.2), di cui rimane soltanto l’estremità superiore, hauna forma composita: un calice cilindrico conmodanature ai margini (di cui quella superiore abecco di civetta), che si restringe verso il fusto, ilcui attacco è segnato da uno spesso anello plas-tico a sezione oblunga.11
Sull’orlo12 rimane parte di un fregio con figureumane inserite fra gruppi di animali, reali e fan-tastici (fig. 3): due figure maschili barbate, sim-metricamente disposte ai lati di un bocciolo di lotodischiuso, che si ripiega sul proprio stelo, levano
la mano destra a reggere una lancia o forse unoscettro (di cui però non resta traccia); la figuraconservata, con il capo coronato da una tainiaincisa, è vestita di un himation paonazzo indossatosu un chiton bianco (fig. 4). Alla sua destra, unascena di zoomachia: un leone, con la lunga crini-era paonazza che scende a ciocche sulle terga eduna sottile coda con l’estremità a ciuffo, attaccaun torello la cui giovane età è indicata dalle cornaappena accennate, ed affonda le zanne nella nucadella sua preda, facendone sgorgare un fiotto disangue; oltre alle digitazioni intercostali ed allafascia muscolare della zampa posteriore, sovrad-dipinte in paonazzo, il pittore ha indicato nellafiera anche la fila dei capezzoli,13 per cui potrebbeforse trattarsi di una leonessa, malgrado la pre-senza della criniera. Si conservano ancora uncinghiale rivolto a sinistra ed alle sue spalle parte
65
Fig. 3. Restituzione grafica del fregio principale, della fascia figurata sull’orlo e della girandola sul fondoesterno (L. Cappuccini).
Fig. 4. Particolare del fregio sull’orlo. Foto Soprin-tendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
di una Sirena con le ali spiegate naturalistica-mente,14 quindi una coppia di Sirene, una con leali falcate e l’altra, retrospiciente, con le ali natu-ralistiche.15 All’incirca diametralmente oppostialla coppia di uomini, due galli si affrontano ailati di una palmetta su volute (fig. 5).16 La com-posizione è intenzionalmente simmetrica, così chela coppia di figure umane risulta circondata da unmondo selvaggio e liminale di violente zoomachie,fiere reali e mostri mitologici, ed è messa in chiaracontrapposizione con la coppia di galli, impettitie battaglieri protagonisti di un latente alektryononagon, una di quelle accese competizioni molto dif-fuse ad Atene, nelle quali si affrontavano i celebrigalli di Tanagra o di Rodi, apprezzati gli uni perla loro aggressività, gli altri per la loro robustezzae resistenza.17
Sulla spalla del dinos, alla base dell’orlo, correla corona di linguette (figg. 2, 4-5), motivo divenutostandard da quando il Pittore della Gorgone, mu-tuandolo dal repertorio dei coevi pittori corinzidei crateri a colonnette,18 lo adottò nel suo dinoseponimo, al Louvre:19 alternativamente nere epaonazze, con il colore sovraddipinto diretta-mente sul fondo, le linguette sono racchiuse insottili gusci diluiti, raccordati inferiormente da unalinea più spessa. Un sottile filetto, tracciato convernice bruna molto diluita, separa la coronadalla sottostante catena di coppie di palmette efiori di loto,20 un registro supplementare certa-mente inserito per spostare più in basso il fregiofigurato ed evitare così il problema delle testedelle figure che andavano ad occupare la zonacurva della spalla; tale espediente21 sembra esserestata un’invenzione del Pittore dell’Acropoli606,22 subito ripresa da altri ceramografi, come
66
Fig. 5. Particolare del fregio sull’orlo. Foto Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
Fig. 6. Dinos su sostegno. Firenze, MuseoArcheologico Nazionale 3785. Foto Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana.
quello di Londra B 76,23 fino ai pittori dei dinoinella variante semiverniciata che si svilupperàintorno al 540 a.C. (come ad esempio un esem-plare inedito del Museo di Firenze;24 fig. 6), perfinire al vaso eponimo del Pittore del Louvre E876, che manterrà lo schema anche in una serie diregistri figurati.25
Il fregio principale raffigura il corteo epitalam-ico di Peleus e Thetis (fig. 3). Lo sposo,26 di cui siconserva parte delle spalle e della testa, con lacapigliatura a lunghe ciocche ondulate con ritoc-chi paonazzi, accoglie il corteo divino davanti allareggia di Phthia (o al palazzo sul Monte Pelion27),cui volge le spalle (figg. 7-8). L’edificio è distilo inantis ed ha la trabeazione a metope, dalla piùesterna delle quali sporge un elaborato hydrorrhoona palmetta; le due colonne centrali sono nere,mentre le due ante esterne sono suddipinte inbianco, probabilmente ad indicare l’impiego dimateriali pregiati, con sottili linee incise che evi-denziano le scanalature verticali del fusto e la filadi ovuli sul capitello;28 al centro, la porta d’ingresso,con le ante chiuse (fig. 9).
La pompe olimpica è costituita da un primogruppo di personaggi che avanzano a piedi (figg.10-12), fra i quali si riconosce Hermes, con glipteroenta pedila, il petasos nero (con una tainia e lanappina superiore paonazze) ed un un lungokerykeion - piuttosto che una rhabdos - nella manodestra:29 il Dio veste un chitoniskos bordato inferi-ormente da una fila di zig-zag e con fasce orna-mentali sulle spalle, sul quale indossa una nebrispaonazza, trattenuta aderente al corpo tramiteuna cintura e con le estremità che pendono suldavanti, come nell’immagine del Dio raffiguratoda Kleitias alle spalle di Achille, nel fregio diTroilo, sul Vaso François.30 Tra Hermes e Peleusrimane uno spazio sufficientemente ampio da faripotizzare la presenza di un elemento (forse un
67
Fig. 7. Particolare del fregio principale: Peleusdavanti alla reggia. Foto Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana.
Fig. 8. Particolare del fregio principale: reggia ePoseidon (?). Foto Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana.
Fig. 9. Ricostruzione grafica della reggia di Peleus(L. Cappuccini).
altare come nel Vaso François?), ma non per unaltro personaggio.
Segue una figura femminile che leva la manosinistra in un ampio gesto interlocutorio,31 proba-bilmente di saluto: la Dea è vestita di un chitonpaonazzo a maniche corte, con un largo bordonero decorato da un motivo a pseudo-guilloches(incise, con oculi paonazzi32), sul quale indossa unhimation nero con incisioni per gli asteriskoi rica-mati;33 i lunghi capelli ondulati, trattenuti sulcapo da una tainia paonazza, incorniciano il voltobianco sul quale sono incisi a tratto sottilissimogli occhi a mandorla, la rima labiale, il padiglioneed il lobo auricolari; anche nelle mani, le dita sonodistinte da finissime incisioni. La Dea potrebbe
essere identificata con Maia, madre di Hermes,che non sembra rientrare fra le figure dipinte daSophilos nelle sue versioni delle celebri nozze, mache invece compare sul carro, insieme al figlio, nelfregio del Vaso François;34 più difficilmente credoche si tratti di una figura legata al Dio che segue,Dionysos, e che vi si possa quindi riconoscereAriadne o Semele, che in questo caso precedereb-bero il Dio stesso.35
Alle spalle di Maia avanza Dionysos,36 vestitodi un himation paonazzo indossato sopra un raf-finato chiton nero con micrografie zoomorfe sovrad-dipinte in bianco,37 un prezioso abbellimento chericorda la lussuosa veste ambrosia intessuta daAthena per Hera:38 sul piano iconografico, il
68
Fig. 10. Particolare del fregio principale: Hermes,Maia (?), Dionysos. Foto Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana.
Fig. 11. Restituzione grafica del primo gruppo didivinità a piedi (L. Cappuccini).
Fig. 12. Particolare del fregio principale: Chiron.Foto Soprintendenza per i Beni Archeologici dellaToscana. Particolare del fregio principale: Peleus
davanti alla reggia. Foto Soprintendenza per i BeniArcheologici della Toscana.
Fig. 13. Particolare del fregio principale: Nymphai oHorai e cavalli della I quadriga. Foto Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana.
motivo si inserisce nel solco di una tradizione cherisale ai pittori di età geometrica e si ritrova finnel pieno VI sec. a.C., in opere di Sophilos,Kleitias, Nearchos e delle loro cerchie, incluso ilPittore di Londra B 76, fino al Gruppo Tirrenico.39
Il Dio del vino, con il capo coronato d’edera40 econ una capigliatura con lunghe ciocche ondulateche ricadono sulle spalle, avanza reggendo nellamano destra un rigoglioso tralcio di vite e solle-vando nella sinistra il kantharos, del quale si con-servano il piede e parte dello stelo;41 alle suespalle, un altro grande ramo di vite si dipartemiracolosamente dalla figura stessa del Dio.
Segue Chiron,42 che avanza carico del suo bot-tino di caccia, due lepri appese al ramo che gravasulla sua spalla sinistra; il Centauro, dal pelamefulvo,43 indossa un chitoniskos bordato sulle spalleed alle maniche da una fascia di S ed inferiormenteda motivi circolari. La posizione dell’avambrac-cio destro suggerisce che la mano corrispondentereggesse qualche oggetto, forse la kithara, simbolodelle elevate qualità etiche del Centauro, o - comesul dinos ex Erskine - un bastone nodoso, chepoteva essere la sua arma da caccia o piuttosto il
suo dono di nozze all’amico Peleo: il ramo difrassino del Monte Pelion dal quale Athena edHephaistos avrebbero ricavato la lancia che, siasecondo l’autore dei Canti Ciprii (Kypria, 3 Allen)che secondo Omero (Il. 16.140-144), Peleus avrebbesuccessivamente donato ad Achille e questi l’avreb-be adoperata una volta soltanto, per l’uccisione diTroilos.44
Si conservano, poi, due Dee di un originariogruppo probabilmente di tre (fig. 13), avvolte nelpharos paonazzo che ne sottolinea l’unione in unfraterno sodalizio e ne dichiara l’appartenenzaalla medesima categoria:45 tra il fondo del tessutocolorato ed il nero dei capelli ondulati si staglianoi volti bianchi, con le fini incisioni per gli occhi amandorla, le arcate sopracciliari ed i padiglioniauricolari, mentre sul collo spicca il sottile hormospaonazzo che lo adorna; la parte inferiore con-serva i bordi orlati degli himatia (fila di S e fasciaa reticolo) ed il peplo nero con gli stessi elementistellari incisi che abbelliscono l’himation di Maia.Il gruppetto potrebbe forse essere identificato conle Ninfe, visto che sul dinos londinese di Sophilosle tre Ny(m)phai sono collocate in una posizioneanaloga,46 oppure con le Horai, come nel fregio diKleitias.47
Alle loro spalle, ma in primo piano, avanzasolenne una quadriga (I), verosimilmente quella diZeus e Hera, visto che per la sua importanza essaapre ovviamente il corteo dei carri nelle scene siadi Sophilos che di Kleitias. I destrieri, tenuti alpasso, sono di colori alternati48 e quello in primopiano, di sponda, sfoggia una plastinx con borchiebianche sovraddipinte; sul carro,49 del quale siintravede il rhymos con i suoi tiranti (si noti l’accu-ratezza nell’evidenziare persino i legacci che assi-curano la barra alla base del pianale, visibili fra iraggi delle ruote50) si conserva parte della figurain primo piano, che dovrebbe essere alla guida,quindi forse Zeus, vestito di un chiton con piegheverticali. Dietro la quadriga, un altro gruppo di trefigure femminili, probabilmente anch’esse avvoltenel pharos paonazzo,51 delle quali si conservanol’estremità della testa, i piedi, un tempo sovraddi-pinti in bianco, e la parte inferiore dei pepli, unodei quali paonazzo e con l’orlo decorato da cer-chietti incisi. La composizione è identica a quelladel dinos ex Erskine di Sophilos, dove le tre figuresono anonime (su quello in frammenti dall’Acro-poli non si conservano), mentre sul Vaso Françoisla coppia divina è accompagnata dalle prime dueMuse,52 Kalliope ed Ourania.
La quadriga seguente (II) trasporta due divinitàmaschili (figg. 14-15): quella in primo piano, conbarba e capelli paonazzi, chiton bianco plissettato
69
Fig. 14. Particolare del fregio principale: coppia didivinità maschili sulla II quadriga, coppia mistasulla III, Mousai (?). Foto Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana.
Fig. 15. Dettaglio della restituzione grafica dellequadrighe II e III (L. Cappuccini).
e himation nero, regge le redini e contemporanea-mente stringe il kentron nella mano destra; quellaal suo fianco, barbata, ha la fronte cinta da unatainia paonazza. In secondo piano rispetto ai ca-valli, un ulteriore gruppo di tre figure femminili,delle quali rimane solo la parte inferiore, con l’in-carnato in bianco e le vesti di colori alternati,abbellite da preziose orlature.53 A differenza delpittore del dinos chiusino, Sophilos e Kleitias sonoconcordi nell’assegnare la seconda quadriga deiloro cortei a Poseidon ed Amphitrite: nel dinos diLondra la coppia marina è accompagnata dalle treCharites ed in quello di Atene da cinque Nysai,54
mentre nel vaso François da altre quattro Muse:Thaleia, Euterpe, Kleio55 e Melpomene. Una coppiadi divinità maschili (Hermes alla guida ed Apol-lon con la kithara) occupa la IV quadriga nel vasolondinese, mentre le figure sulle quadrighe in IVposizione non si conservano né sul dinos di Atenené sul vaso François, ma nel nostro caso Hermesè già raffigurato a piedi, mentre nel cratere fioren-tino è sulla VI quadriga, insieme a Maia.
La III quadriga (figg. 14-15) accoglie una Deaalla guida ed un dio alla sua sinistra,56 entrambi
con il capo cinto da una tainia paonazza; in questocaso i cavalli hanno la criniera incisa a cioccheondulate, che in quello di sponda, in primo piano,è anche sovraddipinta in bianco;57 al di sopra deidorsi, un fascio di otto linee incise rende l’allinea-mento delle briglie in tensione, dalle quali spuntal’oiax all’altezza del garrese: il numero delle inci-sioni, che corrisponde esattamente a quello delleredini previste per un tiro a quattro, potrebbe nonessere casuale, ma indicare l’attenzione del pittorenell’incidere il corretto numero richiesto.58 Suldiphros del carro, paonazzo ma con un’ampia fa-scia bianca in corrispondenza del pianale, rimanel’estremità inferiore della veste femminile, nera ebordata da una fila di S. Dietro i cavalli, tre figurefemminili, con il collo adorno di hormoi paonazzi,di cui la prima con un peplo paonazzo e con ilbordo orlato.59 A parte il dinos dell’Acropoli, chenon conserva le figure, sia per Sophilos che perKleitias la terza quadriga appartiene ad Ares eAphrodite, cui si accompagnano cinque Mo(u)sai
70
Fig. 16. Particolare del fregio principale: cavalli dellaIV quadriga. Foto Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana
Fig. 17. Restituzione grafica di Hephaistos sul muloe Poseidon (?) (L. Cappuccini).
Fig. 18. Particolare dei fregi zoomorfi. FotoSoprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana.
Fig. 19. Particolare del fregio zoomorfo superiore (asinistra, il fr. Landucci). Foto Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana.
nel dinos di Londra e le ultime tre nel Vaso François:Stesichore, Erato, Polymnis. È molto probabile,dunque, sia pur in assenza di iscrizioni, che anchenella III quadriga del nostro dinos si possa rico-noscere la coppia che incarna l’eterno binomio diamore e guerra e forse un gruppo di Muse al suofianco.60
Della IV quadriga si conserva parte dei cavalli(fig. 16), di cui almeno uno di tirella è bianco, pro-babilmente una femmina,61 mentre quello di spondain primo piano, un destriero nero, ha la plastinx aborchie, come nella I quadriga; i chalina sono cos-tituiti dai morsi tripartiti, come in tutti gli altricavalli, e dalle redini, che, essendo tracciate piùin alto che negli altri casi, lasciano visibile l’oiax,delineato in maniera piuttosto schematica. Dietrola quadriga, un ulteriore gruppo di tre figure fem-minili, di cui la prima indossa un peplo rosso conil bordo inferiore a circoletti, la seconda uno nero,orlato da una fascia di motivi a croce e forse conuna fascia verticale bianca al centro, e la terza -conservata soltanto nella parte superiore - indossaun peplo rosso. Nel dinos di Londra, la IV qua-driga è dedicata ad Apollon e Hermes ed èseguita da tre Mo(u)sai, mentre i personaggi nonsi conservano né in quello di Atene né nel crateredi Kleitias, sul quale, tuttavia, non mancano le trefigure femminili.62
Dietro l’ultima quadriga avanza Hephaistos(fig. 17), in groppa all’asino itifallico del quale siconservano parte delle zampe e la testa;63 quest’ul-tima è di dimensioni inferiori rispetto a quelle deicavalli ed in una posizione fortemente flessa versoil basso, probabilmente perché quasi a ridosso dellacoppia sulla IV quadriga. Il Dio è chiaramentericonoscibile dal piede ritorto, in questo caso ildestro, sia che egli cavalcasse all’amazzone, comenei cortei nuziali del dinos londinese e del VasoFrançois,64 sia che montasse a cavalcioni, comenel suo ritorno all’Olimpo sul cratere di Kleitias.65
Il dettaglio del piede ricurvo all’indietro è un es-pediente grafico per rendere la difficoltà di deam-bulazione del Dio, probabilmente elaborato daceramografi di Corinto (come sembra dimostrareun noto amphoriskos paleocorinzio66) e ripreso neglistessi anni, oltre che dal Pittore di Londra B 76,anche da artigiani laconici ed euboici67 che raf-figurarono il ritorno di Efesto sull’Olimpo.68
Mentre in entrambi i dinoi di Sophilos e nelcratere di Kleitias Hephaistos chiude il corteodivino, nel fregio chiusino l’ultimo partecipantesi trova alle spalle del Dio, a ridosso del palazzo diPeleus (figg. 8-9, 17): una figura maschile, vestitadi un chiton paonazzo e di un himation bordato dauna fascia di S, avanza a piedi nudi reggendo nella
destra un oggetto dal lungo manico. È molto proba-bile che si tratti di Poseidon che impugna il tridente,anche se, per il suo rango e per la sua importanzanel pantheon, negli altri cortei nuziali il Dio delmare occupa ben altra posizione, ovvero la qua-driga immediatamente successiva a quella di Zeuse Hera.69 Più difficilmente si potrebbe trattare diOkeanos - nonno della sposa - forse raffiguratocon uno scettro, che nella documentazione icono-grafica di età arcaica mantiene l’aspetto semiani-malesco e le cui sembianze umane sono finoraattestate soltanto a partire dal V sec. a.C., in un’o-pera del Pittore di Syriskos.70 Nel dinos chiusino,dunque, il Pittore di Londra B 76 potrebbe averescelto di chiudere il corteo con Poseidon raffigu-rato a piedi, quindi ancora una volta una divinitàdel mare che accompagna l’imperfetto figlio diHera sul suo mulo, al pari di quanto avviene sianel fregio completo di Sophilos che in quello diKleitias, dove Hephaistos procede insieme adOkeanos anguiforme (l’apsorrhoos omerico edesiodeo) e cornato (il taurokranos dell’Oresteseuripideo).
Se si trattasse realmente di Poseidon, inoltre,non andrebbe trascurata la possibilità che la pompesi apra, dopo il gruppo a piedi, con Zeus, il primodei due originari pretendenti alla mano di Thetis,e si concluda con il Dio del mare, che era il se-condo, come confermano i versi dell’ottava odeistmica di Pindaro.71
La superficie del dinos al di sotto del fregio conil corteo nuziale è decorata da due registri zoo-morfi, separati da coppie di filetti di vernice diluita:combinazioni diverse di animali reali e fantas-tici,72 con qualche rara rosetta negli spazi di risultaed almeno un bocciolo isolato, su un sottile stelo.Nel primo registro sono raffigurati, in corrispon-denza della reggia di Peleus, due leoni affrontatiche agitano le code sulle terga (fig. 18),73 mentreai lati sono sedute due Sfingi con le ali falcate; piùa sinistra, in direzione opposta al corteo divino,una Sirena; al di sotto di Dionysos (fig. 10), duecinghiali affrontati, di cui uno a testa bassa, e piùa sinistra una Sirena con le ali spiegate naturalisti-camente, fra due con le ali falcate (fig. 19); ancoraoltre, in corrispondenza delle quadrighe I e II,parte di un volatile verso destra (fig. 20); alle suespalle, due cinghiali affrontati, di cui quello adestra abbassa la testa di fronte a quello di sinis-tra, un verro di maggiori dimensioni; seguonouna Sirena con le ali naturalistiche, che volge losguardo all’indietro, ed un leone.
Del secondo fregio, conservato solo in minimaparte, rimangono un gruppo costituito da unaSirena naturalistica rivolta a destra tra due con le
71
ali falcate e, più a sinistra, due capri affrontati (fig.18), quindi una zoomachia in cui un leone attaccaun cinghiale (fig. 20), parte di un altro leone rivol-to a sinistra (fig. 19), un capro verso destra (fig. 20,a destra) e due pantere con la faccia frontale dis-poste ai lati di un capro rivolto a destra.
Sul fondo del dinos, dopo una larga fascia nera,una girandola di dodici crescenti lunari alternati-vamente neri, paonazzi e color della terracotta maverosimilmente un tempo bianchi,74 questo moti-vo ornamentale era forse il più idoneo fra quelliche richiedevano l’adattamento ad un campo cir-colare o semisferico,75 come ad esempio l’episemadi uno scudo o il fondo di un aryballos, ma esso fuparticolarmente apprezzato proprio nei dinoi, tantoda essere impiegato in quasi tutti gli esemplaridella prima metà del VI sec. a.C., con qualche rarocaso anche nella seconda metà del secolo.76 Èprobabile, infatti, che si debba vedere una precisacorrispondenza fra il vaso stesso, con la sua pecu-liare forma globulare, ed il motivo spiraliforme
che ne decorava il fondo, entrambi correlati con itermini dinos e dine che indicano il vortice, sia diaria che di acqua (quindi anche della bevandamescolata dentro il recipiente), la forza di rotazi-one di una spinta circolare (quindi anche deltornio che aveva modellato il vaso), il movimentovorticoso della danza corale e persino la rotazionecosmica che tanta importanza ebbe nelle teorie deifilosofi presocratici sulla formazione del kosmos.77
Il sottostante hypokraterion (figg. 2, 21), la cuisagoma mostra forti affinità con la struttura e lemodanature degli esemplari prodotti negli ergaste-ria ateniesi della prima metà del VI sec. a.C., eradecorato da una fila di venti rosette multipetali,78
delimitata in alto e in basso da una stretta fasciapaonazza che corre parallela ad una profonda sol-catura; una banda paonazza corre anche sull’anelloplastico tra il calice ed il fusto. La superficie internaè verniciata fino all’attacco del fusto ed il marginedel calice è ampiamente consunto per l’uso.
Il dinos da Fonte Rotella, con l’orlo costituitosolo da un ispessimento aderente alla spalla (fig.2), corrisponde al Tipo I della classificazione pro-posta da A.B. Brownlee, nella quale la forma glo-bulare del contenitore e quella del supporto, arti-colato in calice, flange e largo piede strombato,risultano fissate in maniera stabile già dal 590circa a.C., probabilmente ad opera dei ceramistiattivi nella bottega in cui lavorava il Pittore dellaGorgone.79 Tale modello fu fedelmente seguitoanche da quelli della generazione successiva,innanzitutto da Sophilos, che dimostrò anche unaparticolare predilezione per la forma;80 fu proprioquesta che, con la sua ampia ed ininterrotta super-ficie, gli suggerì una delle principali innovazionida lui apportate nel campo della ceramografiaattica, ovvero quella del fregio unico che giraintorno al vaso, con il quale veniva superato loschema con due soggetti, precedentemente adot-tato dal Pittore della Gorgone.81 L’innovazioneelaborata da Sophilos fu ripresa immediatamentedagli artigiani coevi, fra i quali il Pittore di LondraB 76, cui il nostro dinos va attribuito.
DISCUSSIONE
Per il vaso di Chiusi è stata calcolata una capacitàintorno a 66 litri, dal momento che esso ne con-terrebbe 66,7 se riempito fino all’orlo raso82 (cosache tuttavia ritengo inverosimile, anche perchéniente affatto funzionale, in quanto l’immersionedi un kyathos, di un arysteros, di un kykethron o diqualsiasi altro tipo di attingitoio avrebbe causatol’immediata fuoriuscita del liquido). Tale misuracorrisponde quasi esattamente a 20 choes, (ciascuna
72
Fig. 20. Particolare del fregio principale (con partedelle quadrighe I e IxI) e dei registri zoomorfi. FotoSoprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
Fig. 21. Parte superiore dell’hypokraterion. FotoSoprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
di litri 3,283) e si avvicina a quella di un metretese due terzi, laddove un metretes (ovvero la prin-cipale unità metrica del sistema attico tradizional-mente considerato soloniano83) corrisponde a39,395 litri ed equivale al quantitativo di 12 choes,cioé di 72 xestai o di 144 kotylai, vale a dire pari alcontenuto di un’anfora SOS di misura media.84
Dunque, a puro titolo di confronto, risulta che ildinos chiusino poteva accogliere all’incirca dueterzi del vino che trovava posto nel Vaso Françoised oltre sei volte quello del dinos ex Erskine, la cuicapacità è di circa 10 litri. Il dinos londinese diSophilos, dunque, sembra non avere una precisacorrispondenza con un’unità di misura, il che tro-verebbe piena giustificazione nella sua datazionead un’epoca antecedente la riforma metrica, che siaessa da considerarsi soloniana oppure pisistra-tea;84 entrambi i vasi da Chiusi, invece, sembranoproprio il risultato della regolamentazione delleunità di misura conseguente a tale riforma, basatasu un criterio che si avvicinava alla suddivisioneper 3 e multipli di 3.
Ora, se consideriamo che la capacità mediadelle kylikes coeve al dinos chiusino (ad esempio,le coppe di Siana del Pittore di Heidelberg86) siaggira intorno a litri 1,75-1,85, ovvero all’incircamezza chous, si può immaginare che dal nostrodinos (che conteneva 20 choes, cioé 1 metretes e dueterzi) potessero essere servite fra 36 e 38 kylikes divino; questo potrebbe significare che, a livellopuramente ipotetico, in un symposion costituito -ad esempio - da 12 persone (due klinai sui tre latidell’andron, ciascuna con due symposiastai), dopole iniziali offerte all’agathos daimon, a Zeus nellesue epiclesi di Pater e di Soter ed agli eroi,87 ognisimposiasta avrebbe potuto bere circa tre kylikesdi vino, per il ragguardevole quantitativo di quasi5 litri a testa! E sempre che il dinos non fosse riem-pito di nuovo: Ateneo, infatti (Deipn. 2.36c), ciinforma che il poeta comico Eubulos di Atene,uno dei principali esponenti del genere letterariodella Commedia di Mezzo, aveva composto, nelIV sec. a.C., un’opera dal titolo Semele, nella qualeera lo stesso Dionysos ad affermare:
‘Tre soli crateri io lascio che mescano i saggi: uno è per la salute, quello che si beve per primo;il secondo è per l’amore e per il piacere;il terzo è per il sonno e, dopo averlo bevuto,gli invitati saggi se ne vanno a casa.Già il quarto, infatti, non appartiene più a noi,bensì all’insolenza;il quinto è del baccano; il sesto delle orge; il set-timo degli occhi lividi; l’ottavo dell’ufficiale giudiziario; il nono dell’ira;il decimo è della follia che fa rivoltare i mobili.’
Lo stesso vale per il Vaso François, che avrebbepotuto servire ben 18 symposiastai, con oltre duekylikes a testa (litri 3,60-3,70), già se riempito sol-tanto una sola volta! D’altronde, il cratere semprepieno e le coppe più volte riempite richiamanoinevitabilmente un noto frammento di Alceo (113Reinach 1980 = CA 2551), che canta:
Porta grandi coppe, amore mio, coppe benornate... riempitele fino all’orlo, una parte di vino perdue di acqua,e che una coppa scacci l’altra
cui fa eco, qualche decennio più tardi, la primaelegia di Senofane di Colofone:
Sta lì il cratere, pieno di gioia;è pronto nei vasi altro vino, che giammai man-cherà,dolce come il miele, profumato di fiori.
Il fatto, poi, che sia il volume del krater di Ergo-timos che quello del dinos chiusino corrispondanoad unità di misura standard del loro tempo (l’unoa due metretai, l’altro a 20 choes, cioè 20 volte unasottomisura del metretes), sembra confermare chetali vasi siano stati modellati con una dimensioneappositamente calcolata per accogliere una pre-cisa quantità di liquido, quindi come contenitorireali; questo potrebbe contraddire l’idea che ilCratere François ed altri vasi analoghi fosserostati concepiti per una funzione più celebrativache pratica.88
Il dinos di Chiusi fu modellato da un ceramistadell’ergasterion in cui dipingeva il Pittore di LondraB 76, attivo nel kerameikos ateniese dell’avanzatosecondo quarto del VI sec. a.C. L’anonimo vasaiodimostra una generale dipendenza dai prodottidella bottega di Sophilos, ma se ne distacca pro-prio per la struttura dei suoi dinoi, che hanno unavasca dal profilo più compresso e con la spallapiù pronunciata, il che determina da un lato ilsensibile restringimento dell’imboccatura rispettoal diametro massimo del vaso e dall’altro la con-seguente necessità di un registro supplementaredipinto sulla spalla (affiancato alla corona di lin-guette), per evitare che le figure del fregio princi-pale subissero una curvatura eccessiva: in questavariante di dinos, il nostro ceramista ed il pittoreche con lui lavorava dimostrano chiaramente diseguire le innovazioni apportate da chi aveva tor-nito e dipinto il dinos 606 dell’Acropoli e creato,così, un tipo di deipnon hoplon che avrebbe avutosuccesso fin oltre la metà del secolo.89
Il ‘nuovo’ dinos chiusino costituisce ora il piùgrande fra quelli dipinti dal Pittore di Londra B76,90 le cui opere rivelano ancora qualche influ-enza dei prodotti di Sophilos e della sua bottega,91
73
come dimostrano sia la forma dell’hypokraterion,92
sia alcune caratteristiche compositive, come la ge-nerale sintassi ornamentale ed alcune peculiaritànelle figure degli animali, soprattutto nella resadelle criniere leonine e nelle teste dei cinghiali.93
Artigiano di buon livello ma non di eccelsa leva-tura, fu certamente influenzato dal Pittore C per lavivace policromia e da quello di Camtar per formevascolari e repertorio figurativo, ma è abbastanzaevidente che il Pittore risentì moltissimo anchedello stile di Kleitias;94 da quest’ultimo derivò - nelnostro dinos - non solo il tema del registro princi-pale e la struttura complessiva del fregio figurato,ma anche alcuni precisi dettagli iconografici (bastipensare alla figura di Hermes, al tipo delle Sfingi,o allo stile generale delle figure, che dimostranoun particolare senso di monumentalità), tanto dafar ritenere che egli abbia lavorato avendo benpresente lo stesso Vaso François. Di conseguenza,proporrei un inquadramento cronologico del dinosnegli anni intorno al 565-560 a.C., in pratica in unmomento coevo o appena successivo al cratere diKleitias, immaginando che a quell’epoca il nostroPittore fosse già in età adulta, il che potrebbe gius-tificare qualche influenza residua da opere piùantiche.
Il Pittore di Londra B 76 dipinse in prevalenzavasi di grandi dimensioni (quattro dei quali dinoi)che, malgrado fossero contraddistinti da scenefigurate meno vitali e vivaci e da un disegno menosicuro rispetto a quelli dei colleghi suoi contem-poranei, furono smerciati, oltre che nella stessaAtene (Agora ed Acropoli), anche ad Eleusi, Tebe,Camiro, Smirne, Cirene e Naucrati ed incon-trarono il favore dei mercati occidentali trovandoacquirenti a Taranto, Marsiglia e - in Etruria - aCeverteri, Vulci e forse anche Vetulonia,95 localitàalle quali si aggiunge ora Chiusi.
Dei suoi stilemi96 si riconoscono chiaramente laparticolare attenzione per le composizioni chiaree leggibili, costruite senza eccessive sovrapposizi-oni di piani, con figure grandi e dalla complessionerobusta, ma con piedi lunghi e sottili, con limitatenotazioni anatomiche incise ma con un’accentuatapolicromia, dai volti carnosi con i capelli segnatida larghi archetti incisi sulla fronte; caratteristichele figure dei cavalli, con le teste massicce che siflettono fortemente verso il basso,97 su un collolargo e robusto, mentre le criniere ricadono lateral-mente, con il margine ondulato oppure a ciocche;i destrieri hanno corpi solidi, dai quarti possenti,abbelliti da elaborate plastinges98 ma con pochissi-me incisioni interne; gli occhi sono larghi e roton-di, con brevi dotti lacrimali e privi dell’indicazionedella pupilla, un tipo di occhio che il Pittore adottò
anche per le figure umane maschili.99 Nel nostrodinos, i tipi di abbigliamento delle varie figure cor-rispondono a quelli comunemente impiegati dalPittore nelle sue opere note, dal prezioso chiton diDionysos ornato da micrografie,100 fino agli aste-riskoi ricamati sull’himation della figura femminileche lo precede ed alle varie orlature che bordanole vesti.101
Nei fregi accessori, costituiti da animali reali(leoni, pantere, capri, cinghiali e volatili) e fanta-stici (Sirene e Sfingi), variamente combinati inschemi araldici ed in raggruppamenti di due o treed associati anche a zoomachie, il disegno si fa piùtrascurato e le incisioni diventano più larghe emeno accurate, come in altre simili raffigurazionidel Pittore di Londra B 76. Anche nel dinos diChiusi, come ad esempio in quello di Boston,102 sinota la tendenza del Pittore a sottolineare i puntifocali del fregio principale con gruppi più com-plessi e significativi collocati nei registri zoomorfiparalleli: è il caso di Peleus, il protagonista dellastoria (maggiormente in questo corteo, dove Thetissembra non essere raffigurata neanche attraversola porta aperta), al quale corrispondono, in basso,la più ampia e simmetrica composizione del sot-tostante fregio animalistico, ovvero una coppia dileoni che si affrontano fra grandi Sfingi sedute, edin alto, ovvero nel fregio sull’orlo, i due galli di-sposti ai lati di un anthemion.103
Versato nel trattare temi mitologici (Perseo e leGorgoni, Agguato a Troilo, Giudizio di Paride,Caccia Calidonia, Riscatto del corpo di Ettore,Consegna delle armi ad Achille, Eracle in lotta conTritone o con Cicno, Teseo e il Minotauro, Cen-tauromachia, Partenza di Anfiarao),104 il Pittore diLondra B 76 tuttavia non copiò pedissequamenteschemi già adottati dai suoi predecessori o da piùdotati ceramografi a lui coevi; lievi variazioni opiù sostanziali modifiche nella combinazione deigruppi, nella successione dei personaggi e nellaposizione di combattenti e caduti rivelano infattiuna chiara riflessione sulla disposizione delle fi-gure e quindi sullo sviluppo della storia narrata,che lo portò a precise scelte individuali.105 Allostesso modo, nel corteo per le Nozze Tessale suldinos chiusino, che ora arricchisce il suo repertorioiconografico di un importante tema mitologico eche costituisce al contempo il fregio più complessoche di lui si conosca, il Pittore si inserì, da unaparte, nel solco di una tradizione che risalivaalmeno a Sophilos e che a lui era certamente nota(visto che almeno una - se non più - era stata dedi-cata sull’Acropoli) e, dall’altra, si ispirò più decisa-mente a Kleitias, che di quella tradizione era ildiretto erede, dotato di maggior talento creativo,
74
fantasia compositiva ed accuratezza grafica; tutta-via, egli modificò in maniera personale e sicura-mente meditata la disposizione delle divinità. Eglimantenne lo schema già noto del corteo (v. tabella),suddividendolo in un gruppo iniziale di Dei cheavanzano a piedi, ai quali fa seguito la teoria dellequadrighe olimpiche, cui si affiancano gruppi diCharites, Nymphai, Mousai e Horai, con Hephaistossul mulo che avanza in coda alla pompe accom-pagnato da Okeanos, quasi che il Dio del maresegni anche il confine cosmico entro il quale lasolenne cerimonia si svolge (secondo una conce-zione di origine orientale, poi ripresa da Anassi-mandro nella configurazione del suo apeiron). Mail nostro Pittore pose Hermes come figura di aper-tura della processione, adottò una differente asso-ciazione delle coppie di Dei sul carro (come nelcaso delle due divinità maschili in seconda posi-zione) e non concluse il corteo con Hephaistos incompagnia di una divinità anguiforme, bensì conun personaggio a piedi, forse addirittura Poseidon- se non si tratta di una versione di Okeanos total-mente umanizzato, almeno nella parte inferioredel corpo, i cui tratti animaleschi avrebbero potutoessere limitati al corno taurino sulla fronte.106
Più volte è stato affermato che Kleitias dovevaconoscere lo schema iconografico adottato daSophilos nelle sue raffigurazioni delle NozzeTessale (che esso derivasse o no dai Kypria o da unipotetico epithalamion, esiodeo o stesicoreo che fosse,oppure da una supposta megalografia, forse corin-zia107) e che lo aveva ampliato, variato e modifica-
to, soprattutto assegnando a Dionysos una posizi-one preminente, collocandolo nel punto centraledel fregio principale, esattamente all’incrocio degliassi maggiori del lato anteriore del vaso, e sottoline-andone graficamente il ruolo conferendogli voltofrontale e dimensioni che oltrepassano i limiti delregistro figurato.108
Anche il Pittore di Londra B 76 apportò signi-ficative variazioni al tema. Lo schema generaleresta immutato, con un lungo fregio che si svolgesulla superficie ininterrotta del vaso, senza l’in-conveniente degli attacchi delle anse;109 la dire-zione del movimento è unica, verso destra, il cuipunto d’arrivo è rappresentato dalla figura diPeleus che accoglie gli ospiti divini, mentre il suopalazzo costituisce l’elemento fisso che chiariscel’inizio e la fine del corteo, dando senso alla nar-razione come destinazione finale della proces-sione.110 La struttura del palazzo è vicina a quelladi Kleitias, che elaborò ulteriormente il modello diSophilos, ma all’articolazione in triglifi e metopeed alle falde del tetto visibili, il nostro Pittore haanche aggiunto il complesso hydrorrhoon ad anthe-mion. Tuttavia, la composizione, che si svolge suuna circonferenza di circa cm 170, con 30 perso-naggi (al massimo 31) e 4 quadrighe, è semplifi-cata rispetto a quelle sia di Sophilos, che si svi-luppa su una superficie di circa cm 131 ma con 44figure e 5 quadrighe, che di Kleitias, che si dis-tende per cm 181, con ben 47 personaggi (48 seincludiamo Thetis nel palazzo) e ben 7 quadrighe.Il Pittore di Londra B 76 ha scelto dunque di arti-
75
Schema della successione delle figure nei fregi delle nozze di Peleus e Thetis(in numeri romani le quadrighe)
Sophilos (Londra) Sophilos (Atene) Kleitias Pittore di Londra B 76
Peleus, di fronte alla sua reggia Reggia di Peleus Peleus (Thetis nella reggia) Peleus, di fronte alla sua reggiaaltare (altare?)
Iris Iris Iris e Chiron HermesHestia e Demeter Hestia e Demeter Hestia, Demeter e Chariklo Maia (?)Leto e Chariqlo Leto e ChariqloDionysos, con un ramo di vite Dionysos, con un’anfora Dionysos, col kantharos
3 HoraiHebeChiron ChironThemis3 Nyphai 3 figg. femm. (Nymphai o Horai ?)I. Zeus e Hera; 3 figg. femm. I. Zeus e Hera I. Hera e Zeus; Kaliope, Orania I. Zeus e Hera (?); 3 figg. femm.II. Poseidon e Anphitrite; II. Poseidon e Anphitrite; II. Poseidon ed Anphitrite; Thaleia, II. 2 divinità masch.; 3 figg. femm.
3 Charites 5 Nysai Euterpe, Kleio, MelpomeneIII. Ares e Aphrodite; 5 Mosai III. Figure su quadriga III. Ares e Aphrodite; Stesichore, III. Ares e Aphrodite (?); 3 figg. femm.
Erato, Polymnis (Mousai ?)IV. Apolon e Hermes; 3 Mosai IV. Quadriga IV Figure su quadriga; 3 figg. femm. IV. Quadriga; 3 figg. femm.V. Athenaia e Artemis; 3 Moirai V. Athenaia e fig. femm.; Doris, Nereus
VI. Hermes e Maia; 4 MoiraiVII. Figure su quadriga; 3 (?) donne
Okeanos Okeanos OcheanosTethys e HilethyaHephaistos sul mulo Hephaistos sul mulo Hephaistos sul mulo Hephaistos sul mulo
Fig. maschile con bastone (Poseidon?)
colare il corteo su una minor quantità di figure,di raggruppamenti e di piani sovrapposti, il checonferisce all’insieme della scena un ritmo chiara-mente più lento. Inoltre, avendo ridotto il numerodei tethrippa armata e soprattutto quello delle di-vinità che avanzano in corteo (l’andatura chamai-pous ricordata da Polluce, 3.40, per le reali ceri-monie nuziali111), risulta un evidente spostamentoin avanti della figura di Dionysos. Nei cortei diSophilos e di Kleitias il Dio del vino è raffiguratoin sesta posizione: l’uno lo mette in risalto da unaparte con l’ausilio del sottostante fregio accessorioe dall’altra ponendolo in diretta relazione inter-locutoria con l’amico Peleus (entrambi hanno lelabbra dischiuse);112 l’altro con la posizione cen-trale sul lato principale, con il suo aspetto pecu-liare e con il significativo attributo dell’anfora.Nel dinos di Chiusi, invece, il Pittore sposta Dio-nysos dopo Hermes (che - potremmo dire - sem-plicemente introduce il corteo, al pari di Iris neglialtri due fregi) e dopo la figura femminile (Maia,oppure una delle Dee che simboleggiano la fami-glia, la fecondità, la maternità e il focolare dome-stico, come negli altri due cortei?). Dionysos, quindi- che qui, come per Sophilos, precede ancheChiron - si trova in terza posizione; nei due fregidi Sophilos è anche il primo fra le divinitàmaschili, mentre qui è posto dopo Hermes (cheperò svolge le sue mansioni specifiche di pro-egetes) e sul Vaso François dopo Chiron (che perònon è un Dio). Il Dio del vino, dunque, con il suoabbigliamento particolarmente ricco, con i rigo-gliosi tralci di vite che lo circondano e con un kan-tharos che doveva essere di grandi dimensioni,sembra spiccare nel gruppo dei personaggi a piedianche per l’ampiezza dello spazio che occupa,quasi il doppio delle figure che lo precedono.Anche in questo, dunque, il Pittore potrebbeessersi allineato alle scelte di Kleitias, nella cuiepoca Dionysos era divenuto una divinità piùchiaramente definita e più importante che inquella di Sophilos, visto che proprio in queglianni ne veniva quasi istituzionalmente sancita ladefinitiva trasformazione in divinità cittadina edessa entrava a far parte a tutti gli effetti del pan-theon ateniese.113
La più evidente variazione dello schema intro-dotta dal Pittore di Londra B 76 è però la figurache segue a piedi Hephaistos, che tuttavia rimaneoscura per le sue lacune.
Il dinos di Chiusi, dunque, offre un’altra dellerare raffigurazioni del corteo divino per il matri-monio di Peleus e Thetis, prodromo al CicloTroiano non soltanto perché gli sposi avrebberogenerato Achille, ma anche perché nel corso della
cerimonia nuziale Eris avrebbe istigato la disputaperi kallous fra le tre Dee olimpiche, che avrebbeportato al giudizio di Paride ed al rapimento diElena, con il conseguente scoppio della guerra. Giànarrato nei Kypria, ma a noi pervenuto nell’epito-me di Proclo (Chrest. 1),114 il racconto della parte-cipazione degli Dei olimpici alle Nozze Tessalecon una solenne pompe fu verosimilmente elabo-rato sul piano iconografico da artigiani corinzi:nel quinto fregio dell’Arca di Kypselos gli sposierano raffigurati distesi su una kline nell’antro diChiron, sul Monte Pelion, al quale il corteo divinosi avvicinava per omaggiare la coppia e per offriredoni nuziali (Paus. Perieg. 5.19.7-9).115
Nella ceramica attica il tema fu raffigurato al-meno due volte da Sophilos,116 intorno al 580 a.C.,sui dinoi di Londra (ex Erskine) e dell’Acropoli587 (15165), in entrambi i casi con uno schemacompositivo differente ed applicato ad una formala cui superficie ininterrotta ben si adattava allosviluppo di un solenne corteo in movimento.
Negli anni successivi, il medesimo schema furipreso da Kleitias, che, pur dipendendo dai mo-delli sofilei, lo magnificò (almeno una volta) conuna composizione più ricca ed elaborata, costi-tuita da un maggior numero di partecipanti equindi carica di maggiori riferimenti simbolici, eche fu anche inserita in un vero e proprio pro-gramma figurativo, complesso e articolato117; alfregio del Vaso François si ispirò poi il Pittore diLondra B 76 nel suo dinos da Chiusi, per il qualeriprese però la forma vascolare adottata daSophilos.
Verso la metà del VI sec. a.C., il tema fu forsedipinto anche dall’anonimo pittore di uno skyphosdedicato sull’Acropoli, in una variante apparen-temente senza le quadrighe e nella quale il corteosfila a piedi verso sinistra, tranne Aphrodite, conin braccio Eros (e forse Himeros?) che sembramuoversi nella direzione opposta.118
Ancora qualche decennio più tardi, intorno al525 a.C., anche il Pittore dell’Altalena scelse forseil corteo epitalamico di Peleus e Thetis, se così sipuò interpretare il fregio esterno sul collo di uncratere a volute rinvenuto a Cuma;119 tuttavia, inmancanza di iscrizioni chiarificatrici non sembrasufficiente la sola presenza di figure divine aqualificare il corteo come quello per le NozzeTessale, poiché la combinazione di figure umanee divine ricorre più volte nelle scene di proces-sioni matrimoniali sui vasi a figure nere,120 proba-bilmente sia come conferma della sacralità dellacerimonia, sancita dalla presenza delle divinità,sia come simbolica trasposizione nel mondo eroi-co e divino del momento celebrativo della nuova
76
unione, sia come favorevole presagio per gli sposi,che iniziano la loro vita comune sotto gli auspicidei theoi propompoi.
Uno schema iconografico diverso,121 con Peleuse Thetis sulla quadriga circondati da varie divi-nità a piedi, è documentato ad Atene almeno dal530 circa a.C., in una nota hydria di Firenze di-pinta nella maniera del Pittore di Lysippides.122
La scena è tuttavia attestata già verso il 550-540a.C., su un lebes gamiskos eretriese123 così dipen-dente da modelli stilistici attici da far supporreche anche lo schema iconografico fosse statoderivato da formule elaborate in un ergasterion delkerameikos ateniese.124
La raffigurazione del celebre matrimonio (siache esso fosse rappresentato in maniera assoluta,atemporale, sia che vi si debba identificare ilmomento degli epaulia delle reali cerimonienuziali125) è comunque carica di valenze sociali diparticolare pregnanza: in essa si può facilmenteleggere un paradeigma della desiderata felicitàconiugale, non soltanto come raffigurazione ben-augurante della vita futura, ma anche - sul pianosociale - come l’adesione ai modelli comporta-mentali propri della classe aristocratica. Le solennie variopinte raffigurazioni su krateres, dinoi,loutrophoroi e lebetes gamikoi, grandi vasi per lecelebrazioni epitalamiche e per i festeggiamentiche le concludevano, costituiscono dunque unaugurio ed allo stesso tempo un orientamentovisivo verso comuni ideali di autoconsapevo-lezza, di completamento familiare e, di con-seguenza, di piena integrazione sociale.
Il matrimonio, infatti, ed in particolare il piùcelebre esempio mitico di Peleo che, secondoPindaro, sposando Thetis aveva raggiunto ‘la piùgrande fortuna che possa toccare ad un uomo’(Pyth. 3.88-89), si configura come il più impor-tante evento sociale della vita,126 così come quellodei futuri genitori di Achille lo era stato nell’in-tera mitologia greca, visto che non soltanto avevagarantito la taxis dell’ordine cosmico costituito,ma - come ricorda Esiodo (Theog. 991) - era statoanche pienamente legittimato e sancito dal voleredi Zeus.127
Nei fregi più completi dipinti da Sophilos e daKleitias, nei quali le figure sono anche delibe-ratamente identificate dalle iscrizioni chiarifica-trici, tutto sembra sottolineare i valori familiari,parentelari ed affettivi, che portano alla stabilitàdella famiglia e quindi della società,128 ed esaltareal contempo l’arete eroica degli aristoi, nel cuimondo innanzitutto quei valori si concretizzanoe che anzi completano, proprio con il raggiungi-mento, prima, del gamos auspicato e fino alla
conclusione della vita, poi, con il kalos thanatos.129
Ne risulta, dunque, esaltato a livello mitico-eroico ed al contempo inquadrato nella prospet-tiva reale e concreta della vita matrimoniale ilconcetto dell’oikos come nucleo familiare, posto afondamento della riforma socio-politica con laquale Solone mirava a rinsaldare la comuneresponsabilità politica all’interno della polis, cheera concepita proprio come l’insieme equilibratodi oikoi e gene:130 uno stabile equilibrio, grazie alcui raggiungimento la polis vedeva persino rin-forzata la propria posizione anche nel campodelle relazioni esterne (proprio con Solone, dopola prima Guerra Sacra, Atene entra a far partedell’Anfizionia Delfica131).
In quest’ottica del mito come paradeigma132 po-trebbero forse essere interpretati anche i registrianimalistici ed i fregi ‘misti’, come quelli che cir-condano la parte inferiore del dinos di Chiusi e nedecorano la faccia superiore dell’orlo. Da unaparte essi rimangono certamente un retaggio delleformule ornamentali di tradizione orientalizzan-te;133 ma dall’altra, gli spaventosi mostri da favolae le feroci fiere sanguinarie, non di rado raffigu-rati insieme perché concettualmente accomunatidal medesimo aspetto di pericolo dell’ignoto edell’indefinito, del selvaggio e della sfida sovru-mana cui soltanto eroi civilizzati e razionali pos-sono far fronte (includendo nella razionalizza-zione anche l’aiuto divino, che interviene solo afavore dell’aristos), si trasformano in simboli ditutto ciò che è estraneo e contrario alla polis, di ciòche è antitetico alla vita regolamentata dalle leggicivili, dell’inquietante sfera dell’eschatià, che costi-tuisce così una sorta di anti-polis134 e che vieneintenzionalmente messa a contrasto con il mito,che incarna invece la vita sociale ed i suoi ideali.Ecco, dunque, che ancor di più spiccano il valoreparadigmatico del registro mitologico con le nozzedi Peleus e Thetis ed il suo ruolo simbolico di aus-picata felicità, se contrapposto alla selva di ani-mali e mostri, che comunque esso sovrasta e suiquali sembra imporre i propri valori.
Persino nel fregio sull’orlo ci si potrebbe forsespingere fino a vedere un’antitesi fra i due per-sonaggi maschili, con una lancia in mano maammantati ed ai lati di un fiore, quindi in un con-testo non di scontro armato ma di pacato con-fronto (quasi rappresentanti di un struttura politicaregolamentata da leggi - quelle nuove soloniane?)e la coppia di galli che si affrontano impettiti nelpunto diametralmente opposto, e le violente zoo-machie, mostri ed animali selvatici che li circon-dano.
77
CONCLUSIONI
Il nuovo dinos, con la raffigurazione del corteo perle Nozze Tessale dipinta dal Pittore di Londra B76, è stato rinvenuto a Chiusi, nella necropoli diFonte Rotella, vale a dire nella medesima area chenell’ottobre del 1844 aveva restituito il cratere diErgotimos e Kleitias.135 Si ha dunque lo stessogenere di oggetto (un mega poterion136), lo stessotema figurato, la stessa fascia cronologica e lostesso luogo di rinvenimento; il che non puòessere casuale.
Come già più volte segnalato,137 a Chiusi il volu-me e la varietà delle importazioni di ceramicaattica rappresentano un fenomeno quasi straordi-nario per una città dell’Etruria interna (analoga-mente a quanto avviene anche nella vicina Orvieto,ma in una fase cronologica lievemente differente)e lasciano intuire una precisa selezione delle formevascolari operata dagli acquirenti. Percorrendouna via commerciale già ampiamente battuta esfruttata dalle precedenti importazioni corinzie egreco-orientali, la ceramica ateniese fa la sua com-parsa a Chiusi proprio con un gruppo di bencinque dinoi, di cui alcuni forse databili già nelprimo quarto del VI sec. a.C.,138 rinvenuti inun’area sacra, in una necropoli ed in un settoreproduttivo dell’abitato. Se si considera che nellostesso trentennio arrivano nella città etruscaanche il Vaso François, il krater-louterion di Berlinocon la liberazione di Prometeo e di lì a poco, dallaMagna Graecia, ancora un dinos ‘calcidese’ conAchille e Memnon139 (forse anche questo prove-niente dalla medesima area funeraria di FonteRotella140), risulta chiaro il panorama di grandi eprestigiosi contenitori da mensa che raggiungonol’ambiente dei principes etruschi di Clevsie-, vasidestinati a comporre il servizio simposiaco, forseanche in speciali occasioni sociali come la cele-brazione di matrimoni aristocratici, prima diessere deposti come pregiati kterismata nei corredifunerari, e comunque oggetti di lusso la cui prove-nienza estera assumeva molteplici valenze socio-culturali, poiché certamente contribuiva all’osten-tazione della ricchezza familiare e di conseguenzaa riconfermare il rango sociale del defunto e l’au-torità politica della gens alla quale egli apparte-neva.
Se la funzione di un grande vaso simposiaco, unmega poterion,141 nel mondo italico può risultareforse più comprensibile, sempre viva rimane invecela vexata quaestio dei temi figurati e del valore cheessi assumevano nell’ambito delle ideologie ari-stocratiche locali, problema che si allarga fino acoinvolgere anche quello di un’eventuale com-
mittenza consapevolmente esercitata sul kera-meikos ateniese, direttamente dagli acquirentiultimi dei vasi o dagli intermediari delle cittàcostiere, come Cerveteri e Vulci, che verosimil-mente detenevano le fila dei commerci marittimi.Ancora di recente è stato proposto, ad esempio,di interpretare il complesso programma icono-grafico del Cratere François alla luce del contestoetrusco al quale il vaso sarebbe stato intenzional-mente destinato e per il quale sarebbe stato appo-sitamente creato, con una consapevole selezionedei temi figurati in fase di realizzazione.142
Tuttavia, in mancanza di evidenze più certe, credosia opportuno, almeno per ampia parte del VIsecolo a.C., limitarsi a tentare di cogliere qualivalenze potessero assumere fregi figurati comequelli di Kleitias e del Pittore di Londra B 76, unavolta che i vasi su cui erano raffigurati venivanoacquisiti dai membri delle aristocrazie chiusine,piuttosto che tentare di dimostrare che di talivalenze i pittori ateniesi fossero consapevoli finoa realizzare opere che rispondessero a precise esi-genze dell’ottica interpretativa etrusca.
Il Vaso François e il dinos da Chiusi rimangono,infatti, indissolubilmente legati e connaturati almondo aristocratico dell’Atene post-soloniana,alla vigilia della conquista del potere da parte diPisistrato; un mondo colto e raffinato, nella cuipaideia dominavano opere letterarie di genereepico, lirico ed elegiaco,143 che determinarono ilformarsi di un nutrito corpus di fonti di riferi-mento, in base al quale - in molti casi e certa-mente per oggetti ‘speciali’ come i grandi vasi concicli figurati - proprio l’erudita committenza delleclassi aristocratiche della polis dettava o suggerivaprecise scelte mitografiche ai ceramografi chelavoravano nel kerameikos, spesso selezionandoprecisi temi che non soltanto esaltavano storie,credenze e valori del mondo epico e mitologico,ma nei quali si potevano anche leggere direttiriferimenti a particolari situazioni politiche esociali del momento.144
NOTE
* Per l’autorizzazione allo studio ed alla pubblicazione,al restauro ed alla ricomposizione del dinos nel MuseoArcheologico Nazionale di Chiusi, sono grato ai Soprin-tendenti per i Beni Archeologici della Toscana che sisono di recente avvicendati: Angelo Bottini, GiuseppinaCarlotta Cianferoni e Fulvia Lo Schiavo; un doverosoringraziamento agli amici e colleghi con i quali ho dis-cusso i problemi posti dal dinos o che hanno agevolatoin vario modo il mio lavoro: Laurent Bavay, MartineDenoyelle, Francesco De Angelis, Anna Maria Esposito,Lynn D. Ennis, Federico Fattorini, Laurent Engels, TonioHölscher, Maria Ida Gulletta, Cornelia Isler-Kerényi,
78
Andy J. Clark, Hans Koens, Nassi Malagardis, HeideMommsen, Mary B. Moore, Jenifer Neils, Sophie Padel-Imbault, Aaron J. Paul, Maria Pipili, Maurizio Pistolesi,Paola Rendini, Athena Tsingarida, Nadine Warzee. Ilrestauro, condotto presso il Laboratorio del MuseoArcheologico Nazionale di Chiusi, è di Alida CazzatoMorbidelli (con la collaborazione di Enzo Toccaceli),mentre la ricostruzione finale è opera di GiuseppeVenturini; le riproduzioni fotografiche sono di RobertoMagazzini, Luigi Miccinesi e Mauro del Sarto (ArchivioFotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologicidella Toscana). Infine, un ringraziamento particolaredevo a Luca Cappuccini (Università degli Studi di Fi-renze) per l’insostituibile aiuto nella realizzazione dellerestituzioni grafiche dei profili, delle sezioni e di quantosi conserva dei fregi figurati.
1 Brunn 1859a, 27-32. Per la storia della collezione Lun-ghini v. anche Westropp 1856, 230-231; Paolucci 1989,78-83.
2 Brunn 1859a, 31.3 Brunn 1859b, 103; Gamurrini 1877; Milani 1898, 67-69;
Milani 1912, 54-55; De Agostino 1939, 501.4 Holmos era il termine allora in uso, poiché appena un
trentennio prima E. Gerhard e S. Campanari lo avevanoadottato per definire quello che oggi consideriamo undinos: Gerhard 1831, 247-248; 1836, 155; Campanari1837, 176-178, 245, nn. 100, 145; Brownlee 1981, 15-17;Radici Colace/Massara 2001, 137-146.
5 Milani 1898, 68; Paolucci 1989, 80; 2000, 144.6 Sui ‘restauri’ a Chiusi: Paolucci 1985, 84-86; 1989, 80;
1995, 146-147, nota 17; 2005, 29 (a nota 132 le ‘formule-ricette’ elaborate da Angiolo Galanti e Vincenzo Monninel XIX secolo, per il restauro dei reperti fittili ebronzei).
7 Paribeni 1993, 266.8 Rinvenuto il 2 aprile 2003 dal Sig. Giuliano Landucci,
e prontamente consegnato al Museo Archeologico diChiusi: Iozzo 2006, 111, note 19-21.
9 Delle due varianti del nome, dinos e deinos, la prima èquella maggiormente frequente nelle fonti letterarie,scolastiche ed epigrafiche, ed è la sola che sia adottatanelle iscrizioni attiche; la seconda, invece, sembra essereuna variazione della prima e non è attestata prima diAteneo: Brownlee 1981, 2-75 e nota 2; Radici Colace/Massara 2001, 137-146.
10 Chiusi, Museo Archeologico Nazionale: 67371+frr. exVagnonville (sine inv.). Vasca: altezza ricostruita cm40,5; diametro massimo ricostruito cm 54 ca; circonfe-renza massima cm 170 ca; diametro ricostruito dell’orlocm 40,3 all’esterno e cm 31, 8 all’interno; larghezzadell’orlo cm 4,2; spessore della parete da cm 0,5 a 1,2;altezza del fregio figurato principale cm 12; altezza deifregi zoomorfi cm 8; diametro della girandola cm 20 caSostegno: altezza conservata cm 15,2; diametro mas-simo, all’esterno dell’imboccatura, cm 32,7; diametrodell’anello all’attacco del fusto cm 14; diametro delfusto cm 11; altezza della fascia decorata cm 4,5. Unanotizia preliminare e qualche immagine dei primi fram-menti ricomposti in Iozzo 2006, 111, 125, 232-233, tavv.II-III; un estratto di questo testo (prevalentemente levicende collezionistiche e la parte descrittiva) è com-parso in Iozzo 2007, 10, 62-65, n. 56.
11 Argilla arancio chiaro, con inclusi bianchi di grandidimensioni, in qualche caso evidenti anche in superficie,che hanno causato ampie scheggiature; leggera ingub-biatura di colore ocra. Il dinos è internamente vernici-ato fino alla curva della spalla, mentre la superficie
inferiore della spalla stessa e dell’orlo è acroma; al disotto della vernice è visibile un grumo che non è statolisciato per l’imperfetto procedimento di politura conla rasiera. La vernice dei fregi ornamentali è in generenon molto densa, a tratti diluita e tendente ai toni delbruno; all’interno è decisamente più densa e compatta,nera e brillante, e conserva un ampio tracciato di stria-ture del pennello. Ampie zone arrossate, soprattuttoall’interno della vasca, rivelano un procedimento di cot-tura eccessivamente prolungato, che in alcune aree hareso la vernice di un colore rosso acceso; un’area per-fettamente circolare, del diametro di cm 4,2, dimostracome, durante la cottura, fosse stato inserito nel dinosqualche altro oggetto che, a contatto con la pareteinterna, non ha consentito il totale annerimento dellavernice.
12 Entrambi i margini dell’orlo sono sovraddipinti in pao-nazzo: su quello interno, il colore è distribuito soprauna leggera verniciatura nera di base; sul margineesterno, a contatto con la spalla, la fascia paonazza èstata sovrapposta alla fila di piccole macchie irregolaricausate dal contatto del pennello intriso di vernice conil punto di raccordo fra spalla e orlo ogni qualvolta ilpittore ha iniziato a dipingere ciascuna delle linguettee tutte le linee dei gusci che le racchiudono.
13 Mi sembra più difficile che si tratti di ciuffi di peli irsuti,ma questo dettaglio non mi è chiaro. È possibile, inoltre,che la criniera sia un generico elemento per indicare iltipo di belva, un leone in generale, e che i capezzoli(forse originariamente dipinti di bianco?) lo caratteriz-zassero come una leonessa.
14 In paonazzo la fascia ventrale ed il ciuffo di pelo delsacco penico, nonché le notazioni muscolari della cosciadel cinghiale, così come le piume copritrici delle scapolealari; in bianco la fascia alla radice delle remiganti delleali.
15 In paonazzo le piume copritrici delle scapole alari, lepenne remiganti alternate delle ali e le capigliature; inbianco la fascia centrale delle ali e l’incarnato fem-minile, con sottilissime incisioni per il profilo degliocchi a mandorla e della rima labiale e con la pupillapaonazza sovraddipinta.
16 In paonazzo i bargigli, le piume copritrici della fasciacentrale delle ali e della radice della coda, le remigantialternate delle ali e della coda, il cuore ed i petali alter-nati della palmetta; in bianco una fascia alla base delleremiganti della coda.
17 Iozzo 1996, 24, nota 13.18 Brownlee 1981, 88, 90; Bakır 1974, 42.19 ABV 8, n. 1, 15-16, 679; Para 6; Addenda 2; Brownlee
1981, 379-386, n. 4; Denoyelle 1994, 58-59, 190, n. 24.20 In paonazzo il cuore delle palmette ed il calice quadran-
golare dei fiori di loto; forse in bianco il sepalo centraledi questi ultimi; la base dei sepali dei calici è decoratacon una linea ondulata incisa o con una fila di piccolizig-zag, che si alternano forse in maniera costante (trecoppie di fiori di loto hanno gli zig-zag e tre le lineeondulate).
21 La necessità di ampliare la fascia sulla spalla sembragià evidente nel dinos di Sophilos ad Atene, EthnikoArchaiologiko Mouseio, AKR 587 (se addirittura nonerano già presenti le linguette al di sopra della catenafloreale): ABV 39, n. 15; 41, n. 26; 681; Addenda 10;Brownlee 1981, 394-398, n. 4; Bakır 1981, 64-65, n. A.2,figg. 5-9, 187-194; Williams 1983, 32; Cohen 2006, 161-163, n. 40.
22 Atene, Ethniko Archaiologiko Mouseio, AKR 606: ABV
79
81, n. 1, 682; Para 30; Addenda 22; Tsachou-Alexandri1991, 202-206, figg. 12-21; Brownlee 1981, 157-177, 436-440, n. 39.
23 Boston, Museum of Fine Arts 34.212: von Bothmer1948, 42-48, figg. 1-3; ABV 87, 18; Addenda 24; CVABoston 2 (USA 19), 8, tavv. 64-65,1; Brownlee 1981, 177-181, 445-447; Woodford 1992, 416, n. 12.
24 Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 3785 (incertaeoriginis): brevemente descritto da Milani 1912, 147;Brownlee 1981, 93-94, n. 73; 1988a, 105, nota 7.
25 ABV 90, 1; Kreuzer 2005, 196-198, figg. 17-18.26 Vollkommer 1994.27 Sulla struttura del palazzo di Peleus e sulla sua identi-
ficazione come reggia di Phthia oppure come il palazzosul Pelion (piuttosto che come il Thetideion o la grottadi Chiron), v. Stewart 1983, 62-63; Williams 1983, 29;Adamopoulos 1986, I, 20-21; Carpenter 1986, 7; Pedley1987, 69-70; Oakley/Sinos 1993, 24; Vollkommer 1994,251-252 (dove sono raccolte tutte le fonti letterarie sulmatrimonio e sulla localizzazione del corteo olimpico);per la citazione di Catullo (64.305 ss.), che, sia purdipendendo da chiari riferimenti di ambiente e cronolo-gia alessandrini, colloca la cerimonia nuziale nelpalazzo di Peleus, v. di recente Morwood 1999. Per leimplicazioni sociali di autorappresentazione aristocrat-ica nelle raffigurazioni degli edifici v. Laxander 2000,59, nota 299.
28 Per gli elementi architettonici sulle raffigurazioni vas-colari e per i colori impiegati nella loro resa, v. le osser-vazioni ed i riferimenti di Moore/Pease Philippides1986, 106, sub n. 47; inoltre Pedley 1987, passim.
29 Halm Tisserant/Siebert 1997a, 728-730; per Hermes e laposizione delle sue mani v. Siebert 1990; Miquel 1992.
30 Cristofani 1981, 191, fig. 225.31 McNiven 1982, 38, 68-69.32 Il motivo ricorre anche nel Gruppo Tirrenico:
Colafranceschi Cecchetti 1972, tav. XXIV, 64.1.33 Come si ritrova anche in opere del Pittore di Heidelberg
e del Gruppo Tirrenico: Colafranceschi Cecchetti 1972,tavv. VIII, 16; IX, 22; X, 26; XXIV, 65.
34 Rafn 1992.35 Per l’identificazione delle figure femminili che affian-
cano Dioniso: Carpenter 1986, 80, note 16-17; Jurgeit1986; Isler-Kerényi 1990b; 1990a; Hedreen 1992, 31-66;Kossatz-Deissmann 1994b; Isler-Kerényi 1997c; 1999;2001, 28, 114-124; Mommsen 2003, passim.
36 Isler-Kerényi 1997a.37 Dal ghost del bianco dissolto si distinguono tre registri
sovrapposti: due Sirene affrontate, un felino rivolto adestra, due che avanzano a sinistra (nel primo registrosi vede solo la parte anteriore del secondo animale, nelterzo si vede solo la parte anteriore della Sirena di sin-istra: due dettagli minuziosi, con i quali il pittore hareso palese che i fregi figurati non erano limitati ad unafascia centrale, ma continuavano sotto l’himation deldio); negli spazi di risulta, rosette a macchia.
38 Il. 14.178-179 (Morris 1992, 19-20); per altre fonti letter-arie v. Manakidou 1997, 306, note 8-9.
39 Colafranceschi Cecchetti 1972, tavv. V, 10-11; XVIII, 44;XX, 48; XXIV, 62; XXVI, 69; Ghedini 1995; Manakidou1997, 297-301, al cui elenco si può aggiungere anche ilPittore di Prometeo: Tuna-Nörling 1996, 43-46, n. 118,tav. 12. Il Pittore di Londra B 76 ha adoperato analoghe‘semifigure’ anche nei preziosi abbigliamenti muliebrisull’hydria 15536 del Nationalmuseet di Copenhagen:ABV 714; Para 32; Addenda 23 (85.2bis); CVA Copen-hague 8 (Danmark 8), 250-251, tavv. 319-21.
40 Si conserva una piccola parte della corona d’edera chegli cinge il capo, con ritocchi paonazzi sulle foglie.
41 Per il kantharos come attributo di Dionysos, cui daglianni intorno al 540 a.C. si affianca il keras, forseintrodotto dal Pittore di Heidelberg, v. Carpenter 1986,117-118. È possibile che la ricostruzione grafica dellamano di Dionysos qui proposta non sia del tutto esatta:la posizione sembra quella che regge il kantharos perl’ansa (piuttosto che per lo stelo), ma poiché la mano èaperta, come dimostrano le linee incise che distinguonole lunghe dita, è probabile che in questo caso il Diotenesse il vaso chiudendo ad anello il pollice e l’indiceed allungando le altre tre dita (analogamente a Gas-parri 1986, nn. 254, 428, 435, 478 e persino, benché condiversa prospettiva, n. 55).
42 Gisler-Huwiler 1986; Padgett 2003, in partic. 18-20; sulsuo ruolo come stipulatore e ‘garante’ delle nozze v.Torelli 2007, 31.
43 Tracce di paonazzo si conservano sui capelli e sullabarba; forse anche sul corpo equino.
44 Kreuzer 2005, 192; contra Böhr 2007 (anche per ragionibotaniche).
45 Guarducci 1928; Schauenburg 1964, 68-70; Buchholz1982; Koch-Harnack 1989, 111-117; Dasen 2005, 158-160;per le attestazioni più antiche, a partire dalla Lekanis diDresda, v. Papadopoulou-Kanellopoulou 1997, 118, subn. 260.
46 Halm Tisserant/Siebert 1997b.47 Machaira 1990, in partic. 508, nn. 44-46; Torelli 2007, 36
(con altri riferim. bibl. a nota 138).48 Si conservano tracce di paonazzo sul corpo del cavallo
di sponda in primo piano, cui probabilmente appar-tiene la coda incisa; al primo cavallo di tirella, con ilcollo paonazzo eretto, appartiene invece la codasovraddipinta in paonazzo che si sovrappone allastanga del carro; al secondo cavallo di tirella oppure alquarto, ovvero quello di sponda più all’interno, con latesta abbassata per la trazione delle redini, appartienela coda nera che spunta dietro il carro.
49 Crouwel 1992; Emiliozzi 1999.50 Per la cura dei dettagli nella raffigurazione del corteo
delle quadrighe divine sul Vaso François, soprattuttorispetto a quelle della gara in onore di Patroclo nel fre-gio sul collo del lato A, v. le giuste osservazioni diManakidou 1994, 125.
51 Si conserva la parte superiore del lembo tirato sulla testa,con il bordo inciso ed il colore paonazzo sovraddipinto.
52 Wachter 1991, 107-108; Queyrel 1992.53 La prima figura a sinistra, in primo piano, indossa un
chiton bianco, con plissettature ondulate incise, al disopra del quale è un himation nero, con pieghe incise;quella centrale veste forse un chiton nero, mentre la terzafigura indossa un peplos paonazzo, con il bordo decoratoda una fila di cerchietti incisi. Lo stato di conservazionein questo punto non consente di distinguere con preci-sione tutti gli elementi dell’abbigliamento.
54 Gottschall 1997; il termine, carico di possibili riferimentialle ninfe di Nysa, è considerato semplicemente unerrore grafico derivato da una confusione tra Nyphai eMosai da Carpenter 1986, 9, seguito da Lyons 1996, subn. 935; di opinione diversa, e forse più nel giusto, sonoinvece Kilmer/Develin 2001, per i quali Sophilos non ècosì inaccurato.
55 Per la variante grafica del nome di Clio: Wachter 1991,108-112.
56 La dea ha il volto sovraddipinto in bianco, con sottiliincisioni per l’occhio a mandorla e per i dettagli dell’orec-
80
chio; il dio ha capelli arricciati sulla fronte e l’occhiomaschile, a cerchietto con trattini laterali. Fra le due fi-gure rimane una mano destra, probabilmente quelladella dea, che regge le briglie e forse anche il kentron;più difficilmente essa appartiene alla figura maschile insecondo piano. Per le scene in cui è la divinità fem-minile alla guida del carro v. Manakidou 1994, 128-135.
57 Il collo del cavallo di sponda conserva tracce di paon-azzo.
58 Williams 1983, 28.59 Volti bianchi, con sottili incisioni per occhi a mandorla,
rime labiali e lobi e padiglioni auricolari; bordo del pep-los della figura a sinistra: linea ondulata fra coppie dilinee incise.
60 Per la coppia di Ares ed Afrodite nei cortei matrimoni-ali v. Beck 1984, 20-21; Manakidou 1994, 124 e nota 62.
61 Per le cavalle bianche impiegate nei tiri a quattro diSophilos v. Moore 1972, 373-374; non sempre la dis-tinzione cromatica è relativa al sesso degli animali (ocomunque, se lo era, non sempre fu rispettata): cfr. adesempio, il cavallo bianco di E(u)rymachos nell’Am-basceria a Troia, sul cratere corinzio ex Astarita inVaticano: Amyx 1988, tavv. 116-7.
62 Da identificare forse, sul Vaso François, con le Chariteso le Nymphai: Kreuzer 2005, 212, nota 213.
63 Riconoscibile anche il profilo del sacco scrotale dell’ani-male, che procede verso destra, reso con un’incisioneche si staglia contro lo sfondo offerto dalla superficieinterna della coscia sinistra avanzata. Per l’iconografiadel mulo nella ceramica attica v. Brownlee 1989, 4, nota6. Per gli animali itifallici, di regola associati a Dionysosed al suo thiasos, v. Padgett 2004, 66 e note-3-4 e 23, conbibl. La posizione della testa, fortemente flessa, si ricavadal tracciato delle linee della tornitura sulla superficieinterna del vaso. La testa è piuttosto quella di un muloche di un asino, comunque una cavalcatura ‘di sec-ond’ordine’, per il cui significato v. Hedreen 1992, 17;Kreuzer 2005, 215.
64 Williams 1983, fig. 34; Cristofani 1981, fig. 74. Per laposizione laterale di Hephaistos, v. Williams 1983, 29-30, nota 34.
65 Cristofani 1981, fig. 92.66 Atene, Ethniko Archaiologiko Mouseio, 664: Amyx
1988, 497 (n. 1), 621-622; Isler-Kerényi 2001, 70, fig. 13.67 Kylix laconica di Rodi, Archaiologiko Mouseio 10711:
Pipili 1987, 54, n. 149, fig. 80; neck-amphora probabilmenteeuboica, ex Borowski: Ancient Greek Vases Formerly in thePrivate Collection of Dr. E. Borowski, Christie’s New York,12.6.2000, 22, n. 26.
68 Per il ritorno di Hephaistos v. Hermary/Jacquemin 1988,in partic. 638-639, nn. 113-128 (dove anche le raffigura-zioni raccolte nel paragrafo successivo, con Hephaistossull’asino itifallico in presenza di Dioniso e di Satiri,sono probabilmente da considerarsi non come scene deldio ‘sans attribut caractéristique’, bensì come momentidel ritorno sull’Olimpo, poiché il riferimento mitologicopresupposto è offerto proprio dallo stesso contesto nar-rativo; in generale, per il motivo del personaggio sulmulo, v. Isler-Kerényi 2004, 47-58); v. inoltre Carpenter1991, 13-17, figg. 10-19 e Isler-Kerényi 2004, 22-24;Shapiro 1995, 1-14; Torelli 2007, 41-42, 59-60.
69 Krauskopf 1994.70 Cahn 1994; per la discussione sulla possibilità che
Okeanos fosse raffigurato con un corpo umano già suivasi attici del 560 circa a.C., analogamente a quantoavvenuto per Nereus (Glynn 1981), v. Brommer 1971 eCarpenter 1986, 3-4.
71 Pind., Isthm. 8.31-40; ma v. Torelli 2007, 31-32 per diversepossibili interpretazioni, basate sulla Teogonia esiodea.
72 In tutti gli animali, ampi ritocchi paonazzi sottolineanole partizioni anatomiche dei corpi, come il pelame dellecriniere leonine e di quelle suine, le digitazioni inter-costali e le fasce muscolari delle fiere e dei capri, le testefino al collo e le fasce ventrali dei cinghiali, il piumaggiodelle scapole alari delle Sfingi e delle Sirene, le fascemediane alari e caudali; in bianco, l’incarnato di Sfingie Sirene (volti e colli, fino all’inizio dello sterno) equalche penna nelle ali falcate. Sono incisi molti deiprofili, le principali partizioni muscolari e le notazioniossee di rilievo, così come i contorni delle criniere, learticolazioni degli arti, le suddivisioni del piumaggiodi ali e code, nonché i dettagli delle teste, le capigliature,gli occhi, le code.
73 Ben delineato l’apparato genitale della fiera che avanzada destra, reso con incisioni che si stagliano contro losfondo offerto dalla superficie interna della coscia destra.
74 La girandola è costituita da dodici segmenti, secondo loschema (forse più recente di quello a sei elementi intro-dotto dal Pittore della Gorgone e adottato anche daSophilos) che combinando tre ‘croci’, una paonazza, unanera e una bianca, costruisce un’alternanza di dodicispicchi ricurvi; nel dinos di Boston, invece, lo stesso pit-tore ha limitato gli elementi a sei crescenti (v. supra,nota 23). Il paonazzo è distribuito direttamente sulfondo della terracotta, come si vede, ad esempio, anchesull’esemplare attribuito a Sophilos da Paul 1997, 46, n.1 A; una girandola di dodici crescenti policromi ben con-servati è sul fondo del dinos di Sophilos, Louvre E 873:Bakır 1981, tav. 48, fig. 88 (Denoyelle 1994, 60-61, n. 25).
75 Con il bianco sovraddipinto sul fondo nero. Per il motivodella girandola, o meglio la ruota di crescenti lunari neicolori alternati: Vaerst 1980, 716-726; Malagardis 2003,31-34; una proposta sul significato è in CVA Kassel 1(Germany 35), 29, sub tav. 8, 13-16.
76 Brownlee 1981, 88-89 e nota 28.77 La questione è sintetizzata da Brownlee 1981, 2-5; v.
inoltre Radici Colace/Massara 2001, 142.78 Le rosette hanno i contorni dei petali incisi ed il cuore
reso da due cerchietti concentrici incisi e ravvivato daun ritocco paonazzo.
79 Brownlee 1981, 90-91, 573 fig 1, I; già anche Richter/Milne 1935, 9-10, fig. 69; Moore/Pease Philippides 1986,33-35; per il Tipo III, elaborato da Exekias, v. Mommsen2005, 260-261.
80 Brownlee 1981, 104-141; Bakır 1981, 55-56; Brownlee1988b.
81 Brownlee 1981, 108-109; 1988b, 81.82 Calcolo eseguito con il sistema informatico del Centre
de Recherches Archéologiques de la Faculté des SciencesAppliquées de l’Université Libre de Bruxelles (Servicede Systèmes logiques et numériques) elaborato da A.Tsingarida, L. Engels e L. Bavay; indipendentemente, lamisurazione del volume è stata effettuata anche con ilmetodo studiato da Hans Koens, dell’Università diAmsterdam, e dal sottoscritto, secondo il metodo diRigoir 1981, con il medesimo risultato.
83 Per il problema dell’inquadramento cronologico delleriforme soloniane, con prospettive di una possibiledatazione più tarda, v. Ruschenbusch 1966; Hitzl 1996,24-41; v. anche Bentz/Böhr 2002, 73; per la riforma:Valdés Guía 2002, 139-240.
84 Alcuni riferimenti bibliografici recenti sulle unità dimisura dei liquidi in Grecia sono raccolti in Iozzo 2003,note 26-30.
81
85 Per il calcolo del volume del cratere di Ergotimos, v. Iozzo2003. Il volume del dinos ex Erskine è stato calcolatodagli stessi ricercatori dell’Università di Bruxelles ricor-dati supra, alla nota 82, con un risultato di litri 10 seriempito fino all’orlo (litri 10,18 se colmo fino all’orloraso).
86 Il dato si basa sullo studio di Hans Koens (Universitàdi Amsterdam), che sta effettuando una ricerca sullacapacità delle coppe di Siana e che considera quelle delPittore di Heidelberg come esemplari standard per con-tenuto.
87 Qualche recente riferimento bibliografico per le fasi delsimposio è raccolto in Iozzo 2005, in partic. 33 e noterelative; per le dimensioni ed il numero delle coppe o deibicchieri di vino usati nei simposi attici e per il valoremorale e culturale della quantità del bere, v. Musti 2001,29-30, 39 e 46-52. Per il numero delle klinai e dei symposias-tai che esse accoglievano e per il concetto della giustaampiezza del symposion, con riferimento agli invitiristretti del medico Onesikrates, come raccontato daPlutarco nei Symposiaka (5.4.5.1), v. Musti 2001, 41-42,67-68 e 145.
88 Di recente Isler-Kerényi 2001, 88.89 Brownlee 1981, 157-158, 181; per il dinos 606 dell’Acro-
poli v. supra, nota 22.90 Per il Pittore v. ABV 85-88, 683, 714; Para 32-33, 524;
Addenda 23-24; von Bothmer 1948, 42; 1959, 8; Paribeni1961; Boardman 1974, 36, 229, figg. 54-55; Kunstwerke derAntike. Münzen und Medaillen A.G., Basel 51, 14-15.3.1975, n. 118, tav. 19; CVA Leiden 2 (the Netherlands 4),2-3, tav. 56; Berger/Lullies 1979, 43-44, n. 15; Brownlee1981, 177-183; Moore/Pease Philippides 1986, 82-83,104, 179, 182, 263, nn. 34, 611, 626, 1346, tavv. 5, 57, 59, 93;Isler 1986 (edizione di Para 32,1); Moore 1987, 5, 12-13,18, 23, nn. 41, 79, 117-118, tavv. 10, 17, 23; CVA Berlin 7(Germany 61), 12-13, tavv. 3:4-6, 4-5; Tuna-Nörling 1995,44-46, n. 186, tavv. 12-14; Papadopoulou-Kanellopoulou2001 (rettifica di Para 32, 6bis); Sotheby’s Catalogue, NewYork 13.6.2002, n. 53 (già in Kunst der Antike. Galerie G.Puhze, Katalog 13, Freiburg 1999, n. 114); Cabrera Bonet2003, 154-157, n. 50 (già in Kunst der klassischen Antike.Ausstellung in Zusammenarbeit mit Münzen und MedaillenAG. Galerie A. Emmerich, Zürich 22.11.1975-10.1.1976, n.6); Padgett 2003, 304-307, n. 81, ha reso nota un’inter-essante anfora a collo distinto in una collezione privatastatunitense, con il riscatto del corpo di Ettore, sullabase della quale credo si possa avvicinare al Pittore diLondra B 76 anche un cratere a colonnette da Vetuloniastudiato da Cygielman 1998. Nella cerchia del Pittore oa lui vicini sono stati inoltre collocati un fr. di anfora acollo distinto da Berezan (Gorbunova 1973, 196, fig. 1)e parti di quattro loutrophoroi dal santuario della Ninfa,sulle pendici meridionali dell’Acropoli (Papadopoulou-Kanellopoulou 1997, 115-117, nn. 253-256, tavv. 50-51;vedi anche Papadopoulou-Kanellopoulou 2005, 215, n.253).
91 Sull’attività di Sophilos e della sua officina: ABV 38-43,681, 714; Para 18-19, 523; Addenda 10-12; Paribeni 1966e Kreuzer 2004; Bakır 1981 (con recensioni di Brownlee1982 e Mommsen 1983); Felten 1982, 26, 42, n. 157, fig. 7,tav. 12 (che attacca con ABV 41, n. 32); von Bothmer 1986;Moore/Pease Philippides 1986, 79-80 e sub indice; Brown-lee 1987, 77-78, nn. 3, 5, tav. 12; 1988; Palaiokrassa 1989,30, n. 82, tav. 5, 3; Olmos 1990, 22-23, n. 7; Mangani 1990,17, fig. 9, 1-2; 1993, 434, tav. VII b; de La Genière 1995;Brownlee 1995; Tuna-Nörling 1995, 43-44, 50, nn. 182-184,213, tavv. 11, 16, tab. 9; Reusser 2002, I, 22 e 27; Tuna-
Nörling 1995, 15, 53, n. 176, tav. 19; Isler-Kerényi 1997a;Ramage 1997, 66, 74 (Att 1: maniera), 79-80 (Att 36:vicino; Att 37: Sophilos?), tavv. 24, 1 e 27, 36-37; Papa-dopoulou-Kanellopoulou 1997, 87-90 (vedi anche Papa-dopoulou-Kanellopoulou 2005, 212, nn. 173 e 177); Paul1997, 23, 46, n. 1; Kreuzer 1998, 88; Padgett 2003, 236-238,n. 53 (che cita anche un fr. inedito nel MetropolitanMuseum, così come altri sono ricordati da Brownlee1995, 369, nota 2, mentre una pyxis tripode di Sophilosè segnalata in una collezione privata di New York daGaunt 2003, 126). Della cerchia del pittore è il fr. reso notoda Manakidou 2003, 194, tav. 31, 2, mentre il piccolo fr.di orlo da Naukratis in Venit 1988, 71, 79, n. 265, tav.60, potrebbe appartenere ad uno dei dinoi già noti;meno certa mi sembra l’attribuzione alla maniera delpittore di un fr. da Sardis in Cahill/Kroll 2005, 601, fig.19c; un piccolo fr. da Cirene richiama le sue opere(Moore 1987, 38-39, n. 256, tav. 42), così come forse ancheuno da Himera (M. Chiovaro, in Di Stefano 1993, 76-77,n. 83); a Sophilos è stata avvicinata anche una lekythostipo Deianira della Collezione D. J., in Westfalia (Cahn1977, 37, n. 18), attribuzione non riportata o condivisada K. Stähler 1984, 243, n. 100. Solo per completezza,ricordo infine il problematico fr. da Segesta, con partedi un’iscrizione che si è proposto di identificare comeuna firma di Sophilos (Tusa 1964, 772, 775, fig. 73), mache è difficile accettare come tale. Per le problematicheiconografiche e per la questione delle firme, v. ancheIsler-Kerényi 1997a, in partic. 69-78; Isler-Kerényi 2001,82-87; Baurain-Rebillard 1999; per le iscrizioni e le loroimplicazioni, di recente Kilmer/Develin 2001.
92 Williams 1983, 11-15; Moore/Pease Philippides 1986, 35,nota 14; un supporto analogo ma attribuito alla manieradel Pittore KX è in Kreuzer 1998b, 125, n. 51, tav. 10,Beil. 2; v. anche un esemplare del Pittore di Kylleniosad Hannover: CVA Hannover 2, 36-37, tav. 21, Beil. 4.
93 Si aggiungano alcuni dettagli relativi al generale effettocoloristico del vaso, come i bordi esterno ed internodell’orlo dipinti in paonazzo e la girandola sul fondodel vaso, entrambi motivi sofilei che furono comunquecomuni nel secondo venticinquennio del VI sec. a.C.(Brownlee 1981, 178).
94 Riferimenti bibl. essenziali in Iozzo 1998 e Kreuzer2001; v. inoltre gli Atti della tavola rotonda sul VasoFrançois tenutasi a Firenze nel 2003 (Shapiro/Iozzo, instampa), che raccolgono saggi di J. Barringer, J. Gaunt,M. Iozzo, B. Kreuzer, A. Lezzi-Hafter, M. G. Marzi, J.Neils, C. Reusser, H. A. Shapiro, M. Torelli, R. von denHoff, su un ventaglio di problemi compositivi, icono-grafici, interpretativi, stilistici, tecnici e del contesto dirinvenimento, incluse le questioni sulla relazione delcratere con il mondo ateniese e con quello etruscodell’epoca; di recente Kreuzer 2005 e Torelli 2007.
95 Per il cratere a colonnette di Vetulonia v. supra, nota 90.96 Per lo stile del Pittore v. von Bothmer 1948, 42; Paribeni
1961; Boardman 1974, 36; Brownlee 1981, 182-183; Isler1986, 102-105.
97 Come ad esempio sulla hydria ovoide da Vulci, alMetropolitan Museum (45.11.2): ABV 85-86, 2; 683; Para524; Addenda 23; Hofstetter 1997, 1097, n. 48.
98 Lo stesso tipo di plastinx del cavallo esterno di spondanelle quadrighe I e IV si ritrova, ad esempio, sullahydria eponima da Camiro, Londra, British Museum1861.1-25.43 (B 76), con la partenza di Hektor con suofratello Kebrione(us) come auriga, e Glaukos: ABV 85,1; Para 32; Addenda 23; Kossatz-Deissmann 1990, 977, n.1, con bibl.; Schefold 1993, 302, fig. 326; Knittlmayer
82
1997, 49, 61, 65, 124, Ca5, tav. 9.1.99 Moore 1972, 35-36, con riferimenti alla resa delle singole
parti anatomiche dei cavalli nelle opere del Pittore diLondra B 76.
100 V. supra, nota 38.101 Cfr., ad esempio, le vesti delle tre donne sul collo della
hydria-loutrophoros 252 (766) di Eleusi (ABV 86, 6; Para 32),la Nereide che consegna elmo e scudo ad Achille sull’an-fora a collo distinto 1922.6-15.1 del British Museum(ABV 86, 9; Para 32; Icard Gianolio/Szabados 1992, 808,307), la dea centrale nel Giudizio di Paride sull’anforaa profilo continuo del Musée des Beaux Arts di Lione(ABV 87, 16; Siebert 1990, 324, n. 454b, con bibl.) e ledue laterali sull’exaleiptron tripode da Tebe a Bruxelles,Musées Royaux d’Art et d’Histoire, A.3 (ABV 87,21;Kossatz-Deissmann 1994a, 178, n. 8).
102 V. supra, nota 23.103 Per la combinazione degli animali nei fregi secondari
del nostro pittore v. Brownlee 1981, 180-181; per ilmotivo dei galli affrontati v. Moore/Pease Philippides1986, 171-172, sub n. 551, con altri riferimenti.
104 È stato da tempo riconosciuto come peculiarità delPittore di Londra B 76 il suo gusto particolare per la raf-figurazione delle quadrighe in veduta frontale, maprobabilmente fu proprio la sua familiarità con i temiepici a suggerirgli la combinazione fra il motivo dellaquadriga ed i soggetti mitologici, come nelle partenze sucarro di Ettore o Diomede, identificati dalle iscrizioni.
105 In particolare, v. quanto detto da Brownlee 1981, 178-180,a proposito della Caccia Calidonia raffigurata sul dinosdi Boston, per il quale v. supra, nota 23.
106 Carpenter 1986, 3-4, nota 14 (v. anche supra, nota 70). Vainoltre ricordato che, stando a quanto afferma ancoraAristotele (Metaph. 1.3.983b 31-32), Okeanos e Thetiserano considerati i primordiali genitori del cosmo, secon-do una versione cosmogonica derivante da antiche tra-dizioni mesopotamiche, che nella filosofia naturalisticagreca risale almeno alle teorie presocratiche e che sembraessere stata confermata anche dal recente rinvenimentodel Papiro di Ossirinco con il riferimento all’opera diAlcmane (v. infra, nota 127). Per una diversa interpre-tazione del ruolo di Okeanos v. Torelli 2007, 31-32.
107 Per il problema della derivazione da una fonte recita-tiva o visiva v. Stewart 1983, 62-63; Williams 1983, 33;Thomas 1985, 28-42; Carpenter 1986, 6-8; Brownlee1988b, 84; Schefold 1993, 218; Scaife 1995, 177-178;Torelli 2007, 31-40, 53. Le fonti antiche sul mito sonoraccolte da Vollkommer 1994.
108 Per il confronto fra le strutture dei cortei di Sophilos eKleitias v. Heidenreich 1952; Brownlee 1981, 113-120;Stewart 1983, 56-64; Thomas 1985, 2-10; Carpenter 1986,1-12; Zunker 1988, 116-125; Schefold 1993, 218-222;Isler-Kerényi 1997c; Laxander 2000, 56-58; Isler-Kerényi2001, 87-90; Kreuzer 2005, 211-217; Torelli 2007, 38-39(37, per il ruolo di Dioniso).
109 Per la forma in relazione allo schema iconografico appli-catovi e per le implicazioni simposiache, nuziali e fune-rarie del dinos, v. Isler-Kerényi 1997c, 67-69; 2001, 83-84.
110 Brownlee 1988b, 80-81.111 Fink 1974, 12; Sutton 1981, 177-180; Oakley/Sinos 1993,
32, con bibl.112 Williams 1983, 28. Per gli stretti rapporti fra Dionysos
e Peleus e le possibili implicazioni nei documenti icono-grafici v. Danali-Giole 1992.
113 Sia che questo fosse un effetto delle riforme di Solone(con il relativo problema della cronologia delle normescritte sui famosi axones e kyrbeis), sia che fosse da
imputare alle direttive politiche del suo successore econtinuatore, Pisistrato: Carpenter 1986, 10-11; Shapiro1989, 89-90; Schefold 1993, 218-219; Isler-Kerényi 1993;Raaflaub 1996, 1052-1053; Isler-Kerényi 1997c, 80-81;Hölscher 1999, 27-29; Isler-Kerényi 2001, 104, 224-228,con sintesi della questione e riferim. bibl.; Valdés Guía2002, 139-240 (e 3, nota 1, per il problema cronologico).
114 Per le fonti antiche v. Séchan 1931a; Lesky 1956; Vollkom-mer 1994, 251-252; Scaife 1995, 177-178. Per la fortunadel mito in epoca rinascimentale e barocca, con parti-colare riguardo alla concezione coreografica e sceno-grafica ed alla tradizione librettistica, v. Cecchetti 2001.
115 Per l’Arca v. von Steuben 1968, 55 e soprattutto Splitter2000, 46-47.
116 Forse il corteo per le nozze di Peleus e Thetis era raffigu-rato anche su un terzo vaso di Sophilos, un krater-kotyledall’Acropoli: Atene, Ethniko Archaiologiko Mouseio,AKR 585 a-b (Graef/Langlotz 1909-1933, 63, n. 585 a-b;ABV 40, 17 e 18, ritenuti frr. di due vasi diversi; contraBakir 1981, 26, 68, A.17, figg. 17-19, tavv. 35, figg. 64-65,e 36, figg. 67-68; Brownlee 1981, 107-108, 398-400, nn.15-16, che accetta il tema delle nozze per il solo fr. 585b,mentre considera 585a un vaso ed un tema differenti,come fanno anche Kron 1981, 286, n. 4, Manakidou 1994,126, nota 74, e Kasper Butz/Krauskopf 1996, 1085, n. 4.È possibile che si tratti del medesimo vaso, ma con duediversi miti sui due lati, separati dalla zona delle anse.
117 Non mi è perfettamente chiaro quale sia il vaso di Klei-tias in cui A. Queyrel ha di recente proposto di identifi-care il tema del corteo nuziale di Peleus e Thetis (Quey-rel 1992, 671, n. 122): l’Autrice cita un fr. di hydria (Atene,Ethniko Archaiologiko Mouseio: AP 3491) con parte didue figure femminili, una delle quali con l’iscrizione[O]rania, e lo mette in relazione con altri due frr. che raf-figurano le Ninfe; quindi, forse sulla base della presenzadi Muse e Ninfe nello stesso contesto, dichiara che sulvaso figura il corteo divino per le Nozze Tessale. Ora,mentre i frr. con le Ninfe sembrano inediti, poiché nonvi sono né rimandi bibliografici né numeri di inventario,per il fr. di hydria vengono forniti i riferimenti bibli-ografici di Graef/Langlotz 1909-1933, tav. 24 e ABV 682,77. La prima citazione è relativa a frr. dei vasi nn. 450a,594, 597 e 613, ma quella di Beazley specifica che si trattadel n. 597f-h, cioè uno skyphos o kantharos di forma spe-ciale, con un’Amazzonomachia su un lato (von Bothmer1957, 9, n. 39, tav. XIX, 1) e verosimilmente la geranos deigiovani ateniesi guidati da Teseo sull’altro (ABV 77, 5;Addenda 22). Un’accolta di divinità, con i nomi iscritti diHermes e delle Moirai, si trova invece sull’analogo vasodi forma ugualmente incerta (Graef/Langlotz 1909-1933,66-67, tav. 24, n. 597a-e; ABV 77, n. 3; Addenda 21-22; il fr.pertinente dalle pendici settentrionali dell’Acropoli è inPease 1935, 227-228, n. 14, fig. 6), che raffigura però lanascita di Atena da una parte e la geranos dall’altra(oppure - come suggerisce Kreuzer 2005, 198-199, nota127 - un’altra raffigurazione delle Nozze Tessale), oltre arecare la firma di Kleitias, secondo l’illuminante letturadi Schefold 1993, 214, 373, fig. 221, che riconosce il kappainiziale del nome del pittore nei resti dell’iscrizione ver-ticale tra Hermes e le Dee del destino. L’unica hydria diKleitias a me nota è quella di cui si conservano due frr.del collo con le Nereidi in corsa (Graef/Langlotz 1909-1933, 66, tav. 24, n. 594 a-b; ABV 77, n. 8; Addenda 22), chepotrebbe forse raffigurare lo scompiglio delle ninfemarine nel momento del rapimento d’amore di Thetisda parte di Peleus, alla presenza della loro madre Doris.Se i frr. ricordati da A. Queyrel realmente appartengono
83
alla medesima hydria e se raffigurano il corteo nuziale,si avrebbe un secondo caso di associazione dei temi delratto e della pompe matrimoniale sullo stesso vaso, comeAhlberg-Cornell 1992, 49-50, nn. 17, 19, figg. 64, 68 haproposto per un’anfora cicladica di Kavala, che costi-tuirebbe l’occorrenza più antica (625-600 a.C.) della sto-ria narrata nei Kypria. Analogamente, è impossibile sta-bilire se raffigurasse lo stesso tema il fregio principaledel dinos attribuito al Pittore dell’Acropoli 627 (Atene,Ethniko Archaiologiko Mouseio, AKR 610+AP 323), conuna coppia sul carro, accompagnata da tre figure fem-minili che avanzano in secondo piano rispetto ai cavallied almeno un’altra al seguito: ABV, 82, n. 3; Brownlee1981, 173-175, 441-442, n. 41; Manakidou 1994, 126, nota75; Isler-Kerényi 2001, 98. Di recente si è proposto diriconoscere le nozze di Peleus e Thetis anche sul piccolofr. di cratere a volute (un tempo ritenuto di un’olpe) diKleitias, da Helva: Kreuzer 2005, 199, nota 127.
118 Atene, Ethniko Archaiologiko Mouseio, AKR 603 (Graef/Langlotz 1909-1933, 63-68, n. 603, tav. 29): processione apiedi di Dionysos, Aphrodite con un piccolo in braccio,Artemis, forse Apollon, Demeter ed altri, con una figuraalata all’inizio, verosimilmente Iris, in corteo verso si-nistra ed accolti da Peleus e Thetis. L’interpretazione èproposta da von Steuben 1968, 120, seguito da Stewart1983, 71, nota 20; v. anche Kahil/Icard 1984, 711, n. 1163;Delivorrias/Berger Doer/Kossatz Deissmann 1984, 143,n. 1502; Beschi 1988, 844, 476; Krauskopf 1990, 797, n.4; Zimmermann 1994, 323, n. 2.
119 Copenhagen, Nationalmuseet Chr. VIII 754: CVA Copen-hague 8 (Danmark 8), 252, tav. 322, 3; Böhr 1982, 21,102, n. 141, tav. 145; Manakidou 1994, 127 e nota 81 (conaltri riferim. bibl.).
120 Oakley/Sinos 1993, 44, figg. 64-67 (per un elenco di sposidivini v. 132, nota 16); v. anche Moore/Pease Philippides1986, 125, n. 182, tav. 22; CVA München 12, 29-30, tavv.16-17, 1; Christie, Manson and Woods. Sale Catalogue NewYork 7.12.2000, 74, n. 434 (Beazley Archive PotteryDatabase, n. 24294); maggiori dubbi sussistono sullascena della grande anfora B in frammenti a Bruxelles eLipsia, attribuita al Pittore di Monaco 1410: ABV 311, n.3; Paul 1973, 17-18, tav. 12; Addenda 84. Per scene dicortei nuziali (con carri e figure a piedi), probabilmentenon divini o comunque di non facile interpretazione, v.Manakidou 1994, 126-127.
121 Non mi è noto quello adottato sul fr. di un’anfora atticaa figure nere con il matrimonio di Peleus e Thetis (Atene,Ethniko Archaiologiko Museio 16184), datata fra il 575ed il 525 a.C., elencato nel data-base del Beazley Archive,n. 9016847.
122 Firenze, Museo Archeologico Nazionale 3790: ABV 260,n. 30, 264, 691; Para 114; Addenda 68; Delivorrias/BergerDoer/Kossatz Deissmann 1984, 124, n. 1293 (1504);Lambrinoudakis 1984, 287, n. 844; Bruneau 1984, 485, n.85; Shapiro 1989, 56, 88, 97, 113, tav. 24 a-b; Oakley/Sinos 1993, 25-28, figg. 62-63; Vollkommer 1994, 266, n.208; Kossatz-Deissmann 1994b, 724, n. 36; Cambitoglou/Paspalas 1994, 977, n. 94; Manakidou 1994, 211, n. 7;Oakley 1995, 63, fig. 1; Orsi 1998, 313, tav. LXXXVII, 1.Sempre alla maniera del Pittore di Lysippides sonoattribuiti altre scene analoghe, ma senza iscrizioni, chepertanto rimangono dubbie: Stähler 1978 (ora in Christie’s-Borowski cit. a nota 67, 42-43, n. 44).
123 Atene, Ethniko Archaiologiko Mouseio 12076: Krauskopf1977, 20, n. 28; Vollkommer 1994, 266, n. 207, con riferim.bibl.; Manakidou 1994, 211, n. 5; Isler-Kerényi 1997a, 20,80, nota 95.
124 Per l’iconografia delle Nozze Tessale (e per il relativorapporto con le scene di cortei epitalamici), v. Beazley1986 (1951), 25-57; Simon 1953-1954, 211-223; Knell 1965,passim; von Steuben 1968, 54-55, 120; Brommer 1973,318-320; Fink 1974; Krauskopf 1977, 13-37; Thomas 1985,2-55; Schefold-Jung 1989, 99-102; Shapiro 1990, 132;Müller 1994, 131-132 (riconsiderato in Müller 2003);Manakidou 1994, 122-128; Scaife 1995, 177-178; Orsi 1998,311-312; Winkler 1999, 111-122; v. anche Woodford 1993,14-17, e Neils 1996, 190-191; inoltre, la bibl. citata supra,a nota 108. Uno schema iconografico differente è quellocreato anche da Euphronios, nella kylix frammentariadall’Acropoli: Stasinopoulou-Kakarouga 1991, 199, n. 44;Manakidou 1994, 127-128 e nota 86 (con bibl.). Brommer1973, 320, ha ipotizzato che anche un fr. di coperchio‘calcidese’ di Leontinoi, con una processione di quadrighecon Leto ed Artemis (530 ca. a.C.) potesse raffigurare ilcorteo delle Nozze Tessale, ma l’ipotesi non sembraaver trovato seguito (Siracusa, Museo ArcheologicoRegionale ‘P. Orsi’: Rumpf 1927, 100, n. 17, tav. XXXVI;Kahil/Icard 1984, 716, n. 1226; Iozzo 1994, 43, 148, 223,240-241, LE 1; Manakidou 1994, 126). Per la possibileinterpretazione di un lato del Vaso Portland come allu-sione al matrimonio di Peleus e Thetis, v. in sintesiWoodford 2003, 234-235, con bibl. Per la saga in gene-rale v. anche Kaiser 1912, Davis 1924, Séchan 1931a e1931b, Schneider 1941; inoltre Krieger 1973, Grabow1998, 206-215, Frontisi-Ducroux 2003, 23-59.
125 Le varie proposte avanzate non sembrano aver trovatoconsensi unanimi: Oakley/Sinos 1993, 24; Manakidou1994, 124-125 e nota 65 (con bibl.); Isler-Kerényi 1997a,70, nota 20; Laxander 2000, 56, nota 283.
126 Oakley/Sinos 1993, 24; Laxander 2000, 57; Blundell 2004,in partic. 41 (relativamente al V sec. a.C.).
127 Sourvinou-Inwood 2005, 257 e nota 68. Il ruolo diThetis come ‘ordinatrice’ della cosmogonia (almenonelle tradizioni di origine laconica) risulta confermato dalrinvenimento, nel 1957, del Papiro di Ossirinco n. 2390,che riporta parte di un commento in prosa risalente alII sec. d. C., secondo il quale Alcmane aveva affrontato,in una sua opera, il tema della cosmologia teogonicaincentrata sulla figura di Thetis (Vernant 1970; Penwill1974). D’altronde, il nome stesso della dea (peraltrovenerata a Sparta, come dea del mare: Paus., Periegesis3.14.4), deriva dalla medesima radice di thesthai o ditithenai, ovvero ‘mettere a posto, ordinare’. Per una pos-sibile diversa interpretazione basata sulla cosmogoniaesiodea v. Torelli 2007, 31-32.
128 Laxander 2000, 58-59; Isler-Kerényi 2001, 105; inoltre,vari contributi in Shapiro/Iozzo (in stampa).
129 Vernant 1982, 45-76; inoltre, vari contributi in Shapiro/Iozzo (in stampa).
130 Oakley/Sinos 1993, 44; Hölscher 1999, 27-28; Laxander2000, 55-60; Isler-Kerényi 2001, 225-226; Valdés Guía2002, 128-131, 150-151; Kreuzer 2005, 201; inoltre, varicontributi in Shapiro/Iozzo (in stampa). Per una speci-ficazione del ruolo del genos, forse da ridurre drastica-mente anche nella politica di Solone, v. Bourriot 1976;Lape 2003; Musti 2003, 77, nota 34.
131 Lefèvre 1998; in sintesi anche Musti 2003, 98, con riferim.bibl.
132 Sul valore delle immagini mitologiche come veicolo divalori sociali, v. di recente Schmidt 1997, 891-896; Borg2002, 96-97.
133 Di recente Winkler-Horacek 2000; in particolare per laclasse dei dinoi, v. Brownlee 1981, 79.
134 Per il significato degli animali, variamente combinati in
84
teorie, in schemi araldici, in raggruppamenti di due otre ed associati anche a zoomachie o a figure umane, v.Erlenmeyer 1958; Hölscher 1972; Müller 1978 (conrecensione di Hölscher 1980); Isler 1978; Stähler 1984(con altri riferim. bibl.); Hoffmann 1987, 28-29; Markoe1989; Steinhart 1997, 32, n. 3; Hölscher 1999, 20; Isler-Kerényi 2001, 30-32.
135 Per la necropoli di Fonte Rotella e per le ricerche arche-ologiche condottevi da Alessandro François fra il 1843ed il 1846, v. Bianchi Bandinelli 1925, 356-360; Marzi1981, 27-28; Paolucci 1998, 21-22; Marzi 1998, 5-10;Paolucci 2000, 144.
136 Per l’appartenenza del dinos alla ‘categoria’ del conteni-tore megas, come esplicitamente affermato dal gramma-tico Dionisio, discepolo di Trifone, e per il suo impiegocome riferito dalle fonti antiche v. Radici Colace/Mas-sara 2001, 139 (n. 20),142-144.
137 Iozzo 2006, con altri riferim. bibl.138 Iozzo 2006, 110, 120. Anche il fr. n. 67193 potrebbe forse
essere più antico delle opere di Sophilos, al quale l’hoavvicinato (Iozzo 2006, 110, 120, fig. I.9); infatti, malgradole limitate dimensioni, spicca la particolarità della pal-metta arricchita da una fila di cerchietti incisi nell’areaintermedia fra il cuore e i petali; benché non abbia finoratrovato confronti precisi, mi sembra che il gusto per unarricchimento dell’anthemion proprio in quella posizionecorrisponda a quanto generalmente avviene nelle operedei Pittori della Gorgone e KX, così come del Gruppodella Lekanis di Dresda; un dettaglio che si ritrova anchein qualche pittore del Gruppo Tirrenico, ma nella ver-sione con una fila di punti suddipinti in bianco (Pittoridi Guglielmi e di Castellani: Kluiver 2003, 217, 243, nn.145, 221. figg. 42, 110).
139 Per i singoli documenti citati si rimanda a Iozzo 2006.Inoltre, parte di un sostegno di un altro dinos, di nongrandi dimensioni (si conservano il piede, con diam.cm 21,2, decorato da una corona di foglie, ed il trattoinferiore del fusto, con diam. cm 7,8, ronato da registrizoomorfi, per un’alt. complessiva di cm 16,5), è nellacollezione Vagnonville (Firenze, Museo ArcheologicoNazionale: V. 697) ed è probabile che provenga daChiusi o dal suo territorio, in quanto anch’esso untempo parte della Collezione Lunghini di Sarteano.
140 Paolucci 2000, 151, nota 1.141 Radici Colace/Massara 2001, 142.142 V. Isler-Kerényi 1997b; Schweizer 2003; inoltre, il con-
tributo di Ch. Reusser in Shapiro/Iozzo, in stampa.143 Jensen 1980, 128-158; Bowie 1986.144 Il concetto è stato recentemente ribadito anche da
Osborne 2004; Kreuzer 2005, 201, 220-223; Hölscher2006; 11; Torelli 2007, 11, 15, 36, 39-40, 54-56, 63, 73 (oltreche dallo Stesso, in Shapiro/Iozzo, in stampa).
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLATOSCANAVIA DELLA PERGOLA 65I-50121 [email protected]
85


























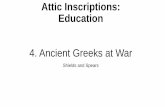


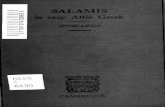
![MAA 385 - [ww2] - Herman Goring Division.pdf](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632522f3e491bcb36c0a272a/maa-385-ww2-herman-goring-divisionpdf.jpg)













