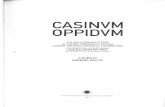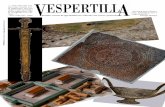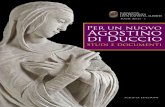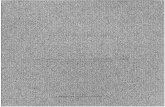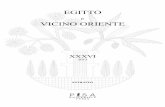Erme efebiche e ginnasi. Tra contesto archeologico e fortuna iconografica
Nuove considerazioni su alcuni sarcofagi del Museo archeologico dell’Hatay
Transcript of Nuove considerazioni su alcuni sarcofagi del Museo archeologico dell’Hatay
RIVISTA DI ARCHEOLOGIAAnno XXXV - 2011
GIORGIO BRETSCHNEIDER EDITORE2012
www.bretschneider-online.it/rda
RIVISTA DI ARCHEOLOGIAUNIVERSITà CA’ FOSCARI - DIpARTImENTO DI STUDI UmANISTICI - VENEzIA
Rivista annuale fondata da
gustavo traversari
Direttore
adriano maggiani
Comitato Direttivo
giorgio bejor - paolo biagi - filippo carinci - ninina cuomo di caprio - sauro gelichi
sandro salvatori - luigi sperti - gustavo traversari - annapaola zaccaria ruggiu
Assistente di redazione: flavia morandini
Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione anche parziale del testo edelle illustrazioni sono riservati per tutti i paesi
Autorizzazione del Tribunale di VeneziaReg. Stampa n. 5 del 1˚ Febbraio 2006
ISSN 0392 - 0895
printed in italy
copyright © 2012 giorgio bretschneider editore - roma
Via Crescenzio 43 - 00193 Roma - www.bretschneider.it
INDICE
p. 5
» 13
» 41
» 45
» 59
» 93
» 97
» 111
» 123
» 137
» 149
» 167
» 185
» 193
» 213
A. Maccari, Un funerale chiusino. Appunti su un cippo inedito di Sarteano . . . . . . . .
P. A. Gianfrotta, La topografia sulle bottiglie di Baia . . . . . . . . . . . . . . .
a. ovadiah, S. Mucznik, The statue from Ampurias/Emporion, reconsidered . . . . . . . .
E. LafLi, J. MEiSchnEr, M. Buora, Nuove considerazioni su alcuni sarcofagi del Museo archeo-logico del l’Hatay, Antakya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. MoinE, Rileggere un vecchio scavo nella laguna nord di Venezia: San Lorenzo di Ammiana . .
a Minoan SEMinar. thE MESara thoLoS toMBS froM thE ProtoPaLatiaL PhaSES throuGh thE MycEnaEan PEriod: nEw foundationS and rE-uSE of thE PaSt
Foreword (F. M. Carinci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. caLoi, Changes and evolution in funerary and non-funerary rituals during the Protopalatial peri-od in the Mesara plain (Crete). The evidence from Kamilari and from the other tholos tombs .
G. fLouda, Reassessing the Apesokari tholos. A funerary record: preliminary thoughts . . . . .
L. GirELLa, The Kamilari project publication . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. aLuia, The re-use of tholos B at the Ayia Triada cemetery . . . . . . . . . . . . .
tEcnoLoGiE nELL’antichità E archEoMEtria
R. BortoLin, Arnie, miele e api nella Grecia antica . . . . . . . . . . . . . . . .
d. cottica, L. tonioLo, Imitazioni versus importazioni: sigillate di prima e media età imperiale dall’insula 104 a Hierapolis di Frigia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. T. raPtiS, L’eredità romana nelle fornaci per la produzione di ceramica in Grecia tra il IV e il XV secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rEcEnSioni E SEGnaLazioni BiBLioGrafichE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELEnco dEi LiBri ricEvuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tavoLE
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi del Museo archeologico dell’hatay, aNtakya *
Ergün LafLı - Jutta MEıschnEr - Maurızıo Buora
abstract
Forty years after the publication of Nikolaus Himmelmann (1970) twelve of the thirty sarcophagi of the Ar-chaeological Museum in Antakya are reviewed here. We offer brief descriptive records of the sarcophagi and a photographic documentation in many cases original. The typological and stylistic variety demonstrates the wide range of origins of these monuments: their high quality emphasizes the high economic standards of An-tioch in imperial times.
Introduzione
si analizzano qui dodici dei trenta tra sarcofagi interi e frammentari conservati nel Museo archeo-logico di hatay, antakya (turchia) e si espongono nuove considerazioni dopo quelle proposte da Ni-kolaus himmelmann nel 1970. himmelmann aveva fotografato, interpretato secondo un punto di vista storico-artistico e disposto secondo una prelimina-re scansione cronologica alcuni sarcofagi in espo-sizione.
lo stesso autore se ne occupò anche l’anno suc-cessivo 1, mentre occasionalmente, dopo il classico manuale di koch e sichtermann, edito nel 1982, singoli sarcofagi vennero nuovamente presi in con-siderazione anche negli anni Novanta 2.
il fine sarcofago in calcare con decorazione a pi-lastri e ghirlande inv. n. 11.162 è stato dettagliata-mente discusso insieme con le sculture da uno degli autori 3 e un altro studio recente riguarda le ste-le conservate nel museo 4. il sarcofago fu realizzato molto tempo prima dell’inizio della produzione di massa, intorno alla fine del secondo secolo.
Il Museo di Antakya
fin dall’inizio del XX secolo, dopo i numerosi rinvenimenti dalla città e dai suoi dintorni, si stabilì con l’auspicio di M. Prost, ispettore francese alle an-tichità di antakya – che era allora sotto il dominio francese –, di fondare un museo. il progetto, con-cepito secondo le teorie museografiche vigenti, fu realizzato nel 1934 dopo gli scavi svolti ad antio-chia, secondo le indicazioni e le proposte avanzate dallo stesso Prost.
gli scavi ebbero inizio nel 1932 per impulso del «committee for the excavation of antioch and its vicinity» (formato dai Musées Nationaux de fran-ce, dal Baltimore Museum of art, dal Worcester art Museum e dall’università di Princeton) e si in-terruppero nell’estate del 1939 per l’approssimarsi della guerra 5. i risultati scientifici furono pubblica-ti in america in quattro volumi 6.
Quando nel 1939 hatay fu unita alla turchia, si completò l’edificio museale e si riunirono qui le ope-re acquisite mediante scavo o in altro modo. suc-cessivamente nel corso di nove anni fu completa-
* lo studio dei sarcofagi del Museo archeologico di hatay è stato cortesemente concesso dalla direzione generale per i beni culturali e i musei del Ministero per la cultura turco nell’anno 2005 [autorizzazione n. B.160.aMg.0.10.00.01/707.1.(0579)-122050].1 hıMMELMann 1971, p. 92 ss.2 ad es. in roggE 1993 e schauEnBurg 1995.3 MEıschnEr 2003, in particolare pp. 336-338.4 LafLı, MEıschnEr 2008.5 una breve sintesi sulla loro storia in DownEy 1959, in particolare pp. 653-654; KonDoLEon 2000, pp. 5-8.6 ELDErKın et alii 1934; stıLLwELL 1938; — 1941; waagé 1941; — 1952.
ergÜN lafli - Jutta MeischNer - Maurizio Buora [rda 3546
ta la suddivisione dei reperti e il 23 luglio 1948 in occasione della festa di liberazione di hatay il museo fu aperto. un corpo aggiuntivo, iniziato nel 1969, fu terminato nel 1973 e aperto con una nuo-va esposizione.
Negli scavi condotti dagli anni trenta si rinven-nero più di 250 pavimenti musivi, che costituisco-no l’aspetto più noto di questo museo. attualmen-te la collezione del Museo archeologico dell’hatay si articola in sette sale e due corridoi, con i reper-ti distinti a seconda delle aree di rinvenimento. i sarcofagi romani si trovano in tre giardini adiacen-ti all’edificio del museo, insieme con altro materia-le architettonico lapideo, stelai, pithoi e un mosaico della chiesa di seleucia di Pieria. È in corso attual-mente da parte di un gruppo di studiosi turchi e stranieri una riconsiderazione e pubblicazione com-pleta delle sue collezioni.
l’insieme dei sarcofagi, arricchitosi nel corso del tempo, è nel suo complesso così importante da me-ritare un catalogo, che esiste già per la plastica a tut-to tondo del museo. in un solo caso, purtroppo, co-nosciamo le circostanze del rinvenimento.
Catalogo
le misure, in centimetri, si riferiscono alla cassa.
1. sarcofago attico con copertura a kline. inv. n. 9.576 (tavv. Xiv a-Xv a)
lungh. 233; alt. 104; prof. 101. linee di appoggio del campo figurato, nella parte an-
teriore e sulle facce laterali, profonde 6. danni ai volti, alla fiaccola del lato destro, nella cor-
nice superiore della parte posteriore. Mancano la testa della figura sul coperchio, il mento delle psychai latera-li, le loro braccia protese in avanti e l’avambraccio de-stro dell’erote.
il coperchio è reso come una kline con due fulcra aguzzi e uno schienale. in rilievo due gambe troppo piccole e un listello a profilo convesso. Perpendi-colarmente ad esse un piano squadrato su cui pog-giano i fulcra e il materasso. su di esso un tessuto a pieghe; una parte cade sporgendo in avanti. un uomo è disteso, vestito con chitone e mantello che copre le gambe. egli appoggia il suo braccio sini-stro su un cuscino e nella mano tiene una piccola
ghirlanda. il retro del coperchio presenta tre con-chiglie incavate e di nuovo due gambe della kline troppo piccole a basso rilievo. esso è palesemente più recente di qualche decennio. l’inusuale motivo a conchiglia del retro e le gambe della kline trop-po piccole, ricavate nel bordo inferiore, non sono adeguate a un sarcofago attico. Pertanto si suppone che sia stato aggiunto un coperchio tratto dal ma-gazzino dell’officina. inusuale anche la presenza di un solo individuo sulla kline 7.
la cassa ha su tutte e quattro le facce, sopra e sotto, una cornice con profilo molto articolato. Que-ste cornici si uniscono perfettamente l’una all’altra agli angoli. le figure sulla faccia principale poggia-no su una linea di base sporgente. amore e Psiche stanno effettuando un sacrificio. amore porta nel-la sinistra una lanx con frutti; Psyche versa con due dita qualcosa sul fuoco da una pisside (?), che tie-ne nella sinistra. ai lati, in posizione araldica, due psychai in peplo poggiano le ginocchia sul dorso dei cervi che stanno sacrificando. sul retro ugualmente un motivo araldico con un elemento centrale (che compare anche nel n. 3) tra due gruppi di leoni e tori che combattono tra loro (cfr. n. 3).
sul lato destro su una linea sporgente si dispo-ne frontalmente un attis/orfeo (?) con berretto fri-gio. egli indossa un lungo e ampio chitone, cinto sotto il petto e un mantello. solleva nel braccio de-stro proteso una fiaccola e alla luce di essa guida una donna velata (euridice ?), che egli tiene con la mano sinistra. la donna raffigurata sembra avan-zare a grandi passi da una porta ad arco lontana e più piccola (ade?). essa, di profilo, è vestita di un lungo chitone e di un velo e porge la sua mano de-stra all’uomo. il braccio sinistro è piegato ad ango-lo; nella mano tiene un oggetto (forse una scatola come Psyche?).
sul fianco sinistro, sulla base sporgente, una cop-pia in chitone e mantello, di pieno prospetto, si tie-ne per mano. la donna, calzata, scosta il velo dal volto, mentre l’uomo, a piedi nudi, stringe nella si-nistra una ghirlanda.
le facce laterali non sono opera della stessa mano che realizzò la fronte. le cornici hanno sul lato anteriore e sui fianchi uguale profondità. il fon-do del rilievo nella parte anteriore e sui lati proce-de come il risalto della cornice superiore: le sezioni sono identiche. esse non derivano da una rilavo-
7 Per cui Koch, sıchtErMann 1982, p. 372, con elenco delle attestazioni.
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi2011] 47
razione successiva di un rilievo laterale eraso (con sfinge?). i grossolani listelli e i fini profili, che han-no esatta corrispondenza, non sono da ricondurre a una medesima mano che avrebbe effettuato in loco la successiva lavorazione. gunthram koch pensa in maniera molto convincente a lati appena abbozzati e a una loro lavorazione successiva. le cornici inferio-ri e superiori sono unitarie e tipiche di un’officina attica. gli abbozzi laterali consegnati ad antiochia sporgevano tra le cornici, lavorate con cura.
come anche la faccia laterale sinistra del sarcofa-go attico a ghirlande n. 3 in questo sarcofago i due fianchi presentano motivi completamente inusuali 8. È chiaro che l’officina si conformò ai desideri per-sonali dell’acquirente, dal momento che i tipi pre-fabbricati a disposizione non rispondevano a que-sti. tra i pochi sarcofagi attici di antiochia si può constatare qui la presenza di due motivi che esula-no completamente dall’ambito del repertorio tradi-zionale. l’atleta con la palma della vittoria del n. 3 potrebbe essere stato realizzato in un’officina atti-ca; il motivo è attico. Qui la maldestra raffigurazio-ne della coppia di coniugi sui fianchi di un sarcofa-go del gruppo di amore e Psiche fa un’impressione provinciale.
il listello sul quale agiscono le figure della fac-cia principale e di quelle laterali non arriva, come sui tipici sarcofagi attici a figure, fino agli angoli la-terali, ma termina già entro la fronte. sabine rogge valuta questa circostanza come frutto di una prima fase di sperimentazione. inoltre contraddistinguo-no il sarcofago le proporzioni allungate della cassa, la sua altezza ridotta e la disposizione molto spa-ziosa delle figure. sorprendentemente la composi-zione araldica non solo della faccia posteriore, ma anche di quella principale con amore e Psiche, è molto lontana dall’affollata pienezza delle figure del-le composizioni di età antonina. il sarcofago è pre-coce, da datare in età adrianea. l’opinione attuale sulla data della sua realizzazione è incerta e diffici-le da motivare. rogge la pone verso il 140, koch e sichtermann appena tra 150 e 170/180 9. alla più antica cassa è stato sovrapposto un coperchio a kli-ne, venuto di moda molto più tardi, che per di più non è attico.
Bibliografia: hıMMELMann 1970a, pp. 15-19, figg. 12-13, tavv. 11-14; Koch 1973, p. 221; gıuLıano, PaLMa 1978, tav. 2, 3; Koch, sıchtErMann 1982, p. 369, nota 4; p. 372, nota 62; p. 381 e nota 32; pp. 425, 443, 438, 459, tavv. 409-410, 456 e 475; Koch 1989, p. 187, fig. 32; roggE 1993, pp. 114, 120-132, nota 52, tav. 53; — 1995, p. 34, nota 120; p. 91, nota 113, n. 57, tav. 111.
2. sarcofago a ghirlande attico con coperchio a spio-venti. inv. n. 15.948 (tavv. Xvi a-Xviii c)
il sarcofago è stato finora appena in parte oggetto di studio: k. schauenburg ne tratta relativamente alle bighe con gli eroti, sopra le ghirlande.
cassa: lungh. 207, con il rilievo 213; alt. 86; prof. 89, con il rilievo 98. coperchio: alt. 47; lungh. 228; prof. 108.
i nasi della sfinge e del putto sinistro sulla biga trai-nata da leoni sono danneggiati.
acroteri curvi, privi di rilievi. il tetto del coper-chio è coperto da tegole a forma di foglie con ner-vatura centrale. cornice superiore e inferiore della cassa a profilatura multipla. sui quattro lati mas-sicce ghirlande di frutta che verso le terminazio-ni si riducono alquanto; al centro ciascuna è avvol-ta da un nastro. sugli angoli sono poste nella parte superiore teste di toro. sulla faccia principale un putto con ricci a cavatappi e una treccia sulla som-mità del capo posto su una base a mezzaluna, in posizione obliqua, è in atto di volar via. col brac-cio sinistro abbraccia anteriormente il nodo della ghirlanda; il destro è volto verso il basso dietro il nastro del nodo. Negli archi delle ghirlande com-paiono eroti alati in atto di salire su una biga, con una corona del vincitore nelle destre protese. il vei-colo di sinistra è tirato da due leoni, quello di de-stra da due pantere. Nella faccia posteriore l’aqui-la che regge il nodo di due ghirlande occupa tutto lo spazio per l’intera altezza della cassa, esattamen-te al centro, come in molti sarcofagi attici 10. Nel ii sec. d.c. a roma l’aquila compare nell’apoteosi im-periale per indicare l’anima che si eleva: troviamo lo stesso motivo dell’aquila che sostiene una ghir-landa nella decorazione tardoantonina nel foro di aqui leia, a indicare la vittoria della armi romane sui barbari (= Marcomanni) 11. Qui l’aquila tiene la
8 hıMMELMann 1970a, pp. 17-18; Koch 1973, p. 221; wıEgartz 1975, nota 206; Koch, sıchtErMann 1982, p. 381.9 Koch, sıchtErMann 1982, p. 459.10 sul motivo e la sua diffusione Koch, sıchtErMann 1982, p. 435.11 casarı 2004.
ergÜN lafli - Jutta MeischNer - Maurizio Buora [rda 3548
sua ala sinistra, semiaperta, sotto la ghirlanda de-stra. l’ala sinistra è quasi coperta; tuttavia si vede sotto la ghirlanda il suo bordo esterno con le penne che la ricoprono. l’ala destra dinanzi alla ghirlanda è completamente visibile. le penne dell’animale di-vino sono molto fini e diversificate con cura. l’aqui-la è posta di tre quarti verso sinistra e volge la testa all’indietro. le penne che rivestono il collo, l’ala e il ventre non sono affatto stereotipate, ma sono rea-lizzate a diversa grandezza e posizione, in parte an-che alquanto rigidamente distanziate. sono poten-temente rigonfie le penne del collo e delle zampe: cannello e scanalatura differenziano chiaramente le penne dell’ala e le penne maestre. gli artigli sono resi con senso del volume; realisticamente si delinea la pelle rugosa sulle zampe. Negli archi delle ghir-lande si trovano teste di leone modellate in manie-ra naturalistica con criniera a ciocche.
sul fianco destro è seduta direttamente sulla ghirlanda, con lo sguardo volto verso il lato con gli eroti su biga, la grande sfinge, motivo tradiziona-le dei lati corti. la lunga coda è piegata in avanti a forma di s e incrocia la ghirlanda. corpo, zampe e ali sono resi con ricchezza di dettagli. le costo-le, la parte superiore del corpo femminile e il volto mostrano forme delicate. la chioma a lievi onde e fini ciocche è pettinata all’indietro. sul fianco sini-stro compare sopra la ghirlanda una testa di leone, uguale a quelle del lato posteriore.
le dodici terminazioni delle ghirlande sono uni-te insieme con sei grossi nodi. Ne discendono lar-ghi nastri con desinenze circolari e un prolungamen-to filiforme. tutte le sei ghirlande sono interrotte al centro della curvatura, alla maniera tipica delle ghir-lande attiche, da uno spazio verticale. ai suoi lati si dispone trasversalmente una serie di tre mele grana-te, che si trovano l’una accanto all’altra, senza toc-carsi. il centro delle ghirlande attiche si caratterizza secondo il seguente schema: due file di mele gra-nate sono disposte frontalmente l’una all’altra come qui, senza essere connesse tra loro. si ha l’impres-sione che una tenia dovesse avvolgere qui la ghir-landa. Quindi nella parte mediana delle ghirlande delle sottili cordicelle avvolgono il festone, ma non al centro, cosa che sembra inspiegabile. Nel sar-cofago n. 3 questa incomprensibile cesura è anco-ra più chiara.
le scenette dei putti che guidano le bighe, sul-
la faccia anteriore, non paiono essere state ispirate dai sarcofagi urbani a ghirlande. di fatto nei pro-dotti delle officine della città di roma compare in genere una linea a rilievo su cui si trovano le figu-re (o le maschere) 12. Qui invece putti e bighe spor-gono direttamente dalla ghirlanda.
le figure a rilievo, così come le teste di leone e di toro, sono modellate con cura senza uso del tra-pano. al contrario della cura e della delicatezza di dettaglio presenti nelle figure, tutti i singoli frutti delle ghirlande e i nodi sono contornati da serie di fitti punti ovvero solchi eseguiti col trapano. listel-li lasciati al loro posto sono visibili ovunque. se si confronta ad es. l’esecuzione delle ghirlande sui lati brevi con quella della faccia con l’aquila, risulta ben chiara una tecnica molto diversa. devono aver lavo-rato alle figure mani diverse rispetto a quelle delle ghirlande. i dentelli e i ponticelli sparsi ovunque e specialmente sui nodi portano a una datazione nel-la piena o tarda età antonina.
Bibliografia: Koch, sıchtErMann 1982, p. 426, nota 16; p. 438, n. 10; p. 445, nota 22; p. 459; si confrontino anche le tavv. 470 (da kephissia) e 471 (da tiro, a Beirut); Koch 1989, pp. 183, 191-192, fig. 39; p. 194, fig. 42 (oreste/ghir-lande); roggE 1993, p. 112, nota 28; schauEnBurg 1995, pp. 26, 40, 46 e nota 269, 58, 99, tavv. 58, 1-2; 59, 1-2.
3. sarcofago attico a ghirlanda con copertura a spio-venti. inv. n. 8.473 (tavv. XiX a-XX b)
lungh. 196; alt. 82; prof. 92.visi e bocche danneggiati.
timpano con acroteri e rosetta solo abbozzato. sulla parte anteriore della cassa due ghirlande di frutta sottolineate da punti tra le teste di toro sugli angoli; al centro un erote in volo su una base spor-gente. sopra gli archi delle ghirlande una testa fem-minile per parte con riccioli a nodino che scendono sulle spalle. i riccioli terminano con affettati bocco-li. himmelmann intende le teste femminili ricciolu-te come immagini dionisiache. sul lato corto destro una testa di leone sopra una ghirlanda; sul lato sini-stro un atleta nudo con una palma sulla spalla, su una linea di base. sulla faccia posteriore (la prin-cipale secondo rogge) un sostegno portafrutta tra leoni in posizione araldica, che sbranano ciascuno un toro (cfr. n. 1).
rilievo del lato destro corto: l’atleta con la pal-
12 si veda ad esempio Koch, sıchtErMann 1982: da Parigi (fig. 267) o a roma, al Museo Nazionale romano (fig. 269) e a s. Maria antiqua, come a hever castle e ostia (figg. 270-272).
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi2011] 49
ma del vincitore 13 è del tutto singolare e certo cor-risponde a uno specifico desiderio del committen-te. Questo desiderio deve essere stato comunicato all’officina in attica (secondo himmelmann a ke-phissia). Non si tratta di una caduta di stile, come tra la fronte e i fianchi nel n. 1. il committente di antiochia l’ha espressamente ordinato di perso-na o tramite un emissario in attica. il lato sinistro minore ripropone una ghirlanda attica secondo le sue caratteristiche tipiche. le due metà sono av-volte al centro da una tenia. ciò non avviene nel-la ghirlanda centrale. la ghirlanda laterale fa sen-tire la mancanza di un avvolgimento al centro: qui si apre una illogica lacuna. rimane libero sempli-cemente uno spazio verticale tra il rilievo di fondo dei livelli delle due mele granate centrali. inoltre le due file di mele granate sono giustapposte al cen-tro della ghirlanda, senza alcuna connessione, e do-vrebbero scendere dal punto di congiunzione fino sulle teste di toro. viene da pensare che al tipo do-vesse appartenere una tenia, che avvolgesse al cen-tro la ghirlanda. dal momento che le metà appaio-no qui come attaccate al centro, è sorprendente che ciò non avvenga al centro delle ghirlande dei lati lunghi. una cesura simile al centro della ghirlan-da si ripete regolarmente sui sarcofagi attici. sopra di essa s’incurva in avanti dai due lati una spiga di grano. il lapicida si avvalse palesemente di un mo-dello per lui incomprensibile, forse derivato da un disegno.
Nell’Handbuch der Archäologie, volume 7 (p. 436), il nostro sarcofago compare nella trattazione dei sarcofagi attici: qui si legge che non vi sarebbe alcun precedente ad atene per i sarcofagi attici a ghirlanda e che le ghirlande non figurerebbero né sugli altari funerari né sulle urne funerarie. in real-tà vi è almeno un altare funerario di epoca tardoel-lenistica. esso si trova nel Museo Nazionale di ate-ne, ha l’inv. n. 1.791 ed è riprodotto in altmann 14. sulla faccia principale si vede un rilievo molto dan-neggiato con la cena dei defunti; sul fianco una tipi-ca ghirlanda, come appare anche sui sarcofagi atti-ci. essa esibisce la nota ‘cesura’, che qui è resa più o meno chiaramente come una tenia avvolgente. un altro nastro si vede al centro della mezza ghirlanda posta accanto a destra. la struttura, appesa a una te-
sta di toro, corrisponde alle più tarde ghirlande im-periali dei sarcofagi attici, con fasci di spighe, pigne, foglie di vite e grappoli come pure con mele gra-nate che si dispongono verticalmente l’una accanto all’altra ai lati dell’avvolgimento centrale.
finora si è riconosciuto un altro precedente dei sarcofagi attici a ghirlanda. si tratta delle ghirlan-de sulla faccia anteriore del sarcofago caffarelli a Berlino 15. la ghirlanda della parte posteriore destra non viene presa in considerazione come un tipo at-tico; essa somiglia piuttosto al tipo dell’Ara Pacis. Ma le due ghirlande della fronte si rivelano anche a una veloce analisi come attiche. esse mostrano pro-prio le due linee verticali di cui qui si è detto, cia-scuna con tre mele granate nel mezzo della ghirlan-da. Questa struttura è attribuita esclusivamente alle ghirlande attiche, non a quelle micrasiatiche o itali-co-romane. il sarcofago caffarelli è stato esaminato approfonditamente da h. herdejürgen e datato alla prima età claudia. esso è dunque un po’ più recente rispetto all’ara funeraria di atene. la configurazio-ne dei lati del sarcofago caffarelli ne rivela l’impa-ginazione romana, che fu realizzata da lapicidi atti-ci. esso si colloca come pezzo unico tra i sarcofagi romani. È incerta la data di inizio della produzione dei sarcofagi attici: f. isık pensa al 120 16, koch al 140 d.c. tra il sarcofago caffarelli (40 d.c.) e i pri-mi sarcofagi attici a ghirlande ci sarebbe un inter-vallo di 80 anni, ovvero di tre generazioni. Questo periodo tra il sarcofago caffarelli e l’ipotetico ini-zio della produzione dei sarcofagi attici a ghirlan-da è oscuro e finora privo di attestazioni per quan-to riguarda la tradizione del tipo della ghirlanda attica.
un altro fenomeno tipico dei sarcofagi a ghir-landa è la differenza nella tecnica del rilievo tra le figure e le ghirlande con frutti. le teste femmini-li ricciolute, le teste di toro e di leone sono lavo-rate senza uso del trapano. così invece non avvie-ne per le parti costitutive delle ghirlande e i nodi. ampi solchi lasciati dal trapano segnano il contor-no di ogni singola parte ovvero lasciano sottilissi-mi puntelli. la resa nel nostro n. 3 è un po’ più grossolana rispetto a quella del sarcofago a ghir-lande n. 2 (inv. n. 15.948). le mani dell’erote sono fuori posto e troppo grandi. si può verificare que-
13 förstEr 1898, p. 187.14 aLtMann 1905, fig. 3.15 da ultimo si veda MEıschnEr, LafLı 2008.16 ısıK 1977.
ergÜN lafli - Jutta MeischNer - Maurizio Buora [rda 3550
sto giudizio nel confronto con la fine lavorazione dell’aquila, della sfinge e delle bighe del n. 2. tut-tavia anche la ghirlanda del n. 3, o per lo meno la sua parte frontale, presenta in larga misura foglie eseguite in vario modo. inoltre in entrambi i sarco-fagi si possono determinare allo stesso modo diffe-renze nella realizzazione tra facciata principale e lati minori. di volta in volta potrebbero aver lavo rato diversi lapicidi per il lato principale e per i fian-chi. È difficile supporre una differenza cronologi ca per la realizzazione delle ghirlande dei due sarco-fagi. come il sarcofago n. 2 con aquila e sfinge an-che quello con teste femminili con riccioli a nodo è medioantonino, ovvero da porre verso il 150/160.
Bibliografia: Gazette archéologique 1885, 10, tav. 29; för-stEr 1898; rEınach 1912, ii 98, 1-4; hıMMELMann 1970a, pp. 12-14, fig. 10, tavv. 15-17; — 1970b, p. 10; Koch 1973, p. 220 ss.; gıuLıano, PaLMa 1978, p. 13, n. 3, tav. 3, 5; Koch, sıch-tErMann 1982, pp. 381, 435-436, 444-445, 458-459; Koch 1989, p. 186 ss., p. 208, figg. 31 e 60; roggE 1993, pp. 112, 114 ss. e nota 52, tav. 46, 3; — 1995, p. 38, nota 148.
4. sarcofago a ghirlande con copertura a spioventi. inv. n. 8.472 (tav. XXi a-b)
cassa: lungh. 265; alt. dello specchio figurato 65, cas-sa fino alle cornici 104; prof. specchio 130, con il rilie-vo 156.
coperchio: alt. 60. calcare.
fortemente danneggiato in più punti. la parte posteriore, come anche la copertura, è stata lascia-ta allo stadio grezzo.
ai quattro angoli teste taurine, su cui sono an-nodate in modo complicato le ampie fasce termina-li delle ghirlande. fasce ondulate pendono a destra e a sinistra delle teste di toro. le due ghirlande del lato anteriore hanno forma diversa. la destra sotto il tondo con Medusa sporge come un semicerchio; la sinistra con la testa di Perseo è più corta; un grap-polo d’uva riempie l’intervallo vuoto tra esse. en-trambe le ghirlande si dispongono dinanzi alle ali distese, sulle spalle di un erote. dai punti di fis-saggio pendono identici nastri, spessi e serpeggian-ti. l’erote (la cui testa manca) poggia su una lunga base, su cui scendono le terminazioni ondulate dei nastri. il suo braccio sinistro tocca da sotto la ghir-landa, mentre quello destro è penzoloni. a destra l’intero semicerchio della ghirlanda è riempito con un tondo, che rinchiude un gorgoneion sull’egida. l’arco sinistro della ghirlanda ha una forma legger-
mente triangolare a causa del grappolo pendente. sopra di esso vi è la testa di Perseo; a sinistra di fianco ad essa un arpione ad arco ovvero una falce con cui egli decapitò Medusa.
sul fianco destro sporge sopra l’arco della ghir-landa con grappolo di nuovo una testa, di ermes, su un lungo collo; a destra di fianco ad essa il suo cadu-ceo alato. al di sopra a sinistra un’iscrizione su due righe, di aspetto poco curato Prnklo eirgseto. sul fianco sinistro una rosetta con petali rigonfi e ondulati su una ghirlanda di alloro, cui è appeso un grappolo d’uva.
tre ghirlande terminano nella parte inferiore in un piccolo grappolo d’uva, ma non sotto il gorgo-neion. le ghirlande non sono stereotipate, ma sono diversificate, prevalentemente a mo’ di ghirlande di foglie. Nella copertura a tetto si dispone a destra una testa di leone, a sinistra una rosetta. il coper-chio corrisponde alla cassa, per quanto concerne la lavorazione e i profili. la sua parte posteriore è pri-va del motivo a tegole. si tratta di un lavoro locale in accordo con i sarcofagi attici a ghirlande con co-pertura a spioventi (?). il sarcofago non segue pedis-sequamente i suoi modelli, ma rivela indipendenza formale e tematica – iniziale ii sec. d.c.
Bibliografia: hıMMELMann 1970a, pp. 8-10 e nota 2, tav. 6, 7; Koch 1973, p. 220; Koch, sıchtErMann 1982, pp. 435 e nota 1, 473, 568, tav. 577; Koch 1989, p. 209; — 1993, p. 193, fig. 111. Per Perseo con l’arpione: ØstErgaarD 1996, n. 65.
5. sarcofago a ghirlande. inv. n. 8.502 (tav. XXii a)
largh. 232; alt. 110; prof. 103. calcare.
sulla faccia principale tre ghirlande sono soste-nute da due massicci eroti e da due teste di toro agli angoli. gli eroti poggiano su basi sporgenti. la gamba verso l’interno è flessa e piegata al ginocchio. essi hanno ali distese verso l’alto, disposte ai lati del-la testa, e poggiano ciascuno, da dietro, un braccio sulla ghirlanda. gambe e mani sono massicce. su-gli archi teste di satiro a destra e a sinistra, al cen-tro una rosetta ad altorilievo con petali ad arco. alle ghirlande di frutta sono appesi dei grappoli d’uva. la disposizione delle ghirlande non è rigidamente uniforme. sui lati minori sono eseguite come nel n. 6 solo una mezza ghirlanda e una mezza rosetta, men-tre l’altra metà e il lato lungo posteriore sono lasciati al grezzo. Questo dettaglio, che compare anche nel sarcofago n. 6, rivela una prassi comune nelle of-
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi2011] 51
ficine di afrodisia 17. frutti e foglie sono circonda-ti da un solco di contorno lasciato dal trapano. so-pra le teste di bue e anche sopra quelle degli eroti sono posti dei nodi di eracle. le terminazioni delle tenie pendono con ampie oscillazioni rese a basso rilievo. le forme rigonfie delle ghirlande permetto-no di ipotizzare come per il n. 6 un’epoca precoce di produzione, entro il ii sec. d.c.
Bibliografia: MoutErDE 1944-1946, p. 42 ss., tav. 3; hıM-MELMann 1970a, p. 5 ss., 10, tav. 5 b; Koch 1973, p. 220; — 1977, p. 393 e nota 128.
6. sarcofago a ghirlande. inv. n. 8.500 (tav. XXii b)
coperchio profilato con acroteri non lavorati. cassa: lungh. 235; alt. 108; prof. 115.coperchio: alt. 45. calcare. la metà posteriore dei lati brevi e il retro non sono
lavorati.
due teste di toro e due eroti sostengono come nel n. 5 tre ghirlande. sulle teste di toro si trova-no ampi e molli nodi di eracle; i nastri non sono a rilievo e sono sottolineati solo da una incisione su-perficiale. i loro nastri sporgono diagonalmente in maniera rigida dalle appendici delle ghirlande. i ro-busti eroti si elevano a gambe larghe su una base che sporge di 8 cm. essi poggiano le loro mani mas-sicce da dietro sulle ghirlande. le ali sono dispo-ste obliquamente dietro alle ghirlande che poggia-no sulle loro spalle. alle ghirlande esterne di frutta sono appesi dei grappoli d’uva massicci, arrotonda-ti e allungati nella parte centrale. al di sopra si di-spone una grande foglia di vite. sugli archi ester-ni delle ghirlande sono poste delle rosette di tipo differente; su quella centrale una maschera comi-ca femminile con una treccia a mo’ di corona. sui lati minori, la cui parte posteriore è lasciata al grez-zo, rosette di tipo diverso e una ghirlanda. i moti-vi degli eroti sulla base con tre ghirlande di frutta, su cui si dispongono rosette, gorgoneia, maschere e teste di satiri s’incontrano in cilicia 18, oltre che in esemplari isolati nei Balcani 19. il pezzo viene dalla medesima officina da cui provengono i nn. 5 e 7. tardo ii sec. d.c.
Bibliografia: MoutErDE 1944-1946, p. 42 ss., tav. 2; hıM-MELMann 1970a, p. 5 ss., 10, tav. 4; Koch 1973, p. 220; — 1977, p. 393 e nota 128.
7. sarcofago a ghirlande. inv. n. 8.501 (tav. XXii c)
lungh. 232; alt. 93; prof. 105. calcare. la cornice superiore e quella inferiore sono danneg-
giate.
due eroti stanti su due basi, appoggiati sulla gamba rivolta verso l’interno, mentre quella all’ester-no è flessa. sulle loro spalle sono appese davanti alle loro ali tre ghirlande, che essi circondano da die-tro con il braccio. le loro braccia all’esterno pen-zolano a fianco del corpo come nel n. 5. le ghir-lande sono legate insieme tra loro agli angoli con un nodo di eracle, fissato sopra le teste di toro. le terminazioni delle tenie sono appese ai nodi e inol-tre accanto agli eroti sono rese con ondulazioni a rilievo molto basso. una grande foglia di vite cir-conda, come nei nn. 5 e 6, la parte centrale delle ghirlande; il pesante grappolo d’uva è qui più ap-puntito. sugli archi esterni si trovano gorgoneia ri-gonfi; nell’arco centrale una rosetta. il lato minore sinistro è appena abbozzato; quello destro ribassa-to insieme con il corno sinistro del toro d’angolo. lavoro modesto del iii sec. d.c.
Bibliografia: MoutErDE 1944-1946, p. 42 ss.; hıMMEL-Mann 1970a, pp. 6 e 10, tav. 5 a; Koch 1973, p. 220; — 1977, p. 393 e nota 128; Koch, sıchtErMann 1982, p. 567 (la tav. 576 non riproduce la faccia qui illustrata alla tav. XXii c).
8. sarcofago a ghirlande. inv. n. 9.384 (tavv. XXiii a-XXiv c)
coperchio non pertinente, spezzato. cassa: lungh. 210; alt. 60; prof. 66. coperchio: lungh. 233; alt. 45; prof. 98.
acroteri doppi agli angoli del frontone con quat-tro eleganti volute a rilievo che terminano in nodi, elegantemente sottolineate da una linea di contor-no, su ogni lato. ogni voluta ha una sua partico-lare forma. Nel frontone una rosetta con petali a girandola. sulla faccia anteriore e posteriore della
17 esso compare anche in alcuni dei sarcofagi esposti nel museo di afrodisia.18 Koch, sıchtErMann 1982, pp. 551-552, fig. 540 (a New york, da tarso) e fig. 541 (ad adana, da korykos).19 Koch, sıchtErMann 1982, p. 334, figg. 355-356 (da Viminacium) e p. 335, fig. 357 (da Ratiaria, forse in marmo procon-nesio).
ergÜN lafli - Jutta MeischNer - Maurizio Buora [rda 3552
cassa tra quattro teste di toro tre ghirlande di frut-ta con grappoli d’uva; al di sopra dei gorgoneia. sui lati analoghe ghirlande. sopra le teste di toro fasce rigonfie, mentre le loro terminazioni e i nodi sono resi a rilievo molto basso. le teste di toro e i gor-goneia sono resi in maniera naturalistica, non stiliz-zata. frutta e foglie delle ghirlande si susseguono tra loro in modo piuttosto semplice e monotono. l’esecuzione non mostra l’opera del trapano. ini-ziale ii sec. d.c.
Bibliografia: hıMMELMann 1970a, p. 11 ss., tav. 10 a. b; Koch 1973, p. 220.
9. sarcofago a ghirlande. inv. n. 8.474 (tav. XXv a)
lungh. 220; alt. 100; prof. 104. Marmo dell’asia minore.
due eroti sulla faccia anteriore e quella poste-riore sostengono tre ghirlande di frutta con grappo-li d’uva appesi ad esse. essi ‘volano’ obliquamente verso l’esterno con la gamba esterna piegata all’in-dietro. sulla faccia anteriore sopra la ghirlanda cen-trale una tabula, come in altri sarcofagi dell’asia Minore 20. ai quattro angoli teste di toro con muso legato alle ghirlande. sopra gli archi delle ghirlande laterali si collocano rosette diverse; nel lato princi-pale gorgoneia. sul lato posteriore si dispongono so-pra tutti e tre gli archi delle ghirlande delle rosette. sulle facce laterali ghirlande con grappoli; sugli spi-goli teste leonine con criniera rotonda. i nastri del-le ghirlande sono appesi sopra le teste di toro con nodi di eracle fortemente plastici. in maniera inu-suale le fasce ondulate che sporgono dai nodi di eracle corrono orizzontalmente sulla cornice supe-riore della cassa; ai nodi sono appese, come altre volte, due ulteriori fasce, leggermente concave. le forme colpiscono per la loro tipizzazione astrattiz-zante. si apprezza il loro effetto elegante, ma non la loro naturalezza. gli eroti svolazzando formano quasi una sorta di balletto. la criniera leonina è di-venuta puro ornamento; le terminazioni delle tenie offrono una cornice decorativa. le pigne nelle ghir-lande sono formate da un tratteggio di rombi. l’of-ficina non è attestata ad antiochia da altre opere.
koch e sichtermann ritengono che il sarcofago sia ispirato a modelli attici. i grappoli d’uva che pen-dono all’esterno delle ghirlande, i nodi di eracle e le tenie disposte orizzontalmente tuttavia non com-paiono sui sarcofagi attici. Né le ghirlande né gli eroti sono copiati da modelli attici.
lavoro eccellente del iii sec. d.c.
Bibliografia: hıMMELMann 1970a, p. 10 ss., fig. 8, tav. 3 a; Koch 1973, p. 220; Koch, sıchtErMann 1982, pp. 436, nota 7, 471 e 568.
10. sarcofago delle stagioni. due frammenti. inv. n. 16.280 (tav. XXv b-c)
lungh. 70/82; alt. 30/42; prof. 23/26, spessore del rilievo 7.
a lato del campo centrale stanno tre geni delle stagioni con mantello. a sinistra del campo centra-le sono conservate solo due figure. Quella a destra è disposta frontalmente con nella sinistra una oino-choe. a sinistra viene dietro un genio di tre quarti verso sinistra (di chi guarda), che tiene con la sini-stra un capretto per le corna. il capretto è il sim-bolo corrente per la primavera. a destra del cam-po centrale stanno tre geni. Quello di destra è in piedi, ritto verso l’esterno, con oinochoe nella de-stra; la sua sinistra deve essere stata sollevata come quella dei due geni vicini. il genio centrale è volto di tre quarti verso destra. il genio che segue a sini-stra è disposto frontalmente. il suo mantello scen-de dalle sue spalle, sopra la sinistra fino al ginoc-chio. entrambe le braccia sono sollevate: in esse si possono inserire idealmente canestri di frutta e di fiori. lavoro molto buono di modellazione morbi-da del ventre e del petto.
lo stato frammentario non consente di ricono-scere l’iconografia completa dei geni. troviamo dei geni maschili che rappresentino le stagioni a partire dall’arco di traiano, a Benevento, accanto alle figu-re di vittoria. lì essi si prestano ad esprimere non solo una funzione di propaganda imperiale, ma an-che il concetto di Aeternitas. la loro comparsa sui sarcofagi romani occidentali sembra frequente spe-cialmente nel iii e fino all’iniziale iv secolo, come ha ben messo in evidenza il krantz 21. essi com paio-
20 cfr. un sarcofago di afrodisia, per cui Koch, sıchtErMann 1982, fig. 518 (e p. 528, nota 48, per il catalogo degli esempla-ri micrasiatici) e altro da Pergamo, p. 515, fig. 501.21 Kranz 1984.
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi2011] 53
no anche in sarcofagi cristiani, tra cui si citano ad esempio uno di tipasa e il sarcofago conservato a dumbarton oaks 22.
Prima metà del ii sec. d.c.
Bibliografia: inedito.
11. sarcofago con gli eroti dei dodici mesi. inv. n. 8.475 (tav. XXvi a-c).
lungh. 203; alt. 51; prof. 82. Pezzo non finito del Proconneso.
al di sopra scozia e cornice terminale. anterior-mente su un listello piatto, sporgente, dodici eroti con gli attributi delle stagioni. essi hanno trecce sulla sommità del capo e ricci che arrivano alle orecchie. sono disposti in vari atteggiamenti in corsa o in ri-poso e tengono in mano uno o due attributi. da si-nistra a destra 1. figura non identificabile; 2. ero-te con le braccia abbassate, reca nella mano destra un frutto, nella sinistra un grappolo d’uva; 3. Quel-lo successivo tiene con le mani un’anatra; 4. com-paiono qui una ghirlanda massiccia, sostenuta dalla mano sinistra e un canestro conico con frutta o fio-ri sulla spalla sinistra; 5. gli attributi sono un lago-bolon nella destra protesa e una lepre nella sinistra; 6. canestro di frutta (?) sulla spalla destra; 7. ap-paio no un coltello nella destra e un grande grappolo d’uva nella sinistra piegata; 8. l’erote tiene un frut-to rotondo nella mano destra sollevata; 9. figura un canestro di frutta sulla spalla sinistra; 10. ghirlanda appesa nella mano destra, thyrsos e pietra nel braccio sinistro; 11. l’amorino tiene un fascio di spighe in entrambe le mani; 12. data la presenza di un grande oggetto (?), il braccio sinistro accanto ad esso non ha abbastanza posto. l’ultima figura (n. 12) sporge di molto rispetto al rilievo del lato vicino.
anatra, leprotto e lagobolon caratterizzano l’in-verno; il grappolo d’uva e anche il frutto esibito dall’erote n. 8 simbolizzano l’autunno. i canestri di frutta sono resi malamente come canestri di fiori, mentre le ghirlande alludono alla primavera. il fa-scio di spighe rappresenta l’estate. la combinazio-ne di ghirlanda e tirso dell’erote n. 10 sembra del tutto arbitraria. le proporzioni non sono felici; le
braccia sono troppo lunghe, le gambe troppo cor-te, i grappoli d’uva giganteschi.
lato posteriore: tre ghirlande con grappolo d’uva e rosetta rimasti allo stato di abbozzo effettuato in cava. il lato posteriore mostra l’abitudine tipica del-le officine del Proconneso di esportare lungo la co-sta micrasiatica e in aree più lontane sarcofagi ap-pena abbozzati 23. il sarcofago figura nell’elenco dei prodotti semilavorati esportati dalle officine del Pro-conneso, gruppo i 7, fornito dalla asgari nel 1977.
lati minori: ghirlanda con grappolo d’uva e te-sta di leone, sugli angoli posteriori mezze teste di ariete. – iii sec. d.c.
Bibliografia: hıMMELMann 1970a, p. 12, fig. 9, tav. 8, 9; Koch 1973, p. 220; asgarı 1977, in particolare pp. 361 e 378; Koch, sıchtErMann 1982, pp. 471, 473 e 568, tav. 578.
12. sarcofago a colonne di tipo a dell’asia mino-re con coperchio a kline. inv. n. 18.153 (tavv. XXvii a-XXXii d)
rinvenuto nel 1993 nel corso di lavori stradali nella particella n. 487, di kıslısaray, via harbiye nel centro del-la città di antakya. Nel sarcofago si trovavano due schele-tri femminili e uno maschile; inoltre monete di gordiano iii, gallieno e di salonina come pure un braccialetto in gagate, orecchini d’oro e resti di tessuto purpureo.
cassa: lungh. 247; alt. 120; prof. 123-128. coperchio: lungh. 245/49; alt. 54/100.
i lati lunghi mostrano la suddivisione tipica con una nicchia centrale timpanata e due laterali desi-nenti ad arco. sei colonne con scanalature a torti-glione scandiscono le fronti. la faccia anteriore pre-senta su un piedestallo profilato la coppia degli sposi defunti, disposti agli angoli l’uno di fronte all’altra. a destra siede l’uomo su uno sgabello a zampe leo-nine, coperto da una pelle di leone. egli porta una barba da filosofo, una capigliatura riccioluta, chito-ne e mantello. la destra è levata in alto nel gesto di chi insegna (la sua postura da seduto manca in Wie-gartz; al posto della destra alzata si trova là il rotolo nella sinistra). alla sua sinistra nell’intercolunnio tra la nicchia ad arco e quella timpanata vi è una don-na in chitone e mantello (tipo Wiegartz f 14, ove è identificata con una musa). essa riprende il tipo
22 cfr. ad es. BuDrıEsı 1974; per il sarcofago di dumbarton oaks fondamentale hanfMann 1951; utile in generale anche roDà 1979.23 enorme la bibliografia sull’argomento, dal fondamentale warD PErKıns 1958, attraverso gıuLıano 1962 e fErrarı 1966, fino ai numerosi lavori della asgari, tra cui asgarı 1990. una veloce sintesi in soDını 2002.
ergÜN lafli - Jutta MeischNer - Maurizio Buora [rda 3554
della «grande ercolanese» 24. al centro dinanzi alla nicchia timpanata sta, parimenti in piedi, ma volta a sinistra la figura di un giovinetto nudo con spa-da e mantello (tipo Wiegartz M 16, datato tra 170 e 190). essa è da intendere come il terzo compo-nente della famiglia, ovvero il figlio e l’eroe prova-to in più combattimenti. segue a sinistra una figu-ra maschile, stante, che corrisponde a quella seduta a destra (tipo Wiegartz M 4), che si rivolge come mentore alla donna defunta al bordo sinistro. Que-sta siede con le gambe incrociate su un seggiolino pieghevole con un cuscino. Nell’atteggiamento del-la Pudicitia ella tocca il mantello con la sinistra e poggia il capo sulla mano destra, dall’indice prote-so. Questa figura non ha confronti in altri sarcofa-gi (perciò Wiegartz erroneamente concludeva che l’atteggiamento di filosofo per i defunti sui sarco-fagi tardi non trovava alcuna applicazione per le fi-gure femminili). entrambi gli uomini barbuti por-tano sandali; le donne calzature chiuse. le figure sedute hanno la medesima altezza di quelle in pie-di. il motivo della coppia posta in antitesi l’una di fronte all’altro agli angoli sopravvive nel così detto “motivo licio” che non presenta alcuna figura ag-giuntiva, ma solo una tabula ansata.
la parte posteriore reca nella nicchia timpanata centrale una caccia al leone a cavallo, con l’accom-pagnamento di cani. a destra e a sinistra in atto di procedere verso l’esterno stanno in posizione anti-tetica i dioscuri, vestiti di un chitone, fermato da una cintura, e di un mantello. essi conducono i loro cavalli verso l’esterno e sono accompagnati da cani. sul fianco rivolto all’interno portano lunghe lance. i dioscuri (= gemelli) sono le divinità della costel-lazione dei gemelli, simbolo di luce e di armonia. il cavaliere e i dioscuri poggiano ciascuno su basi con diverso profilo, mentre i due compagni di cac-cia sono posti sul pavimento tra le nicchie. Quello a sinistra tiene cornucopia e lancia, quello a destra il tirso e le redini del cavaliere che caccia il leone. tutte le cinque figure portano alte calzature. su en-trambe le facce in leggero rilievo compaiono sui
pennacchi delle nicchie eroti, animali, piante e gor-goneia. l’architettura del fondo nel lato posteriore ha la funzione di suddividere lo spazio più che sul-la faccia principale.
sul lato minore di destra compare il motivo del-la porta dell’ade 25 con la coppia degli sposi che sta effettuando un sacrificio. l’uomo tiene la patera nel-la destra protesa, nella sinistra un rotolo, che egli porta sotto la piega del mantello (sorprendentemen-te sulla faccia principale alla figura seduta manca il rotolo. i vari personaggi seduti della tipologia del Wiegartz lo tengono sempre nella sinistra). la don-na velata a sinistra tiene nella sinistra una acerra, su cui appoggia l’indice della mano destra. tra la por-ta e la figura femminile stante è raffigurata una pic-cola vittima sacrificale, posta frontalmente. dinanzi alla porta, su un tavolino a zampe di leone, sta un piccolo altare, su cui arde una fiamma. fiamma e gambe del tavolo sono lavorate a giorno; sono sta-ti lasciati ponticelli di marmo sulla tavola del sacri-ficio e sulla testa dell’ariete; alle pareti della porta si appoggia il piccolo altorilievo. Non sappiamo se queste persone partecipino al sacrificio funebre per i morti, come opina r. Özgan, o se siano gli stessi defunti presentati nell’atto di sacrificare. le figure e le architetture poggiano su una base comune, dal complesso profilo.
il lato minore sinistro presenta tre figure allun-gate, stanti: al centro la donna velata, di nuovo nel motivo della Pudicitia e con l’indice proteso; a sini-stra un giovinetto nudo eroizzato, con mantello ma senza spada; a destra il cavaliere della faccia poste-riore. Manca qui la figura seduta della faccia prin-cipale, in atto di insegnare, il marito e padre. la donna poggia su una base quadrangolare, gli uomi-ni su basi rotonde. le quattro colonne danno l’im-pressione di essere poste sui quattro lati di un edi-ficio quadrato. Non è riuscito il collegamento della base sinistra con la colonna d’angolo vicina.
la copertura a kline sostiene la coppia dispo-sta su un materasso. Manca la parte superiore del corpo dell’uomo, che tiene nella sinistra un testo
24 sul tipo scultoreo della ‘grande ercolanese’, già concordemente ritenuta replica di un originale greco del iv sec. a.c., fon-damentale BıEBEr 1962, poi ripreso dalla stessa in BıEBEr 1977, pp. 148-162. sulla popolarità del tipo in asia Minore si veda ataLay 1989, p. 77 ss., figg. 28-31. Per le recenti opinioni che fanno risalire i tipi della ‘large’ e ‘small herculaneum Woman’ o ‘girl’ a una creazione ellenistica si vedano, da ultimo DaEhnEr 2007, la quale menziona 196 copie del tipo, e infine Kous-sEr 2008, in particolare pp. 142-145.25 sulla rappresentazione di porte a rilievo: haarLØv 1977, pp. 9 ss.; waELKEns 1982, pp. 109-123; — 1986, dove tale deco-razione sui sarcofagi viene interpretata come porta di ingresso alla camera funeraria e non come porta degli inferi. secondo il Waelkens, le porte a rilievo avrebbero origine frigia.
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi2011] 55
arrotolato. il capo della donna è appena abbozza-to. agli angoli del materasso siedono degli eroti a grandezza naturale; al centro dinanzi al bordo del coperchio un gruppo di eroti di dimensioni ridot-te in posizione di lotta. agli angoli anteriori teste di cavallo e a quelli posteriori teste di Pan. la par-te posteriore e i lati minori del fulcrum sono deco-rati a cassettoni.
lo schema generale della faccia principale cor-risponde al così detto ‘Normaltypus’ creato secon-do koch e sichtermann intorno al 160 e rimasto in uso per un secolo 26. esso è ben rappresentato dal sarcofago di Perge (inv. n. 1005) del Museo di an-talya, con cui ha in comune molti caratteri, tra cui l’atteggiamento dei coniugi, la posizione degli eroti (mancano però qui quelli piccoli, al centro), il lem-bo della veste che scende sul materasso, le sporgen-ze lisce del soffitto a cassettoni nella parte inferiore del coperchio, la decorazione architettonica, mentre sono variate le figure che hanno in comune l’accon-ciatura degli uomini e delle donne. la lavorazione a giorno degli elementi decorativi corrisponde esat-tamente a quella del sarcofago di tipo sidamara di istanbul, che fu realizzato verso il 260 d.c. 27. Per-tanto anche la data di esecuzione del sarcofago di antakya va fissata allo stesso torno di tempo.
il tipo corrisponde ai sarcofagi a colonne che sa-rebbero stati prodotti nelle officine di Doki meion. da questa località, posta in anatolia, dopo un viag-gio anche via mare, il sarcofago non completato nei particolari sarebbe giunto ad antiochia, secon-do esen Ögüs. le monete d’oro di gallieno tro-vate nel sarcofago, col suo secondo tipo di ritratto monetale – oltre a una di gordiano iii – indicano solo che il sarcofago fu chiuso l’ultima volta qualche anno dopo il 260 d.c. (tav. XXXi). un manierismo proprio del periodo anteriore alla tetrarchia si rive-la qui nelle tre figure allungate con collo cilindrico del lato minore sinistro. anche i rinvenimenti all’in-terno del sarcofago appartengono alla seconda metà del iii sec. d.c. (tav. XXXii). – 260/270 d.c.
Bibliografia: özgan 2000, figg. 1-4 e 10; KonDoLEon 2000, p. 103; ögüs 2004. Per il tipo cfr. strocKa 1971; wıEgartz 1965, pp. 30 ss., 156 ss., tavv. 7 c, f; p. 34; öz-gan 2000, p. 373, fig. 6.
Conclusioni
si offre qui una documentazione fotografica completa dei più significativi sarcofagi provenien-ti dalle necropoli della romana Antiocheia; la cui esatta provenienza peraltro non è documentata. Nel 1921 edmund spense Bouchier scriveva che «seve-ral sarcophagi of the roman age also exist, carved with genii, Medusa or bull’s heads, garlands, palm branches, rosettes, ram’s horns, etc.» 28. alcuni di questi hanno ora un’edizione completa. il sarcofa-go del tipo ‘sidamara’, rinvenuto nel 1993, attesta l’arredo pretenzioso delle necropoli cittadine anco-ra nel iii sec. d.c. in due casi (nn. 1 e 3) vedia-mo l’ingresso nel programma decorativo di motivi totalmente atipici. vi fu dunque il soddisfacimen-to di richieste particolari: in un caso un atleta con la palma del vincitore (n. 3) figura già presente nel repertorio dell’officina attica; in un altro (n. 1) su un sarcofago attico di importazione. Queste osser-vazioni se paragonate alla scarsa documentazione ar-cheologica sulla metropoli siriaca gettano una luce considerevole sulla comprensione della sua autoco-scienza urbana. in conclusione possiamo concorda-re con gary vikan secondo il quale «surviving ev-idence in and around antiochia leaves non doubt that the demand of sarcophagi in this area was satis-fied by local manifacturers as well by imports from several centers» 29. lo stesso giudizio era già stato espresso da koch e sichtermann nel 1982. in qual-che modo possiamo su questo dare ragione al cit-tadino di antiochia ammiano Marcellino il quale definisce la città – ovviamente al suo tempo, ovve-ro nel iv secolo d.c. – «nota a tutto il mondo, con cui nessun’altra può rivaleggiare per la quantità di beni importati o locali» 30.
ora sulla base di una attenta analisi stilistica pos-siamo affermare che in città giunsero sarcofagi dal-le officine attiche (in parte anche rilavorati local-mente) (qui n. 1-3), altri semilavorati dall’area delle cave del Proconneso e dalle relative officine (n. 11) con successiva lavorazione e completamento locale: tuttavia la maggior parte dei sarcofagi qui esamina-ti pare scolpita direttamente ad antiochia dall’ini-ziale ii sec. fino al 260 circa d.c.
26 Koch, sıchtErMann 1982, pp. 503-505 e fig. 488.27 istanbul n. 1179, per cui wıEgartz 1965; Koch, sıchtErMann 1982, p. 548 («etwa 250/260 n. chr.»).28 sPEnsEr BouchıEr 1921, p. 6.29 vıKan 1995, p. 12.30 aMM. Marc., Xiv, 8.
ergÜN lafli - Jutta MeischNer - Maurizio Buora [rda 3556
BIBlIoGRAFIA
aLtMann W. 1905, Die römischen Grabaltäre der Kaiserzeit, Berlin.
asgarı N. 1977, Die Halbfabrikate kleinasiatischer Girlan-densarkophage und ihre Herkunft, AA 3, pp. 329-380.
asgarı N. 1990, objects de marbre finis, semi-finis et ina-chevés de Proconnèse, in Pierre éternelle du Nil au Rhin: carrière et préfabrication, M. Waelkens (ed.), Bruxelles, pp. 106-126.
ataLay e. 1989, Weibliche Gewandstatuen des 2. Jahrhun-derts n. Chr. aus ephesischen Werkstätten, Wien.
BıEBEr M. 1962, The Copies of the Herculaneum Women, Proceedings of the American Philosophical Society 106, Phil-adelphia, pp. 11-134.
BıEBEr M. 1977, Ancient Copies. Contributions to the Histo-ry of Greek and Roman Art, New york.
BuDrıEsı r. 1974, Il sarcofago con Geni delle stagioni nel Par-co archeologico di Tipasa (Algeria), in Atti del III Congresso nazionale di archeologia cristiana, trieste, pp. 497-518.
casarı P. 2004, la decorazione architettonica del portico fo-rense di Aquileia: analisi e riflessioni, AAAd 59, pp. 217-256.
DaEhnEr J. 2007, The Herculaneum Women: History, Con-text, Identities, New york-dresden.
DownEy g. 1959, libanius’ oration in Praise of Antioch (oration XI), Proceedings of the American Philosophical So-ciety 103, 4, Philadelphia, pp. 652-686.
ELDErKın g. W. et alii 1934, Antioch-on-the-orontes, 1, The excavation of 1932, Princeton.
fErrarı g. 1966, Il commercio dei sarcofagi asiatici, roma.
förstEr r. 1898, JdI 13, pp. 185-187.
gıuLıano a. 1962, Il commercio dei sarcofagi attici, roma.
gıuLıano a., PaLMa B. 1978, la maniera ateniese di età ro-mana. I maestri dei sarcofagi attici («studi miscellanei» 24, 1975-1976), roma.
haarLØv B. 1977, The Half-open Door: A Common Symbol-ic Motif within Roman Sepulchral Sculpture («odense uni-versity classical studies» 10), odense.
hanfMann g. M. a. 1951, The Season Sarcophagus in Dum-barton oaks (Cambridge, MA), harvard university Press.
hıMMELMann N. 1970a, Sarkophage in Antakya, Mainz («ab-handlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen klas-se» 9).
hıMMELMann n. 1970b, Der Sarkophag aus Megiste, Mainz («abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen klasse» 1).
hıMMELMann N. 1971, Sarkophage in Antakya und Bericht über eine Reise nach Kleinasien, AA, pp. 92 ss.
ısıK f. 1977, Zur Datierung des verschollenen Girlandensar-kophag aus Alasehir, AA 3, pp. 380-383.
Koch g. 1973, Rez. zu N. Himmelmann, «antakya», Gno-mon 45, pp. 220-222.
Koch g. 1977, Sarkophage im römischen Syrien, AA 3, pp. 388-395.
Koch g. 1989, Der Import kaiserzeitlicher Sarkophage in den römischen Provinzen Syria, Palästina und Arabia, BJb 189, pp. 163-211.
Koch g. (ed.) 1993, Grabeskunst der römischen Kaiserzeit, Mainz.
Koch g., sıchtErMann h. 1982, Römische Sarkophage, Mün-chen («handbuch der archäologie» 7).
KonDoLEon c. 2000, Antioch. The lost Ancient City, cata-logo della Mostra di Worcester, cleveland, Baltimore, Prin-ceton, N.J.
KoussEr r. M. 2008, Hellenistic and Roman Ideal Sculptures: the Allure of the Classical, New york.
Kranz P. 1984, Die antiken Sarkophagreliefs, 5, 4. Jahreszei-ten-Sarkophage. Entwicklung und Ikonographie des Motivs der vier Jahreszeiten auf kaiserzeitlichen Sarkophagen und Sar-kophagdeckeln, Berlin.
LafLı E., MEıschnEr J. 2008, Hellenistische und römische Grabstelen im Archäologischen Museum von Hatay in Anta-kya, ÖJh 77, pp. 145-184.
MEıschnEr J. 2003, Die Skulpturen des Hatay Museums von Antakya, JdI 118, pp. 285-339.
MEıschnEr J., E. LafLı 2008, Die Girlanden attischer Sarko-phage und der Sarkophag Caffarelli, BABesch 83, pp. 155-170.
MoutErDE r. 1944-1946, Antiquités et inscriptions (Syrie, li-ban), MUSJ 26, pp. 37-79.
ögüs e. 2004, The Antakya Sarcophagus: Aspect and Deco-ration, Transportation and Dating, Bilkent University. The Department of Archaeology & History of Art, Newsletter 3, pp. 28-31.
ØstErgaarD J. 1996, Cat. Ny Carlsberg Glyptotek. Imperial Rome, kopenhagen.
özgan r. 2000, Säulensarkophage und danach, IstMitt 50, pp. 365-387.
rEınach s. 1912, Répertoire de reliefs, Paris.
roDá i. 1979, Un nou sarcòfag romà de la província de Ter-ragona, Epigraphica 41, pp. 59-65.
roggE s. 1993, Tektonik und ornamentik attischer Sarko-phage, Studien zur Chronologie dieser Denkmälergattung, in Koch 1993, pp. 111-132.
roggE s. 1995, Die Sarkophage Griechenlands und der Do-nauprovinzen. Die attischen Sarkophage. Achill und Hippoly-tos, Berlin (ASR iX 1, 1).
schauEnBurg k. 1995, Die stadtrömischen Eroten-Sarkopha-ge. Zirkusrennen und verwandte Darstellungen, ASR v 2, 3, Berlin.
soDını J.-P. 2002, Marble and Stoneworking in Byzantium, Seventh-Fifteenth Centuries, in The Economic History of By-zantium: from the Seventh through the Fifteenth Century, a. e. laiou (ed.), «dumbarton oak studies» 39, pp. 129-146.
Nuove coNsiderazioNi su alcuNi sarcofagi2011] 57
sPEnsEr BouchıEr e. 1921, A Short History of Antioch, 300 B.C. - A.D. 1268, oxford-london.
stıLLwELL r. 1938, Antioch-on-the-orontes, 2, The excava-tions, 1933-1936, Princeton.
stıLLwELL r. 1941, Antioch-on-the-orontes, 3, The excava-tions 1937-1939, Princeton.
strocKa v. 1971, Kleinasiatische Klinensarkophag-Deckel, AA, pp. 62-86.
vıKan g. 1995, Catalogue of the Sculpture in the Dumbar-ton oaks Collection from the Ptolemaic Period to the Ren-aissance, Washington, d.c.
waagé d. B. 1941, Antioch-on-the-orontes, 4, pt. i, Ceram-ics and Islamic Coins, Princeton.
waagé d. B 1952, Antioch-on-the-orontes, 4, pt. ii, Greek, Roman, Byzantine and Crusaders Coins, Princeton.
waELKEns M. 1982, Dokimeion. Die Werkstatt der repräsen-tativen kleinasiatischen Sarkophage. Chronologie und Typo-logie ihrer Produktion, Berlin («archäologische forschun-gen» 11).
waELKEns M. 1986, Die kleinasiatischen Türsteine. Typolo-gische und epigraphische Untersuchungen der kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheintür, Mainz.
warD PErKıns J. B. 1958, Roman Garland sarcophagi from the Quarries of Proconnesus, Washington, d.c.
wıEgartz h. 1965, Kleinasiatische Säulensarkophage, Berlin («istanbuler forschungen» 26).
wıEgartz h. 1975, Kaiserzeitliche Reliefsarkophage in der Nikolaoskirche, in Myra. Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, J. Borchhardt et alii (edd.), Berlin («istanbuler forschungen» 30), pp. 161-251.
TAV. XIV [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a) Sarcofago n. 1, Inv. n. 9.576, lato anteriore (archivio di V. Vaelske, Berlin); b) Sarcofago n. 1, Inv. n. 9.576, lato posteriore (foto E. Laflı, 2005)
a)
b)
[RdA 35, 2011] TAV. XVLAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a)
b) c)
Sarcofago n. 1, Inv. n. 9.576: a) angolo destro, lato posteriore; b) fianco destro; c) fianco sinistro. (Archivio di V. Vaelske, Berlin)
TAV. XVI [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
Sarcofago n. 2, Inv. n. 15.948: a) angolo destro, lato anteriore (archivio di V. Vaelske, Berlin);b) lato principale, particolare (foto E. Laflı, 2005); c) lato principale, particolare (archivio
di V. Vaelske, Berlin)
a)
b)
c)
[RdA 35, 2011] TAV. XVIILAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
Sarcofago n. 2, Inv. n. 15.948: a) lato posteriore; b) lato principale, particolare;c) lato posteriore, particolare. (Archivio di V. Vaelske, Berlin)
b)
a)
c)
TAV. XVIII [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a) b)
Sarcofago n. 2, Inv. n. 15.948: a) lato destro, particolare (Archivio diV. Vaelske, Berlin); b) lato sinistro (Archivio di V. Vaelske, Berlin);
c) lato destro, faccia principale (foto E. Laflı 2005)
c)
[RdA 35, 2011] TAV. XIXLAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
b)
Sarcofago n. 3, Inv. n. 8.473: a) lato principale e fianco destro (archivio di V. Vaelske, Berlin); b) lato anteriore (foto E. Laflı, 2005)
a)
TAV. XX [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
b)
a)
Sarcofago n. 3, Inv. n. 8.473: a) lato posteriore; b) lato posteriore, particolare(Archivio di V. Vaelske, Berlin)
[RdA 35, 2011] TAV. XXILAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a)
Sarcofago n. 4, Inv. n. 8.472: a) lato principale; b) lato destro fronte(Archivio di V. Vaelske, Berlin)
b)
TAV. XXII [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a)
c)
a) Sarcofago n. 5, Inv. n. 8.502, lato principale (Archivio di V. Vaelske, Berlin); b) Sarcofago n. 6, Inv. n. 8.500, fronte (foto E. Laflı, 2005); c) Sarcofago n. 7, Inv. n. 8.501, fronte (foto E. Laflı, 2005)
b)
[RdA 35, 2011] TAV. XXIIILAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a)
b)
Sarcofago n. 8, Inv. n. 9.384: a) fronte (foto E. Laflı, 2005); b) angolo sinistro (archivio di V. Vaelske, Berlin)
TAV. XXIV [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a)
b)
c)
Sarcofago n. 8, Inv. n. 9.384: a) lato posteriore; b) lato posteriore, particolare; c) lato sinistro (foto E. Laflı, 2005)
[RdA 35, 2011] TAV. XXVLAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a) Sarcofago n. 9, Inv. 8.474, lato sinistro, fronte (foto E. Laflı, 2005); b-c) Sarcofago n. 10, Inv. n. 16.280, campo centrale (foto E. Laflı, 2005)
b)
c)
a )
TAV. XXVI [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
Sarcofago n. 11, Inv. n. 8.475: a) angolo sinistro, fronte (archivio di V. Vaelske);b) lato posteriore; c) fianco sinistro (foto E. Laflı, 2005)
a)
b)
c)
[RdA 35, 2011] TAV. XXVIILAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
b)
a)
Sarcofago n. 12, Inv. n. 18.153: a) fronte; b) lato posteriore (foto E. Laflı, 2005)
TAV. XXVIII [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
Sarcofago n. 12, Inv. 18.153: a) fronte, particolare; b) fianco destro, particolare (foto E. Laflı, 2005)
a)
b)
[RdA 35, 2011] TAV. XXIXLAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a)
b)
a-b) Sarcofago n. 12, Inv. n. 18.153: lato posteriore, particolare (foto E. Laflı, 2005)
TAV. XXX [RdA 35, 2011] LAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
b)
Sarcofago n. 12, Inv. n. 18.153: a) fianco sinistro; b) coperchio (foto E. Laflı, 2005)
a)
d)
[RdA 35, 2011] TAV. XXXILAFLI, MEISCHNER, BUORA - NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNI SARCOFAGI
a-e) Sarcofago n. 12, Inv. n. 18.153, monete d’oro (foto E. Laflı, 2005)
a) b)
c) d)
e)