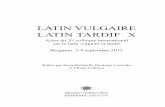Il tema del conflitto balcanico in alcuni scrittori emigrati in Italia ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il tema del conflitto balcanico in alcuni scrittori emigrati in Italia ...
Università degli studi di Roma «LaSapienza»
Il tema del conflitto balcanicoin alcuni scrittori emigrati in
Italia dal 1990
di Barbara Ronca
Corso di laurea in letteratura musicae spettacolo
anno accademico 2003/2004
Relatore: Armando Gnisci
I
Gli anni Novanta del XX secolo si aprono e si chiudono
sulle date di inizio e fine1 di una delle più recenti e tragiche
diaspore europee: quella dai Balcani.
Scatenatosi nella ex-Jugoslavia un feroce conflitto etnico,
molte nazioni europee hanno assistito all’arrivo disperato di
migliaia di profughi in fuga da genocidi e violenze che
sembravano ormai cancellati dalla memoria del vecchio
continente.
La Bosnia detiene il triste primato di essere il primo
paese europeo ad aver avuto campi di sterminio e di
concentramento sul suo territorio dopo la fine della seconda
guerra mondiale.
Il “cuore dell’Europa” ha vissuto, negli anni tra il 1991 e
il 1999, una delle pagine più buie della storia recente, a seguito
della quale la federazione Jugoslava ha cessato di esistere, e
con essa sono scomparsi i delicati equilibri che avevano
permesso ad una popolazione etnicamente e religiosamente
eterogenea di convivere pacificamente per quasi 70 anni.
Eppure, questo ex stato federale che per alcuni decenni
aveva reso possibile il sogno di una compagine statale
multietnica, tollerante e pacifica, meritava forse – lo dice
anche Predrag Matvejevi – un diverso destino; ć seppur
cosciente di quello che profetizzava Ivo Andric nella sua
Lettera del 1920, e cioè che i Balcani comprendevano un
mosaico di etnie e popolazioni che amavano ardentemente la
propria terra, “ma in tre o quattro modi che si escludono a
1 In realtà, la diaspora balcanica non può dirsi conclusa dopo il 1999, continuando infattiancora oggi: le due date indicate sono però quelle in cui si è concentrato il maggior numerodi migrazioni.
IV
vicenda, e si scontrano frequentemente, con un fervore che
genera un'ostilità senza tregua”, l'Europa è rimasta incredula e
impotente di fronte agli eccessi di furore esplosi nel 1991.
I Balcani sono stati abbandonati a se stessi come se non
fossero l'Oriente del nostro mondo, ma un ricettacolo di orrori
con cui il nostro civile continente, sempre più volto ad
Occidente, non doveva confondersi.
Eppure, a pochi anni dalla fine del conflitto che ha
insanguinato questa regione, è necessario tornare a parlare
della sua importanza culturale e storica; i Balcani sono di per
sé un crocevia, una linea di demarcazione, tra Oriente e
Occidente, tra Cristianesimo e Islam, tra Cattolicesimo e
Ortodossia, tra i resti di imperi sopranazionali e conquistatori,
come il turco e l’asburgico, tra capitalismo e comunismo, tra
paesi sviluppati e in via di sviluppo.
Questa regione ha dimostrato nei secoli “una tenace
volontà di superare la maledizione di ‘eterne
contrapposizioni’”2, e nel momento in cui è caduta vittima di
una dilagante miopia politica volta all’omogeneizzazione
culturale, ci ha mostrato come “la negazione dell'Altro spesso
significa la mutilazione del proprio essere storico, del proprio
vissuto, della complessità culturale insita nell'identità culturale
europea.”3
Se è vero, come sostiene Predrag Matvejevic, che
l’Europa degli stati nazionali lascia spazio ad un’Europa
sopranazionale, di questa i Balcani sono stati, e possono
ancora essere, un banco di prova.
2 Melita Richter, “Due note sull’identità”, in «Sagarana»,http://www.sagarana.net/rivista/numero16/hibridazioni1.htm/
3 Melita Richter, op. cit.
V
Ho scelto di sottolineare l’importanza culturale di questa
terra di confine attraverso le opere degli scrittori migranti che
dai Balcani sono arrivati in Italia (e hanno cominciato a
scrivere nella nostra lingua, inserendosi quindi nel solco della
nostra letteratura) perché la loro produzione letteraria mi
sembra rivestire una particolare importanza.
Prima di tutto, perché, come ogni scrittore migrante, essi,
vivendo in un paese diverso da quello in cui sono nati, e
scrivendo in una lingua diversa da quella dell’infanzia, si
pongono come punti di raccordo, e d’incontro, tra realtà
culturali diverse ed eterogenee. Lo “straniamento” di cui sono
vittime (l'ostranenie di cui parlava Josif Brodskij) costituisce
un terreno straordinariamente fertile per la creazione artistica:
il migrante vive in equilibrio tra i mondi, tra il paese di
partenza e quello di arrivo, e li modifica e arricchisce
entrambi.
In secondo luogo, perché i migranti che hanno
abbandonato la ex-Jugoslavia in fiamme non hanno operato
una scelta, per quanto dolorosa o sofferta: hanno agito per
necessità, fuggendo da un paese in cui non potevano più essere
davvero se stessi, e in cui la loro identità, e la loro vita, non
potevano più essere difese.
Per le migliaia di profughi dei Balcani, la migrazione ha
assunto i caratteri di un esilio, perché la guerra li ha privati
(oltre che del presente, del passato e della speranza per il
futuro) di un paese a cui tornare, o verso cui, semplicemente,
proiettare il desiderio del ritorno.
La scelta letteraria è diventata, per chi ha visto il proprio
mondo e la propria identità culturale cancellati con violenza,
una scelta di dissidenza, e quindi di resistenza.
VI
Gli scrittori della diaspora balcanica sono il monito più
forte contro chi difende particolarismi ed erige barriere, e la
dimostrazione più convincente del potere salvifico della
letteratura: portando con sé la propria testimonianza, essi
hanno salvato se stessi e ciò che rimane del proprio paese
dall’oblio.
Nel presentare la situazione balcanica, cercando di
illustrare la complessità e la ricchezza culturale, politica e
sociale della regione, mi sono servita dei testi di Predrag
Matvejević, intellettuale che da anni vive “tra asilo ed esilio”,
e che dal 1994 ha fatto dell’Italia la sua patria d’adozione.
Opponendosi, con le proprie opere, ad ogni forma di tirannia
politica ed egemonia culturale, egli propone una nuova
definizione dell’Europa, che non si rassegni alla
massificazione e alla sopraffazione.
I testi su cui è stata basata l’analisi critica sono i racconti
e i romanzi del bosniaco Božidar Stanišić e delle croate Vera
Slaven e Tamara Jadrejčić (molti dei racconti di questa
scrittrice sono ancora inediti in Italia, e sono stati citati con il
consenso dell’autrice).
La scelta di questi testi, e di questi autori, ha seguito
diversi criteri: gli scrittori le cui opere sono state analizzate
sono tutti emigrati in Italia dopo il 1990; i testi considerati
sono stati scritti, con qualche eccezione per quanto riguarda
Stanišić, in italiano, e si è scelto di considerare scrittori che
avessero prodotto un numero di opere non troppo esiguo.
Fondamentale è stata infine una considerazione riguardo
al contenuto delle opere stesse: il tema del conflitto balcanico è
infatti centrale in tutte quelle prese in considerazione.
VII
1 La letteratura della migrazione.
Nella prefazione al libro di racconti di Božidar Stanišić
Bon Voyage4, Paolo Rumiz parla di una “geniale
mistificazione” che Benito Mussolini compì quando fece
scolpire, sul palazzo dell’ Eur a Roma, l’inno agli Italiani
“santi e navigatori”.
L’ultimo dei mestieri citati, fa notare Rumiz, è
“trasmigratori”: non “emigranti”, che faceva troppo pensare “a
valigie di cartone”, sventurate traversate transoceaniche e
miseria senza fine che costringe ad abbandonare una vita per
iniziarne un’altra chissà dove e chissà come, ma
“trasmigratori”.
La mistificazione geniale consiste proprio in questo:
nell’aver rovesciato, con abile mossa linguistica, il significato
di intere esistenze: non si parlava più di vite spezzate di
disorientati sofferenti in cerca di fortuna, ma di virili corse
incontro al futuro, di entusiastici balzi verso una nuova
avventura.
Provocatoriamente, Rumiz suggerisce allora di rivalutare
il vocabolo mussoliniano: “Ma sì, torniamo a questa parola
fascista. Può aiutarci a chiamare allo stesso modo quelli che
partono e quelli che arrivano. Capire che viaggiatori e
profughi, immigrati ed emigranti, fanno parte della stessa
macchina maledetta. Trasmigratori, vivaddio.”
4 Božidar Stanišić, Bon voyage, Nuova Dimensione, Portogruaro, , 2003, p.8
IX
1. 1 Immigrati, migranti, trasmigratori
Riporto volentieri la provocazione nel momento in cui mi
accingo a parlare del profondo e fruttifero cambiamento –
sociale e politico, senza dubbio, ma anche culturale - avvenuto
al nostro paese da quando, da qualche anno a questa parte, da
terra di “emigranti” ci siamo trasformati in terra di
“immigrati”.
A differenza di altri paesi europei, che all’arrivo della
prima ondata migratoria hanno assistito negli scorsi decenni, e
della cui importanza e portata culturale non sempre si sono
accorti per tempo, noi Italiani abbiamo l’enorme privilegio di
veder compiersi questo fenomeno proprio sotto i nostri occhi, e
di parteciparvi.5
La realtà della migrazione, che riveste caratteri di
tragicità assoluta per chi la vive in prima persona, è però
straordinariamente promettente, dal punto di vista culturale,
per noi che la vediamo accadere.
A differenza di quanto avvenne ai “nostri” migranti, agli
Italiani che andarono nel mondo e non ebbero portavoci
(cantori, artisti) che potessero testimoniarne la “diaspora
planetaria”6, i nostri nuovi interlocutori portano con sé anche
un gran desiderio di narrare la propria esperienza, di
5 Una precisazione riguardo la definizione mi sembra d’obbligo: nell’introduzione alla suaraccolta di saggi “Creolizzare l’Europa”, Armando Gnisci fa notare che, se parliamo diqualcuno che abbandona il proprio paese per ricominciare la propria esistenza altrove, propriodi prima ondata migratoria si tratta, e non di prima generazione, definizione che identificapiuttosto i figli nati in Italia da coloro che arrivano ora nel nostro paese.6 Armando Gnisci, Creolizzare l’Europa, Meltemi, Roma, 2003, p. 10
X
testimoniare il “pressappoco”, il “perenne stato di
sospensione”7 in cui il migrante vive.
Nasce quindi con loro una nuova forma di letteratura,
elaborata nella nostra lingua da autori provenienti dai quattro
angoli del globo terrestre (o, per essere più precisi, da
quell’asse migratorio che va dal Sud-Est al Nord-Ovest del
mondo), e che si presenta non come provinciale
particolarismo, né come esotica appendice di quella
Weltliteratur (letteratura del mondo) ormai più o meno
appiattita sulle logiche di mercato; piuttosto, come nuova
frontiera della Worlds’ Literature (letteratura dei mondi) che
rappresenta, secondo una definizione gnisciana, la “poetica
dell’avvenire”.
1.2 Tra “qui” e “altrove”: una vita in equilibrio
Ma chi è, in definitiva, lo scrittore migrante?
Almeno tre sono gli elementi che lo definiscono:
1. vive in un paese diverso da quello in cui è
nato.
2. sceglie la lingua di arrivo come lingua
letteraria.
3. vivendo nella memoria la prima parte della
propria vita, che ha definitivamente
abbandonato, si pone come ponte, punto di
raccordo tra la cultura da cui proviene e
quella in cui è stato – più o meno – accolto;
7 Tahar Lamri, “E della mia presenza; solo il mio silenzio. Una riflessione lunga cinqueantologie”, introduzione a Parole oltre i confini, sul sito www.eksetra.net/database/texts_body.php?code=0128&file=parole_in_04.html
§§
XI
E’ ovvio che questa semplificazione non permette
di cogliere tutte le sfumature insite in una condizione
esistenziale e culturale di delicatezza estrema; sono però
presenti, già in queste poche righe, alcune delle caratteristiche
fondamentali dello scrittore migrante, che rendono il suo
scrivere così prezioso per noi lettori/ospiti.
Prima di tutto, lo scrittore migrante vive diviso tra la
prima parte della vita, spesa in “un altrove che era, e rimane,
comunque patria, e la seconda”, vissuta “da qualche anno in
una lingua nuova”8.
Ricordando che parliamo di scrittori di prima ondata, e
seguendo il loro peregrinare, è evidente l’assoluta unicità della
loro condizione: perché a chi attraversa mari per giungere nella
nostra patria, “nel distacco si spezza la vita in due tronconi
(…): il primo resta sulla riva del paese del passato, e l’altro
cresce sulla costa ancora ignota del paese del dopo.”9
La partenza divide la vita in due “blocchi esistenziali”
che non sempre hanno lo stesso peso, pur risultando magari,
alla fine, quantitativamente uguali.
Nel suo saggio I viaggi e la letteratura10, Domenico
Nucera analizza l’etimologia del verbo “partire”. Esso deriva
da latino pars, partis, cioè “parte, frazione”; ha quindi in sé,
implicito, il senso della separazione, del distacco, termini che
in genere troviamo applicabili alla morte, alla “dipartita”.
Eppure, dice ancora Nucera, dalla stessa radice viene il
verbo parere, cioè “partorire”. “Partire significa abbandonare
uno stato, nel senso di condizione, per cercarne un altro;
lasciare qualcosa di sé alla ricerca di una rinnovata identità.
8 Armando Gnisci, Creolizzare l’Europa, Meltemi, Roma, 2003, p. 7 9 Armando Gnisci, op. cit, p. 1010 Domenico Nucera, “I viaggi e la letteratura”, in Introduzione alla letteratura comparata, a
cura di Armando Gnisci, Bruno Mondadori, Milano, 1999, p. 120
XII
(…) Nell’atto del partire è quindi contenuta una morte e poi
una nascita, una separazione e poi il tentativo di
congiungimento con il futuro”.
Tanto più se la partenza, come spesso accade nel caso del
migrante, non prevede un ritorno, ma una nuova esistenza da
innestare sulle macerie della vecchia, abitando un altrove e una
nuova lingua.
L’impossibilità di tornare nel proprio paese costituisce
uno dei fardelli del migrante; preda della nostalgia, vede la
patria abbandonata come “un mondo intatto nel quale,
qualunque cosa succeda, rimane vuoto un posto destinato a
lui”11; nella sua disperata ricerca di un punto fermo, egli –
soprattutto se è uno scrittore – costituirà nella sua mente
l’immagine poetica della patria abbandonata, stregato da
quella che Kundera definisce “la grande magia del ritorno”.12
Sospeso tra un passato che “rimorde” in senso
demartiniano e un futuro immerso nell’incertezza, il migrante
soffre doppiamente l’allontanamento dalle proprie radici, da
tutto ciò che costituisce una solida definizione di sé.
La perdita culturale diviene quindi anche esistenziale:
“solo nella mia terra – scrive Predrag Finci – io sono padrone
del mio destino, non importa quanto miserabile esso sia”13.
Andare altrove significa lottare per ricostruire un’identità
perduta, sentirsi esclusi da una cultura che non ci appartiene e
che ci ricorda in ogni momento che siamo stranieri,
indesiderati, perdersi in una società che chiude per noi “le
anime e le porte”.14
11 Nora Moll, “Immagini dell “ altro”. Imagologia e studi interculturali”, in Introduzione allaletteratura comparata, op. cit, p. 243
12 Milan Kundera, L’ignoranza, Adelphi, Milano, 2001, p. 1113 Predrag Finci, Il Blues dei rifugiati , in «PaginaZero, Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre
2004, p.2514 Gladys Basagotia Dazza, citata da Serge Vanvolsem in “La letteratura d’immigrazione
ossia la forza della parola, da Parole oltre i confini, sul sito
XIII
Eppure, nonostante la drammaticità di questa lacerazione,
a ben guardare ciò che di irripetibile un migrante porta con sé è
proprio la possibilità di vivere in equilibrio tra i mondi: tra il
paese di partenza e quello di arrivo, tra la cultura abbandonata
forzatamente e quella che si deve imparare a fare propria, tra la
lingua dell’infanzia, che rimane da qualche parte nella
memoria, e quella della nuova quotidianità; tra la nostalgia del
mondo lasciato dietro di sé e la nuova identità, che si insinua
tra le pieghe della nuova vita.
Lo scrittore migrante, dotato di uno sguardo
caleidoscopico, di molteplici prospettive ed esperienze di vita,
costituisce un ponte tra la cultura di origine e quella
dell’arrivo, apportando ad entrambe elementi di novità.
Secondo Predrag Matvejević15, egli parte “con un libro in
valigia” e conserva la propria identità con la quale “feconda il
paese di accoglienza”; sospeso tra qui e altrove, acquisisce una
polivalenza esistenziale che gli consente di porsi come
elemento di raccordo tra realtà lontane ed eterogenee,
modificandole, arricchendole entrambe .
1.3 “Désir d’exister”: la letteratura della migrazione e
la cultura europea
Lo scrittore migrante, che non appartiene a “una, due, o
più nazioni ma alla rete delle relazioni formata dalla
migrazione transmondiale”16 , si pone, nei confronti della
nostra secolare cultura europea, come un detonatore di
innovazione.
www.eksetra.net/database/texts_body.php?code=0130&file=parole_in_06.html15 Predrag Matvejevic, Introduzione al Quaderno balcanico II in I cittadini della poesia, a cura
di Mia Lecomte, Loggia dei Lanzi, Firenze, 200016 Armando Gnisci, Creolizzare l’Europa, Meltemi, Roma, 2003, p. 9
XIV
La storia della modernità occidentale si presenta come
storia imperialista; e l’Occidente, nutrito delle proprie
certezze, difficilmente accoglie uno sguardo “altro”, che possa
far crollare i valori attraverso i quali i suoi figli si riconoscono,
si identificano, si definiscono.
Secondo Milan Kundera17, la storia degli ultimi decenni
ha portato l’Europa ad allontanarsi da ciò su cui, nell’era
moderna, aveva poggiato la sua unità, ciò che rappresentava la
realizzazione dei valori supremi attraverso cui gli Europei
definivano se stessi: la cultura, la “creazione culturale”.
Crollato questo baluardo identitario – sostituito forse dalla
tecnologia, dalla politica, dal mercato globale - “l’immagine
dell’identità europea si allontana nel passato”, e l’Europeo
perde sempre più di vista “tanto l’insieme del mondo quanto se
stesso, affondando così in quello che Heidegger (…)
chiamava, con una formula bella e quasi magica, ‘l’oblio
dell’essere’”.
A questo oblio si oppongono le opere dei migrant writers,
i quali, con le loro identità doppie, multiple, ricostruite,
precarie, sempre in bilico – o meglio, in equilibrio – tra i
mondi, offrono uno sguardo nuovo, straniante, sulla cultura
ormai stanca del nostro millenario continente.
Propongono una nuova definizione dell’identità europea,
che si costruisca certamente a partire da valori culturali, ma
che non si rassegni alla massificazione e al dominio dell’altro;
piuttosto, che trovi il suo fondamento nel riconoscimento del
potere salvifico rappresentato dalle nuove realtà che
pacificamente “invadono” e “colonizzano” il nostro
continente.
17 Milan Kundera, L’arte del romanzo, Adelphi, Milano, 1988, p. 179
XV
La letteratura della migrazione si pone quindi non come
“una letteratura marginale, o una letteratura etnica, ma come
letteratura tout court, perché innova il dire, innova le
rappresentazioni di mondi possibili. (…) Essa costruisce, se
pure a livello dell’immaginario, mondi possibili, sentimenti
negati; è una letteratura dell’esistente, che rivendica il suo
diritto all’esistenza. E nel dur désir de durer – come nei versi
di Apollinaire – essa esprime il dur désir d’exister .”18
Questa breve citazione di Khaled Foum Allam conferma
la portata rivoluzionaria di questi autori; i quali, con le loro
opere, offrono “rappresentazioni di mondi possibili”: ci
donano cioè la possibilità della creazione di mondi, o
quantomeno l’esaltante consapevolezza che il nostro non sia
l’unico possibile.
Ci dicono che proprio nella pluralità, nel colloquio,
nell’esperienza dell’ospitalità, nell’alterità come ricchezza
sono rintracciabili i semi identitari del nuovo intellettuale
Europeo.
1.4 Una nuova forma di cultura, transnazionale e creola
Quando Khaled Fouad Allam afferma che la letteratura
della migrazione si presenta come letteratura dell’esistente,
intende probabilmente porre l’accento sulla “posizione
privilegiata” di cui il migrante gode nell’essere testimone della
Storia attraverso la propria esperienza.
Privato delle certezze che regolavano la prima parte della
propria vita, costretto ad una continua “migrazione identitaria”
dentro e fuori di sé, posto a confronto con una cultura che non
18 Khaled Fouad Allam, “Introduzione”, in Mosaici d'inchiostro, sul sito §§www.eksetra.net/database/texts_body.php?code=0028&file=mosaici_in_02.html
XVI
gli appartiene, egli vive, nella propria storia personale, il senso
di quella “creolizzazione planetaria” di cui parla Edouard
Glissant19.
Egli è il vivente portatore dei due mutamenti culturali
attraverso cui si manifesta la creolizzazione: essa infatti è
possibile solo se si abbandona la radicata convinzione secondo
cui ogni identità si definisce escludendo e/o dominando
l’identità altrui; e si manifesta come la relazione di elementi
eterogenei che si “intervalorizzano”, senza subire
degradazioni, e con in più il valore aggiunto dell’imprevisto.
Riprendiamo la metafora usata da Matvejević che ho citato
qualche riga fa: lo scrittore migrante si avvia verso il nuovo
con una valigia in cui “solo qualche libro trova spazio”
assieme a “pochi altri oggetti cari o indispensabili”.20
Il cammino intrapreso è quello dell’intervalorizzazione
non degradante: il nostro trasmigratore viene armato, sì, ma
della sua cultura. Il punto d’arrivo è l’imprevisto: l’incontro tra
questa e la nostra produce effetti che possiamo seguire nel loro
svolgersi, ma che per ora sono assolutamente imprevedibili,
tantopiù che nascono da un fenomeno già di per sé totalmente
inaspettato: una nuova – e non belligerante – invasione
dell’Europa, che segue di oltre un millennio la precedente.
Seguendo questi cambiamenti culturali fino alle estreme
conseguenze, non potremo più parlare, quindi, di letteratura
come immutabile oggetto accademico e strumento di dominio;
ma di una nuova poetica, rivoluzionaria e sperimentale, di cui
gli autori migranti rappresentano l’avanguardia.
19 Edouard Glissant, La poetica del diverso, Meltemi, Roma, 1998, p.20 Predrag Matvejević, introduzione a “in Quaderno balcanico II” in I cittadini della poesia, a cura
di Mia Lecomte, Loggia dei Lanzi, Firenze, 2001, p. 8
XVII
La realtà che il migrante rispecchia, nelle proprie opere
letterarie e nelle proprie esperienze, non è, non può essere,
univoca, controllata o prevedibile; avendo attraversato la
Storia, egli riflette, come dice Roberta Sangiorgi21, “immagini
non di se stesso ma di più mondi.”
Riconoscendo la pluralità dell’umano, e rivendicandone
l’esistenza – e la resistenza - lo scrittore migrante si pone
quindi davvero nel solco della letteratura, della vera letteratura
(della letteratura tout court, dicevamo); del resto, già Josif
Brodskij, in un discorso del 198722, sosteneva che la diversità
umana sia la materia prima della letteratura, e che ne
costituisca la ragion d’essere; che “essendo la forma più antica,
e anche la più letterale, di iniziativa privata, l’arte” – e in
particolar modo la letteratura – “stimola nell’uomo, volente o
nolente, il senso della sua unicità”.
Lo scrittore migrante non è, in definitiva, solo un
numero, uno delle migliaia di sventurati che si riversano ogni
anno, per le ragioni più disparate, nel nostro paese; egli è,
come dice Jarmila Očkayova, il portavoce del fondamentale
passaggio da un modello culturale faustiano – l’intellettuale
europeo pecca di orgoglio – ad uno amletiano, shakespeariano:
il migrante “apre le porte al dubbio”. Ed è un dubbio salvifico
quello che ci pone, (ogni dubbio è un omaggio alla speranza,
sosteneva Voltaire) perché ci insegna che riconoscere la
propria unicità, rifiutare la massificazione, specie per coloro
che il destino ha voluto divisi tra più patrie, tra più vite,
significa anche intraprendere il cammino verso la libertà.
21 Roberta Sangiorgi, “La ricchezza del doppio sguardo”, in Il doppio sguardo, culture allospecchio, sul sitowww.eksetra.net/database/texts_body.php?code=0000000192&file=doppio_in_02.htm
22 Josif Brodskij, La condizione che chiamiamo esilio, in Dall’esilio, Adelphi, Milano, 1988, p.15
XVIII
Ci ricorda che il nuovo, il “diverso”, altro non è se non
un “potente antidoto contro la malattia dell’omologazione”.23
Ci rinnova la consapevolezza che la letteratura sia “una
maestra di finesse umana, la più grande di tutte, sicuramente
migliore di qualsiasi dottrina”.24
23 Jarmila Očkajova, L’impegno di vivere, in Da qui verso casa, a cura di Davide Bregola, Edizioniinterculturali, 2002, p.60
24 Josif Brodskij, op. cit., p.15
XIX
…anomalo,
dissimile,
sproporzionato,
per nulla calibrato,
quindi
squisitamente
balkanico…
Angelo Floramo
XX
2. I Balcani
Peculiarità della situazione balcanica.
Questione identitaria e difesa della diversità come valore
culturale, testimonianza della macrostoria e migrazione che
assume i caratteri di un esilio, scelta della letteratura come
ultimo baluardo di una dissidenza possibile e frattura
esistenziale in cui siano ben distinti un “prima” ed un “dopo”,
ridefinizione culturale che si basi sul dialogo e non sulla
sopraffazione: tutto ciò che caratterizza il fenomeno della
letteratura migrante è particolarmente evidente nella più
recente diaspora europea: quella dai Balcani.
Migliaia di persone hanno abbandonato questa regione
situata nel cuore dell’Europa durante gli anni che vanno dal
1991 al 1999: date di inizio e fine dell’ultima guerra nella ex-
Jugoslavia, la prima che insanguinasse il nostro continente
dalla fine del secondo conflitto mondiale.
Diretta conseguenza dell’orrore bellico scatenatosi a
seguito del riemergere di folli ideologie nazionaliste, la
migrazione dai Balcani, e quindi anche la produzione letteraria
ad essa collegata, assume caratteri assolutamente peculiari:
primo fra tutti, la migrazione è un passo obbligato e doloroso,
non una delle scelte possibili, volto a garantire due dei diritti
fondamentali per chi fugge: la vita e il rispetto della propria
umanità.
Secondariamente, la scelta della letteratura come forma
di denuncia, in qualche modo di resistenza, è di estrema
importanza per chi ha visto cancellare il proprio mondo.
XXI
E’ necessario ripercorrere le fasi di questo conflitto, e
conoscere il complesso quadro storico-politico all’interno del
quale si inserisce, per comprendere l’importanze degli scrittori
migranti dai Balcani e della loro produzione letteraria.
2.1 L’importanza dei Balcani: alcune metafore
Il “nostro” secolo breve è iniziato, si dice, nel 1914 a
Sarajevo; ed è finito, nel 1999, a Belgrado.
In mezzo a questi due estremi c’è il Novecento, con tutta
la storia che ha prodotto; in mezzo, ci sono anche i Balcani,
continente nel continente, che sfugge a prima vista ad ogni
definizione, o si presta a molte.
L’“anomalia balcanica” consiste, da sempre, nella
sorprendente convivenza di una moltitudine di gruppi etnici,
religiosi e linguistici all’interno di uno spazio geografico
relativamente ristretto e non sovrappopolato.
Questo mosaico non è stato, com’è noto, immune da
scontri e tensioni, che anzi sembrano essere una delle sue cifre
caratteristiche, tanto da produrre per questa regione le
definizioni di “polveriera” o “ventre molle” d’Europa. Già
Miroslav Krleža, scrittore deceduto dieci anni prima che la
dissoluzione del suo paese avesse inizio, difendeva
strenuamente, accanto alla sua identità croata, anche quella
jugoslava, avvertendo i suoi “confratelli” della pericolosità dei
“culti ideologici” e dei nazionalismi esasperati.
Nel 1952, al Congresso degli scrittori di Lubiana,
sosteneva: “Rimettere insieme tutta la coscienza politica,
culturale e intellettuale che nei nostri giorni si vede frantumata
e dispersa dai nostri provincialismi, (…) mettere in evidenza
XXII
gli aspetti tragici dei nostri propri scismi così come delle
nostre negazioni reciproche, questa dovrebbe essere la nostra
missione”25.
In molti non hanno esitato a definire i Balcani “culla”
d’Europa, o suo “cuore”, volendo coglierne così la ricchezza
culturale e storica e la complessità sociale, ma anche
l’importanza nella costruzione di un’identità europea.
Qui si è infatti costituita la civiltà mediterranea; questa
regione di fronte alla quale la “fortezza Europa”, sempre più
volta ad Occidente, chiude le sue frontiere, anche culturali, non
è un’entità politico-culturale a noi estranea, o da noi
indipendente.
Quella che chiamiamo con la bella e rassicurante
metafora di casa Europa, andando verso est, si ricompone, non
si allarga, fa notare Melita Richter26.
Abbiamo dimenticato – ed è una grave perdita, in termini
culturali – che dell’identità europea partecipa anche “l’anima
grande dell’Oriente”27; quello che una volta era “l’Oriente del
nostro mondo”, “oggi è solo Est, una sigla che marchia le
periferie della politica e della mente”28.
Non sembra quindi azzardato parlare di questa Regione
come di una “vetrina” del nostro continente, una sorta di suo
“compendio”; in definitiva, parlare di Balcani significherebbe
parlare di Europa ma soprattutto all’Europa. Perché la storia
balcanica (non solo quella più recente) ci insegna e ci avverte;
se consideriamo il conflitto degli anni Novanta, essa
25 Miroslav Krleža, citato da Predrag Matvejevic, in Mondo «ex», Confessioni Identità, ideologie,nazioni nell’una e nell’altra Europa, Garzanti, Milano, 1996, p. 103
26 Melita Richter, “Sono le soglie, non i confini, a facilitare l’incontro”, in «Osservatorio suiBalcani», marzo 2004, sul sito www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/2889/1/50
27 Paolo Rumiz, E’ oriente, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 1528 Paolo Rumiz, op. cit, p. 39
XXIII
costituisce anzi, per utilizzare le parole di Edmund Stillmann,
“un avvertimento mortale” 29.
Un continente nel continente, abbiamo definito i Balcani;
un’Europa nell’Europa, uno “specchio perfetto delle nostre
divisioni, e al tempo stesso l’ultima isola della nostra
complessità perduta”30, secondo Rumiz; “una specie di campo
di prova”31 delle tensioni europee per Predrag Matvejević; “la
camera oscura dell’Europa32” a parere di Angelo Floramo,
nella quale “il buio genera forme, linee, idee, sogni.”; infine,
nell’opinione di Georges Prévélakis, “termometro per
l’Europa”, che anticipa e riassume cambiamenti culturali e
tensioni sociali che turbano l’intero continente.33
E’ partendo da questi presupposti che si può
comprendere il sanguinoso conflitto degli anni Novanta.
Perché la complessità è sicuramente una delle caratteristiche
fondamentali della regione balcanica (all’interno della quale la
Jugoslavia è esistita come stato federale solo per alcuni
decenni) e riveste l’ambito geografico, politico, storico, etnico,
linguistico; gran parte degli eventi degli ultimi quindici anni
trovano la propria origine in questa complessità.
2.2 Comprendere i Balcani attraverso le opere di
Predrag Matvejević
29 Edmund Stillman, citato da Georges Prévélakis, ne I Balcani, il Mulino, Bologna, 1997, p. 1130 Paolo Rumiz, L’ultima isola, in «I Quaderni 1. 98», Associazione Fondo Moravia, Roma, 1998,
p.15431 Predrag Matvejevic, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma edizioni, Napoli, p.932 Angelo Floramo, Parole in esilio, tra il sogno e la voce. Spunti per una rapsodia balkanica, in
«PaginaZero Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre 2004, p. 21Angelo Floramo è studioso medievista, esperto di tecniche multimediali, intenditore raffinato della
vignettistica, e un profondo conoscitore delle culture dell'est Europa di cui spesso scrive su giornalie riviste di ogni nazione.
33 Georges Prévélakis, Les Balkans, poudrière ou thermomètre de l’ Europe, in «ConfluencesMéditerranée», n.8, 1993, p.97
XXIV
Alla fine del 1994 un gruppo di intellettuali e politici
europei si ritrova a Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina,
per commemorare una tragica ricorrenza: la città bosniaca,
trascinata nel 1992 nella guerra fratricida che sta dilaniando la
ex-Jugoslavia, ha superato il millesimo giorno di assedio.
Più di settantamila persone sono intrappolate all’interno
della città, senza cibo né acqua, costantemente sotto il tiro dei
cecchini che presidiano le più importanti strade del centro.
Diecimila sono già morti.
Altrettanti sono fuggiti chissà dove.
Sarajevo (l’unica capitale al mondo che avesse nel suo
centro, a poche centinaia di metri di distanza, quattro luoghi di
preghiera, uno ebraico, uno musulmano, uno cattolico e uno
cristiano ortodosso) diviene, nella prima metà degli anni
Novanta, il simbolo di una guerra tragica e insensata, di fronte
alla quale l’Europa e il mondo s’interrogano, stupiti e
impotenti, senza riuscire a fare nulla per fermarla.
Gli intellettuali intervenuti a sostegno della popolazione
imprigionata in quello che ormai viene definito “il più grande
campo di concentramento del mondo”34 pubblicano
sull’International Herald Tribune un necrologio “in memoria dei
nostri cari Principi, Valori morali e Impegni, defunti in Bosnia
nel 1994”.35
Tra quegli intellettuali c’è Predrag Matvejevic.
Jugoslavo per nascita ed Europeo per scelta, è nato a Mostar,
in Bosnia Erzegovina, da madre croata cattolica e padre ucraino di
origine, russo di lingua, ortodosso per formazione, jugoslavo di
adozione.
34 Predrag Matvejevic, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma, Napoli, p. 4335 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991 – 1999, Einaudi, Torino, 2002, p. 440
XXV
Questo complesso mosaico identitario viene sempre,
fedelmente, riportato, ogni volta che si parla di questo scrittore
che da qualche anno ha fatto dell’erranza una scelta di vita, e che
vive “tra asilo ed esilio”, lavorando tra Roma, Parigi, e ciò che
resta della sua Jugoslavia ormai perduta.
Si riportano questi dati biografici forse cercandovi l’origine
della sua predilezione per la “dissidenza”36, il “cosmopolitismo”37,
la necessità di testimonianza e di denuncia di tutti gli orrori del
mondo; specialmente del suo mondo, quello dell’“altra Europa”,
quell’“est” da cui sempre più ci allontaniamo.
Credo che questa predilezione sia da ricercarsi, oltre che
nella complessità delle sue origini (di sé, nel suo testo Mondo
«ex» Matvejević dice : “ero destinato ad essere internazionale”38),
nella sua scelta di porsi sempre dalla parte dell’umano; ciò che il
dissidente Metvejević combatte nei regimi di cui ha avuto, più o
meno direttamente, esperienza, sono i particolarismi, i
nazionalismi esasperati, i fondamentalismi, i clericalismi (in più di
una sede, l’autore ha tenuto a precisare che non ama, in genere, gli
“ismi”; preferisce, dice, le parole che finiscono per “tà”: libertà,
fraternità, jugoslavità, e, soprattutto, verità.)
La necessità, intimamente sentita e portata avanti con
coraggio, di denunciare le storture della storia e dei governi, l’ha
portato lontano dalla Jugoslava che amava, ma in cui vedeva
avverarsi il celebre monito di Ivo Andrić, secondo cui “la verità è
la prima vittima della guerra”.
In una lettera diretta ad Andrej Sacharov del 1984,
nell’esprimere la necessità che egli continui a parlare al suo
36 Predrag Matvejevic, Mondo «ex», Confessioni Identità, ideologie, nazioni nell’una e nell’altraEuropa, Garzanti, Milano, 1996, p. 40
37 Predrag Matvejević, Tra asilo ed esilio, Romanzo epistolare, Meltemi editore, Roma, 1998, p. 23338 Predrag Matvejevic, Mondo «ex», Confessioni Identità, ideologie, nazioni nell’una e nell’altra
Europa, Garzanti, Milano, 1996, p.89
XXVI
popolo (Sacharov era allora confinato a Gorkij), Matvejević lo
definisce “ostaggio della verità”39.
Ed è così che lui stesso ci appare: cosciente di ciò che
affermava il pittore Kazimir Malević, cioè che l’arte ha bisogno di
verità, non di sincerità, non rinuncia mai, nei suoi scritti, alla
ricerca del nesso profondo tra arte e vita, tra ispirazione ed
occasione.
I suoi libri sono fedele cronaca dei nostri tempi: non sapendo
che farsene di “poesie che non riposano su niente”40, diffida
dell’intellettuale che non si schiera, dolorosamente conscio che,
anche nelle pieghe più dolorose della storia, “ci deve essere pure
chi ricorda”41.
Di lui, Robert Brechon scrive: “Ormai, ‘erede senza eredità’,
socialista senza socialismo, democratico senza democrazia,
iugoslavo senza Iugoslavia, europeo senza Europa, poiché la sola
Europa nella quale avere ‘cieca fiducia’, cioè la nostra, a sua volta
si richiude nelle sue frontiere, tutto ciò che può fare è di eseguire
questi esercizi di libertà di pensiero che sono i suoi libri. Il
vagabondaggio geopoetico nello spazio terraqueo del
Mediterraneo e le ‘bottiglie gettate in mare’ incaricate di portare
ai suoi fratelli europei i messaggi della ‘nuova dissidenza’, tutto
ciò sembra testimoniare, in quella coscienza ferita, di una
invincibile fiducia nell’uomo”42.
Non va dimenticato infatti – e soprattutto non dovrebbe
dimenticarlo l’intellettuale – che della storia “siamo talvolta tutti
responsabili, per quanto possiamo essere individualmente
impotenti”43.39 Predrag Matvejević, Tra asilo ed esilio, Romanzo epistolare, Meltemi, Roma, 1998, p. 13040 Wolfgang Goethe, Conversazioni con Eckermann, 18 settembre 1823, citato da Predrag
Matvejevic, Mondo « ex», Confessioni Identità, ideologie, nazioni nell’una e nell’altra Europa,Garzanti, Milano, 1996, p. 176
41 Predrag Matvejevic, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma, Napoli, p. 6542 Robert Brechon, “Cittadino di un’ Europa introvabile”, postfazione a Predrag Matvejevic,
Mondo «ex», Confessioni Identità, ideologie, nazioni nell’una e nell’altra Europa, Garzanti,Milano, 1996, p. 186
43 Predrag Matvejevic, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma, Napoli, p. 67
XXVII
Indispensabile chiave di lettura della storia recente della
“nostra” e dell’“altra” Europa, le sue parole saranno utili nel
ripercorrere la storia del crollo del suo paese, così tanto amato.
2.3 Una regione piena di contraddizioni
“Chi approda nei Balcani” afferma Matvejević in un
recente articolo “non tarda a rendersi conto delle loro
contraddizioni”44.
E’ l’essere un crocevia, probabilmente, il senso ultimo
di questa zolla d’Europa: nei secoli, essa si è trovata ad essere
un punto di incontro (e di scontro) tra Oriente e Occidente, tra
mondo bizantino e mondo latino, tra Impero d’Oriente e
Impero d’Occidente, tra cattolicesimo e ortodossia, tra Austria
asburgica e Impero Ottomano, tra cristianesimo e islam, tra
paesi del blocco sovietico e occidente industrializzato.
Essa rimane vittima di quella che Prévélakis chiama
“tirannia della geografia”45: perché, ben lungi dall’essere
caratterizzata da una natura accogliente e favorevole, pure ha
una posizione invidiabile, che l’ha resa nei secoli preda di
bramosie di ogni genere.
Mentre si rafforzava così nelle popolazioni che
l’abitavano lo spirito di resistenza e il senso di una libertà da
difendere anche a costo della vita, i Balcani vivevano il
dramma di una unificazione che risultava impossibile se non
sotto una dominazione straniera.
Mai costituitasi in un’entità indipendente, questa
regione vive la tirannia della storia tanto quanto quella
geografica: perché non avere una storia globale della penisola,44 Predrag Matvejević, “I Balcani”, in «PaginaZero, Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre 2004, p.
745 Georges Prévélakis, I Balcani, il Mulino, Bologna, 1997, p. 18
XXVIII
ma singole storie nazionali spesso in contrasto tra loro ha reso
più semplice il salto (quasi impercettibile ma pericolosissimo)
da cultura nazionale a ideologia della nazione46.
Infine, parlare dei Balcani vuol dire ammettere, come
base dell’analisi, una certa indeterminatezza; anche solo
definire quali paesi facciano parte a tutti gli effetti della
Regione non è impresa da poco: “A quale regione appartiene la
Romania, ai Balcani o all’Europa Centrale? (…) Dobbiamo
includere nei Balcani la Slovenia, così vicina, geograficamente
e culturalmente, all’Austria? In che misura la Croazia cattolica
è balcanica? E la Turchia? (…)”47. Dubbi come quelli che si
pone Prévélakis sono inevitabili, inoltrandosi nel territorio che
sta oltre la catena montuosa della Stara Planina: le cause di
questa particolarità vanno ricercate in quindici secoli di storia,
durante i quali il territorio dei Balcani è stato teatro di vicende
molto complesse, e che hanno lasciato come eredità
un’estrema instabilità politica.
2.4 La Jugoslavia prima del conflitto
Divisi fin dall’antichità greca tra ellenismo e barbarie, i
Balcani videro aumentare la propria importanza dopo il 330
d.C., quando, unificati sotto il dominio di Roma,
Costantinopoli divenne il reale centro di gravità dell’impero
ormai in declino.
Le tensioni politiche, dovute alle pressioni barbariche
sui confini, e quelle religiose dovute all’affermazione del
cristianesimo come fondamento ideologico dell’impero,
portarono ad un graduale allontanamento tra centro e periferia,
46 Predrag Matvejević, “I Balcani”, in «PaginaZero, Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre 2004, p.947 Georges Prévélakis, I Balcani, il Mulino, Bologna, 1997, p. 16
XXIX
culminato nel primo Scisma del 482, poi in quello definitivo
del 1054, e quindi nell’affermazione della Chiesa Ortodossa.
Tra il IX e il X secolo, l’impero bizantino è al suo
culmine, e si presenta come un impero multinazionale che non
ha problemi a gestire le invasioni di popoli barbari (tra cui
Serbi e Croati, che slavizzano gran parte della regione) a nord
dei suoi territori; la vera minaccia mortale è l’Occidente, che
nel 1204, con la quarta crociata, attacca e distrugge
Costantinopoli affermando la propria superiorità politica ed
economica.
Nel momento della definitiva presa di Costantinopoli,
nel 1453, i Balcani sono divisi tra un’area linguistica slava e
una greca, ma uniti dall’ortodossia, con le sostanziali eccezioni
della Croazia cattolica e dell’islam, affermatosi in Bosnia,
Bulgaria, Albania grazie all’influenza ottomana.
Ed è proprio con la conquista da parte dell’impero
Ottomano che i Balcani ritrovano una certa stabilità con la
cosiddetta pax ottomanica.
E’ una pace che però ha il suo prezzo: il dominio turco,
imposto per quasi mezzo millennio a tutta la regione, taglia
fuori i popoli balcanici (in misura minore quelli del nord, come
croati e sloveni, in modo drammatico quelli del sud, come
serbi, albanesi, bulgari, rumeni, ma anche greci e macedoni) da
ogni contatto culturale con il resto d’Europa.
E’ solo nel Settecento, con la decadenza ottomanica e
l’affermazione nella regione dell’influenza asburgica, che idee
riformiste e un certo fervore culturale iniziano a palesarsi.
Influenzata a partire dall’ Ottocento dal nazionalismo
romantico di matrice tedesca, una pleiade di letterati, poeti e
studiosi, soprattutto filologi, si impegna per riscoprire la storia
e la lingua dei popoli balcanici, per rendere possibile
l’inserimento della regione nell’Europa.
XXX
La cultura si laicizza; si afferma un forte sentimento
patriottico, e per quanto riguarda le popolazioni slave, la
sensazione di far parte di una grande famiglia.
In una regione in cui l’affinità etnica aveva avuto
certamente più peso dell’unità politica, l’idea herderiana del
popolo-nazione quale organizzazione naturale e spontanea,
contrapposta alla nazione-Stato, diviene centrale.
Nasce l’Illirismo, e con esso l’idea di unificare tutti gli
“Slavi del sud”, legati tra loro dall’affinità linguistica, in un
unico stato; “la lingua è la storia dell’umanità, la sua eredità”48,
affermavano i romantici: su questa base si tenta di semplificare
e razionalizzare una realtà estremamente frammentaria.
Ma le spinte nazionalistiche sono fortissime; e il secolo
successivo è sconvolto da una serie di rivolte che portano alla
graduale emancipazione dalla Sublime Porta e alla creazione di
uno Stato Serbo sempre più forte che aspira al ruolo di
Piemonte balcanico.
L’Austria Ungheria, che già “aveva avvertito il glaciale
passaggio dell’ombra della propria fine”49 si oppone con
fermezza allo Jugoslavismo occupando la Serbia nel 1878.
Il progetto è destinato a fallire, e la resistenza serba
culmina nella crisi finale del 1914.
Dopo la prima guerra mondiale (durante la quale i Serbi
combattono dalla parte degli alleati mentre Sloveni e Croati a
fianco degli imperi centrali), viene costituito un regno “dei
Serbi, dei Croati e degli Sloveni” che diviene, nel 1929,
“Regno di Jugoslavia”.
Lo stato fra le due guerre si mostra politicamente fragile
ed economicamente in difficoltà: nel 1941 il paese non resiste
all’attacco delle truppe tedesche, italiane, ungheresi e bulgare,48 Giampiero Moretti, Heidelberg romantica, Romanticismo tedesco e nichilismo europeo, Guida,
Napoli 2002, p. 11049 Josip Krulic, Storia della Jugoslavia dal 1945 ai giorni nostri, Bompiani, Milano 1997, p. 14
XXXI
e “crolla come un castello di carte”50. La Jugoslavia cessa in
pratica di esistere, la Germania e l’Italia spartiscono il
territorio e permettono agli ustascia di Ante Pavelić di
costituire un Regno Croato indipendente, fortemente antiserbo.
Si levano in armi a questo punto i cetnici di Draža
Mihalović (serbi e filomonarchici), e i partigiani guidati da
Josip Broz, detto Tito (filosovietici e decisi a portare avanti
una rivoluzione di tipo bolscevico), ostili tra di loro e agli
ustascia: quella che segue è una vera lotta di tutti contro tutti.
Il movimento partigiano esce vittorioso dalla guerra, e
Tito ristruttura la nuova Jugoslavia socialista su basi federali.
Il paese tra il 1945 e il 1980 è fortemente caratterizzato
dal prestigio del suo presidente, che riesce ad affermarsi al
punto di sollevare economicamente lo stato grazie
all’autogestione e all’autodeterminazione e ad opporsi allo
stalinismo – nel 1948 tra Jugoslavia ed Unione Sovietica nasce
un’insanabile contrasto che porterà ad un vero e proprio
scisma, accolto con favore dall’Occidente.
Tito rende l’instabile Jugoslavia non solo il centro del
movimento dei non allineati, ma anche “uno dei rari paesi
multinazionali del mondo, che aveva saputo risolvere il
problema della convivenza”.51
L’impatto sull’opinione pubblica internazionale è
fortissimo.
Ma la sicura unità jugoslava, la promessa di una serena
convivenza tra popoli non aveva tenuto in debito conto alcuni
dei maggiori focolai di tensione del paese: sussistevano
ancora, negli anni Settanta – e anzi cominciavano a minacciare
la sicurezza titoista – le gravi contraddizioni del problema
delle minoranze, del risorgere di miti nazionalistici e della
50 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991 – 1999, Einaudi, Torino, 2002, p. 1651 Predrag Matvejevic, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma, Napoli, p. 9
XXXII
pericolosa convivenza di spirito bellico tradizionale (in cui le
forme comunitarie del clan e della famiglia superano per
importanza quella dello stato) e patriottismo espansionistico di
stampo moderno.
Nel 1980, in occasione della morte di Tito, decine di
statisti di tutto il mondo giungono a Belgrado per inchinarsi
davanti al feretro dell’uomo che aveva reso possibile l’unità e
la pacificazione di una regione priva di stabilità. Senza averne
piena coscienza, salutano anche uno stato ormai avviato verso
la fine; scomparso il presidente, “tutti i nodi” della Jugoslavia
vengono infatti “fatalmente al pettine”52.
2.5 La guerra
Eppure quando, negli anni Novanta, le tensione
nazionalistiche maturate in seno alla ex-Jugoslavia sono
esplose in uno dei conflitti più crudeli degli ultimi decenni,
l’Europa è rimasta a lungo incredula di fronte al risvegliarsi di
odi che pensava superati.
I conflitti identitari erano stati relegati al rango di
barbarie che mai si sarebbero ripetute dopo il termine della
seconda guerra mondiale. Si era coscienti che la creazione
dello stato federale non aveva dato vita a nazioni etnicamente
omogenee; ma si era creduto che “il secolare komišiluk –
parola di origine turca che in Bosnia indicava cordiali rapporti
di vicinanza tra persone di diversa religione e tradizione –
avrebbe prevalso sui sospetti e gli odi reciproci”53.
Invece la Jugoslavia, col suo sogno di uno stato
plurinazionale in cui la convivenza pacifica fosse non solo
52 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991 – 1999, Einaudi, Torino, 2002, p. 22653 Jože Pirjevec, op. cit., p. 124
XXXIII
possibile, ma addirittura necessaria alla sopravvivenza dello
stato stesso, è miseramente crollata sotto i colpi delle ideologie
nazionaliste.
Le vecchie ferite, che si credevano rimarginate, hanno
ricominciato a sanguinare; e l’Europa si è trovata impreparata
di fronte ad un conflitto di cui era stato possibile, come
afferma Predrag Matvejević, prevedere l’odio, ma non il
furore.
Una guerra durata dieci anni, che ha fatto del rancore
etnico il suo vessillo, che ha visto realizzarsi sul suolo del
civilissimo Vecchio Continente massacri, stupri etnici,
deportazioni, campi di concentramento e di sterminio, ha
chiaramente dimostrato quanto in realtà fosse fragile
l’illusione di una soluzione dei contrasti che non prevedesse
uno scontro armato.
Cronologicamente, l’ultimo conflitto consumatosi nella
penisola balcanica si colloca negli anni Novanta del XX
secolo.
Esplode nel territorio di quella che ancora nel 1990 era
la Repubblica Federale Socialista Jugoslava, in cui
“convivevano sei gruppi nazionali: serbi, croati, sloveni,
macedoni, montenegrini e musulmani bosniaci, oltre a una
miriade di gruppi etnici minori quali albanesi, ungheresi,
italiani, bulgari, rumeni, slovacchi, cechi, ucraini, rom
(zingari), turchi; (…) si usavano tre lingue ufficiali e due
alfabeti – latino e cirillico – (…) si praticavano le religioni
cattolica, ortodossa e musulmana”54, e si configura come un
conflitto etno-nazionalista, la cui ferocia è stata aumentata a
54 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991 – 1999, Einaudi, Torino, 2002, p. 4
XXXIV
dismisura da una fatale mescolanza di miti caricaturali (la
“Grande Serbia”, la “Sacra aria croata”) e revisionismo storico.
Un conflitto che vede a capo dello stato più forte della
federazione, la Serbia, Slobodan Milošević, politico dotato di
forte personalità ma preda di folli volontà espansionistiche, e
dimentico del fatto che questa “penisola è (…) troppo ristretta
per simili ambizioni”55. (Non sarà l’unico, ma sarà certo il più
pericoloso).
I teatri di guerra, infine, sono quattro: l’asburgica e
quasi etnicamente pura Slovenia; la cattolica ma molto più
“balcanica” Croazia; la Bosnia Erzegovina, un vero mosaico
etnico-religioso (il paese che più ha sofferto per questo
conflitto); il Kosovo, appartenente alla Serbia ma con
popolazione a maggioranza (quasi il 90%) albanese.
Ricordando una suggestiva suddivisione delle fasi del
conflitto operata da Matvejević in suo diario, e semplificando
eventi che richiederebbero una trattazione ben più ampia, si
potrebbe affermare che il 1991 è l’anno in cui i demoni
nazionalistici si risvegliano: la Slovenia, la più ricca delle
repubbliche jugoslave, riesce, dopo una guerra lampo, ad
ottenere l’indipendenza.
Il 1992 è l’anno della nascita di nuove frontiere: il
conflitto si sposta in Croazia, dove le truppe fedeli a Milošević
rivendicano il possesso dei territori a maggioranza serba; la
Jugoslavia non ha solo perso una delle sue repubbliche, ma è
ormai vittima di un meccanismo crudele che è impossibile
fermare. Le immagini di Vukovar assediata fanno il giro del
mondo: ancora incosciente della perdita, il mondo attende una
soluzione che non arriva.
55 Predrag Matvejević, “I Balcani”, in «PaginaZero, Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre 2004, p.18
XXXV
Nello stesso anno, la guerra giunge in Bosnia, e si
svolge ora su due fronti: sia i Serbi che i Croati portano avanti
rivendicazioni territoriali ai danni dell’etnia musulmana, che
costituisce la maggioranza della popolazione bosniaca. Dal
1992 al 1995, le ferite inferte al cuore dell’Europa diventano
irreparabili, e il sogno di unità dei migliori tra gli jugoslavi
cede il posto alla disillusione e allo sgomento.
Con gli accordi di Dayton del 1995, la Bosnia è divisa
in una Repubblica Serba e una Federazione Croato-
musulmana. In un momento che l’Europa vive come un
trionfo, gli abitanti di uno stato ormai “ex” riconoscono la
sconfitta di vincitori e vinti.
Il conflitto sembra risolto, ma si riaccende nel 1999, con
l’attacco di Milošević al Kosovo: i bombardamenti NATO su
Belgrado mettono fine al contrasto, senza peraltro risolvere le
questioni etniche.
Nel 1995, Bogdan Bogdanović, ex sindaco di Sarajevo,
dichiarava: “I serbi hanno perso la guerra, hanno perso
l’anima, hanno perso l’onore, hanno perso tutto.”56 Questo non
impedisce al maggiore artefice dell’orrore jugoslavo, Slobodan
Milošević, nel 1999, di affermare, con vana retorica e senza
tema di cadere nel ridicolo, che la “sua” Jugoslavia era “il
paese più libero e più democratico di tutto il mondo”57.
La migrazione dai Balcani.
2.6 Colpire i simboli:
nuove frontiere e ponti che crollano
56 Bogdan Bogdanović, citato da Jože Pirjevec, in Le guerre jugoslave, 1991 – 1999, Einaudi,Torino, 2002, p.553
57 Bogdan Bogdanović, op. cit., p.553
XXXVI
Ci sono immagini di questo conflitto che racchiudono in
sé tutto il senso di un orrore durato anni: le case distrutte della
città croata di Vukovar, tenuta sotto assedio dalle truppe serbe
durante il 1991; lo sterminato memoriale di Potočari, nella
cittadina di Srebrenica, in Bosnia, in cui, nel 1995, più di
ottomila cittadini di etnia musulmana sono stati massacrati
nell’arco di appena tre giorni; la biblioteca di Sarajevo,
splendido edificio che conteneva manoscritti di inestimabile
valore, bombardata e divorata dalle fiamme, ridotta ormai ad
uno scheletro le cui finestre sono orbite vuote; i posti di blocco
e le frontiere, che non esistevano affatto, prima; infine, il
simbolo forse più forte e più tragico: il ponte, costruito nel
1566 e distrutto dalle truppe croate, nel 1993, a Mostar, la città
“dove Oriente e Occidente si erano date la mano”58.
“I simboli”, dice Gigi Riva59 in un articolo del 1998,
“contano sempre. Soprattutto contano in guerra.”60
In particolar modo, contano in questa guerra, in cui gli
opposti nazionalismi, per risultare accettabili in una regione
da secoli abituata alla convivenza multietnica, hanno
necessitato del risveglio di fantasmi passati, della promozione
mediatica di un feroce odio etnico, della demonizzazione
dell’altro, dell’identificazione di chi difendeva il pluralismo
culturale con un nemico da annientare, anche fisicamente.
Acquistano allora un senso più profondo le parole della
scrittrice Melita Richter, quando afferma che assieme al
Vecchio (lo Stari, così i mostarini chiamavano la superba
costruzione che si ergeva sulla Neretva “come un arco sottile58 Predrag Matvejevic, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma, Napoli, p.1959 Gigi Riva, giornalista professionista, vanta esperienze al Gazzettino di Venezia, al Giorno, a
Repubblica e in televisione come collaboratore di Gad Lerner nel programma Pinocchio. Haseguito le guerre dei Balcani, in Croazia e Bosnia come inviato speciale sino al 1996, conflitti suiquali ha scritto due libri. Attualmente è inviato speciale del settimanale L'Espresso.
60 Gigi Riva, “Kamerni Teatar” 55, in «I Quaderni 1. 98», Associazione Fondo Moravia, Roma,1998, p.154
XXXVI
di luna”61, come se fosse uno di famiglia) “annegò un mondo
intero; l’antico mondo che aveva fatto sua l’arte e la saggezza
del vivere insieme”62.
Simbolo di unione e condivisione per eccellenza, il
ponte è una metafora di enorme forza, che molti scrittori hanno
utilizzato nei secoli: primo fra tutti – inevitabile citarlo
parlando di questo most bosniaco - Ivo Andric: che dei ponti
balcanici è stato il più grande narratore, e che ne ha colto,
molto prima che il suo mondo si disgregasse, il profondo
significato simbolico; nel breve e famoso racconto I ponti, del
1963, dice infatti: “Di tutto ciò che l’uomo, spinto dal suo
istinto vitale, costruisce ed erige, nulla è più bello e più
prezioso per me dei ponti”, che si propongono “come eterno e
mai soddisfatto desiderio dell’uomo di collegare, pacificare e
unire insieme tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai
nostri occhi, ai nostri piedi, perché non ci siano divisioni,
contrasti, distacchi…”63.
La spinta verso l’altro, la ricerca di un’altrove possibile,
dice lo scrittore Mauro Daltin, attiva “nell’essere umano la
capacità creativa di gettare ponti (il linguaggio, la metafora, il
dialogo...) che consentono comunicazione e possibilità
d’incontro tra differenti sponde, senza per questo ostacolare né
ostruire il fluire di ciò che in mezzo scorre”64.
Se è vero, come abbiamo affermato, che i simboli
contano sempre, e soprattutto in guerra, allora “la distruzione
del ponte di Mostar, così come quella della biblioteca di
Sarajevo, (…) ci fanno intravedere l’abisso di barbarie nel
61 Melita Richter, “All’ombra del ponte”, in «PaginaZero, Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre2004, p. 15
62 Ibidem63 Ivo Andrić, Racconti di Bosnia, Newton Compton, Roma, 1995, p.15764 Mauro Daltin “Editoriale”, in «PaginaZero, Letterature di frontiera», n. 5, Ottobre 2004, p.5
XXXVI
quale sprofonda l’umanità quando disconosce i valori etici e
culturali”.65
E’ sembrato impossibile tornare a darsi la mano dopo un
atto di violenza che non aveva nulla di strategico, ma che
voleva solo dimostrare la cieca volontà dei distruttori, per cui
la vendetta contava di più della “buona intesa” di chi si
bagnava nel fiume all’ombra del Vecchio; perché questa
distruzione ha avuto come conseguenza l’annullamento stesso
della possibilità di pensare un’alternativa, l’obbligo di
scegliere se stare da una parte o dall’altra del fiume: un ponte
non attraversabile è, a tutti gli effetti, metaforici e non, una
barriera invalicabile.
2.7 “Un paese che produce più storia di quanta
riesca a gestirne”: il peso del passato nell’intellettuale
balcanico
Dopo aver appreso la notizia del bombardamento,
Matvejević scrisse un testo, intitolato semplicemente Mostar,
in cui esprimeva il suo dolore con queste parole: “Non avrei
mai creduto che avrebbero osato distruggere il vecchio ponte
della mia città natale. Durante questi anni di emigrazione,
andavo da una città all’altra senza cessare di evocarlo.(…) Ero
convinto che, nonostante tutto, sarebbe rimasto in piedi,
garante dei valori e della storia comuni, per salvare quanto
ancora poteva essere salvato in Bosnia Erzegovina e nella ex-
Iugoslavia, di fronte alla guerra fratricida, alla distruzione
barbara, alla strage.”66
65 Mauro Daltin “Editoriale”, op. cit., p.4
66 Predrag Matvejević, Mondo «ex», Confessioni Identità, ideologie, nazioni nell’una e nell’altraEuropa, Garzanti, Milano, 1996, p. 167
XXXIX
Non è più solo architettonica la perdita che ha colpito la
Jugoslavia nel luglio del 1993; è di questo spirito di unione e
condivisione che si è perduto il senso dopo la distruzione del
“miracolo dell’arcata”67.
Sembrava che ogni forma di impegno intellettuale fosse
ormai inutile; eppure, dice ancora Matvejević, “bisognava
prendere posizione, o tradire se stessi”. Nonostante la sfiducia
maturata a seguito di una guerra che sembrava non voler
concedere tregua, il testo fu trasmesso a più riprese da una
radio locale che tentava di ridare coraggio ai sopravvissuti, e di
tenere in vita l’idea di un futuro in cui fosse ancora possibile
dialogare; e, in qualche modo, il tentativo riuscì.
“Fu una delle rare volte nella mia vita – commenta
Matvejević – in cui ebbi davvero l’impressione che la
letteratura potesse essere più che un gioco o un lusso”.
Nel suo ribellarsi al non dire, al non scegliere,
l’intellettuale può addirittura (seguendo il corso etimologico
della sua ribellione: da re-bellum), opporsi alla guerra.
2.8 Tra asilo ed esilio: nuove forme di dissidenza dai
Balcani
Al di là dell’estrema complessità che caratterizza questo
conflitto (dal punto di vista politico, religioso, geografico, in
qualche modo anche antropologico), nella sostanza esso ricalca
ciò che tutte le guerre portano inevitabilmente con sé: esse
privano l’essere umano del suo presente, cancellano il suo
passato e minacciano il suo futuro; e quindi dimostrano, nelle
parole e nei fatti, a chi le subisce, che nulla più gli appartiene:
neanche la sua stessa vita.
67 Così i costruttori musulmani chiamarono lo Stari Most al tempo della sua costruzione.
XL
E, in special modo quando il conflitto assume i caratteri
di una guerra etnica, quando cioè può bastare un nome a
determinare se ci si trova o meno dalla parte “giusta” della
barricata, viverlo vuol dire molto di più che temere per la
propria vita (o per quella dei propri cari).
Vuol dire riconoscere di non poter controllare più nulla,
neanche la propria esistenza; che si è stranieri in patria, e che
nulla di ciò che si conosceva sarà mai come prima; che non
sarà più concessa la possibilità di costruire il proprio destino,
né quello dei propri figli, e che l’ultima cosa di cui si verrà
privati sarà il proprio diritto primario, quello di essere
considerati esseri umani.
Andarsene, migrare altrove, non è quindi – come nel
caso di chi fugge dalla miseria alla ricerca di una nuova vita -
una scelta, per quanto dolorosa e sofferta: è una necessità.
Si abbandona il proprio mondo in fiamme – o quel che
ne resta – perché l’unica alternativa possibile, in patria, alla
morte, è il silenzio, l’umiliazione, una non-vita in cui nulla di
ciò che si era trova spazio.
Lo sguardo di chi decide di partire, di scegliere “con
piena consapevolezza uno status, poco confortevole, tra asilo
ed esilio”68, si posa sul passato infranto tanto quanto su un
futuro possibile, ancora da costruire: fuori da quella che
nell’ultimo quindicennio è diventata la “prigione dei popoli”
jugoslava, e dentro l’Europa.
Ed è letteralmente dentro l’Europa che si costruisce una
nuova esistenza per chi fugge dall’orrore della guerra: è nei
nostri paesi – in Germania, in Francia, in Italia – che ha inizio
la seconda metà della loro vita.
68 Predrag Matvejevic, op. cit., p. 97
XLI
Dai molti luoghi della loro diaspora, gli scrittori
migranti denunciano un mondo che “amalgama, banalizza ed
espelle, una dopo l’altra, le diversità”69.
La migrazione è un incentivo inesauribile alla difesa
dell’identità, ma anche della pluralità, culturale; perché, come
afferma lo scrittore albanese Ron Kubati, conferisce una
sensibilità sociale che diventa poi prospettiva letteraria: la
microstoria del migrante, apolide ed emarginato dalla vita
pubblica del paese di arrivo, si inserisce nella macrostoria70.
La sua testimonianza è preziosa: perché se è vero ciò
che sosteneva Hanna Arendt, (“Non c’è filosofia, analisi,
aforisma, per quanto profondi, che si possano paragonare per
intensità e ricchezza di significati a un racconto ben
narrato”)71, gli unici che possano denunciare ogni totalitarismo
che distrugga e appiattisca le differenze, sono i narratori di
altri mondi possibili; nel caso presente, i figli di quei Balcani
maledetti che hanno scelto “questa” Europa come
interlocutrice del proprio dolore.
La stessa terminologia con cui descriviamo la loro
condizione contribuisce a definire il peso del recente passato
sulle loro esistenza; noi parliamo infatti di “migranti”, mentre
loro spesso definiscono se stessi “esiliati”; forse nessuno dei
due termini descrive con esattezza la situazione, ma certo la
loro scelta non è casuale né insensata.
La differenza tra un esiliato e qualcuno che vive “tra
asilo ed esilio”, spiega Matvejevic72, è che il primo è vittima di
un regime totalitario che impedisce, a chi si allontani più o
meno volontariamente dal proprio paese, di tornare; il secondo,
invece, vive in una nuova “democratura” (neologismo col69 Paolo Rumiz, “L’isola”, in «I Quaderni 1. 98», Associazione Fondo Moravia, Roma, 1998, p.15370 Ron Kubati, “La ricerca dell’altrimenti”, in «Kúmá, rivista di arte e letteratura “creola”», sul sito
www.disp.let.uniroma1.it\kuma\kuma.html71 Hanna Arent, L’umanità nei tempi bui. Pensieri su Lessing, p. 1472 Predrag Matvejević, Tra asilo ed esilio. Romanzo epistolare, Meltemi, Roma, 1998, p. 249
XLII
quale Matvejevic definisce quei regimi che non sono
democrazie né dittature in senso stretto) e il suo abbandono dei
luoghi dell’infanzia non esclude il ritorno.
Non “esiliati”, quindi, almeno nella terminologia, i
Bosniaci, i Croati, o i Serbi che vivono nei nostri paesi; ma
esiliati nella sostanza, perché un paese a cui tornare non
l’hanno più.
Tornando tornano appunto in Serbia, Croazia, Bosnia, o
in quel che ne resta: non certo nella Jugoslavia in cui sono nati
e cresciuti, in cui si è sviluppata la loro identità e nutrita la loro
cultura, che quello è un paese che, nell’arco di pochissimi anni,
è scomparso, tragicamente, dalle carte geografiche.
La testimonianza del filosofo Ivan Iveković non è rara
né esclusiva: "Mio padre è nato in Austria-Ungheria, io nel
Regno di Jugoslavia, i miei due figli nella Repubblica
Federale Socialista Jugoslava ed io sono un cittadino croato
che vive temporaneamente in Egitto, ma non posso prevedere
dove nasceranno i miei nipoti e come si identificheranno"73
A volte non è necessario andare “altrove” per sentirsi
stranieri.
In un brano del suo testo “Mondo ex”, Predrag
Matvejević scrive: “Siamo abituati a perdere. Ogni giorno
qualcuno intorno a noi si allontana o sparisce, un’amicizia o un
amore impallidisce o si estingue, la morte si porta via uno dei
nostri. Perdere fa parte del nostro destino.
Però è raro perdere un paese. A me è capitato. Non
parlo di uno stato o di un regime, ma proprio del paese dove
73 Ivan Ivekovic, “Postille sull'identità”, in Melita Richter, Identità e genere nel conflitto jugoslavo,(libro in preparazione)
XLIII
sono nato, e che, ancora ieri soltanto, era il mio. Non c’è
più.”74
Nel descrivere il disagio del migrante, forzatamente
allontanato da tutto ciò che costituisce una sua definizione
identitaria, la scrittrice e psicologa Christiana de Caldas Brito
sostiene che la migrazione comporta una triplice perdita:
quella della madre biologica, quella della madrepatria, quella
della madrelingua. Per i migranti balcanici se ne aggiunge una
quarta, spaventosa e quasi grottesca: quella del proprio paese
di origine, non tanto (o non solo) in termini di allontanamento,
quanto piuttosto di cancellazione del luogo a cui si vorrebbe
tornare, e della complessità culturale che ne costituiva la
ragion d’essere: il migrante che abbandona la ex-Jugoslavia
sembra non aver diritto neanche alla nostalgia.
La loro salvezza sta nella testimonianza, e nella
letteratura; lo scrittore che fugge dai Balcani è, a tutti gli
effetti, un dissidente, termine ormai desueto, che identifica
però un ruolo di cui, dopo la resurrezione delle ideologie
nazionalistiche in seno alla nostra Europa, forse sarebbe il caso
di riappropriarsi.
“Un certo tipo di dissidenza – dice ancora Matvejević
pensando alla sua Jugoslavia distrutta – rimane quindi
necessario e di nuovo indispensabile.”75
Il compito degli scrittori migranti, e in particolare di
quelli provenienti dai Balcani, è quindi rendere possibili,
all’interno dell’Europa tutta, ove necessarie, nuove forme di
dissidenza.74 Predrag Matvejević, Mondo «ex», Confessioni Identità, ideologie, nazioni nell’una e nell’altra
Europa, Garzanti, Milano, 1996, p. 95
75 Predrag Matvejević, op. cit., p. 44
XLIV
Scrittori non si diventa per caso:
il subdolo effetto della biografia è il primo e il più
intenso stimolo.
E ciò che predomina in una biografia è la sensazione
della diversità,
è il marchio infamante della diversità il detonatore della
fantasia.
Lo scrittore o il futuro scrittore
si interrogano sulla propria esistenza,
cercano di spiegare l’origine di questa diversità
e la sua relazione con il mondo.
Quando poniamo a noi stessi delle domande
facciamo anche il primo passo verso la letteratura,
la quale, come disse Barthes,
altro non è se non il porre questioni a se stessi.
Danilo Kiś
XLV
3. I testi e gli autori: gli scrittori migranti dai
Balcani in Italia
3.1 Un conflitto nel cuore
dell’Europa:l’autobiografia come specchio della
storia
Si comincia a parlare, negli ultimi anni, di scrittori
migranti dai Balcani. Si comincia ad apprezzare le loro opere e
a riconoscere l’importanza della loro testimonianza. Si
comincia a capire che il loro esempio di difesa dell’umano
contro la barbarie, ci è “dannatamente prezioso”76. Perché ci
apre gli occhi sugli orrori consumati nel cuore stesso del nostro
continente; e perché ci racconta cose che nessun migrante,
almeno nessun migrante europeo, aveva mai raccontato.
Nel 1992, una giovane giornalista di Sarajevo, Jadranka
Hodzić, da qualche anno residente in Italia, “nella Rimini di
Fellini” 77, si toglie la vita sulla riva dell’Adriatico, al di là del
quale aveva abbandonato la propria città in fiamme.
Cosciente dell’impossibilità di un ritorno, poco prima di
morire aveva scritto in italiano queste righe, nelle quali
sembrano condensarsi la dolente malinconia e il doloroso
stupore di chi sente di non appartenere più “a nessun luogo e a
nessuna lingua, ma solo a qualche pezzo di carta ufficiale”78:
76 Paolo Rumiz, prefazione a Božidar Stanišić, Bon voyage, Nuova dimensione, Portogruaro, 2003, p.1077 Jadranka Hodzić, “L’altra parte dell’ariatico”, da Mosaici d’inchiostro, autori vari a cura di SanGiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1996, p. 17
78 Gabriella Parati introduzione a Mosaici di inchiostro, autori vari a cura di San Giorgi Roberta eRamberti Alessandro, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1996, p.23
XLVI
“Quando fuggi dalla Bosnia, e dalla guerra, sei convinto
che un giorno da qualche parte ti fermerai.
Ti sistemi temporaneamente e pensi di esserci riuscito,
perché l’importante era sfuggire alla disgrazia da cui ti separa
solo il mare; tutto d’un tratto capisci che in realtà non
appartieni più a nessuno, nemmeno a te stesso, la tua vita è
uscita dal binario, sei colpevole senza avere delle colpe, ti senti
come Kafka: lo sguardo degli occhi è spento guardando il
mare, immagini com’è dall’altra parte dell’Adriatico, sulla
costa che una volta ti faceva sentire te stesso e dove ora non
puoi appoggiare il piede senza un permesso speciale. Ti fai una
passeggiata, e il pensiero ti risuona nella mente: E’ facile
tornare se sai dove.”
Sistemata “temporaneamente” dall’altra parte
dell’Adriatico, separata dalla sua città in fiamme solo da una
striscia di mare, Jadranka ha scelto di morire, proprio sulla riva
di qual mare su cui la sua esistenza stava sospesa, senza
riuscire a staccarsi definitivamente dalla Jugoslavia né a
sentire di appartenere ormai, definitivamente, all’Italia.
Jadranka era una delle migliaia di profughi che hanno
abbandonato la ex-Jugoslavia dal 1991 al 1999, e una degli
scrittori migranti che dai molti luoghi della loro diaspora
hanno testimoniato l’orrore vissuto da questo paese “ex”
situato nel cuore dell’Europa.
La giornalista non ha retto al crollo dei suoi ideali; ma, a
dieci anni dalla fine della guerra in Bosnia e a cinque dalla
(discutibile) soluzione della faccenda kosovara, molti altri
scrittori balcanici hanno alzato la propria voce sopra i rumori
della guerra, e popolano ora il nostro panorama letterario: la
diaspora balcanica trova nelle opere di Božidar Stanišić, Spale
XLVII
Miro Stevanović, Vera Slaven, Stevka Smitran, Vesna Stanić,
Tamara Jadreičić la sua più attenta e trascinante
rappresentazione in Italia. Attenta e trascinante, perché questi
autori oscillano tra una minuta e accurata descrizione della
realtà che li circonda e una resa del proprio intimo sentire
intensa e dolente.
“Piccolo fiore di nostalgia”79, definisce Paolo Rumiz la
raccolta di racconti di Bozidar Stanišić I buchi neri di Sarajevo,
e così ci appaiono le opere di tutti questi autori, che si infilano
nelle pieghe della storia restituendoci, con stordente forza
poetica, vite perdute, amori infranti, quotidianità dissolte.
Fuggiti in fretta dal “sanguinoso imbroglio jugoslavo”80,
privati di tutto ciò che costituiva il loro passato – quindi anche
una promessa per il futuro – gli scrittori balcanici si
appropriano della nostra lingua, la abitano, la rinnovano, e
attraverso di essa intraprendono quel cammino di difesa contro
la massificazione che abbiamo visto essere il fardello più
prezioso che il migrante porta con sé.
Difendere, davanti agli orrori delle dittature e dei
totalitarismi, il ruolo degli intellettuali, riconoscere il valore
politico del loro operare, l’importanza della loro difesa della
pluralità dell’umano, significa porsi automaticamente contro
un’ideologia per definizione massificatrice (i totalitarismi
agiscono sugli uomini “con la delicatezza di una ruspa”, diceva
Josif Brodskij).81
Eppure, abbiamo visto, è un atto necessario per non
tradire se stessi. Le opere letterarie degli scrittori migranti dai
79 Paolo Rumiz, prefazione a I buchi neri di Sarjevo e altri racconti, Božidar Stanišić, Mgs Press,Trieste, 1993, p. 7
80 Paolo Rumiz, Bon voyage, Božidar Stanišić, Nuova dimensione, Portogruaro, 2003, p. 781 Iosif Brodskij, Dall’esilio, Adelphi, Milano 1998, p. 15
XLVIII
Balcani posseggono, rispetto al resto della letteratura migrante,
un valore aggiunto.Claudio Magris, nel suo romanzo-saggio intitolato
Danubio, scrive: “Quando una realtà sta venendo cancellata
con violenza, pensarla diventa un atto di fede”82: è operando
quest’atto di fede che gli autori balcanici, privati del loro
mondo, scelgono la letteratura come forma di resistenza.
All’irrazionale logica del conflitto, all’impavida gioia dei
distruttori, i narratori oppongono le parole, il racconto, la
memoria; perché sono consapevoli che “il paese che brucia i
propri ricordi è un paese che vuole morire”83.
Portando con sé nella loro precipitosa fuga, tra le poche
cose care o indispensabili, la propria denuncia, essi salvano se
stessi dall’oblio, e insieme preservano ciò che è rimasto della
propria patria perduta; con le loro opere – in cui è sempre
presente una forte componente autobiografica - si oppongono
non solo alla guerra e alla sua violenza fratricida, ma anche al
suicidio di una cultura che si priva, man mano che esaspera
particolarismi e nazionalismi, del proprio potenziale per il
futuro.
Nel suo romanzo autobiografico Cercasi Dedalus
disperatamente, Vera Slaven, scrittrice croata rifugiatasi in
Italia all’inizio della guerra, “quando nessuno fuggiva
ancora”84 scrive: “Per quell’aria pesante e per non rendermi
indifferente a tutto sono scappata in un paese straniero, per non
vedere come si distrugge una parola grande come ‘patria’.
(…) Non si scappa dalla propria pelle – forse sono giuste
le dicerie popolari, ma io ancora non voglio credere che tutto
ciò che è successo e che ancora accadrà, si ricucirà un giorno
82 Claudio Magris, Danubio, Garzanti, Milano, 1997, p. 6383 Agata Keran, “L’andata senza ritorno”, tratto da Anime in viaggio, autori vari a cura di San GiorgiRoberta e Ramberti Alessandro, Adnkronos, Roma, 200184 Vera Slaven, Cercasi Dedalus disperatamente, Tracce, Pescara, 1997, p.26
XLIX
con ‘fatalità slava’ o con altre due parole come ‘polveriera
balcanica’ e ‘doveva succedere’.”
3.2 Tematiche migranti e tematiche belliche
Se in tutti i testi sono sicuramente presenti, come
avevamo già notato, tutte quelle che potremmo identificare
come tematiche migranti (ossia comuni a tutti gli autori divisi
tra due o più patrie, vite, lingue) ce ne sono però anche altre,
più specificamente legate al contesto da cui questi autori
provengono, e che potremmo definire tematiche belliche.
Nei racconti e nelle poesie scaturite dalle penne di questi
uomini e donne dei Balcani la guerra campeggia su tutto,
nelle sue numerose (e a volte non tutte facilmente
immaginabili) declinazioni: la fame, l’assedio, il freddo, la
fuga, la follia, in una sorta di catartica disamina del proprio
recente passato.
Eppure quest’introspettivo viaggio “lungo strade che si
allungano all’indietro”85 non impedisce alla maggior parte di
questi scrittori di padroneggiare la nostra lingua e la propria
capacità poetica fino a giungere ad un prodotto letterario di
qualità.
Il peso della storia non àncora la loro produzione
letteraria al ristretto ambito dell’autobiografia, ma si dipana
come una trama sottesa ad ogni racconto o poesia, e non
necessariamente ostacola il loro inserimento a pieno titolo nel
solco della vera letteratura.
L’essenza dell’identità balcanica consiste, secondo Goran
Petrović, nell’assenza di presente compensata da un eccesso di
85 Božidar Stanišić, “Il rapimento”, in Parole oltre i confini, autori vari a cura di San Giorgi Robertae Ramberti Alessandro, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1999, p184
L
passato e futuro86. Lo scrittore balcanico, preda di questa
oscillazione priva di un centro di gravità permanente, sembra
essere innamorato dell’attimo.
Ed è l’attimo di una lacerazione profonda, personale
quanto storica, che questi autori catturano nei loro testi,
affrontando sostanzialmente lo stesso tema pur partendo da
prospettive diverse.
La “Jugotragedia”87 diventa la materia incandescente
attraverso cui il valore delle loro opere può mostrarsi.
3.3 La guerra in casa e la quotidianità stravolta.
Tamara Jedreičić
Uno degli elementi che caratterizza questo conflitto, e ne
svela la tragicità, è il modo in cui esso è stato condotto: il
contrapporsi di nazionalismi, in un territorio etnicamente
eterogeneo, ha portato ad una guerra condotta con chirurgica
precisione, nella quale l’ “altro”, il nemico, veniva stanato
all’interno della propria abitazione ed eliminato attraverso
sommarie esecuzioni.
In una sorta di incubo ad occhi aperti, le soleggiate
primavere jugoslave si trasformano improvvisamente in un
orrore di cui non si vede la fine. L’autrice che meglio ha reso
nelle sue opere l’istantanea del momento in cui il corto circuito
storico deflagra, è stata senza dubbio Tamara Jadrejčić.
La produzione letteraria di questa autrice è costituita da un
discreto numero di racconti per la maggior parte ancora inediti
in Italia, con alcune sostanziali eccezioni (ad esempio Il86 Angelo Floramo, a cura di, “Una babele di storie e di sogni: dialogo con Goran Petrović”, da
«Pagina Zero. Letterature di frontiera», Quadrimestrale di letterature, arti e culture, Ottobre 2004 –Numero 5, Direttore Mauro Daltin, Sede Cervignano del Friuli, (UD), p. 48
87 Božidar Stanišić, “Il rapimento”, in Parole oltre i confini, autori vari a cura di San Giorgi Robertae Ramberti Alessandro, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1999, p.186
LI
bambino che non si lavava, con cui l’autrice ha vinto l’edizione
del 2002 del concorso per scrittori migranti Eksetra, e I
prigionieri di guerra, primo classificato alla XVII edizione del
premio Italo Calvino – Tamara sembra essere la più perfetta
dimostrazione che la letteratura migrante non può essere ancora
a lungo considerata marginale o esotica).
La scrittrice, croata di nascita, per molti anni residente in
Italia e ora sistematasi – momentaneamente? – a New York, nei
suoi racconti “italiani” ferma lo sguardo, lucido e rassegnato,
sull’attimo esatto in cui la guerra invade l’esistenza, travolge la
quotidianità, diventando “un argomento giornaliero, come
andare a prendere il pane, lavorare, sfamare i bambini,
comprare il gelato.”88
Con una narrazione fluida e lineare, Tamara fotografa la
Jugoslavia perduta nel momento in cui tradisce se stessa.
Nel racconto Il bottino, Joško e Petar, due amici “di
sempre, vale a dire d’infanzia e di guerra”, alla ricerca di un
guadagno facile, giungono in un villaggio abbandonato, in cui
tutto testimonia silenziosamente la precipitosa fuga dei suoi
abitanti.
Attraversando il paese “completamente muto”, le cui case
hanno ancora “le persiane alzate e spesso i portoni dei cortili
aperti” i due giungono ad un’abitazione: “dentro, come
congelata dentro ad un freezer, c’era scritta la vita di una
famiglia”.
“La prima porta aperta portava in cucina. Sul tavolo,
coperto di briciole di pane, c’erano dei bicchieri e due tazzine.
Sul pavimento erano volate carte e tovaglioli, come se fosse
passata una folata di vento. Di lato, accanto alla finestra, il
88 Vera Slaven, Cercasi Dedalus disperatamente, Tracce, Pescara, 1997, p.67
LII
lavandino con i piatti messi ad asciugare e il fornello con sopra
una grande pentola d’acciaio inox.”
La materia bellica è filtrata dalla scrittrice con voce
originale e disincantata; il quotidiano è reso minuziosamente e
puntualmente, ogni particolare diventa prezioso, rilevante,
anche perché il punto di vista adottato è spesso quello di chi non
è perfettamente cosciente di quello che accade, e percepisce la
tragedia come un’anomalia della quotidianità.
Come accade in Il bambino che non si lavava, in cui a
rendere ancora più evidente l’ovvia verità secondo cui quando
uno stato entra in guerra, sono in realtà i suoi cittadini a
combatterla, Tamara osserva la realtà attraverso gli occhi di
Ivan, figlio undicenne di Sanja.
Armato solo della sua rabbia, con il suo rifiuto di lavarsi,
di ubbidire alla madre, Ivan esprime la propria dolorosa protesta
per un mondo che gli è troppo velocemente mutato intorno, e di
cui non comprende più le regole.
Lo sguardo bambino permette a Tamara di cogliere
l’insensatezza di ogni conflitto e l’angoscia di chi si ritrova
privato di certezze e affetti.
“Sanja non poteva neanche immaginare che ogni mattina
Ivan si alzava sperando di incontrare il padre arrivato la notte
precedente. E che prima di addormentarsi se lo ricordava con
quello strano vestito verde, un giaccone largo con tante tasche,
una grossa cintura di pelle consumata, degli stivali grandi e neri
che quasi da soli riuscivano a mettere paura. Gli sembrava una
via di mezzo tra Robin Hood e i combattenti Ninja. Aveva già
visto tante volte in televisione della gente vestita nello stesso
modo, però per ragioni inspiegabili sembravano tutti diversi, più
LIII
sporchi, più brutti, più terribili. Non aveva mai notato uno che
gli assomigliasse.”
L’accuratezza della descrizione si accompagna sempre ad
una sincera disamina dei sentimenti, e il tempo della narrazione
appare come dilatato, sospeso.
Nel racconto intitolato Una questione di fiducia – toccante
narrazione del rifiuto di una madre di convincersi della morte
del figlio – la reazione dei due protagonisti alla telefonata che
annuncia la tragedia diviene materia di una profonda e attenta
analisi psicologica, e di una voce narrante che si posa, quasi con
gentilezza, sul dolore dei due genitori.
“Quella mattina, sette anni fa, fu lui a rispondere al
telefono.
(…) Dopo aver messo giù la cornetta era rimasto per buoni
due minuti in mezzo al corridoio. Con il suo pigiama a righe e
le pantofole di plastica, con i capelli arruffati dal sonno e ritti
dietro la pelata come i pennacchi dei capi indiani. Respirava a
bocca aperta lottando per l’aria, cercando intanto di riempire
con qualche parola intelligente il vuoto che gli si era creato in
testa.
Erano i suoi ultimi minuti da protagonista. Appena
sarebbe tornato nella stanza da letto, la sofferenza sarebbe
ingiustamente diventata solo materna, per un’antica e ingiusta
convinzione che le donne, ma soprattutto le madri, abbiano una
capacità maggiore nel sentire il dolore.
Nel frattempo, Katarina sapeva che una persona normale
non chiamava per una sciocchezza a quell’ora e che lui non
stava impalato lì in mezzo per un nulla. Aveva trascorso gli
ultimi cinque minuti sereni della sua esistenza seduta sul letto
LIV
con le mani incrociate in grembo, affondata nei cuscini bianchi,
come un regalo prezioso appoggiato sull’ovatta.
Ormai era così che passava la gran parte della notte,
poiché il sonno non s’infilava più con semplicità nel suo corpo,
a conferma che le anime tristi non sono benvolute proprio da
nessuno. Quando lo vide entrare nella stanza, le sembrò sfinito,
ridotto di volume, come sprofondato in se stesso.
Così rimpicciolito si sedette sul letto.”
I testi di Tamara seguono un percorso narrativo che giunge
infine ad una svolta, una sorta di “rivelazione” (il momento in
cui l’ostinazione di Ivan cede il posto alla confessione: “Io sono
un maschietto e faccio il bagno solo con papà”, o la fiduciosa
rivelazione di Katarina davanti alla salma del figlio: “…è
vivo…me l’ha detto la Madonna!”) raggiunta la quale il climax
emotivo si scioglie, lasciando spazio al sollievo o alla
rassegnazione.
Il tono è sempre pacato e misurato, e l’utilizzo
dell’italiano è consapevole e maturo; la narrazione è molto più
lineare di quella di altri autori, meno stratificata e inusuale, ma
Tamara gioca con la lingua italiana ottenendo effetti di grande
suggestione.
“ (…) Quando una granata del calibro 128 mm, e nella
maggioranza dei casi erano quelle, cade sull’asfalto, lascia un
segno simile ad una goccia d’acqua sfracellata sul vetro.”
L’angosciante sensazione di prigionia in cui la guerra
precipita chi la subisce è resa da Tamara attraverso le toccanti
parole di Dara, protagonista del racconto La poltrona rossa, in
cui l’ultima speranza di due coniugi separati da tutta la famiglia
è un gruzzoletto di marchi tedeschi nascosto nella federa di una
poltrona della loro casa di Dubrovnik, precipitosamente
abbandonata.
LV
Pensando alla figlia lontana, alla madre e alla sorella, Dara
si lascia sfuggire un commovente lamento sull’insensata
crudeltà della guerra: “O Dio! (…) O, Marko, che cosa ci è
successo? Com’è possibile che tutto sia cambiato
all’improvviso? Non siamo più sicuri di niente e non crediamo a
nessuno. Ci siamo ridotti come delle bestie. Prima eravamo
gente normale, partivamo, telefonavamo, mandavamo cartoline
d’auguri, mentre adesso cerchiamo di decifrare i bigliettini
puzzolenti e sgualciti della Croce Rossa.
Che disastro…Mi sento morire l’anima!”
La disumanizzazione del nemico, e la sensazione di potere
essere considerati da chiunque come il nemico, è evidente ne La
guerra di Mira, in cui la protagonista, veterana di quella che
Tamara chiama “una guerriglia casalinga”, affronta
quotidianamente il marito soldato.
Incattivito dalla familiarità con morte e distruzione,
consumato dalla non –vita condotta al fronte, considera Mira il
bersaglio migliore per la sua rabbia.
E lei, cercando di sopravvivere alla guerra che l’ha
raggiunta in casa, “era cambiata tanto da non riconoscersi più in
questa donna impaurita, bugiarda, pronta ai compromessi.”
Se gli affetti sono l’unico rifugio di fronte alla distruzione,
se si può contare solo su se stessi e su chi si ama, tutta
l’amarezza di Tamara, tutta la sofferenza di chi vive assediato
dalla paura, si condensano in queste poche parole: “Mira aveva
imparato bene come può cambiare il mondo dopo che hai visto
sopra la testa il buchino vuoto e nero della canna del fucile. La
gentilezza e la purezza d’animo se ne vanno per primi. Come se
non fossero mai stati tuoi. E non importa di chi è la mano che
tiene l’arma.(…) Il dolore viaggia più veloce della coscienza.”
LVI
3.4 Il sé e l’altro: la paura del fratello slavo
Vera Slaven
Nelle opere degli autori presi in considerazione, alla
narrazione della guerra si accompagna l’incredulità per la
brutalità di un conflitto che ha distrutto la fiducia tra popoli
che, pur tra scontri e tensioni, negli ultimi decenni avevano
convissuto pacificamente: il terremoto è politico, ma anche
esistenziale; perché la dolorosa coscienza di non potersi fidare
di nessuno porta a temere chiunque.
Dall’inizio della guerra, racconta Tamara Jadrejčić, si
cominciò “ad aver paura di quelli che corrono e di quelli che si
fermano, di quelli che parlano e di quelli che stanno zitti, che
guardano, che hanno le mani in tasca, che portano il cappello.
Tutto poteva significare tutto, tutti potevano avere una bomba
in tasca e a chiunque potevi non piacere.”89
Si arriva a desiderare di essere il più possibile muti ed
incorporei, di “abitare un mondo senza lingua e senza forma”.
Nel suo romanzo autobiografico intitolato Cercasi
Dedalus disperatamente, Vera Slaven descrive così il
momento in cui si cominciò a non riconoscere nessuno,
neanche se stessi, quando, per la prima volta, lo speaker di una
radio annunciò lo stato di guerra.
“Tutti fuggivano a casa…come se fosse una fortezza
dove la guerra non può arrivare. La radio era rimasta accesa…
alzai il volume…si trasmetteva la solita musica (…) Ero
impaziente. Volevo spiegazioni. Volevo sapere cosa fare. Mi
affacciai al balcone …Al balcone del palazzo di fronte vidi un
giovanotto (più un ragazzo che un giovane uomo) che puliva e89 Tamara Jadrejčić, L’abito da sposa, (opera non pubblicata.)
LVII
ungeva due fucili. La scena mi sconcertò così tanto che
scappai dentro. Rimasi stupefatta. Non conoscevo per niente il
ragazzo, non conoscevo le abitudini della sua famiglia, mi
sentii estranea a quella gente che mi circondava, mi sentii
persa.”90
Anche Vera Slaven è una scrittrice croata, ed è uno dei
pochi narratori della diaspora balcanica ad essersi cimentata
nella stesura di un romanzo interamente elaborato nella nostra
lingua.91
In Cercasi Dedalus disperatamente la narrazione di Vera
oscilla tra passato e presente, in un continuo rimando tra i due
tronconi di vita che stanno ai due lati dello spartiacque
costituito dalla guerra.
Il linguaggio di Vera è diretto e a tratti evocativo;
l’italiano è una lingua correttamente padroneggiata, che
costituisce lo strumento per giungere al distacco necessario per
ripercorrere la propria esistenza.
(“Lara: ‘Piangeresti alla fine di ogni rigo se scrivessi nella
tua lingua?’
Io: ‘Si, morirei alla fine di ogni pagina. (…) L’italiano è
una linea di distacco, una frontiera invisibile, ma
invalicabile’.”)
Quella di Vera è una “cronaca del quotidiano” di forte
impatto emotivo, resa con un linguaggio omogeneo e denso.
La struttura del romanzo è duplice, alternata; da una parte
la narrazione della vita di Vera, dall’altra la struttura
aneddotica, nella quale si inseriscono la figura di Lara e il
ricordo tormentoso della guerra.
90 Vera Slaven, Cercasi Dedalus disperatamente, Tracce, Pescara, 1997, p.6691 Un altro è Spale Miro Stevanović, con Le Confessioni, Opera, Venezia, 2001.
LVIII
“Nel momento in cui, entrando in casa, ho messo il piede
in un lago di merda (i tubi di scarico si erano congelati o erano
scoppiati, non so) e dai due water strapieni usciva, piano piano,
la ‘cosa’. (…) Ho urlato per un’ora intera, per l’umiliazione, per
la nostra disperazione estrema, non più tollerabile, mentre i miei
vicini portavano via in assoluto silenzio i tappeti e staccavano la
moquette. (…)
Sono scappata di casa con la certezza che la guerra mi era
entrata sotto la pelle e che non avrei più potuto lavarla né
levarla di dosso.”92
Eppure, nonostante tutto, emerge nella narrazione di Vera
il tentativo di mostrare i modi di resistenza attraverso cui
vincere l’orrore: come le feste da ballo organizzate a Sarajevo,
che permettevano ai cittadini di non arrendersi “nella città
assediata, senza via di scampo, senza futuro, con un passato
scottante e bruciante. (…)Abbiamo deciso di fare le feste per
non morire prima della morte. Abbiamo staccato per un
momento gli attori e i cantanti dai bar e li abbiamo costretti a
vivere. (…) Non posso spiegare l’ebbrezza di quei balli”.
Fortissimo in questo romanzo l’elemento autobiografico;
centrale nella prima produzione migrante, in quest’opera non è
stato ancora abbandonato a favore di una creazione narrativa a
tutto tondo.
3.5 L’esilio dell’intellettuale jugoslavo: si perde
un’identità per acquistarne una nuova?
Božidar Stanišić
92 Vera Slaven, op. cit., p. 86
LIX
La questione dell’identità e dell’alterità si pone con
gravità estrema, quando ci si sente estranei a tutti e vicini a
nessuno.
Nel momento in cui ci si confronta con un mondo che non
è più quello che si conosceva, si è costretti a fare i conti anche
con il passato, che rischia di essere completamente rimesso in
discussione.
L’autore in cui appare più evidente lo spaesamento e la
sensazione di costante straniamento esistenziale che segue
questa perdita identitaria è sicuramente Božidar Stanišić, nelle
cui opere l’umanità astratta si trasforma in volti, persone che
chiedono di poter riconoscere un ruolo nel proprio mondo e che
s’interrogano, con tristezza ma non con disperazione, su un
futuro umano incerto, che si sa difficile ma si ritiene possibile.
Božidar Stanišić è nato a Visoko, in Bosnia Erzegovina.
Ex insegnante di letteratura, ha abbandonato la Bosnia
nel 1992, spinto alla fuga dal rifiuto di vestire qualsiasi divisa,
e si è rifugiato prima in Slovenia e poi in Italia, dove risiede
tuttora, a Zugliano, presso Udine.
Continuando in Italia l’attività letteraria intrapresa in
patria, (in Bosnia aveva pubblicato testi di narrativa per
ragazzi e critica letteraria), Stanišić ha continuato a narrare il
suo mondo di memorie operando una sostituzione, graduale ma
non irreversibile, della lingua serbo-croata con quella italiana.
L’italiano si configura per Božidar come la “lingua
dell’essenziale” contrapposta alla lingua “delle sfumature”93, e
quest’essenzialità narrativa diviene evidente anche
stilisticamente: nel passaggio dall’una all’altra lingua il
93 Intervista in Quarto Seminario degli scrittori migranti, da Sagarana, sul sitowww.sagarana.net/scuola/seminario4/home.htm
LX
linguaggio si fa più scarno, quasi telegrafico, antinaturalistico
e rarefatto.
Non è un caso che uno dei più recenti lavori di questo
autore sia una piece teatrale, intitolata Il sogno del mio amico
Orlando94, in cui la storia di un pacifista disilluso si intreccia a
quella di due profughi bosniaci, Ivan e Petar, che in una
lunghissima conversazione telefonica si confrontano sul
proprio passato, e sulla nuova vita, che conducono l’uno in
Canada e l’altro nella provincia del nord-est italiano.
Ivan ha mantenuto il ricordo della patria e dell’identità
perdute, e vive il proprio sradicamento diviso tra memoria e
speranza; Petar, gettato via l’inutile fardello del rimpianto, si è
ormai convinto che adattarsi al nuovo mondo, dimenticare chi
era, sia l’unico mezzo per sopravvivere all’ondata del passato
che ritorna: accusato dall’amico di miope cinismo, si difende
avvertendolo che “essere normali è più che necessario... Più
che necessario...”.
L’utilizzo del linguaggio teatrale, quindi il ricorso quasi
esclusivo al discorso diretto, permette a Božidar di condensare
in poche righe una grande intensità emotiva. Il confronto tra i
due amici, i cui sguardi sulla vita sono ormai irrimediabilmente
divergenti, diventa un’amara constatazione del pericolo insito
nella negazione della propria memoria storica, e un fervente
invito a salvare se stessi dall’oblio.
Ivan: Hai ricevuto la mia lettera?
Petar: La tua lettera? Nessuna lettera, da nessuno... Qui ormai
la posta viene usata soltanto per spedire materiali
pubblicitari e gli auguri per Natale... Che lettera!
94 Božidar Stanišić , “Il sogno del mio amico Orlando”, in «Kúmá, rivista di arte e letteratura“creola”», direttore Armando Gnisci, sul sito www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html
LXI
Ivan: In quella lettera che non è ancora arrivata ti ho scritto
di Orlando...
Petar: Orlando? Di chi stai parlando?
Ivan: Orlando, uno dei miei migliori amici...
Petar: Orlando, Orlando, Orlando...?
Ivan: Non ricordi?
Petar: O, Dio...(cammina frettolosamente) Aspetta...
Ivan: Ti ricorderò io... Dieci anni fa...
Petar: (tenta di scherzare) Dieci anni fa, quindi in un secolo
passato, in un millennio dietro le nostre spalle...95
Attraverso la sua scrittura complessa e stratificata, ricca
di incisi e parentesi che si nutrono di diversi linguaggi, da
quello pubblicitario a quello giornalistico, da quello del parlato
quotidiano a quello della tradizione popolare balcanica,
Stanišić riflette la frammentazione dell’identità del migrante e
l’incertezza dell’esistenza.
Il libro del 2003 Bon voyage raccoglie due racconti, uno
dei quali è la narrazione di un viaggio in treno compiuto dal
protagonista, Mirko, attraverso il nord Italia.
E’ un racconto polifonico, in cui le voci dei viaggiatori
(“una vecchietta con un cappellino di velluto nero”, un giovane
“dagli occhi brillanti”, un “critico dei ladri di orizzonti”, un
“giovane nero” studente di medicina) si intrecciano in un
dialogo in cui è spesso udibile la voce dell’autore.
Mirko non interviene nella discussione, ma i suoi pensieri
sono indagati da Božidar, che li insegue attraverso il loro
scontrarsi con l’esterno, perlopiù con i cartelloni pubblicitari
che scorrono fuori dal finestrino.
“(Un attimo prima il nostro viaggiatore era stato guardato
dall’orso bianco di un’insegna pubblicitaria:
95 Božidar Stanišić, ibidem.
LXII
ACCOMODATEVI…non era riuscito a leggere: le esigenze
del nostro tempo che chiede ecc. ‘Risposte? Urgenti o attuali?’
sussurrò nella lingua da cui si era allontanato nel tempo e nello
spazio).”96
Nei suoi testi, che egli chiama non-poesie o qualcosa-
come-racconti, emerge costantemente la difficoltà di
testimoniare, che si scontra con la necessità morale di
continuare a farlo. Nel gioco di incastri intertestuali e nella
sperimentazione linguistica entrano spesso domande esistenziali
che è l’autore stesso a suggerire al personaggio.
Come accade per Lela, la protagonista de Il rapimento,
che, abbandonata ormai la Bosnia per vivere in Italia, e
scoprendo sulle pagine dell’Oslobodjenje la morte del suo
amato, si ritrova a pensare: “la morte è un oblio e una
lontananza che devo attraversare”.97
I testi di Stanišić nascono dal “cuore” dell’esilio; la guerra
non è mai attesa – tranne in alcuni racconti della raccolta I
buchi neri di Sarajevo, scritti però nel 1992 – ma è sempre già
stata vissuta: il protagonista è sempre qualcuno che fa i conti
con il proprio post-conflitto interiore.
E quest’intima esplorazione conduce spesso al sogno di
un’altra esistenza, al desiderio di negare la propria identità per
cancellare il proprio passato, quando non all’estrema
conseguenze di questa negazione, la follia.
Questo è ciò che succede a Neven O., nel lungo racconto
Il giardino di Mr. O’Brien, quando tenta di liberarsi di un
passato troppo ingombrante cambiando nome e paese, e
addormentandosi ogni notte sognando di essere qualcun altro.96 Božidar Stanišić, Bon voyage, Nuova dimensione, Portogruaro, 2003, p.1897 Božidar Stanišić, “Il rapimento”, in Parole oltre i confini, autori vari a cura di San Giorgi Roberta
e Ramberti Alessandro, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1999, p. 191
LXIII
Il primo passo verso l’oblio Neven lo compie distruggendo
tutti i ritagli di giornale, fino ad allora gelosamente custoditi,
riguardanti la guerra che sta dilaniando il suo paese; “così
comincia la liberazione dal passato, la negazione del presente e
il pensiero del futuro di Neven O. : buttando i ritagli di giornale
nella carta vecchia”.
Diventato ormai Virgin O’Brien, uomo di successo che in
Australia si spaccia per sudafricano con origini montenegrine,
soddisfatto della sua ricca mediocrità, Neven dovrà alla fine
affrontare i fantasmi del suo passato.
Le ombre delle persone che ha abbandonato (il suo
commilitone al fronte, con cui aveva progettato la fuga, un
compagno di liceo, poeta e rivoluzionario, il primo amore, una
ragazzina bionda di Mostar, l’anziana madre…) verranno a
cercarlo per ricordargli chi è davvero.
“Un uomo non può avere due mari al mondo”98, lo
ammonisce il padre; e Neven, che ha ossessivamente tentato di
fuggire da sé, perderà completamente la capacità di ritrovarsi.
Narratore abile e colto, Božidar Stanišić utilizza le armi
della parola dell’ironia per scovare l’umanità anche in mezzo
alla distruzione del conflitto, per cercare uno spiraglio di
speranza anche per chi è “in fuga dalle cuciture fra i mondi”.99
Una delle liriche contenute nella raccolta Non-poesie,
intitolata Simile a rosa incantevole100, scritta nel 1995, si
conclude con questi versi:
“…Dio, Ti ringrazio per i doni che mandi, anche a noi,
che siamo, da così tanto tempo, sulla bassa terra,
e perdona la mia stanchezza, in un giorno in cui la mia
anima,98 Božidar Stanišić, “Il giardino australiano di Mr Virgin O’ Brien”, in Bon voyage, Nuova
dimensione, Portogruaro, 2003 p. 9899 Božidar Stanišić, Tre racconti, Associazione culturale “E. Balducci”, Zugliano, 2002, p.24100 Božidar Stanišić, “Simile a rosa incantevole”, in Non poesie, Associazione culturale “E.
Balducci”, Zugliano 1995
LXIV
tuttavia, la primavera intuisce.”
3.6 La lingua italiana
Ciò che appare certo nelle opere di tutti questi autori è
che risulta quasi impossibile per loro trovare un luogo in cui si
possa ormai essere davvero se stessi, non c’è una lingua
abitabile che sia davvero la propria.
Il rapporto con la lingua è uno degli aspetti più complessi
e interessanti della produzione letteraria della migrazione; lo
scrittore migrante utilizza, nelle sue opere, la lingua del paese
d’arrivo: e in questa scelta, audace e “fisiologica” ad un tempo,
si rispecchia l’elemento fondamentale della scrittura migrante,
ovvero, secondo una definizione di Julio Monteiro Martins,
“una deterritorializzazione interiore ed esteriore, (…)
straordinariamente fertile”101.
L’ostranenie, quello straniamento che Josif Brodskij
considera alla base di ogni produzione artistica, si concretizza
nel vissuto di chi è costretto ad abitare due culture, due lingue.
In un testo intitolato significativamente Il ponte Vesna
Stanić, scrittrice croata residente in Italia da venticinque anni,
parla dello sradicamento vissuto da ogni migrante; e spiega che
esso si configura come “una sensazione di non appartenenza a
nessun luogo. Ci si allontana dalla propria cultura e lingua e si
sente una nostalgia immensa, ci si avvicina ad un’altra e non si
diventa mai veramente suoi figli.”
101 Julio Monteiro Martins, Intervista in Quarto Seminario degli scrittori migranti, da Sagarana, sulsito
www.sagarana.net/scuola/seminario4/home.htm
LXV
Si vive “come su un ponte: né di qua, né di là.” Ben
coscienti che ogni ponte unisce solo se lo si attraversa, gli
scrittori migranti operano una costante oscillazione linguistica:
perché l’utilizzo di una lingua diversa da quella madre può
essere sia uno strumento di collegamento tra sé e la nuova
realtà culturale in cui si desidera integrarsi, sia il filtro
necessario attraverso cui guardare con distacco un passato
toppo doloroso.
E se l’italiano, la più ricca stratificata tra le lingue
europee, da quest’incontro esce modificato e in qualche modo
“tradito”, è un tradimento fecondo quello che subisce.
Perché attraverso di esso diviene veicolo di messaggi che
non possiamo più ignorare; e, soprattutto, perché quest’italiano
che si presta a chi non l’ha imparato da bambino, si modella, si
rinnova, risultando sicuramente più interessante di quello
stanco e un po’ banale di certi scrittori alla moda.
Tornando allo specifico degli autori fin qui considerati, la
lingua italiana si piega alle loro esigenze letterarie fluida,
docile, a volte esitante, ma mai clamorosamente sbagliata.
E se stride, stride nella creazione di neologismi/refusi
che, a ben analizzarli, sembrano rendere l’idea voluta molto
più precisamente di quanto possa fare qualsiasi parola
dell’italiano corretto: come quando Spale Miro Stevanović, di
una poesia che può essere recitata a due voci col proprio
amante, suggerisce di declamarla – molto più sensualmente -
“a due bocche”; o quando, nella penna di Tamara Jadreičić, un
divano di cuoio logoro, segnato dal tempo e dalla vita dei suoi
proprietari, non è più di un neutro color “marrone”, ma
teneramente si degrada in “marrognolo”.
LXVI
La lingua rimossa dell’infanzia ritorna, ad inquinare e
rinsanguare un italiano che non è più solo il nostro, in una
mescolanza inedita che rende la parola di questi autori
sperimentale, essenziale e ricca di sfumature allo stesso tempo.
Se poi l’idioma lasciato dietro di sé è quel serbo-croato
sfinito da anni di strumentalizzazioni sistematiche, la scelta
della nostra lingua (lingua dell’essenziale e barriera
necessaria, secondo le già citate definizione di Stanišić e
Slaven), equivale ad acquistare un nuovo centro di gravità
culturale senza perdere se stessi e la propria complessità.
Gli scrittori della diaspora balcanica ci mostrano quindi il
volto di un’Europa che dobbiamo imparare a ri-conoscere come
parte integrante del nostro bagaglio culturale; e se lo fanno
nella nostra lingua, e abitando la nostra terra, è perché siamo
noi, ormai, gli interlocutori del loro dolore.
LXVII
“Nessuno può immaginare cosa significhi
nascere e vivere al confine tra due mondi,
conoscerli e comprenderli ambedue
e non poter far nulla per avvicinarli, amarli entrambi
e oscillare fra l’uno e l’altro per tutta la vita,
avere due patrie e non averne nessuna,
essere di casa ovunque e rimanere estraneo a tutti,
in una parola, vivere crocefisso
ed essere carnefice e vittima allo stesso tempo”
Ivo Andrić
LXVIII
La dolorosa sensazione di non appartenenza – vera
costante sottesa a tutte le opere fin qui analizzate – diviene
specchio, nelle opere degli autori balcanici, di una realtà
storica di tragica instabilità.
La vita ormai “uscita dal binario”, deviata per sempre da
una normalità impossibile da riconquistare, viene resa
possibile (che tanto basta alla sopravvivenza: una possibilità)
attraverso l’esercizio letterario, che da sempre si propone come
“casa comune” o patria d’elezione a chi non ha patria: gli
scrittori e gli apolidi; nel caso – non così raro – che le due
condizioni convivano (o coincidano), essa diventa una vera e
propria “sovrapatria”.
Nel parlare di patrie d’elezione, sovrapatrie, apolidi e
migranti, pensiamo di sottolineare quasi insignificanti
questioni terminologiche e ci accorgiamo invece di andare
all’essenza del problema: la questione identitaria. Che è – lo
abbiamo visto nel primo capitolo - il fondamentale filtro
attraverso cui leggere ed interpretare le opere di ogni autore
migrante, e che assume un significato di particolare rilevanza
per gli autori dei Balcani.
Perché è sulla questione identitaria che si sono innestate
le ideologie ultranazionaliste da cui è deflagrato il conflitto, e
perché difendere la propria identità (se non di jugoslavi in
senso politico almeno di slavi del sud in senso culturale) è
diventato un modo, forse l’unico, per risollevarsi sulle macerie
del proprio passato. Bisogna difendere la pluralità culturale
come unico anticorpo contro l’omologazione, dice Jarmila
Očkajova; questa potente verità letteraria (ma anche
esistenziale) valida per ogni autore migrante, diventa
LXIX
paradigmatica per il migrante balcanico; che della negazione
di sé ha avuto direttamente esperienza attraverso quell’atroce e
insensato tentativo di massificazione che è la guerra etnica.
Eppure la con-vivenza culturale, la necessità di affermare
se stessi senza annientare l’altro, siamo ormai costretti a
riconoscerla (l’abbiamo già visto parlando della nascente
creolizzazione planetaria di cui gli scrittori migranti sono i
portavoce) come elemento vivificatore e innovatore di ogni
cultura; dovremmo ormai essere coscienti che “la questione
non solo dei Balcani, ma del futuro europeo non consiste nel
radicamento e nella difesa delle identità particolari, esclusive,
ma nella capacità di uno sviluppo armonioso di identità
plurime”102.
Pretendere che ogni identità sia limitata ad
un’appartenenza definita alla nascita, è quantomeno
anacronistico; perché presuppone un’idea ormai superata, e
cioè che, usando le parole di Tzvetan Todorov, “la cultura sia
un codice immutabile, cosa empiricamente falsa”103 .
Al contrario: come afferma l’antropologa Arianna
Dagnino, “l’uomo è un improvvisatore culturale”, e di questa
capacità creativa sono dotati, in modo particolare, gli scrittori
migranti, che vivono, in una sola vita, più vite; e che ci
accompagnano, coi loro testi, verso una nuova definizione
culturale possibile: “ci avviamo verso l’Utopia”, afferma
Božidar Stanišić.
Non possiamo non riconoscere di avere il diritto/dovere
di accoglienza e di ascolto nei confronti dei migranti (e degli
scrittori migranti) che arrivano sulle nostre coste: tanto più nel102 Melita Richter, Sono le soglie, non i confini, a facilitare l’incontro, in Osservatorio sui Balcani,
sul sito www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/2889/1/50/103 Tzvetan Todorov, L'uomo spaesato. I percorsi di appartenenza, Donzelli Roma, 2000, p. 11
LXX
caso di migranti della ex-Jugoslavia, e tanto più noi Italiani,
che dai Balcani siamo divisi da solo dalla striscia di mare che
costituisce l’Adriatico. (I greci e i romani alternavano, per
definirlo, i termini di “golfo” e “mare”; questa duplicità ne
accompagna la storia, dice Matvejevic, e sicuramente accorcia
le distanze, almeno ideologiche, tra “noi” e “loro”.)
E proprio gli autori fin qui considerati si pongono come
necessario e fecondo punto di raccordo tra quel “noi” e quel
“loro” i cui rapporti è necessario tornare ad indagare.
A partire da una concezione che non preveda confini, ma
ponti: che sia possibile attraversare, perché un ponte non
attraversato presume la diversità che sta al di là del fiume, e
separa, invece di unire.
Nel luglio 2004, il Vecchio Pomte di Mostar, lo Stari, è
stato restituito ai mostarini, e al mondo, completamente
ricostruito.
Durante una cerimonia di grande suggestione, e di
profondo impatto, molte personalità internazionali hanno
commentato l’importanza, anche simbolica, dell’evento.
Predrag Matvejeic, il 24 luglio, all’ex Teatro dei
Burattini, si è espresso su questo fatto dicendo:
“Il ponte di Mostar è stato ricostruito; ma si potrà dire
che la sua ricostruzione sarà completata quando tutti i
mostarini, di ogni origine ed etnia, vi avranno lasciato le loro
impronte.”
Quello che Matvejevic auspica per il Nuovo Vecchio
della sua città, è quello che gli scrittori migranti dai Balcani
già fanno per noi: camminano sui ponti tra noi e loro, si
pongono come mediatori, punti di contatto, equilibristi,
LXXI
facilitando l’incontro, e la contaminazione, tra “questa”
Europa, che è già qui, e l’altra, che attende.
Paolo Rumiz, che dell’Oriente dell’Europa (Oriente dalla
“grande anima”, come è solito chiamarlo) ha fatto l’oggetto di
numerosi studi – o il soggetto di un colloquio appassionato – si
chiede a chi possa interessare, ormai, occuparsi di Balcani, e di
ex-Jugoslavia, per rispondere immediatamente che una tale
analisi dovrebbe interessare l’Europa tutta.
Perché “la guerra in Jugoslavia non era una cosa
Jugoslava. Era una malattia europea, anzi mondiale (…). Il
buco nero in cui guardare siamo noi, ricchi, sazi, frastornati,
dunque poveri di percezione e impauriti di fronte alla
complessità”104.
Non solo: lo scrittore Dževad Karahasan, bosniaco
migrato in Germania nel 1994, sostiene, nel suo libro del 1995
Il centro del mondo. Sarajevo, esilio di una città: “La prova
della tua esistenza non sta nel fatto che tu pensi, come pensava
un signore molto intelligente. La prova del fatto che tu esisti te
la dà il fatto che qualcun altro pensa a te”.105
Aprire le porte alla complessità, e ridare esistenza e
solidità all’identità – culturale ma non solo – dei figli della
diaspora balcanica: questo sembra essere l’invito che le opere
di questi autori ci porgono, ed è anche un’inestimabile
opportunità che viene donata all’ Europa.
Poiché tentare di comprendere le vicende di questo
“brandello esausto” del nostro continente, ascoltare le voci di
chi è giunto sulle nostre terre armato della sua preziosa
104 Paolo Rumiz, prefazione a Bon voyage, Božidar Stanišić Nuova dimensione, Portogruaro, 2003,p.7-8
105 Dževad Karahasan “Il centro del mondo. Sarajevo, esilio di una città” citato da Armando Gnisci,Creoli mitici migranti clandestini ribelli, Meltemi, Roma, 1998, p.115
LXXII
testimonianza, significa riscoprire un nuovo modo di intendere
l’Europa, e la cultura europea.
Affrontare questa riscoperta dal punto di vista della
letteratura, e rimanendo consapevolmente dalla parte di chi fa
letteratura, vuol dire infine porsi, senza esitazioni, dalla parte
del liberamente umano.
LXXIII
BIBLIOGRAFIE
Gli autori
Andrić Ivo, Racconti di Bosnia, Newton Compton, Roma, 1995
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Le vocidell’Arcobaleno, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1995
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Mosaici diinchiostro, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1996
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Memorie inValigia, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1997
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Destini sospesidi volti in cammino, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1998
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Parole oltre iconfini, FaraEditore, Santarcangelo di Romagna, 1999
Lecomte Mia, a cura di, I cittadini della poesia in Quaderno balcanico I,Loggia dei Lanzi, Firenze, 2000
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Anime inviaggio, Adnkronos, Roma, 2001
Autori vari a cura di Sangiorgi Roberta e Ramberti Alessandro, Il doppiosguardo. Culture allo specchio, Adnkronos, Roma, 2002
Lecomte Mia, a cura di, I cittadini della poesia in Quaderno balcanico II,Loggia dei Lanzi, Firenze, 2001
Slaven Vera, Cercasi Dedalus disperatamente, Tracce, Pescara, 1997
Smitran Stevka, Itaca e oltre,Tracce, Pescara, 2004
Stanić Vesna, L’isola di pietra, AIEP, Repubblica di San Marino, 2000
Stanišić Božidar, Bon voyage, Nuova dimensione, Portogruaro, 2003
Stanišić Božidar, I buchi neri di Sarjevo e altri racconti, Mgs Press, Trieste,1993
Stanišić Božidar, Metamorfosi di finestre, Associazione culturale “E.Balducci”, Zugliano 1998
LXXIV
Stanišić Božidar, Non poesie, Associazione culturale “E. Balducci”, Zugliano1995
Stanišić Božidar, Primavera a Zugliano, Associazione culturale “E.Balducci”, Zugliano 1994
Stanišić Božidar, Tre racconti, Associazione culturale “E. Balducci”,Zugliano, 2002
Stevanović Spale Miro, Le confessioni, Opera, Venezia , 2001
Inediti
Jadrejčić Tamara, I prigionieri di guerra
Jadrejčić Tamara, Il bottino
Jadrejčić Tamara, Il bambino che non si lavava
Jadrejčić Tamara, L’abito da sposa
Jadrejčić Tamara, La guerra di mira
Jadrejčić Tamara, La poltrona rossa
Jadrejčić Tamara, Una questione di fiducia
Testi critici
Bogdan Hernry, Storia dei paesi dell’est, SEI-Società Editrice Internazionale,Torino, 1991
Bregola Davide, Da qui verso casa, Edizioni Interculturali, Roma 2002
Brodskij Iosif, Dall’esilio, Adelphi, Milano 1998
Gnisci Armando, a cura di, Introduzione alla letteratura comparata, BrunoMondatori, Milano 1999
Gnisci Armando, Creolizzare l’Europa. Letteratura e migrazione, Meltemi,Roma, 2003
Gnisci Armando, Creoli mitici migranti clandestini ribelli, Meltemi, Roma,1998
LXXV
Gnisci Armando, La letteratura italiana della migrazione, Lilit Edizioni,Roma, 1998
Gnisci Armando, Una storia diversa, Meltemi, Roma, 2001
Glissant Edouard, La poetica del diverso, Meltemi, Roma,1998
Krulic Josip, Storia della Jugoslavia dal 1945 ai giorni nostri, Bompiani,Milano 1999
Kundera Milan, Itestamenti traditi, Adelphi, Milano, 1994
Kundera Milan, L’arte del romanzo, Adelphi, Milano, 1988
Kundera Milan, L’ignoranza, Adelphi, Milano, 2000
Le Breton Jean Marie, Una storia infausta. L’Europa centrale e orientale dal1917 al 1990, Il Mulino, Bologna, 1997
Magris Claudio, Danubio, Garzanti, Milano, 1997
Magris Claudio, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna,Einaudi, Torino, 1996
Matvejević Predrag, Ex-Jugoslavia, diario di una guerra, Magma, Napoli
Matvejević Predrag, Mondo “ex”, Confessioni. Identità, ideologie, nazioninell’una e nell’altra Europa, Garzanti, Milano 1996
Matvejević Predrag, Tra asilo ed esilio. Romanzo epistolare, Meltemi, Roma1998
Moretti Giampiero, Heidelberg romantica. Romanticismo tedesco e nichilismoeuropeo, Guida, Napoli 2002
Motta Giovanna a cura di, I turchi il mediterraneo e l’Europa, Franco Angeli,Milano 1998
Pirjevec Jože, Le guerre jugoslave 1991- 1999, Einaudi, Torino 2001
Prévélakis Georges, I Balcani, Il Mulino, Bologna, 1997
Richter Melita, Identità e genere nel conflitto jugoslavo, (libro inpreparazione)
Rumiz Paolo, E’ Oriente, Feltrinelli, Milano 2003
LXXVI
Todorov Tzvetan, L’uomo spaesato. I percorsi di appartenenza, Donzelli,Roma, 2000
Riviste e sitografia
«I Quaderni 1. 98», Luglio 1998, Associazione Fondo Moravia, a cura di ToniMaraini, Roma
«Pagina Zero. Letterature di frontiera», Quadrimestrale di letterature, arti e culture,Maggio 2004 – Numero 4, Direttore Mauro Daltin, Sede Cervignano del Friuli, (UD)
«Pagina Zero. Letterature di frontiera», Quadrimestrale di letterature, arti eculture, Ottobre 2004 – Numero 5, Direttore Mauro Daltin, Sede Cervignanodel Friuli, (UD)
Kuma, rivista di arte e letteratura creola, a cura di Armando Gniscihttp://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html
Osservatorio sui Balcani, per uno sviluppo umano, democratico e responsabiledell' est Europa http://www.osservatoriobalcani.org/
Sagarana, Rivista letteraria trimestrale on-line, direttore Julio MonteiroMartins www.sagarana.net
El Ghibli, rivista on line di letteratura della migrazione, direttore responsabilePap Kohuma http://www.elghibli.it/
LXXVI