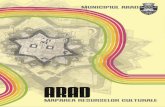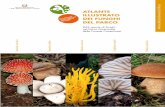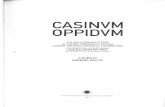Nuove considerazioni su alcuni sarcofagi del Museo archeologico dell’Hatay
Parco archeologico culturale di Tuscolo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Parco archeologico culturale di Tuscolo
Periodico romano di approfondimento culturale: arti, lettere, spettacolo
“...non più una cul-tura che consoli nel-le sofferenze, ma unacultura che proteggadalle sofferenze, chele combatta e le eli-mini...”Elio Vittorini, 1945
“Scrivere non è descri-vere. Dipingere non èrappresentare.”
George Braque
VE
SP
ERT
ILLA
- Ann
o X
II -
n°3
mag
gio-
giug
no 2
015-
prez
zo 5
eur
o
2
VESPERTILLA
Direttore Responsabile: Serena Petrini
Direttore Editoriale: Luigi Silvi
Condirettore: Ilaria Lombardi
Vicedirettori: Serena Epifani, Francesca Martel-lini
Segretaria di Direzione: Maria Pia Monte-duro
Hanno collaborato a questo numero: Michela Barbieri, Giulia Capogna, Micaela DeFilippo, Ada Foschi, Silvia Guidi, MarinaHumar, Ilaria Lombardi, Francesca Martellini,Maria Pia Monteduro, Sofia Orsino, Sibilla Pa-nerai, Laura Ruzickova, Luigi Silvi, Ofelia Sisca.
La collaborazione sotto ogni forma è gratuita
Impaginazione grafica: Maria Pia Monte-duro
Editing: Francesca Martellini
Editore:Associazione Culturale ANTICAMentevia Sannio 21, 00183 Roma
INFO [email protected]@tiscali.it
Pubblicazione registrata presso il TribunaleCivile di Roma n. 335-05.08.2004
Stampa:Copypoint - via de’ Funari 25 00186 Roma
Doganalisti specializzati in Mostre d’Ar tePadova Rovigo Vicenza
Tutte le operazioni doganal i e le istanzepr esso la Sovr intendenza al le Bel le Ar t iper r epert i ar cheologic i e opere d’ar tepr ovenient i da l l ’estero e inv iat i a l l ’e-stero per esposiz ioni e scambi cul tural i .
PADANA SPEDIZIONI S.A.S.SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI
Padana Spedizioni S.a.S.
35127 Padova-Zona Industriale-Corso Stati Uniti, 18
Telefono (049)8702322 - Telefax (049)8702327
e-mail [email protected]
Codice fiscale e Partita I.V.A. 00289000283
3
SEZIONE ARCHEOLOGIA
Sommario
BERE INSIEME SINTESI DELAL DEMOCRAZIA DELLA POLISIn alto i kantharoi. Acquarossa a banchetto, Museo Nazionale Etrusco, Rocca Albornoz (Viterbo), di Luigi Silvi PAG. 4
ROMANIZZAZIONE DELLA PIANURA PADANABrixia. Roma e le genti del Po, un incontro di culture III-I secc. a.C., Santa Giulia Museo della Città (Brescia), di LuigiSilvi PAG. 6
IL MARE RICONSEGNA UNA SPADA DEL TEMPO DELLE CROCIATESpatha. Dal mare una spada con 1000 anni di storia, Museo Archeologico della Laguna (Marano Lagunare),di Luigi Silvi PAG. 28
PARCO ARCHEOLOGICO CULTURALE DI TUSCOLO, di Marina Humar PAG. 32
IL TEMPIO DI MATIDIA A CAMPO MARZIO: MATIDIA SUOCERA FORTUNATA O VEICOLO DI PROPADANDA POLITICA?di Marina Humar PAG. 46
4
Ar cheologia
BERE INSIEME SINTESI DELLA DEMOCRAZIA DELLA POLISIN ALTO I KANTHAROI. ACQUAROSSA A BANCHETTO, Museo Nazionale Etrusco, Rocca Albornoz (V
5
Ar cheologia
Il cerimoniale del simposio ha origine inOriente nel corso dell’VIII secolo a.C., dovesi caratterizza con prerogative esclusiva-mente regali. Raggiunge l’Etruria tramite lacolonizzazione greca dell’Italia meridionale.Trattasi di rituale di forte valenza sociale erappresenta l’unità della classe egemone cheostenta il proprio lusso e la propria ric-chezza, e di conseguenza il proprio potere,esibendo ornamenti, arredi e vasellame raf-finati e di gran valore. Gli Etruschi pren-dono dal simposio greco sia gli aspettiesteriori che le implicazioni culturali. Il sim-posio è la pratica cerimoniale che seguiva ilbanchetto, quella dedicata al bere. Nel corsodi tale cerimonia i commensali bevevano se-condo le prescrizioni del simposiarca (capodel banchetto), scelto per estrazione. Il vinoera accompagnato da formaggi, olive, fruttasecca, stuzzichini salati e piccanti e venivamiscelato con acqua (una parte di vino, dueparti d’acqua), perché il vino troppo ubria-cante era considerato usanza barbarica; vi siaggiungevano miele ed erbe aromatiche; avolte era rinforzato con formaggio, comeconfermano le grattugie ritrovate negli am-bienti dedicati al simposio. I convitati into-navano skolla, canti conviviali originari diLesbo (VII sec. a.C.), recitavano carmi, dan-zavano e si dedicavano a conversazioni coltee argute; ascoltavano e anche direttamentesuonavano akroabata, musiche eseguite conl’aulos, la lyra e la cetra, a volte con il cro-talo e piccoli tamburi. Il simposio raccogliei valori che rendono nobile l’uomo: vera apropria forma di conoscenza, cui si accedeabbandonandosi alle pratiche previste dalrituale. Il simposio era una componente fon-damentale della vita della polis. Si svolgevain un’ala separata e riparata della casa, dovenon era consentito l’accesso alle donne spo-sate e ai bambini. Consisteva in una sanatrasgressione delle regole, non poteva cele-brarsi prima del tramonto, non si dovevamai bere da soli, ma sempre in gruppo. Leetere, uniche donne ammesse al simposio,danzavano e suonavano. I convitati che nonsapevano suonare, segnavano il ritmo delproprio canto battendo il tempo con aisakos(ramoscello di alloro o di mirto); a volte mu-siche e danze erano affidate a compagnieprofessioniste specializzate di danzatori emusici. Scopo principale del simposio era loscambio di idee e di opinioni. I convitati sidedicavano anche a vari intrattenimenti lu-dici, indovinelli ed enigmi, e soprattutto algioco del kottabos, che consiste nel lancio
delle ultime gocce di vino rimaste nelletazze per colpire plasthinghes (piattelli) dibronzo collocati su un rhabdos kottabike (astadi bronzo). Tali piattelli erano posati inequilibrio precario: il successo consistevanell’andare a segno con la goccia facendolicadere, provocando così gran clangore. Lakylix veniva appoggiata al polso, facendopresa sull’indice; le gocce venivano scagliateda posizione sdraiata ed erano accompa-gnate da un gesto di lancio. Il kottabos con-serva tracce di antichi significati augurali esacri; era legato ai riti di libagione, che con-sistevano nello spargere vino per terra. Ilgesto aveva anche valenza erotica e di ferti-lità, simile a quella del lancio del giavel-lotto, ed era accompagnato dall’invocazionedel nome della persona di cui si desidera-vano i favori. I convitati partecipavano alsimposio sdraiati su letti, davanti ai quali sutavolini bassi erano coppe a bacili; a dispo-sizione dei commensali anche alcuni inser-vienti. Il vino già preparato fuoridall’ambiente in cui si svolgeva la cerimoniaera contenuto nel kantharos, tazza a dueanse, emblema di Dioniso, grande recipientein ceramica o in bronzo, a volte in argento ooro. Con oinochoe (brocche) il vino venivaversato nei recipienti utilizzati per bere:kylix, skiphos, kotyle. Venivano utilizzati me-stoli di varie dimensioni e forme per servireil vino e anche per dosare gli ingredienti ecolini per filtrare il vino prima di servirlo.Nella sala in cui si svolgeva il simposio vierano bruciaprofumi e bracieri nei quali ve-nivano combuste sostanze aromatiche. Du-rante le stagioni calde il ghiaccio sostituival’acqua; oppure il vino era mantenutofreddo nello psykter, apposito recipiente cheveniva tenuto immerso nel ghiaccio. Al sim-posio seguiva il komos, che consisteva nelloscendere nelle strade in corteo, spesso dicarri, per far baldoria ubriachi in compagniadelle etere. La mostra ripropone oggetti fun-zionali, stoviglie e strumenti utilizzati nelsimposio, come raffigurati nella lastra di Ac-quarossa, che presenta una dettagliata de-scrizione di scena di simposio, proponendoreperti anche inediti, provenienti dai depo-siti del museo e da collezioni private. In par-ticolare utensili di servizio in bronzo eceramica, di produzione sia greca che etru-sca dalla Necropoli di Olmobello a Bisenzio,che consentono di apprezzare la grande ori-ginalità degli apparati per il simposio etru-sco in età arcaica.
Luigi Silvi
LA DEMOCRAZIA DELLA POLISbornoz (Viterbo)
6
Ar cheologia
Brescia, romana Brixia, al centro della PianuraPadana, allestisce una mostra che per la primavolta illustra le vicende che tra III e I secolo a.C.portarono all’unione tra Roma repubblicana e gliabitanti della valle del Po. Un’epopea di incontri,ma anche di scontri di civiltà e di profonda inte-grazione. Epopea i cui protagonisti sono Anni-bale, Scipione, Emilio Lepido, Mario, Silla, laRoma repubblicana, la Gallia Cisalpina. Da que-sta storia tra pace e guerra nasce un nuovo mo-dello sociale: si assiste alla trasformazione, intermini di modernizzazione, del territorio: tra-sformazione innanzi tutto sociale e culturale, maanche fisica con disboscamenti, bonifiche, messea coltura, fondazioni di città che vengono uniteda grandi strade. La mostra, curata con altascientificità, ripropone e analizza la romanizza-zione di tutta la Pianura Padana come alto mo-mento di integrazione di un luogo d’Italia chedivenne laboratorio appunto d’integrazione traetnie e culture diverse e uno dei luoghi del con-fronto tra cultura greca e cultura romana. La mo-stra inizia con i ritratti dei protagonisti, letradizioni delle popolazioni che vi vivevano e iprimi segnali di apertura a messaggi culturalinuovi e diversi. Sono esposti: lamine in bronzoda Castiglion dello Stiviere (III sec. a.C.) decoratea sbalzo, pertinenti carnix (tromba da guerra) e aelementi di animale totemico; busto fittile diguerriero da Ravenna (III sec. a.C.), scultura interracotta raffigurante giovane guerriero in nu-dità eroica con balteo e clamide, frutto di un’at-mosfera culturale già profondamente ellenizzata.La guerra e la propaganda romana, forma lungi-mirante di fidelizzazione per mezzo dell’assimi-lazione in una nuova ideologia religiosa deisantuari sparsi nella città e sul territorio, vincolatia tradizioni locali, come già avvenuto in Lazio.Ne sono testimonianza il frontone in terracottadi Talamone (fine III, metà II sec. a.C.) con altori-lievi effigianti i Sette contro Tebe e acroteri informa di cavalli marini: secondo alcuni studiosi èda collegarsi alla vittoria contro i Galli nel 255a.C. avvenuta nei pressi di Talamone, il rilievo nerappresenterebbe la trasposizione in chiave sim-bolica e mitica; la lamina votiva di bronzo prove-niente da Vicenza (II sec. a.C.) lavorata a sbalzoe incisione con corteo di donne di alto rango ad-dobbate e vestite sontuosamente; altre lamine(IV-III sec. a.C.) con teorie di dignitari, armati eatleti, proveniente da luogo di culto probabil-mente dedicato a divinità protettrice della città,guaritrice e garante dei passaggi della vita. Sonoesposti inoltre per la prima volta corredi funebridi guerrieri provenienti dalla valle padana, conarmi sia di combattenti romani che appartenentia popolazioni autoctone. La fondazione delle
grandi città inserite in un’efficiente rete viaria,segno questo della definitiva romanizzazionecon l’adozione di modelli urbanistici e architet-tonici comuni, con precise esigenze sia ideologi-che che funzionali come attestano la simapolicroma fittile decorata con testa di gorgone etesta di leone (II-I sec. a.C.). Pavimento in opuscoementicium da Sarsina decorato con tesserebianche e nere (fine II sec. a.C.); letto decoratocon elementi in osso da Piacenza (II sec. a.C.) conscene simboliche raffiguranti erote o giovaneDioniso sostenente cornucopia con anfora aipiedi; sui fulcra (poggiatesta) decorazioni ad altorilievo con busti di eroti alati e leoni accovacciati:aveva funzione rappresentativa del rango del suoproprietario. I rituali legati alla morte ripropon-gono l’incontro tra culture, immagine e memoriasi fondono secondo codici espressivi antichi enuovi allo stesso tempo. Stele di Ostalia Galleniada Padova (I sec. a.C.) raffigurante scena di viag-gio agli Inferi: l’auriga e un uomo in costume ro-mano e una donna abbigliata secondo la foggiavenetica, su biga tirata da due cavalli. Importantetestimonianza di transizione alla romanizzazionela Stele di Komevios da Torino (fine II sec. a.C.)proveniente dalla necropoli celtica di Dormel-letto, che propone testa maschile con ai lati duemotivi circolari concentrici, richiami al disco so-lare. Razionalizzazione dei paesaggi e della cam-pagna per dare maggiore impulso alle attivitàagricole, a quelle economiche e agli scambi conruolo fondamentale della viabilità, che collegacittà e campagne con una rete di comunicazioneparticolarmente efficiente che aggrega anche isantuari periferici dedicati agli dei del territorio,assimilando la tradizione celtica a quella elle-nico-romana: falere da Manerbio (metà I sec.a.C.), dischi in lamina d’argento decorati asbalzo, facenti parte di bardature di cavalli, deco-rata da triskele, motivo a tre braccia, e serie con-tinua di teste umane stilizzate, lastraarchitettonica a rilievo da Rimini (metà II sec.a.C.) raffigurante abbraccio tra Dioniso ebbro eArianna, probabilmente ornamento di tempio:attesta l’adesione totale a canoni culturali, arti-stici ed estetici ellenizzanti. La mostra si con-clude con un omaggi a Gaio Valerio Catullo,poeta di famiglia celtica, ma di raffinata culturaellenistica, nato a Verona, ma fortemente legato aBrixia: affresco da Sirmione effigiante figura ma-schile abbigliata con tunica e toga exigua con fa-scia purpurea, tipiche della tarda Repubblica,segno di appartenenza all’ordine dei cavalieri; trale mani un rotolo che indica l’appartenenza alceto intellettuale e artistico; si è suggerita l’iden-tificazione con Catullo.
Luigi Silvi
ROMANIZZAZIONE DELLA PIANURA PBRIXIA. ROMA E LE GENTI DEL PO, UN INCONTRO DI CULTURE III-I SEC. A.C., Santa Giulia Museo della Città (Brescia)
7
Ar cheologia
ELLA PIANURA PADANAia Museo della Città (Brescia)
Lamina decorata a sbalzo, III secolo a.C., bronzo, Mantova, Museo Archeologico Nazionale di Mantova.
9
Ar cheologia
Busto di guerriero, III secolo a.C., Ravenna, Museo Archeologico Nazionale di Ravenna.
10
Ar cheologia
I Sette contro Tebe, frontone del tempio di Talamone, II secolo a.C., terracotta, Orbetello, Museo Archeologico “Polveriera Guzman”.
14
Ar cheologia
Corteo di donne, lamina sbalzata e incisa, IV-III secolo a.C., Vicenza, Museo Naturalistico Archeologico.
15
Testa di divinità femminile, da Alba Pompeia, fine II-inizi I secolo a.C., Torino, Museo Archeologico Nazionale.
16
Ar cheologia
Sima con testa di Gorgone e testa di leone tra palmette, II-I secolo a.C., Rimni, Museo della Città.
18
Ar cheologia
Kleomenes (documentato ad Atene I secolo a,C., attivo ad Atene e in Italia Settentrionale), Apollo (?), prima metàI secolo a.C., marmo, Piacenza, Museo di Palazzo Farnese.
20
Ar cheologia
Statua femminile acefala, fine II-inizio I secolo a.C., marmo, Milano, Civico Museo Archeologico.
24
Ar cheologia
Stele di Komevios, da Necropoli celtica di Dormelletto, fine II secolo a.C., Torino, Museo di Antichità.
25
Ar cheologia
Falera, da Manerbio, con triskele e serie di teste umane, I secolo a.C., argento sbalzato, Brescia, Museo di Santa Giulia.
28
Ar cheologia
Viene esposta per la prima volta alpubblico, dopo essere stata ripulita eaccuratamente restaurata e dopo unabreve esposizione per la riconsegnanel 2012, una spada risalente all’epocaaltomedioevale, ritrovata nel 2011 dadue pescatori, i fratelli Adriano e An-gelo Milocco, nelle acque antistanti ilversante marino dell’Isola di Marti-gnano, nota anche come Isola delle
Conchiglie, nella Laguina di Marano.Il reperto risale all’epoca delle Cro-ciate ed è stato protetto per quasi1000 anni da un guscio naturale disabbia cementata, che l’ha conservato.La spatha è lunga 106 cm, del tipo auna mano, la lama è in ferro e il fo-dero è ligneo; è databile tra la metàdel IX e la metà dell’XI secolo. Laspatha è un tipo di spada risalente al-
IL MARE RICONSEGNA UNA SPADA DEI TEMPI DELLE CROCIASPATHA. DAL MARE UNA SPADA CON 1000 ANNI DI STORIA, Museo Archeologico della Laguna (Marano Lagunare)
Spatha, IX-XI secolo, bronzo, cm 106, Marano Lagunare, Museo Archeologico della Laguna.
29
Ar cheologia
ADA DEI TEMPI DELLE CROCIATEa (Marano Lagunare)
l ’epoca romana, con lama molto piùlunga di quella del gladio. La spathaera usata in Europa settentrionale edentra nell’armamento del legionarioromano al momento della germaniz-zazione dell’esercito, quando cioè leintere formazioni militari di barbarivengono inserite, in pianta stabile,nell’esercito romano. Era utilizzatadai legionari per colpire, e non per
parare, perché si piegava facilmentenelle collusioni con altre lame o scudi.La spatha con poche variazioni diven-terà l ’arma per eccellenza del cava-liere medioevale e rimarrà in uso finoal Rinascimento. Il termine deriva dalgreco “spathe” , che indica qualsiasilama piatta di legno o di metallo eanche la lama piatta di spada.
Luigi Silvi
30
Ar cheologia
Spatha, IX-XI secolo, spada bronzo, fodero legno, spada cm 106, Marano Lagunare, Museo Archeologico della Laguna.
32
Ar cheologia
L’antica città di Tusculum a circa 20 chilo-metri a sud-est di Roma, fu fondata, se-condo la leggenda, da Telegono, figlio diUlisse e della maga Circe. I primi insedia-menti umani nel territorio risalgono alXIV secolo a.C., età del bronzo medio, evi si sovrappongono tracce archeologichedi epoche storiche diverse. In età romanafu una delle più importanti città dellalega Latina e si oppose all’espansionedella potenza di Roma fino a quando fusconfitta al lago Regillo nel 496 a.C. Rico-nosciuta la supremazia romana sui centrilatini con il Foedus Cassianus (493 a.C.),Tusculum divenne fedele alleata di Roma,poi fu colonia e successivamente munici-pio romano e i suoi abitanti ebbero la cit-tadinanza romana. Per la sua posizione inepoca imperiale divenne residenza estivaper personaggi importanti: senatori,scrittori e imperatori come Cicerone, Lu-cullo, Tiberio e Matidia. Cicerone in par-ticolare parla in alcune epistole delle sueproprietà tuscolane e vi compose nel 45a.C. opere filosofiche come le Disputatio-nes Tusculanae. La zona che in età arcaicaera occupata dall’acropoli, in epoca me-dioevale divenne cittadella fortificatacentro del potere dei Conti di Tuscolo.Tra l’XI-XII secolo la zona tornò a essereoccupata stabilmente e le nuove abita-zioni sorsero direttamente sulle strutturedi epoca romana e ne riutilizzarono i ma-teriali. A questa fase appartengono i restidi due edifici paralleli separati da unmuro lungo oltre nove metri. Dagli scavisono emersi focolari, scorie metalliche,resti di ceramica e strumenti artigianali,che permettono di supporre un uso com-merciale o artigianale degli ambienti. Lacittà subì alterne vicende militari, fu piùvolte assediata e nel 1191 definitivamentedistrutta da Roma. Il territorio rimase ab-bandonato fino ai secoli XVI-XVII,quando per la sua posizione fu conside-rato adatto alla costruzione di ville. NelXIX secolo, inserita come tappa nei GrandTour, Tuscolo destò interesse per le anti-che vestigia e così furono promossi scaviarcheologici da Luciano Bonaparte, pro-
prietario allora del territorio. Passata laproprietà alla famiglia Savoia, il re diSardegna Carlo Felice affidò le indaginiall’archeologo Luigi Biondi e successiva-mente a Luigi Canina. Da allora l’area ar-cheologica fu “dimenticata” tanto dacomprometterne la conservazione; solonel 1984, con l’acquisizione dei terrenidove sorgeva Tusculum da parte della XIComunità Montana del Lazio “CastelliRomani e Prenestini” la cittadina è tor-nata a “vivere”. Infatti è stato realizzatoun parco archeologico che ha richiestomaggiore tutela da parte della Sovrinten-denza per i Beni Archeologici del Lazio.Con l’intento di valorizzare il territoriosono stati avviati studi e progetti di ri-cerca e nuovi scavi sono stati eseguitinegli anni 1994-2011, in particolare nell’a-rea del Foro e del Teatro, grazie alla col-laborazione dell’Escuela Española deHistoria y Arquelogia en Roma. Nel 2003è stato riaperto al pubblico il teatro ro-mano, utilizzato per la rappresentazionedi spettacoli classici, e Tuscolo ha avutouna nuova stagione di successi, grazie al-l’accordo del 2008 con l’Istituto Nazio-nale del Dramma antico, anche perquest’anno è stato preparato un ricco ca-lendario di iniziative, promosse dall’ATSTusculum con visite guidate, animazioniper i bambini, musica e teatro. L’area mo-numentale della città era costituita dalforo e dal teatro, che fu costruito intornoal 75 a.C. con una capienza massima di500 posti. La cavea, che poggia sul decli-vio del monte era a semicerchio, con undiametro di 45 metri. Le gradinate eranosostenute da muri in opera quadrata euna balaustra separava la cavea dall’or-chestra, mentre la scena era a pianta ret-tangolare con le tre porte tradizionali. Undoppio ordine di colonne con capitelli io-nici e corinzi e statue decoravano la fronsscaenae. I resti oggi visibili risalgono allaprima fase costruttiva, perché nel I secolod.C. il teatro fu ampliato e il diametroraggiunse i 51 metri con una capacità di2000 spettatori. All’inizio del II secolosubì un’ulteriore trasformazione e abbel-
PARCO ARCHEOLOGICO CUL
34
Ar cheologia
Resti delle mura in opera quadrata con blocchi squadrati di tufo, 75 a.C., Tusculum (foto M. Humar).
35
Ar cheologia
limento: fu modificato l’accesso alle gra-dinate e tutto l’edificio fu impreziositocon decorazioni di marmi di provenienzadiversa. Sul lato occidentale in corrispon-denza della cavea, si apriva la Via tecta ,un passaggio lastricato coperto che per-metteva il collegamento tra acropoli eforo. Tra la vegetazione, alle spalle delteatro, vi sono i resti di una cisterna (m17 x 25) databile II-I secolo a.C. che ali-mentava anche una fontana a emiciclo di-smessa per la costruzione del teatro. Eraa pianta rettangolare, divisa da pilastrisostenenti volte a crociera ed era rivestitadi cocciopesto. Le strutture furono riuti-lizzate in età giulio-claudia, probabil-mente per gli spettatori, creando unportico colonnato. Fu anche pavimentatala piazza del foro che fu circondata daportici. L’area di forma trapezoidale (m80 x 25 x 40) era delimitata da edifici oggiancora oggetto di scavo da parte dellaEscuela Española de Historia y Arquelo-gia. Sul lato nord è stato rinvenuto un ca-nale in peperino, realizzato nella primametà del I secolo a.C., interrotto a inter-valli regolari da pozzetti di decantazione.Nel I secolo d.C. il canale fu messo fuoriuso dalla nuova pavimentazione in pietrasperone della piazza e sostituito da fognesotterranee. Nell’angolo sud-occidentaledel foro, dove confluiscono la via Latina ela via Labicana e dove in età arcaica c’erail mercato, tra fine del II secolo-inizio Ia.C. fu innalzato un tempietto dedicato aMercurio. Era un ambiente absidato conpronaos che si apriva sulla strada e cellacon pareti dipinte e pavimento mosai-cato. Le prime realizzazioni nell’area delforo furono piccoli edifici, identificaticon tempietti datati tra II e I secolo a.C.Durante gli scavi sono stati rinvenuti uncippo con dedica a Ercole e una base pro-babilmente per il tripode di Apollo. Sonostati recuperati resti di pavimentazione amosaico e in cocciopesto decorato, oltreche lacerti di rivestimenti in marmo e inintonaco dipinto delle pareti interne. Nonè possibile ricostruire l’aspetto originariodegli edifici, perché l’area, abbandonatadal III secolo d.C., subì un sistematicosaccheggio e soltanto in epoca medioe-vale (XI sec.) venne rioccupata riutiliz-
zando le strutture romane. Fuori dell’areaurbana nel versante sud-occidentale sonovisibili tra la vegetazione imponenti restidi ambienti voltati attribuibili a com-plesso edilizio di natura cultuale, proba-bilmente simile per l’impiantoarchitettonico ai grandi santuari di arealaziale. Si può riconoscere nella parte in-feriore un’ampia terrazza addossata inparte al pendio del pianoro e in parte co-struita con doppia fila di ambienti voltatiin opus reticolatum. Al centro della ter-razza vi era il tempio di cui resta il nu-cleo cementizio del podio. Una scalinata,sostenuta da sostruzioni a volta, permet-teva l’accesso al tempio, preceduto daportico con quattro colonne. Il santuarioera forse dedicato a Giove o a Ercole, pa-trono della transumanza. All’esterno delperimetro della città antica un anfiteatrosolamente in parte scavato nel IX secoloattualmente coperto da vegetazione. L’e-dificio che sfrutta in parte il declivio delcolle fu costruito nella metà del II secolod.C., datazione confermata da bolli late-rizi rinvenuti. Le strutture sono in operaquadrata e in opera mista nelle muratureche sostengono la cavea. La pianta è ellit-tica (m 53 x 35) e l’edificio poteva conte-nere circa 3000 spettatori. Un corridoioanulare con porte architravate che siaprono sull’arena e sulle gallerie d’in-gresso, corre intorno all’alto podio cheseparava l’arena dalla cavea. Tutte lestrutture sono realizzate in opera qua-drata di peperino e le sostruzioni inopera cementizia con paramenti in opusreticolatum di tufo e con ammorzature inlaterizio. Le recenti campagne di scavosotto il parcheggio dell’area archeologicahanno riportato alla luce anche i resti diun grande edificio del I-II secolo d.C.:cinque ambienti con porticato in operareticolata e in tufo e mattoni in cui, inepoca medioevale, furono scavati tresilos, usati forse per immagazzinare der-rate. Dagli scavi sono tornati alla lucemolti reperti marmorei, tessere di mo-saico, iscrizioni, monete e gioielli: ciò fasupporre che le vestigia rinvenute appar-tenessero a una villa di un personaggioautorevole.
Marina Humar
36
Ar cheologia
Muro di terrazzamento vicino alla fontana arcaica II-I secolo a.C., Tusculum (foto M. Humar).
40
Ar cheologia
Edificio romano, I-II secolo d.C., cinque ambienti in opus reticolatum, tufo, mattoni, Tusculum (foto M. Humar).
46
Ar cheologia
IL TEMPIO DI MATIDIA A CAMPO MARZIO: MATIDIA SUOCERA FOR
Busto di Salonina Matidia, marmo di Carrara, cm 50, II secolo d.C., Roma, Musei Capitolini.
47
Ar cheologia
Presto sarà possibile vedere i resti del tempio diMatidia, tornati alla luce durante i lavori di restaurodel complesso di Santa Maria in Aquiro, di pro-prietà dell’IPAB, (Istituzione Pubblica di Assistenzae Beneficenza), iniziati nel 2004. Nel cantiere dicirca 3000 mq disposti su quattro piani tra via diSanta Maria in Aquiro, via dei Pastini, vicolo dellaSpada di Orlando e piazza Capranica, durante i la-vori sono riaffiorate colonne di granito grigio e dimarmo cipollino e pregiati marmi di rivestimentopertinenti al Templum Matidiae. Nella nuova sededistaccata del Senato, che ha preso in affitto l’edifi-cio, sarà creata un’area archeologica sotterranea conun sistema di pavimentazioni con lastre di vetro eilluminazioni che permetteranno la visione dei mo-numentali resti. L’edificio, eretto nel 1591 per vo-lontà del Cardinal Salviati quale “Ospizio degliOrfani”, presentava seri problemi strutturali. Gliscavi iniziati per il restauro hanno riportato allaluce, a cinque metri di profondità, una platea di cal-cestruzzo di circa otto metri e una sequenza di co-lonne colossali in granito e marmo cipollino, chefurono tagliate nella parte superiore al momentodella realizzazione del pavimento dell’edificio. Unacolonna si è conservata in tutta la sua altezza, per-ché inglobata nel muro laterale, ed è ora visibile al-l’interno del salone della nuova sede degli uffici delSenato insieme ad alcune basi che presentano unaricca decorazione con fregi con girali alternati a ma-scheroni e corone di alloro. Sono state rinvenuteinoltre pregiate lastre marmoree pertinenti al pavi-mento e al rivestimento del podio. Al di sotto dellaplatea di calcestruzzo, sicuramente adatta a soste-nere un grande tempio, è stata rinvenuta una piat-taforma di palafitte che, con il radiocarbonio, sonostate datate tra il 50 a.C. e il 70 d.C. e che costitui-scono un unicum, perché trattasi di sistema di co-struzione mai documentato prima a Roma. Iltempio fu dedicato a Matidia da Adriano ed era fi-nora noto solo attraverso le fonti antiche: infatti eracitato nell’iscrizione di una fistula acquaria, rinve-nuta nei pressi del Pantheon, e su una moneta del120-121 d.C. in cui era raffigurato il tempio con duecorpi di fabbrica laterali porticati e sul rovescio lalegenda DIVAE MATIDIAE SOCRVI. Si è conser-vato anche un denario in cui compare al dritto lalegenda DIVA AVGUSTA MATIDIA e al rovescioCONSECRATIO, dimostrazione della sua diviniz-zazione. Matidia era nipote di Traiano e suocera diAdriano. È probabile che Adriano volesse, attra-verso la moglie Sabina, rafforzare il proprio legamecon la famiglia degli Ulpii Traiani, Matidia perciòaveva per Adriano un’importanza dinastica e perquesto motivo, a scopo propagandistico, subitodopo la sua morte, avvenuta nel 119 d.C. la divi-nizzò, dedicandole il tempio in Campo Marzio. Inbase alla pianta Severiana, l’edificio posto a norddei Saepta Iulia doveva essere periptero, ottastilocon ai lati due basiliche, la basilica di Matidia e labasilica di Ulpia Marciana, sorella di Traiano e
madre di Matidia. Già in passato nella zona eranoriaffiorate vestigia romane ora attribuibili al tem-pio di Matidia. A nord-est del Pantheon, nel vicolodella Spada di Orlando, tra via dei Pastini e piazzaCapranica furono rinvenute cinque colonne inmarmo cipollino, due delle quali sono state inglo-bate nella casa al numero 76 di piazza Capranica.La base di una terza colonna è visibile in vicolodella Spada di Orlando. Quest’ultima misura circa1,70 m di diametro, il che lascerebbe supporreun’altezza di almeno diciassette metri. Il vicolodeve il suo nome a una leggenda legata proprio allacolonna che presenta dei solchi e dei fori interpre-tati come la conseguenza dei colpi della Durlin-dana, famosa spada del paladino. Il tempio con alcentro la statua di Matidia e le due basiliche porti-cate dovevano apparire come un complesso monu-mentale che rientrava nel progetto diriqualificazione del Campo Marzio voluto daAdriano. Egli intervenne intensamente in questaarea attraverso il restauro di numerosi edifici: ilPantheon, i Saepta, la Basilica di Nettuno, le Termedi Agrippa, l’Arco di Claudio, il Portico Argonauta-rum et Divorum, la riedificazione del Pomerium el’innalzamento del piano del Solarium e dell’AraPacis, entrambi fatti costruire da Augusto. Il tem-pio di Matidia e le due basiliche dovevano esseredelimitate da un porticato su tre lati che creava unaspecie di grande piazza dotata di giardini e giochid’acqua, come il tempio della Pace ai Fori Imperiali.Il complesso, dopo la morte dell’ImperatoreAdriano, fu ampliato da Antonino Pio, suo succes-sore, con la costruzione nel 145 d.C. dell’Hadria-neum, tempio periptero poggiante su un alto podiodi peperino (circa quattro metri) con otto colonnesui lati brevi e tredici su quelli lunghi, alte quindicimetri con diametro di 1,44 m, con la facciata rivoltaad est verso la via Lata. I resti del lato destro, undicicolonne con capitelli corinzi, sono ancora visibilioggi in piazza di Pietra inglobati nel palazzo dellaBorsa Valori. Nel 2013, dopo otto anni di lavori perla ristrutturazione del complesso di Santa Maria inAquiro, la Soprintendenza speciale per i Beni Ar-cheologici di Roma, in collaborazione con l’IstitutoArcheologico Germanico, ha organizzato un Semi-nario di Studi sul Campo Marzio, per integrare lepreesistenze note nel tessuto urbano con i nuovidati di scavo (2005-2012). Il territorio della IX Regioaugustea infatti continua a offrire sempre nuove“sorprese”, come i resti pertinenti alla struttura difondazione del porticato del tempio di Adriano, oriaffiorati durante i lavori di ristrutturazione di unnegozio presso Palazzo Ferrini-Cini in piazza diPietra. Nella Galleria d’arte di Francesca Anfosso,dopo gli interventi della Soprintendenza, sono oravisibili i blocchi della platea di fondazione del por-tico che, secondo alcuni studiosi, circondava ilgrandioso Hadrianeum, formando una grandepiazza porticata (100 x 90 m).
Marina Humar
CERA FORTUNATA O VEICOLO DI PROPAGANDA POLITICA?
52
Fondazione del porticato del Tempio di Adriano, II secolo d.C., Roma, sotterranei “Galleria 28”, piazza di Pietra (foto M. Humar).
54
Ar cheologia
Fondazione del porticato del Tempio di Adriano, II secolo d.C., Roma, sotterranei “Galleria 28”, piazza di Pietra (foto M. Humar).