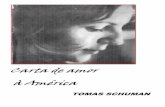Carta Archeologica. Schede 33-42, in in O. Belvedere - A. Burgio (a cura di), Carta Archeologica e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Carta Archeologica. Schede 33-42, in in O. Belvedere - A. Burgio (a cura di), Carta Archeologica e...
Indice
1. PREMESSA p. 11
Oscar Belvedere
2. STORIA DEGLI STUDI E DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA p. 13
Maria Carmela Spagnolo
3. IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE p. 25
Maria Assunta Papa
i. la piattaforma GIS ed il sistema schedografico;
ii. il sistema di posizionamento GPS e la sua integrazione con il GIS;
iii. elaborazioni GIS, carte tematiche e prime analisi sui dati.
4. METODOLOGIA DELL’INDAGINE p. 51
Oscar Belvedere, Aurelio Burgio, Daniela Lauro, Maria Assunta Papa
i. la prospezione archeologica;
ii. il software ZMap e la sua applicazione alle foto aeree;
iii. dalla cartografia e le riprese aeree ai dati archeologici.
5. CARTA ARCHEOLOGICA p. 91
Giuseppe Bordonaro, Arianna Di Miceli, Ferdinando Lentini,
Maria Carmela Spagnolo
6. I RISULTATI DELL’INDAGINE p. 129
Giuseppe Bordonaro, Arianna Di Miceli, Ferdinando Lentini,
Maria Carmela Spagnolo
L’area urbana: i. dalla città greca alla città romana e medievale;
L’area extraurbana: ii. le necropoli;
iii. le aree artigianali;
iv. il suburbio;
v. il santuario di S. Anna e la UT 30.
7. PROSPETTIVE FUTURE DELLA RICERCA p. 169
Oscar Belvedere
8. BIBLIOGRAFIA E ABBREVIAZIONI p. 171
125
UT 33 – Monte San Calogero. Area di frammenti fittili di età preistorica.
Monte San Calogero è un’altura di modesta entità (q. 138 m s.l.m), ubicata sulla destra idrografica
del fiume San Biagio. Delimitato a Nord e a Sud da ripide pareti, è accessibile con facilità sul lato
Sud-Est, da cui si raggiunge la spianata sommitale, piuttosto allungata sull’asse NO-SE.
Lungo le pendici meridionali del rilievo, tra la curve di livello di m 140-120, si rinviene una
modesta quantità di frammenti ceramici di età preistorica pertinenti alla facies di Castelluccio (Fig.
143). Poche decine di metri più ad Ovest, si rileva, invece, la presenza di un’area di reperti fittili
ascrivibile ad età neolitica. Sono state individuate, inoltre, tre tombe del tipo a grotticella artificiale,
che possono essere messe in relazione ad un insediamento dell’Antica Età del Bronzo che doveva
essere ubicato sulla spianata sommitale, ma che non è stato possibile prospettare, per il diniego di
accesso del proprietario del terreno.
I materiali sono costituiti in prevalenza da orli e pareti di ceramica d’impasto, databili al Neolitico
Antico e Medio. Si segnala un frammento di parete di grande contenitore decorato ad unghiate ed
alcuni frammenti di pareti, decorati a linee incise parallele o a rocker (Fig. 144). E’ documentata,
inoltre, la presenza di selce (strumenti e scarti di lavorazione) e di ossidiana di Lipari. Sporadici i
frammenti fittili di età ellenistica, tra cui si riconosce un mortaio e una coppetta a vernice nera.
Fig. 143 - Stralcio della carta archeologica con il posizionamento dell’UT 33.
126
Fig. 144 - UT 33. Frammenti ceramici di età preistorica.
UT 34 – Contrada San Biagio. Area di frammenti fittili di età imperiale.
L’UT si stende su un piccolo appezzamento di terreno limitato a Nord-Est e Nord-Ovest dai fianchi
scoscesi del fiume San Biagio e di un suo affluente. Il podere, raggiungibile attraverso alcune strade
sterrate, è interessato da un orto e da una piccola abitazione rurale a q. 63,6.
I cocci in superficie, dilavati e consunti, sono costituiti in prevalenza da coppi ad orlo inspessito e
sono inquadrabili in età romano imperiale. Sporadica, invece, la ceramica da mensa, tra cui un
frammento di coppa in sigillata africana D ed alcuni contenitori in ceramica comune. La densità dei
reperti, alta nei pressi del casolare (13 reperti per mq), va nettamente diminuendo sui terreni
limitrofi. L’ubicazione dell’area e la tipologia dei manufatti fanno ipotizzare la presenza di un
piccolo insediamento rurale.
UT 35 – Contrada Pezzino. Necropoli di età classica.
Si tratta della più vasta necropoli di età arcaico-classica della città di Akragas15
. Ubicata ad
occidente del torrente Drago, si estende lungo le pendici sud-occidentali del colle di Girgenti per
36,5 ha. Le indagini di superficie hanno consentito di definirne i limiti e di verificarne lo stato di
conservazione (Fig. 145). L’area cimiteriale occupa i terreni a Nord e ad Ovest del Viadotto
Morandi ed è definita a Nord-Est da una cresta che si erge sino a m 130 s.l.m., mentre sugli altri lati
è delimitata da balze rocciose. Su quest’area, attraversata dalla linea ferrata e caratterizzata da
terreni in parte coltivati ed in parte incolti, sono visibili numerose sepolture e si osservano, laddove
la visibilità lo consente, molti frammenti ceramici a vernice nera (tra i quali si segnala un orlo di
15
DE MIRO 1984-1985; FIORENTINI 1988-1989a; DE MIRO 1988a.
127
cratere, frammenti di ceramica figurata e di coppette ad orlo ingrossato). Le tombe individuate, per
lo più del tipo a cassa, presentano spesso una risega per l’alloggiamento della lastra di chiusura. Si
rinvengono tombe singole o plurime, di varie dimensioni, nella maggior parte dei casi in cattivo
stato di conservazione, perché distrutte dai lavori agricoli. Frammenti di pareti e orli di grandi
contenitori, quali pithoi e anfore, inoltre, attestano il rito della cremazione. Sono stati rinvenuti
anche due frammenti di rocchi scanalati di colonne, a poca distanza l’uno dall’altro, che potrebbero
essere interpretati come segnacoli.
Le condizioni di visibilità si presentano discontinue essendo molti terreni interessati da una fitta
copertura erbosa, mentre in alcuni punti affiora il banco roccioso in cui sono visibili i tagli per
ricavare le sepolture.
Fig. 145 - Immagine da Google Earth dell’area della necropoli di Pezzino.
UT 36 – Casa Tedesco. Area di frammenti di età arcaico-classica.
Sporadici frammenti fittili costituiti in prevalenza da solenes, pareti di pithoi e da contenitori in
ceramica comune, si rinvengono sulla sommità di un rilievo quotato 115,4, prospiciente il settore
Sud-Est della Collina dei Templi, su cui insiste una piccola abitazione rurale denominata Casa
Tedesco (Fig. 146). I frammenti, in alcuni casi utilizzati come rinzeppo nei muri del casolare, sono
inquadrabili genericamente tra l’età arcaica e classica e si distribuiscono sul terreno con una densità
medio-bassa (1/2 reperti per mq).
La tipologia dei reperti e l’ubicazione dell’area a poca distanza dalla città di Agrigento fanno
ipotizzare che si tratti di un modesto insediamento rurale.
128
Fig. 146 - Casa Tedesco. Veduta da Nord-Ovest.
UT 37 – Piana di San Gregorio. Insediamento rurale di età romano-imperiale.
Nella pianura di San Gregorio, circa 200 m a Nord del Tempio di Asclepio, su un terreno da poco
arato (Fig. 147), si individua un’area di frammenti estesa 7.250 mq e caratterizzata dalla presenza di
reperti ceramici ascrivibili all’età imperiale (III-IV sec. d.C.). Rispetto ai campi circostanti,
interessati da costante presenza di frammenti ceramici a bassa densità, in quest’area si assiste ad un
aumento del numero dei reperti (10 reperti per mq). I cocci sono costituiti in prevalenza da coppi ad
orlo inspessito e da contenitori in ceramica comune; sono presenti anche frammenti di anfore
africane, di dolia, di ceramica da mensa in sigillata africana D, ceramica da cucina africana e
ceramica di Pantelleria (Fig. 148). Si segnalano anche tubuli in terracotta, per lo più concentrati in
una sola area. Per le caratteristiche tipologiche e cronologiche, l’area di frammenti, dai limiti ben
definiti, non sembra sia da mettere in relazione con il santuario vicino, né con la necropoli, ma
potrebbe essere identificato come un insediamento rurale.
130
UT 38 – Poggio Giache. Rinvenimento sporadico di età medievale.
Su un terreno incolto, ubicato immediatamente alle falde nord-orientali di Poggio Meta e compreso
tra una strada sterrata, il fiume Sant’Anna e un condotto collegato ad un impianto di depurazione,
situato sul versante opposto del corso d’acqua, si raccolgono sporadici frammenti ceramici. I
reperti, frammisti a ceramica moderna, si rinvengono in condizioni di visibilità medie. Si tratta di
tegole con malta celamidarum, di pareti di contenitori con costolature e di un orlo di una piccola
anfora. La tipologia e la quantità dei reperti non consentono un’interpretazione certa del
rinvenimento, che tuttavia sembra riconducibile ad età medievale.
UT 39 – Collina di Montelusa. Area di frammenti fittili di età ellenistico-romana.
Imboccando una strada sterrata che si diparte dalla periferia sud di Villaseta, dopo aver oltrepassato
la ferrovia, si giunge ai piedi della collina di Montelusa (Fig. 149). Sulle pendici nord-orientali di
tale rilievo, su un campo incolto si localizza un sito esteso circa 9.300 mq. Sul terreno si osservano
numerosi frammenti di coppi ad orlo inspessito, di anfore e di ceramica comune di epoca
ellenistico-romana. Nel corso delle ricognizioni effettuate nel mese di Febbraio 2009 era stato
possibile individuare alcuni reperti nei campi limitrofi; tuttavia, le cattive condizioni di visibilità
non avevano consentito allora di delimitare con precisione l’area di frammenti, né di riscontrare la
zona di maggiore concentrazione. I cocci sono in cattivo stato di conservazione, combusti e per lo
più privi di forme diagnostiche. Il sito, data la tipologia dei reperti, potrebbe essere interpretato
come un piccolo insediamento rurale.
Fig. 149 - Stralcio della carta archeologica con il posizionamento dell’UT 39.
UT 40 – Contrada Sant’Anna. Rinvenimento sporadico di età ellenistico-romana.
Si tratta del rinvenimento di sporadici reperti ceramici individuati ad Est del fiume Sant’Anna, su
un campo pianeggiante raggiungibile attraverso una strada secondaria che, costeggiando la clinica
Sant’Anna, giunge ad alcune abitazioni private (Fig. 150). Circa 50 m a Sud della siepe che
delimita il giardino di una di queste case, su un tratto di terreno di recente sottoposto a fresatura, si
131
rinvengono sporadici frammenti ceramici (1-2 repp./mq) attribuibili al periodo ellenistico-romano.
Si tratta di solenes, di un puntale di anfora, di poca ceramica comune e a vernice nera. Si segnala,
inoltre, il rinvenimento di uno scarto di fornace, e di un solen mal cotto. I rinvenimenti, data la
breve distanza, potrebbero essere pertinenti all’UT 6. Tuttavia le condizioni di visibilità, a tratti
nulle, non permettono di verificare continuità o discontinuità tra le due unità topografiche. L’areale
di frammenti prosegue oltre la strada, in direzione Est, in corrispondenza di un terreno incolto e
compatto, delimitato da un muretto a secco nel quale è riutilizzato sporadico materiale da copertura.
Fig. 150 - Stralcio della carta archeologica con il posizionamento dell’UT 40 e dell’UT 6.
UT 41 – Piana di San Gregorio. Necropoli di età romana.
Si tratta di una vasta area cimiteriale (nota come “Necropoli Giambertoni”), ubicata a Nord-Est e
Sud-Est del Quadrivio di Porta Aurea, che si sviluppa sulle pendici sud-orientali della Collina dei
Templi fino alla piana di San Gregorio, per un’estensione complessiva di 73.400 mq (Fig. 151).
Oggetto di scavi fin dalla fine del XIX secolo16
, la necropoli comprende sepolture monumentali,
come la cosiddetta Tomba di Terone, tombe a fossa coperte da lastroni e definite da un recinto
costituito da grossi blocchi, sarcofagi monolitici. Si osservano, sul terreno, i resti dei recinti
caratterizzati dalla presenza di blocchi squadrati e si individuano alcuni affioramenti pertinenti alle
suddette sepolture anche ad Est e a Ovest dell’area di scavo ubicata a Sud della SS 115,
rispettivamente presso un appezzamento di terreno incolto, dove è stato rinvenuto anche un rocchio
di colonna, e in un podere interessato da un mandorleto. Qui, sparsi sul terreno si trovano, fino
all’altezza di un rudere, numerosi blocchi squadrati di grandi dimensioni che testimoniano la
presenza di altre tombe.
16
DE MIRO 1988a.
132
Fig. 151- Immagine da Google Earth dell’area della necropoli Giambertoni.
UT 42 – Contrada Forche. Necropoli di età classica.
La necropoli, ubicata in prossimità di Porta I (Fig. 152), si estende lungo le pendici sud-orientali
della Rupe Atenea, a Sud della Chiesa di San Biagio, in contrada Forche. Raggiungibile attraverso
alcuni sentieri che attraversano un bosco di eucalipti e di pini, il sepolcreto è caratterizzato da un
numero considerevole di tombe, prevalentemente del tipo a cassa (Fig. 153). Si riconoscono
sepolture multiple o singole, nella maggior parte dei casi in cattivo stato di conservazione, scavate
nella roccia affiorante o nei grandi massi staccatisi dalla sommità della rupe. Meritevole di
attenzione è il rinvenimento di un frammento di sarcofago fittile con copertura a doppio spiovente.
Ad eccezione di alcuni grandi frammenti di solenes, non è stato possibile constatare la presenza di
altri reperti ceramici, a causa delle pessime condizioni di visibilità dovute alla presenza di una folta
vegetazione.