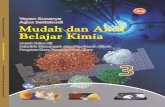Alcuni poemi di Barhebraeus e Bar Ma'dani nella redazione del ms. Firenze, Biblioteca Medicea...
-
Upload
universiteitgent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Alcuni poemi di Barhebraeus e Bar Ma'dani nella redazione del ms. Firenze, Biblioteca Medicea...
73
EVO XXXVI (2013)
AlcunI pOEmI dI BArhEBrAEus E BAr mA‘dAnI nEllA rEdAZIOnE dEl ms. FIrEnZE, BIBlIOtEcA mEdIcEA
lAurEnZIAnA, OrIEntAlE 2981
Marianna Mazzola
Il vescovo e poligrafo siro‑ortodosso Gregorius Barhebraeus, forma latinizzata di Gri‑gorios Abū al‑Farāǧ Bar ‘Ebrāyā, nato nei pressi di Melitene nel 1225/26, interpreta, con la sua ampia ed eclettica produzione letteraria, lo spirito culturale che anima il periodo compreso tra il XII e XIV secolo, noto come Rinascimento siriaco2. La ritrovata prosperità delle comunità cristiane determina una nuova consapevolezza identitaria e un periodo di grande produttività letteraria, caratterizzata da una forte recezione della cultura arabo‑isla‑mica. L’attività di Barhebraeus testimonia questo nuovo atteggiamento con un lascito di opere teologiche, filosofiche, esegetiche, storiografiche e scientifiche, caratterizzate da un vasto ricorso a fonti arabe e persiane3.
Nell’ambito di questa produzione si inserisce il Libro dei poemi4 (ܬܐ ‑rac ,(ܟܬܒܐ ܕܡܘܫܚcolta di oltre 200 componimenti in versi eptasillabi e dodecasillabi, rimati, di carattere narrativo‑didascalico e di argomento prevalentemente religioso. Di un Libro dei poemi si ha notizia, per la prima volta, nella Cronaca ecclesiastica, quando Gregorio Barsauma Safi, fratello di Barhebraeus, ne elenca tutte le opere, fornendone una breve descrizione.
Se l’elevato numero di testimoni manoscritti dimostra la grande diffusione e popolari‑tà della poesia di Barhebraeus, le notevoli differenze di contenuto e ordine della raccolta provano una trasmissione piuttosto caotica e suggeriscono che egli non abbia provveduto a completare una collezione “autorizzata” delle sue opere poetiche prima della sua morte. Una conseguenza è che nel corso della trasmissione, ai poemi di Barhebraeus si siano ag‑giunti, spesso senza soluzione di continuità, i poemi del patriarca siro‑ortodosso Giovanni Bar Ma‘dani (1261‑1263).
La tradizione manoscritta del Libro dei poemi consta di oltre 200 testimoni, di cui 36
1 Desidero porgere un sentito ringraziamento al prof. Pier Giorgio Borbone e al dott. Giovanni Mazzini per avermi incoraggiato a scrivere il presente articolo, che riassume alcuni punti trattati nel mio lavoro di tesi magistrale «I poemi di Barhebraeus e Bar Ma‘dani nel ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Orientale 298». 2 Baumstark per la prima volta utilizza l’espressione Rinascimento siriaco; v. BauMstark 1922. 3 V. teule 2003: 21‑43. 4 Si preferisce tradurre con “poemi” piuttosto che con un generico “poesie” per indicare componimenti in versi distici conosciuti come mīmrē, che costituiscono la totalità della produzione poetica di Barhebra‑eus, in contrapposizione ai madrāšē, componimenti in strofe di carattere liturgico; v. Brock 2008: 657‑671.
74
raccolte complete5. Il più antico testimone esistente è il ms. Orientale 298 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (datato al 1488)6.
Partendo dai dati forniti da H. Takahashi, possono essere individuate almeno due redazioni:
redazione I: redazione IIEd. Scebabi7 Ms. Hunt. 1 (ca. 1498)8
Ms. BNF. 270 (XV sec.)9 Ms. DZ 76 (< 1791)10
Ms. Vat. sir. 174 (XVI sec.)11 Ms. BNF. 197 (XVI sec.)12
L’identificazione delle due redazioni è fondata principalmente sulle differenze nella compo‑sizione della raccolta: la redazione II divide i poemi di Barhebraeus da quelli di Bar Ma‘dani, ponendo questi ultimi al termine. Inoltre, sebbene in entrambe le raccolte i poemi sembrino organizzati in ordine di lunghezza decrescente, tale ordine non è rigoroso, tanto che si rile‑vano sostanziali divergenze. Non ultimo, nella redazione I è assente il celebre poema mistico De divina sapientia.
Il rapporto del ms. Orientale 298 con le due redazioni ipotizzate non è stato adeguatamen‑te indagato. Ci si limiterà nel presente contributo a fornire alcuni dati che possano aiutare ad inserire il testo di questo manoscritto nell’ambito della tradizione.
ms. Orientale 298
Datazione e aspetti codicologiciSi tratta di un manoscritto composito, in grafia serto, contenente la Grammatica metrica
5 Per una lista completa v. takahashi 2005. All’elenco di Takahashi va aggiunto il ms. Vat. sir. 422 = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, sir. 422 (> 1584). Angelo Mai nel suo catalogo attri‑buisce erroneamente la datazione del poema De Perfectione all’intero ms. Vat. sir. 422 (v. Mai 1831: 67). In realtà, il manoscritto è posteriore al 1584, anno di fondazione del Collegio maronita. Ringrazio Pier Giorgio Borbone per aver consultato per mio conto il manoscritto. 6 Il ms. Qaṣīr usato per l’editio princeps di A. Scebabi è perduto. 7 Editio princeps del Libro dei poemi: sceBaBi 1877. Y. Dolabani nell’introduzione alla sua edizione dei poemi riferisce che l’edizione di Scebabi è condotta sulla base del ms. Dannā e emendato sui mss. Qaṣīr e Ming 282Bc (DolaBani 1929: N). Qaṣīr = Mosul, coll. Metr. Athanasius Thomas Qaṣīr (XIV‑XV sec.); Dannā = Mosul, coll. Ni‘mat‑Allāh Dannā (non datato); Ming. 282BC = Birmingham, Orchard Learning Resources Centre, coll. Mingana, 282BC (1507/1508). La datazione del ms. Dannā è proposta da Dolabani su base paleografica (DolaBani 1929: N). Vale la pena di considerare l’edizione di Scebabi come fonte autonoma in quanto testimone del più antico manoscritto conosciuto del Libro dei Poemi. Per le varianti tra il ms. Dannā e ms. Vat. sir. 174 è da notare che nel Vat. sir. 174 il poema De perfectione presenta una chiusa con data e luogo di composizione (Bagdad anno dei Greci 1588), informazioni assenti nell’edizione di Scebabi; v. anche nestle 1879: 545‑547. 8 Hunt. 1 = Oxford, Bodleian Library, Huntingdon 1 (ca. 1498). 9 BNF. 270 = Parigi, Bibliothèque nationale de France, syr. 270 (XV sec.). 10 DZ. 76 = Dair al‑Za‘farān, syr. 76 (<1791). 11 Vat. sir. 174 = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. sir. 174 (XVI sec.). 12 BNF. 197 = Parigi, Bibliothèque nationale de France, syr. 197 (XVI sec.).
75
di Barhebraeus (ܓܪܡܛܝܩܝܬܐ ܒܡܫܚܬܐ ܐܦܪܡܝܬܐ) (f. 3v/80 r), una raccolta di poemi (ܩܠܝܠ ܡܘܫܚܬܐ) (f. 83r/104v), sezioni dell’opera filosofica Causa causarum (ܢ ܥܠ ܟܠ ܕܥܠܬ ܟܬܒܐ ܡܢ (ܩܠܝܠ (f. 105r‑139r) e discorsi di padri siri (f. 139r/141v)13.
Il primo colofone (f. 80v) ci informa che la prima parte del manoscritto (f. 1r/81v), contenen‑te la Grammatica metrica e una lista di opere di Barhebraeus (f. 81r/v), è datato all’anno 1360.
Dal f. 82r interviene una nuova mano, come è possibile notare non solo dalla diversa grafia ma anche dal colore dell’inchiostro utilizzato, che continua la copiatura fino al termine del manoscritto. Il secondo colofone (f. 142r) ci fornisce informazioni certe sulla data dell’ultima parte del codice:
ܐ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܐ ܘܟܗܢ ܪܝ ܐ ܕܒܫܡ ܕܝ ܐ ܘܡܐܠ ܡܘܡ ܐ܁ ܐܢܫ ܚܛܝ ܐ ܐܚܪܝ ܐ ܚܕܬ ܘܕܒܩ ܘܟܬܒ ܠܚܡܫܐ ܟܘܪܣ ܝ ܘܢ ܒܫܢܬܐ ܐܥܨܛ ܕܝܨܝ ܫܘܒܚܐ܁ ܡܪܝ ܕ ܩܣܛܪܐ ܡܒܪܟܬܐ܁ ܒܝܘܡܝ ܐܒܗܬܢ ܬܪܝ ܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܕܥܠ ܓܒ ܡܐܕܝ ܐ܁ ܒܕܝ ܝ ܫܘܡܗܐ ܘܟܘܢ
ܐ ܕܒܗ ܥܡ ܫ ܕܝ ܐ ܩ ܘܝ ܐ ܘܥܢ ܪܝ ܐ ܘܕܝ ܝ ܢ ܐ ܪܘܚ ܐ ܕܝܠܗ ܕܕܘܟܬܐ ܘܐܚ ܢ܁ ܘܡܪܝ ܩܘܪܝܠܘܣ ܚܣܝ ܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝ ܪܟ ܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝ ܐܝܓܢܢ܁ ܐ ܢܓܪܐ ܐܡܝ ܝܗܘܢ ܠܙܒܢ ܝ ܐ ܢܡܬܘܚ ܚ ܐ܁ ܡܪܝ ܪܝ ܐ ܕܐܒܗܬܐ ܘܕܝ ܫܪܟ
ܐ ܕܒܗ܁ ܒܒܥܘ ܡܢܟܠ ܐܚܐ ܐ ܕܓܪܡܐܛܝܩܝ ܘܕܫܪܟ ܝ ܐ ܡܐܠ ܚ ܐ ܕܕܝܠܗ܁ ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܗܢ ܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܡܐ ܡܐܕܝ ܝ ܡܛܠ ܐܚܐ ܕܡܢܚܣܐ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܘܒܟܬܒܐ ܝܬܐ ܗܝ ܕܠܐܗܐ ܢ ܩܪܐ ܐܘ ܢܦܓܥ ܢܣܪܚ ܨܠܘܬܐ ܚܘܒܢ ܢ ܢ ܦܪܘܫܐ ܕܒܣܘܪܛܐ ܗܠܝ
ܢ܁ ܚܣܐ ܡܢ ܠܐܗܐ ܢܬܚܣܐ ܐܡܝ ܘܬܐ܁ ܘܟܠ ܕܢ ܪ ܘܕܠܐܗܐܗܝ ܠܚܘܕ ܡܫܡܠܝ ܐ ܚܣܝ ܐܠ ܒܕ ܟܠ ܒܪܝ ܥܕܘܠ ܠܥܕܝ ܐ܁ ܘܐܠ ܢ ܗܢܐ ܦܫܗ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝ ܝܚ ܢ ܐ ܢ ܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܡܪܝ ܐ܁ ܚ ܐܝܠܘܠ ܚܕܪܚܐ ܝ ܙ ܣܥܪܕܝ ܚܐ ܕܗܘ ܥܙܝ ܐ ܕܡܕܢ ܢ ܕ ܡܦܪܝ ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܥܢ
ܢ܁ ܐܡܝ
Nell’anno 1799 dei Greci, un peccatore e pieno di colpe, solo di nome monaco e sacerdote e ben lontano dal titolo e dall’appellativo, riparò, rilegò e scrisse gli ultimi cinque fascicoli nel monastero di Sant’Abele e Sant’Abramo, presso Midyat, fortezza benedetta, nei giorni dei nostri Padri orto‑dossi Ignazio patriarca del Tur Abdin e Cirillo vescovo del posto e dei fratelli spirituali, monaci e santi asceti che sono in esso, con il resto dei padri e dei monaci. Il Signore prolunghi la loro vita per lungo tempo. Amen. A motivo del fratello di sangue, sacerdote Tommaso di Midyat al quale appartiene questo libro pieno di vita, della Grammatica e del resto che contiene, io prego ogni fratello sagace che legga o s’imbatta in queste lettere, che pronunci una preghiera amorevole affinché Dio perdoni chiunque abbia rapporto con noi e con questo scritto e non imputi colpa al peccatore perché ogni creatura è inadeguata e solo Dio possiede la perfezione, e chiunque perdoni sarà perdonato da Dio. Amen. Quest’anno è morto il mafriano d’Oriente Aziz Sardaya, l’otto del mese di settembre, di domenica. Il Signore dia riposo alla sua anima nel regno del cielo. Amen.
Come dichiarato nel secondo colofone, il nuovo copista è intervenuto nel restauro e nell’assemblaggio degli ultimi cinque fascicoli (10°‑14°) avvenuto nell’anno 1488.
Il fascicolo 9° è solo nel suo primo foglio (f. 81r/81v) opera del primo copista, per cui è possibile affermare che facesse già parte del codice del 1360 e che la lista delle opere di Barhebraeus fosse già presente, essendo poi semplicemente completata dal nuovo copista, probabilmente sulla base di fogli del codice originario.
Nulla di certo è possibile dire sul contenuto delle altre pagine del fascicolo o sull’even‑tuale esistenza di altri fascicoli del manoscritto originario.
Dai soli dati testuali del colofone emergono certamente le azioni di riparazione (ܚܕܬ) rilegatura (ܕܒܩ) e scrittura (ܟܬܒ). L’oggetto delle suddette azioni sembrano essere i cinque
13 P.G. Borbone in Fani e Farina 2012: 138.
76
fascicoli e non l’intero libro14. Non possiamo sapere se gli interventi sulla rilegatura vadano attribuiti a questo copista o ad altri, ma è preferibile pensare che le azioni di riparazione si riferiscano semplicemente all’aggiunta degli ultimi cinque fascicoli; non si spiegherebbe, infatti, perché il nostro copista parli solo degli ultimi cinque se il fascicolo 9 non fosse già esistito precedentemente15. Dobbiamo presupporre, quindi, che abbia menzionato i cinque fascicoli in quanto aggiunta a ciò che il nostro manoscritto conteneva.
Nel colofone, quando il copista fa riferimento al codice posseduto dal presbitero Tom‑maso di Midyat, parla solo della «Grammatica» (ܓܪܡܐܛܝܩܝ) e del «resto che contiene» (ܐ ܫܪܟ non vi è alcun accenno esplicito alla presenza dei poemi. Inoltre è più probabile che la ;(ܕܒܗperdita delle pagine avvenga alla fine del codice dove la compagine è meno robusta e che quindi la lista di opere di Barhebraeus si trovasse tra gli ultimi fogli.
Per quanto è possibile valutare a livello codicologico, al primo foglio del fascicolo 9 (f. 81r/v) di mano del primo copista avrebbe dovuto seguire almeno un altro foglio per con‑tenere il resto della lista ed eventualmente la biografia di Barhebraeus, ma il f. 90, parte dello stesso bifoglio del f. 81, doveva evidentemente essere vuoto visto che vi ritroviamo solo la grafia del nuovo copista; per questo motivo sembra plausibile ipotizzare che non vi fosse altro se non la presenza di almeno un foglio contenente la seconda parte della lista di opere e forse la vita di Barhebraeus.
In conclusione, alla luce dei dati codicologici e testuali appena esposti, sembra prefe‑ribile ritenere la raccolta di poemi di nostro interesse come testimonianza di una stesura avvenuta nel 1488 e non dalla copiatura di un testo del 1360.
Aspetti redazionaliIl ms. Or. 298 contiene 227 componimenti o strofe16 a fronte degli oltre 300 delle altre due
redazioni. Questo dato potrebbe condurre a considerare il manoscritto come una semplice antologia. Il titolo della raccolta (f. 83r), infatti, recita:
ܐ ܐܒܘ ܠܐܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܘܕܡܪܝ ܚܐ ܩܠܝܠ ܡܘܫܚܬܐ ܡܢ ܣܝܡܗ ܕܗܘ ܒܪ ܥܒܪܝ ܐ ܕܡܕܢ ܢ ܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܡܦܪܝ ܕܝܠܗ ܟܝ ܕܗܘ ܐܗܪܘܢ ܢ ܡܥܕܢ ܘܚܢ ܝ
Dello stesso nostro padre mafriano d’Oriente, un po’ di poesie dall’opera di Barhebraeus Abū al‑ Faraǧ Aronne e di Giovanni Bar Ma‘dani cioè Aronne.
Nonostante le parole del copista, numerosi dati suggeriscono che la raccolta testimonia‑ta dal ms. Or. 298 non sia prodotto di una selezione.
Il ms. Or. 298 manca di almeno tre poemi rispetto alle altre due redazioni: De anima rationali, De perfectione e De Socratis dicto. Questi poemi sono tra i più celebri di Barhe‑
14 A questo proposito, valga come esempio la sottoscrizione sul codice XIII del Catalogo di Assemani da parte di un suo possessore, Lazzaro presbitero del Tur Abdin e artefice di un’opera di restauro del libro venuto in suo possesso. In questo caso l’uso dei verbi ܚܕܬ e ܕܒܩ è chiaramente riferito al libro ܟܬܒܐ. V. as‑seMani 1759: 47 e Payne sMith 1879: 1206. 15 Il copista ha completato la trascrizione del nono fascicolo ma non lo cita tra i fascicoli riparati 16 Non è sempre chiaro se la dicitura ܐ altro” possa riferirsi a poemi differenti o a strofe di uno“ ܐܚܪܢstesso poema. Un’analisi più accurata dell’intera raccolta può condurre ad identificare correttamente il numero dei poemi.
77
braeus e i più diffusi nella tradizione manoscritta; sembra dunque singolare che il copista abbia operato una simile scelta, escludendoli dalla propria antologia. Appare invece più probabile che tali poemi fossero di fatto assenti dalle fonti dello scriba.
Inoltre, ben sette poemi (n. 4/133‑ 14/88‑ 24/130‑ 40/165‑ 85/116‑ 134/192‑170/17517) sono stati copiati due volte. Questo fa pensare, come già suggerito da Takahashi, che il co‑pista abbia usato almeno due fonti per il proprio lavoro. L’ordine delle ripetizioni fa suppor‑re che la prima fonte ricoprisse tutta la prima parte della raccolta, almeno fino al n. 85. La concentrazione dei poemi di Bar Ma‘dani (n. 118‑119‑120‑122‑167‑213‑216‑21718) e di poe‑mi attestati solo nel ms. Or. 298 (n. 129‑131‑132‑136‑168‑218‑219) nella seconda parte della raccolta, consente di individuare con maggiore chiarezza la presenza della seconda fonte.
In definitiva, sembra che lo scriba si sia limitato a ricopiare, una di seguito all’altra, le fonti utilizzate, senza operare alcuna selezione e senza riordinare la raccolta.
Possiamo inoltre notare che il ms. Or. 298 manca del poema De divina sapientia. Que‑sto poema è attestato per la prima volta nel ms. Hunt. 1 (1498) e quindi nell’ambito della seconda redazione. Se Dolabani data correttamente il ms. Dannā, utilizzato da Scebabi per la sua edizione, ci troveremmo di fronte ai due codici più antichi dell’opera, il ms. Or. 298 e il ms. Dannā, in cui il poema De divina sapientia è assente19. I tre manoscritti in cui è possibile verificare l’attestazione del De divina sapientia, il ms. Hazā20, il ms. Hunt. 1 e il ms. Vat. 20421 dividono i poemi di Barhebraeus da quelli di Bar Ma‘dani, ponendo questi ultimi alla fine della raccolta; perciò è possibile che l’ingresso del De divina sapientia sia avvenuto nell’ambito della seconda redazione.
Riguardo l’assenza dei poemi De anima rationali, De perfectione e De Socratis dicto si è già detto in precedenza. Possiamo notare, tuttavia, che la prima attestazione nell’ambito della redazione I è attribuibile al Vat. sir. 174 che è certamente posteriore al nostro manoscritto. Possiamo quindi rilevare che non esistono, tra le raccolte complete, testimoni più antichi del ms. Or. 298 attestanti questi componimenti e che la loro prima testimonianza è il ms. Hunt.1. Se questi componimenti fossero prodotto di un’aggiunta successiva, dovremmo credere che tale aggiunta sia avvenuta in un ramo di trasmissione comune alle redazioni I e II.
Barsauma Safi nella Cronaca ecclesiastica descrive così il Libro dei Poemi22: ܟܬܒܐ ‑libro di poesie in cui ci sono poemi meravigliosi”. Innanzi“ ܕܡܘܫܚܬܐ ܘܐܝܬܝ ܒܗ ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܗܐ
17 I numeri fanno riferimento alla concordanza proposta da H. Takahashi (takahashi 2013: 78‑139). 18 La concordanza dei n. 216‑217 nel ms. Or. 298 è da aggiungere alla lista di Takahashi. 19 A ciò aggiungiamo che, tra le raccolte parziali, il De divina sapientia non compare mai prima dell’atte‑stazione nel Vat. sir. 204. Non sembra nemmeno casuale che Gabriele Sionita (1577‑1648) nella sua edizione del 1628 del De divina sapientia abbia attribuito il poema ad un «antico filosofo siro» invece che a Barhe‑braeus. Forse la fonte da lui utilizzata non riportava il nome di Barhebraeus e ciò avvalora il sospetto che il componimento non facesse parte delle prime raccolte (v. sionita 1628). Per quanto ci è possibile constatare dal catalogo di Payne Smith, il titolo presente nel ms. Hunt. 1 non lo attribuisce esplicitamente a Barhebraeus (riporta solo «ܬܐ .riguardo la sapienza divina»). V. Payne sMith 1864: 371‑383» «ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܠܐܗܝ 20 Hazā = Gerusalemme, collezione Joseph Hāzā Bēt‑Zabdāyā (XVII sec.). Codice usato da Dolabani per la sua edizione. Dolabani nella sua introduzione riferisce che solo i mss. Hazā e Antūn dividono i poemi di Barhebraeus da quelli di Bar Ma‘dani. Possiamo dunque ipotizzare che appartengano alla seconda redazione. 21 Vat. sir. 204 = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. sir. 204 (1533). 22 BarheBraeus 1872‑1877: col. 479.
78
tutto, sembra insolito che Barsauma impieghi il termine ܗܐ meravigliosi” esprimendo“ ܬܡܝun giudizio di valore sui poemi, laddove per le altre opere si è limitato ad una scarna e di‑staccata descrizione del contenuto; ma più significativo è il fatto che non abbia utilizzato il verbo ܟܢܫ “raccogliere” e ܩܗܠ “mettere insieme”, “radunare”, laddove è stato utilizzato in almeno altre due occasioni nella lista23. Sorge il sospetto che ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܗܐ faccia riferimento al ,ܕܬܡܝܗܘܬܐ 24ܡܐܡܪܐ sembra perciò più plausibile intendere “libro dei poemi in cui c’è il poema sulla meraviglia (della creazione del cielo)”. Sembra, dunque, che Barsauma abbia evidenziato nella sua descrizione la presenza dell’unico poema “lungo” della raccolta.
Il confronto dei titoli dei poemi tra le edizioni di Scebabi e Dolabani e i mss. Or. 298 e Hunt.1 mostra una sostanziale concordanza tra l’ed. Scebabi e il ms. Or. 298 e l’ed. Dola‑bani e il ms. Hunt. 1. I titoli del ms. Hunt. 1 mostrano chiaramente tentativi di estensione e spiegazione del significato dei poemi, tanto da avvalorare l’ipotesi che la redazione II abbia apportato delle innovazioni nella trasmissione della raccolta25.
In definitiva, in base ai dati sopra esposti, possiamo suggerire che il ms. Or. 298 non sia una semplice antologia ma aiuti a ricostruire, almeno in parte, quella che doveva essere una delle redazioni originarie e che la redazione II abbia apportato alcune innovazioni, tra cui l’inserimento del poema De Divina Sapientia.
I poemi di Barhebraeus e Bar ma‘dani nel ms. Or. 298. Come osserva Leroy, l’espressione “Rinascimento siriaco” non ha attinenza con il si‑
gnificato canonico di riscoperta dell’antichità ma indica, più genericamente, un periodo di ritrovata vivacità culturale26. Non sorprende, dunque, che le caratteristiche della poesia siriaca del XII‑XIII sec. non siano da ricercarsi nella poesia classica di Efrem, ma nascano e si evolvano sulla scorta della tradizione arabo‑islamica.
Una delle due forme della poesia siriaca, il cosiddetto mīmrā, attestato già in Efrem ma portato in auge, con una florida produzione, da Giacomo di Sarug, viene riscoperta nel XIII sec. e ampiamente utilizzata da ‘Abdišo‘ Bar Brikha, Giovanni Bar Ma‘dani e Barhebraeus, con l’introduzione di numerosi elementi mutuati dalla poesia araba. L’uso esteso della rima
ܘܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ 23 ܐ ܕܦܝܠܘܦ ܢ ܬܐ ܘܪܥܝ ܝ ܘܬܐ ܚܟܡܬܢ ܢ ܡܢ Grande libro“ ܟܬܒܐ ܪܒܐ ܕܚܘܬ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗ ܟܢܫ ܘܩܗܠ ܟܠܗܝdella crema della scienza in cui ha raccolto e messo insieme tutte le parti sapienziali e le idee filosofiche di Aristotele”; ܬܐ ܐ ܟܢܫ ܒܗ...ܩܪܝ .”…Libro del magazzino dei misteri in cui ha raccolto le letture“ ܟܬܒܐ ܕܐܘܨܪ ܪܐܙBarheBraeus 1872‑1877: coll. 477, 480). 24 Poema di argomento filosofico, in 192 versi dodecasillabi. Il poema occupa la prima posizione nella raccolta del ms. Or. 298. L’edizione di Scebabi presenta al termine di questo poema la chiusa ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ .il che avvalora la nostra ipotesi ܕܬܡܝܗܐ 25 Per le estensioni dei titoli v. Hunt. 7‑9‑75. Il titolo di Hunt. 31 recita ܒܘܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ ܕܥܒܕ ܛܒܘ ܩܘܒܠ ܛܝ Ringraziamento a uno dei padri che gli fece del bene”. In questo caso, sebbene il titolo sia più corto“ܥܡܗ rispetto a quello del ms. Or. 298 (ܐ ܪܬ ܕ ܡܥ ܐ ܨܝ ܚ ܕܒ ܘܢ ܒܡ ܒ
ܗ ܗܘ ܐ ܦܫ ܕ ܚܒܫ ܢ ܐ ܟ ܒ ܘܣ ܣ ܝ ܐܛ ܓܢ ܝ
ܪܝ ܐ ܐ ܡ ܪܟ ܪܝ ܛ ܐ ܕܥܠ ܦ ܪܢ ܐܚ
ܗܘܬ ܪܝ ܐ ܕܕܝ ܘܡ ܕ ܝ ܪ ܚ
ܬ ܐ ܒ ܝ ܘܟ ܛܝ ‑risulta chiaro il richiamo al testo del poema, configurando il titolo come un’ag ,(ܕܐܢ
giunta del copista. Da notare, inoltre, che in buona parte dei casi, i titoli del ms. Or. 298 riportano varianti più corrette rispetto alle altre redazioni. A titolo esemplificativo si veda il poema 152 nel ms. Hunt. 1 dove solo il ms. Or. 298 mantiene la lezione corretta ܐ ܠܝ arroganti”, laddove Scebabi e ms. Hunt. 1 attestano“ ܫܘܥܝܐ .ismailiti”. Per le concordanze dei poemi secondo l’ordine del ms. Hunt. 1 v. takahashi 2013“ ܐܝܫܡܥܠܝ 26 leroy 1971: 131‑148.
79
e di molti artifici retorici, cui si farà riferimento, è l’espressione più chiara di questa opera‑zione. Possiamo osservare come le novità introdotte in questo periodo agiscano soprattutto a livello formale. Ma alcuni autori, proporzionalmente alla propria formazione e attitudi‑ne personale, assorbono anche temi e contenuti della poesia araba e persiana, inserendoli nell’ambito di una tradizione letteraria di matrice dichiaratamente cristiana27.
Non è possibile, in questa sede, affrontare uno studio esteso della poesia di Barhebraeus. Ci si limiterà a fornire l’edizione e traduzione dei poemi inediti, contenuti nella redazione del ms. Or. 298. Nella seconda parte, si fornirà l’edizione diplomatica secondo il ms. Or. 298 di alcuni poemi editi, al fine di mostrare, a titolo di esempio, la ricchezza tematica della produzione di Barhebraeus e le varianti testuali presenti nel manoscritto.
Poemi inediti28
f. 98r (n. 129)
ܐ ܪܢ ܐܚColui che sopporta fino alla fine sarà salvato ܐܚ ܐ ܗܘ ܠܡ ܢ
ܪܬ ܐ ܠܚ ܪ ܥܕܡ ܒ ܝ ܣ ܢ ܕܢ ܡ
e nel rango dei giusti, dei sacerdoti e degli illustri sarà annoverato
ܐ ܚ ܨܝ ܐ ܘܕܢ ܐ ܡܬܡܢ ܗܢ ܐ ܘܟ ܐܢܘܒܕܪܓ ܟ
e chi ha una vita sobria, pacifica e tranquilla ܐ ܚ ܝ ܦ ܢܐ ܗܘܘ ܐ ܢ ܝ ܡܫ
ܐܠ ܘܗܝ ܒܗܝ ܝ ܐ ܕܚ ܢ ܝ
ܘܐ
sarà degno di ogni lode sublime ܐ ܚ ܝ ܐ ܫܒ ܡ ܐ ܪ ܣ ܘܠ ܘܐ ܠܟܠ ܩ ܘ ܕܫ ܗܘܝ
(a) ܢ ܢ nel codice è :ܡ ‑ma il tratto spesso della puntazione suggerisce che non si tratti della vocalizza ܡzione ā29. I due punti potrebbero corrispondere all’accento di intonazione metdamrānā30.
(b) ܐ ܚ ܨܝ participio aggettivale dalla radice :ܢ ܨܚ ܢ “splendere”, “brillare”, indica metaforicamente una persona illustre, degna di nota. Il termine è utilizzato anche in riferimento ai martiri31.
(c) ܐ ܚ ܝ ܦ ܢܐ ܗܘܘ ܐ ܢ ܝ ܡܫ
ܐܠ ܗܝ la costruzione singolare di questa catena è dovuta essenzialmente ad esigenze :ܒ
metriche. L’aggiunta della congiunzione ܘ davanti a ܐ ܢ ܝ avrebbe comportato la vocalizzazione della stessa ܡܫe quindi la presenza di una sillaba in più (ܐ ܢ ܝ ܐ al contempo la presenza del participio aggettivale ;(ܘܡܫ ܚ ܝ in ܢfondo al verso serve alla costruzione della rima. La scelta di ܦ
sembra dovuta ܘ al posto della congiunzione ܐ
ad una semplice scelta stilistica, forse per evitare l’eccessiva allitterazione con il precedente perfetto 32 ܗܘܘ.(d) ܐ ܝܚ attestata al pa‘‘el come “pregare”, “glorificare”. Si ܫܒܚ participio aggettivale dalla radice :ܫܒ
sceglie qui di non tradurre l’aggettivo poiché il significato è sostanzialmente affine a quello di ܣ ܘܠ .ܩ
27 Si pensi all’introduzione del genere della khamriyya (v. taylor 2010: 31‑52). 28 I numeri indicati fanno riferimento a takahashi 2013. 29 Nel manoscritto la vocalizzazione è segnata con un tratto più sottile mentre i punti diacritici e il seyāmē con un tratto più spesso. 30 Duval 1881: 148. 31 Payne sMith 1879: 2438. 32 In questo caso l’esigenza non è di rispettare la metrica in quanto la sostituzione di ܐܦ con ܘ avrebbe permesso di perdere una sillaba, riequilibrando la metrica, qualora l’autore avesse utilizzato una waw da‑vanti ܐ ܢ ܝ Evidentemente la necessità di evitare accumuli di waw in fondo al verso deve avere generato .ܡܫla costruzione sopra riportata.
80
Il contenuto della quartina è suddivisibile in due parti33: i primi due versi di contenuto escatologico e i seguenti di carattere più elogiativo. Quanto ai soggetti del poema non sembra esserci alcuna opposizione tra le due unità, che in ogni caso sono riferite ad una stessa o molto affine categoria di persone. Come detto, la distinzione tra le due parti sembra dovuta più al tipo di ricompensa percepita in una vita futura nel primo caso, e nella vita terrena nel secondo, ma non sembra emergere una vera e propria contrapposizione.
Dal punto di vista stilistico, emerge l’uso di una catena sinonimica volta ad enfatizzare il concetto espresso: “giusti”, “sacerdoti”, “illustri” nel secondo verso; “sobria”, “pacifica”, “tranquilla” nel terzo verso; “sublime” e “lodevole” nel quarto verso.
f. 98v (n. 131)
ܐ ܪܢ ܐܚGuardati, fratello mio, da questo mondo e sii per te stesso un guardiano
ܪ34 ܝ ܐ ܘܗܘܝ ܠܟ ܥ ܢ ܗܢ ܥܠܡ ܘܢ ܡ ܐܙܕܗܪ ܐܚ
affinché tu non sia come un’ancora sepolta nel mare. ܪ ܝ ܐ ܛܡ ܡ ܐ ܕܒܝ ܢ ܝ ܟ ܐܘܩ ܗܘܐ ܠܟ ܐܝ ܬ
ܕܐܠ
Quando lo sposo, il Messia, sarà giunto nel giorno predetto,
ܪ ܝ ܐ ܕܐܡ ܘܡ ܐ ܒܝ ܚ ܝ ܐ ܡܫ ܬܢ ܐ ܚܬܐ ܕܐ ܡ
ܕܐܠ
non farti sorprendere come le sciocche che avevano dormito e non vegliato.
ܝܪܝ ܥ ܐ
ܡܝ ܗܘܝ ܘܐܠ ܐ ܕܢ
ܠܬ ܟ ܟ ܣ ܝ
ܡܫܬܟܚܬ ܠܟ ܐ
(a) ܘܢ .Nella traduzione si renderà con la I singolare presupponendo che sia l’autore a parlare :ܐܚ(b) ܗܘܐ
anche ,ܗܘܝ si sceglie di tradurre come una proposizione finale dipendente dall’imperativo :ܕܐܠ ܬ
in virtù del segno di interpunzione taḥtāyā al termine del primo verso e che segna la fine di una protasi. In alternativa la costruzione ܐܠ e imperfetto è utilizzata per esprimere un imperativo negativo, da cui la traduzione “non essere come un’ancora nascosta nel mare” ma non si spiegherebbe la presenza della dalet.
(c) ܐ ܢ ܝ ‑àncora”. La figura dell’àncora ricorre nella Lettera agli Ebrei 6, 1935 come metafora del giu“ :ܐܘܩramento di Dio fatto ad Abramo e rinnovato con la venuta di Cristo e che quindi costituisce per i cristiani una speranza per il futuro.
(d) ܪ ܝ ܡ coprire”, “nascondere” ma primariamente di “nascondere con“ ܛܡܪ participio aggettivale da :ܛla terra” quindi “seppellire”36. L’idea è che l’àncora, mezzo di approdo e quindi di salvezza per le navi, sia introvabile e pertanto inutilizzabile per il suo scopo.
(e) ܐ ܬܢ sposo”. Si tratta di un riferimento alla Parabola delle dieci vergini (Matteo 25,1‑13) dove“ :ܚl’arrivo dello sposo corrisponde metaforicamente a quello di Cristo.
(f) ܪ ܝ letteralmente è “detto”, “pronunciato”; si sceglie la traduzione “predetto” per sottolineare il :ܐܡmessaggio escatologico del poema e del passo evangelico cui fa riferimento.
33 La divisione è ulteriormente suggerita dal segno ܀ alla fine del secondo verso. 34 Il primo verso ha tredici sillabe anziché dodici come previsto dal metro. In poesia sono consentite alcune variazioni vocaliche mirate ad equilibrare la metrica del verso, tra cui la possibilità di non vocaliz‑zare una yod o una aleph iniziale. In questo caso ܐܙܕܗܪ suonerebbe ܐܙܕܗܪ, costaz 1963: 229. 35 In riferimento alla speranza: «in essa infatti abbiamo come un’ancora della nostra vita, sicura e sal‑da…» (Ebrei 6,19). aurelio et al. 1981. 36 Come primo significato in sokoloFF 2009 “to hide”, “to dig deep” e Payne sMith 1902 “to hide or bury under the earth”.
81
(g) ܟ .sembra essere dovuto solo ad esigenze metriche37 ܠܟ in questo caso l’inserimento di :ܠ(h) ܪܝ ܝ ܥ
ܪܝ il manoscritto riporta :ܐ ‑ma, ai fini della rima, occorre ipotizzare che la forma sia un per ܥܝ
fetto III plurale femminile af‘el38, quindi il testo va integrato con una aleph. (i) Rimandi fonetici connettono tutti i quattro versi: ܡܐ ܘܡܐ mare” e“ܝ nei ܗܘܝ ;giorno” nei versi II‑III“ ܝ
versi I‑IV (imperativo del verbo ܗܘܐ “sii” nel verso I e perfetto plurale femminile del verbo essere nel verso IV ); allo stesso modo ܪ ܪܝ/ܥܝ sostantivo maschile “guardiano” nel verso I e perfetto plurale femminile) 39 ܥܝ“hanno vigilato” nel verso IV).
Le citazioni evangeliche sopra illustrate chiariscono il contenuto escatologico del poema. L’interlocutore è invitato a provvedere da sé alla propria salvaguardia morale, in attesa dell’arri‑vo di Cristo; a questo messaggio concorre l’identificazione del destinatario con l’àncora, mezzo necessario per l’approdo e quindi la salvezza delle navi, sublimato qui dalla metafora religiosa. Ugualmente il riferimento alla parabola delle dieci vergini invita a vigilare, evitando l’esempio delle cinque vergini stolte che non si erano preparate per l’arrivo dello sposo.
f. 98v (n. 132)
ܐ ܪܢ ܐܚQuesta è l’ingiustizia: lo sciocco prospera in questo mondo
ܪ ܝܬ ܗܘܐ ܥ ܐ ܢ ܒܥܠܡ
ܟܐܠ ܐ ܕܣ ܗܘ ܗܢ
ܘܐܠ ܥ
e in confronto ai saggi, è enorme la sua ricompensa! ܪ ܝܬ ܗܘܐ ܝ ܗ ܢ
ܝܬ ܐܦܣܘܢ ܐ ܒ ܡ ܝ ܟ ܢ ܚ ܘܡ
Mentre il saggio è onorato presso Dio, ܪ ܝ ܩ ܘܗܝ ܕܝܬ ܝ
ܗܐ ܐ
ܕ ܠܐ ܝܡ ܨܝ ܟ ܐ ܕܚ ܢ ܘܐܝ
in mezzo agli sciocchi nel mondo dei malvagi, egli è triste.
ܪ ܝ ܘܗܝ ܕܟܡܬ ܝ
ܐ ܐ ܫ ܝ ܐ ܕܒ ܒܥܠܡ
ܐܠ ܟ ܬ ܣ ܢ ܝ ܒ
Per troppo tempo hai inflitto le tue torture ad un uomo abile,
ܪ ܐ ܕܡܗܝ ܢ ܝܟ ܐܠ ܕܝ ܢ ܐ ܫ ܢ ܕܘ ܬܣܒܠ ܙܒ ܟ
forse temevi che ti sfidasse e si adirasse contro di te, ܪ ܝ ܬܬܦ ܐ ܘܢ ܥ ܠܟ ܣ ܗ ܕܥ ܢ ܢܬ ܡܪ ܕܚܠ ܐ ܒ ܟ
altrimenti perché lo sciocco prospera in questo mondo in ogni momento?
ܪ ܝܬ ܐ ܟܠ ܫܥ ܥ ܒܥܠܡ
ܟܐܠ ܐ ܣ ܢ ܠܡ
ܐܠܘܐ
Dato che il saggio è considerato abominevole e oscuro in mezzo agli sciocchi,
ܪ ܝ ܕ ܗܘ ܘܟܡ ܕܝ ܢܐܠ ܟ ܬ ܣ ܢ ܝ ܐ ܒ ܡ ܝ ܟ ܕ ܚ ܟ
perché tu, con la tua mente industriosa, invece non sei sciocco?
ܪ ܝ ܫ ܟ ܟ ܢܬ ܒܗܘܢ ܗܘܐ ܐ
ܐܠ
ܟܐܠ ܐ ܣ ܢ ܠܡ
E devi rifugiarti in mezzo agli amici per mantenerti nobile?
ܪ ܝ ܦ ܗܘܐ ܫܟ ܕܬ ܪܝ ܒ ܬ ܚ ܢ ܝ ܦܫܟ ܒ ܬ ܢ ܢ ܘܩ
37 Talvolta il complemento oggetto all’interno del verso può essere ripetuto con il pronome suffisso; v. costaz 1963: 229. 38 Il perfetto pe‘al dei verbi di media waw conserva la ā durante la flessione (ܪܝ e il perfetto pa‘‘el (ܥrisulterebbe vocalizzato con a‑e (nel caso di ܥܪ per effetto della gutturale è ܪܝ ܝ .(ܥ 39 Come osserva Allen in merito alla rima nella poesia araba: «l’idea della rima visuale è del tutto inesistente». Dall’osservazione dei poemi, possiamo notare come questa considerazione sia perfettamente sovrapponibile all’opera di Barhebraeus; v. allen 2006.
82
(a) ܣܟܐܠ: “sciocco”. Il manoscritto non riporta vocalizzazione, per cui possiamo ipotizzare anche una forma ܐܠ stupidità” attestato solo una volta nei Carmina Nisibena di Efrem40; non si accoglie questa“ ܣܟvariante in quanto richiederebbe la forzatura del significato di ܪ ܝ ܬ ‑e la vocalizzazione della dalet pre 41 ܥcedente, aggiungendo una sillaba di troppo al verso. La scelta del termine “sciocco”, inoltre, rispetta il parallelismo con ܚܟܝܡܐ “saggio” e non ܚܟܝܡܘܬܐ“saggezza”.
(b) ܪ ܝ ܬ ܗܘܐ ܥ ܐ ܢ ܠܡ ܒܥܐܠ ܟ ‑letteralmente “lo sciocco è ricco nel mondo”. Si sceglie di tradurre “in que :ܕܣ
sto mondo” per sottolineare la contrapposizione tra la condizione dello sciocco nel mondo terreno e quella nel mondo ultraterreno, in cui risulterà sostanzialmente ribaltata rispetto a quella del saggio.
(c) ܪ ܝ ܡ ‑essere scuro”. L’aggettivo definisce specificamente una carat“ ܟܡܪ participio aggettivale da :ܟteristica fisica ma è anche attestato come “triste”, “cupo”. Qui indica lo stato d’animo del saggio in mezzo agli sciocchi e non l’opinione che questi ultimi hanno di lui42.
(d) ܕܝܟ ܢ ܐ ܫ ܢ il costrutto genitivale manca della preposizione dalet ma a meno che non si accompagni :ܙܒܐ ܢ ܕܘ a ܙܒ risulta l’unico costrutto possibile. “Il tempo delle tue torture” sottolinea il carattere transitorio 43 ܟdella prepotenza degli sciocchi sui saggi.
(e) ܪ ܝ ܡ ܕ ܘܟ ܕܝ ܪ abominevole e oscuro”. In questo caso si sceglie di tradurre“ :ܢ ܝ ܡ ‑come “oscuro” piut ܟtosto che “triste”, per mantenere il parallelismo con ܕ ܕܝ che definisce chiaramente la percezione che gli ܢsciocchi hanno di lui, non uno stato d’animo personale.
(f) ܪ ܝ ܫ ܟ ܟ ܢܬ ܒܗܘܢ ܐܠ ܗܘܐ ܐ
ܐܠ ܟ ܐ ܣ ܢ la domanda, verosimilmente, è rivolta dall’autore a se stesso. La :ܠܡ
radice ܟܫܪ del participio indica “riuscire”, “avere successo in qualcosa” da cui, forse, il riferimento alla contestazione mossa nel quinto verso cioè all’invidia dello sciocco verso chi è superiore a lui in capacità.
(g) ܟ ܦܫ ܬ ܢ ܢ letteralmente “la tua anima costruisce un nido”. L’idea è quella di crearsi un riparo dalle :ܩaccuse degli sciocchi, in mezzo ai compagni e agli amici più cari.
Il tema della stoltezza sembra essere piuttosto diffuso all’interno della raccolta; probabil‑mente si tratta di un argomento toccato sia dalla produzione poetica di Barhebraeus che di Bar Ma‘dani44.
L’intero poema è sotteso dalla contrapposizione tra la condizione dei saggi e quella degli sciocchi nel mondo, tema che viene declinato in più modi nel corso della poesia: la ricompensa degli stolti rispetto ai saggi (vv. I‑II), lo stato d’animo dei saggi presso Dio e inversamente pres‑so gli stolti (vv. III‑IV), le persecuzioni perpetrate dagli stolti per invidia ai saggi (vv. V‑VI). Non è chiaro se questi ultimi due versi possano riferirsi ad un particolare episodio autobiogra‑fico; certamente sappiamo che non necessariamente il tema della “stupidità” emerge nella pro‑duzione di Barhebraeus in occasione di rivendicazioni personali, legate ad un particolare evento ma può essere oggetto di trattazione che fa uso, talvolta, di complesse nozioni filosofiche45.
40 “Omnibus enim temporibus magna est stultitia sapientum” ܡܐ ܢ ܪܒܐ ܗܘ ܕܚܟܝ .eFreM 1866: 15 .ܣܟܐܠ ܒܟܠ ܕܪܝ 41 La radice ܥܬܪ indica principalmente “essere ricco”, “diventare ricco”, “aumentare”, “guadagnare”. Talvolta il participio è attestato come “abbondante”, “copioso” da cui la traduzione alternativa “la stupidità è abbondante nel mondo”. Payne sMith 1879: 3013. 42 Si confronti con il verso 8. 43 In questo caso non si spiega perché ܕܘ ܐ e ܟ ܢ .siano divisi dal verbo ܙܒ 44 Nella raccolta del ms. Or. 298 solo un epigramma sull’argomento è attribuibile a Bar Ma‘dani. Non è escluso, tuttavia, che uno studio approfondito dei poemi possa condurre ad accrescerne il numero, verifi‑cando la corretta attribuzione di alcune quartine. 45 Ne è un esempio il poema Quod praestantes in hoc mundo odio haberi solent edito da H. Takahashi (takahashi 2010). Il poema presenta tutt’altro tenore stilistico sebbene tratti lo stesso tema del 132. Il con‑fronto tra stolti e saggi, infatti, è espresso con immagini di alto profilo poetico: il sole e la luna, gli astri più
83
f. 98v (n. 136)
ܐ ܪܢ ܐܚDel nostro tempo malvagio con i suoi cicli malvagi ecco ciò che ci istruisce:
ܐܪܬ ܢ ܗܐ ܡ ܐ ܠ ܫ ܝ ܘܕܪܘܗܝ ܒ ܐ ܒܚ ܫ ܝ ܢ ܒ ܕܙܒܢ
trascinandoci, non si ferma mai per concederci di bere. ܐܫܬ ܐ ܢ ܝ ܐܓܪ ܕܡ ܣܟ ܡ
ܢ ܐܠ ܪ ܠ ܐ ܕܕܒ ܕܡ
(a) ܘܕܪܘܗܝ ܘܕܪܐ indica “circondare”, “girare intorno” da cui ܚܕܪ i suoi cicli”. La radice“ :ܚ ܚ “cerchio”, “circonferenza”, utilizzato principalmente in senso fisico46. Il termine è usato anche per definire il libro contenente il ciclo di letture dell’anno liturgico siriaco47. Sebbene non sia chiara l’accezione precisa del termine, emerge certamente l’idea di ciclicità e ripetizione. A questo proposito può tornare utile un con‑fronto con un altro epigramma di Barhebraeus sul tema del tempo, edito da Caesar von Lengerke48. La traduzione di Lengerke suona: «Tempus, coecum es, sicut talpa et spinis plenum sicut erinaceus. Forma tua spherica similis est areae et architectus tuus est noctua». Sebbene il senso dell’epigramma sia oscuro, affiora comunque l’immagine circolare del tempo, paragonata all’area per la trebbiatura.
(b) ܪ la radice indica “portare”, “condurre”. Nella traduzione è “trascinare” per rendere il senso dello :ܕܒscorrere senza possibilità di pausa.
(c) ܐܫܬ ܢ ܐ ܝ letteralmente “affinché beviamo acqua”. Nella traduzione si è scelta la perifrasi “per :ܕܡ
concederci di bere” dato il rapporto di dipendenza che sembra intercorrere tra gli uomini e il tempo nel poema.
f. 104 v (n. 218)
ܐ ܪܢ ܐܚ
Oh ricercatore di vera conoscenza, visitatore di saggi, ܐ ܡ ܝ ܟ ܘܪ ܚ ܥ ܐ ܣܘܫܬ ܢ ܩ ܘܠܦ ܐ ܕܝ ܘܥ ܒ
ܘ ܬ
ܐ
alleggerisci gli arti dal sonno e dalla sazietà, ܐܢ ܗܕܡ ܐ ܡ
ܘܬ ܦ ܣܒܥ
ܐ ܐ
ܬ ܢ ܩܠ ܫ
ܘܐ
e indaga sempre, notte e giorno, ܐ ܡ ܡ ܘܢ ܥܡ ܐܝܠ ܝ ܝܢ ܒܟܠ ܠ ܐܡ ܘܗܪܘܓ ܒ
poiché nella meditazione sorgono la conoscenza e i sagaci.
ܐ ܡ ܪܝ ܐ ܥܡ ܥ ܢ ܘܠܦ ܡ ܝ ܪ ܩ ܝ ܕܒܗܪܓܐ ܓ
(a) ܐ ܘܥ ܒ indica “cercare”, “domandare”, “desiderare” da ܬܒܥ indagatore”, “investigatore”. La radice“ :ܬ
cui la traduzione “ricercatore”, in coerenza con il ruolo che sembra ricoprire il destinatario del poema. (b) ܘܪ ܥ sorvegliante”. Per gli stessi motivi della voce precedente, si sceglie di tradurre seguendo il“ :ܣ
significato base della radice ܣܥܪ “visitare”. (c) ܐ ܡ ܡ ܡ ܐܝ ܘܢ ܥ
ܠ ܝ ܡ letteralmente “in tutti i giorni con le notti”. La scelta di :ܒܟܠ ܠ in sostituzione ܥ
della congiunzione waw è dovuta ad esigenze metriche. È possibile interpretare diversamente l’intera
grandi e belli, che sono però i soli soggetti alle eclissi, o il mare che conserva le perle nell’abisso e quindi nell’oscurità mentre fa riaffiorare in superficie solo i cadaveri putridi, diventano oggetto di paragone della condizione dei saggi. L’eleganza delle metafore e l’interpretazione della sofferenza dei saggi alla luce del carattere transitorio e corruttibile del mondo rende questo poema molto differente da quello proposto nel presente lavoro, il che fa dubitare della sua attribuzione a Barhebraeus. 46 In Barhebraeus è attestato come “perimetro” di una città o anche “orbita astronomica”. V. Payne sMith 1879: 1205‑1206. 47 AA.VV. 2006: 291.ܘ ܥܘܕܐ 48 ܟ ܩܘܦܕܐ ܣܦܪܟ ܕܡܐ ܐܠܕܪܐ ܘܐܪܕܟܠܟ ܗܘܝ ܬ ܐܝ ܟ ܚܘܠܕܐ ܘܟܘܒܐ ܡܐܠ ܐܢ ܬ ܐܝ ܐ ܣܡܐ ܐܢ .(von lengerke 1838: 7) ܙܒܢ
84
frase, considerando la bet come parte di un costrutto verbale con 49 ܗܪܘܓ; conseguentementeܘܢ ܠ ܝ ܠ ܟܠ
costituirebbe l’oggetto del verbo ma il senso del verso risulterebbe oscuro.
Il poema rientra nella vastissima categoria degli ammonimenti; il destinatario è invitato dall’autore ad astenersi dall’eccesso di cibo e di riposo, dedicandosi alacremente alla medita‑zione, unico mezzo possibile per il raggiungimento della conoscenza.
f. 104v (n. 219)
ܐ ܪܢ ܐܚÈ più facile che un uomo scavi una grande fossa con un ago,
ܪܐܐ ܐ ܪܒܬ ܒ ܛ ܫ ܒܡܚ ܘܪ ܐܢ ܚܦ ܝܩ ܗܘ ܕܢ ܦܫ
che raccolga la via del Tempio di Gerusalemme dentro l’ala di un passero,
ܪܐ ܐ ܕܨܦ ܦ ܘܪܫܠܡ ܒܓܝܬ ܕܐ ܐ ܒ ܘܪܚ
ܘܫ ܐ ܟܢ ܘܢ
che misuri l’acqua del Mediterraneo con un vaso rotto, ܪܐ ܝ ܐ ܬܒ ܨܦ ܐ ܒܚ ܐ ܪܒ ܡ ܐ ܕܝ ܝ ܝܠ ܡ ܟ ܘܢche scavi il pozzo di Betlemme con un pezzo di legno, ܪܐ ܝ ܣ ܐ ܢ ܣ ܝ ܝܬ ܠܚܡ ܒܩ ܐ ܕܒܒ ܘܪ ܓܘܒ ܩ ܢ ܘܢche lavi un servo nero tanto da farlo diventare bianco, ܘܪܐ ܗܐ ܚ ܐ ܢ ܡ ܘܟ
ܒܕܐ ܛܒ ܐ ܫܝܓ ܥ ܘܢ
piuttosto che un uomo cada nelle fauci di un popolo assetato di rovina.
ܪܐ ܐ ܨܗܐ ܠܬܒ ܡ ܢ ܥ ܫ ܦܠ ܒܠ ܫ ܢ ܕܐܢܘܐܠ
(a) ܪܒܬ: avverbio “molto”, “grandemente”. Non si interpreta come aggettivo in quanto non sono presen‑ti nel primo verso sostantivi di genere femminile. L’uso dell’avverbio può essere correlato a ܝܩ da cui ܦܫ“molto più facile”50 o accompagnarsi a ܪܐ
ܐ .fossa” sebbene non in funzione attributiva“ ܒ
(b) ܘܪܫܠܡܝܬ ܕܐ ܘܪܚܐ ܒ
ܘܪܫܠܡ la via del Tempio di Gerusalemme”. Il manoscritto riporta“ :ܐ
ܘܪܚܐ ܟܝܬ ܕܐ
Si .ܐ
è scelto di emendare ܟܝܬ con ܝܬ non solo in ragione della grande somiglianza grafica, ma perché risulta ܒpiù coerente con il senso del versetto e il contesto generale del poema. L’idea di “raccogliere” una strada, si suppone il più grande possibile, dentro l’ala di un passero, quindi un uccello di piccole dimensioni, è uno dei paradossi che l’autore vuole proporre nei suoi versi; “raccogliere”, però, una strada generica, una delle tante, senza specificare quale, non servirebbe bene il senso del testo, soprattutto se nel verso successivo il luogo di riferimento è specificato come “pozzo di Betlemme” e non un pozzo in generale.
Numerosi viaggiatori e pellegrini in Terra Santa dal XII al XIII secolo raccontano nei loro resoconti dell’esistenza di una “via del Tempio” che collegava proprio i resti del Tempio con la porta Aurea sul lato orientale della cinta muraria della città51.
La dalet precedente ܘܪܫܠܡ‑per cre ܟܝܬ con ܒܝܬ si ritiene un’aggiunta successiva alla sostituzione di ܐ
are il nesso genitivale con ܐ ܘܪܚܝܬ in quanto la lezione originaria ܐ si trova già allo stato costrutto e non ܒ
richiede l’uso della dalet. (c) ܘܪ ܩ ܢ ܩܪ imperfetto III singolare da ܢ ܪ La forma corrente di questo imperfetto sarebbe .ܢ ܩ ‑per assi ܢ
milazione della nun ed effetto della gutturale sulla seconda vocale ma probabilmente, la costruzioneܘܪ ܩ ܢ ܢviene proposta per mantenere la simmetria con il verbo ܘܫ ܟܢ .del secondo verso ܢ
(d) ܡ ܝܬ ܠܚ ܐ ܕܒܒ pozzo”, “cisterna di Betlemme”. Burcardo di Monte Sion, un domenicano del“ : ܓܘܒXIII secolo, riferisce nella sua Descriptio terrae sanctae di una “cisterna di Betlemme” sull’entrata ovest
49 La bet ܒ in costruzione con la radice ܗܪܓ introduce l’oggetto dell’indagine. 50 Nella costruzione del comparativo, tuttavia, non risulta l’utilizzo di avverbi. 51 De sanDoli 1983: 403, e De sanDoli 1984: 33.
85
della città52, ma questa risulta l’unica attestazione in merito. Numerosi sono invece i riferimenti ad un “pozzo di Betlemme” in cui si racconta che sarebbe caduta la stella che guidava i magi, una volta arrivati alla mangiatoia53. Si sceglie di riferirsi a quest’ultima attestazione, non solo per la maggiore notorietà del luogo per i fedeli e quindi per l’autore ma anche perché si presta meglio all’immagine di enorme profondità del pozzo, contribuendo alla realizzazione del paradosso.
(e) ܐ ܡ ܘܟܒ ܐ ܕܐ ܛ ܒ ܕܐ servo nero”. Non è chiaro perché venga utilizzato il termine“ :ܥ ܒ servo” piuttosto“ ܥ
che ܫ .se non per ragioni metriche54 ܐܢ(f) ܢ ܫ ܦܠ ܒܠ ,l’espressione è oscura. Non sono rintracciabili costruzioni idiomatiche di questo genere :ܢ
per cui si preferisce rendere letteralmente con “cadere nella lingua” o meglio “cadere nella bocca, nelle fauci”, sfruttando il segmento successivo “di un popolo assetato di rovina”, ipotizzando un’eventuale sotto‑missione, ma la mancanza di titolo e contesto ci impedisce di comprendere a pieno il significato del verso.
I primi cinque versi del poema propongono una serie di operazioni realizzate con strumenti inadeguati, al fine di creare una successione di azioni paradossali da contrapporre al conte‑nuto dell’ultimo verso. Come accennato in nota, il significato dell’ultimo verso è oscuro ma la traduzione di ܪܐ ܐ ܨܗܐ ܠܬܒ ܡ popolo assetato di rovina, di avversità” fa pensare, in via del“ ܥtutto ipotetica, che si faccia riferimento ad un qualche tipo di asservimento politico o religioso.
Il componimento è costruito in modo tale da risultare simmetrico: il secondo e quarto verso sono introdotti da un imperfetto p’eal regolare (ܘܪ ܩ ܢ ܟܢܘܫ/ܢ il terzo e quarto verso ,55(ܢda un imperfetto af‘el di verbo di media waw (ܫܓ ܝܠ/ܢ ܟ inoltre il secondo e quarto verso (ܢsono accomunati dalla citazione di luoghi particolarmente noti ai pellegrini del tempo (via del Tempio/pozzo di Betlemme).
52 “... E ivi presso la porta vi è la cisterna della cui acqua Davide desiderò bere quando era nell’accam‑pamento”. De sanDoli 1984: 197. 53 De sanDoli 1983: 65, 77, 113, 359, e De sanDoli 1984: 33. 54 Gli aggettivi ܐ ܡ ܘܟ
ܘܪܐ e ܐ hanno anche una connotazione etnica: il primo fa riferimento agli abitanti ܚ
dei paesi del Sud (Arabia, Egitto, Etiopia) mentre il secondo alle popolazioni del Mediteranneo (Asia mi‑nore e isole). La suddivisione è naturalmente fondata sul passo di Genesi 10,1‑31. 55 Su ܘܪ ܩ ܢ .v. note al testo ܢ
Fig. 1 ‑ Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Orientali 298, c. 83r, su concessione MiBACT (vd. tav. 4)
86
Poemi editif. 100v (n. 170)
Al patriarca Dionisio quando iniziò ad eliminare gli abitanti del monastero.
ܕܘ ܪܝ ܠܡܘܒ ܕ ܫ ܘܣ ܟ ܘܣܝ ܘܢ ܪܝ ܕܝ ܐ ܡ ܪܟ ܪܝ ܛ ܝ ܦ ܦܐ ܐܠ ܪܢ ܐܚ
ܘܡܪܐ56 ܝ ܥ ܢ ܒ ܠDi essere tuo amico o confidente non ho intenzione;
ܐ ܠܝܬ ܠܝ ܫ ܝ ܪ ܪܐܙܟ ܢ ܘ ܒܗܘܐ ܪܚܡܟ ܐ
ܕܐ
perché non mi appartiene un giardino che germoglia ogni giorno un nuovo capo.
ܐ ܠܝܬ ܠܝ57ܕܬ ܐ ܚ ܫ ܘܡ ܪܝ ܠܝ ܐ ܟ ܐ ܕܡܘܥܝ
ܬ ܕܓܢ
Presso di te stanno gli ambiziosi mentre io non ho ambizione;
ܐ ܠܝܬ ܠܝ ܫ ܐ58 ܚ ܢܟ ܐ ܝܬ ܠ
ܐ ܐ ܢ ܫ ܗܐ ܚ
per questo motivo io non considero un gioco la vita monastica.
ܐ59 ܠܝܬ ܠܝ ܘܫ ܐ ܟ ܥܝ ܕܡܘܬ ܫ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒ
ܐ ܪܢ ܐܚTu ti stanchi facilmente degli amici ܢܬ
ܒܥ ܐ ܐ60 ܥܓܠ ܣ ܢ ܒ ܐܚ ܢ ܡ ܐ ܕܡ ܢ ܝ
ܢܬ ܗܘ ܐ
ܐ
e ad irrequieti e calunniatori presti subito ascolto. ܢܬܪܨܐ ܥܓܠ ܫܡܥ ܐ ܠܝ ܩ ܟ
ܐ ܘܐܠ ܢ ܫ ܘܠܚ
Perché abbatti subito la difesa della mia amicizia sincera
ܢܬܪܥ ܐ
ܪܐ ܥܓܠ ܬ ܪܝ ܘܒܝ ܫ ܓܐ ܕܚ ܠܡܘܢ ܠܣܝ
dato che io sono quello che ancora non conosci? ܢܬܕܥ ܐ ܝ
ܝܠ ܐܠ ܝ ܗܘ ܕܥܕܟ
ܬ ܝ
ܐ ܐ ܢ
ܕܐ
(a) ܐ ܘܡܪ ܝ ܥ ܢ ܒ ܕܘ ܠ ܘܒ ܪܝ ܠܡ ܕ ܫ ܘܣ ܟ ܘܣܝ ܘܢ ܪܝ ܕܝ ܐ ܡ ܪܟ ܝ ܪ ܛ ܝ ܦ ܦܐ ܐܠ ܢ ܪ tutte le varianti sono concordi nel :ܐܚ
ritenere destinatario del poema il patriarca Dionisio Angur (1252‑1261) protagonista di una storia dalle tinte fosche, narrata in dettaglio nella Cronaca ecclesiastica61. Nello specifico, il titolo sembra fare riferimento al passo in cui si racconta che Dionisio avrebbe preso a torturare con il flagello gli abitanti del monastero di Mār Barsaumā in cui risiedeva62, dopo essersi macchiato dell’omicidio di Ṣaliba, suo allievo. Numerosi sono gli episodi cui potrebbe riferirsi il poema, ma a giudicare dalla Cronaca, Barhe‑braeus non sembra mostrarsi ostile a Dionisio se non dopo questo evento63. Questo ci consente di datare
56 D: ܝ ܥܘܡܪܐ ܕ ܫܪܝ ܠܡܘܒܕܘ ܠܒܢ ܟ ܘܣܝܘܣ ܘܢ ܕܝ ܐ ܡܪܝ ܪܟ ܦܛܪܝ ܐܠܦܝ ܐ ܕ ܫܪܝ :S ‑ܐܚܪܢ ܟ ܘܣܩܪܘܣ ܥܢܓܘܪ ܕܝ ܐܠܦܝ ܐ ܐܚܪܢܕ ܝ ܠܘܡܪܐ ܒܫܢ .ܠܡܘܒܕܘ ܠܒܢ 57 S: ܠܝ ܝܬ ܠ ܐ ܫ ܪܝ ܐ
ܕܘܬ ܚ ܟܠ ܐ ܝ ܘܥ Del giardino che fa crescere ogni gioia il capo non è il mio”. La“ ܕܡ
lezione sembra migliore di quella attestata nel ms. Or. 298. La costruzione del verso è infatti identica a quella degli altri, rispettando precise corrispondenze fonetiche (ܝܬ ܠܝ ܐ ܠ ܫ ܝܬ ܠܝ/ܚ ܐ ܠ ܫ ܝܬ ܠܝ/ ܪܝ ܐ ܠ ܫ ܝ ;(… ܢinoltre il participio ܐ ܝ ܘܥ è un causativo e in quanto tale è più indicato considerarlo come transitivo “fare ܡcrescere” piuttosto che “germogliare”. 58 D:
ܐ ܢ
.ܘܐ
59 S: ܐ ܘܫ ܐ ܟ ܠܝ ܐ Probabilmente un errore di stampa per .ܫ ܘܫ vita tranquilla”, “vita monastica”. Lo stesso“ ܟvale per ܐ ܠܝ ܐ tranquillità” in luogo di“ ܫ ܝ ܥ a meno che non sia un errore scribale dovuto alla presenza di ܫܐ ܘܫ .ܟ 60 D‑S: ܐ ܢ ܒ ܚ .ܡ 61 BarheBraeus 1872‑1877: coll. 730‑738.ܐ ܫܪܝ ܠܡܪܕܐ 62 ܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܡܪܓܢ ܡ ܒܫܘܛ ܩܕܝ ܘܢ ܕܡܢ quos antea virgis castigabat scorpionibus castigare“ ܘܠܗܢcoepit”. BarheBraeus 1872‑1877: coll. 737‑738. 63 Nella Cronaca si racconta che Dionisio viene accusato di numerosi furti e omicidi, avvenuti addirit‑tura all’interno del monastero, da Saliba, suo ex allievo e sostenitore del suo rivale al patriarcato Giovanni Bar Ma‘dani. Tali accuse, tuttavia, vengono considerate da Barhebraeus come una personale vendetta di
87
la composizione del poema nel periodo tra l’anno della morte di Ṣaliba e quella di Dionisio, quindi tra il 1259 e il 1261.
Tralasciando quanto riportato nei titoli, il poema potrebbe riferirsi anche ad un altro momento di attrito tra Barhebraeus e un patriarca. Nella Cronaca ecclesiastica64, Barhebraeus racconta di avere incontrato nel 1268 il patriarca, suggerendogli di non affidare ai funzionari mongoli il giudizio su un’accusa, non meglio specificata, nei confronti di un certo Simone del monastero di Mar Barsauma. Da quanto appren‑diamo nella Cronaca, il patriarca non deve avere seguito il consiglio di Barhebraeus. I fatti, essendosi svolti nel 1268, non possono riguardare il patriarca Dionisio Angur, morto nel 1261, ma devono necessa‑riamente riferirsi al patriarca Ignazio III, cioè Giosuè di Gawikat, eletto nel 1264. In tal caso, la datazione del poema andrebbe alzata al 1268/1269.
(b) ܝܬ ܠܝ ܐ ܠܕܬ ܐ ܚ ܫ ܘܡ ܪܝ ܠܝ ܐ ܟ ܝ ܐ ܕܡܘܥ
ܬ ܢ perché non mi appartiene un giardino che germoglia ogni“ :ܕܓ
giorno un nuovo capo”; possiamo intendere che l’autore non cambi idea in base all’avvicendarsi di nuovi patriarchi. In alternativa: “del giardino che germoglia ogni giorno, il nuovo capo non è il mio”; si potrebbe pensare, visto il tono critico dell’autore, ad un rifiuto dell’autorità del patriarca ma non è chiaro il riferi‑mento al giardino; ܪܝܫ nell’accezione di “fine”, “inizio” o “cima” non sembra suggerire un’interpretazione migliore del verso.
(c) ܐ ܢ ܫ soffrire”65, è utilizzato nella Cronaca ecclesiastica“ ܚܫ schiavi delle passioni”. Dalla radice“ :ܚin almeno due passi per definire contestatori in occasione di elezioni di mafriani e patriarchi66. Il termine ha certamente un’accezione negativa e da quel che sembra, le contestazioni in questione avvengono per invidia, per ambizione. Si intende, dunque, persone i cui sentimenti negativi portano ad uno stato di irre‑quietezza e insoddisfazione.
(d) ܐ ܫ ‑sofferenza”. Si sceglie qui la traduzione di “ambizione” in coerenza con quanto detto in me“ :ܚrito al termine ܐ ܢ ܫ .ܚ
(e) ܣܒܥ: participio di ܣܒܥ “essere sazio”. Il verbo non risulta costruito con ܡܢ ma la preposizione si interpreta qui nella sua accezione causativa per cui letteralmente risulta “essere sazio a causa degli amici” ma visto il significato del verbo e il contesto si tradurrà come “averne abbastanza”.
Il titolo, come detto precedentemente, attribuisce il poema ad un preciso momento della storia di Dionisio Angur e questo dato risulterebbe confermato da quanto contenuto nella Cronaca ecclesiastica. Non si esclude, tuttavia, che il poema possa riferirsi anche all’episodio sopracitato che vede coinvolto il patriarca Ignazio III. Appare chiaro, in entrambi i casi, lo scontento dell’autore e il tono di rimprovero che assume nei confronti del patriarca ma diversi passaggi del poema sono oscuri e richiederebbero di conoscere precisi dati biografici dell’au‑tore che non emergono dalle fonti a nostra disposizione.
Quanto alla composizione del poema possiamo notare come le due quartine si trovino in sequenza sia nel ms. Or 298 che nell’ambito delle prime due redazioni e presentino argomento e struttura affine.
Saliba nei confronti di Dionisio, colpevole di non avergli concesso il prolungamento della carica di archi‑mandrita. Secondo il racconto, lo stesso Saliba sarebbe poi stato ucciso all’interno del monastero per or‑dine di Dionisio. Solo dopo questo episodio, della cui veridicità Barhebraeus non sembra affatto dubitare, lo stesso inizia a mostrarsi critico nei confronti del patriarca, introducendo così il passo dove si parla delle torture cui fa riferimento il titolo del poema: ܐܬܪܘܪܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܩܠܝ ܥܠ ܕܚܠܬܐ “semetipsum porro exaltans et metum audacia superans” (BarheBraeus 1872‑1877: coll. 737‑738). 64 BarheBraeus 1872‑1877: coll. 737‑738; v.III, coll. 439‑442. 65 Nello specifico “patire passioni”, quindi “essere agitato”; “essere irrequieto”. 66 BarheBraeus 1872‑1877: coll. 451, 517.
88
f. 99v (n.154)Sul patriarca Ignazio Saba quando il nostro padre (Barhebraeus) si rinchiuse nel santuario di una grotta di Antiochia dopo un giorno di vita monastica.
ܕ ܚܒܫ ܐ ܟ ܒ ܘܣ ܣ ܝ ܐܛ ܝܓܢܪܝ ܐ ܐ ܡ ܪܟ ܪܝ ܛ ܐ ܕܥܠ ܦ ܪܢ ܐܚ
ܪ ܬ ܐ ܒ ܝ ܛܝܘܟ ܐ ܕܐܢ
ܪܬ ܕ ܡܥ ܐ ܨܝ ܕܒܚ ܘܢ ܒܡ ܒ
ܦܫܗ ܗܘ ܐ ܢ
ܗ67ܘܬ ܪܝ ܐ ܕܕܝ ܘܡ ܕ ܝ ܚ
Il Padre che nella mia tristezza ieri mi ha sostenuto, ܢܝ ܬܡܠ ܣܡܟܪܘܬܝ ܠܒܝ ܐ ܝ ܬܒ ܘܐ ܒ ܐ ܕܓ ܒ
ܐ
per me quando è entrato, la sua luce ha brillato sulle mura della mia casa.
ܢܝ ܝ ܡܫܟ ܐܣ ܙܥܓ ܒܘܗܪܗ ܐ ܕ ܥܠ ܢ ܘܠܘܬܝ ܟ
Tanta è la grazia che mi è stata concessa da lui ܢ ܟܫܬ
ܗ ܠܝ ܐ ܢ ܘ ܡ ܒ ܝ ܠܗ ܛ ܐ ܟ ܗܢ
che per vergogna il mio capo rimaneva ancora chinato.
ܢ ܪܟ ܫܝ ܗܐ ܡ ܕ ܗܫ ܪܝ ܕܡܝ ܥ ܐ ܩܨܬ ܚܡ
ܢ ܬ ܕܡ
ܐ ܪܢ ܚܐ
Quando le anime piangono, desiderano le virtù; ܐܬܪܬ ܢ ܠܡܝ ܘܚ ܢ ܣ ܝ ܟ ܐ ܒ
ܬ ܫ ܦ ܕ ܢ ܟ
per la mia anima tu sei il massimo di quelle più nobili,
ܐܪܬ ܝ ܦ ܢ ܫ ܠܗܝ ܐ ܕܟ ܫ ܗܘ ܪܝ
ܬ ܢ
ܦܫܝ ܐ ܠܘܬ ܢ
con te essa è annoverata nella schiera illustre delle perfezioni
ܐܪܬ ܝ ܐ ܕܓܡ ܠܝ ܐ ܡܥ ܐܓܡ
ܐ ܒܬ ܝ ܢ ܟ ܡܬܡ ܒ
e nel rapporto con te non la sfiorano le imperfezioni. ܐܬ ܪ ܝ ܣ ܗ ܚ ܢ ܒ ܦ ܫ ܓ
ܟ ܐܠ ܢ ܝ ܢ ܥ ܘܒ
(a) ܐ ܘܡ ܕ ܝ ܪ ܚܬ ܐ ܒ ܝ ܘܟ ܛܝ ܐ ܕܐܢ
ܪܬ ܕ ܡܥ ܐ ܨܝ ܚ ܕܒ ܘܢ ܒܡ ܒ
ܦܫܗ ܗܘ ܐ ܕ ܚܒܫ ܢ ܐ ܟ ܒ ܘܣ ܣ ܝ ܐܛ ܓܢ ܝ
ܪܝ ܐ ܐ ܡ ܪܟ ܝ ܪ ܛ ܐ ܕܥܠ ܦ ܪܢ ܐܚ
ܗܘܬ ܪܝ Il titolo dell’edizione di Scebabi e il ms. Or. 298 concordano nell’attribuire il poema al momento :ܕܕܝ
della visita del patriarca Ignazio Saba a Barhebraeus durante il suo noviziato ad Antiochia. Come già osservato da Takahashi68, il dato che Barhebraeus abbia preso i voti proprio ad Antiochia ci è trasmesso solo dal titolo attestato in alcuni manoscritti; il fatto che il titolo si mostri più o meno affine nell’edizione Scebabi e nei mss. Vat. sir. 174 e BNF. 197 ci suggerisce che questa attribuzione si sia creata e mantenuta nell’ambito della prima redazione e che, viste le considerazioni esposte, possa essere considerata piuttosto antica. Il titolo attestato nell’ambito della seconda redazione sembra essere una ripresa del contenuto del poema e possiamo quindi ipotizzare che si tratti di un’aggiunta69.
(b) ܢ ܫܟ abitare” indica semplicemente “dimora”, “abitazione”. Il titolo ci informa“ ܫܟܢ dalla radice :ܡche si tratta del santuario costruito all’interno di una grotta dove probabilmente si ritiravano in preghiera i canditati all’ordinazione ecclesiastica70.
(c) “ :ܢ ܪܟ ܫܝ ܗܐ ܡ ܕ ܗܫ ܪܝ ܕܡܝ ܥ ܐ ܩܨܬ ܚܡ
ܢ ܬ .”che per vergogna il mio capo rimaneva ancora chinato :ܕܡ
In alternativa si può pensare che il soggetto del verso sia lo stesso patriarca, traducendo “per modestia davanti a me il mio superiore si è chinato”; sebbene un tale atto di umiltà non contrasti di certo con le qualità del patriarca che l’autore vuole evidenziare, a questa interpretazione si oppongono i seguenti dati: il termine ܐ ܨܬ ܚܡ
‑che indica al pa‘‘el più propriamente “vergognarsi”; un senti ܚܡܨ proviene dalla radice ܬ
mento di vergogna non pare addirsi ad un patriarca che visita un novizio, per quanto possa essere umile. Inoltre la suddetta traduzione non rende ragione dell’avverbio ܕ ܗܫ ancora” che è invece meglio inserito“ ܥ
67 D: ܐ ܪܟ ܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝ ܐ ܟܕ ܣܥܪܗ ܐܝܓܢ ܒܘܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ ܕܥܒܕ ܥܡܗ ܛܒܘ ܘܒܐܚܪܢ ܐ ܐܡܪܗ ܟܕ ܣܥܪܗ :S – ܩܘܒܠ ܛܝ ܐܚܪܢܘܬܗ ܪܝ ܘܡܐ ܕܕܝ ܐ ܒܬܪ ܚܕ ܝ ܝ ܘܟ ܛܝ ܕ ܡܥܪܬܐ ܒܐܢ ܦܫܗ ܒܡܕܒܚܐ ܕܨܝ .ܣܒܐ ܘܗܘ ܚܒܫ ܢ 68 takahashi 2005: 17. 69 Il titolo richiama i termini ܐ ܒ
ܘ e ܐ ܒ ܝ .presenti nel poema ܛ
70 takahashi 2005: 17.
89
nella traduzione scelta71. (d) ܐ ܝ ܢ .si tratta di un hapax :ܡܬܡ(e) ܟ ܢ ܝ ܢ ܥ ܐ .”in rapporto con te“ :ܒ ܢ ܝ indica un rapporto piuttosto confidenziale e stretto come anche ܥ
“conversazione”. (f) Utilizzo dell’espediente grafico della yod quiescente nel pronome personale di I persona singolare
in modo che la rima risulti inalterata nei quattro versi: ‑ken(y) nel I‑II verso e ‑ken nel III‑IV verso.
Secondo quanto osservato prima, è probabile che il poema si riferisca proprio al patriarca Ignazio III Davide Saba (1222‑1252). Il poema può dunque essere datato tra il 1243/44, anno in cui la famiglia di Barhebraeus si trasferisce ad Antiochia e il 1246 quando, dopo un sog‑giorno a Tripoli, Barhebraues viene eletto vescovo di Gubos.
f. 98v (n.137)Sulla candela 72ܐ ܘܢ ܪܝ ܥܠ ܩ
O candela dal colore pallido, cosa ti è capitato? ܐ ܓܕܫܟ ܢ ܐ ܡ ܢ ܓܘܢ ܪܩ ܐ ܝ ܘܢ ܪܝ ܘ ܩܐ
Forse la sera fa soffrire anche te. 74ܚܫܟܦ ܠܟ ܐ
ܐ73 ܐ ܝ ܝܬ ܪܡܫ ܐ ܟ ܢ ܐ ܙܒ ܕܠܡ
Non solo a te brucia la testa tutta la notte ܠܗ ܪܡܫܟ75 ܛ ܟܐ ܟ ܣ ܫ ܟ ܪܝ ܘܕܝ ܠܚ ܠܘ ܒ
ma anche io ho nel cuore ciò che tu hai in testa. ܫܟ ܪܝ ܐ ܕܒ ܐ ܡ ܢܐ ܐ ܢ ܐ ܩ ܒ ܐ ܒܠ ܢ
ܦ ܐ
ܕܗܐ76 ܐ
ܐ ܪܢ ܚܐ
Ho interrogato la candela: perché mai al momento della sera
ܐ ܕܢ79 ܪܡܫ ܐ77 ܗܟܝܠ78 ܒܥ ܐܠܬ ܕܠܡ ܘܢ ܫ ܪܝ ܠܩ
la tua bocca ride mentre i tuoi occhi versano lacrime di sofferenza?
ܐ ܫ ܐ ܕܚ ܥ ܢ ܕܡ ܪܕܝ ܝܟ ܡ ܢ ܝ ܟ ܘܥ ܘܡܟ ܓܚ ܦ
Ha risposto: perché mi hanno separata dalla cavità amica del miele
ܐ ܐ 81ܕܕܒܫ ܡ ܝ ܐ 80ܪܚ ܘܒ ܢ ܓܘ ܥ ܝ ܡ ܘܢ ܪܫ ܐ ܥܠ ܕܦ ܥܢ
e mi hanno messo un fuoco sulla testa tutta la notte. ܐ ܫ ܢ ܪܝ ܐ ܠܥܠ ܡ ܝܠܗ ܠܐ ܘܪܐ ܣܡܘ ܠܝ ܟ ܘܢ
71 Non è da escludere un collegamento tra il quarto e il secondo verso per cui il capo di Barhebraeus non rimane abbassato solo per vergogna della benevolenza mostratagli ma anche per la luce irradiata dell’in‑gresso del patriarca nel santuario. 72 S: ܐ ܘܢ ܐ ܥܠ ܩܪܝ .ܐܚܪܢ 73 D: ܐ ܝ ܐ ܗܘ ܪܡܫ ܫ ܝܬ ܚ ܐ ܟ .ܠܡ 74 S: ܟܟ ܚܫ
oscurare” non sembra adattarsi al contesto visto che la notte richiede che la“ ܚܫܟ La radice .ܐ
candela venga accesa e il tema della sofferenza (radice ܚܫ) attraversa tutta la composizione. 75 D: ܠܗ ܪܡܫܟ ܟ ܟ ܫ ܛ ܪܝ
ܐ ܟ ܣ ܘܕܝ ܢܬ ܠܚ
ܘ ܐ ܢܬ Il pronome .ܠ
sembra essere un’aggiunta per riequilibrare il ܐ
numero di sillabe data la perdita di ܒ. 76 D: ܗܐ. 77 D: ܕܠܡܘܢ ‑ S: ܢ .ܕܠܡ 78 D: ܢ .ܗܟ 79 D‑S: ܢ ܙܒ .ܒ 80 S: ܘܒܗ .ܥ 81 D: ܝܡܐ .ܪܚ
90
(a) ܐ ܘܢ ܪܝ ‑il tema della candela è particolarmente diffuso nella letteratura mistica persiana82. At :ܥܠ ܩtestata come metafora a partire dal X sec. quando Ḥusayn bin Manṣūr Ḥallāj83 utilizza per la prima volta l’immagine della candela e della falena84, la candela è stata utilizzata nella poesia di Aḥmad Ghazalī e Manūchihrī Dāmghāni come simbolo dell’amante che, proprio come la cera sotto l’effetto della fiamma, si consuma di passione. È proprio alla qaṣīdā di Manūchihrī Dāmghāni dedicata al poeta ‘Onṣorī85 che si ispira Barhebraeus per la composizione di questo poema.
(b) ܐ .si preferisce tradurre come particella dubitativa “forse” piuttosto che come interrogativo86 :ܕܠܡ(c) ܫܟ ܪܝ ܐ ܕܒ ܐ ܡ ܢ
ܐ ܐ ܢ ܐ ܩ ܒ ܐ ܒܠ ܢ
ܦ ܐ
anche io ho nel cuore ciò che tu hai in testa”. Da notare la somiglianza“ :ܐ
con il verso di Manūchihrī «that which I have placed in my heart, I see upon your head; what you have placed upon your head, its homeland is my heart»87. Ci si riferisce chiaramente alla fiamma della candela che diventa metafora della passione per cui brucia il petto del poeta.
(d) ܐ ܫ ܐ ܕܚ ܥ ܢ ܕܡ ܪܕܝ ܟ ܡ ܝ ܢ ܝ ܟ ܘܥ ܚ ܘܡܟ ܓ ܐ... ܦ ‑perché la tua bocca ride mentre i tuoi occhi versano la“ :ܕܠܡcrime di sofferenza?”. Il verso richiama quello di Manūchihrī «You always laugh and weep at once; this is very rare»88. Il sorriso della candela è la fiamma che trema e le lacrime sono le gocce di cera che scendono per effetto del calore. La costruzione del paradosso si basa proprio sulla contemporaneità delle due azioni.
(e) ܢ ܓܘ ܓܘ separare da” e considerare“ ܦܪܫ alla radice ܡܢ dentro” ma qui si preferisce associare“ :ܡin stato costrutto con ܥܘܒܐ.
(f) ܐ ܐ ܕܕܒܫ ܡ ܝ ܐ ܪܚ ܘܒ ܢ ܓܘ ܥ ܝ ܡ ܘܢ ܪܫ mi hanno separata dalla cavità amica del miele”. Si sceglie di“ :ܕܦtradurre ܐ ܘܒ come “cavità”, “recesso” in riferimento al procedimento di estrazione della cera d’api con ܥcui venivano prodotte le candele89. Naturalmente non si esclude che il termine assuma anche un significato simbolico. Seyed Gorab riferisce nel suo studio «In conventional metaphors, the candle is compared to a lover separated from its beloved honey, as candles were then made from honey’s wax». Il termine ܐ ܘܒ ܥindica principalmente “grembo” quindi sembra che l’estrazione della cera dalle cavità del favo richiami l’immagine della separazione dell’amante dal grembo dell’amato. Questa metafora è d’altronde confer‑mata dal gioco di parole innescato da ܐ ܡ ܝ ܐ riferibile sia a ܪܚ ܡ ܝ ܐ ܪܚ ܘܒ ܐ grembo amato” sia a“ ܥ ܫ ܐ ܕܕܒ ܡ ܝ ܪܚ“amico del miele”, esprimendo cioè la connessione tra favo e miele. Nella qaṣīdā di Manūchihrī non è presente un verso affine a questo quindi Barhebraeus deve avere attinto anche ad altre fonti per la com‑posizione del poema.
82 sulla ricchezza di immagini e metafore legate alla candela nella letteratura persiana; v. ehsan 1990, pp. 748‑751 e seyeD gohraB 2012: 81‑124. 83 Ḥallāj compone le sue opere in arabo e non si inserisce, quindi, nella tradizione letteraria neopersia‑na, tuttavia introduce una metafora molto usata dai mistici persiani di XI e XII secolo. 84 La falena, come l’uomo nei confronti dell’amato, è attratta dalla fiamma della candela, e una volta venuta in contatto con essa, perisce. Ḥallāj non cita direttamente la candela ma parla di una lampada. seyeD gohraB 2012: 84. 85 Si tratta di un componimento molto celebre, in cui il poeta si rivolge direttamente alla candela, interrogandola. La dettagliata descrizione dell’oggetto diventa occasione per creare raffinate metafore e paradossi che ritroviamo nei versi di Barhebraeus. 86 Non sembra appropriata una domanda in questo verso dato che in quello seguente l’autore ha già individuato il motivo di sofferenza della candela. Inoltre ܐ come interrogativo presuppone una risposta ܕܠܡnegativa che non sembra essere ragionevole in questo contesto. 87 seyeD‑gohraB 2012: 88. Diversamente traduce Browne: «i behold upon thy head what in my heart doth hidden rest; thou upon thy head dost carry what I hide within my breast» (Browne 1928: 155). 88 Browne: “Even midst thy smiles thou weepest and moreover strange to tell” (Browne 1928: 155). 89 Le prime candele, prodotte con grasso animale vengono poi sostituite dalle candele di cera d’api. La cera espulsa dalle api operaie viene utilizzata per la costruzione degli opercoli, cioè le coperture delle celle del favo e da lì estratta dagli apicoltori. È proprio a queste cavità che potrebbe riferirsi il termine ܐ ܘܒ .ܥ
91
Il poema sembra ispirato alla qaṣīdā di Manūchihrī ma non ne costituisce una vera e pro‑pria traduzione, non solo perché costituito da 8 versi a fronte dei 38 di Manūchihrī ma anche perché i versi che abbiamo posto a confronto non fanno pensare ad una traduzione letterale. La metafora del settimo verso lascia intendere che siano anche altre le fonti utilizzate da Barhebraeus per la composizione della poesia.
Nel corso della poesia l’autore si identifica con la candela il cui consumarsi durante la notte richiama la sofferenza dell’amante90; il bruciare della fiamma per la candela e il brucia‑re della passione per l’amante porta entrambi a consumarsi e quindi ad autodistruggersi. La separazione della cera dal favo è motivo di sofferenza per la candela così come per l’amante separato dall’amato.
Che Barhebraeus conoscesse il persiano ci è noto dall’uso di fonti persiane per la stesura di alcune opere91. È possibile che l’autore sia venuto a conoscenza della poesia di Manūchihrī e di altri mistici persiani in occasione dei suoi periodi di soggiorno a Maragha a partire dal 1256 e in cui ebbe la possibilità di accedere alla biblioteca della città92.
f. 91r/v (n. 42)Un’altra che ha composto su se stesso e che ha scritto su un bacile di bronzo ricoperto d’argento.
ܐ ܫ ܚ ܐ ܕܢ ܢ ܒܗ ܥܠ ܠܩܦܫܗ ܘܟܬ ܡܪܗ ܥܠ ܢ
ܐ ܕܐ ܪܢ ܐܚ
ܐ93 ܐܡ ܒܣ
Tu che lavi con l’acqua mani e viso tutti i giorni ܘܡ ܠܝ ܐ ܟ ܝ ܐ ܒܡ ܦܕܐ ܘܐ ܝ
ܬ ܐ ܢ
ܘ ܕܡܫܝܓ ܐ
ܐ
perché non lavi l’anima che è piena di macchie? ܠܡܘܡ ܐ ܟ ܕܐ ܕܡܠܝ ܝܐ94 ܐ ܦܫ ܬܫܝܓ ܢ
ܐ ܐܠ ܢ ܠܡ
Ogni bocca testimonia che la sporcizia del corpo insudicia il corpo stesso
ܗܕ95 ܟܠ ܦܘܡ ܐ ܣ ܐ ܕܦܓܪܐ ܠܦܓܪܐ ܡܟܬܡܕܨܐܬ
mentre la sporcizia dell’anima penalizza anima e corpo96. Non dormire!
ܘܡ ܬܢܐ ܐܠ ܩ ܢ ܐ ܘܦܓܪܐ ܡܫ ܦܫ ܐ ܠܢ ܦܫ ܐ ܕܢ
ܘܨܐܬ
Perché, uomo, non ti ricordi mai ܘܡܟ ܓܒܪܐ ܡܡܬ ܘܗܕܢ ܐ ܥܠ ܥ
ܬ ܝ
ܬ
ܠܡܘܢ ܐܠ
che stai per presentarti alla porta dello sposo il giorno del banchetto?
ܢܬ ܕܬܩܘܡܕ ܐ ܝ
ܐ ܥܬ
ܘܬ
ܘܡ ܡܫܬ ܐ ܝ ܬܢ ܕܒܬܪܥ ܚ
Se non abbellirai la tua anima con le virtù, amico, 97ܘ ܪܚܘܡܟ ܐ ܦܫ ܐ ܢ
ܬܪܬ ܬܨܒܬ ܒܡܝ
ܢ ܐܠ
ܐ
anche se la ricoprissi d’oro, sarai cacciato. 98ܩܪܘܡܟ ܬ ܦܫ ܐ ܠܢ ܢ ܕܗܒ ܦ
ܢܬ ܗܘ ܐ
ܪܕ ܐ ܡܬܛ
Se non imbavaglierai la bocca del corpo dalle arroganze
ܒܠܘܡ ܬ
ܢ ܐܠ
ܐ ܐ
ܬܐܘ ܢ ܓ ܐ ܕܦܓܪܐ ܡ ܘܡ ܦ
90 Come nella letteratura sufi, i sintomi descritti potrebbero chiaramente riferirsi a quelli di un amore carnale se il contesto non suggerisse che in realtà si tratta di amore mistico. 91 takahashi 2005: 28. 92 BorBone 2004: 121. 93 D: ܚܫܐ ܒܣܐܡܐ ܐ ܕܢ ܦܫܐ ܟܬܒܗ ܥܠ ܠܩܢ ܘܬ ܢ ܝ ܘܬܐ ܡܛܠ ܕܟ ܢ ܐ ܘܡܪܬܝ ܚܫܐ :S – ܟܘܘܢ ܐ ܕܢ ܐ ܥܠ ܠܩܢ ܢ ܐ ܕܟܬܒܗ ܐܒܘܢ ܡܦܪܝ ܐܚܪܢ.ܒܣܐܡܐ 94 D‑S: ܦܫܟ .ܢ 95 S: ܗܪ .Probabilmente è un errore di stampa .ܣ 96 Nel codice non c’è interpunzione all’interno del verso. 97 S: ܪܚܘܡܝ. 98 D‑S: ܐ ܠܦܓܪܟ ܢ ܕܗܒ ܦ
ܕܐ ܐ ܝ ܪ ܗܘܐ ܛ
.ܬ
92
Non gusterai le delizie del succo del banchetto. ܐ ܙܘܡܪܘܬ ܓܝ ܫ ܒ
ܛ ܢ ܦ ܢܬ ܡ
ܡ ܐ ܥ ܛ
ܐܠ
Sii misericordioso e generoso e non essere oppressore.
ܠܘܡ ܬܗܐ ܛܕܐ ܘܐܠ ܐܝ ܪ ܒ ܝ
ܬ ܐ ܘܥ ܢ ܗܘܝ ܡܪܚܡ
Affinché tu non digrigni i denti e pianga con voce tremante.
ܕܪܥܘܡܐܠ ܐ ܒܩ ܒܟ
ܐ ܘܬ
ܢ ܪܩ99 ܫ ܬܗܐ ܬܚ
ܕܐܠ
Al giardino del tuo desiderio fai sorgere delle barriere, recinta e confina
ܝܓ ܘܬܚܘܡ ܪܐ100 ܘܣ ܟ ܝܡ ܣ ܩܟ ܐ
ܬ ܪܓܬ ܠܓܢ
affinché tu non sia dirottato dai servi dello sposo nell’abisso.
ܐ ܒܬܗܘܡ ܬܢ ܝ ܚ ܫ ܡ ܢ ܫ ܪܓܠ ܡܫܬ
ܬ
ܕܐܠ
Perché non giunga subito il banchetto, prega e digiuna
ܦ ܨܘܡܐ ܨܐܠ101 ܐ
ܘܬ
ܘ ܬܗܐ ܡܫܬ ܒ ܪܗܝ ܒ
ܕܐܠ
fino a che sia lavato e purificato il tuo vaso nero. ܘܟܡ102ܟ ܕܐ ܐܢ ܠ ܡ ܨܛ ܦ ܢ
ܠ ܐ ܬܚ ܕ ܢ ܥ
(a) ܘܡ ܬ ܕܬܩ ܢܕ ܐ ܝ
ܕ letteralmente “pronto per presentarti”. Il participio :ܥܬ ܝ
seguito da dalet esprime ܥܬ
tempo futuro103 quindi renderemo con “stai per presentarti” per rendere la prossimità dell’evento. (b) ܘܡ ܬ ܕܬܩ ܢ
ܕ ܐ ܝ
ܐ ܥܬ
ܘܬ
ܘܡ ܡܫܬ ܐ ܝ ܬܢ che stai per presentarti alla porta dello sposo il giorno del“ :ܕܒܬܪܥ ܚ
banchetto”. Il richiamo è alla Parabola delle dieci vergini (Matteo 25,1‑13)104.(c) ܙܘܡ: il termine è piuttosto complesso tanto che entrambi gli editori ritengono di segnalarlo nei glos‑
sari delle edizioni di A. Scebabi e Y. Dolabani. Scebabi suggerisce il significato di “muso” o “uccello”; che il termine abbia a che fare con il mondo
animale e nello specifico con qualche tipo di volatile è suggerito anche dalla radice ܙܘܡ “cinguettare”105. Il termine sembra riferirsi in particolare ad un tipo di volatile da caccia ma non è chiaro se vada inteso come cacciagione o uccello rapace utilizzato nella falconeria. Payne Smith nel suo Thesaurus riferisce «avis quaedam rapax aquilae similis, quae quum vocat eam Barhebraeus» il che ci porta a scegliere la seconda ipotesi106; per questa ragione non sembra ragionevole pensare che sia questo il significato scelto da Barhe‑braeus per il suo verso, dato che il termine non indicherebbe un animale commestibile.
Nel lessico di Dolabani troviamo invece ܕܒܫܝܠ ܒܣܪܐ ‑succo d’uva acerba107 bollito” che ricon“ ܡܝ duce all’attestazione di ܙܘܡ come traslitterazione del greco ζωμός “succo”, “liquido” o più precisamente “fermento”108, in riferimento ad un tipo di bevanda. Barhebraeus non è estraneo all’uso di grecismi nelle sue opere quindi sembra preferibile accogliere questa intepretazione del termine. Nella traduzione rende‑remo genericamente con “succo”.
(d) ܕܐܠ ܬܗܐ: si traduce qui come una proposizione ipotetica “se non lo sarai” ma questo entra in contrasto con diversi dati: la dalet generalmente non introduce questo genere di proposizioni e gli ultimi versi sono costruiti in modo tale da far seguire ad un imperativo una proposizione finale negativa; in questo contesto, dunque, sembrerebbe più ragionevole interpretare ܬܗܘܐ ܕܐܠ come una finale e emendare di conseguenza la
99 D‑S: ܪܩ Per le considerazioni esposte nel commento, si ritiene questa lezione migliore di quella .ܡܚtestimoniata dal ms. Or. 298. 100 D: ܪܐ ܘܟ ܪܐ :S ܣ ܘܟ .”barra”, “blocco“ ܣ 101 S: ܨܐܠ 102 D‑S: ܘܡ ܡ Scebabi nel suo lessico riporta il significato “nero” come .ܐܟ ܘܟ
.ܐ
103 Payne sMith 1902: 431. 104 Si confronti con il poema n. 131. 105 “Tintinnare”, “squillare” ma in riferimento agli uccelli “cinguettare”. 106 Payne sMith 1879: 1101 e sokoloFF 2009: 373. 107 Payne sMith 1902: 49. 108 Payne sMith 1879: 1102 e sokoloFF 2009: 373.
93
lezione ܪܩ ܪܩ con quella di Dolabani e Scebabi ܬܚ ‑da cui la traduzione letterale “affinché tu non sia di ܡܚgrignante i denti…” in coerenza con la costruzione degli altri versi109. Per questo motivo, sebbene nel testo sia proposta la lezione del ms. Or. 298, renderemo la traduzione come se fosse presente ܪܩ .ܡܚ
(e) ܐ ܘܬ ܡܫܬ ܬܗܐ ܘ ܒ ܪܗܝ ܒ traduciamo :ܕܐܠ ܬܗܐ con “giunga” anziché “sia” per sottolineare la prossimità
dell’evento. Ci si riferisce al banchetto delle nozze della Parabola delle dieci vergini.(f) ܘܟܡ
ܟ ܕܐ ܐܢ ܠ ܡ ܨܛ ܦ ܢ
ܠ ܐ ܬܚ ܕ ܢ fino a che sia lavato e purificato il tuo vaso nero”. Probabilmente è :ܥ
un riferimento al bacile per le abluzioni, indicando metaforicamente il processo di purificazione cui deve sottoporsi l’uomo fino all’eliminazione di ogni sporcizia morale; la connessione simbolica tra macchia del corpo e quella dell’anima si riversa, dunque, nell’immagine del vaso ormai pulito da ogni sporcizia.
La concordanza di tutti i titoli suggerisce che il poema fosse effettivamente inciso su un bacile per abluzioni. L’intero componimento gioca sul sovrapporsi simbolico di purificazione fisica e spirituale, richiamandosi costantemente al destino post‑mortem dell’uomo. L’invito a redimersi e purificarsi dai peccati è certamente un tema cardine che accomuna questo poema ad almeno altri due editi nel presente lavoro, richiamando, nel caso del poema n. 131, lo stesso passo evangelico.
BibliografiaAA.VV., Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, S.P. Brock, A.M. Butts, G.A. Kiraz
and L. Van Rompay (eds.), Piscataway, NJ 2011.AA.VV., Les Liturgies Syriaques, Françoise Cassingena‑Trévedy and Isabella Jurasz (eds.), Paris
2006.AA.VV., Nos Sources: Arts et Litterature Syriaques, Antelias 2005.allen, r., La letteratura araba, Bologna 2006 (ed. or.: An Introduction to Arabic Literature,
Cambridge, 2000; trad. di Bruna Soravia).aMalDi, D., Storia della letteratura araba classica, Bologna 2004.asseMani, g.s., Bibliotheca Orientalis Clementina Vaticana, Romæ 1719.asseMani, s.e. e asseMani G.S., Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codicus Manuscriptorum
Catalogus in Tres Partes Distributus, Partis Primae, Tomus Tertius, Romæ 1759.asseMani, s.e., Bibliothecae Mediceae Laurentianae et Palatinae Codicum Mss. Orientalium
Catalogus, Florentiæ 1742.Buzzetti, c., aurelio t., Mannucci v., Le lettere di Paolo, Torino 1981.BarheBraeus, Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum I‑III, J.B. Abbeloos, T.J. Lamy (edd.),
Lovanii 1872‑1877.BarheBraeus, Ktābā d‑Maktbānūt Zabnē d‑Sīm l‑Mār Grīgōriyōs Bar ‘Ebrāyā. Gregorii Barhebraei
Chronicon Syriacum, Paul Bedjan (ed.), Paris 1890.BarheBraeus, Die Scheune der Mysterien. Kommentar Zum Alten und Neuen Testament Des Mor
Gregorios Yohanna Bar Ebroyo (1226‑1286), Glane‑Losser 2003.BarsouM, aPh., The Scattered Pearls. A History of Syriac Literature and Sciences, Piscataway 2003.
109 A sostegno di questa ipotesi rileviamo che è ambiguo l’oggetto di riferimento di “se non lo sarai” dal momento che nel verso precedente si scrive “Sii misericordioso e generoso e non essere oppressore”; visto l’imperativo negativo finale la frase “se non lo sarai” sarebbe contraddittoria.
94
BauMstark, a., Geschichte der Syrischen Literatur, Berlin 1922.BorBone, P.g., «Barhebraeus e Juwayni: un cronista siro e la sua fonte persiana», Egitto e Vicino
Oriente 27 (2004), 121‑144.Brock, s., A Brief Outline of Syriac Literature, Kottayam 2008.Brock, s., «Poetry and Hymnography: Syriac», in The Oxford Handbook of Early Christian Studies,
D. Hunter S. Ashbrook Harvey (ed.), Oxford 2008: 657‑671.Browne, e.g., A Literary History of Persia, Cambridge 1928.BuDge, e.a.w., The Laughable Stories, London 1897.chaBot, J.‑B., «Une Poesie Syriaque de Gregoire Bar‑Hebreus», in Melanges Charles de Harlez.
Recueil de travaux d’erudition offert a Mgr. Charles de Harlez a l’occasion du vingtcinquieme anniversaire de son professorat a l’université de Louvain 1871‑1896, Leiden 1896.
costaz, l., Dictionnaire siriaque‑français, Beyrouth 1963.costaz, l., Grammaire syriaque, Beyrouth 1955.De sanDoli, s., Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum, Vol. III. Tempore Recuperationis Terrae
Sanctae (1187‑1244), Jerusalem 1983.De sanDoli, s., Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum, Vol. IV. Tempore Regni Latini Extremo
(1245‑1291), Jerusalem 1984.DolaBani,y., Ktobo d‑Bar Ma‘adani, Losser 1929.DolaBani, y., Mushhata d‑Mar Grigoriyos Yohannan Bar‑ ‘Ebraya Mapryana d‑Madnha, Jerusalem
1929.Duval, r., Traité de grammaire syriaque, Paris 1881, no., Amsterdam 2004.eFreM, S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena, Lipsiae 1866.Fani, s., Farina M., Le vie delle lettere: la Tipografia Medicea tra Roma e l’Oriente, Firenze 2012.Fiey, J.M., «Esquisse d’une Bibliographie de Bar Hébraeus», Parole de l’Orient 16 (1986), 279‑312.healey, J.F., Leshono Suryoyo: First Studies in Syriac, Piscataway 2005.hölscher, g., Syrische Verskunst, Leipzig 1932, no.kiraz, g.a., A Grammar of the Syriac Language, Piscataway 2012.von lengerke, c., «Gregorii Barhebraei Carmina Syriaca Aliquot Adhuc Inedita», in Festum
Pentecostes Pie Celebrandum Civibus Academicis Indicunt Prorector, Director, Cancellarius et Senatus Academiae Albertinae, Konigsberg 1836.
von lengerke, c., «Gregorii Barhebraei Carmina Syriaca Aliquot Adhuc Inedita Pars II», in Festum Jesu Christi Natalitium Pie Celebrandum Civibus Academicis Indicunt Prorector, Director, Cancellarius et Senatus Academiae Albertinae, Konigsberg 1837.
von lengerke, c., «Gregorii Barhebraei Carmina Syriaca Aliquot Adhuc Inedita Pars III», in Festum Paschatis Pie Celebrandum Civibus Academicis Indicunt Prorector, Director, Cancellarius et Senatus Academiae Albertinae, Konigsberg 1838.
von lengerke, c., «Gregorii Barhebraei Carmina Syriaca Aliquot Adhuc Inedita Pars IV», in Festum Pentecostes Pie Celebrandum Civibus Academicis Indicunt Prorector, Director, Cancellarius et Senatus Academiae Albertinae, Konigsberg 1838.
leroy, J., «La Renaissance de l’eglise syriaque aux XIIème‑XIIIème siècles», Cahiers de Civilisation Mediévale 54 (1971), 131‑148.
Mai, a., Scriptorum Veterum Nova Collectio, Roma 1831.Marchetti, a., I canti della Chiesa siriaca, Bologna ‑ Roma 1993.
95
Mengozzi, a., «A Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collections», Egitto e Vicino Oriente 33 (2010), 187‑203.
Muraoka, t., Classical Syriac for Hebraists, Wiesbaden 1987.nestle, e., «Bibliographische Anzeigen: Gregorii Bar‑Hebraei Carmina. A Patre Augustino Scebabi
monacho Maronita Libanensi Aleppensi correcta, ac ab eodem lexicon adjunctum», Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 33 (1879), 545‑47.
nolDeke, th., Kurzgefasste Syrische Grammatik, Darmstadt 1966.Payne sMith, r., Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae, Oxford 1864.Payne sMith, r., A Compendious Syriac Dictionary, Oxford 1902.Payne sMith, r., Thesaurus Syriacus, Oxford 1879.Pazzini, M., Grammatica siriaca, Gerusalemme 1999.sceBaBi, a., Gregorii Bar‑Hebraei Carmina. A Patre Augustino Scebabi monacho maronita libanensi
aleppensi correcta, ac ab eodem lexicon adiunctum, Roma 1877.segal, J.B., The Diacritical Point and the Accents in Syriac, London ‑ New York ‑ Toronto 1953.seyeD‑gohraB a.a., «Waxing Eloquent: The Masterful Variations on Candle Metaphors in the Poetry
of Hafiz and His Predecessors», in Metaphor and Imagery in Persian Poetry, Seyed‑Gohrab A. A. (ed.), Leiden 2012: 81‑124.
sionita, G., Veteris Philosophi Syri de Sapientia Divina Poema Aenigmaticum, Paris 1628.sokoloFF, M., A Syriac Lexicon, Piscataway 2009.starkey, P. – scott MeisaMi, J., Encyclopedia of Arabic Literature, London 1998.takahashi, h., Barhebraeus: A Bio‑Bibliography, Piscataway 2005.takahashi, h., «Gregorii Barhebraei Carmen “Quod praestantes in hoc mundo odio haberi solent”»,
in Seiyō‑Kotengaku No Asu He: Itsumi Kiichiro Kyōju Taikan Kinen Ronshū, N. Noike Y. Oshiba (eds.), Tokyo 2010: 363‑371.
takahashi, h., «The Poems of Barhebraeus: A Preliminary Concordance», Hristjanskji Vostok 6 (2013), 78‑139.
taylor, D.g.k., «“Your Sweet Saliva is the Living Wine”: Drink, Desire, and Devotion in the Syriac Songs of Khāmīs Bar Qardāh», in The Syriac Renaissance, H. Teule, C. Fotescu Tauwinkl, B. ter Haar Romany e J. van Ginkel (eds), Leuven ‑ Paris ‑ Walpole 2010: 31‑52.
teule, h., «Gregory Barhebraeus and His Time: The Syrian Renaissance», Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 3 (2003), 21‑43.
yarshater, e. (ed.), Encyclopaedia Iranica. Vol. 12. Harem‑Illuminationism, London 2004.yarshater, e. (ed.), Encyclopaedia Iranica. Vol. 4: Bayju‑Carpets, London 1990.zingerle, P., «Ueber Den Reim in Syrischen Gedichten», Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft 10 (1856), 110‑116.zotenBerg h., Catalogues des manuscrits syriaques et sabéens (mandaïtes) de la Bibliothèque
Nationale, Paris 1874.