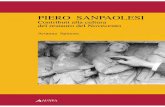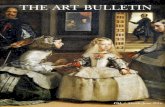Davanti alla "Resurrezione di Cristo" di Piero della Francesca. Osservazioni, emozioni, e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Davanti alla "Resurrezione di Cristo" di Piero della Francesca. Osservazioni, emozioni, e...
PIERO DELLA FRANCESCA:RESURREZIONE DI CRISTO
Osservazioni, emozioni e riflessioni di Bruna Rossi ([email protected])
Questo grande affresco di Piero della Francesca, dipinto tra il 1463 e il 1465, rappresenta la Resurrezione di Cristo. Si trova nel Museo Civico di Sansepolcro, che ho visitato circa un anno fa. Il sentimento di stupore e ammirazione che ho provato in quell‘occasione si è mantenuto nel tempo, anzi, è cresciuto, perché quest’opera non si dimentica, ma matura lentamente alla coscienza, e questo probabilmente è ciò che l’artista voleva trasmetterci...La cosa che più mi ha colpito, in questo dipinto, sono stati gli occhi del Cristo, spalancati e fissi ad osservare non solo chi sta davanti all’opera, come spesso accade nelle immagini sacre, ma qualcosa di più grande; sereni, ma vigili e consapevoli di una Verità che va... oltre...
E quegli occhi colpiscono ancora di più se li confrontiamo con quelli dei soldati posti a guardia del sepolcro: essi infatti non vedono! E non soltanto perché sono stati colti dal sonno... Il loro è un sonno ignaro, eccoli infatti immobili, abbandonati in un atteggiamento di apatia, di noncuranza, di distacco quasi dal miracolo che si sta realizzando davanti ai loro occhi, occhi però decisamente chiusi, occhi di chi vive nel buio...Quelle palpebre abbassate danno più l’impressione di trovarci davanti a persone colte da cecità, piuttosto che dal sonno: è la cecità dell’indifferenza, di chi per ignoranza o per scelta ha deciso di non vedere, come l’uomo sulla sinistra, che, pur sveglio, si copre volontariamente gli occhi ed abbassa la testa. Sono chiusi gli occhi come il loro cuore ed essi sono come pupazzi inanimati e ignari...
Il tempo si è fermato, per loro, quel tempo che opera cambiamenti nella Natura alle spalle del Cristo (vero padrone del Tempo) è precluso a quegli uomini da una parete invalicabile costituita dallo stesso sepolcro: sono loro in realtà i veri morti alla Luce, è la loro sostanza materiale che occupa tutto o spazio visibile ai piedi del sarcofago, come se essi ne fossero i veri occupanti, o come, addirittura, se la loro pesante materialità desse consistenza al sepolcro, che disegna il confine tra l’umano e il divino... E’ proprio questa materialità in primo piano che l’osservatore deve superare, oltrepassando l’intrico pungente delle gambe dei dormienti, il corpo possente dei due soldati seduti (uno armato e l’altro, immagine dello stesso autore, quasi apparentemente nudo, massiccio ma inerme), per poter accedere alla Luce, alla sacralità data dal Cristo. Pare addirittura che il ginocchio del soldato sdraiato sulla destra indichi la direzione, come una freccia vestita di ali di drago, quel drago che da sempre è rappresentato come custode delle energie profonde della Terra che aspirano a riunirsi a quelle celesti.
Il tema del sonno perciò appare qui non come un momento di riposo, di ricarica o rigenerazione, ma siamo davanti ad un sonno inteso come intorpidimento dei sensi e della mente, che impedisce di vedere e di capire, di conoscere, di aprire gli occhi e il cuore alla verità e alla luce. E’ un sonno che equivale ad una morte, una morte dalla quale proprio il Cristo, con il suo risorgere, invita a risvegliarsi, a sollevare il velo che sotto forma di palpebre abbassate oscura la loro visione: anche gli uomini, se volessero, potrebbero ritrovare in loro stessi la matrice divina.I colori dei loro abiti sono gli stessi che ritroviamo nella “Madonna del Parto”, i colori dei quattro elementi della Terra, i colori anche dell’energia della Terra... ma non c’è qui la stessa armonia, quella perfetta alternanza e simmetria che trasmette il movimento della vita: qui essi sono più confusi, quasi disordinati,
esistono in embrione, ma non riescono a trovare un loro ordine, mancano della consapevolezza data dalla conoscenza...
Eppure è per questi esseri umani senza luce che il Cristo è morto ed è risorto, è sopra la loro miseria umana che si eleva l’umanità divina di Gesù.La sua figura, perfettamente centrata, domina tutta la scena, dividendola in due parti. Il corpo pare dipinto di luce e l’aureola ellittica sopra la sua testa rappresenta il Sole; è il Cristo l’asse intorno al quale ruotano le stagioni e il ciclo stesso della vita.Alla destra l’Est, il chiarore rosato dell’aurora, che porta la Luce al mondo, ed esso risponde, in un rigoglio di piante verdi, dai giovani fusti che si protendono verso il cielo. Anche la collina è viva, non solo per il paesaggio: il rilievo è dolce e morbido, sinuoso come un grembo femminile, sottolineato da una concava linea che pare quasi uno spicchio di luna crescente; vi si accenna all’ingresso di una grotta, luogo di incubazione e rinascita che richiama il ventre materno, ma vi compare anche l’opera dell’uomo, in quel castello turrito che si dice raffiguri il luogo in cui Piero si rifugiò per sfuggire alla peste, un luogo quindi di guarigione, un luogo per lui salvifico...Per contro, sulla sinistra, individuiamo l’ovest, per gli antichi la regione delle cose finite, del tramonto, della morte... Ed è infatti la morte che domina in quella parte del dipinto: gli alberi sono spogli, il paesaggio brullo, sullo sfondo una collina conica, aspra ed irta, richiama, nella sua forma maschile e vulcanica, l’ingresso del mondo infero... Gesù ha infatti la gamba destra ancora dentro l’urna mortale, a testimoniare la propria discesa nel regno dei defunti, ma vi pianta anche il suo vessillo, a dichiarare su di esso la sua vittoria! ... Ecco perché lo sguardo punta glorioso a sud, verso il sole alla sua massima espressione vitale! Un sole che Gesù può fissare senza timore, ma anche senza spavalderia, con consapevole compostezza, perché è la sua stessa divinità quella con cui si sta confrontando!
Osservando questo dipinto, mi accorgo anche, però, di come l’arte di Piero della Francesca fosse completamente intrisa della tradizione etrusca della sua terra d’origine, in quella cosmogonia che trasuda dai paesaggi, dalla composizione dell’opera, dalla posa dei personaggi, dalle scelte cromatiche, ... quasi che il pittore si fosse identificato in un antico aruspice;... quasi che Piero traesse le sue immagini dalle terrecotte dissepolte dei suoi avi; ... quasi che egli specchiasse la sua arte in un prezioso specchio sacro;
... quasi che la ritualità di miti arcaici riemergesse dal suo pennello, da quella trama di colori che tanto richiamano i paesaggi della Valtiberina nell’avvicendarsi delle stagioni... E’ come se Tages in persona riapparisse improvvisamente sollevandosi dai fertili solchi, uscendo dalle viscere del misterioso mondo ctonio che genera e regola i cicli della vita, per riportare al mondo umano la nuova Luce della Verità...
Questo specchio è esposto al Museo Archeologico di Firenze.L’immagine graffita rappresenta Tages, o Tagete, la divinità che, secondo la tradizione mitologica, rivelò al popolo etrusco l’arte dell’aruspicina. Esso è equiparabile, nella mitologia greca ad Hermes Ctonio.
Cicerone narra che il dio, sotto le sembianze di un bambino, anche se con i tratti e la saggezza di un vecchio, comparve improvvisamente al contadino Tarconte, uscendo dalle profonde zolle del campo che l’uomo stava arando nei pressi di Tarquinia. L’indiscussa saggezza dimostrata dal fanciullo richiamò una folla da tutta l’Etruria e si dice che proprio grazie ai suoi insegnamenti nacque la civiltà presso gli Etruschi, civiltà fondata soprattutto su un profondo senso del sacro, sulla conoscenza dei rituali cerimoniali e sulle tecniche divinatorie, legate alla lettura delle viscere animali, del volo degli uccelli, dei fulmini e perfino dei terremoti. Secondo alcuni antichi scrittori romani, Tages trasmise i suoi insegnamenti attraverso il canto, confermando così il valore sacro della musica per gli Etruschi. Musica come forza creatrice, di cui oggi abbiamo perso il senso...Gli insegnamenti segreti del dio furono raccolti dai dodici principi o lucumoni delle più importanti città dell’Etruria (le dodici città confederate nella Lega Etrusca), poi, improvvisamente come era comparso, il giovanetto scomparve per sempre. Il nome Tages pare significhi “tirato fuori dalla terra”, ma sulla Terra egli dimostra il suo dominio, che insegna al suo popolo. E gli Etruschi se ne faranno fedeli custodi ed esecutori, mettendo la loro sapienza sacerdotale al servizio degli altri popoli, anche dei potenti Romani, senza però rivelarne i segreti, che tuttora possiamo solo intuire...Ecco che troviamo, nelle immagini del dio e dei suoi sacerdoti nell’atto di svolgere l’atto divinatorio, quel piede sinistro poggiato su di una pietra, a dimostrazione della conoscenza che permette loro di esercitare il proprio potere sulla materia grazie all’intervento divino. L’Aruspice è quindi l’intermediario fra l’uomo e la divinità, con la quale è possibile entrare in contatto prestando attenzione e interpretandone i segni celesti intorno a noi.Ma da quella pietra il sacerdote trae anche l’energia della Terra, energia che gli dà potere e che egli solo sa interpretare, ma che a sua volta trasmette al mondo con i suoi consigli...
Sono evidenti i punti in comune con la resurrezione del dipinto, dove abbiamo il dio fra gli uomini (quelli dello specchio però hanno gli occhi ben aperti!) che, con il piede sinistro sulla pietra del sepolcro, esprime il suo dominio sulla materia e sulla morte, il rinnovarsi traendo nuova linfa proprio da quella pietra che aveva accolto il suo corpo inanime. Anch’egli è uscito dalla terra, nascendo simbolicamente in una grotta, ha ricevuto l’omaggio di re maghi ed ha trasmesso le sue conoscenze ai dodici apostoli (pare che tra i discepoli di Tages vi fosse anche una figura femminile, che possiamo individuare nella Maddalena della tradizione cristiana).
Lo stesso bastone nella destra del Cristo richiama il lituo etrusco, insegna del ruolo sacerdotale di intermediario con il cielo, che l’Aruspice teneva nella mano ad indicare il luogo sacro, il templum caeleste, che corrispondeva ad un ampio spazio aperto e non ad un edificio (anche se le due colonne ai lati del dipinto ricordano proprio l’ingresso in un tempio).Pare che anche la croce, sul vessillo di Gesù, vada ad indicare i punti cardinali attraverso un cardo e un decumano, entro cui si svolge il mistero della resurrezione... e il rosso delle linee, tanto simile al colore del sangue sul costato, individuato nel dipinto nel punto del fegato, simbolo etrusco di forza e vitalità, ma anche di divinazione, di incontro con il dio. Il fegato utilizzato per interpretare segni divini proveniva solitamente da un agnello sacrificale ed è così che viene definito anche il Cristo immolato sulla croce. Il sangue del Figlio di Dio è la testimonianza di quel sacrificio che ha riportato l’amicizia di Dio agli uomini. Il Cristo diventa l’elemento unificatore dell’Universo: l’uomo che si era scostato dalla matrice divina, spirituale, facendosi materia (è forse questo il peccato originale?), viene perdonato da Dio nel momento in cui Gesù dimostra che dalla decomposizione della materia si può risorgere, che non vi è discontinuità tra la vita e la morte, che il soffio vitale che pervade ogni cosa è regolato da leggi e ritmi che l’uomo ha da sempre sotto gli occhi, ma che solo pochi riescono a penetrare e comprendere...L’uso cerimoniale dello specchio ci riporta così anche al tema del vedere: attraverso lo specchio si ha una proiezione, una visione indiretta della realtà: si può vedere infatti oltre la propria visuale, anche ciò che sta dietro, inteso forse come un cogliere i significati nascosti del mondo circostante, che solo la presenza di luce può attivare... è quasi il mito della caverna, la cui allegoria si ripropone agli uomini per incoraggiarli a saper distinguere la vera luce oltre le ombre...Bruna Rossi