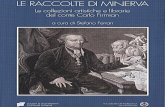Uno stato feudale nella Calabria del Cinquecento. La platea di Giovanni Battista Carafa, marchese di...
Transcript of Uno stato feudale nella Calabria del Cinquecento. La platea di Giovanni Battista Carafa, marchese di...
III
VINCENZO NAYMO
Uno stato feudalenella Calabria del Cinquecento
La Platea di Giovanni Battista CarafaMarchese di Castelvetere
e Conte di Grotteria
Corab
V
Indice generale
PARTE PRIMA:
Premessa VII
Introduzione IX
I. Nascita ed espansione dello stato Carafa X
II. Dall’espansione alla crisi: Giovanni Battista Carafa XII
III. La redazione della platea XVIII
IV. I feudi e le terre dei vassalli XXII
V. Le concessioni enfiteutiche XXXVIII
VI. I diritti e le proprietà feudali LI
VII. I privilegi LXXXIX
VIII. I confini dello stato XCII
IX. La chiusura della platea CIII
X. Conclusioni CVIII
XI Criteri di edizione del testo CXIV
Illustrazioni CXV
Bibliografia CXXIII
PARTE SECONDA:
Descrizione diplomatica del documento 3
Annotazioni sulla copertina pergamenacea della platea 5
Testo della platea 7
Indice toponomastico 503
Indice onomastico 527
VII
Nonostante i progressi più recenti nel campo dell’indagine storica, le fonti per lastoria calabrese ed in genere quelle per l’intero Regno di Napoli, sono ancora oggi pococonosciute e studiate così che taluni orientamenti ritenuti ancora attendibili, specie perl’età moderna, sono stati ereditati quasi acriticamente dalla trionfante storiografia postunitaria di chiaro stampo risorgimentale, il cui reale interesse a conoscere a fondo l’orga-nizzazione e le vicende di un Regno cancellato e spogliato - occorre ammetterlo - oggiappare decisamente poco credibile.
Queste riflessioni hanno reso evidente, ed ai miei occhi pressante, la necessità el’opportunità di incrementare l’opera di studio ed edizione di fonti storiche sul feudalesimoper la Calabria al fine di fornire i lettori e in particolare gli studiosi di un mezzo per laconoscenza del passato ed allo stesso tempo di una fonte attendibile su cui organizzare ivari giudizi.
L’occasione di poter concretizzare tali intenti mi si è presentata grazie allo studioe alle ricerche che ormai da numerosi anni conduco nell’Archivio Carafa di Roccella,allorquando mi sono imbattuto in una monumentale platea cinquecentesca dello statofeudale calabrese della potente famiglia napoletana. Sfogliando per la prima volta quellepagine non impiegai molto a realizzare che si trattava di un manoscritto per certi versiunico nel suo genere in Calabria, per le dimensioni del testo (circa un milione di battute),per l’alta datazione (1534) ma soprattutto per la straordinaria varietà e capillarità delcontenuto; una fonte la cui portata consentiva realmente la conoscenza e lo studio appro-fondito dell’economia e del territorio di uno fra i più importanti ed estesi stati feudalicalabresi durante la prima metà del XVI secolo. Il confronto più stretto di questo docu-mento è possibile con la platea dei beni del monastero di S. Stefano del Bosco1, fonte dallestesse potenzialità ed importanza di quella Carafa, ma ben nota e adoperata dagli studio-si da numerosi decenni al contrario della nostra, di fatto fino ad oggi completamenteignorata.
Il presente volume contiene l’edizione integrale del testo originale in lingua latinadella platea del Marchesato di Castelvetere e della Contea di Grotteria, redatta ai tempidel marchese Giovanni Battista Carafa. L’edizione è preceduta da un commentointroduttivo il cui scopo è quello di presentare il manoscritto, di descriverne la genesi, lecaratteristiche formali e contenutistiche e, soprattuttto, di condurre una analisi critica
1 Il testo di questa platea è stato di recente edito integralmente a cura di P. De Leo, cfr. La platea di SS.Stefano del Bosco, Soveria Mannelli 1998.
VIII
del testo. È necessario avvertire, tuttavia, che tale commento non ha alcuna pretesa diesaustività, giacché la platea offre così tanti filoni di ricerca che affrontarli in questa sedesarebbe stato assolutamente improponibile: ciò avrebbe dilatato a dismisura un volumefin troppo ampio. Chi scrive, tuttavia, ha già in corso di stampa una nuova edizione dellaplatea, corredata di un commento approfondito del manoscritto, che, analizzando fino infondo il suo contenuto attraverso un confronto sistematico con altre realtà feudali calabresie del Regno di Napoli, si è posto l’obiettivo di valutare fino in fondo il ruolo del sistemafeudale nell’economia e nella società meridionale del secolo XVI.
La presente edizione è corredata di un indice analitico (toponomastico e onomasti-co) dell’intero testo della platea, un mezzo essenziale per una rapida ricerca di nomi ecose notevoli nonché di una carta topografica dello stato Carafa, così come si presentavadurante la prima metà del XVI secolo, ricostruito su una cartografia I.G.M. a scala1:50.000, sulla quale sono stati segnati i confini esterni ed interni, i suffeudi, i complessiindustriali ed agricoli, taluni luoghi di culto, la ricostruzione della rete viaria antica emedievale, la toponomastica del tempo ed altre cose notevoli.
Nel concludere questa breve nota introduttiva voglio esprimere i miei ringrazia-menti al prof. Angelo Sindoni, mio maestro, per i preziosi suggerimenti nella redazionedel presente lavoro, a Gustavo Cannizzaro per alcune informazioni sul territorio diCastelvetere, a Domenico Romeo per quelle su Siderno e a Vincenzo de Nittis per averpartecipato ad alcune delle ricognizioni topografiche.
Gioiosa Jonica, 28 aprile 2004
V. N.
IX
Le fonti documentarie sul feudalesimo in Calabria sono tutt’altro che consistenti.L’incuria degli uomini e gli eventi naturali sono fra le cause principali della mancata oparziale conservazione di documenti fondamentali per lo studio e la ricostruzione dellevicende di storia feudale della regione. Se per epoche relativamente prossime alla nostra,quali il Settecento ed i primi anni dell’Ottocento, il materiale tramandatoci ha una certaconsistenza ed organicità, per secoli più remoti le notizie si fanno sempre più frammentarieed insufficienti2. Il Cinquecento può essere considerato al riguardo un secolo cesura per-ché se per la fine dello stesso è possibile rinvenire una qualche documentazione, per iprimi anni i documenti diventano assai rari e, in taluni casi, inesistenti. Giova ricordareche tale situazione è stata originata dalla dispersione di gran parte degli antichi archividelle corti e dei castelli, divenuti, salvo rare eccezioni, proprietà di privati3. Fortunata-mente non tutto è andato perduto: i fondi degli antichi tribunali competenti sui feudi,almeno dal Cinquecento in poi, sono pervenuti intatti, sebbene non sempre corretta-mente ordinati. Ciò nonostante, il rinvenimento di una documentazione completa ed or-ganica per un feudo calabrese risalente alla prima metà del Cinquecento rimane sempreun caso abbastanza raro e per certi versi unico.
Fra le carte dell’Archivio Carafa di Roccella4, al cui studio attendo ormai da numerosianni, si ritrova un grosso volume5 pergamenaceo rilegato di 237 cc. manoscritte per un totaledi 474 facciate. Il volume, che per supporto scrittorio, dimensioni e rilegatura assomiglia adun codice medievale, contiene il testo di una grande platea generale dello stato calabrese deiCarafa redatta nell’anno 1534 per volere di Carlo V su richiesta del feudatario Giovanni Bat-tista Carafa († 1552), marchese di Castelvetere e conte di Grotteria.
Va precisato subito che si tratta di un documento pressoché sconosciuto6, di raraimportanza per la storia del feudalesimo calabrese ed in particolare per quella di un vasto
2 Va ricordato che per il periodo anteriore al Seicento o al tardo Cinquecento tace anche la stragrandemaggioranza delle fonti notarili, spesso in grado di far luce indirettamente su vicende di natura feudale.
3 Occorre rilevare, non senza disappunto, che la stragrande maggioranza del materiale documentarioconservato da tali archivi è andato disperso soltanto durante il XX secolo.
4 Il fondo si ritrova versato presso l’Archivio di Stato di Napoli, nella sezione Archivi privati.5 Cfr. Archivio di Stato di Napoli (= A.S.N.), Carafa di Roccella, b. 31, n. 1.6 Soltanto il Cingari in un suo studio su Roccella Jonica segnala la redazione di una platea Carafa stilata
dal notaio Jacopo Cannata da Terranova, certamente identificabile con il nostro documento. Lo studioso, tuttavia,dopo la vana ricerca dei protocolli del citato notaio, aveva dato definitivamente per disperso tale documento, cfr.G. CINGARI, Profilo storico di Roccella nell’Età Moderna, Campo Calabro 1980, inedito di cui circolano copie inciclostile, p. 120, nota 8.
X
stato dell’antica Calabria Ulteriore. Questa immensa platea, infatti, contiene una descri-zione capillare, quasi fotografica, dello stato Carafa durante la prima metà del Cinque-cento. Il testo pullula di elenchi di proprietà del feudatario, di riferimenti toponomastici eonomastici, di beni immobili quali palazzi, castelli, mulini, ecc., di liste di enfiteuti (reddentes)e dei loro rispettivi beni, di notizie di carattere economico, di importanti elementi sullaviabilità, di notizie sulle foreste, sui monti, sui fiumi, sui luoghi di culto, sui confini con ifeudi limitrofi, sui costumi e le usanze del tempo, su alcune abitudini dei vassalli; insom-ma una straordinaria messe di dati che consente lo sviluppo di qualsiasi indirizzo diricerca e che, a mio parere, giustifica ampiamente l’edizione integrale del testo.
Prima di descriverne la genesi e di procedere al commento della platea mi sembraopportuno premettere alcune brevi notizie sulla formazione e l’espansione dello statoCarafa al fine di inquadrare la redazione della medesima nel più ampio contesto dellevicende storiche e feudali della potente famiglia napoletana.
I. Nascita ed espansione dello stato Carafa
Nell’anno 1479 il re Ferrante I d’Aragona assegnò i feudi di Castelvetere e Roccella,nella Calabria Ulteriore, al patrizio napoletano e Regio Consigliere Iacopo Carafa († 1489)7,gettando le basi di quello che in breve tempo sarebbe divenuto uno fra i più ampi statifeudali della regione. La volontà di ricompensare il Carafa ed il suo giovane figlio Vincen-zo dei numerosi servigi resi in armi in difesa della corona aragonese8 fu prevalente ri-spetto alle precedenti promesse del re di mantenere demaniali le due terre calabresi.Ritenuto da alcuni un personaggio dalla condotta dispotica - fama legata probabilmenteall’ostilità dei cittadini di Castelvetere e Roccella contrari all’infeudazione e comunquenon abituati alla presenza di un signore residente nello stato - Iacopo Carafa mantenne ilpossesso dei feudi fino alla morte, avvenuta nel 1489.
La sua denuncia da parte dei vassalli per le prepotenze ed i furti ad essi perpetratie l’ottenuta concessione sovrana della demanialità per Castelvetere e Roccella (1490)9, seda un lato ritardarono la successione del figlio Vincenzo (1496-1526) nei feudi paterni,
7 Sulla famiglia Carafa cfr. B. ALDIMARI, Historia Genealogica della famiglia Carafa, Napoli 1691; per lasuccessione feudale dello stato Carafa cfr. M. PELLICANO CASTAGNA, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari dellaCalabria, Catanzaro 1996, Vol. II, Cas-Is, successione feudale di Castelvetere, p. 40. Va precisato che il feudo sitrovava incamerato dal Regio Fisco a causa di precedenti vicissitudini feudali, ibidem, pp. 39-40.
8 Il Carafa aveva seguito il re nella guerra contro Giovanni d’Angiò ed i baroni ribelli capeggiati dalmarchese di Cotrone Antonio Centelles. Ebbe modo di comandare in Calabria un notevole contingente militarelasciato nella regione dal re fin dal 1459; si era distinto particolarmente nell’assedio di Vasto in Abruzzo e nellacattura del potente conte di Trivento Antonio Caldora, cfr. G. CINGARI, Profilo storico..., cit., p. 25; R. FUDA,Formazione e immagine di uno stato feudale, Gioiosa Jonica 1995, p. 8.
9 Sull’argomento cfr. D. ZANGARI, Capitoli e grazie concessi dal re Ferdinando I d’Aragona all’università diCastelvetere, «Rivista Critica di Cultura Calabrese», II (1922), fasc. III, pp. 7-15.
XI
dall’altro avevano favorito, nel 1489, l’assegnazione formale a quest’ultimo della baroniadi Grotteria, da conseguire di fatto dopo la morte improle del conte di Terranova Mari-no Correale.
La netta posizione filo aragonese assunta da Vincenzo Carafa durante il travagliatoperiodo che sconvolse l’assetto politico del Regno dopo la morte di Ferrante I (†1494) fuoggetto di profonda riconoscenza da parte dei successori del defunto monarca del qualeil Carafa era stato prediletto. Ciò influì in misura determinante nella conferma10 e succes-siva immissione in possesso di Castelvetere e Roccella da parte di re Federico avvenutamanu militari sul finire del 1496 a causa del tenace rifiuto degli abitanti delle due terre disottomettersi all’autorità del nuovo signore11.
Quando, fra Quattro e Cinquecento, si spense il conte di Terranova Marino Correale(†1499 o 1501), Vincenzo Carafa entrò di fatto in possesso dell’intera baronia di Grotteria,la cui titolarità gli era stata nel frattempo confermata da re Federico durante il 149612.Fu allora che l’unione della grande baronia grotterese ai nuclei originali di Castelveteree Roccella diede vita ad uno fra i più vasti stati feudali del tempo.
Agli inizi del XVI secolo, infatti, lo stato Carafa raggiungeva una superficie com-plessiva di 494,4 kmq13. Questo territorio includeva al suo interno quattro feudi in capi-te curiae14, nove centri abitati (quattro terre e cinque casali), estendendosi fra i fiumiPrecariti e Novito, fra il Mar Jonio e le Serre e comprendendo le grandi vallate dei fiumiTorbido ed Allaro.
Gli anni di dominio di Vincenzo Carafa segnarono un’epoca di relativa crescitaeconomica nello stato nonostante l’instabilità del quadro politico generale. In questo pro-gresso l’azione esercitata dal feudatario, uomo pio, moderato e da tutti ritenuto un buoncristiano, fu spesso determinante.
Nel periodo compreso fra il 1513 ed il 1519, egli curò a proprie spese un radi-cale restauro della chiesa Matrice di Castelvetere sotto il titolo S. Maria Assuntadetta «la Cattolica», nel tempo in cui era protopapa della medesima l’abate Berardinode Viterbo15.
10 L’atto di conferma porta la data del 9 ottobre 1496 ed un suo regesto fu trascritto nella platea edita nelpresente volume, cfr. platea, f. 106r e v.
11 L’ordine perentorio del re rivolto al cardinale Alfonso d’Aragona fu eseguito immediatamente e sem-bra avesse sortito ben presto l’effetto desiderato, cfr. lettera di re Federico diretta al cardinale Alfonso d’Aragonadel 4 dicembre 1496 in B. ALDIMARI, Historia genealogica..., cit., p. 251.
12 Cfr. M. PELLICANO CASTAGNA, La storia dei feudi..., cit., successione feudale di Grotteria, p. 335. Sull’annodi morte di Marino Correale non vi è accordo fra gli studiosi. La questione, che si rifà rispettivamente a quantoscritto dall’Ammirato, che propone la data del 4 aprile 1501, e dal Volpicella che indica invece il 1499, è stata direcente riassunta esaustivamente da R. Fuda in Formazione e immagine..., cit., p. 11, n. 31.
13 La contea di Grotteria si estendeva per 239 kmq; la baronia di Castelvetere, con annesso il feudo diRoccella, raggiungeva i 255,4 kmq.
14 Cioè la contea di Grotteria con i casali di Sideroni, Mammola, San Giovanni, Martone ed Agnana ; e lebaronie di Castelvetere, Roccella e Motta Gioiosa.
15 Ho avuto modo di consultare un interessante fascio di documenti sul restauro di tale chiesa; al riguardocfr. A.S.N., Carafa di Roccella, b. 36, sez. 3, nn. 1 e sgg., aa. 1513 e 1519.
XII
Nell’anno 1514 furono emanate dal Carafa importanti pandette16, leggi che, rego-lando per iscritto i rapporti fra il potere feudale e le varie università, sancivano il ricono-scimento ufficiale da parte del feudatario di numerosi diritti che garantivano alle univer-sità l’autonomia necessaria per una accettabile amministrazione delle città.
In quegli anni fu ripresa l’attività delle ferriere17, edificati nuovi fondaci, incre-mentata in misura considerevole la produzione di seta ed il commercio al di fuori dellostato. In linea con la tendenza del secolo si registrò un notevole incremento demograficoche portò in cinquant’anni quasi al raddoppio della popolazione18.
La politica del conte, improntata al miglioramento dell’economia locale, si rese evi-dente anche nella concessione in enfiteusi di considerevoli estensioni di proprietà fondiariafeudale a decine di cittadini dello stato. Questo tipo di patto, infatti, permetteva aibeneficiari in grado di sfruttarlo rapide scalate sociali, perché garantiva loro l’opportu-nità di usufruire di gran parte della rendita di vasti appezzamenti di terreno che nonavrebbero mai potuto acquistare direttamente a causa dell’alto prezzo dei medesimi. Fucosì che massari e mastri, cittadini e nobili di Castelvetere, Roccella, Grotteria, MottaGioiosa, Sideroni, Mammola, ecc. si trovarono in possesso, documenti alla mano, di unaparte considerevole di beni feudali al cui sfruttamento il feudatario non poteva attenderedirettamente.
L’azione del conte contribuì in misura considerevole ad attenuare, e probabilmen-te a far svanire del tutto, l’iniziale opposizione al suo dominio da parte di Castelvetere eRoccella, due fra le più importanti terre dello stato.
Vincenzo Carafa si spense durante il 1526; quando nel settembre 1528 Giovanni Bat-tista Carafa, figlio del defunto conte, fu ufficialmente investito dei feudi paterni, lo stato carafescostava attraversando un periodo di relativa stabilità e progresso.
II. Dall’espansione alla crisi: Giovanni Battista Carafa
Sul dominio di Giovanni Battista Carafa vi è un’alternanza di luci e di ombre sullequali risulta non facile fare chiarezza. I primi anni di governo del giovane feudatariofurono caratterizzati da una coraggiosa politica di sostegno economico e militare alleimprese dell’imperatore Carlo V. In occasione dell’invasione del Lautrec il Carafa arruolòa proprie spese un nutrito contingente militare, alla cui testa pose il cognato LorenzoSiscar19 e la cui condotta ebbe un ruolo determinante sull’esito della guerra. Alcuni anni
16 Alcuni brevi estratti dal testo di tali pandette, riguardanti Motta Gioiosa, sono contenuti in un LiberBaptizatorum della chiesa Matrice gioiosana, cfr. Archivio Parrocchiale della Matrice di Gioiosa (A.P.M.), LiberBaptizatorum aa. 1743-1799.
17 La notizia si ritrova nel privilegio di conferma di Grotteria a favore di Vincenzo Carafa dell’anno 1505,cfr. J. MAZZOLENI, Fonti per la storia della Calabria nel Viceregno (1503-1734) esistenti nell’Archivio di Stato di Napoli,Napoli 1968, p. 176.
18 Cfr. G. CINGARI, Profilo storico di Roccella..., cit., pp. 39-44.19 Era consorte di Alfonsina Carafa, sorella di Giovanni Battista, cfr. platea, f. 42r.;. B. ALDIMARI, Historia
Genealogica..., pp. 261-262.
XIII
dopo (1535), in occasione dell’imminente attacco navale spagnolo presso Tunisi, Gio-vanni Battista fece costruire a proprie spese due galere che, successivamente, preseroparte alla spedizione sotto il comando del barone della Scaletta20. In quegli stessi anni ilCarafa seguì personalmente l’imperatore in Provenza arruolando un proprio contingen-te militare21. Si calcola che in breve tempo Giovanni Battista arrivò a spendere per ilsovrano l’iperbolica somma di 59100 ducati22, capitale mai recuperato. Tali meriti gliguadagnarono prima il titolo di marchese di Castelvetere nel 153023, poi quelli piùprestigiosi di cavaliere di San Giacomo e Grande di Spagna di Prima Classe24.
Se da un lato la riconoscenza da parte del sovrano si espresse attraverso l’esclusi-va concessione di titoli onorifici, dall’altro le ingenti ed unilaterali spese del marchesefinirono per gravare non poco sul bilancio dello stato. Le sue iniziative, infatti, compor-tarono un indebitamento per migliaia di ducati, deficit che con il passare degli anni andòrapidamente dilatandosi fino a raggiungere nell’anno 1548 la considerevole somma di20000 ducati25.
Sul fronte interno molteplici aspetti positivi della politica paterna furono fatti proprianche dal marchese. Nell’incremento di fiere e mercati, per esempio, l’azione del Carafaconseguì ottimi risultati: in Grotteria istituì la fiera di San Domenico, la cui sopravvivenzagli fu tanto a cuore da indurlo, per accrescerla, a ridimensionare temporaneamente quelladi Santa Maria delle Grazie sul fiume Torbido26. Nel 1529, egli determinò personalmentel’istituzione del rinomato mercato sabato-domenicale di Motta Gioiosa27. Qui, negli annisuccessivi, diede nuovo impulso alle festività di Santa Maria delle Grazie, istituendo unaseconda fiera annuale della durata di 10 giorni, a partire dalla prima domenica di agosto28.Fra il 1531 ed il 1533 ottenne conferma del diritto di esazione del ferro e dell’acciaio daiporti di Reggio e di Roccella29. Furono gli anni nei quali, grazie all’azione del feudatario, il
20 La notizia in R. FUDA, Formazione e immagine, cit., p. 13 n. 44. L’autore ritiene, sulla scorta di undocumento da me segnalatogli, che almeno una delle due imbarcazioni da guerra sia stata costruita presso lamarina di Motta Gioiosa da cui l’attuale toponimo di Galea.
21 Cfr. B. ALDIMARI, Historia Genealogica..., p. 269.22 La notizia in un documento edito in F. CARACCIOLO, Il feudo di Castelvetere e i crimini del marchese Giovan-
battista Carafa negli anni del governo del viceré Toledo, «Archivio storico per la Calabria e Lucania», XII (1973-74),pp. 55-56.
23 Il privilegio, datato 5 agosto 1530 è edito in B. ALDIMARI, Historia Genealogica..., cit., pp. 262-265.24 Ibidem, p. 269.25 Cfr. F. CARACCIOLO, Il feudo di Castelvetere..., cit., p. 28.26 Sull’argomento cfr. V. NAYMO, Fiere e pretese tributarie nella Calabria del Cinquecento: Santa Maria delle Grazie
in Gioiosa e le dispute con Grotteria (1566-1572), «Incontri mediterranei» n. 0 (1999), pp. 21-72.27 Cfr. D. PRATI, Mocta Sideronis, Siderno 1913, p. 33.28 La fiera istituita dal Carafa, genericamente segnalata dall’Aldimari e dal Fuda in Motta Gioiosa, va a
mio avviso identificata con quella della Madonna delle Grazie della durata di dieci giorni. Quest’ultima non vaconfusa con quella tradizionale che si teneva nella stessa località i primi due giorni di luglio in occasione dellaricorrenza della titolare. Cfr. V. NAYMO, Fiere.., cit., Le fiere della vallata del Torbido nel Cinquecento; B. ALDIMARI,Historia Genealogica..., cit., p. 268; R. FUDA, Formazione e immagine..., cit., p. 13 e nn. 50-51.
29 Cfr. B. ALDIMARI, Historia Genealogica..., cit., p. 270; la notizia anche in C. RUSSO, Dizionario biografico degliitaliani, Roma 1976, vol. XIX, p. 568.
XIV
volume degli scambi commerciali che si svolgevano attraverso il fondaco di Roccella creb-be in modo considerevole30. L’azione di Giovanni Battista Carafa evidenzia la sua nettadeterminazione nell’incrementare la produttività dello stato, sfruttandone oculatamentele risorse. I risultati di tale condotta non tardarono ad arrivare; essi sono testimoniatidall’aumento esponenziale della rendita feudale fra il 1528 ed il 155231.
Anche nel campo dei rapporti con le università la politica del marchese risultò oculata.Nell’anno 1535 fu emanata una nuova pandetta che ricalcando quella del 1514, confermava iprecedenti privilegi delle università32.
Nel settore militare il Carafa curò particolarmente l’apparato difensivo delle sueterre, in relazione non solo alle continue incursioni saracene ma anche al periodo partico-larmente instabile che stava attraversando il Regno in quel tempo: nel 1529 egli ottennela muratura e la costituzione di feudo in capite del casale di Sideroni33; negli stessi annicurò un radicale restauro del castello di Motta Gioiosa inviandovi come capitano a guer-ra il nobile Ferdinando Molignano da Napoli34.
Sulle montagne della contea di Grotteria, nella località chiamata Cardini, egli edifi-cò un magnifico e grande palazzo, sua residenza nei periodi di caccia35.
Neppure nel campo delle opere pie si può affermare che Giovanni Battista siastato meno magnanimo del padre. Fa fede al riguardo la generosa concessione che eglifece intorno al 1532 della grande foresta di Ninfo e Jiyo a favore dei certosini di SantoStefano del Bosco, appositamente distaccata dal territorio di Castelvetere36. I monaci furonocosì riconoscenti verso il Carafa da erigergli una statua con la seguente iscrizione:
30 Cfr. G. CINGARI, Profilo storico di Roccella..., cit., p. 35.31 Ibidem, p. 36.32 Sull’argomento cfr. V. NAYMO, Il castello di Gioiosa in Calabria Ulteriore, Gioiosa Jonica 1996, p. 54.33 Cfr. B. ALDIMARI, Historia genealogica..., cit., p. 268.34 Cfr. V. NAYMO, Il castello di Gioiosa..., cit., pp. 29-31.35 L’esistenza di tale dimora era fino ad oggi ignorata; ho trovato la notizia in un interessante documento
che ho in corso di pubblicazione e di cui riporto qui le parti salienti: «Visto per me il territorio de la terra dellaGroctaria, San J[oanne, Martoni], Mamola et Agnana soi casali per me Jacobo Antonio B[arbaro] una con lomagnifico Joan Francisco Irgidamo et Joan Lore[ntio] Antiquo baglivo in lo presente anno de ditta terra, hotrovato in ipso territorio et in lo loco detto Li Cardini uno edificio fatto per lo comodo della caczia per lo quondamSignor Marchese, consistente in una sala con tavolato seu solaro de tavole coperta ad tecti, con focolaro etciminera, una simile camera, un’altra con lo simile solaro, intempiatura et tecti, con un’altra camera con solaro deastraco, intempiatura et tecto con dormitorie de legname musiate et fasciate, con focolaro et ciminera, con cantunide marmore et edeficio de sette cancellari, stalle et altri membri, con furno. Ditto loco è comodo de acqua et sonoin ipso da quaranta pedi de cerasi, frondi nuce et altri frutti...». Cfr. V. NAYMO, Fonti per la Calabria Ulteriore framedioevo ed età moderna, in corso di pubblicazione.
36 L’atto di donazione fu stipulato in Napoli dal notaio Virgilio de Vublito, cfr. platea, f. 111r e v. Sebbene,come riferisce l’Aldimari rifacendosi allo Zazzera (cfr. B. ALDIMARI, Historia genealogica..., cit. p. 270), tale conces-sione fosse stata successivamente contestata per mancanza di regio assenso, nel 1534 la foresta non fu reintegratama, al contrario, fra le parti risultava raggiunto un accordo circa la concessione ai monaci. Cfr. platea, transazionefra il marchese di Castelvetere Giovanni Battista Carafa ed il monastero di S. Stefano del Bosco per la foresta diNinfo, ff. 109v-112v, 22 agosto 1532.
XV
IOANNES BAPTISTA CARAFAMAGNVS COMES GRVTTERIAE
NOSTER BENEFACTORQUI DEDIT NOBIS NINFVM
ANNO 152337.
Frattanto nell’anno 1525 con privilegio dato in Roma presso San Pietro il 13dicembre papa Clemente VII aveva concesso al Carafa il giuspatronato di alcune chiesedi Castelvetere38. Nel 1532 il marchese vinse la vertenza intrapresa dal padre sul dirittodi presentare il rettore della chiesa Matrice e di quella di S. Marina del Castello diCastelvetere e, in Roccella, per le chiese di S. Maria dei Latini e S. Maria de Pignatellis39.
Nonostante lo stato delle finanze non particolarmente prospero, gli acquisti ope-rati da Giovanni Battista Carafa furono notevoli sia all’interno che all’esterno dei suoifeudi. Nel 1527 acquistò 400 ducati della rendita di Grotteria40. Stessa cosa fece nel1530 per 1194 ducati sulle entrate erariali di Grotteria, Castelvetere e Roccella41.
Sul fronte esterno nell’anno 1533 il marchese acquistava con il patto di retrovenditala terra di Casaldone dal duca di Maddaloni, con atto stipulato in Napoli dal notaio Anto-nio de Luisi42.
All’interno dello stato il marchese si fece promotore di una politica tendente allaformazione di latifondi, anche di natura non feudale, ai danni della piccola proprietà pri-vata cittadina. Il caso dell’area nei pressi del feudo di S. Maria delle Grazie, in territoriodi Motta Gioiosa, risulta emblematico al riguardo. Fra il 1528 ed il 153443, con acquistie permute da cittadini gioiosani e grotteresi, egli formò un grande appezzamento diterreno di quaranta salmate chiamato Lo Feo, da cui il feudo di S. Maria delle Grazie44.
Nel territorio di Motta Gioiosa la concentrazione delle proprietà del marchesedivenne altissima quando nel 1545 egli acquistò in blocco i beni del nobile Simone
37 Cfr. B. ALDIMARI, Historia Genealogica..., cit., p. 269-270. Circa la datazione della concessione ritengoerrato, forse a causa di un refuso di stampa, l’anno 1523 contenuto nell’epigrafe al monumento eretto al Carafa epubblicato dall’Aldimari, che leggerei piuttosto 1532 periodo al quale risale la transazione fra le parti di cui allanota precedente.
38 Le chiese erano S. Maria della Misericordia, S. Nicola e S. Caterina. Ibidem, p. 266.39 Ibidem.40 Ibidem, p. 268.41 Ibidem, p. 270.42 Ibidem.43 In quest’anno il latifondo si trovava già costituito e descritto nella platea edita in questa sede, cfr.
platea, f. 223v, 2 giugno 1534.44 Trascrivo il passo di un antico documento che riporta la notizia: «...Per quanto esso testimonio se
recorda sape et have visto che lo loco nominato Santa Maria de la Gratia seu Lo Feo, quale se dice al presenti,prima, in tempo antiquo erano terre et lochi de homini particulari de la Motta et de la Gruttaria et quilli se lletenevano et possedevano et percepevano li frutti et quilli che erano de li homeni de la Motta respondevano etpagavano li pagamenti a la Motta como lochi che stevano intro le pertinentie de la Motta e suo territorio. Et intempo che viveva lo illustre marchese Ioan Baptista Carrafa de Castelloveteri, Signore de ditta terra de la
XVI
Caracciolo, uno degli ultimi discendenti degli antichi conti di Gerace, abitante nella Mottae fino ad allora proprietario di corpi feudali che avevano costituito l’antico feudo diRagusia45. Fra tali corpi vi erano vastissimi appezzamenti di terreno quali la forestamontana di aglanda detta Sclavo, il giardino di Donatone, quello della Guarnaccia, e tantialtri46.
Nonostante le apparenze la situazione delle finanze del marchese era tutt’altroche rosea. Il deficit creatosi con le spese per sostenere l’imperatore non era mai statocolmato. Gli acquisti, i restauri e la costruzione di nuovi immobili avevano al contrariofavorito l’aumento del disavanzo. Già nel 1540 al marchese apparve chiaro che non erapossibile eliminare i debiti senza alienare, almeno temporaneamente, una parte dello sta-to47. Così in quell’anno il Carafa fu costretto a cedere con il patto della ricompra a Gio-vanni Gagliego i casali di Mammola e Agnana per 7000 ducati48. Tale vendita costituì ilprimo atto dello smembramento della contea di Grotteria e, con esso, dell’avvento delperiodo di più grave crisi nella storia dello stato Carafa in Calabria Ulteriore.
La ferrea politica di riaffermazione di alcuni diritti feudali, di riappropriazionedelle proprietà e di maggiore rigore amministrativo, intrapresa all’interno dello stato apartire dal 1530, finì per diffondere un sordo ma crescente malcontento fra gli abitanti.Abituati al moderato dominio del conte Vincenzo, i vassalli dello stato mal tolleravano lenovità introdotte dal figlio, soprattutto quando queste minacciavano la sopravvivenzadi antiche concessioni e consuetudini cittadine in materia di amministrazione e di impo-ste che, bene o male, erano state fino ad allora rispettate.
Dietro tale malcontento si celerebbero le cause reali della denuncia del marcheseda parte degli abitanti di Castelvetere, tradizionalmente i più ostili alla famiglia Carafa.Tale denuncia, ufficialmente originata dagli abusi, dalle sopraffazioni e dalle violenze aidanni dei vassalli, portò nel 1548 all’arresto di Giovanni Battista Carafa e alla sua reclu-sione in Napoli nelle carceri della Vicaria in attesa di processo49.
Gruttaria et Motta preditta giettò mano et se nde pigliò multi de ditte terre de li particulari et fece lla uno locogrande, quale se dice al presente Lo Feo ed a chi donao dinari ed a chi donao scambio et al presente nce nde sonoancora homini de la Motta che nce le teneno ditti beni como ei messer Palmero Condarcudi et altri in ditto locoditto Santa Maria de la Gratia et pagano lli pagamenti in la Motta como beni intro lle pertinentie et territoriode la Motta ordinari et extraordinari et questo lo sape per quanto se recorda esso testimonio et visto utsupra...». Cfr. V. NAYMO, Fonti..., cit., testimonianza a favore di Gennaro Caracciolo contro Marco AntonioLoffredo nel processo per il confine fra Motta Gioiosa e Grotteria. Motta Gioiosa, novembre 1560.
45 Sull’argomento cfr. V. NAYMO, La platea di Ragusia in Motta Gioiosa, in corso di pubblicazione; per itrascorsi del feudo R. FUDA, Sui feudatari di Ragusia, poi Gioiosa, in Calabria, «Rivista storica calabrese», n.s. XVIII(1997), pp. 101-124.
46 Cfr. V. NAYMO, La platea di Ragusia..., cit., atto di vendita del 23 aprile 1545.47 A dire il vero già nel 1536 il marchese aveva alienato con il patto della ricompra per 5000 ducati la
terra di Motta Sideroni al cosentino Michele Arduino ma negli anni successivi l’aveva riacquistata per poirivenderla al nobile Simone Caracciolo da Motta Gioiosa; cfr. D. M. ROMEO, Le vicende feudali della terra di Sidernonei primi anni del ‘500 e la sua cessione a Pirro de Loffredo, «Historica» n. (1997), pp. 123-124.
48 Cfr. F. CARACCIOLO, Il feudo di Castelvetere..., cit., p. 35.49 Ibidem, p. 27.
XVII
Questo episodio diede il colpo di grazia alle finanze del marchese: per reperire ildenaro necessario alla sua vana difesa egli compromise definitivamente l’integrità dellostato. Nel 1549, alienò di nuovo Siderno, questa volta a Pirro de Loffredo50. L’anno suc-cessivo fu la volta dei casali di Martone e San Giovanni venduti a Ferrante Capano51.
All’epoca dell’arresto i debiti del Carafa ammontavano alla somma di 20.000ducati52, un capitale di grossa entità ma che allora sarebbe stato possibile recuperare.Negli anni successivi il deficit salì vorticosamente fino a raggiungere circa 60.000 ducatinel 1552. Fra coloro che prestarono grosse somme al marchese figuravano il napoletanoGiovanni Vincenzo Crispano (creditore di 12000 ducati) e Marco Antonio Loffredo (di24000). Entrambi si sarebbero rifatti negli anni successivi ai danni di Girolamo Carafafiglio ed erede di Giovanni Battista, il primo ottenendo dal Sacro Regio Consiglio, nel155553, la terra di Motta Gioiosa; il secondo con la messa all’asta ed il successivo acquistodi Grotteria e casali nel 155854.
Interrogato nel febbraio 1552 Giovanni Battista Carafa finì per confessare sottotortura gran parte dei crimini contestatigli55. Giudicato colpevole, il 17 dicembre 1552,alle ore sei, il marchese veniva decapitato dentro le mura della Vicaria56. L’esecuzioneprovocò molto scalpore nel Regno terrorizzando molti baroni.
Gli indubbi meriti nei confronti del sovrano, le intercessioni presso quest’ultimodi parenti ed amici molto influenti, nonché svariati e costosi tentativi di corruzione nonerano stati sufficienti a fare accogliere la richiesta di grazia da lui presentata57.
Il rigore delle autorità nella condanna del marchese apparirebbe di difficile let-tura se non lo si inquadrasse nel contesto politico dell’epoca. Il ventennio di governodel viceré Pietro de Toledo fu caratterizzato da un’azione esemplare di lotta alla tur-bolenza dei baroni del Regno i cui esiti furono assai soddisfacenti. Giovanni BattistaCarafa più che dei suoi gravi crimini, comuni anche ad altri feudatari e, secondo alcu-ni studiosi, volutamente ingranditi58, fu vittima dell’intento di Carlo V di ammonireed impaurire con una condanna esemplare i baroni al fine di limitarne gli abusi. An-che la condotta del marchese apparirebbe incomprensibile se non si considerasse chegran parte dei suoi crimini erano stati commessi prima dell’avvento del Toledo e cioè
50 Ibidem, p. 34.51 La notizia in F. SCANDONE, Carafa di Napoli, in P. LITTA, Famiglie celebri italiane, s. II, Vol. XV, Tav. IV.,
Napoli 1910.52 Cfr. F. CARACCIOLO, Il feudo di Castelvetere..., cit., p. 28.53 Cfr. V. NAYMO, Il castello di Gioiosa..., cit., p. 55.54 Cfr. F. CARACCIOLO, Il feudo di Castelvetere..., cit., p. 35.55 Il testo della confessione è edito dal Caracciolo, ibidem, appendice documentaria, doc. 1, 26 febbraio
1552, pp. 42-54.56 Cfr. Archivio General de Simancas, Estado, leg. 1045, f. 129r.57 Ibidem, leg. 1044, f. 13, a. 1552.58 Il giudizio del Trasselli sulla vicenda è assai emblematico: egli ritiene la confessione del Carafa un
documento da leggere come una novella pornografica, cfr. C. TRASSELLI, Lo Stato di Gerace e Terranova nel Cinque-cento, Reggio Calabria 1979, pp. 20-23.
XVIII
in un’epoca nella quale la monarchia non aveva ancora iniziato l’opera di repressionedell’arbitrio di alcuni baroni59.
L’esecuzione capitale del marchese Giovanni Battista Carafa e gli ingenti debiti dalui contratti, diedero vita negli anni successivi ad un periodo di grave instabilità, duratocirca sette anni, che si concluse, come accennavo in precedenza, con il definitivo smembra-mento della contea grotterese. Occorre avvertire, tuttavia, che questa crisi, così comeanaloghe registrate in quegli anni in altre aree della regione, non fu affatto originata daproblemi di natura economica (la rendita feudale dello stato Carafa, come si è visto, era incontinua crescita) ma generata da ragioni legate ad una errata gestione politico-ammini-strativa. Per i Carafa la partecipazione alle imprese di Carlo V fu causa di gravissimoindebitamento. Il sostegno all’imperatore era costato caro anche ad altre case feudalicalabresi: basterà ricordare le note vicende dei principi di Bisignano, titolari del più grandestato feudale della Calabria del tempo. Fra le principali cause dell’indebitamento cheaveva condotto alla dissoluzione del grande stato dei Sanseverino va annoverata anchela politica di sostegno alle guerre dell’imperatore promossa dal principe Pietro AntonioSanseverino60.
Le nefaste conseguenze di tali vicende si sarebbero avvertite a lungo nello statocarafesco, le cui sorti sarebbero state risollevate soltanto sul finire del secolo grazie al-l’oculato intervento di Fabrizio Carafa, primo principe di Roccella e di sua madre LiviaSpinelli61.
III. La redazione della platea
Come si è visto a partire dal 1528 la politica di Giovanni Battista Carafa all’inter-no dello stato fu caratterizzata dalla spinta al recupero di almeno una parte dei numerosibeni feudali che il suo predecessore aveva largamente concesso a molti cittadini. Questadeterminazione, alimentata anche dalla necessità di bilanciare lo sforzo economico soste-nuto a favore dell’imperatore, si inseriva e trovava giustificazione nel contesto più ampiodella repressione di un fenomeno che aveva caratterizzato gli anni precedenti, la cui pe-ricolosità non era sfuggita al marchese di Castelvetere. Le sue continue assenze in occa-sione delle spedizioni militari e le instabili vicende del regno durante gli anni venti delsecolo, infatti, avevano favorito l’insorgere nello stato di una sorta di anarchia fiscale,aggravata dal dilagare dei casi di indebita appropriazione di proprietà feudale delle cortida parte di molti vassalli dei rispettivi centri61. Spesso tali usurpazioni venivano spaccia-te per antiche concessioni emesse su disposizione del conte padre Vincenzo o della con-
59 Si leggano le considerazioni del Caracciolo al riguardo, cfr. F. CARACCIOLO, Il feudo di Castelvetere..., cit., pp.33-34.
60 Si consideri per esempio la crisi che colpì e mandò in rovina il grande stato di Bisignano, cfr. G. GALASSO,Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli 1967, pp. 10-11.
61 Cfr. G. CINGARI, Profilo storico di Roccella..., cit., p. 37.
3
VINCENZO NAYMO
Uno stato feudalenella Calabria del Cinquecento
la Platea di Giovanni Battista CarafaMarchese di Castelvetere
e conte di Grotteria
Agnana - Caulonia - Fabrizia - Gioiosa Jonica - GrotteriaMammola - Martone - Mongiana - Nardodipace
Roccella Jonica - San Giovanni di Gerace - Siderno
Tomo II
Corab
PLATEA GENERALE DELLO STATO CARAFA
MARCHESATO DI CASTELVETERE E FEUDO DI ROCCELLA
CONTEA DI GROTTERIA E FEUDI DI MOTTA GIOIOSA E MOTTA SIDERONI
Originale: Napoli, Archivio di Stato, Carafa di Roccella, cas. 31, n. 1, volumepergamenaceo di 237 cc. manoscritte.
Scrittura: corsiva notarile cinquecentesca; accettabile grado di calligraficità edeleganza estetica; maiuscola decorativa ai capoversi; separazione fra le paroleben marcata; interlinea costante di mm. 8; abbondante uso di abbreviature siaper troncamento che per contrazione.
Nel testo ricorrono cinque mani di scrittura: quella del notaio estensoreIacopo Cannata; quella di un anonimo e poco colto scrivano limitatamente allesole cc. 18, 25 e 32; quella del giudice annuale Filippo de Idario che si sottoscri-ve sui ff. 117r e 237r; ed infine quelle di due testimoni Giovanni AntonioCorsaro (ff. 117r e 237r) e Giovanni Battista Colonna (f. 237r).
Il volume pergamenaceo, che appare di ottima fattura, misura mm. 247 x182 (225 x 147). Il supporto scrittorio presenta un’erosione al centro del margi-ne destro che lo ha reso mutilo soprattutto nelle cc. centrali del volume dove laprofondità raggiunge i 10 mm. La superficie scrittoria appare generalmenteliscia e ben levigata. L’inchiostro, di colore bruno, presenta una buona tenutafatta eccezione per alcune cc. nella parte centrale del volume dove il testo sipresenta sbiadito ma di non complessa decifrazione. La legatura è ancora quellaoriginale, sebbene nella parte centrale del volume stia venendo meno.
Fra le cc. 108 e 109 si ritrova un inserto cartaceo di 10 cc. contenente lacopia autentica di una donazione del principe di Roccella Carlo Maria CarafaBranciforte a beneficio del monastero di S. Stefano del Bosco data in Mazzarinoil 21 luglio 1694 (ff. 1r-2r); ed un atto di accordo fra i medesimi rogato in S.Stefano del Bosco il 2 giugno 1694 dal notaio Antonio Longo da Grotteria (ff.3r-10r)1. Lungo il testo, sporadicamente, si ritrovano sottolineature e brevi glossedi età successiva.
1 Tali atti saranno pubblicati in appendice nella prossima edizione.
4
© 2001Edizioni CorabGioiosa Jonica
Proprietà letteraria riservataRitratto di Giovanni Battista Carafa in una incisione del XVII secolo
edita nel volume di B. Aldimari “Historia genealogica della famiglia Carafa”
5
PLATEA GENERALE DELLO STATO CARAFA
MARCHESATO DI CASTELVETERE E FEUDO DI ROCCELLA
CONTEA DI GROTTERIA E FEUDI DI MOTTA GIOIOSA E MOTTA SIDERONI
Originale: Napoli, Archivio di Stato, Carafa di Roccella, cas. 31, n. 1, volumepergamenaceo di 237 cc. manoscritte.
Scrittura: corsiva notarile cinquecentesca; accettabile grado di calligraficità edeleganza estetica; maiuscola decorativa ai capoversi; separazione fra le parole benmarcata; interlinea costante di mm. 8; abbondante uso di abbreviature sia pertroncamento che per contrazione.
Nel testo ricorrono cinque mani di scrittura: quella del notaio estensore IacopoCannata; quella di un anonimo e poco colto scrivano limitatamente alle sole cc.18, 25 e 32; quella del giudice annuale Filippo de Idario che si sottoscrive sui ff.117r e 237r ; ed infine quelle di due testimoni letterati Giovanni Antonio Corsaro(ff. 117r e 237r) e Giovanni Battista Colonna (f. 237r).
Il volume pergamenaceo, che appare di ottima fattura, misura mm. 247 x182 (225 x 147). Il supporto scrittorio presenta un’erosione al centro del margi-ne destro che lo ha reso mutilo soprattutto nelle cc. centrali del volume dove laprofondità raggiunge i 10 mm. La superficie scrittoria appare generalmenteliscia e ben levigata. L’inchiostro, di colore bruno, presenta una buona tenutafatta eccezione per alcune cc. nella parte centrale del volume dove il testo si pre-senta sbiadito ma di non complessa decifrazione. La legatura è ancora quellaoriginale, sebbene nella parte centrale del volume stia venendo meno.
Fra le cc. 108 e 109 si ritrova un inserto cartaceo di 10 cc. contenente lacopia autentica di una donazione del principe di Roccella Carlo Maria CarafaBranciforte a beneficio del monastero di S. Stefano del Bosco data in Mazzarinoil 21 luglio 1694 (ff. 1r-2r); ed un atto di accordo fra i medesimi rogato in S.Stefano del Bosco il 2 giugno 1694 dal notaio Antonio Longo da Grotteria (ff.3r-10r)1. Lungo il testo, sporadicamente, si ritrovano sottolineature e brevi glossedi età successiva.
1 Tali atti sono editi in appendice, cfr. tomo I.
Annotazioni sulla copertina pergamenacea della platea
La Signora donna Sabella Carrafa [na]cque alli vintisei di marso, ad oretre di notte, di Giovedì Santo nell’anno 1561.
Allo tre di febraio nell’anno 1564, ............... bona e felice nacque la Signo-ra Lucretia a li dicessetti ..... di Dominica
Locatori, folio 103. Nota di robbe burgensatici folio 234 a tergo.Iacobella Garzia per li terri a San Nicola a Mari, oggi di don Giuseppe
Lucano, 1779.A folio 91 si vede il ius di scannagio. A folio .....gio di Roccella.................................................................... folio 234 || (1v).A dì quattro di marzo mille cenquecento ottanta due, cioè l’anno gregoriano
di vennerdì a hore dudici et meza, mancò meza quarta, in Napoli, nelli casi cheforno del marchese del Guarzo et allora del duca di Monte Alto, facci fronteSanta Maria a Maggiore, nacque don Geronimo Carrafa, primogenito del mar-chese di Castelvetere cioè del rescritto don Fabricio principe della Roccella.
A di undici di settembro 1584 di martidì a ore venti una in Castelloveterenacque don Carlo Carrafa secondo genito del sopradetto marchese.
A ventiuno di augusto 1585 di mercoridì ad ore ventidue, in Napoli, nellicasi che forno del duca di Amalfi a Santo Domenico, nacque don Vincentio Carrafafiglio del detto marchese e di donna Giulia d’Aragona, figlia del duca di TerraNova di Sicilia. Da la quale sono nati ancora l’altri dui sopra detti don Geronimoet don Carlo (morse di diecedotto anni).
A dì 27 di settembro 1586 nacque don Pietro in Castelvetere di Sabato amezo giorno.
A dì 13 di octobre 1587 nacque don Giovan Battista in CastelvetereA dì 2 di aprile 1589 nacque donna Livia in Castelvetere (morsi di uno anno).A dì 10 di marzo 1591 nacque don Iacopo di Domenica in Castelvetere.A dì 23 di giugno 1592 nacque donna Livia in Castelvetere (morsi di uno anno).A dì 11(?) di settembro 1593 nacque don Vincenzo in Castelvetere di Saba-
to a ore 14.A di 21 di febbraio 1596 nacque don Silvestro in Napoli di mercori ad ore 21.A di 31 di marzo 1597 nacque donna Isabella in Napoli (morsi di uno anno).A di 3 di giugno 1598 nacque donna Emilia in Napoli ad ore una di notti di
Mercuri.A di 17 di giugno 1599 nacque don Francesco in Castelvetere di Giovidì ad
ore tre di notte.
7
IN NOMINE DOMINI DEI ETERNI ET SALVATORIS nostri Iesu Christi amen.Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi millesimo quingentesimotrigesimo quarto, die vero vigesimo septimo mensis iunii, septimae inditionis,in terra Agroptereae et proprie in domo ecclesiae Sanctae Mariae Catholicae,sita et posita in dicta terra, iuxta ipsam ecclesiam praedictam, iuxta domumNicolai Angeli Panetta et iuxta vias publicas a duobus lateribus. Regnantibusserenissimis atque catholicis maiestatibus et dominis nostris, dominis Carolodivina favente clementia quinto romanorum imperatore regeque Alamaniaesemper augusto et Ioanna matre et eodem Carolo eius filio Dei gratia regibusCastellae, Aragonum, Utriusque Siciliae, Hierusalem et cetera, anno eorumdemin hoc Regno Neapolis decimo nono, feliciter, amen. Nos Petrus de Hispania decivitate Terraenovae U.I.D. et caesarearum et catholicarum maiestatum et earumviceregis in dicto Regno Neapolis seu Siciliae Citra farum commissariusspecialiter ordinatus ad conficiendum infrascriptum inventarium bonorumpheudalium, iurium, reddituum et reddentium, vaxallorum, iurisditionum,territoriorum et rationum ac actionum omnium spectantium et pertinentiumquomodocunque et qualitercunque ad marchionatum Castriveteris et comitatumAgroptereae provintiae Calabriae Ultra ac ad reintegrandum et reintegrationesfaciendum omnium bonorum pheudalium, iurium, reddituum bonorum etreddentium indebite occupatorum praedicti marchionatus et comitatus et pheudisdicti marchionatus et comitatus, incorporandum et uniendum. Assidentibusnobiscum egregio viro notario Iacobo Cannata de praedicta civitate Terraenovae,puplico ubilibet per provintias Calabriae regia autoritate notario, actore magistroper nos deputato in confectione dicti inventarii et reintegratione praedicta acPhilippo de Idario de civitate Hyeracii, iudice ad contractus et testibusinfrascriptis in numero oportuno nosque praedicti notarius, iudex et testesinfrascripti ad infrascripta vocati et rogati declaramus, notum facimus et testamurqualiter olim die sexto mensis februarii, septimae inditionis 1534 in terra Panayaecomparens, coram nobis, nobilis vir Hypolitus de Lupis de civitate Neocastripro parte illustris domini Ioannis Baptistae Carraffae marchionis marchionatusCastriveteris et comitis Agroptereae infrascriptas regias commissionales licterasnostrae commissionis nobis exibuit et praesentavit tenoris et continentiaesubsequentis videlicet.
8
Litterae commissionales
«CAROLVS quintus divina favente clementia romanorum imperatorsemper augustus rex Germaniae, Ioanna mater et idem Carolus eius filius, regesCastellae, Aragonum, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae,Croaciae et cetera. Don Petrus de Toledo marchio Villefranchae caesarearum etcatholicarum maiestatum in praesenti regno vicerex, locumtenens et capitaneusgeneralis et cetera. Magnifico viro U.I.D. Petro de Spagnia de Terranova regiofideli dilecto et commissario ad infrascripta specialiter deputato gratiam regiamet bonam voluntatem. Nuper pro parte illustris Ioannis Baptistae Carraffaemarchionis Castriveteris et comitis || (2v) Grotteriae regis consiliarii fidelisdilectissimi fuerunt nobis praesentatae quaedam provisiones et licterae patentesreintegrationis caesarearum et catholicarum maiestatum tenoris sequentis videlicet.
Regiae provisiones
“CAROLVS divina favente clementia romanorum imperator semperaugustus rex Germaniae, Ioanna eius mater et idem Carolus Dei gratia regesCastellae, Aragonum, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae,Croatiae, legionis Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, MaioricarumHispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae,Gibraltaris insularumque Canariae nec non insularum Indiarum et TerraeFirmae maris oceani, archiduces Austriae, duces Burgundiae, Brabantis et cetera,comites Barchinonae, Flandriae et Tiroli, duces Athenarum et Neopatreae,comites Rossilionis et Ceritaniae, marchiones Oristanni et Goriani. Illustri donPetro de Toledo marchioni Villefranchae viceregi, locutenenti et capitaneo no-stro generali. Illustribus, magnificis fidelibus nobis dilectis consiliariis sacri nostriregii collateralis consilii Neapoli residenti gratiam nostram et bonam voluntatem.Pro parte illustris Ioannis Baptistae Carraffa de Neapoli, marchionis Castriveteriset comitis Grotteriae, fidelis nobis dilecti, fuit nobis reverenter expositum ipsuma nobis et nostra regia curia inmediate et in capite tenuisse et possedisse ac inpraesentiarum tenere et possidere praedictum marchionatum Castriveteris etcomitatum Grotteriae in provintia Calabriae cum toto ipsorum integro statu,membris, districtibus, iuribus et pertinentiis, castris, fortellitiis, hominibus,vaxallis, vaxallorumque redditibus, mero mistoque imperio et gladii potestatefeudis, subfeudis, tenimentis, territoriis, planis, montibus, aquis, aquarumdecursibus aliisque iuribus et pertinentiis ad dictas terras spectantibus prout in