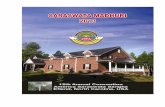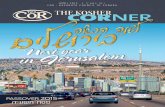Conte Goltara De Carli direttiva 2000-60 per GA 2008
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Conte Goltara De Carli direttiva 2000-60 per GA 2008
EuropAm
biente
75Ga - 1/08
I Piani di tutela delle acque
Con la Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro in materia di acque, l’Unione europea viene aregolare la gestione delle acque interne superficiali, sotterranee, di transizione e costiere al fine diprevenirne e ridurne l’inquinamento, promuoverne l’utilizzo sostenibile, proteggere l’ambiente,migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della sic-cità. La Direttiva Quadro prevede in particolare l’individuazione delle acque europee e delle lorocaratteristiche, classificate per bacino e per distretto idrografico di appartenenza, e l’adozione diPiani di gestione e di programmi di misure adeguate per ciascun corpo idrico.
L’articolo che qui pubblichiamo è tratto da uno studio svolto dal CIRF (Centro italiano per lariqualificazione fluviale) per la Fondazione CARIPLO, che aveva l’obiettivo di evidenziare gliaspetti più innovativi della Direttiva e di verificarne l’applicazione nella normativa italiana e, inparticolare, nella pratica amministrativa della Lombardia e del Piemonte, rilevando in che misurai contenuti innovativi della Direttiva siano stati effettivamente fatti propri dalle norme e dagli stru-menti di pianificazione.
La Direttiva 2000/60/CE e i Piani di tutela delle acque: avre-mo acque in buono stato nel 2016?*
di Giulio Conte(*), Alessandro de Carli(**), Andrea Goltara(*)
(*) Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)(**) IEFE - Università Bocconi
1. Premessa
La Direttiva europea 2000/60/CE (WaterFramework Directive, WFD), che istituisceun quadro per l’azione comunitaria in mate-ria di acque, ha rappresentato un’importan-te innovazione per l’impianto normativo dimolti Paesi europei e costituisce un fonda-mentale tentativo di integrazione delle poli-tiche di gestione dei bacini idrografici (per le
acque superficiali) e idrogeologici (per leacque sotterranee).
La Direttiva viene concepita negli anni ’90,quando comincia ad apparire chiaramente chele politiche di tutela delle acque dall’inquina-mento basate sul controllo degli scarichi, puravendo contribuito a ridurre le situazioni dicontaminazione più gravi, non erano suffi-cienti a garantire un pieno recupero della qua-lità delle acque. Gli ecosistemi acquatici – in
* Il presente articolo è tratto da una ricerca svolta dal CIRF per la Fondazione CARIPLO, che si ringrazia per averne resopossibile la pubblicazione.
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 75
particolare laghi e fiumi – non presentavanosensibili miglioramenti1 mentre i primi studisistematici sulla qualità delle acque sotterra-nee mostravano una diffusa contaminazioneda nitrati e da sostanze tossiche e nocive.
Esaminata oggi, la Direttiva mostra inrealtà alcuni aspetti contraddittori, che met-teremo in luce al prossimo paragrafo: in par-ticolare si percepisce che il testo è statoredatto in un lungo periodo di tempo2, nelcorso del quale l’impostazione centrata ini-zialmente sulla qualità delle acque – anchese intesa come qualità per gli ecosistemi – siè ampliata cercando di recepire la crescentesensibilità verso il valore “in sé” degli ecosi-stemi e cercando di favorire l’integrazionetra le diverse politiche riguardanti le acque ei suoli. Certamente però la Direttiva contie-ne una serie di elementi innovativi di fonda-mentale importanza e, interpretata in modointelligente, potrebbe portare grandi benefi-ci al governo delle acque.
Il presente articolo è tratto da uno studiosvolto per la fondazione CARIPLO, cheaveva l’obiettivo di evidenziare gli aspettipiù innovativi della Direttiva e di verificar-ne l’applicazione nella normativa italiana e,in particolare, nella pratica amministrativadella Lombardia e del Piemonte: non si limi-ta, quindi, a verificare il mero recepimentonormativo, ovvero la presenza nell’articola-to delle norme nazionali o regionali di riferi-menti alla Direttiva 2000/60/CE, ma puntapiuttosto di evidenziare in che misura i con-tenuti innovativi della Direttiva siano statieffettivamente fatti propri dalle norme edagli strumenti di pianificazione.
2. Elementi chiave della Direttiva 2000/60/CE
Gli elementi più innovativi della Diret-tiva possono essere così sintetizzati:– l’individuazione del bacino idrografico
come unità spaziale di riferimento;– la definizione di obiettivi di qualità
ambientale dei corpi idrici: il passaggiodalle norme regolatorie sui fattori di pres-sione alla definizione di obiettivi per gliecosistemi;
– la classificazione integrata dello stato eco-logico dei corpi idrici (per i corsi d’acqua:elementi di qualità biologici, fisico-chimi-ci, e idromorfologici);
– l’introduzione dell’analisi economicanella pianificazione delle misure e nell’al-locazione dei diritti di utilizzo, e di stru-menti economici basati sul principio di“chi inquina o usa paga”;
– la partecipazione pubblica come nuovometodo per la pianificazione e la gestio-ne, condizione necessaria per la definizio-ne dei Piani di gestione (e più in generaleper prendere decisioni realmente effica-ci).
2.1. Il bacino idrografico come unità spazia-le di riferimento
L’idea che l’unità spaziale elementare perpianificare e gestire le acque sia l’interobacino è tutto sommato intuitiva. GiulianoCannata (1994) evidenzia come i primi“Piani di bacino” – realizzati negli StatiUniti e in Unione Sovietica e rivolti preva-lentemente allo sfruttamento idroelettricodelle acque – risalgano addirittura agli anni’30 del secolo scorso. La normativa europea,tuttavia, non aveva ancora recepito taleprincipio e lo fa solo con l’art. 3 dellaDirettiva 2000/60/CE, che prescrive agliStati membri di individuare i bacini idro-grafici ed assegnarli a “distretti idrografici”,che possono riguardare uno o più bacini.Per ciascun distretto, gli Stati membri indi-viduano una “autorità competente” che hail compito di applicare le norme previstedalla Direttiva stessa e in particolare dicoordinare i programmi di misure per ilraggiungimento degli obiettivi.
2.2. Obiettivi di qualità ambientale
L’art. 4 della Direttiva prescrive che gliStati membri “proteggano, migliorino eripristinino” sia i corpi idrici superficiali chele acque sotterranee (garantendo per questeultime anche l’equilibrio tra prelievi e lanaturale capacità di ravvenamento)3 al finedi raggiungere un “buono stato”, definito in
Euro
pAm
bien
te
76
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 76
base alle disposizioni di cui all’allegato V.Nello stesso articolo la Direttiva definiscetutti i casi in cui è possibile derogare dalcomma 1 e raggiungere obiettivi di qualitàambientale meno ambiziosi dello statobuono.
Come ricordato in premessa, l’introdu-zione di “obiettivi di qualità” per i corpiidrici recettori è forse l’innovazione princi-pale introdotta con la Direttiva, che compor-ta il superamento della politica degli “stan-dard allo scarico” (la necessità di rispettaredeterminate concentrazioni delle acqueimmesse nei corpi idrici) e pone l’attenzionesui recettori: le falde acquifere e gli ecosiste-mi acquatici. Questo cambiamento ha delleconseguenze notevoli su molti altri aspetti esoprattutto sulla modalità di pianificazionedel settore. Il nuovo approccio, infatti,implica di fissare obiettivi di qualità perogni corpo idrico, e se tali obiettivi non sonogià raggiunti, comprenderne le cause, e ipo-tizzare e pianificare le soluzioni che ne con-sentano il raggiungimento, facendo ricorsoa tutti gli strumenti disponibili. In buonasostanza, quindi, la politica di gestione delleacque e dei bacini idrografici, che era untempo solo questione di “opere idrauliche”(dighe, derivazioni, acquedotti, difese, retti-ficazioni, fognature, depuratori) deve impa-rare a ricorrere ad un “cassetta degli attrez-zi” molto più ampia che si applica non solosul corpo idrico ma su tutto il bacino idro-grafico:– riducendo al minimo le portate sottratte
alla circolazione naturale, modificandopratiche gestionali e intervenendo sulladomanda idrica per promuovere un realerisparmio (civile, agricolo e industriale);
– innovando profondamente l’intero ciclourbano dell’acqua, secondo i principidella “sustainable sanitation”4;
– agendo secondo l’“approccio combinato”previsto dalla stessa Direttiva anche suicarichi diffusi (prevalentemente agricoli);
– aumentando la capacità “autodepurativa”del territorio e dei corsi d’acqua stessi.Per applicare una politica così nuova e
diversificata è necessario prevedere nonsolo opere innovative, ma anche modalità di
pianificazione diverse, passando da unapolitica dirigistica di “comando e controllo”(spesso limitata al “comando” e poco effica-ce nel “controllo”) ad una politica di coin-volgimento dei diversi attori che partecipa-no al raggiungimento degli obiettivi (impre-se, mondo agricolo, ed altri utilizzatori diacqua o produttori di inquinamento, maanche enti di sviluppo, consorzi di bonificae irrigazione, uffici regionali responsabilidella difesa idraulica, ecc.). Da qui la neces-sità della “partecipazione pubblica”, cheassume un ruolo determinante.
L’introduzione degli obiettivi di qualitàsui corpi idrici rappresenta dunque unagrande innovazione, anche limitandosi adinterpretare tali obiettivi come riferiti esclu-sivamente alla “qualità dell’acqua”. Ma laWFD cerca di andare oltre e – all’allegato V– definisce gli obiettivi di qualità ambienta-le introducendo, per gli ecosistemi acquatici,diversi elementi di classificazione non riferi-bili esclusivamente alla qualità delle acquema agli ecosistemi nel loro complesso, comedescritto nel paragrafo seguente.
2.3. Classificazione dei corpi idrici: definirelo stato ecologico in modo integrato
Come abbiamo visto, la WFD introducecome obiettivo ambientale da raggiungere(fatte salve le deroghe previste) il “buonostato” delle acque. L’allegato V della Diret-tiva è dedicato alla definizione dello “stato”delle acque, ed è anch’esso un elemento diinnovazione importante, anche se, comevedremo, presenta a nostro avviso alcunilimiti.
L’allegato è suddiviso in due parti: laprima definisce gli elementi che devonoessere considerati per valutare lo stato delleacque superficiali (fiumi, laghi, acque ditransizione e acque costiere), la seconda èdedicata alle acque sotterranee. Per questeultime la definizione è basata su criteriquantitativi – l’equilibrio tra prelievi e capa-cità di rinnovamento della falda – e qualita-tivi – assenza di contaminazione di origineantropica. Più complessi e significativi sonoi criteri di valutazione dello stato delle
EuropAm
biente
77Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 77
acque superficiali5, ed in particolare quelliriguardanti lo stato ecologico dei corsi d’ac-qua. La Direttiva infatti introduce alcuniimportanti elementi di valutazione che“descrivono” lo stato, non solo in funzionedella qualità delle acque, ma tenendo contodi altri possibili impatti: in particolare lavalutazione è basata sugli elementi biologici– considerati prioritari – e sugli elementiidromorfologici e chimici – considerati “disupporto” agli elementi biologici (si veda lafigura 1).
L’introduzione di elementi non dipen-denti dalla qualità delle acque è un segnaledi grande importanza: esso infatti riconoscela necessità di tutelare i corsi d’acqua nonsolo dall’inquinamento, ma anche dalle tra-sformazioni “fisiche” (alterazioni morfolo-giche dell’alveo, modifiche del regime delleportate). Tuttavia, nonostante l’impostazio-ne teorica avanzata e le migliori intenzioni,il sistema di classificazione dello stato ecolo-gico introdotto nella Direttiva contiene alcu-ni limiti capaci, potenzialmente, non solo dicomprometterne il pieno raggiungimentodegli obiettivi, ma addirittura di legittimarel’ulteriore deterioramento dei corsi d’acqua.
Buone “condizioni idromorfologiche”garantiscono lo svolgimento dei processifluviali: il trasporto solido, la dissipazionedell’energia della corrente, il mantenimentoe rinnovamento delle forme fluviali, gli
scambi di organismi, materia ed energia conla piana inondabile e con la zona iporreica.Esse hanno pertanto, a nostro modo di vede-re, un valore di esistenza in sé, anche indi-pendentemente dalla funzione di “suppor-to” agli elementi biologici, la cui importanzaper il mantenimento delle comunità biotichee di elevati livelli di biodiversità è nota(NAIMAN et al., 1993; 2001; KERN et al. 2002).
Ne deriva che la considerazione degliattributi idromorfologici assume un signifi-cato cruciale per la valutazione dello statoecologico dei corsi d’acqua, come del restoormai riconosciuto a livello internazionale(EA, 1998; EPSRC, 2001). La Direttiva invecestabilisce che la valutazione degli elementiidromorfologici vada effettuata solo per icorpi idrici che – dal punto di vista biologi-co e chimico – appaiano in stato elevato: talelimitazione (basata presumibilmente suldiscutibile presupposto che gli elementi bio-logici siano in grado di “rappresentareanche gli impatti di tipo fisico”) rischia diritardare la definizione di un metodo inte-grato di valutazione dello stato dei corsid’acqua verso cui orientare politiche altret-tanto integrate.
Proprio per evitare ulteriori ritardi ed av-viare risolutamente le politiche idriche versogli obiettivi della Direttiva stessa, chi scriveritiene che il recepimento della Direttiva nellenorme nazionali dovrebbe cercare di inter-pretare al meglio i contenuti della Direttiva,superandone i limiti ed anticipando le even-tuali revisioni e integrazioni che presumibil-mente si renderanno necessari.
D’altra parte, la volontà del legislatore diincludere nel “buono stato” degli ecosistemiacquatici, anche gli aspetti idromorfologiciappare chiaramente dall’articolo 11 chedescrive le “misure” che gli Stati membridevono adottare per raggiungere gli obietti-vi ambientali. Tale articolo infatti prevedemisure volte ad evitare “… qualsiasi altroimpatto negativo considerevole sullo statodei corpi idrici, di cui all’articolo 5 e all’alle-gato II, in particolare misure volte a garanti-re che le condizioni idromorfologiche delcorpo idrico permettano di raggiungere lostato ecologico prescritto o un buon poten-
Euro
pAm
bien
te
78
Fig. 1: Elementi di qualità da considerare per la classificazionedello stato ecologico dei fiumi.
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 78
ziale ecologico per i corpi idrici designaticome artificiali o fortemente modificati”.
2.4. Analisi e strumenti economici
Il principio di “chi inquina o usa, paga”,uno dei cardini teorici dell’economiaambientale, è alla base di molte politicheambientali europee e internazionali e laDirettiva 2000/60/CE lo introduce ancheper l’acqua. Si tratta di un aspetto particolar-mente rilevante in quanto sottende l’ideache l’attribuzione di un prezzo adeguato aduna risorsa scarsa, sia uno dei meccanismichiave per garantirne l’uso efficiente. Inaltre parole: l’acqua per i diversi usi vieneoggi fornita a prezzi molto bassi, assoluta-mente inadeguati per ripagare anche solo ilsuo costo “industriale”: sia in termini diinvestimento (le opere di captazione e, per leacque superficiali, di regolazione) che digestione e manutenzione. Inoltre sarebbenecessario mettere nel conto anche il “costoambientale”, ovvero il danno provocato dalprelievo: sui corsi d’acqua (che vengonoalterati dalle opere di captazione e di regola-zione) e sulle falde acquifere.
All’analisi economica la WFD dedica par-ticolare attenzione, come appare dai continuirichiami ad essa, evidenziati in tabella 1.
In generale, una valida analisi economicapuò aiutare a:– comprendere le questioni economiche e i
trade-off in gioco all’interno di un bacinoidrografico: il ripristino della qualità del-l’acqua può influenzare settori economi-ci che svolgono un ruolo importante nel-l’economia locale, regionale e nazionale(in termini di risultati economici, com-mercio e impiego); inoltre, differenti set-tori economici si trovano spesso a com-petere per le stesse risorse idriche (dibuona qualità);
– valutare la strategia economicamente piùconveniente al fine di conseguire obiettiviambientali ben definiti per le risorse idri-che. Chiaramente, questo assicura unmiglior uso delle limitate risorse finanzia-rie disponibili;
– valutare l’impatto economico dei pro-grammi di misure proposti, finalizzati amigliorare lo stato dei corpi idrici (peresempio stabilendo chi ci guadagna e chici rimette). In alcuni casi tale valutazionepuò evidenziare il bisogno di svilupparespecifiche misure di accompagnamento,per compensare (parzialmente) chi è inperdita, facilitando così l’attuazione dellemisure proposte;
– individuare le regioni o i corpi idrici dovel’obiettivo buono non può essere rag-giunto, e possono essere previste proro-ghe (purché adeguatamente giustificate),in ragione dei costi “sproporzionati”delle misure necessarie per raggiungerloe dei relativi impatti economici e sociali;
– sostenere lo sviluppo di strumenti econo-mici e finanziari (per esempio determina-zione dei prezzi dell’acqua o misure sup-plementari quali canoni per l’inquina-mento e tasse ambientali), che possanofacilitare il conseguimento degli obiettiviambientali.A supporto del processo di implementa-
zione della WFD, le Linee Guida WATECO(2003) hanno declinato le differenti funzioniche devono svolgere gli strumenti economici:– conduzione di un’analisi economica degli
usi alternativi dell’acqua in ciascun bacino;– definizione di trend nell’offerta di acqua,
nella domanda di acqua e negli investi-menti;
– identificazione di aree destinate alla pro-tezione di specie acquatiche economica-mente significative;
– individuazione di corpi idrici fortementemodificati;
– valutazione dei costi e dei relativi livelli emodalità di copertura;
– supporto per la selezione di programmidi misure basate su criteri di cost-effective-ness;
– valutazione del ruolo potenziale del pri-cing e degli strumenti economici di politi-ca ambientale;
– individuazione delle opportunità dipotenziali deroghe (tempi ed obiettivi)dagli obiettivi ambientali della Direttiva
EuropAm
biente
79Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 79
attraverso la valutazione di costi e benefi-ci delle diverse alternative (valutazionedei costi sproporzionati);Da quanto riportato appare chiaramente
il significato dell’analisi economica riferitaagli usi dell’acqua. Ma un’interpretazionedegli obiettivi di qualità come “stato degliecosistemi” in senso ampio, intesi comedetto al paragrafo 2.3, porterebbe ad esten-
dere anche il significato dell’analisi econo-mica e del recupero dei costi, che potrebbeessere riferito non esclusivamente agli usidell’acqua, ma più in generale alle politichedi gestione dei bacini idrografici, includen-do tra queste anche quelle di riduzione delrischio idraulico, oggetto della recenteDirettiva 2007/60/CE (“relativa alla valuta-zione e alla gestione dei rischi di alluvioni”).
Euro
pAm
bien
te
80
Tab. 1: I richiami all’analisi economica contenuti nella Direttiva 2000/60/CE.
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 80
Tale Direttiva afferma esplicitamente in piùpunti la necessità di garantire l’integrazionedelle misure di prevenzione dal rischio conquelle volte a raggiungere gli obiettivi diqualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.
Secondo questa interpretazione, sarebbepossibile prevedere, all’interno dei Piani digestione del distretto idrografico, misureintegrate di riduzione del rischio idraulico edi miglioramento dello stato degli ecosistemi,che prevedano il recupero di condizioni dinaturalità dei corpi idrici che hanno subitoalterazioni morfologiche, riportandoli versole condizioni di riferimento. In questa pro-spettiva anche l’analisi economica sarebbeapplicata a tali Piani integrati, permettendodi valutare le possibili sinergie e il valoreaggiunto di soluzioni che potrebbero rivelar-si economicamente troppo onerose se consi-derate all’interno di Piani settoriali. Allo stes-so modo, questa interpretazione potrebbeportare alla designazione di un minor nume-ro di corsi d’acqua come “Corpi IdriciFortemente Modificati”, in quanto interventidi costo “sproporzionato” ai fini del solomiglioramento ambientale potrebbero essereeconomicamente accettabili se contribuisco-no anche alla riduzione del rischio idraulico.
2.5. Partecipazione pubblica
L’art. 14 della WFD recita: “Gli Stati mem-bri promuovono la partecipazione attiva ditutte le parti interessate all’attuazione dellapresente Direttiva, in particolare all’elabora-zione, al riesame e all’aggiornamento deiPiani di gestione dei bacini idrografici …”.
La partecipazione non è in realtà unobiettivo della Direttiva, ma deve essereintesa come una nuova “modalità di lavoro”per raggiungere gli obiettivi dichiarati. Ilcontesto in cui il decisore pubblico è chiama-to a definire i Piani e le norme per la gestio-ne delle risorse idriche è diventato estrema-mente complesso: conflitti tra diversedomande di “uso” dell’acqua e del suolo, tramisure per la riduzione dei carichi inqui-nanti diffusi o puntiformi, tra opere idrauli-che e recupero di condizioni di naturalità. Iprocessi di partecipazione hanno dunque in
primo luogo il compito di fornire al decisoreuna base informativa il più esaustiva possi-bile sugli attori che hanno degli interessisulle risorse del bacino e su quali giudizi divalore associno ad esse.
L’esperienza accumulata negli anni, rela-tivamente al coinvolgimento degli attori, hafatto emergere l’importanza fondamentaleche, in qualunque processo partecipato, pos-siede la variabile dell’informazione: un pro-cesso partecipato è innanzitutto da inten-dersi come processo di apprendimento col-lettivo (Ridder et al., 2005). Non si tratta solodi rendere accessibili e disponibili informa-zioni tecniche; si tratta semmai di mettere inmoto un processo di scoperta e progressivocoagularsi di una cultura condivisa, cheinveste la percezione dei problemi, le com-ponenti di valore in gioco e le modalità dellaloro attribuzione, le modalità di interazione,lo spazio disponibile per la ricerca dellesoluzioni; ma prima ancora serve alla comu-nità di riferimento a riconoscersi in quantocomunità interessata da un medesimo pro-blema (Massarutto, 2005).
La partecipazione dei diversi attori nelprocesso decisionale è anche uno strumentoormai irrinunciabile per l’attuazione delledecisioni stesse: le politiche previste daiPiani di gestione sono infatti molto comples-se, non più limitate al “comando e control-lo”, e inevitabilmente coinvolgono moltissi-mi soggetti diversi, istituzionali e non: ilmancato coinvolgimento di tali soggettinella formazione delle scelte comporta spes-so grandi difficoltà nella loro attuazione.
Nelle Linee Guida per l’applicazione dellaWFD vengono individuati tre livelli di parte-cipazione: informazione, consultazione ecoinvolgimento attivo. Questi differenti livel-li di partecipazione pubblica non sonomutuamente esclusivi e possono essere com-binati in funzione degli obiettivi e dei benefi-ci attesi, dei livelli amministrativi coinvolti(legislazione o regolamentazione ambientale,definizione di standard tecnici, pianificazioneterritoriale, procedimenti autorizzativi, ecce-tera), delle fasi del processo decisionale (exante, in itinere o ex post), delle risorse disponi-bili e degli stakeholder da coinvolgere.
EuropAm
biente
81Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 81
3. Il recepimento della 2000/60/CE nel qua-dro normativo italiano e nei Piani di tuteladi Lombardia e Piemonte
3.1. Il recepimento nella normativa nazionale
La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita“ufficialmente” nel 2006, con l’approvazionedel Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006.Gli aspetti relativi al recepimento dellaDirettiva sono contenuti nella parte terzadel Decreto, che è oggetto di una revisioneaffidata ad una commissione di esperti gui-data dal senatore Turroni: una prima bozzadel testo modificato è stata presentata pub-blicamente nel settembre 2007 (www.grup-po183.org/area_tematica.asp?ID_AREA_TEMATICA=19)6.
In realtà gli elementi chiave evidenziati alcapitolo precedente sono entrati a far partedel quadro normativo italiano a partire dallafine degli anni ’80, anche se alcune conmodalità che sono state spesso criticate econtinuano a suscitare un ampio dibattito.
3.1.1. Il bacino idrografico come unità spa-ziale di riferimento
Questo fondamentale concetto entra nellanormativa italiana con la Legge 183/89, cheistituisce le Autorità di Bacino (AdB): talelegge aveva come oggetto prevalente la“difesa del suolo”, ma tra le sue finalità rien-travano anche “il risanamento delle acque,la fruizione e la gestione del patrimonioidrico per gli usi di razionale sviluppo eco-nomico e sociale, la tutela degli aspettiambientali ad essi connessi”. Le AdB diven-tano operative nei primi anni ’90 e dedicanola propria attività prevalentemente alla pia-nificazione per la prevenzione del rischio (inparticolare dopo il D.Lgs. 180/98) ma alcu-ne di esse svolgono un fondamentale ruolodi coordinamento delle politiche idriche nelbacino: diverse AdB infatti elaborano deli-berazioni o anche interi Piani (stralci delPiano di bacino) riguardanti la qualità o gliusi delle acque.
Né l’istituzione delle AdB, né l’attuazionedella L.183/89, tuttavia, modificano radical-
mente il quadro delle competenze in mate-ria di politiche idriche, che resteranno finoad oggi suddivise tra Stato7, Regioni ed entisottoordinati, mantenendo una frammenta-zione che ha spesso suscitato forti critiche.D’altra parte è necessario evidenziare comela Direttiva 2000/60, prescrivendo che “gliStati membri provvedano ad adottare ledisposizioni amministrative adeguate, ivicompresa l’individuazione dell’autoritàcompetente, per l’applicazione delle normepreviste dalla presente Direttiva all’internodi ciascun distretto idrografico presente nelloro territorio”, non richiede necessariamen-te un unico ente per l’attuazione di tutte lepolitiche idriche, quanto un’“autorità com-petente” che per ogni distretto idrograficogoverni e coordini le politiche in modo daraggiungere gli obiettivi della Direttiva stes-sa. Pur essendo evidenti le criticità legatealla frammentazione delle competenze inmateria, ci sembra che la “filosofia” con cuile AdB erano state originariamente concepi-te – ovvero enti “leggeri”, con strutture tec-niche competenti incaricate della pianifi-cazione di livello strategico e del coordina-mento delle politiche più che della loroattuazione – risponda in pieno al dettatodella WFD.
Nell’attuazione della Legge 183/89 vi èstata senz’altro una “debolezza” del ruolodelle AdB nello svolgere questo ruolo dicoordinamento (e l’entrata in vigore delD.Lgs. 152/06 senza le opportune modificherischierebbe di peggiorare la situazione).Questo è vero certamente per le politiche ditutela delle acque, in particolare per i Pianidi risanamento (ex Lege 319/76), realizzati ingran parte prima che le AdB divenisseroeffettivamente operative (e quindi senzatener conto dell’unità del bacino e deglieffetti cumulativi degli interventi) ma inparte anche per i Piani di tutela regionali, dicui parleremo nei prossimi paragrafi. Ma ilmancato “coordinamento sul bacino” daparte delle AdB ha riguardato spesso anchela programmazione degli usi e gli interventidi difesa idraulica, spesso finanziati e realiz-zati senza un reale controllo da partedell’AdB.
Euro
pAm
bien
te
82
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 82
In conclusione ci sembra di poter rilevareche il concetto di bacino idrografico siaormai solidamente interiorizzato dall’im-pianto normativo, che le Autorità di Bacino(o le prossime Autorità di Distretto) corri-spondano alle autorità competenti richiestedalla Direttiva, ma che il loro ruolo vada raf-forzato, attribuendo loro un maggior poteredi coordinamento e controllo, per garantireche interventi realizzati sul bacino da unqualsiasi ente non producano effetti indesi-derati su un’altra porzione di bacino.
3.1.2. Gli obiettivi di qualità ambientale
Questo aspetto della Direttiva è statorecepito nel quadro normativo italiano dalD.Lgs. 152/99, anche se i criteri di classifica-zione dello stato ecologico, come vedremo alprossimo paragrafo, sono stati recepiti soloparzialmente. La “rivoluzione concettuale”che sposta dagli scarichi ai corpi recettoril’oggetto delle politiche di tutela delleacque, è comunque pienamente interpretatadal D.Lgs. 152/99; con conseguenze poten-zialmente molto rilevanti, in particolare perle acque sotterranee che, ricevendo moltoraramente scarichi diretti erano state perdecenni la “cenerentola” delle politichenazionali di tutela dall’inquinamento idrico.
È opportuno ricordare che fino all’appro-vazione del D.Lgs. 152/99 in molte Regioni– in particolare nel centro-sud – non si prati-cava un monitoraggio regolare dello statodelle acque, per cui era praticamente impos-sibile valutare gli effetti delle politiche ditutela. Anche nelle Regioni del bacino pada-no – soprattutto in Lombardia e Veneto,meno in Piemonte ed Emilia Romagna doveil coordinamento di Regione ed ARPA si èavviato prima – vi era una notevole disomo-geneità nei dati disponibili e nelle modalitàdi monitoraggio, soprattutto per le acquesotterranee. Il D.Lgs. 152/99 ha avuto ilgrande merito di definire protocolli comuniper la raccolta dei dati e la classificazionedello stato dei corpi idrici.
In analogia con la WFD, il D.Lgs. 152/99stabilisce come “norma” per tutti i corpi idri-ci il raggiungimento dell’obiettivo “buono”
entro il 2016, ma lascia la possibilità che leRegioni stabiliscano o tempi più lunghi per ilraggiungimento dell’obiettivo buono, o obiet-tivi “diversi” (meno impegnativi del “buo-no”), quando ricorrano le seguenti condizioni:a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni
in conseguenza dell’attività umana cherendono manifestamente impossibile oeconomicamente insostenibile un significa-tivo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell’obiettivo di quali-tà previsto non è perseguibile a causadella natura litologica ovvero geomorfo-logica del bacino di appartenenza;
c) l’esistenza di circostanze impreviste oeccezionali, quali alluvioni e siccità.In realtà i meccanismi di “deroga” al rag-
giungimento dell’obiettivo previsti dallaDirettiva sono più complessi di quelli previ-sti dal D.Lgs. 152/99: infatti è possibile fissa-re l’obiettivo buono e dilazionare il raggiun-gimento (per varie cause) oppure fissare inmodo definitivo obiettivi diversi dal buono,ma solo per i corpi idrici “fortemente modifi-cati”. Ciononostante, ci sembra che il dettatodella Direttiva (raggiungere l’obiettivo buo-no come regola, ed obiettivi meno ambiziosicome eccezione, solo per i corpi idrici interes-sati da una “pressione antropica” molto ele-vata) sia stato sostanzialmente recepito.
È ancora presto per dire se il cambiamentodell’impianto normativo porterà i necessarimiglioramenti: gli strumenti attuativi delD.Lgs. 152/99, i Piani di tutela regionali, cheincludono i “programmi di misure”, sonostati redatti ed approvati solo negli annirecenti (nel prossimo capitolo faremo alcuniapprofondimenti e considerazioni sui Piani diLombardia e Piemonte). È possibile comun-que affermare che, concettualmente, la nor-mativa italiana dà oggi pieno recepimentoalla Direttiva 2000/60/CE, fatte salve le con-siderazioni riportate al paragrafo seguente.
3.1.3. La classificazione dello stato dei corpiidrici
Al paragrafo 2.3 abbiamo ampiamentediscusso come il sistema di classificazione
EuropAm
biente
83Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 83
dello stato dei corpi idrici sia uno snodo fon-damentale per orientare correttamente lepolitiche idriche del futuro, e abbiamo chiari-to come sia opportuno interpretare il metododi classificazione proposto in modo lungimi-rante. Da questo punto di vista, il recepimen-to operato in Italia è certamente carente: talecarenza era giustificabile nel 1998, quando siterminò l’elaborazione del testo del futuroD.Lgs. 152/99 e la Direttiva ancora non erastata approvata, ma è francamente menocomprensibile nel D.Lgs. 152/06, che lasciainvariato l’allegato tecnico che specifica lemodalità di classificazione dei corpi idrici.
Il sistema di classificazione proposto èinfatti coerente con la WFD per quantoriguarda le acque sotterranee, ma non per leacque superficiali. In particolare, gli ele-menti di qualità biologici, considerati essen-ziali dalla Direttiva, sono pressoché assentinei sistemi di valutazione della normativaitaliana. Limitandoci a laghi e fiumi (consi-derato l’ambito di interesse di Piemonte eLombardia), la WFD prevede che la classifi-cazione sia effettuata tenendo presente lacomposizione e l’abbondanza (e per lafauna ittica anche la struttura di età) dellaflora acquatica, dei macroinvertebrati ben-tonici e della fauna ittica. La classificazioneprevista dal D.Lgs. 152/99 (e dal D.Lgs.152/06 attualmente in vigore) prevede ele-menti biologici di valutazione esclusiva-mente per i fiumi: per cui il raggiungimen-to dell’obiettivo è determinato anchedall’Indice Biotico Esteso, che potrebbeessere considerato un “proxy” della compo-sizione e abbondanza dei macroinvertebra-ti, (anche se vi sono diversi dubbi su talepossibilità di “assimilazione”). Per i laghi laclassificazione è basata esclusivamentesulle condizioni di trofia.
Ma il fatto che alcuni aspetti tecnici dellanormativa italiana non recepiscano fedel-mente quanto previsto dalla Direttiva ancoranon ci dice quello che ci interessa maggior-mente, ovvero: queste carenze nei metodi diclassificazione sono così gravi da esporre leacque italiane al rischio di rimanere in catti-vo stato? In altre parole, il fatto di avere rece-pito parzialmente gli elementi in base ai quali
si valuta lo stato delle acque, e quindi di nonmonitorare tali parametri sulle acque italiane,rischia di non permetterci di rilevare condi-zioni di degrado e, di conseguenza, di nonattivare le necessarie misure?
Per i laghi questo rischio è limitato ad unaspetto: la fauna ittica. Le modalità di rileva-mento di questa importante componente del“buono stato” di un lago non sono ancorasufficientemente strutturate e regolari. Anchese non si può dire che manchi una conoscen-za del problema – vi sono studi approfonditisulle comunità ittiche dei laghi italiani - cer-tamente integrare questi aspetti nel sistemadi valutazione dello stato dei laghi potrebbeaiutare a definire programmi di misure piùefficaci. D’altra parte va considerato che gliimpatti sulla fauna ittica sono solo in partericonducibili alle politiche idriche (in partico-lare per i laghi, la qualità dell’acqua) e dovu-ti in larga misura alla gestione faunistica stes-sa, che ha profondamente alterato le comuni-tà ittiche in tutte le acque interne italiane. Perquanto attiene strettamente le politiche idri-che, non vi è dubbio che i problemi maggioridei laghi italiani siano l’eutrofizzazione e lacontaminazione da sostanze pericolose,entrambi aspetti considerati nei sistemi diclassificazione in vigore.
Per i fiumi la situazione è più critica,come abbiamo in parte anticipato al para-grafo 2.3. Infatti la mancata integrazionedegli aspetti idromorfologici e biologici – inquesto caso oltre alla fauna ittica, per cuivale quanto detto per i laghi, è importanteanche la vegetazione delle fasce riparie –non permette di rilevare il notevole impattosu questi ecosistemi, dovuto alle pratiche digestione degli alvei, alla realizzazione diopere di difesa idraulica e di sbarramenti eall’alterazione del regime idrico. In questocaso, quindi, il mancato recepimento, adoggi, degli aspetti citati espone effettiva-mente al rischio di non registrare una ogget-tiva condizione di degrado.
3.1.4. L’analisi economica
Anche prima della pubblicazione dellaDirettiva 2000/60/CE, la normativa italiana
Euro
pAm
bien
te
84
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 84
già prevedeva, in linea di principio, la valu-tazione economica e l’uso di strumenti eco-nomici nella pianificazione delle risorse idri-che e dei servizi idrici.
La L. 36/1994 (nota anche come LeggeGalli) riportava il titolo “Disposizioni in ma-teria di risorse idriche”, sebbene fosse pre-valentemente incentrata su disposizioni inmateria di servizi idrici, ed in particolarequelli asserviti alle utenze civili. La LeggeGalli introduceva il concetto di gestioneindustriale del servizio idrico, basato sui cri-teri di efficienza, efficacia ed economicità,che voleva contrapporsi alle gestioni “ineconomia” del servizio idrico da parte deisingoli Comuni.
La Legge definiva che i servizi idrici venis-sero organizzati sulla base di ambiti territo-riali ottimali delineati secondo dei criteri fisi-ci (bacino idrografico) e gestionali (riduzionedella frammentazione verso dimensionigestionali adeguate). La Legge stabiliva inol-tre che la tariffa del servizio idrico fossedeterminata in modo da assicurare la coper-tura integrale dei costi, ma limitatamente aquelli di investimento e di esercizio. Lanorma dunque non prendeva in considera-zione i costi ambientali e della risorsa.
Le disposizioni in merito agli usi produt-tivi delle risorse idriche venivano trattateseparatamente dal servizio idrico integrato;tuttavia non vi erano indicazioni sulle stessemodalità di gestione dei servizi, rimandan-do alla normativa competente i consorzi dibonifica e irrigazione per quanto riguarda iservizi idrici per l’agricoltura. Uno dei limi-ti della Legge Galli è stato quello di conside-rare come “servizio idrico” esclusivamentequello asservito agli usi civili, tralasciandoin primis i servizi idrici a favore delle attivi-tà produttive e all’agricoltura; a seguire tuttigli altri servizi indicati come tali dallaDirettiva 2000/60/CE (infrastrutture per lanavigazione, sistemi idroelettrici, servizi diprotezione dalle piene).
Il D.Lgs. 152/1999 prevedeva, in meritoall’analisi economica, che i Piani di tutelacontenessero:– una relazione sulle iniziative e misure
pratiche adottate per l’applicazione del
principio del recupero dei costi dei servi-zi idrici ai sensi della L. 36/1994 e sintesidei Piani finanziari predisposti ai sensidell’articolo 11 della stessa Legge;
– una sintesi dei risultati dell’analisi econo-mica, delle misure definite per la tuteladei corpi idrici e per il perseguimentodegli obiettivi di qualità, anche allo scopodi una valutazione del rapporto costibenefici delle misure previste e delle azio-ni relative all’estrazione e distribuzionedelle acque dolci, della raccolta e depura-zione e riutilizzo delle acque reflue;
– sintesi dell’analisi integrata dei diversi fat-tori che concorrono a determinare lo statodi qualità ambientale dei corpi idrici, alfine di coordinare le misure per assicurareil miglior rapporto costi benefici dellediverse misure; in particolare richiedeva diprendere in considerazione quelli riguar-danti la situazione quantitativa del corpoidrico in relazione alle concessioni in atto ela situazione qualitativa in relazione al ca-rico inquinante immesso nel corpo idrico.Se da un punto di vista teorico, dunque, la
normativa italiana già prevedeva l’uso dell’a-nalisi economica e di strumenti economicinella pianificazione e nella gestione dellerisorse idriche e dei servizi idrici prima dellapromulgazione della WFD, dal punto di vistapratico si è sentita la mancanza di LineeGuida comuni adeguate. È poi mancata - emanca tuttora - una consolidata prassi istitu-zionale all’utilizzo delle valutazioni econo-miche intese come strumento di supportoalle decisioni; troppo spesso la valutazioneeconomica viene inserita a valle delle decisio-ni per rispondere alle domande “quantocosta” e “dove reperisco i fondi”. Queste dueconsiderazioni sono constatabili nella estre-ma eterogeneità delle valutazioni economi-che riportate nei Piani di tutela regionali.
I contenuti del D.Lgs. 152/2006 in materiadi valutazioni economiche e strumenti econo-mici riprende fortemente l’impostazione defi-nita dalla L. 36/1994 e dal D.Lgs. 152/1999,inserendo alcune definizioni prese dallaDirettiva 2000/60/CE. Manca ancora unaprecisa indicazione sul fatto che l’analisi eco-
EuropAm
biente
85Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 85
nomica debba contribuire, insieme alle ana-lisi ambientali e tecniche, alla caratterizza-zione del bacino idrografico e alla definizio-ne delle misure di Piano.
L’attuale impianto della parte terza delCodice ambientale risulta essere confuso inmerito alla definizione di servizio idrico e direcupero dei costi del servizio idrico. Se dauna parte, il Codice ambientale riprendealcune definizioni introdotte dalla WFDcome quella di servizio idrico, di costoambientale e costo della risorsa (art. 74) erichiede che “le Autorità competenti tenga-no conto del principio del recupero dei costidei servizi idrici, compresi quelli ambienta-li e relativi alla risorsa, prendendo in consi-derazione l’analisi economica effettuata inbase all’allegato 10 alla parte terza del pre-sente Decreto e, in particolare, secondo ilprincipio “chi inquina paga” (art. 119), dal-l’altra parte si richiede che la tariffa del ser-vizio idrico integrato (quindi per i soli usicivili) permetta una copertura dei soli costiindustriali (art. 154, comma 1). Al commasuccessivo si trova scritto che le componen-ti di costo per la determinazione della tarif-fa relativa ai servizi idrici per i vari settoridi impiego dell’acqua verranno definiti perdecreto del MATT “tenuto conto della ne-cessità di recuperare i costi ambientali an-che secondo il principio “chi inquina paga”.Infine si fa riferimento al recupero dei costiambientali e della risorsa nella determina-zione dei canoni di concessione per l’utenzadi acqua pubblica (art. 154, comma 3).
L’allegato 10 alla parte terza del D.Lgs.152/20068 intitolato “Analisi economica” èripreso quasi integralmente dalla traduzio-ne ufficiale italiana dell’allegato 3 dellaWFD. Tale versione riporta l’espressione “lacombinazione di misure più redditizie”come traduzione di “most cost effective combi-nation of measures”, che risulta alquantofuorviante. Una più corretta traduzionedovrebbe essere “la combinazione di misurepiù efficaci economicamente”.
Come già accennato, tuttavia, l’iter direvisione del Decreto è ancora in corso, eanche l’allegato citato potrebbe subire varia-zioni significative.
3.1.5. La partecipazione pubblica
Varie forme di partecipazione pubblica,per quanto non ancora coerenti con i requi-siti della Convenzione di Aarhus, sono giàpreviste dalla disciplina nazionale e regio-nale relativa agli strumenti di pianificazioneambientale e territoriale. In alcuni casi visono state Amministrazioni pubbliche chehanno adottato approcci fattuali di pianifi-cazione partecipata, come l’Autorità diBacino del Po (Massarutto e Pesaro, 1996).
In relazione ai procedimenti autorizzativi,l’art. 15 della Direttiva 96/61/CE, come mo-dificato dall’art. 4 della Direttiva 2003/35/CEprevede l’informazione e la partecipazionedel pubblico nell’ambito della proceduraautorizzativa.
Particolarmente interessanti risultanoalcune forme di partecipazione codificate,che costituiscono delle metodologie incor-porate in alcuni processi amministrativi,come:– la VIA,– la VAS,– l’Agenda 21 locale.
L’attuale impianto della parte terza delD.Lgs. 152/20069 prevede che le Autorità diBacino e le Regioni promuovano la parteci-pazione attiva di tutte le parti interessateall’elaborazione, al riesame e all’aggiorna-mento, rispettivamente, dei Piani di bacino edei Piani di tutela.
Tuttavia sono da segnalare numeroseincongruenze con quanto richiesto dall’art.14 della WFD. Per quanto concerne il Pianodi distretto vi sono due omissioni moltoimportanti (cfr. Tabella 2). In primo luogonon si prevede la possibilità di accesso alladocumentazione di riferimento e alle infor-mazioni in base alle quali è stato elaboratoil progetto del Piano; in secondo luogo nonviene fatto alcun riferimento alla consulta-zione pubblica nel caso di revisione delPiano.
Per quanto concerne il Piano di tutela,l’art. 122 del D.Lgs. 152/2006 riprendequasi fedelmente la Direttiva, ma ha intro-dotto la “richiesta motivata” per l’accesso
Euro
pAm
bien
te
86
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 86
agli studi di supporto del Piano. Questoapproccio lascia molta discrezionalità allaRegione sul fatto di concedere l’accessoalle informazioni richieste. Infine è dasegnalare che per il Piano d’Ambito non èprevista alcuna procedura di partecipazio-ne pubblica.
3.2. Il recepimento nei Piani di tutela delleacque regionali di Lombardia e Piemonte
Lo strumento ad oggi chiave per l’attua-zione delle politiche di miglioramento delleacque superficiali e sotterranee è il “Piano ditutela delle acque”, previsto dal D.Lgs.
EuropAm
biente
87Ga - 1/08
Tab. 2: Confronto tra il testo della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/2006 relativamente al tema della partecipazione pubblica.
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 87
152/99, di competenza regionale; il Piano ditutela definisce le misure per il raggiungi-mento degli obiettivi di qualità delle acque econtiene:a) i risultati dell’attività conoscitiva;b) l’individuazione degli obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione;c) l’elenco dei corpi idrici a specifica desti-
nazione e delle aree richiedenti specifichemisure di prevenzione dall’inquinamentoe di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantita-tive tra loro integrate e coordinate perbacino idrografico;
e) l’indicazione della cadenza temporaledegli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell’efficaciadegli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;I Piani di tutela (PTA) sono quindi Piani
attuativi del D.Lgs. 152/99; di conseguenzai loro contenuti risentono delle carenze -precedentemente citate - con cui la WFD èstata recepita all’interno di tale norma.Ciononostante, essendo stati elaborati per lopiù dopo il 2001, quando la Direttiva era giàstata approvata, in alcuni casi hanno cercatodi anticiparne i contenuti.
Nel caso della Lombardia, l’attuazionedel D.Lgs. 152/99 che avvia l’elaborazionedel PTA fa esplicito riferimento alla WFD.Infatti, con l’approvazione della Leggeregionale 12 dicembre 2003, n. 26 (modifica-ta dalla Legge regionale 18/2006) laLombardia ha indicato il “Piano di gestionedel bacino idrografico” (in linea con quantoprevisto dalla Direttiva 2000/60) quale stru-mento regionale per la pianificazione dellatutela e dell’uso delle acque. Ha inoltre sta-bilito che, nella sua prima elaborazione, talePiano costituisce il “Piano di tutela delleacque” previsto dal Decreto Legislativo152/99, come Piano stralcio di settore delPiano di bacino previsto dalla Legge 183/89.In pratica la Lombardia dichiara esplicita-mente la “sovrapposizione” tra Piano digestione ai sensi della Direttiva e Piano ditutela ai sensi delle leggi italiane. Il Piano digestione del bacino idrografico della
Regione Lombardia, è costituito dall’Atto diIndirizzo, approvato dal Consiglio regionaleil 27 luglio 2004 e dal “Programma di tutelae uso delle acque” (che continueremo a chia-mare Piano di tutela o PTA in questo testo).definitivamente approvato con Deliberazio-ne n. 2244 del 29 marzo 2006.
Il Piano di tutela del Piemonte non siattribuisce esplicitamente il ruolo di attua-zione della WFD, anche se nella deliberazio-ne di adozione (settembre 2004), fa riferi-mento alla consonanza delle finalità delPiano stesso con la Direttiva. Il PTA delPiemonte viene approvato definitivamentenel marzo 2007.
Ma al di là delle dichiarazioni e delle ter-minologie usate, ciò che ci interessa è verifi-care in che misura gli aspetti chiave dellaDirettiva 2000/60/CE siano entrati effetti-vamente nei Piani di tutela delle acque diLombardia e Piemonte: a questa verificasono dedicati i paragrafi che seguono.
3.2.1. Il bacino come unità di riferimento
I quadri conoscitivi di entrambi i PTAindividuano i bacini idrografici come unitàdi riferimento per le acque superficiali e,analogamente, unità spaziali omogenee cor-rispondenti ai bacini idrogeologici per leacque sotterranee. Per quanto riguarda l’ap-plicazione territoriale delle misure, entram-bi i PTA stabiliscono programmi di misuresu due livelli: un livello generale, che riguar-da le misure da attuare su tutto il territorioregionale e un livello di dettaglio, che iden-tifica programmi di misure per i bacini idro-grafici. In linea generale, quindi vi è unabuona aderenza con la Direttiva per questoaspetto.
D’altra parte va rilevato come, per leRegioni che insistono sullo stesso bacinoidrografico – come è il caso di Piemonte eLombardia – sia stato estremamente deboleil ruolo di coordinamento dell’Autorità diBacino. Questa mancanza di coordinamentoha riguardato sia l’impostazione complessi-va dei PTA – sono mancate Linee Guida cherendessero più omogenea l’impostazionedei PTA nelle diverse Regioni –, sia la defini-
Euro
pAm
bien
te
88
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 88
zione delle misure riguardanti i bacini “diconfine”. Su quest’ultimo aspetto, un acco-glimento dei principi della Direttiva avreb-be richiesto l’applicazione ai bacini compre-si in più Regioni di quanto la WFD prevedeper i bacini compresi tra più Stati: la defini-zione di programmi di misure unitari voltial raggiungimento degli obiettivi (punti 3 e4, art. 3). Allo stato attuale non ci sembrache i PTA regionali abbiano recepito questoimportante aspetto della Direttiva.
Sulla opportunità di attribuire la compe-tenza del Piano di tutela delle acque alleRegioni piuttosto che alle Autorità di Bacinosi dibatte da molti anni; secondo molti l’at-tribuzione di competenza alle Regioni rendedi fatto impraticabile il coordinamento neibacini nazionali e interregionali, secondoaltri, il livello di dettaglio delle elaborazionirichieste non permette, per bacini di grandidimensioni, l’elaborazione di un unicoPiano in capo all’Autorità di Bacino. Senzaentrare nel merito del conflitto di competen-ze, è probabile che una fase di coordinamen-to iniziale tra le Regioni sarebbe stata suffi-ciente a facilitare l’integrazione tra i PTA,semplicemente concordando procedure co-muni su alcuni aspetti:– le modalità di costituzione del quadro
conoscitivo, per poter disporre di unabase dati georiferita comune del bacinoidrografico;
– le modalità di valutazione ambientalestrategica, ed in particolare i criteri per lavalutazione degli obiettivi non definitidalla legge nazionale (come vedremo aiprossimi paragrafi sia il PTA della Lom-bardia che il PTA del Piemonte definisco-no criteri, diversi tra loro, per valutare lostato complessivo degli ecosistemi);
– i modelli per la previsione degli effetti: sisarebbe potuto concordare l’uso dimodelli comuni (tenuto conto che si trat-ta di strumenti da riutilizzare frequente-mente, quando, in fase di attuazione deiPiani, i programmi di misure vengonoaggiornati);
– una classificazione comune delle “tipolo-gie” di misure, così da poter avere un
quadro unico per tutto il bacino dellemisure previste dai diversi Piani e facili-tare così la valutazione della loro effettivaapplicazione;
– un protocollo di monitoraggio degli effet-ti dei Piani condiviso a scala di bacino (ebasato su una strategia unitaria a livellodi bacino del Po).Non è questo il luogo per valutare le mo-
tivazioni per cui tale coordinamento non èavvenuto, al di là di possibili implicazionipolitiche, è possibile “condividere” equa-mente le responsabilità considerato che:– era assente nel D.Lgs. 152/99 una specifi-
ca tecnica che richiedesse esplicitamentetale coordinamento preventivo (e vaanche sottolineata la assoluta genericitàdella descrizione dei contenuti del Pianodi tutela fornita dall’allegato 4 del De-creto, motivo per cui i PTA regionali sonouno diverso dall’altro);
– è mancata da parte dell’AdB la capacitàdi richiederlo, in funzione del fatto che iPTA erano stralci del Piano di bacino;
– le Regioni avrebbero potuto promuovereautonomamente tale coordinamento.
3.2.2. Gli obiettivi di qualità ambientale
L’individuazione dei corpi idrici per cuisono previsti obiettivi di qualità è legger-mente diversa nei due PTA, ma comunquecoerente con quanto previsto dalla Direttiva.
Per le acque sotterranee, il PTA Lombardiaindividua “aree acquifere omogenee”, suddi-vise in bacini idrogeologici, mentre il PTAPiemonte definisce tre distinte classi, all’in-terno delle quali comunque individua unitàcorrispondenti al bacino idrogeologico:1. aree idrogeologicamente separate dell’ac-
quifero superficiale;2. macroaree idrogeologiche di riferimento
dell’acquifero superficiale;3. macroaree idrogeologiche di riferimento
dell’acquifero profondo.Per le acque superficiali il PTA Lombardia
definisce obiettivi di qualità solo per i corpiidrici significativi, individuati seguendo leindicazioni del D.Lgs. 152/9910, e lascia ai
EuropAm
biente
89Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 89
Piani territoriali delle Province il compito didefinire obiettivi da raggiungere ed eventua-li misure specifiche per i corpi idrici nonsignificativi. Il PTA Piemonte invece fissaobiettivi di qualità, oltre che per i corpi idri-ci significativi, per altre due categorie dicorpi idrici:– corpi idrici che, per le loro caratteristiche
qualitative e quantitative, possono avereuna influenza rilevante sui corpi idricisignificativi;
– corpi idrici che, per valori naturalistici opaesaggistici, hanno rilevante interesseambientale.Gli obiettivi fissati da entrambi i Piani al
2016 – tralasciando gli obiettivi intermedi al2008 che sono fissati più per necessità for-mali, considerato che i Piani di Lombardia ePiemonte sono stati approvati definitiva-mente nel 2006 e nel 2007 – coincidono quasisempre con lo “stato buono” o con il mante-nimento, quando esistente, dello stato eleva-to. Fanno eccezione alcuni corsi d’acquasignificativi in Lombardia (i fiumi Olona,Lambro Settentrionale a valle della stazionedi monitoraggio di Lesmo, LambroMeridionale e Mella) e non significativi inPiemonte, alcuni laghi in condizioni trofichenaturalmente elevate in Lombardia e leacque sotterranee degli acquiferi superficia-li in Piemonte: per tutte queste acque si fissal’obiettivo sufficiente invece di buono. Ingenerale sembra di poter affermare cheentrambi i Piani interpretano correttamentelo spirito di puntare al “buono stato” ameno di forti condizioni limitanti, di cui si èdetto al paragrafo 3.1.2.
Sia il Piano della Lombardia che il Pianodel Piemonte si spingono oltre le prescrizio-ni del D.Lgs. 152/99 e definiscono – in parti-colare per i corsi d’acqua – metodi di caratte-rizzazione dello stato complessivo degli eco-sistemi in attuazione dei principi dellaDirettiva discussi al paragrafo 2.3: ne dare-mo conto nel paragrafo 3.2.3. Il migliora-mento delle condizioni degli ecosistemi flu-viali costituisce però un obiettivo del PTAsolo in Lombardia, mentre in Piemonte la“caratterizzazione ecosistemica” e più in ge-
nerale il complesso sistema di valutazioneintegrata sviluppato in sede di VAS non va acostituire un sistema di obiettivi del PTAstesso, né viene recuperato nell’impiantonormativo. Le norme del PTA Lombardia, nelcapo II, titolo III, definiscono gli obiettivi delPiano, riprendendo solo quelli riguardanti laqualità ambientale o per specifica destinazio-ne d’uso previsti dal D.Lgs. 152/99 ed inte-grandoli con obiettivi di riduzione del caricoinquinante già previsti da strumenti appro-vati precedentemente dall’AdB Po. Il PTALombardia però introduce, per i soli corsid’acqua, un obiettivo di miglioramento dellostato complessivo degli ecosistemi all’art. 43,dove riconosce che la “caratterizzazione e va-lutazione integrata” degli ecosistemi effettua-ta dal PTA (si veda allegato 13 del Piano)costituisce riferimento e indirizzo per la pia-nificazione territoriale e la programmazioneai diversi livelli di governo del territorio che,relativamente agli ambiti di competenza, con-corrono all’attuazione degli obiettivi di PTUAsecondo le modalità di seguito riportate:a) nei tratti individuati come “OK” si deve
provvedere a:– acquisire ed approfondire gli elementi
conoscitivi per una caratterizzazioneintegrata del corso d’acqua;
– valutare la congruenza delle misure, cheinteragiscono con i corpi idrici, con l’o-biettivo di preservare l’equilibrio ambien-tale evidenziato;
b) nei tratti individuati come “Rpot”:– acquisire e approfondire gli elementi
conoscitivi per una caratterizzazioneintegrata del corso d’acqua;
– valutare l’incidenza positiva delle misurepreviste, che interagiscono con i corpiidrici, con l’obiettivo di migliorare l’equi-librio ambientale evidenziato,
c) nei tratti individuati nella tavola come“KO” deve essere valutata prioritaria-mente la congruità degli interventi intra-presi con gli elementi di criticità indivi-duati al fine di promuovere azioni direcupero individuate come prioritarie.In sintesi quindi si può affermare che i
PTA di Lombardia e Piemonte interpretano
Euro
pAm
bien
te
90
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 90
correttamente lo spirito della Direttiva nelfissare obiettivi di qualità, entrambi cercanoinoltre di superare i limiti di recepimentoprevisti dal D.Lgs. 152/99 (vedi paragrafo3.1) introducendo elementi integrativi divalutazione biologica e idromorfologica,anche se solo la Lombardia traduce tali va-lutazioni in obiettivi che esplicitamente sipropone di raggiungere attraverso le misuredel PTA. Va tuttavia sottolineato che ilRegolamento per la tutela dei corpi idrici edegli ecosistemi connessi, che dovrebbeindicare le modalità degli interventi diriqualificazione, “con riferimento alla classi-ficazione indicata”, al contrario degli altriregolamenti attuativi previsti dal PTA, non èancora stato pubblicato.
Preso atto di questo, proviamo a farequalche considerazione sulla capacità dellemisure di raggiungere gli obiettivi. Ovvia-mente le considerazioni non possono cheessere preliminari e prive di riscontri ogget-tivi: solo tra qualche anno sarà possibilevalutare se le misure messe in campo sianoeffettivamente efficaci per raggiungere,entro il 2016, gli obiettivi. Eppure nell’ana-lizzare i PTA – e non solo quelli dellaLombardia e del Piemonte – si ha la perce-zione di una grande “distanza” tra obiettivimolto ambiziosi e misure/azioni decisa-mente troppo timide. Anche limitandosi allasola qualità dell’acqua, risulta difficileimmaginare che acque che si trovano dadecenni in stato scadente o sufficiente – no-nostante l’enorme investimento realizzatoin queste Regioni per ridurre il carico inqui-nante – riescano in pochi anni a raggiungerelo stato buono, senza cambiamenti profondinelle politiche idriche. Poiché è evidente cheil recepimento della Direttiva non significasolo fissare – correttamente – l’ambiziosoobiettivo buono su gran parte delle acque,ma anche attivare misure adeguate a rag-giungerli, riteniamo che le modalità con cuile misure previste dai PTA saranno attivatenei prossimi anni costituisca un campo diindagine e approfondimento di grande inte-resse. Riteniamo quindi utile fornire alcunispunti a riguardo, con valore puramenteesemplificativo.
Una misura su cui i PTA puntano moltoper migliorare la qualità delle acque superfi-ciali è l’aumento delle portate in alveo attra-verso l’applicazione del DMV. Ora, il rilascioin alveo di maggiori portate è legato alla pos-sibilità di ridurre i prelievi e quindi i consumiidrici, in particolare, nelle regioni del bacinopadano, in agricoltura: sulla riduzione deiconsumi agricoli il PTA del Piemonte puntamolto, anche in funzione di una specificaLegge regionale di riorganizzazione del setto-re irriguo (L.R. 21/99). Ciononostante le azio-ni operative ipotizzate – ad esempio per l’areadel basso Po – sono sostanzialmente dimiglioramento dell’efficienza dei sistemi diirrigazione, mentre risulta difficile immagina-re di riuscire a rispettare il DMV (Deflussominimo vitale) in mancanza di strategie voltea modificare significativamente gli ordina-menti colturali delle aree interessate dalla risi-coltura. A tal proposito è interessante notarecome nessuna Regione abbia incluso tra lemisure per la riduzione dei consumi agricolilo strumento più semplice ed immediato: l’in-nalzamento dei canoni, che oggi si aggiranosugli 0,001 centesimi a metro cubo, portando-li anche semplicemente ai livelli dei canoni aduso civile (0,05 centesimi a metro cubo).
Analogamente, per ridurre i prelievi sullefalde i PTA puntano sulla riduzione dei con-sumi idrici civili. Ora in Lombardia e Pie-monte tali consumi si aggirano su valori cheoscillano tra i 250 e i 400 litri/ab/giorno,dovuti a consumi domestici dell’ordine dei200 litri/ab/giorno, cui si aggiunge unaquota variabile di altri consumi (per attivitàeconomiche e servizi che si approvvigiona-no attraverso la rete acquedottistica). I 200litri/ab/giorno di consumi domestici sonogeneralmente considerati nella pianifica-zione idrica civile (Piani d’Ambito e primadi essi dai Piani degli acquedotti) come la“dotazione minima” necessaria. Eppurequesto valore è molto elevato: i consumidomestici in Austria e Germania sono infe-riori a 140 litri/ab/giorno, mentre l’uso dibuone pratiche come il riuso delle acque gri-gie depurate e la raccolta delle acque meteo-riche consentirebbero consumi domestici procapite inferiori a 100 litri/ab/giorno11. Per
EuropAm
biente
91Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 91
questo aspetto è interessante l’approccio delPTA Emilia Romagna: l’unico che ha fissatotra i suoi obiettivi anche una riduzione delconsumo domestico civile, indicato in 150litri/ab/giorno.
Un altro aspetto per cui le misure appaio-no poco convincenti è il risanamento dellefalde contaminate da nitrati (molto diffusesia in Lombardia che in Piemonte). Si nota, adesempio, come in Lombardia, siano stati fis-sati ovunque ambiziosi obiettivi di risana-mento delle acque di falda – tutte le faldedella Regione in stato buono entro il 2016 – afronte di misure che, per l’inquinamento dif-fuso, sono sostanzialmente limitate all’ado-zione dei Codici di buone pratiche agricole.
Per quanto riguarda la riduzione dei cari-chi puntiformi, nei PTA Lombardia e Piemon-te non si mette chiaramente in luce la rilevan-za dell’impatto dovuto agli sfioratori delle retifognarie miste. Tale rilevanza è invece eviden-ziata, ad esempio, dal PTA dell’EmiliaRomagna, ed appare ormai chiaro in granparte dell’Europa, in particolare per i bacinidove il completamento dei sistemi depurativiè più avanzato, che la quota maggiore del ca-rico inquinante di origine puntiforme è dovu-to agli sfioratori di piena. È presumibile cheanche su gran parte dei bacini di Lombardia ePiemonte la quota di carico proveniente daglisfioratori delle reti miste sia superiore al cari-co proveniente da reti non trattate o al residuosversato dai depuratori. È compito – per oradisatteso – del Piano di tutela evidenziare talesituazione e indirizzare i Piani d’Ambitoverso interventi che riducano l’impatto deglisfioratori (interventi a monte, per ridurre gliafflussi in fognatura, vasche di laminazione inrete per evitare gli sfiori o sistemi di tratta-mento per ridurne il carico inquinante12).
3.2.3. La classificazione dello stato dei corpiidrici
Come detto, le principali innovazioni del-la WFD sono relative alla classificazionedello stato ecologico dei corpi idrici superfi-ciali, e in particolare dei corsi d’acqua. Inquesto ambito sia il PTA Lombardia che ilPTA Piemonte non si limitano ad effettuare
una caratterizzazione dello stato dei corsid’acqua basata sugli elementi di qualità pre-visti dal D.Lgs. 152/99 (qualità fisico-chimi-ca delle acque e macroinvertebrati bentoni-ci) ma contengono analisi e tentativi di valu-tazione maggiormente integrati.
Il PTA Lombardia adotta uno schema diclassificazione13 che tiene in conto tutti gli ele-menti di qualità previsti dalla WFD (Allegato13, Caratterizzazione integrata dei corsi d’ac-qua e riqualificazione fluviale); in base adesso viene effettuata una zonizzazione deiprincipali corsi d’acqua naturali significativi,indicando dove “promuovere azioni di tute-la, riqualificazione e recupero”. Questa zoniz-zazione, come detto, è inserita nelle Normetecniche di attuazione del Piano (art. 42 e 43)e dovrebbe dunque avere valore attuativo,costituendo “riferimento e indirizzo per lapianificazione territoriale e la programmazio-ne ai diversi livelli di governo del territorioche, relativamente agli ambiti di competenza,concorrono all’attuazione degli obiettivi diPTUA”. Purtroppo la già menzionata assenzadel relativo regolamento attuativo (Regola-mento per la tutela dei corpi idrici e degli eco-sistemi connessi), ne limita, ad oggi, la possi-bilità di attuazione.
Anche il PTA Piemonte prevede un’attivi-tà di analisi e classificazione integrata che vaoltre le indicazioni del D.Lgs. 152/99, limita-ta però ad attributi legati alla vegetazioneriparia e alla componente geomorfologica.Analogamente a quanto effettuato per la clas-sificazione del PTA Lombardia, la metodolo-gia è ampiamente basata sulla fotointerpreta-zione. A differenza del PTA Lombardia, tutta-via, la classificazione integrata effettuata nonrientra tra le Norme di Piano, le quali - sebbe-ne nell’art. 33 (tutela delle aree di pertinenzadei corpi idrici) prevedano il mantenimentodella vegetazione ripariale presente - inclu-dono tra gli obiettivi di qualità ambientaleesplicitamente citati nell’art. 18 solo gli ele-menti previsti dal D.Lgs. 152/99.
3.2.4. L’analisi economica
In tabella 3 sono riportati sinteticamente irisultati di una verifica14 dell’aderenza dei
Euro
pAm
bien
te
92
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 92
due PTA regionali con quanto definito delleLinee Guida WATECO.
Per quanto riguarda la fase di caratteriz-zazione del bacino, risulta che nessuno deidue Piani abbia effettuato l’analisi sulla rile-vanza economica degli usi dell’acqua, men-tre è presente in entrambi l’analisi dei trendfuturi dei fabbisogni idrici dei principali set-tori economici.
Per quanto riguarda l’attuale livello dicopertura dei costi dei servizi idrici solo laRegione Lombardia ha effettuato la valuta-zione del livello di copertura dei costi del SII
attuale e futuro. L’analisi si è tuttavia limita-ta alla verifica della copertura dei costi indu-striali del servizio idrico integrato. È dasegnalare inoltre una valutazione dellasostenibilità sociale delle tariffe rispetto airedditi più bassi. Il Piano del Piemonte nonriporta alcuna analisi sul recupero dei costidei servizi idrici.
Per quanto concerne la valutazione dellemisure di Piano, l’analisi dei due PTA hamesso in evidenza che, in nessun caso, l’ana-lisi economica è stata utilizzata per valutarele misure e scegliere tra diverse alternative
EuropAm
biente
93Ga - 1/08
Tab. 3: Coerenza delle valutazioni economiche dei PTA regionali con i requisiti richiesti dalla WFD.
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 93
di intervento: non sono state condotte anali-si costi-efficacia, né costi-benefici sullepotenziali alternative.
Si segnala tuttavia che la Regione Lom-bardia ha effettuato un’analisi sugli impattieconomici sul settore idroelettrico a frontedell’applicazione del DMV.
Mancano infine, in entrambi i Piani, con-siderazioni su eventuali “costi sproporzio-nati” delle misure necessarie a garantire gliobiettivi di qualità, condizione necessariaper la richiesta di deroghe o di proroghe15.Infine, in relazione alle implicazioni finan-ziarie del Piano, il PTA piemontese si è limi-tato alla quantificazione degli investimentinecessari nei diversi anni di attuazione delPiano e alla identificazione dei canali difinanziamento (prevalentemente trasferi-menti Stato-Regione, fondi regionali genera-ti da canoni di concessione, flussi generatida gestione SII), tralasciando l’impatto dellemisure sui vari settori economici.
3.2.5. La partecipazione pubblica
La valutazione degli aspetti di partecipa-zione pubblica, ovvero di quanto la parteci-pazione sia effettivamente diventata una“prassi ordinaria di lavoro” nell’ambito deiPTA, è stata effettuata sia in relazione al per-corso che ha portato alla definizione del pro-getto di Piano e alla sua successiva adozionee approvazione, che ai modi previsti per lafase di attuazione.
Nella fase di elaborazione del progetto delPTA del Piemonte, è stato costituito un grup-po di lavoro interassessorile con il supportodell’ARPA Piemonte e del Politecnico diTorino, senza alcuna apparente condivisionecon i portatori d’interesse. Dopo l’approva-zione del progetto di Piano da parte dellaGiunta regionale, l’iter per l’adozione delPiano si è limitato alla “norma di legge”, cheprevede la consultazione del progetto diPiano e l’invio delle osservazioni dalle partiinteressate. Nella fase di consultazione èstato organizzato un incontro in ogni ATOdella Regione (in totale 6), nei quali le comu-nità locali sono state informate dell’inciden-za delle determinazioni del Piano sulle
diversificate realtà del proprio territorio esollecitate a prendere visione sia del Progettodi PTA che della corposa documentazionetecnica a corredo.
La Regione Lombardia ha apparentemen-te strutturato in modo maggiore la parteci-pazione dei portatori di interesse nella fasepreparatoria del Piano. È stato costituito unprimo gruppo di lavoro “istituzionale” com-prendente rappresentanti delle diverseDirezioni regionali, dell’ARPA, delle Ammi-nistrazioni provinciali e di altri enti pubblici,che ha lavorato dal 2001 al 2004. Nel periodo2003-2004 è stato costituito un secondo grup-po di lavoro comprendente i principali uti-lizzatori delle acque: gestori idroelettrici,consorzi di bonifica, consorzi di regolazionedei laghi, associazioni ambientaliste e altrecategorie di portatori d’interesse.
Per la fase di attuazione del Piano,entrambe le Regioni fanno esplicito riferi-mento ai “Contratti di Fiume e di Lago”. LaRegione Lombardia ha individuato sia nelleNorme tecniche di attuazione del PTA chenella L.R. 26/2003 sui servizi di pubblicautilità i Contratti di Fiume (così come i Con-tratti di Lago) come processi di gestione inte-grata fra i soggetti competenti e di sviluppodel partenariato funzionali all’avvio dellariqualificazione dei bacini fluviali. Dal cantosuo, anche la Regione Piemonte individua, tragli strumenti di attuazione del PTA previstidalle Norme tecniche di attuazione (Art. 10),il ricorso alle procedure negoziate e agliaccordi ambientali. Ad oggi la RegioneLombardia ha promosso tre Contratti diFiume: Olona-Bozzente-Lura, Seveso e Lam-bro, di cui i primi due sono già giunti alla fasedi “firma del contratto”, nella forma del-l’Accordo Quadro di sviluppo territoriale.Dopo queste prime esperienze il ruolo trai-nante della Regione sembra tuttavia essersinotevolmente ridotto16. Nella Regione Pie-monte sono invece stati avviati cinque Con-tratti di Fiume (Sangone, Belbo, Agogna,Orba e il recentemente avviato percorso rela-tivo alla Stura di Lanzo, oltre al Contratto diLago Viverone), promossi dalle singoleProvince, ma con il sostegno finanziario dellaRegione, la quale ha inoltre da poco attivato
Euro
pAm
bien
te
94
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 94
un tavolo di coordinamento per definire, inbase ai risultati dei contratti sperimentali incorso, una metodologia comune da adottareper i successivi, che dovrebbero riguardaretutti i rimanenti sottobacini significativi dellaRegione. Oltre ai percorsi citati ve ne sono poidiversi altri (si veda lo stato dell’arte riporta-to in tabella 4), che costituiscono attività preli-minari in vista dei contratti veri e propri, cheauspicabilmente dovrebbero realizzarsi inuna fase successiva.
Va tuttavia sottolineato che i percorsi par-tecipativi realizzati e in corso sono tra loromolto eterogenei e che, nonostante i citatiriferimenti normativi, il ruolo dei Contratti diFiume nell’ambito della pianificazione dibacino – e territoriale in generale – nel Bacinodel Po e in Italia (al contrario di altri Paesieuropei in cui è uno strumento ormai conso-lidato, in particolare in Francia17) è ad oggiancora molto incerto e fonte di dibattito.
L’analisi critica delle singole esperienzedi partecipazione a scala di bacino esula daquesto lavoro (oltre ad essere limitata daldiverso livello di avanzamento dei singolipercorsi); si possono tuttavia riportare alcu-ne considerazioni di carattere generale (inparte basate su quanto emerso dal semina-rio “Processi di riqualificazione dei sottoba-cini fluviali della valle del Po”, organizzatodall’Autorità di Bacino del Po a Parma il 31gennaio 2008). Nonostante i riconosciutieffetti positivi di queste esperienze, in parti-colare nella costruzione di reti di partenaria-to, nella facilitazione del dialogo tra diverseistituzioni e nel favorire nella popolazione ilrecupero di una “cultura del fiume” spessoandata perduta, le difficoltà incontrate sonomolteplici. La prima è dovuta alla non chia-ra definizione degli obiettivi del Contratto:uno strumento di attuazione di azioni giàdefinite dalla pianificazione in atto (comedichiarato nei PTA e di fatto interpretato daiprimi contratti lombardi), oppure uno stru-mento di pianificazione partecipata (inter-pretazione che sembra prevalere nella mag-gior parte delle altre esperienze)? E nelsecondo caso, il percorso partecipato ha loscopo di definire “vision” e Linee Guida ge-nerali (da recepire da parte della pianifica-
zione ordinaria), oppure di concordare azio-ni precise e contestualizzate nel territorio? Ilrapporto tra contratti e pianificazione (cosìcome per i percorsi di Agenda 21) appareancora sostanzialmente ambiguo, e in parti-colare quello con i Piani di gestione previstidalla Direttiva 2000/60: il Contratto diFiume costituisce il Piano di gestione parte-cipato previsto dalla Direttiva, ponendosiquindi come obiettivo primario il raggiungi-mento del buono stato ecologico (cercandosinergie con la riduzione del rischio idrauli-co e con altri obiettivi) oppure deve occupar-si di tutte le tematiche di pertinenza dellapianificazione territoriale? Non chiaro è poiil ruolo dell’Autorità di Bacino: deve defini-re obiettivi strategici di sottobacino, cheandrebbero a costituire vincoli per i singoliContratti di Fiume? Oppure la costruzionedel Piano di gestione è di fatto un’attività chetiene conto dei Contratti, ma sostanzialmen-te separata? Il rischio, in questo momento, èche i Contratti di Fiume si trasformino in unulteriore (debole) livello di pianificazione,sovrapposto ma non integrato con i Piani esi-stenti.
Il ridotto livello di cogenza è poi un limi-te evidenziato da molti, al pari della man-canza negli enti di strutture adeguate e conla formazione necessaria per gestire questiprocessi e della difficoltà di coordinamentotra diversi livelli amministrativi e pianifica-tori, spesso geograficamente “trasversali” albacino idrografico. Critica risulta poi la nonchiara individuazione dei fondi che dovreb-bero provvedere all’implementazione deiPiani d’azione risultanti dai processi parte-cipati, che rischiano di rimanere lunghi elen-chi di buone intenzioni destinate a rimanereirrealizzate, generando quindi sfiducia inquesto tipo di strumenti.
A nostro modo di vedere una maggiore epiù esplicita connessione dei Contratti diFiume con il percorso di implementazionedella Direttiva Quadro porterebbe, quanto-meno, ad una loro più agevole definizione.Risulta comunque evidente la necessità disviluppare in breve tempo Linee Guida con-divise, possibilmente a scala di bacinopadano.
EuropAm
biente
95Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 95
4. Conclusioni
Sulla base dell’analisi riportata, sembrapossibile concludere che, indipendentemen-te dal formale “recepimento” della Direttiva2000/60 nella normativa nazionale, i conte-nuti chiave della Direttiva sono entrati ingran parte, anche se con alcune importantieccezioni, nella pratica amministrativa ita-liana. Per quanto riguarda la normativa
nazionale le mancanze più gravi riguardanoi criteri di classificazione dello “stato” deicorpi idrici superficiali: l’impostazione pre-vista dalla Direttiva, che prevede la defini-zione dello stato in base a criteri biologici,chimico-fisici e idromorfologici appare soloparzialmente recepita, anche se, almeno pergli elementi biologici, potrebbe esseremigliorata in tempi brevi18. Particolarmentegrave sembra essere la mancanza di criteri
Euro
pAm
bien
te
96
Tab. 4: Stato dell’arte dei Contratti di Fiume e di Lago e dei processi partecipati preliminari ai contratti veri e propri realizzati oin corso in Lombardia e Piemonte.
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 96
geomorfologici per determinare il buonostato dei corsi d’acqua, in quanto impediscedi registrare il peggioramento dello statodelle acque dovuto a vari tipi di opereidrauliche e non incentiva il ricorso a strate-gie che integrino misure per il miglioramen-to degli ecosistemi e misure per la riduzionedel rischio idraulico; integrazione che avreb-be – nel lungo periodo – probabili beneficieconomici per tutta la società.
Per quanto riguarda l’attuazione delle po-litiche attraverso i Piani di tutela regionali,l’esperienza delle Regioni Lombardia ePiemonte mostrano, per alcuni aspetti, diaver anticipato il legislatore nazionale, inclu-dendo obiettivi di qualità non previsti dallanormativa nazionale (in particolare per i corsid’acqua). Gli aspetti più critici della pianifica-zione regionale sembrano essere: a) l’insuffi-cienza delle analisi economiche, che nonsembrano rispondere alle esigenze per cuierano state introdotte dalla Direttiva; b) ledifficoltà nel praticare la partecipazione pub-blica come strumento che faciliti, invece dirallentare, l’attuazione delle misure previsteper raggiungere gli obiettivi; c) l’insufficienza– per il momento solo “percepita” e quindi daverificare nel corso dell’attuazione dei Piani –delle misure previste, rispetto agli obiettivifissati dai Piani stessi.
Bibliografia
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, 2006. Studiodi fattibilità concernente lo sviluppo dell’anali-si economica dell’utilizzo idrico a scala di baci-no del fiume Po così come prevista dallaDirettiva 2000/60/CE, Parma.
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, 2007. Propostadi attività per l’implementazione della Direttiva2000/60/CE nel bacino fiume Po, Parma.
CANNATA P.G., 1994. Governo dei bacini idro-grafici: strumenti tecnici e pianificatori.Etaslibri, Milano.
CIRF, 2006. La riqualificazione fluviale in Italia.Linee Guida, strumenti ed esperienze pergestire i corsi d’acqua e il territorio.Mazzanti editore, Venezia.
ENVIRONMENT AGENCY, 1998. River habitat qua-lity. The physical character of rivers andstreams in the UK and Isle of Man (p. 84).Agency, Bristol: Environment.
EPSRC, 2001. River Habitat Survey, Engine-ering and Physical Sciences ResearchCouncil, UK (http://ncrfs.civil.gla.ac.uk/habitat.htm).
GAUMAND C., Lafitte J.J., 2005. Contrats derivière et de baie. Nouvelles modalités d’agré-ment e de financement, Ministère del’Ecologie et du Développement Durable.
GHETTI P.F., 1986. I macroinvertebrati nella sor-veglianza ecologica dei corsi d’acqua.Provincia Autonoma di Trento.
KARR J.R. E DUDLEY D.R., 1981. Ecological per-spective on water quality goals. Environ.Manag. 5 (1): 55-68.
KERN K., FLEISCHHACKER T., SOMMER M.,KINDER M., 2002. Ecomorphological survey oflarge rivers: monitoring and assessment ofphysical habitat conditions and its relevance tobiodiversity. Large Rivers, 3, 1–28.
MASSARUTTO A. E PESARO G., 1996. LaPianificazione di bacino come politica pubblica:il caso del Po, Quaderni di ricerca Iefe,Università Bocconi, Milano.
MASSARUTTO A., 2005. Partecipazione del pubblicoe Pianificazione del settore idrico, Documentopresentato nell’ambito del convegno: “Lapartecipazione pubblica nell’attuazionedella Direttiva quadro europea sulle acque,Università Bocconi, Aula Maggiore, Milano,30 maggio 2005 (www.iefe.unibocconi.it).
NAIMAN R.J.,DECAMPS H., POLLOCK M., 1993.The role of riparian corridors in maintainingregional biodiversity. Ecological Applica-tions 3: 209-212.
RIDDER D., MOSTERT E., WOLTERS H.A. (Eds.),2005. Learning Together to Manage Together –Improving Participation in Water Manage-ment, Harmonicop Project.
WATECO, 2003. Common ImplementationStrategy for the Water Framework Directi-ve (2000/60/EC) Economics and the envi-ronment, The implementation challenge ofthe Water Framework Directive, Guidancedocument no 1. Luxembourg. UE.
EuropAm
biente
97Ga - 1/08
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 97
Note
1 Negli anni ’80, si erano diffuse in tutti i Paesi europei i metodi di controllo biologico delle acque correnti (Karr & Dudley1981; Ghetti 1986), che mostravano l’inadeguatezza dei soli parametri fisico chimici a determinare il “buono stato” degli ecosi-stemi acquatici.
2 Uno degli autori del presente studio ha fatto parte del gruppo tecnico che ha elaborato il D.Lgs 152/99, che nel 1997 giàdisponeva di una bozza della “futura” Direttiva, da usare come “guida” per la stesura del decreto.
3 In ottemperanza dell’art. 17 della Direttiva 2000/60, nel 2006 è stata emanata una Direttiva “figlia”, ad essa strettamentecollegata: la 2006/118/CE, “sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”.
4 La fonte più autorevole sulla ”sustainable sanitation” è probabilmente il progetto “Ecosan”, promosso dal Governo tedesco conil supporto di molti altri partner in tutto il mondo http://www.gtz.de/ecosan/english/, ma sul tema si veda anche il gruppo spe-cialistico dell’International Water Association www.iwahq.org/templates/ld_templates/layout_633184.aspx?ObjectId=633923
5 Lo “stato delle acque superficiali” è l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dalvalore più basso del suo stato ecologico e chimico.
6 L’iter di revisione del “Codice ambientale” è, al momento della redazione di questo articolo (gennaio 2008), ancora in corso:il 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di D.Lgs recante modifiche alle norme inmateria di VIA/VAS, acque e rifiuti e, in quella occasione, il Ministro dell’ambiente ha annunciato un futuro decreto correttivocon ulteriori modifiche in tema di aria, acque e bonifiche.
7 In realtà, il ruolo dello Stato sulla materia si è progressivamente ridotto, essendo ormai passata alle Regioni la pianificazio-ne in materia sia di tutela delle acque che degli usi (concessioni di derivazione ed estrazione dal sottosuolo).
8 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, pag. 167.9 L’analisi fa riferimento al testo attualmente in vigore, non tiene conto delle modifiche proposte dalla Commissione presie-
duta dal Senatore Turroni.10 Sono considerati corpi idrici significativi: a) i corsi d’acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero
possieda una superficie maggiore di 400 kmq; b) i laghi naturali aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2 o supe-riore; c) i canali artificiali, affluenti di corsi d’acqua naturali, con portata di esercizio (intesa quale portata media dei mesi inver-nali) superiore a 3 m3/s; d) i serbatoi o i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che nepossano compromettere la qualità e aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 km2 o con volume d’invaso almeno paria 5 milioni di m3; e) le falde sotterranee della pianura lombarda, in quanto accumuli d’acqua di dimensioni significative e di gran-de estensione e continuità, permeanti la matrice litica e posti al disotto del livello di saturazione permanente.
11 Nel campo della riduzione dei consumi civili ha fatto notizia il recente Piano del Queensland Australiano, che punta aduna riduzione superiore all’80% http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=w21_december_2007
12 I sistemi di depurazione naturale (fitodepurazione) sono stati applicati con successo in questo campo e si stanno rapida-mente diffondendo in gran parte d’Europa. Interessante a questo proposito è lo Studio di fattibilità sull’uso dei sistemi naturaliper il trattamento degli sfioratori delle reti miste sui bacini del Lamino, Olona, Seveso in corso da parte di AdB Pohttp://www.adbpo.it/monitoraggio_aree/cartografiadati/SistemiNaturali_SeminarioMI%203Luglio07.
13 Il sistema di indicatori e indici adottato è stato in seguito modificato dal CIRF (indice FLEA, si veda CIRF, 2006) e imple-mentato a livello sperimentale in alcuni bacini fluviali, anche nell’ambito di progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo (TwoLee STRARIFLU Oglio).
14 L’analisi è stata condotta solo sui documenti accessibili via internet, anche per verificare l’accessibilità al Piano e agli studidi supporto.
15 Nei Piani sono presenti indicazioni sul mancato raggiungimento degli obiettivi al 2016, ma senza alcuna giustificazione,né tecnica né economica.
16 Va segnalata l’attività denominata “Patto per l’Acqua”, messa in campo nel 2007 dalla Regione Lombardia per cercare dicondividere un programma di azioni regionali per affrontare l’emergenza idrica, recuperare la qualità dell’acqua e mantenerlanel tempo. Nonostante il dichiarato intento di condivisione e partecipazione, tuttavia, numerose critiche sono state rivolte dapartecipanti ed esperti all’impostazione data al percorso. Ad oggi il Patto non è ancora stato sottoscritto dai partecipanti.
17 La procedura dei Contratti di Fiume in Francia, instaurata nel 1981, aveva come obiettivo principale di federare, attornoad un programma di lavori pluriennali imperniato su uno o più temi, l’insieme degli attori coinvolti nella gestione di un fiume.Dal 1992 la pianificazione delle risorse idriche in Francia è strutturata a due livelli, basata su due Piani: SDAGE (Piano direttivodi tutela e di gestione delle acque) e SAGE (Piano di tutela e di gestione delle acque). Lo SDAGE fornisce un quadro di riferi-mento con un valore giuridico per la diagnosi ed orientamento della politica dell’acqua per 15 anni a livello del bacino, stabili-sce gli orientamenti fondamentali della politica dell’acqua, prende in considerazione i principali programmi decisi dagli entipubblici e coordina le iniziative locali (SAGE). Con l’entrata in vigore della Direttiva Quadro Acque (WFD), e ora della Direttiva“Alluvioni” 2007/60/CE, lo SDAGE svolge il ruolo di Piano di gestione di bacino, ed in particolare volto a definire programmidi misure, in particolare misure di tipo regolatorio e di misure finanziarie incentivanti. Il SAGE è un documento di gestione conun valore giuridico che attua concretamente le raccomandazioni e strumenti definiti dallo SDAGE e coordina delle iniziative alivello del sottobacino. In questo nuovo contesto pianificatorio, i Contratti di Fiume rappresentano uno strumento di riferimen-to per applicare in maniera concreta le azioni previste dal SAGE (Gaumand e Lafitte., 2005).
18 Da alcuni anni, per iniziativa del Ministero dell’ambiente, e con il contributo di strutture tecniche quali APAT, IRSA-CNR,Università, sono stati attivati gruppi tecnici che stanno studiando i metodi per l’integrazione degli elementi biologici nelle pro-cedure di classificazione.
Euro
pAm
bien
te
98
08 CONTE.qxd 23/04/2008 7.43 Pagina 98