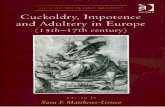Tradizione storica e rinnovamento politico. La cultura nel Litorale Austriaco e nell'Istria tra...
Transcript of Tradizione storica e rinnovamento politico. La cultura nel Litorale Austriaco e nell'Istria tra...
CIVILTAÁ DEL RISORGIMENTO
COLLANA DI SAGGI, TESTI E STUDI DEL COMITATO DI TRIESTE E GORIZIA
DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
A CURA DI GIULIO CERVANI E FULVIO SALIMBENI
85
ANTONIO TRAMPUS
TRADIZIONE STORICA
E RINNOVAMENTO POLITICO
La cultura nel Litorale Austriaco e nell'Istria
tra Settecento e Ottocento
DEL BIANCO EDITORE
PROPRIETAÁ LETTERARIA RISERVATA____________
# Copyright 2008 by Del Bianco Editore - Udine
Stampato in Italia - Printed in Italy
Tipolitografia « La Grafica » - Vago di Lavagno (Verona)
PREMESSA
Questo volume eÁ stato concepito come contributo alla riflessionesulla crisi dell'Antico Regime, sino all'etaÁ della Restaurazione, a par-tire da un contesto geografico da sempre posto ai confini tra aree lin-guistiche, economiche e sociali molto diverse tra loro. Nel corso degliultimi vent'anni la storiografia austriaca ha avuto il merito di appro-fondire molte indagini sul territorio, sull'amministrazione e sull'eco-nomia del Litorale Austriaco e dell'Istria in etaÁ moderna, individuan-do gli archetipi di queste regioni di frontiera e invitando a rinnovaregli studi su un'area che, tra Settecento e Ottocento, divenne un veroe proprio laboratorio di riforme politiche, di tolleranza religiosa, diesperienze linguistiche e di innovazioni amministrative 1. EÁ apparsoevidente che il Litorale Austriaco e l'Istria veneta, considerati all'in-terno delle compagini statuali cui storicamente appartennero, cioeÁ lamonarchia asburgica e la repubblica di Venezia, non rappresentanosoltanto un pur interessante caso di studio, ma offrono gli spunti perritornare sull'adeguatezza di categorie interpretative da tempo dibat-tute, quali il concetto di frontiera con i suoi significati e il dualismofra centro e periferia nella formazione dello Stato moderno 2.
5
1 K. VOCELKA, Glanz und Untergang der hoÈfischen Welt. RepraÈsentation, Reformund Reaktion im Habsburgischen VielvoÈlkerstaat, Ueberreuter, Wien 2001, pp. 14-23;si vedano poi in particolare i molti studi di Eva Faber nati da programmi di ricerca pro-mossi dall'UniversitaÁ di Graz, tra cui E. FABER, Litorale Austriaco. Das oÈsterreichischeund kroatische KuÈstenland 1700-1780, SteiermaÈrkisches Landesarchiv, Trondheim-Graz,1995; EAD., Vom Schicksalsverlauf einer Grenzregion in der Neuzeit am Beispiel Istriens,« Carinthia », 187 (1997), pp. 283-326.
2 I ritmi della discussione si possono cogliere attraverso E. FASANO GUARINI, Centro eperiferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli stati in etaÁmoderna? inG. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (a cura di), Origini dello Stato. Processi di forma-zione statale in Italia fra medioevo ed etaÁmoderna, il Mulino, Bologna 1994, pp. 147-176(traduzione inglese in J.J. MARTIN (a cura di), The Renaissance. Italy and abroad, Routled-ge, London 2003, pp. 189-104). Il caso francese eÁ documentato da D. NORDMAN, Fron-tieÁres de France. De l'espace au territoire XVIeÁme-XIXeÁme sieÁcle, Gallimard, Paris 1998.
A queste tematiche si affiancano le prospettive offerte dalla storiaculturale che, per quanto riguarda il Litorale e l'Istria, sono rimaste alungo soffocate da letture che collegavano finalisticamente l'etaÁ mo-derna a posteriori vicende economiche e politiche, lette sovente attra-verso il prisma dell'ascesa della borghesia o della contrapposizione tramodelli urbani e modelli rurali. Tuttavia anche da questo punto di vi-sta il quadro appare assai variegato e problematico, come se la mobi-litaÁ del confine geografico riflettesse le dinamiche altrettanto mobilidei fenomeni intellettuali, linguistici e politici. L'escussione sistemati-ca delle fonti d'archivio, che sta alla base di questa ricerca, vuole met-tere a nudo le radici settecentesche della cultura nel Litorale e nell'I-stria, mostrando in che misura saperi antichi continuarono a convive-re con saperi nuovi e, allo stesso tempo, quanto la forza propulsivadeterminata dallo sviluppo del porto franco di Trieste e dai mutamen-ti dell'economia istriana consentõÁ di innestare culture nuove, legate al-la pratica del commercio, nel ceppo antico della tradizione colta ederudita. Quanto piuÁ si moltiplicavano gli incontri fra idiomi, comuni-taÁ religiose e tradizioni diverse, tanto piuÁ cresceva la funzione media-trice della lingua e della cultura italiana. Per comprendere in che mo-do gli uomini di queste regioni vissero il passaggio dalla seconda metaÁdel XVIII secolo alla Restaurazione e per capire con quale animo par-teciparono alle grandi trasformazioni politiche del loro tempo, hoscelto di privilegiare lo studio delle pratiche culturali, ricostruendo ipercorsi della sociabilitaÁ accademica, delle presenze massoniche, delladiffusione e della circolazione del libro, della nascita del giornalismo,della vita musicale e teatrale e di altre strategie di consumo culturalediffuse nella seconda metaÁ del XVIII secolo.
Per una fortunata coincidenza, la prima edizione di questo libroapparve nel 1990 contemporaneamente all'ultimo volume del Sette-cento riformatore di Franco Venturi 3, dedicato ad uno straordinario
6
Per lo spazio asburgico cfr. G. WALTER-KLINGENSTEIN, Was bedeuten `̀ OÈsterreich'' und`̀ oÈsterreichisch'' im 18. Jahrhundert?, in R.G. PLASCHKA, G. STOURZH, J.P. NIEDERKORN
(a cura di),Was heiût OÈsterreich? Inhalt und Umfang des OÈsterreichbegriffes vom 10. Jahr-hundert bis heute, OÈ sterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1995.
3 F. VENTURI, Settecento riformatore, V/2, La Repubblica di Venezia (1761-1797),Einaudi, Torino 1990.
affresco della morente Repubblica di Venezia, all'interno del qualeper la prima volta la storia dell'Istria e della Dalmazia veniva restitui-ta alla cultura italiana dell'etaÁ dei lumi. Gli anni trascorsi hanno con-sentito non soltanto la maturazione di molte riflessioni avviate conqueste ricerche, ma anche l'approfondimento di alcuni temi partico-larmente legati allo svolgersi del dibattito storiografico, che hannoformato oggetto di discussione e di confronti con studiosi italiani estranieri. Numerose ipotesi di ricerca, che nel 1990 erano state solotracciate, sono state poi da altri riprese, discusse e approfondite ar-ricchendo un quadro per molti aspetti affascinante. Di tutto questoho tenuto conto, grazie anche alla generosa disponibilitaÁ della Presi-denza del Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la Storia delRisorgimento italiano che mi ha consentito di riproporre il lavoro inuna versione ampiamente rielaborata e aggiornata.
7
PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE
Partito da Graz il 12 agosto 1728, Montesquieu inizioÁ il primoviaggio in Italia attraverso Lubiana, capitale della Carniola, costeggian-do il Litorale Austriaco, a settentrione della penisola istriana, per giun-gere nella contea di Gorizia e di Gradisca prima di entrare in terra ve-neta. In pochi giorni attraversoÁ , seguendo il consueto itinerario deiviaggiatori provenienti dal centro della monarchia, buona parte deidomini ereditari austriaci presso l'Adriatico. AnnotoÁ brevi osservazio-ni sulla natura dei luoghi; consideroÁ l'importanza degli interventi sulterritorio, in particolare delle strutture viarie, promossi dallo Statoasburgico: «On peut dire qu'il est impossible de traverser ces pays[...] et de voir les chemins, les ponts, les chausseÂes » ± osservoÁ ± « sansavoir de l'admiration pour le prince qui a fait ces ouvrages, et avoirbonne opinion d'un gouvernement ouÁ il y a une si bonne police » 1.
Il rapido passaggio non gli consentõÁ peroÁ soste apprezzabilmentelunghe nelle principali cittaÁ della regione, ne gli permise di cogliereosservazioni piuÁ precise sulla popolazione, sulle attivitaÁ economicheo sulla vicina terra istriana. Rimase tuttavia l'impressione favorevolesulla « si bonne police » del principe asburgico, indizio di una signi-ficativa attenzione per la politica sovrana e, in qualche misura, per ilrapporto fra governanti e governati, valutabile anche oggettivamentedall'esame dei servizi pubblici ed economici.
Le osservazioni di Montesquieu risalgono agli anni in cui nei do-mini ereditari austriaci sulla costa marittima si videro i primi segni diaffrancamento dai retaggi tardomedioevali nelle attivitaÁ economiche,nelle opere pubbliche, nelle manifestazioni della cultura. Furono for-
8
1 Cito da MONTESQUIEU, Voyage de Gratz aÁLa Haye in ID., Oeuvres compleÁtes, textepreÂsente et annoteÂe par R. CALLOIS, I, Gallimard, Paris 1985, p. 545; per la tr. it. cfr.MONTESQUIEU, Viaggio in Italia, a cura di G. MACCHIA e M. COLESANTI, Laterza, Ro-ma-Bari 1990, pp. 3-4.
me varie di un medesimo movimento riformatore operante nell'am-ministrazione dello Stato, di un rinnovamento politico proseguito ne-gli anni che pote influire nello stesso tempo sulle attivitaÁ economichee sulle forme della cultura.
Tradizione storica e rinnovamento politico sono concetti appa-rentemente incompatibili nell'assolutezza dei termini generali eastratti. E allo stesso modo potrebbero sembrare inconciliabili in va-rie manifestazioni dell'attivitaÁ umana. Invece, nello sviluppo dellesensibilitaÁ culturali, delle relazioni sociali ed economiche nel LitoraleAustriaco e nell'Istria (veneta ed austriaca), apparvero costantementein rapporto di reciproca influenza, con soluzioni mediate e talvoltacontraddittorie. Questi stessi esiti, per determinati motivi storici epolitici, si manifestarono ancora nel primo Ottocento. PiuÁ volte in ta-li vicende, ma senza episodi traumatici, i tradizionali rapporti socialie culturali si invertirono.
Nel Litorale non vi fu posto per una Rivoluzione francese: la for-za della borghesia si era consolidata giaÁ alla metaÁ del Settecento e nel-le prime occupazioni militari (1797, 1805) i francesi furono trattaticon diffidenza, se non con ostilitaÁ . Nell'Istria veneta i princõÁpi ideali-stici trovarono accoglimento in pochi intellettuali, ma venne a man-care la base sociale che potesse garantirne la realizzazione. Il rinno-vamento politico fu la forza dirompente della tradizione storica,che paradossalmente da esso trovoÁ rinvigorimento. I figli della tradi-zione, delle consolidate esperienze sociali e culturali, trovarono occa-sioni di confronto e nuova forza nel rinnovamento politico: i figli delrinnovamento e dei nuovi ordini sociali seppero, allo stesso tempo,rileggere e valorizzare la tradizione storica.
Per tali riguardi l'attenzione va rivolta al Litorale Austriaco e al-l'Istria e in questa prospettiva critica si possono individuare elementidi originalitaÁ . Il Litorale fu la base territoriale progressivamente indi-viduata e plasmata dall'amministrazione dello Stato nel Settecento,comprendente in origine la regione fra Aquileia, Trieste (con il suoretroterra fino alla Carniola), Porto Re 2 fino a Carlopago 3, cui fu
9
2 Oggi Kraljevica in Croazia.3 Oggi Karlobag in Croazia.
in seguito aggiunta la contea di Gorizia e di Gradisca. L'Istria invece,distinta prima in territorio veneto (costiero) e territorio austriaco (in-terno), poi ± dopo il 1797 ± interamente austriaca, divenne in perio-do napoleonico provincia autonoma con capoluogo Trieste. Il Lito-rale Austriaco e l'Istria dopo la Restaurazione, fino al 1822, trovaro-no poi unitaÁ nel Regno austriaco d'Illiria, comprendente Gorizia eGradisca, la Carsia con Trieste, l'Istria giaÁ veneta, l'Istria austriacae la Croazia civile fino alle isole del Quarnero 4.
Le denominazioni Litorale Austriaco e Istria sono quindi tra lepoche espressioni geografiche, storicamente fondate, che consento-no un'identificazione complessiva delle regioni orientali dell'altoAdriatico e che, in senso delimitativo e sufficientemente preciso, ri-spettano la storia della cultura e delle culture tra Settecento e Ot-tocento. Diversamente, si avverte l'imbarazzo degli studiosi nel vo-lere adattare altre indicazioni geografiche a terre che oggi, per vi-cissitudini politiche passate e recenti, appartengono a Stati diffe-renti, Italia, Jugoslavia 5 e anche Austria. Mentre invece la quantitaÁe la varietaÁ delle relazioni storiche danno conferma della continui-taÁ geografica e culturale tra le civiltaÁ di lingua italiana, slovena etedesca.
Invero, nessuna delle numerose espressioni geografiche ideate inetaÁ moderna e contemporanea sembra soddisfare appieno questi ca-ratteri e tutte lasciano escluse una o piuÁ civiltaÁ culturali o aree geo-grafiche: ne Venezia Giulia, regione Giulia o Marca Giulia, ne Friuliorientale o Litorale illirico, ne Carniola o Istria veneta e austriaca. Amaggior ragione, quindi, si puoÁ ricorrere ai termini Litorale Austria-co e Istria cui tra l'altro corrisponde oggi in apprezzabile misura la
10
4 Per la storia delle varie espressioni geografiche e dei lineamenti istituzionali e am-ministrativi cfr. E. SESTAN, Venezia Giulia. Lineamenti di storia etnica e culturale, Edizio-ni Italiane, Roma 1947, pp. 125-128; G. CERVANI, Il Litorale Austriaco dal Settecento alla« Costituzione di dicembre » del 1867, Del Bianco, Udine 1979; ID., Maria Teresa e Trie-ste. Il Litorale Austriaco come provincia storica, «Quaderni Giuliani di Storia », I, 2(1980), pp. 33-53; U. COVA, Note per una storia delle istituzioni amministrative della re-gione Friuli-Venezia Giulia, C.D.C., Udine 1986.
5 Oggi le repubbliche di Slovenia e di Croazia.
rappresentazione geografica, economica, culturale e politica tran-sfrontaliera della ComunitaÁ di Lavoro «Alpe Adria » 6.
Questo eÁ inoltre l'orientamento storiografico che ha consentito lapubblicazione, per cura dello SteiermaÈrkisches Landesarchiv diGraz, di un primo censimento delle fonti per la storia delle istituzioniamministrative del territorio. Il volume trilingue (tedesco, sloveno eitaliano) HandbuÈcher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den LaÈn-dern KaÈrnten, Krain, KuÈstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918(= Manuali e carte sulle strutture amministrative delle province di Ca-rinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918) riguarda proprio quellaparte degli Stati ereditari che per tutto il Settecento ebbe la denomi-nazione complessiva di InneroÈsterreich, cioeÁ Austria Interiore 7.
CosõÁ si possono ricostruire le basi dei rapporti culturali e sociali,cosõÁ pure si possono intendere e discutere i punti nodali e problema-tici degli argomenti cui si riferiscono i capitoli di questo volume.
La storiografia moderna ha trascurato fino a tempi recenti nonpochi elementi essenziali di questo ampio quadro, per ragioni di op-portunitaÁ storica o politica, per impossibilitaÁ contingenti, per l'arre-tratezza degli studi in determinati settori, eccettuati pochi spunti nel-l'erudizione locale. Ne la ricerca e lo studio delle fonti, a parte alcuneinteressanti novitaÁ degli ultimi decenni, hanno portato contributi ul-teriori alla chiarificazione scientifica della storia culturale in questeregioni. In tale situazione, una storia della cultura nel Litorale Au-striaco e nell'Istria tra Settecento e Ottocento puoÁ essere fornita soloper sintesi generiche o per indagini esemplificative dei problemi sto-rico-culturali piuÁ rilevanti, secondo un orientamento di ricerca coe-rente e unitario. I capitoli di questo volume, che riprendono e svilup-
11
6 EÁ stata costituita nel novembre 1978, originariamente tra le regioni Friuli-VeneziaGiulia, Veneto, Carinzia, Austria superiore, Stiria, Croazia, Slovenia, per il coordina-mento delle attivitaÁ transfrontaliere e la soluzione dei problemi comuni riguardanti lecomunicazioni, le infrastrutture, l'energia, il patrimonio naturale e culturale. Nel corsodegli anni, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino (1989) il numero delle regioniche vi aderiscono eÁ notevolmente aumentato e si sono allargate anche le attivitaÁ ; cfr.www.alpeadria.org.
7 J. ZÏ ONTAR (a cura di), HandbuÈcher und Karten zur Verwaltungsstruktur in denLaÈndern KaÈrnten, Krain, KuÈstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918, SteiermaÈrki-sches Landesarchiv, Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste 1988.
pano analoghi interventi apparsi in diverse sedi a partire dal 1984, siriferiscono essenzialmente al secondo e piuÁ ampio obiettivo sopra in-dicato, nell'intento pure di proporre nuovi orientamenti di ricerca.
Nella citazione delle fonti a stampa, anche anteriori al 1800, eÁstato rispettato fedelmente il testo originale, seppure in presenza diparticolaritaÁ ortografiche e sintattiche. Nella citazione dei manoscrittisono stati seguiti i consueti criteri di trascrizione accolti in Italia, conattenzione per le indicazioni, riferibili alle fonti manoscritte in gene-rale, proposte nelle Norme per l'edizione del carteggio muratorianodel Centro di studi muratoriani di Modena (1989) e negli atti delconvegno su Metodologia ecdotica dei carteggi tenuto in Roma nel1980, editi nel 1989. Diversamente, talvolta altri criteri di trascrizio-ne si sono resi necessari per uniformitaÁ con edizioni internazionali dideterminati fondi archivistici omogenei (per esempio, nel caso dell'e-pistolario di Giacomo Casanova). Di tali casi eÁ data opportuna avver-tenza in nota.
[1990]
NOTA ALLA NUOVA EDIZIONE
I risultati di queste ricerche, in particolare di quelle sulla figura e sul diario
di Karl von Zinzendorf e sulla dinamica statale austriaca in cui si collocano le
vicende del Litorale, non sarebbero stati possibili senza l'appoggio finanziario
della Kommission fuÈ r Neuere Geschichte OÈ sterreichs e senza la disponibilitaÁ
del suo presidente Fritz Fellner e di Grete Klingenstein, che desidero sincera-
mente ringraziare. In un'epoca nella quale la ricerca scientifica ed universitaria
continua ad essere gravemente penalizzata nelle strutture e nelle risorse econo-
miche ho avuto anche la fortuna di poter proseguire molti studi sul Settecento
europeo partecipando con continuitaÁ ± a partire dal 1993 ± a programmi di ri-
cerca di rilevante interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'UniversitaÁ e
della Ricerca (giaÁ MURST ± Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e giaÁ MIUR ± Ministero dell'Istruzione, UniversitaÁ e Ricerca) e coordinati
nel tempo da Giuseppe Ricuperati, Antonio RotondoÁ e Vincenzo Ferrone.
12
Molto devo al confronto e alle discussioni con persone cui va la mia gra-
titudine: in particolare gli amici Fulvio Salimbeni, ora all'universitaÁ di Udine e
Ivano Cavallini, ora all'universitaÁ di Palermo, con i quali ho condiviso lunghe
discussioni e gran parte della mia crescita culturale; Grete Klingenstein, Elisa-
beth Garms-Cornides e Eva Faber, assieme ai colleghi dell'Institut fuÈ r Ge-
schichte nella Karl-Franzens-UniversitaÈt di Graz, con cui ho vissuto l'avventura
del progetto per l'edizione dei diari del conte Karl von Zinzendorf; Giulio Cer-
vani, professore emerito all'universitaÁ di Trieste, e Maria Rosa Di Simone, ora
all'universitaÁ di Roma Tre, che mi hanno seguito nella formazione giovanile e
nella maturazione di queste riflessioni.
Numerose parti di questo volume hanno tratto vantaggio dalle discussioni,
avvenute nel corso degli anni in piuÁ occasioni, con amici e colleghi. In partico-
lare il mio debito eÁ grande nei confronti di Michela Messina e di Tullia Catalan,
che con pazienza e disponibilitaÁ hanno interamente riletto il lavoro, in vista di
questa nuova edizione, aiutandomi a correggere errori e imperfezioni. Renzo
Arcon, Maria Grazia Bravar, Ugo Cova, Pierpaolo Dorsi, Adriano Dugulin,
lo scomparso Mons. Luigi Parentin, Anna Rosa Rugliano, Otello Silvestri, Gra-
zia TatoÁ , Maria Carla Triadan hanno reso piuÁ agevole la frequentazione degli
archivi di Trieste e Gorizia affidati alle loro cure. Pierre-Yves Beaurepaire, Ser-
gio Bonazza, Furio Luccichenti, Helmut Watzlawick mi hanno comunicato no-
tizie e materiali utili per approfondire le ricerche. Infine desidero ricordare Elio
Apih, per le osservazioni che volle riservare alla prima versione del testo, e la
contessa Paola Rossetti de Scander, che con grande generositaÁ mi consentõÁ di
accedere e lavorare nell'archivio di famiglia. Ringrazio inoltre l'Istituto Giulia-
no di Storia, Cultura e Documentazione, nella persona del Presidente Prof. Ti-
no Sangiglio, che giaÁ ospitoÁ nelle sue collane la prima edizione di questo volu-
me, per averne acconsentito la ripubblicazione, in forma integralmente rivista e
ampliata.
Devo a mia madre Rita e Lucy D'Urso, da sempre le mie prime lettrici,
molte osservazioni utili al miglioramento del lavoro; a mia moglie Martina
non solo un aiuto fondamentale per la trascrizione e revisione del testo origina-
rio, ma anche un appoggio totale ed entusiasta. Il volume eÁ dedicato, com'era
giaÁ nella prima edizione, alla memoria di Cesare Pagnini (1899-1989), editore
degli scritti di Lorenzo Da Ponte, studioso di Giacomo Casanova e Johann Joa-
chim Winckelmann e maestro di ricerche sul Settecento giuliano.
Rispetto alla prima edizione questo volume appare ampiamente rielabora-
to ed aggiornato. I documenti originariamente pubblicati nel testo sono stati
13
riuniti nell'appendice. Alcuni capitoli raccolgono anche integrazioni e appro-
fondimenti pubblicati nel corso degli ultimi anni in diverse sedi italiane e stra-
niere:
± il capitolo I comprende anche i saggi L'etaÁ moderna, in F. Stener (a cura di),
Rovigno d'Istria, vol. I, Famia Ruvignisa, Trieste 1997, pp. 119-128 e L'accade-
mia, l'arcadia e la figura di Tarsia, in «MuzikolosÏki zbornik / Musicological An-
nual », XXX, Ljubljana 1994, pp. 29-33.
± il capitolo II nasce dalla rielaborazione dei saggi Die GruÈndung einer neuen
Stadt. Aufbruchsstimmung im Triest des 18. Jahrhunderts, «Das achtzehnte
Jahrhundert und OÈ sterreich », 11 (1996), pp. 47-54 e I privilegi antichi e
le libertaÁmoderne: la cultura triestina tra Settecento e Ottocento, in M. GIRAR-
DI, P. DA COL (a cura di), Attorno al palcoscenico, Arnaldo Forni Editore,
Bologna 2001, pp. 1-38.
± il capitolo IV eÁ stato pubblicato con il titolo Carriere professionali nel Litorale
Austriaco. La formazione del funzionario in etaÁ teresiana, in B. MAZOHL-
WALLNIG e M. MERIGGI, OÈsterreichisches Italien - Italienisches OÈsterreich? In-
terkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhun-
dert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, Verlag der OÈ sterreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, Wien 1999, pp. 349-368.
± il capitolo V nasce dalla rielaborazione dei saggi Karl von Zinzendorf tra Ma-
ria Teresa e Giuseppe II, «Quaderni Giuliani di Storia », IX, 1-2 (1993), pp.
45-55; Dalla storia delle idee alla storia della musica: il diario del conte Zinzen-
dorf come fonte per una ricerca interdisciplinare, « Recercare », V (1993), pp.
153-169; Economia e stato delle riforme nel Litorale Austriaco dal diario del
conte Zinzendorf (1771), « Archeografo Triestino », s. IV, L (1990), pp.
67-106; Kaunitz und das Litorale Austriaco, in G. KLINGENSTEIN, F. A. J. SZA-
BO (a cura di), Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711-1794.
Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europaÈischen AufklaÈrung, An-
dreas Schneider Verlagsatelier, Graz-Esztergom-Paris-New York 1996, pp.
261-265; All'orizzonte degli slavi del sud: Sigismondo Zois e Karl von Zinzen-
dorf, «MuÈnchner Zeitschrift fuÈ r Balkankunde », 9 (1993), pp. 45-52.
± il capitolo VIII comprende anche i saggi Dal cosmopolitismo europeo al co-
smopolitismo triestino: convergenze o divergenze?, apparso in I. CAVALLINI
(a cura di), Itinerari del classicismo musicale. Trieste e la Mitteleuropa, Libre-
ria Musicale Italiana, Lucca 1992, pp. 81-93; Settant'anni di attivitaÁ storiogra-
fica di Cesare Pagnini, «Quaderni Giuliani di Storia », IX, 2 (1988), pp. 257-
270, e poi come appendice alla prima edizione di questo volume; La circola-
14
zione delle `Turbolenze di Polonia' a Trieste nei secoli XVIII e XIX, « L'Inter-
meÂdiaire des Casanovistes », VIII (1991), pp. 32-33; Johan Meerman sulla via
dell'Italia (1791): il soggiorno triestino, « Incontri. Rivista di studi italo-neer-
landesi / Tijdschrift voor ItalieÈ-Studies », 7 (1992), pp. 31-38; Storia della cul-
tura e storia della storiografia: la `Trieste letterata' di Lorenzo Miniussi, «Qua-
derni Giuliani di Storia », XII, 1-2 (1991), pp. 63-71.
± il capitolo XI comprende anche il saggio La censura austriaca dal Veneto alla
Dalmazia della Restaurazione, apparso in «Atti e memorie della SocietaÁ dal-
mata di storia patria », n.s. XV (1992), pp. 117-124.
± il capitolo XII eÁ stato pubblicato con il titolo Czoernig, le riforme e la storia
dell'amministrazione fiscale a Trieste nel volume Karl Czoernig fra Italia e Au-
stria (Atti del convegno di studio nel centenario della morte, Gorizia 15 di-
cembre 1989), Istituto di Storia sociale e religiosa, Gorizia 1992, pp. 151-166.
± il capitolo IX della prima edizione, dedicato a La discussione storiografica sul
Litorale Austriaco e sull'Istria nell'opera di Cesare Pagnini, eÁ confluito all'in-
terno del capitolo VIII, senza l'appendice bibliografica. La bibliografia degli
scritti a stampa di Pagnini (1918-1988) eÁ reperibile, oltre che in quell'edizio-
ne, anche in A. TRAMPUS, Settant'anni di attivitaÁ storiografica di Cesare Pagni-
ni, «Quaderni Giuliani di Storia », IX, 2 (1988), pp. 257-270.
ABBREVIAZIONI:ADTs Trieste, Archivio diplomatico
AmC Capodistria (Koper), Archivio antico municipale
ASTs Trieste, Archivio di Stato
ARS Trieste, Archivio dei conti Rossetti de Scander
ASCTs Trieste, Archivio storico del Comune
ASVe Venezia, Archivio di Stato
BCTs Trieste, Biblioteca Civica «Attilio Hortis »
CMSA Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte
FSA Trieste, Fondazione Giovanni ScaramangaÁ di Altomonte
HA Zadar, Historijski Archiv
HHStA Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
KB Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
NA Den Haag, Nationaal Archief
StA Antwerpen, Stadsarchiev
StOA Praha, Sta tnõ Oblastnõ Archiv
15
I domini asburgici dell'Austria Interiore, con Trieste e la regione immediatamente
circostante (il Litorale Austriaco), nella seconda metaÁ del XVIII secolo (rielabo-
rato da E. FABER, Litorale Austriaco. Das oÈsterreichische und kroatische KuÈsten-
land 1700-1780, Graz-Trondheim 1995, p. 262).
16
I. - I LUMI IN ARCADIA. PER UNA STORIA DELLA CUL-TURA NELL'ISTRIA E NEL LITORALE AUSTRIACOTRA SEICENTO E SETTECENTO
Agosto 1792: nella sala dell'accademia capodistriana dei Risorti ilsecolo morente ± e l'etaÁ moderna stessa ± viene congedato dagli eru-diti istriani con il piuÁ angoscioso degli interrogativi, oggetto di unconcorso letterario: quale eÁ stato veramente il carattere specificodel secolo diciottesimo? Quale deve diventare il ruolo degli intellet-tuali « in tempi per noi sõÁ felici quanto altrove funesti per gravissimiavvenimenti »? Risponde Gian Paolo Polesini da Montona: la ragionedel nostro operare eÁ ridotta allo spirito del commercio. RispondeAlessandro de Gavardo di Capodistria: « oppressa umanitaÁ dal crudotelo d'insana ambizion [...] guerre, dissidi, torbidi progetti [...] ecco-vi la moral de' giorni nostri » 1.
Quale che fosse la spontaneitaÁ di queste apocalittiche visionicontrorivoluzionarie, gli eruditi istriani di fine Settecento preferivanorivolgere lo sguardo verso un rassicurante passato, piuÁ che verso unfuturo incerto. E l'intensitaÁ di questo sguardo e dei sentimenti che neerano alla base era maggiore a Capodistria rispetto a Parenzo e a Po-la, mentre minore era in Istria rispetto agli altri domini veneti la ten-
17
1 B. ZILIOTTO, Accademie e accademici di Capodistria (1478-1807), « ArcheografoTriestino », s. IV, VII (1944), pp. 237-241.
sione riformatrice e meno vivace la discussione tecnico-politica ri-spetto alla realtaÁ contemporanea 2.
Come a Capodistria, a Parenzo e a Pola, anche nella vicina Ro-vigno ci fu chi andoÁ ad interrogare il passato nel tentativo di rico-struire l'ordine infranto; cosõÁ in oltre mille pagine manoscritte, Anto-nio Angelini collezionoÁ le Notizie storiche di Rovigno in ordine crono-logico dal 1400 al 1797 caduta della Repubblica di Venezia 3, co-minciando il suo narrare dal 1401, anno della restituzione del corpodi Sant'Eufemia alla Chiesa di Rovigno. Mentre Bartolomeo Vergot-tin, dall'osservatorio parentino, glorificava la comunitaÁ di Rovignointerpretando in chiave profetica i significati simbolici dello stemmacittadino 4.
Dal punto di vista storiografico, la situazione istriana eÁ tipica diuna realtaÁ per la quale, pur vantando una solida tradizione storico-erudita, al distacco cronologico dagli avvenimenti non eÁ generalmen-te corrisposto, fino ai nostri giorni, un completo affrancamentoscientifico dalle passioni politiche che hanno accompagnato le vicen-de tragiche di quella terra; tanto da portare inevitabilmente a vuotistoriografici e alla fiducia sulle presunte certezze offerte da un patri-monio di conoscenze giaÁ acquisito e ormai invecchiato. CosõÁ eÁ avve-nuto per la storia di molte cittaÁ istriane e, ad esempio, per il caso diRovigno, dove la piuÁ completa storia cittadina eÁ rimasta per lungotempo quella pubblicata da Bernardo Benussi nel 1888 5. Ed eÁ tipicodi queste ricostruzioni ottocentesche della storia istriana il fatto diconcepire la narrazione dell'etaÁ moderna essenzialmente come storiaveneta ± oltre a tutto con significative omissioni che riguardano so-
18
2 VENTURI, Settecento riformatore, V/2, cit., p. 427. A Venturi si deve il merito diaver reintrodotto, con queste pagine, la cultura dell'Istria nel contesto storiograficodel Settecento riformatore veneto e italiano.
3 G. RADOSSI, A. PAULETICH, Compendio di alcune cronache di Rovigno di AntonioAngelini, « Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno », VI (1975-1976), p. 253.
4 B. VERGOTTIN, Della antica origine, successive vicende ed attuale stato di Rovigno,esame storico [1798], « Archeografo Triestino », s. II, I (1869), p. 237.
5 B. BENUSSI, Storia documentata di Rovigno [1888], nuova edizione a cura di G.GERVANI, UniversitaÁ Popolare di Trieste, Trieste 1977; solo recentemente ad essa si sonoaffiancati i due volumi collettanei curati da F. STENER, Rovigno d'Istria, Famia Ruvignisa,Trieste 1997.
prattutto la storia dei ceti subalterni e dei gruppi slavi 6; anche se ilrapporto con la Dominante poi in realtaÁ si riduce ad una presenzameramente cronologica e il primato dell'esperienza veneta eÁ solo ap-parente dinanzi alla dimensione della piccola grande patria. Nel casorovignese, il governo e la presenza veneziani nella cittaÁ sono trattatiin una dozzina di pagine per ben cinque secoli di storia, quantitati-vamente assai meno rispetto allo spazio riservato alle vicende piuÁ an-tiche del dominio dei patriarchi di Aquileia o a quelle del libero Co-mune medioevale. Tutta la successiva descrizione delle « condizioniinterne » della cittaÁ dal 1283 al 1797, nonostante la profusione di da-te e di dettagli cronologici, sfuma sostanzialmente in una dimensionesenza tempo, per rientrare bruscamente nel fluire della storia con lacaduta della Serenissima. Si tratta certo di un genere particolare distoria politica, nella quale peroÁ non trova ancora esaltazione il mitodi Venezia, quanto anacronisticamente « l'animo dei Rovignesi » oil loro « patriottismo » 7.
Il caso di Rovigno puoÁ essere quindi a buon titolo utilizzato permostrare quale tipo di retaggi e di condizionamenti culturali ha im-pedito sovente un serio rinnovamento degli studi sulla cultura dell'I-stria nell'etaÁ moderna.
In primo luogo, questa dimensione del governo veneziano cheabbiamo definito senza tempo, se ha conferito risalto alle minute an-notazioni dell'erudizione antiquaria, ha reso difficili piuÁ ampi tenta-tivi di periodizzazione e, di conseguenza, anche la possibilitaÁ di rico-noscere alcuni problemi centrali della storia istriana. L'intento diconferire autonomia e autoritaÁ morale ad una « etaÁ veneta » rinsaldatadirettamente con l'etaÁ comunale, a Rovigno per effetto del patto disoggezione del 1283, ha reso prive di valore le trasformazioni socialifra basso Medioevo e prima etaÁ moderna, fino a dissolvere i significaticivili e religiosi della crisi del Cinquecento. C'eÁ di piuÁ : in una simileprospettiva, persino una fase di discontinuitaÁ per la storia dell'Istriaveneta come la guerra contro gli Uscocchi (1614-1617) ± corsari nel-
19
6 CERVANI, Introduzione alla ristampa di BENUSSI, Storia documentata di Rovigno,cit., p. XIII.
7 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., pp. 117, 191.
l'Adriatico ± eÁ apparsa nel ristretto ambito della storia di Rovigno co-me un fatto episodico, anche se portatore di « serie conseguenze » 8.
In questo panorama, i tentativi di sintesi dell'etaÁ moderna inIstria non possono prescindere dal preliminare problema della perio-dizzazione, onde poter meglio individuare alcuni momenti di svoltanella storia della penisola, quali la crisi religiosa del Cinquecento ele vicende connesse alla guerra degli Uscocchi. Come molta partedell'Istria costiera e interna, anche Rovigno, per rimanere al nostroesempio, venne lambita dagli effetti della Riforma protestante, in mi-sura forse minore rispetto ad altre cittaÁ vicine, ma piuÁ rilevante diquanto era sembrato di vedere. Non vi fu solo qualche sporadicoprocesso del Sant'Uffizio nel maturo Seicento ± come credeva Benus-si 9 ± ma si assistette ad un coinvolgimento di rovignesi giaÁ nei pro-cessi del 1561 sulla diffusione del luteranesimo a Umago, tale da la-sciar intravedere una precoce influenza eretica fino a Rovigno nellacreazione di un'atmosfera che puoÁ spiegare anche il successivo falli-mento del tentativo di fondarvi un seminario vescovile, poi creato aSanvincenti 10. Altri processi, accanto a quelli giaÁ segnalati da Benus-si, sono documentati per gli anni 1633, 1663, 1655 e 1699. Viene dariflettere sull'effettiva penetrazione dell'eresia protestante nel rovi-gnese e probabilmente non si eÁ lontani dal vero quando si afferma
20
8 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., p. 65; A. TENENTI, Venezia e i corsari,Laterza, Bari 1961, pp. 13-28; P. CABANES (a cura di), Histoire de l'Adriatique, EÂ ditionsdu Seuil, Paris 2001; M. WAKOUNIG, Gli uscocchi all'epoca di Ferdinando I, «QuaderniGiuliani di Storia », XXIV, 2 (2003), pp. 229-242; A. PANJEK, La diplomazia del vino e la"libera navigazione del mare Adriatico''. Alla ricerca di una politica economica nel meridio-ne austriaco (1500-1717), «Histoire des Alpes / Storia delle Alpi / Geschichte der Al-pen », 10 (2005), pp. 93-112.
9 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., p. 188.10 A. MICULIAN, La riforma protestante in Istria. Processi di luteranesimo III, « Atti
del Centro di ricerche storiche di Rovigno, » XII (1981-1982), pp. 144, 148. Si vedaanche il caso sul confine opposto, interessante per un approccio comparativo, documen-tato da S. CAVAZZA, Un'eresia di frontiera. Propaganda luterana e dissenso religioso sulconfine austro-veneto nel Cinquecento, « Annali di storia isontina », 4 (1991), pp. 5-34.Si veda anche S. CAVAZZA, J. RAINER, `̀ Infrascripti libri combusti fuerunt''. Inquisizionee roghi di libri a Gorizia, Gradisca, Duino 1586-1599, in G. HOFER (a cura di), `̀ La gloriadel Signore''. La Riforma protestante nell'Italia nord-orientale, Edizioni della Laguna,Mariano del Friuli 2006, pp. 159-186.
che, se le adesioni al luteranesimo furono occasionali e limitate a po-che persone di maggiore preparazione culturale, tra i ceti inferioriqualche suggestione trovoÁ invece fertile terreno nella superstizione,nella credenza nelle streghe e nelle fattucchiere 11, in un ambientecioeÁ del tutto simile a quello del resto della penisola istriana 12.
Se la Riforma e la nuova offensiva della Chiesa nella riconquistacattolica contraddistinsero anche in Istria la svolta cinquecentescadella crisi delle coscienze, ben piuÁ gravida di conseguenze sulla societaÁe sull'economia appare la cosiddetta guerra degli Uscocchi, o guerradi Gradisca, che vide opposte al sorgere del Seicento la Repubblica diVenezia e la casa d'Austria con la presenza, appunto, degli Uscocchi,temuti corsari nell'Adriatico. Queste vicende belliche determinaronoil definitivo consolidamento di situazioni politiche ed economiche ca-ratteristiche dell'Istria nell'etaÁ moderna, destinate a perdurare ben ol-tre la caduta della Serenissima, almeno fino alla Restaurazione.
Le conseguenze degli episodi bellici (in primo luogo, la riduzionedell'Istria a un'economia di sussistenza) e il porsi in tutta la sua com-plessitaÁ di una « questione adriatica » caratterizzata dalla permanentemobilitaÁ dei confini, portarono all'irrigidimento dei rapporti politicie ad un accentuamento del fenomeno della regionalizzazione 13. Dalpunto di vista economico, cioÁ finõÁ per ripercuotersi sulla permeabilitaÁdel confine tra Istria veneta e Istria austriaca, riverberandosi sui traf-fici e sullo scambio dei prodotti ittici e costieri con il bestiame e iprodotti dell'interno 14. Le cittadine costiere subirono trasformazioni
21
11 MICULIAN, La riforma protestante, cit., p. 154.12 V. BRANCA, S. GRACIOTTI (a cura di), L'Umanesimo in Istria, Olschki, Firenze
1983; P. DELBELLO, La maledizione del segno. Risvolti magici nelle tradizioni agrarieistriane, «Quaderni Istriani », 3-4 (1991), pp. 65-72. Il quadro va peroÁ arricchito rispet-to pure al contesto dei domini asburgici; si vedano le linee tracciate da S. CAVAZZA, Re-ligione, cultura e societaÁ nelle province austriache. Un bilancio storiografico, in ID. (a curadi), Controriforma e monarchia assoluta nelle province austriache. Gli Asburgo, l'Europacentrale e Gorizia all'epoca della guerra dei Trent'anni, Istituto di storia sociale e religiosa,Gorizia 1997, pp. 119-123.
13 A. BIN, La repubblica di Venezia e la questione adriatica 1600-1620, Il Veltro, Ro-ma 1992, pp. 33-47.
14 Per gli esiti nel lungo periodo si veda A. MICULIAN, Venezia, le cittaÁ istriane e lanavigazione nell'Adriatico nel '700, «Histria terra », 4, pp. 7-30.
urbanistiche adattandosi a piazzeforti: Rovigno ebbe rifatte le mura ele torri, approfonditi i fossati, aumentati costantemente la guarnigio-ne e l'armamento fino alla guerra di Morea del 1714 15. Ma, soprat-tutto, fu turbato l'equilibrio fra attivitaÁ marittime ed attivitaÁ agricole,tanto da determinare una diminuzione dell'agricoltura e dell'alleva-mento del bestiame 16, fattore che avrebbe condizionato l'economiaistriana per tutto il Settecento, sino al tramonto dell'etaÁ napoleonica.
Mutamento delle condizioni economiche, peggioramento diquelle sanitarie con aumento delle epidemie, rigiditaÁ dei confini po-litici furono quindi tra i fattori di spopolamento delle cittaÁ istriane trala fine del Cinquecento e la prima metaÁ del Seicento, da Capodistriaa Rovigno, a Pola 17. E furono allo stesso tempo tra le ragioni dellanuova politica di ripopolamento promossa da Venezia e tradottasinella colonizzazione della zona rovignese da parte di famiglie in mas-sima parte slave (morlacche), ma anche albanesi e greche 18. Il rap-porto numerico degli abitanti di Rovigno tra il 1554 ed il 1741, adesempio, evidenzia un aumento della popolazione della cittaÁ in per-centuale assoluta del 345,28% (da 1.789 a 6.177 anime), a fronte diun aumento nel territorio circostante del 166, 92% 19. Una delle zoneche trasse i maggiori benefici da questo aspetto della politica venezia-na fu proprio quella del contado rovignese, ove nel tardo Seicento siavvertirono i primi segni di una ripresa dell'agricoltura e della pasto-rizia, tali da contribuire a riassegnare a Rovigno un ruolo strategiconelle comunicazioni tra la penisola e Venezia 20, grazie anche allo
22
15 BENUSSI, Storia di Rovigno, cit., pp. 65-68. Per un confronto con altre realtaÁ cit-tadine E. IVETIC, Lo sviluppo dell'ambiente urbano di Parenzo nel Settecento, « Atti e Me-morie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », XLII (1994), pp. 275-298.
16 M. BERTOSÏA, La guerra degli Uscocchi e la rovina dell'economia istriana, « Atti delCentro di Ricerche storiche di Rovigno », V (1974), pp. pp. 60, 85.
17 Cfr. Anche G. DUDA MARINELLI, Appunti di vita politica e sociale tra il Settecentoe l'Ottocento a Cherso, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia pa-tria », XXXIX n.s. (1991), pp. 17-52.
18 G. CERVANI, E. DE FRANCESCHI, Fattori di spopolamento nell'Istria nei secoli XVIe XVII, « Atti del Centro di Ricerche storiche di Rovigno », IV (1973), pp. 37, 97; BE-
NUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., 269.19 M. BERTOsÏA, L'Istria veneta nel Cinquecento e nel Seicento, « Atti del Centro di
ricerche storiche di Rovigno », VII (1976-1977), p. 155.20 M. BERTOSÏA, Due progetti veneti per sistemare i porti di Parenzo e di Rovigno nella
sfruttamento delle cave di pietra utilizzata per le costruzioni nella cit-taÁ lagunare 21.
Ridefinizione dei rapporti sociali ed economici, quindi, come ri-definizione dei rapporti politici. Alla necessitaÁ di contenimento delbrigantaggio e delle fasce di emarginazione 22 corrispose una politicadel diritto volta a riaffermare la supremazia della Dominante, con unmantenimento solo formale delle autonomie giuridiche locali di fron-te alla imposizione sostanziale di una nuova politica statutaria in lineacon i princõÁpi del Comune Veneciarum 23. Un piuÁ penetrante control-lo da parte dei podestaÁ veneziani 24, rispetto ad una libertaÁ del gover-no comunale solo apparente e ad una crescente opposizione localeall'irrazionalitaÁ delle imposizioni fiscali 25, contribuirono al formarsidi un'identitaÁ municipale espressa in forma di patriottismo. Un sen-timento che avrebbe anche favorito ± nel 1764 ± l'opposizione rovi-gnese alla « terminazione » veneziana cioeÁ alla decisione che, rico-noscendo rilevanza politico-giuridica alla popolazione del territo-rio, avrebbe autorizzato l'elezione di « Sindaci del popolo » inseno alle magistrature cittadine 26.
Queste situazioni politiche si riflettono pure nella redazione enelle vicende degli statuti comunali, massima espressione dell'auto-
23
seconda metaÁ del XVII secolo, « Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno », IV(1973), pp. 183-184.
21 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell'Istria (1681), a cura di G. BORRI e L.PARENTIN, Tipografia Coana, Trieste 1968, pp. 373-374.
22 M. BERTOSÏA, Slikovci i prognanici. Socijalno razboisÏtvo u Istri u XVII. i XVIII. Sto-liecu, IKK Grozd, Pula 1989, pp. 40-42, 185-190.
23 G. COZZI, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVIal secolo XVIII, Einaudi, Torino 1980, pp. 43-46; qualche altro riferimento in E. IVETIC,Aspetti dell'amministrazione provinciale dell'Istria veneta nel Settecento: alcune considera-zioni, «Histria terra », 1 (1996), pp. 43-64; ma su questi temi, per un quadro d'insieme,rimane importante A. VIGGIANO, Governanti e governati. LegittimitaÁ del potere ed eser-cizio dell'autoritaÁ sovrana nello Stato veneto della prima etaÁmoderna, Fondazione Benet-ton-Canova, Treviso 1993, nonche ID., Note sull'amministrazione veneziana in Istria nelsecolo XV, « Acta Histriae », III (1994), pp. 5-20.
24 M. BERTOSÏA, Epistolae et communicationes rectorum histrianorum, I, 1607-1616,Academia scientiarum et artium slavorum meridionalium, Zagabriae 1979, pp. 31-36,110-111.
25 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., p. 111.26 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., pp. 92-93.
nomia municipale. Infatti, se eÁ vero che l'ultima redazione organicadi quelli di Rovigno risaliva al 1531 (e sarebbe rimasta in vigore finoal 1806), eÁ anche vero che la pubblicazione a stampa del codice ven-ne interrotta nel 1720 per ordine dell'autoritaÁ veneziana, che vedevanella sua diffusione un pericolo e un ostacolo al livellamento della le-gislazione locale con quella veneta 27. Il cosiddetto Libro catastico del1637 ± il censimento dei beni agricoli ± evidenzia invece una situazio-ne socio-economica che vedeva un buon equilibrio nel territorio fraestensione degli arativi e della proprietaÁ privata, allevamento del be-stiame e pastorizia. Le misurazioni e quindi le delimitazioni dei ter-reni venivano condotte in base alla capacitaÁ produttiva e venivanodeterminate, oltre che in stariolli (staia) e in quartariolli (quartini),anche in mezzene (macine), che costituivano l'unitaÁ di base nella mi-surazione degli arativi, corrispondente alla capacitaÁ di produrre 66chilogrammi di grano. Tanto, che le proprietaÁ della popolazione cit-tadina venivano stimate in 128 mezzene (kg 8.448) e quelle del terri-torio in 109 mezzene (kg 7.194) 28.
Quanto alla vita religiosa, la regolaritaÁ delle funzioni e della pra-tica devozionale sarebbe attestata dalla costante sequenza di fabbri-che, di altari e di monasteri documentati dagli annali ecclesiastici 29.Ma eÁ legittimo supporre che, all'ombra di Sant'Eufemia, la Chiesaera percorsa da nuovi fermenti, non soltanto in relazione alle eresieprotestanti e allo zelo controriformistico. Soggetta ancora e semprealla cattedra episcopale di Parenzo, la cittadina di Rovigno, ad esem-pio, viveva la duplice condizione di sede di culto martiriale e di chie-sa suffraganea, trovandosi cosõÁ in posizione subordinata fin dall'epo-ca dei patriarchi e del pontificato di Sergio IV 30. Sarebbe interessan-te capire in che modo questa mancanza di indipendenza venissevissuta dinanzi alle velleitaÁ autonomiste che il comune manifestava
24
27 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., p. 106.28 A. PAULETICH, Il libro catastico del 1637, « Atti del Centro di ricerche storiche di
Rovigno », II (1971), 103-110.29 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., pp. 242-279; G. RADOSSI, A. PAULE-
TICH, « Le chiese di Rovigno e del suo territorio » di Antonio Angelini, « Atti del Centro diricerche storiche di Rovigno », X (1979-1980), pp. 315-406.
30 PETRONIO, Memorie, cit., p. 371.
rispetto a Venezia, ma la documentazione scarseggia, ne in questa di-rezione si sono orientati gli interessi storiografici.
Nel corso del XVIII secolo gran parte dell'Istria conobbe un co-stante aumento demografico, nelle cittaÁ e nelle campagne: a Rovigno,per rimanere ancora al nostro esempio, rispetto ad una popolazionedi 5.653 anime, segnalate per il 1710, si giunse alle circa 13.000 regi-strate all'anagrafe del 1766. Mentre invece l'intera circoscrizione, for-mata da cittaÁ , territorio immediato e campagne vicine per una super-ficie di 206 km quadrati, raggiungeva la cifra di 19.462 abitanti 31,anche se poi gradualmente diminuirono fino ad assestarsi sui12.411 nel 1807 32. Il considerevole aumento della popolazione, no-tato giaÁ da Benussi 33, va posto in relazione sia con lo stabilizzarsi del-la situazione economica e politica dopo la pace di Passarowitz(1718), sia con lo sviluppo di piccole attivitaÁ protoindustriali, comead esempio la cantieristica. L'operositaÁ degli squeri divenne partico-larmente fiorente nel mezzo secolo che precedette la caduta di Vene-zia e nel momento di massimo splendore, intorno al 1780 circa, lasola Rovigno poteva contarne almeno dieci, a fronte di una flotta lo-cale di oltre duecento imbarcazioni di apprezzabile tonnellaggio 34.Una situazione che si rifletteva anche su altre attivitaÁ economiche eche produceva benefici effetti sull'assetto sociale del territorio; a Ro-vigno giaÁ nel 1766 a fronte di una delle piuÁ basse percentuali di mi-nori di etaÁ (il 30,78 % della popolazione rispetto alla media istrianadel 35,38 %), si assisteva ad un allungamento delle aspettativa mediadella vita (il 10,53 % della popolazione era costituito da anziani, ri-spetto alla media istriana del 5,74 %), mentre si raggiungeva il piuÁalto numero di componenti per nucleo familiare, cioeÁ 7,68 rispetto
25
31 G. NETTO, L'Istria veneta nell'anagrafe del 1766, « Atti e Memorie della SocietaÁistriana di archeologia e storia patria », XXIII n.s. (1975), p. 232.
32 G. NETTO, Istria 15 luglio 1807, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeo-logia e storia patria », XXVI n.s. (1978), p. 265. Ora anche ID., La Dalmazia veneta allavigilia del '97, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria »,XLV n.s. (1997), pp. 499-584.
33 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., p. 124.34 F. BABUDIERI, Squeri e cantieri a Trieste e nella regione Giulia dagli inizi del Set-
tecento agli inizi del Novecento, Lint, Trieste 1986, pp. 28-29.
alla media istriana di 5,34 35. Un gran numero di greggi, di telai (93),di oliveti (16) e di mulini da grano (375) contribuiva a delineare lafisionomia di un territorio che si caratterizzava comunque fra i piuÁprosperi della regione 36.
Eppure l'Istria e le sue cittaÁ costiere continuavano a soffrire graviarretratezze culturali; sembrava, anzi, che dove minore era il benes-sere ± come a Capodistria, piuÁ povera di risorse ± maggiori erano leaspirazioni culturali, mentre dove si ritrovava un po' piuÁ di benesse-re, come a Rovigno grazie alla pesca e all'agricoltura, meno spazio ri-manesse per attivitaÁ intellettuali. Questa dinamica ben fa compren-dere perche a Capodistria potesse essere riservato l'appellativo di«Atene dell'Istria », mentre a Rovigno quello di « popolana dell'I-stria ». GiaÁ nel tardo Seicento, infatti, il cronachista Prospero Petro-nio aveva lamentato la « rozzezza » di civiltaÁ a Rovigno 37 e ancora nel1764 [sic!] la comunitaÁ locale si oppose all'alfabetizzazione (« il saperleggere e scrivere ») come condizione per poter accedere alle carichepubbliche dichiarando che « l'esclusiva che ne deriva porta lo scon-tento e rammarico alla maggior parte dei cittadini privi di questo re-quisito » 38. La povera Accademia degli Intraprendenti (la cui intra-prendenza si manifestoÁ per appena tre anni, dal 1763 al 1765) sareb-be stata composta da sette sacerdoti, due medici e due dottori inlegge e di essa non ci rimane che lo statuto 39. Ma nel complesso l'in-tera penisola istriana soffriva di due situazioni che l'avrebbero grave-mente penalizzata nel Seicento e nel Settecento: l'assenza di una cat-tedra vescovile importante, di una corte o di una nobiltaÁ moralmentee culturalmente qualificata, cioeÁ di poli di attrazione e di organizza-zione della vita culturale e civile; e l'assenza di una strategia politicariformatrice ed emancipatrice, che avrebbe potuto essere promossa
26
35 NETTO, L'Istria veneta, cit., pp. 234-235.36 Cfr. anche G. ZALIN, Economia e produzione olearia nell'Istria del secondo Sette-
cento, « Economia e storia », II (1976), pp. 177-220.37 PETRONIO, Memorie, cit., p. 372.38 BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, cit., p. 183.39 M. MALUSAÁ , L'Accademia degli Intraprendenti di Rovigno (1763-1765), « Atti del
Centro di ricerche storiche di Rovigno », XX (1990), pp. 243-254.
da Venezia per dare luogo a nuove esperienze di vita civile e intellet-tuale, come avrebbero fatto gli Asburgo nella vicina Trieste.
La situazione rovignese appariva sostanzialmente simile a quelladella vicina Capodistria. Nel tranquillo fluire del tempo in quest'al-tra cittaÁ soggetta al dominio veneziano, divenuta celebre patria diGianrinaldo Carli ma scarsamente popolata nel tardo Seicento dacronachisti ed eruditi « operosi » (come si autodefinivano nella vitaaccademica), rimane ancora notizia della brevissima stagione diuna accademia di «Divertiti » ± forse in contatto con i Concordidi Rovigo ± sorta in seno al collegio gesuitico e attorno alla figuradel somasco padre Foresti 40. Parrebbe questo l'unico spunto origi-nale in un contesto di complessivo decadimento, sia dal punto di vi-sta culturale che da quello socio-economico, dopo la devastanteguerra degli Uscocchi 41. Con la differenza che, mentre gli storicidell'economia e della demografia storica continuano a rinvenire, an-che per questo periodo, una documentazione sufficientemente ab-bondante, gli studiosi della cultura letteraria e politica potrebberosolo arrendersi davanti ad un panorama bibliografico e documenta-rio desolatamente vuoto.
Se scorriamo tuttavia l'elenco dei letterati piuÁ rappresentatividella regione nel XVII secolo sembra giaÁ di poter assistere ad un fe-
27
40 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., p. 41. Su questo tema si vedano ora inve-ce, con ben altro profilo, BERTOSÏA, La guerra degli Uscocchi, cit., pp. 35-100; ID., L'Istriaveneta nel Cinquecento e nel Seicento, « Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno »,VII (1976-1977), pp. 138-160; C.W. BRACEWELL, The Uskoks of Senj: Banditry and Pira-cy in the Sixteenth-Century Adriatic, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1992.
41 BERTOSÏA, La guerra degli Uscocchi, cit., pp. 35-100; ID., L'Istria veneta nel Cinque-cento e nel Seicento, cit., pp. 138-160; BRACEWELL, The Uskoks of Senj, cit.; BIN, La re-pubblica di Venezia e la questione adriatica, cit.; F. SALIMBENI (a cura di), Istria. Storia diuna regione di frontiera, Morcelliana, Brescia 1994. Rispetto alla prima metaÁ del secolo, ilsecondo Seicento presenta nell'Istria forti elementi di discontinuitaÁ economica e cultu-rale, dipendenti per buona parte dallo spostamento verso nord dell'asse economico ve-neto, puntato fino alla guerra di Cipro (1540-1571) verso l'Oriente. Sulla politica vene-ziana del Seicento cfr. G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezianell'etaÁmoderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, UTET, Torino 1992 e, per una ve-rifica di come Venezia reinterpretoÁ il proprio ruolo adriatico dopo la pace di Carlowitz,F.M. PALADINI, «Un caos che spaventa ». Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dal-mazia della tarda etaÁ veneta, Marsilio, Venezia 2002, soprattutto le pp. 25-93.
nomeno caratteristico dei secoli successivi e manifestazione di preco-ce emigrazione intellettuale: Santorio Santorio, professore di medici-na a Padova come Girolamo Vergerio a Pisa; Cesare Zarotti attivo aVenezia come Marco Petronio Caldana a Vienna. Rimaneva, dopoNicoloÁ Manzioli ± l'autore della Nova descrittione della provintia del-l'Istria (1611) ± la coppia rappresentata da Giacomo Filippo Tom-masini e da Prospero Petronio, autori di cronache ecclesiastiche cosõÁ
come i coetanei Vincenzo Scussa ed Ireneo della Croce a Trieste. EdeÁ oltremodo significativo il fatto che fra tutti loro solo Ireneo dellaCroce riuscõÁ a pubblicare il proprio manoscritto, seppure con gravidifficoltaÁ economiche e lontano dalla patria, a Venezia; mentre gli al-tri rimasero inediti fino al XIX secolo 42.
Erano quindi cronachisti e corografi, nelle opere dei quali la sto-ria profana si intrecciava con la storia sacra, a testimonianza tutt'alpiuÁ del retaggio di una tradizione umanistica 43. Ma cosa era rimastorealmente di questo retaggio erudito nell'ambiente istriano dell'ulti-mo Seicento?
Le testimonianze sull'accademia capodistriana dei Risorti ci in-formano di una ricostituzione nel 1646 e dei primi, incerti avvii sottola protezione del capitano veneto Marc'Antonio Grimani tra le muradel teatro Ristori 44. La totale assenza di un seminario fino al 1710, ladecadenza del collegio gesuitico fino alla riorganizzazione del
28
42 B. ZILIOTTO, Storia letteraria di Trieste e dell'Istria, La Editoriale Libraria, Trieste1924, pp. 50-56; cfr. inoltre G.F. TOMMASINI, De' commentarj storici-geografici della pro-vincia dell'Istria, libri otto con appendice, a cura di D. ROSSETTI, «Archeografo Triesti-no », s. I, IV (1837), pp. 554; V. SCUSSA, Storia cronografica di Trieste, cogli annali dal1695 al 1848 di P. Kandler, edizione a cura di G. CERVANI, Edizioni Italo Svevo, Trieste1968 (prima edizione 1863); PETRONIO, Memorie sacre e profane dell'Istria, cit.
43 G.F. TREBBI, La chiesa e le campagne dell'Istria negli scritti di G. F. Tommasini(1595-1655) vescovo di Cittanova e corografo, «Quaderni Giuliani di Storia », I, 1(1980), pp. 9-49. Inoltre G.L. BRUZZONE, Lettere di Giacomo Filippo Tommasini allo stu-dioso Angelico Aprosio (1640-1654), « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeolo-gia e storia patria », LIII/1 n.s. (2005), pp. 25-98.
44 Tutte le notizie sui Risorti capodistriani che si possiedono sono raccolte in ZI-
LIOTTO, Accademie e accademici, cit., pp. 35-39. Nessuna notizia sull'accademia nel coevoP. NALDINI, Corografia ecclesiastica ossia descrittione della cittaÁ e della diocesi di Giusti-nopoli, Albrizzi, Venezia 1700, ne nel piuÁ recente F. SEMI, Capris-Iustinopolis-Capodi-stria, Edizioni Lint, Trieste 1975.
1676 45, confermano come l'unica istituzione attorno alla quale po-tesse coagularsi una parvenza di attivitaÁ culturale dovette essere l'ac-cademia. In essa, infatti, e senza sorpresa, ritroviamo sia ProsperoPetronio sia Gerolamo Vergerio, Giovan Battista Brati, Orazio Finied Antonio Sabini futuri consultori in iure della Serenissima, comea dire l'aristocrazia intellettuale della cittaÁ .
Poco ci illuminano sull'attivitaÁ dei Risorti le cronache contempo-ranee; pare comunque che ci si limitasse all'attivitaÁ poetica. Aurelio deBelli volse in versi latini laGerusalemme liberata del Tasso, Rinaldo deGavardo scrisse sonetti, Orazio Fini un poema Adelasia e i giuochi diamore e di fortuna e, piuÁ tardi, una tragedia, la Medea in Istria.
Nulli o assai scarsi i contatti con le altre accademie istriane, trie-stine e con quelle venete; contatti che comunque non risultano inda-gati dalla storiografia recente. Una traccia eÁ certamente rappresenta-ta da un manoscritto dei Divertiti segnalato come esistente nella bi-blioteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo 46. Per quale stradail testo giungesse nella cittadina veneta non eÁ dato a sapere. Si puoÁsenz'altro ipotizzare ± e la via meriterebbe di essere ulteriormente ap-profondita ± che contatti diretti o indiretti dovessero risalire all'epo-ca in cui vescovo di Capodistria era divenuto Baldassarre Bonifacio,
29
45 Si veda la filza di manoscritti Per gli Reverendi Padri delle Scuole Pie Direttori delSeminario di Capodistria 1675-1752, in ADTS, segn. 2 D 31. L'importanza del rapportotra mondo gesuitico ed istituzioni accademiche eÁ ben documentato da W. MUÈ LLER, Or-dine dei Gesuiti e movimento delle Accademie. Alcuni esempi dal XVII al XVIII secolo, inL. BOEHM, E. RAIMONDI (a cura di), UniversitaÁ, Accademie e societaÁ scientifiche in Italia ein Germania dal Cinquecento al Settecento, il Mulino, Bologna 1981, pp. 379-394 e dalquadro offerto nei contributi raccolti da G.P. BRIZZI, R. GRECI (a cura di), Gesuiti e uni-versitaÁ in Europa (secoli XVI-XVIII), CLUEB, Bologna 2002. Per un confronto con l'a-rea dalmata cfr. S. TUKSAR, Music and Bourgeois Thought in Philosophical Dialogues ofthe Ragusan `̀ Accademia dei Concordi'', in I. CAVALLINI (a cura di), Il teatro musicaledel Rinascimento e del Barocco tra Venezia, regione Giulia e Dalmazia: idee accademichea confronto, Circolo della cultura e delle arti, Trieste 1991, pp. 9-14.
46 ROVIGO, Accademia dei Concordi, fondo Silvestriano, segn. Silv. 96-7-5 (fasc. 2),ms. Le smanie della gratitudine angustiata dalla necessitaÁ del parlare e del tacere. Accade-mia per la partenza dell'Ill.mo et Ecc.mo Signore il Signor Marco Michiel Salomone dal suoacclamatissimo reggimento di Capodistria, recitata alla di lui presenza da i Signori Accade-mici Divertiti sotto la direzione del P. Gio. Maria Foresti C. R. S. l'anno 1698 nel mese disettembre. Ringrazio la dott. Michela Marangoni dell'Accademia dei Concordi per aver-mi confermata la collocazione.
nativo di Rovigo, letterato e latinista (1653-1659). EÁ da sottolineare,ad ogni modo, il sensibile dislivello culturale tra le due sponde del-l'Adriatico. Tutta definita, ormai, stava diventando la fisionomia del-l'accademia rodigina: salda nei riti, precisa negli interessi eruditi, ma-nifestava l'autocoscienza celebrativa degli intellettuali locali. Nellasua attivitaÁ di quegli anni non si colgono ancora gli « affanni dellacultura » che avrebbero contraddistinto gli esiti declinanti del seicen-tismo al confronto con l'Arcadia nascente 47. Gli orientamenti cultu-rali appaiono enciclopedici e sufficientemente rappresentati: lettera-tura, erudizione, musica 48, piuÁ tardi l'agricoltura.
Gli affanni che invece si potevano cogliere a Capodistria giaÁ allametaÁ del Seicento avevano un'origine del tutto diversa dalla decaden-za manieristica del tardo seicentismo italiano. La scomparsa dell'Ac-cademia Palladia, con la sua tradizione letteraria e musicale relativa-mente ricca, era sostanzialmente coincisa ± negli anni Trenta del Sei-cento ± con l'assenza di nuove leve che andassero a infoltire la schieradegli ormai anziani accademici 49. Oltre a cioÁ , l'epidemia di peste del1631 aveva ulteriormente aggravato la situazione generale, riducendoil numero complessivo degli abitanti a tremila 50. I pochi giovani ditalento, comunque di statura intellettuale alquanto inferiore rispettoai predecessori, si radunarono nei Risorti.
Si tratta di una involuzione assai evidente, comprovata indiretta-mente dalla diminuita produzione letteraria dell'accademia nella se-conda metaÁ del secolo e dimostrata dal chiaro restringimento degli
30
47 Cfr. G. BENZONI, Gli affanni della cultura. Intellettuali e potere nell'Italia dellaControriforma e barocca, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 159-162 e passim; ID., Spunti acca-demici polesani, in A. OLIVIERI (a cura di), Eresie, magia, societaÁ nel Polesine tra '500 e'600, Minelliana, Rovigo 1989, pp. 206-208.
48 I. CAVALLINI, Le accademie venete del Rinascimento tra musica e teatro, in Il dilet-to della scena e dell'armonia. Teatro e musica nelle Venezie dal '500 al '700, Minelliana,Rovigo 1990, pp. 50-52.
49 Sull'Accademia Palladia cfr. I. CAVALLINI, Musica, cultura e spettacolo in Istria tra'500 e '600, Olschki, Firenze 1990, pp. 95-136 ma si veda anche ID., I domini da mar, inP. FABBRI (a cura di), Musica nel Veneto. La storia, Motta, Milano 1998, pp. 138-155.
50 Cfr. Itinerario fatto da me Michiel Priuli l'anno 1646 nella cittaÁdi Capo d'Istria, etProvincia d'Istria, in A. CHERINI, Viaggio di Michele Priuli a Capodistria, « Atti e Memoriedella SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », XXIX-XXX n.s. (1981-1982), pp.115-126.
orizzonti culturali. L'attivitaÁ in questo periodo si riduce esclusiva-mente a quella d'occasione: traduzioni, odi, sonetti, poemi di varioimpegno. Lo statuto dell'accademia rovignese degli Intraprendenti,che nel maturo Settecento ricalca fedelmente gli statuti capodistriani,eÁ chiaro nel considerare attivitaÁ accademica le sole « composizioni »letterarie, in lingua « o latina, o vulgare, o prosa o verso » 51.
In tale contesto si inseriscono anche momenti piuÁ alti della vitaculturale, tra cui quello legato alla figura del compositore ed organistaAntonio Tarsia cui sono stati dedicati studi recenti. La sua famiglia,annoverata tra le piuÁ cospicue di Capodistria, giaÁ nel corso del Quat-trocento e del Cinquecento aveva dato alla cittaÁ una serie di pubbliciufficiali e vicedomini 52 e, al sorgere del Seicento, aveva consolidato ilproprio prestigio portando diversi membri alla funzione di drago-manno, cioeÁ di interprete veneto di lingua turca a Costantinopoli 53.Un prestigio che, nell'ambito della vita sociale capodistriana, finivacol manifestarsi in due modi: individualmente, mediante un certo di-stacco fisico e intellettuale rispetto alla comunitaÁ , proprio delle fami-glie che davano alti ufficiali allo Stato veneto, talvolta impegnati ± co-me nel caso dei Tarsia ± anche presso corti estere; rispetto alla comu-nitaÁ locale, invece, il prestigio acquisito si evidenziava attraverso unaprecisa collocazione nel rituale delle solennitaÁ pubbliche e delle gerar-chie sociali 54. Tipico eÁ il caso della scorta d'onore inviata a Venezia
31
51 MALUSAÁ , L'Accademia degli Intraprendenti, cit., p. 251,52 Tra gli altri Giacomo Tarsia, generale veneto (+ post 1493), Damiano Tarsia ge-
nerale e asservitore dell'Istria interna a Venezia (metaÁ XVI sec.), Giandomenico Tarsia,letterato alla metaÁ del Cinquecento. Cfr. E. GARDINA, La famiglia capodistriana dei Tar-sia, in S. ZÏ ITKO (a cura di), Antonio Tarsia 1643-1720: 350 let /anni, Consiglio esecutivodell'assemblea comunale, Koper / Capodistria 1993, pp. 11-24; F. SEMI, Istria e Dalma-zia uomini e tempi, I, Istria e Fiume, Del Bianco, Udine 19922, pp. 165-166.
53 Cfr. anche il manoscritto Relazione di me Tomaso Tarsia cavaliere Dragomannogrande della Serenissima Repubblica di Venezia alla Porta Ottomana con la descrittionedel Compendio delli successi piuÁ essenziali accaduti nella guerra intrapresa da' Turchi con-tro l'Ungheria, in AmC, reg. 1486, cc. 35 (copia microfilmata presso l'Archivio di Statodi Trieste); vedi poi pure G. PALADINO, Due dragomanni veneti a Costantinopoli (Tom-maso Tarsia e Gian Rinaldo Carli), «Nuovo Archivio Veneto », n.s. XVII, XXXIII(1917), pp. 183-200.
54 Vedi A. ALISI, Materiali per le genealogie capodistriane, vol. II, manoscritto inADTS, segn. 2 A 20, sub Tarsia.
nel 1674 per l'elezione del doge NicoloÁ Sagredo: vi facevano parteventi nobili, rappresentanti di altrettante famiglie, tra cui un AndreaTarsia; e cinque paggi, ad uno solo dei quali era stato attribuito l'ono-re di essere coppiere, cioeÁ il giovane Giovanni Tarsia, figlio di Andrea,segno quindi di una particolare distinzione sociale. Seguivano il clero,alcuni staffieri, trombettieri e gondolieri 55. Se ne trae percioÁ l'impres-sione di una famiglia perfettamente inserita nel contesto socio-cultu-rale dell'Istria di Antico Regime, conscia del proprio ruolo sociale edella propria tradizione. Suoi membri si ritrovano in tutte le istituzio-ni locali, ivi compresa l'Accademia dei Risorti, nella quale il conte Cri-stoforo Tarsia recitava fra gli ultimi anni del Seicento e i primi del Set-tecento la propria quota di composizioni poetiche.
La scarsitaÁ e soprattutto la disomogeneitaÁ dei dati biografici suAntonio Tarsia rendono oltremodo ardua la ricostruzione di unsuo attendibile profilo intellettuale, che superi le mere informazionicronologiche (nascita nel 1643-morto nel 1722) e l'elenco delle com-posizioni musicali conservate nel duomo di Capodistria. A ben vede-re, le sole notizie di rilievo concernono l'affidamento dell'incarico diorganista nella cattedrale (1662), il rinnovo nel 1664 con l'aggiuntadell'insegnamento a due giovani concittadini, e la conferma negli an-ni successivi fino al 1710 56.
Nulla autorizza a dubitare che anche Antonio Tarsia, come i suoifamiliari, fosse perfettamente inserito nel coevo tessuto sociale di Ca-podistria. L'assenza di documentazione, pur non fornendo altre con-ferme, non costituisce certo una prova negativa. L'incarico di organi-sta e di compositore nel duomo giaÁ di per se stesso doveva costituireun titolo d'onore e non solo fra le gerarchie ecclesiastiche soprattuttose, come appare confermato, si trattava di ufficio di speciale prestigiosin dagli anni in cui era salito alla cattedra vescovile il rodigino Bal-dassarre Bonifacio 57, particolarmente attento alle funzioni dell'orga-nista-compositore. Oltre a cioÁ , motivo di ulteriore lustro dovette de-
32
55 G. CAPRIN, Istria nobilissima, II, Stab. Art. Tip. G. Caprin, Trieste 1907, pp. 233-234.
56 CosõÁ G. RADOLE, La musica a Capodistria, Centro studi storico-religiosi del Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1990, pp. 47-50.
57 RADOLE, La musica, cit., pp. 47-48.
rivargli dall'incarico di insegnamento a quei due giovani concittadiniche, se probabilmente non puoÁ autorizzare l'ipotesi dello stabilimen-to coevo di una « scuola musicale » 58, qualche traccia dovette purelasciare. Tanto eÁ vero che ± come vedremo ± proprio da Capodistriamossero poi i primi passi l'abate Gavardo de Gavardo, in seguito im-pegnato in rifacimenti teatrali a Londra, e Giacomo de Belli, poiautore a Venezia di divertimenti musicali 59.
Il dato che colpisce all'interno del quadro di cui si eÁ tentata laricostruzione eÁ la mancata partecipazione di Antonio Tarsia alle atti-vitaÁ accademiche dei Risorti. L'ipotesi che la posizione economica esociale di tutta sicurezza, unita forse ad un carattere scostante, avessecondizionato lo stile di vita del personaggio non puoÁ essere esclusa.Ma, anche volendo contestualizzare la figura di Antonio Tarsia, oc-corre interpretare piuttosto la peculiaritaÁ della vita accademica nell'I-stria fra Seicento e Settecento. Permane infatti l'impressione di unorizzonte culturale e di una visione del modo di fare cultura divenuti± dopo la grande stagione umanistica e dopo figure come quella diPierpaolo Vergerio il giovane 60 ± assai ristretti e limitati per lo piuÁall'intrattenimento 61. La vita accademica e culturale, in altre parole,non veniva vissuta come un fattore di promozione sociale e d'altraparte il fatto che l'Istria fosse una periferia dello Stato veneto (cosõÁ
come Trieste era una periferia di quello asburgico) rendeva evidentel'assenza di una corte, di mecenati e persino di un patriziato sensibilealle forme culturali 62. Ragione per la quale l'Atene dell'Istria si era
33
58 RADOLE, La musica, cit., p. 49.59 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., pp. 50-51.60 Su di lui cfr. A.J. SCHUTTE, P.P. Vergerio e la Riforma a Venezia, 1498-1549, tr.
it., Il Veltro, Roma 1988 (ed. or. 1977); S. CAVAZZA, P.P. Vergerio nei Grigioni e in Val-tellina, in A. PASTORE (a cura di) Riforma e societaÁnei Grigioni, Valtellina e Valchiavennatra '500 e '600, FrancoAngeli, Milano 1991, pp. 33-62; U. ROZZO (a cura di), P.P. Ver-gerio il Giovane, un polemista attraverso l'Europa del Cinquecento, Forum, Udine 2000.
61 Anche per quanto riguarda la pratica delle esecuzioni musicali domestiche, sem-bra che a Capodistria questa debba essere fatta risalire appena ai primi anni del Sette-cento, cfr. B. ZILIOTTO, Aspetti di vita politica ed economica nell'Istria del Settecento,« Pagine Istriane », 14 (1965), pp. 19-24.
62 CosõÁ I. CAVALLINI, Un compositore barocco a Capodistria: Antonio Tarsia, in ZÏ ITKO(a cura di), Antonio Tarsia 1643-1722, cit., pp. 43-48.
ridotta ormai a capitale ± come avrebbe scritto un podestaÁ venetonella sua relazione al Doge ± di « una Provincia di fondo vasto masterile, e vi si aggiunge la pigrizia e la scarsezza d'abitatori » 63.
Paradossalmente, poco piuÁ di trent'anni dopo queste parole, loscenario doveva completamente cambiare. E dalla vicina Trieste, la-boratorio politico degli Asburgo in riva all'Adriatico, terreno di spe-rimentazioni economiche e di programmi riformistici, doveva giun-gere una proposta innovativa: « Per ottenere un fine sõÁ proficuo e sa-lutare a tutte le province dell'Austria interiore, se si prendono inriflesso tutte e ciascheduna delle circostanze, non eÁ fra tutte le cittaÁdell'Austriaco Litorale il luogo piuÁ opportuno ed adattato per ergereun'UniversitaÁ de' studii e delle scienze, che la cittaÁ di Trieste [...], trail Friuli, Istria e Cragno [...]; la situazione stessa dimostra quall'agio ecomodo avrebbero queste confinanti nazioni di mandare li loro figliallo studio delle scienze in Trieste » 64.
Queste chiare parole introducevano il testo essenziale di una pe-tizione inoltrata alle autoritaÁ asburgiche, presentata da qualificatipersonaggi triestini ed istriani negli ultimi giorni del luglio 1774 allaCesarea Regia Suprema Intendenza Commerciale.
Il lettore avvertito dei lineamenti essenziali della storia politicaregionale del primo Novecento per l'affermazione della cultura italia-na nelle province meridionali dell'Impero, potrebbe senz'altro porrequesto brano in collegamento con le rivendicazioni irredentiste del1904 per l'universitaÁ a Trieste. Il passo eÁ quindi oltremodo significa-tivo perche riassume, nella sostanza, i termini di una vicenda cultu-rale oggi soltanto in parte conosciuta e che non si esauriva semplice-mente nella richiesta di un'istituzione universitaria. Il documento ri-
34
63 Relazione al Doge del N.H. Paolo Condulmer, PodestaÁ e Capitano di Capodi-stria, datata 26 luglio 1741 pubblicata in Relazioni dei podestaÁ e capitani di Capodistria,« Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », s. I, II (1893), p.56.
64 Il documento eÁ pubblicato da A. TAMARO, Documenti di storia triestina del secoloXVIII, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », s. I, XL(1928), p. 369; sulle vicende dell'ateneo triestino cfr. M.R. DI SIMONE, La questione uni-versitaria a Trieste tra Settecento e Ottocento, in G.P. BRIZZI, J. VERGER, Le UniversitaÁminori in Europa (secoli XV-XIX), Rubettino, Soveria Mannelli 1998, pp. 487-508,con riferimenti alla bibliografia precedente.
sale infatti ad un'epoca troppo spesso ritenuta per il Litorale e perl'Istria di scarso impegno culturale e contiene l'individuazione del-l'emporio adriatico come riferimento geografico per un'ampia regio-ne culturalmente estranea alle confinazioni politiche (Friuli austriaco,Litorale, Istria veneta e Istria austriaca); dimostra una sensibilitaÁ cul-turale ormai acquisita e non dipendente della mera o presunta utilitaÁpolitica o economica; rivela, nell'articolazione, quella vocazione co-smopolita individuata dalle indagini storiografiche degli ultimi de-cenni; esemplifica infine, nella serie dei firmatari, alcune importanticomponenti sociali del territorio (alti funzionari dello Stato, rappre-sentanti del clero, membri della nobiltaÁ , commercianti ed altri espo-nenti della borghesia).
GiaÁ queste problematiche offrirebbero gli spunti per serie ricon-siderazioni, suffragate dalla necessaria documentazione, di angusteinterpretazioni veterostoriografiche riscontrabili nello spoglio dellabibliografia regionale degli ultimi due secoli e messe seriamente incrisi dal rinnovamento degli studi nel secondo dopoguerra.
Con cioÁ si vuole alludere alle posizioni di quanti vedevano il Set-tecento nel Litorale Austriaco come epoca sõÁ di splendore ma pura-mente economico-commerciale, in opposizione peraltro ad un'Istriaveneta vista semplicemente come patria della tradizione culturale ve-neto-istriana propria di una nobiltaÁ in felice (e incosciente) decadi-mento.
Certo, vanno giustamente considerate le suddivisioni politichedella regione nel XVIII secolo, perche molte differenze rimanevanotra Istria veneta e Litorale Austriaco e, nelle stesse regioni meridio-nali della monarchia, tra il Friuli austriaco, la Carniola, il Litoralepropriamente detto, l'Istria interna. Ma sul piano della storia cultu-rale non vi eÁ luogo per semplicistiche ripartizioni geografiche o epo-cali, come non eÁ concesso porre dubbi interpretativi senza il suppor-to di una adeguata e pertinente documentazione. Tutto cioÁ , con spe-cifico riguardo all'ampio ambito geografico ora considerato, vamesso in rapporto con una situazione atipica rispetto allo stato attua-le degli studi sul Settecento italiano ed europeo, poiche qui risultanoquasi del tutto sconosciute ricerche altrove avanzate sui dibattiti nelleaccademie, sulla circolazione libraria, sugli epistolari, sull'attivitaÁ disingoli operatori culturali. PiuÁ indagato eÁ invece ± fortunatamente
35
± il tema della produzione e della circolazione delle gazzette 65. Che ilricercatore debba anzitutto confrontarsi, nell'approccio allo studiodelle realtaÁ culturali e sociali del Settecento triestino e istriano, contali problemi non eÁ poca cosa.
In veritaÁ , la ricordata contrapposizione geografico-politica tra Li-torale Austriaco e Istria veneta ha prodotto in campo storiograficoun parziale vantaggio, che si eÁ risolto nell'incoraggiamento delle in-dagini sulle attivitaÁ culturali nell'Istria costiera del Settecento. E, ta-cendo di un personaggio d'eccezione come Gianrinaldo Carli (in pa-rallelo al triestino Antonio de Giuliani) che soltanto entro certi limitisi puoÁ ritenere espressione culturale della terra d'origine in quantocosmopolita per formazione e per attivitaÁ professionale, eÁ indispensa-bile fare riferimento iniziale ai preziosi studi condotti per piuÁ decennida Baccio Ziliotto 66, le cui ricerche, per l'Istria, attendono continua-zione e proficua meditazione.
Non eÁ un caso che proprio a Ziliotto si debba l'unica Storia let-teraria di Trieste e dell'Istria apparsa ancora nel 1924 e in larga partecondizionata dalla ristrettezza dello spazio e dall'essenzialitaÁ dell'e-sposizione 67. Infatti l'agile volumetto apparve in una collana di pub-blicazioni per la scuola media, il che potrebbe dare spunto per ulte-
36
65 Per un panorama sintetico degli studi sul Settecento italiano nel dopoguerra cfr.Immagini del Settecento in Italia, a cura della SocietaÁ italiana di studi sul secolo XVIII,Laterza, Roma-Bari 1980, nonche i volumi tematici pubblicati per cura della medesimaassociazione e risultato di altrettanti convegni di studio, a cura di A. POSTIGLIOLA, Epi-stolari e carteggi del Settecento. Edizioni e ricerche in corso, SocietaÁ italiana di studi sulsecolo XVIII, Roma 1985; Periodici italiani d'antico regime, SocietaÁ italiana di studisul secolo XVIII, Roma 1986; La memoria, i lumi e la storia, SocietaÁ italiana di studisul secolo XVIII, Roma 1987; Libro, editoria, cultura nel Settecento italiano, SocietaÁ ita-liana di studi sul secolo XVIII, Roma 1988; Pubblicare il Settecento. Edizioni e ricerche incorso, SocietaÁ italiana di studi sul secolo XVIII, Roma 1991; Opinione, lumi, Rivoluzio-ne, SocietaÁ italiana di studi sul secolo XVIII, Roma 1993.
66 B. ZILIOTTO, Le lettere italiane nella Venezia Giulia, in La Venezia Giulia terrad'Italia, SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria, Venezia 1945, pp. 20-26; ID., Echidi vita giuliana del Settecento, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia estoria patria », s. I, LI (1941), pp. 54. Di altri contributi dello stesso autore verraÁ datoriferimento piuÁ oltre.
67 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit.; non puoÁ essere dimenticato che un apprezzabilecontributo all'approfondimento di quegli studi, sempre destinato al settore didattico etuttavia diverso per l'ambito geografico esaminato, eÁ stato dato piuÁ recentemente dal vo-
riori riflessioni sul valore della didattica e della divulgazione anchenel campo della storiografia regionale.
Queste e altre considerazioni, che giaÁ hanno sollecitato l'attenzionecritica degli studiosi 68, inducono ad incoraggiare studi attenti di ricercastorica per individuare anzitutto gli spunti e le principali ipotesi di la-voro, onde procedere in successione temporale ad indagini accuratee organiche che non portino ad estraniare le espressioni culturali diqueste regioni dai piuÁ vasti fenomeni intellettuali, storici e letterari dellacultura italiana ed europea del Settecento 69. Qui giova anzitutto dareesauriente sintesi dello stato degli studi e delle prospettive di ricerca.
Per comoditaÁ di esposizione le considerazioni che seguono sonoriferite al costante confronto tra le realtaÁ storico-culturali del LitoraleAustriaco e dell'Istria veneta. Non si mancheraÁ peraltro di rilevare lecircostanze che rendono maggiormente percepibile il superamento ditale contrapposizione.
Terre di diversa composizione sociale furono quindi il Litorale el'Istria costiera 70; inoltre differente per ricchezza ± nonche inevita-bilmente per vicende storico-politiche ± fu l'humus che favorõÁ la sen-sibilitaÁ alle forme della cultura. Quando a Capodistria venne fondatal'Accademia dei Risorti, nel 1699, a Trieste era terminata la breveesperienza della secentesca Accademia degli Arrischiati e sarebberotrascorsi ottant'anni dall'alba del nuovo secolo prima della nascitadell'Arcadia. A Capodistria, invece, nell'arco del Settecento si succe-dettero i Risorti (1699-1739), gli Operosi (1739-1742), nuovamente iRisorti (1742-1767), i « secondi » Operosi (1763-1767) e i Risorti fino
37
lume di P. SARZANA, Friuli-Venezia Giulia, La Scuola, Brescia 1989, apparso nella collana«Letteratura delle regioni d'Italia. Storia e testi ».
68 Cfr. anche F. SALIMBENI, Rassegna storica della storiografia giuliana. Un vuoto dacolmare. Per una storia della storiografia giuliana dell'Istria: un breve profilo, « Il Territo-rio », 25 (1989), pp. 146-157.
69 Si vedano pure, piuÁ in generale ma con eguale profitto anche per la materia quiconsiderata, le riflessioni critiche esposte dai singoli studiosi, per le rispettive disciplinestoriche, in L. DE ROSA (a cura di), La storiografia italiana degli ultimi vent'anni, II, L'etaÁmoderna, Laterza, Roma-Bari 1989.
70 Si veda ora anche E. FABER, Territorio e amministrazione, in R. FINZI, L. PANARITI,G. PANJEK (a cura di), Storia economica e sociale di Trieste, II, La cittaÁ dei traffici (1719-1918), Lint, Trieste 2003, in particolare pp. 115-116.
al sorgere dell'Ottocento 71. A Pirano l'accademia fu rinnovata nel1706, a Rovigno sorse nel 1763 l'Accademia degli Intraprendenti. At-torno a queste istituzioni fecero capo quasi tutti gli intellettuali dellapenisola, in prevalenza nobili, ma anche uomini di chiesa e ammini-stratori pubblici. A Parenzo Gian Paolo Polesini (1739-1829), forma-tosi nell'ambiente culturale patavino e cultore in particolare di ar-cheologia 72, e il vescovo Gaspare Negri, pure studioso di storia anti-ca 73, animarono la vita di una cittadina che contava ± negli anniSessanta del Settecento ± poco piuÁ di tremila anime. A Cittanova ol-tre al vescovo Giandomenico Stratico 74, che amava riunire attorno ase amici intellettuali in piacevoli conversazioni, vi era la famiglia Ri-go, tra i cui membri Giandomenico accolse Metastasio in terra istria-na, Maria Giovanna si dilettoÁ di poesia e frequentoÁ l'accademia vien-nese, Bartolomeo scrisse di storia patria disquisendo con i contempo-ranei 75. A Pirano Petronio Caldana (1685 c.-1753) si impegnoÁ nellapoesia con successo 76, mentre a Rovigno Giuseppe Angelini si inte-ressoÁ di memorie storiche cittadine 77 e a Pinguente Marcello Mar-
38
71 Per le accademie istriane rimane fondamentale lo studio di ZILIOTTO, Accademiee accademici, cit., pp. 115-180, rispetto al quale alcuni aspetti sono stati poi approfonditi,con specifico riguardo ai temi musicologici e per il Seicento, da I. CAVALLINI, Musica efilosofia nell'Accademia Palladia di Capodistria: considerazioni sul dialogo «Dieci de' Cen-to dubbi amorosi » (1621), « Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno », XVII(1986-1987), pp. 195-214, al quale autore si deve pure il saggio, rilevante per la storiadell'Istria nel Seicento, Quelques remarques sur la musique sacreÂe en Istrie au XVII s.et les premiers essais monodiques de Gabriello Puliti, in VIII International MusicologicalCongress Musica Antiqua Europae Orientalis, I, Szwalbe, Bydgoszcz, 1988, pp. 233-247.
72 Su di lui cfr. C. DE FRANCESCHI, Gian Paolo Sereno Polesini da Montona e le suerelazioni con alcuni dotti di Padova, « La Porta Orientale », XX (1951), pp. 200-212.
73 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 57.74 Nato a Zara nel 1739 e morto nel 1799; prima di divenire vescovo di Cittanova
(1776) era stato professore a Siena e a Pisa (A.F. ADEMOLLO, Gian Domenico Stratico,« Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino », II (1883), pp. 346-382; V. BRUNEL-
LI, La vita e le opere di Giandomenico Stratico, « Annuario dalmatico », IV (1887), pp.228-240; M. BERENGO, Giornali veneziani del Settecento, Feltrinelli, Milano 1962, p. 37.
75 Sulla famiglia Rigo vedi ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 61 e ID., Aspetti di vitapolitica ed economica, cit., p. 23.
76 B. ZILIOTTO, Petronio Petronio Caldana rimatore piranese del secolo XVIII, « Ar-cheografo Triestino », s. III, IX (1921), pp. 247-298.
77 RADOSSI, PAULETICH, Compendio di alcune cronache di Rovigno, cit., pp. 245-375.
chesini, noto anche per avere scritto alcuni libretti d'opera per il tea-tro San Carlo di Napoli (uno fu musicato da Cimarosa), scrisse dieconomia politica 78. E per completare il panorama, prima di accen-nare a Capodistria, vanno ricordati ancora Bartolomeo Giorgini 79,che scrisse sulla storia di Albona, e Bartolomeo Vergottin, autoredi un saggio sulla storia di Parenzo 80.
Capodistria fu indubbiamente la capitale morale e culturale del-l'Istria veneta del Settecento, non soltanto per avere dato i natali aGianrinaldo Carli, gloria « nazionale », ma soprattutto per essere sta-ta il riferimento costante nell'attivitaÁ erudita di personaggi tra i qualivanno annoverati non solo l'abate Gavardo de Gavardo (morto nel1736) 81 e Giacomo Belli 82, ma anche Alessandro de Gavardo(1732 c.-1818), noto per il poema eroicomico la Rinaldeide sulla vitadi Carli 83, il verseggiatore Giuseppe Bonzio 84 e soprattutto i fratelliGravisi, Giuseppe e Gerolamo, cugini di Carli e suoi attivi corrispon-denti 85; infine Stefano Carli 86.
Si tratta di figure di intellettuali e di letterati sulle quali nel se-condo dopoguerra, complici le vicissitudini politiche che hanno resomaggiormente difficoltoso l'accesso alle fonti archivistiche, sono ve-nute a mancare ricerche nuove, modernamente impostate, che miras-sero a fornire un quadro organico e completo dell'attivitaÁ e che rico-
39
78 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 61.79 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 54.80 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., p. 134.81 B. ZILIOTTO, L'abate Gavardo Gavardo. Contributo alla storia del melodramma
italiano in Inghilterra, « La Porta Orientale », II (1932), pp. 812-823.82 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 61.83 B. ZILIOTTO, « La Rinaldeide » di Alessandro Gavardo e la giovinezza di Gianrinal-
do Carli (1720-1825), « Archeografo Triestino », s. IV, X-XI (1946), pp. 239-368.84 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 59; da ricordare anche la figura di Giuseppe
Voltiggi, linguista, su cui B. ZILIOTTO, Giuseppe Voltiggi da Antignana d'Istria (1750-1825), « La Porta Orientale », XXIV (1954), pp. 7-23.
85 D. VENTURINI, Il casato dei marchesi Gravisi, « Atti e Memorie della SocietaÁ istria-na di archeologia e storia patria », s. I, XXII (1906), pp. 296-436 e XXIII (1907), pp. 98-156.
86 Cfr. infra, cap. IV e anche B. ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli e anche di CarloGoldoni, « Archeografo Triestino », s. IV, XIV-XV (1948), pp. 273-298 e R.M. COSSAR,Epistolario inedito del conte Stefano Carli (1726-1813), « Archeografo Triestino », s. IV,XVI-XVII (1949-1950), pp. 257-316.
struissero le trame dei contatti epistolari e personali. NeÂ, d'altra par-te, in questa direzione sono orientati gli interessi prevalenti dellanuova storiografia istro-croata 87.
Uno studio di Ziliotto risalente al lontano 1907 su Salotti e con-versari capodistriani del Settecento puoÁ fornire ancora un utile spuntoper comprendere come e in quali proporzioni si svilupparono gli in-teressi culturali eruditi nella penisola 88. L'accademia capodistrianaera stata rinnovata pochi anni dopo la fondazione dell'Arcadia in Ro-ma. I suoi membri, benche mai avessero voluto (nemmeno negli annisuccessivi) aggregarsi alla « federazione » delle accademie italiane ri-fuggendone la struttura rigidamente organizzata 89, avevano ben pre-sto assimilato di fatto gli orientamenti e i gusti dominanti in gran par-te delle accademie arcadiche 90. Certo che le accademie istriane ebbe-ro interessi peculiari, in vario modo influenzati da elementi esterni.Ma se alla tradizione schiettamente veneta puoÁ ricollegarsi l'interesse,alquanto tardo peroÁ , per i temi di politica agraria e per la meccani-ca 91, eÁ da ritenersi piuttosto dovuto alla prima attivitaÁ storiograficadi Carli il gusto, talvolta esasperante, per la ricerca e lo studio dell'ar-
40
87 M. BERTOSÏA, Quale « paradigma » storico per un corpo sociale «moribondo ». Sto-ria dell'Istria veneta e « nuova storia », «Metodi e ricerche », n.s., VII, 2 (1988), pp. 71-79; ID., PiuÁ storie per una storia. Una considerazione sulla storiografia del periodo postbel-lico, « Il Territorio », XII, 25 (1989), pp. 158-161.
88 B. ZILIOTTO, Salotti e conversari capodistriani del Settecento, « Archeografo Trie-stino », s. III, III (1907), pp. 317-340.
89 Il mondo delle accademie eÁ stato ampiamente indagato in questi ultimi decenni;per alcuni orientamenti cfr. l'ormai classico D. ROCHE, Le SieÁcle des LumieÁres en provin-ce. AcadeÂmies et acadeÂmiciens provinciaux (1680-1789), 2 voll., Mouton, Paris-La Haye1978 (nuova edizione, 1989); Accademie e cultura. Aspetti storici fra Sei e Settecento,Olschki, Firenze 1979; BOEHM, RAIMONDI, UniversitaÁ, accademie e societaÁ scientifiche,cit.; H.E. BOÈ DEKER, Accademie, in V. FERRONE, D. ROCHE, L'Illuminismo. Dizionario sto-rico, Laterza, Roma-Bari 19992, pp. 263-270.
90 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., pp. 56-57, che sottolinea inoltre come « a Capo-distria e a Pirano l'orgoglio municipale non si rassegnoÁ a sottomettere all'altrui dominiole accademie superbe delle loro tradizioni secolari ».
91 M. BERENGO, Le origini settecentesche della storia dell'agronomia italiana, in L'etaÁdei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi, II, Jovene, Na-poli 1985, pp. 863-890; B. DOOLEY, Le accademie, in G. ARNALDI, M. PASTORE STOCCHI
(a cura di), Storia della cultura veneta, 5/1, Il Settecento, Neri Pozza, Vicenza 1985, pp.77-90.
cheologia istriana. D'altra parte Carli stesso, quando negli anni Cin-quanta del Settecento ritornoÁ a reggere le sorti dei Risorti capodi-striani, seppe imprimere notevole originalitaÁ alle tematiche discusse,che divennero problemi di storia dell'alto e basso Medioevo istrianononche della Riforma e Controriforma 92, studi non semplici e benpresto abbandonati. Infine eÁ da sottolineare che il successo delle ac-cademie istriane fu quasi sempre legato in gran parte a personalitaÁculturali carismatiche, come Carli stesso, come Girolamo Gravisi, co-me Gian Paolo Polesini, la scomparsa delle quali determinoÁ poi lacessazione o il decadimento dei lavori.
Quando a Capodistria fiorivano i Risorti e Carli studiava le anti-chitaÁ dell'Istria, Trieste sembra stesse diventando ± secondo un'im-magine cara alla mitizzazione kandleriana ± poco piuÁ di un borgodi pescatori. Che il definitivo decollo economico e commerciale del-l'emporio avvenisse dopo la Hauptresolution del 1749 eÁ dato acqui-sito, quali fossero peroÁ le condizioni morali e culturali della cittaÁ (checomunque contava giaÁ 12.000 abitanti) eÁ ancora da verificare com-piutamente.
Trieste nel Settecento non poteva assolutamente vantare una no-biltaÁ moralmente e culturalmente preparata come quella di molte cit-taÁ istriane. Nelle generalitaÁ , riferiva verso il 1750 un osservatore ve-neto, quanti « vantano il titolo di nobiltaÁ sono poveri cittadini chepochi anni [or] sono governavano il loro pocco terreno et in alloravivevano mediocremente bene. Ora che si sono mes[s]i sopra l'ariadi non vollere travagliare le campagne di loro ragione, ma divertirsidi spassaggiar la piazza, si vanno riducendo miserabili, che piuÁ d'unonon sano come vivere e sono questi cosõÁ contrarial foresto et al com-mercio che con l'ochio vorrebbero il tutto anichilire » 93.
Si era giaÁ alle avvisaglie del caratteristico fenomeno della societaÁtriestina di fine secolo che avrebbe visto venir meno l'antico patrizia-to locale con l'affermarsi della borghesia nuova di recente immigra-zione.
41
92 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., p. 184.93 U. TUCCI, Una descrizione di Trieste a metaÁdel Settecento, «Quaderni Giuliani di
Storia », I, 2 (1980), p. 111.
Tuttavia, benche non esistesse una classe patrizia nella generalitaÁculturalmente preparata e nonostante mancassero tipografie fino al1755, non vi era completo deserto culturale, nemmeno tra la stessasocietaÁ locale. C'era Antonio Marenzi (1687-1760), capitano sostitu-to della cittaÁ , fermo sostenitore delle teorie liberiste e convinto asser-tore del porto franco che difendeva con decisione contro le magistra-ture patrizie di Trieste che ne volevano ostacolare il progresso. DiMarenzi esistono alcuni manoscritti che lo rivelano non soltanto fun-zionario di notevole preparazione e di forte carattere, ma soprattuttoattento lettore della cultura mercantilistica francese e di quella came-ralistica austriaca, che mediava conciliandole con i primi bagliori fi-siocratici nel tratteggiare la dinamica della prosperitaÁ commerciale diTrieste; e cioÁ avveniva nel 1748-1749, in preparazione della Hauptre-solution 94. In quell'epoca, inoltre, operavano giaÁ in patria, nella rico-gnizione del patrimonio archivistico e documentario della Vicedomi-neria, Andrea Giuseppe de Bonomo e Aldrago de Piccardi, dei qualisaraÁ detto oltre.
Pur mancando quasi del tutto ricerche capillari in questa direzio-ne, eÁ da aggiungere che gli interessi culturali non si esaurivano di cer-to tra questi e altri patrizi « illuminati » al servizio dello Stato. EÁ fa-cilmente ipotizzabile, nonche del tutto rispondente ai princõÁpi delledinamiche culturali, che buona parte degli immigrati a Trieste nelSettecento, cioeÁ dei fondatori della cittaÁ nuova, non fosse costituitada delinquenti, rifugiati o poveracci rozzi e incolti che appena sape-vano fare di conto per poter calcolare i propri guadagni, secondo al-tro stereotipo della storiografia triestina dell'Ottocento. EÁ di confor-to il fatto che, dopo decenni in cui il Settecento triestino eÁ stato rias-sunto soltanto nella crescita economica e nel balzo demografico,nuove prospettive si sono aperte alla storiografia con la proposizionedi tematiche un tempo quasi sconosciute 95. E, per rimanere nei ter-
42
94 Cfr. infra, cap. II.95 Cfr. gli ormai classici lavori di E. APIH, La societaÁ triestina del secolo XVIII, Ei-
naudi, Torino 1957 e ID., La societaÁ triestina tra il 1815 ed il 1848, in G. TABACCO (a curadi), Italia del Risorgimento e mondo danubiano-balcanico, Del Bianco, Udine 1958, pp.25-38, nonche G. CERVANI, La borghesia triestina nell'etaÁ del Risorgimento. Figure e pro-blemi, Del Bianco, Udine 1969. Molto utili per l'organica comprensione delle problema-
mini cronologici individuati, pare esemplare lo studio condotto suPasquale de Ricci, « immigrato » giunto a Trieste nel 1750, da MariaGrazia Biagi 96, che costituisce la dimostrazione evidente di quanto sipossa ancora indagare su personaggi il cui valore era stato finoraignorato o, tutt'al piuÁ , soltanto intuito. Tanto piuÁ appare apprezzabi-le tale ricerca, in quanto rivela come sia possibile lavorare anche sen-za fare ricorso ad opere a stampa (ritenute spesso il criterio per ec-cellenza di valutazione del personaggio) e su persone quindi, comede Ricci, tra i piuÁ alti e preparati funzionari dello Stato nel governodi Trieste, che nulla pubblicarono e il cui pensiero eÁ individuabiledall'esame dei numerosi manoscritti, memoriali o pareri, ancora esi-stenti negli archivi dei cessati ordinamenti governativi.
Le cose ovviamente mutarono quando nel 1755 si stabilõÁ a Trie-ste il primo tipografo « privilegiato » e quando l'anno dopo inizioÁnell'emporio la propria attivitaÁ lo stampatore viennese Trattner, notoa Vienna per le sue imprese editoriali 97.
Negli ultimi quattro decenni del Settecento gli esponenti del cetomercantile poterono contare cosõÁ sempre piuÁ spesso sulla possibilitaÁmateriale e intellettuale di dedicarsi ± in modo piuÁ o meno impegna-to ± alla cultura, alla lettura e alla scrittura, e il fenomeno comincioÁ arivelarsi in tutte le sue proporzioni. Fatta eccezione per i pochi nobilidella vecchia classe patrizia giaÁ segnalati, la maggioranza dei nuoviintellettuali era espressione della cittaÁ nuova, e non di una cultura na-ta provvidenzialmente ex abrupto, ma di culture diverse, di « impor-tazione », di confronto e coesione. CioÁ indurrebbe, a mio parere, adanticipare il termine originario della storia culturale della cittaÁ diTrieste, per farlo risalire almeno alla metaÁ del Settecento ± tenendopresente che l'instaurarsi di una progressiva consapevolezza di un
43
tiche accennate anche i saggi di F. SALIMBENI, Nuove prospettive della storia locale: fonti,metodi, problemi. Il caso giuliano, «Quaderni Giuliani di Storia », II, 2 (1981), pp. 7-39 eID., Problemi e prospettive di storia locale nel Friuli-Venezia Giulia, «Quaderni Giulianidi Storia », III, 2 (1982), pp. 117-131.
96 M.G. BIAGI, Giuseppe Pasquale Ricci funzionario imperiale a Trieste (1751-1791).Primi risultati di una ricerca, ETS, Pisa 1986.
97 C. PAGNINI, I giornali di Trieste dalle origini al 1959, SPI Centro Studi, Milano1959, p. 12.
impegno intellettuale e civile fu solo graduale ± rispetto ai riferimentitradizionalmente individuati nel terzo decennio dell'Ottocento, nelmomento cioeÁ in cui una rilevante immigrazione di intellettuali diorigine veneta avrebbe rinnovato le iniziative culturali dell'emporio.
Si tratta certo di un'impostazione ampiamente verificabile e ne-cessaria di vasta e pertinente documentazione; ma le ricerche che sultema sono state condotte nel corso degli anni hanno dato risultati in-coraggianti e comprovanti l'attendibilitaÁ della proposta 98, tanto che± in qualche caso ± si eÁ potuto addirittura individuare parte delle bi-blioteche private.
Del resto, introducendo cosõÁ il tema delle biblioteche e della cir-colazione libraria, non c'eÁ che da suggerire di compulsare e pubbli-care integralmente ± quale fonte di grande interesse per la storia dellasocietaÁ triestina del Settecento ± i numerosi inventari di bibliotecheprivate 99: si tratta di documenti inseriti fra le pratiche di ventilazione
44
98 Mi riferisco, oltre che al citato lavoro di Maria Grazia Biagi su de Ricci, anche aF. GALLO, La doppia patria di Jakob Nicolaus Craigher, « Almanacco culturale della Car-nia », V (1989-1990), pp. 47-77 (su J.N. Craigher, poeta e commerciante a Trieste nelterzo decennio dell'Ottocento) e al saggio di I. CAVALLINI, Ricezione della musica classicae cultura a Trieste tra Sette-Ottocento, in F. CAPUTO (a cura di), Neoclassico a Trieste. Ar-te, architettura e cultura a Trieste 1790-1840 (catalogo della mostra, Trieste 1990), Mar-silio, Venezia 1990, pp. 65-71. Importante, perche volto a dare un quadro d'insieme ditemi culturali prima trascurati, S. DE LUGNANI, La cultura tedesca a Trieste dalla fine del1700 al tramonto dell'Impero absburgico, Italo Svevo, Trieste 1986 (pp. 11-20. Utili in-fine per ulteriori approfondimenti i due volumi a cura di F. SALIMBENI, La cultura slovenanel Litorale, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorizia 1988 e Cultura friulana nel Go-riziano, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorizia 1988; cfr. infine anche ID., Una fontesettecentesca per la storia del Territorio, « Il Territorio », IV, 6 (1981), pp. 79-84.
99 Il tema eÁ stato affrontato soprattutto dal punto di vista della storia del collezio-nismo: A. GROSSI, S. VOLPATO (a cura di), Incunaboli e cinquecentine, 2 voll., FondazionePalazzo Coronini Cronberg di Gorizia, Umberto Allemandi, Torino 2004; S. VOLPATO,La biblioteca privata di Giuseppe Domenico Della Bona (1790-1864). I libri, la collezionenumismatica, il carteggio, Biblioteca Statale Isontina-Forum, Udine 2003; ID., NapoleoneBonaparte tra i libri della famiglia Coronini Cronberg: questioni di bibliofilia e catalogo,« Archeografo Triestino », s. IV, LXIV (2004), pp. 449-483; ID., `̀ Studio e lavoro comeun ragno''. Domenico Rossetti e la raccolta petrarchesca e piccolominea, i cataloghi e i re-pertori bibliografici, in A. NUOVO (a cura di), Biblioteche private in etaÁmoderna e contem-poranea, Sylvestre Bonnard, Milano 2005, pp. 271-282; A. SIRUGO (a cura di), Le colle-zioni del Museo Petrarchesco Piccolomineo della Biblioteca Civica `̀ A. Hortis'' di Trieste,Olschki, Firenze 2005.
ereditaria giacenti presso l'Archivio di Stato di Trieste, riferibili a si-tuazioni culturali di maturo Settecento e finora solo raramente utiliz-zati 100.
Concludendo la breve rassegna di personaggi « interessati di cul-tura », c'eÁ da osservare che mentre in Istria gli intellettuali proveni-vano in prevalenza dalla nobiltaÁ e dalle alte gerarchie ecclesiastiche,a Trieste la composizione sociale era piuÁ varia. Accanto ad alti fun-zionari, come il giaÁ ricordato Pasquale de Ricci (che peroÁ originaria-mente era esponente della borghesia mercantile) e come il direttoredi polizia Pietro Antonio Pittoni 101, v'erano esponenti del clero, no-bili di antica tradizione, come de Bonomo e come Aldrago de Piccar-di (che fu pure vescovo di Pedena), e componenti della borghesia co-smopolita, come Antonio Rossetti de Scander, come Francesco Tad-deo Reyer, come Francesco Emanuele Baraux e altri 102. Tuttioperatori che neppure lontanamente, per specificitaÁ di interessi eru-diti, politici, letterari o teatrali, potevano ricordare qualche scompar-sa figura di diarista della prima metaÁ del secolo. Tale articolato tes-suto sociale si riconosce nella composizione dell'Accademia degli Ar-cadi Romano-Sonziaci, « dedotta » a Trieste nel 1782 dal romanoGiuseppe de Coletti e germe della prima biblioteca pubblica cittadi-na 103. Di questo tipo d'Arcadia (per larga parte sui generis), derivata
45
100 Cfr. infra, cap. II.101 A. TAMARO, Fine del Settecento a Trieste. Lettere del barone P. A. Pittoni (1782-
1801), « Archeografo Triestino », s. IV, V-VI (1942-1943), pp. 3-428; P. DORSI, « Liber-taÁ» e « legislazione ». Il rapporto del barone Pittoni sullo stato della cittaÁ di Trieste e delsuo territorio, « Archeografo Triestino », s. IV, XLIX (1989), pp. 137-185.
102 Si vedano giaÁ i firmatari dell'istanza del 1774 per l'universitaÁ , ricordata piuÁ so-pra e utilizzata da TAMARO, Documenti di storia triestina, cit., p. 370. Vanno ricordateperoÁ anche le parole di ammonimento di Antonio de Giuliani (1803): « EÁ vero che Trie-ste eÁ una cittaÁ semplicemente mercantile, ma non per questo la cultura dello spirito sideve credere incompatibile con la professione del Negoziante » (A. DE GIULIANI, Scrittiinediti, a cura di C. PAGNINI, All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano 1969, p. 310).
103 Per l'arcadia goriziana cfr. R.M. COSSAR, La cultura goriziana e l'Accademia set-tecentesca dei Filomeleti, « Archeografo Triestino », s. IV, VIII-IX (1945), pp. 51-118.Per l'accademia triestina rimane fondamentale C. DE FRANCESCHI, L'Arcadia romano-son-ziaca e la biblioteca civica di Trieste, « Archeografo Triestino », s. III, XV (1929-1930),pp. 95-225. Per Giuseppe de Coletti inoltre B. ZILIOTTO, Lorenzo Da Ponte e Giuseppede Coletti, « Archeografo Triestino », s. IV, I-II (1938-1939), pp. 117-173 e C. DE FRAN-
CESCHI, Giuseppe de Coletti tipografo e giornalista, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana
da quella goriziana fondata qualche anno prima, eÁ da sottolineare, amio avviso, un aspetto importante divergente dalle classiche iniziativedisimpegnate dei « pastori » contemporanei e finora non oggetto del-la considerazione che meritava: l'interesse attivo, cioeÁ , per la situazio-ne economica e sociale della regione e l'impegno civile (e non sem-plicemente erudito) nella discussione dell'avvenire economico dellarealtaÁ circostante, maturato fin dai primi anni di attivitaÁ e prima dellaoccupazione napoleonica del 1797 104.
Come nell'Istria anche nel Litorale quindi le accademie, l'Arca-dia goriziana e quella triestina, funsero ± sebbene appena nel secon-do Settecento ± da elemento di coesione degli intellettuali e dei cul-tori di temi storico-letterari.
Da Gorizia provenne invece il primo tipo di iniziativa giornalistica,la «Gazzetta goriziana », durata dal 1774 al 1776; fu un'operazioneculturale di indubbio rilievo che sensibilizzoÁ i contemporanei prepa-randoli a piuÁ durature imprese consimili 105. Quando la gazzetta diGorizia cessoÁ le pubblicazioni, a Trieste si cominciarono a stampare± per uso prevalentemente amministrativo, politico ed economico ± al-cuni fogli periodici sul movimento marittimo e commerciale 106, seguitinel 1781 dal giornale «Triester Welt-Korrespondent », nel 1784 dalla«Triester politische und Handlungs-Zeitung » e in quello stesso annoda «L'Osservatore Triestino » 107. Si tratta di iniziative editoriali in lar-
46
di archeologia e storia patria », s. I, XLVI (1934), pp. 3-48. Aggiunge poco F. DONAÁ ,L'Arcadia nel Litorale Austriaco all'epoca di Giuseppe II, «Quaderni Giuliani di Storia »,XV, 2 (1994), pp. 131-136.
104 Si vedano gli atti accademici in BCTS, segn. R. P. MS. 3-26 (1-11).105 Per la «Gazzetta goriziana » cfr. PAGNINI, I giornali, cit., pp. 12-14; sull'atten-
zione di questa per gli avvenimenti contemporanei anche A. TRAMPUS, I gesuiti e l'Illu-minismo. Politica e religione in Austria e nell'Europa centrale (1773-1798), Olschki, Fi-renze 2000, pp. 67-68. Va rilevato, rispetto alla situazione triestina, quanto piuÁ ricchesiano le indagini sul patrimonio librario di Gorizia in etaÁ moderna; cfr. S. CAVAZZA, Ca-talogo del fondo antico della biblioteca del Seminario di Gorizia, La Nuova Italia, Firenze1975; ID., Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia tra Cinquecento e Seicento,« Studi Goriziani », XLIII, 1(1976), pp. 29-80; A. MARTINA, Orientamenti culturali dellabiblioteca del seminario arcivescovile di Gorizia dall'erezione della diocesi alla soppressione(1751-1788), « Studi Goriziani », LXVII, 1 (1988), pp. 129-151.
106 PAGNINI, I giornali, cit., pp. 20-21.107 Per le gazzette di lingua tedesca S. DE LUGNANI, Il giornalismo tedesco a Trieste:
ga parte rispondenti alle necessitaÁ di un emporio commerciale e marit-timo, che peroÁ vennero aprendosi alla cultura in senso piuÁ ampio,ospitando recensioni, dibattiti storiografici, articoli di vario genere.
Le accademie, in Istria e nel Litorale, furono allora per tutto ilSettecento i principali punti di riferimento e di coordinamento del-l'attivitaÁ dei singoli operatori culturali e in apertura, d'altra parte,si era notato come fosse possibile e anche doveroso superare la con-trapposizione fra Litorale Austriaco e Istria veneta per dare una rap-presentazione della storia culturale quanto piuÁ possibile vicina allarealtaÁ .
A tale superamento, che permette di cogliere in modo piuÁ preci-so la vivacitaÁ degli ambienti letterari ed eruditi delle regioni conside-rate, porta la documentazione dei rapporti tra gli intellettuali triestinie istriani e tra la cultura regionale e quella italiana ed europea.
Bisogna risalire ai primi anni del Novecento per rintracciare laprima consistente fonte documentaria di tal genere, cioeÁ l'edizioneinsuperata del carteggio tra Gianrinaldo Carli e i Gravisi curata daZiliotto 108. Lavoro fondamentale, che permette tuttora di intuire everificare l'opera mediatrice di Carli tra la cultura dell'Istria venetae quella della Lombardia austriaca, non soltanto in riferimento aiGravisi ma pure ad altri eruditi contemporanei operanti a Gorizia,a Trieste ed in Istria, frequentemente citati nelle lettere. Tuttavia sidoveva attendere il secondo dopoguerra per vedere pubblicato un al-tro importante carteggio da Ranieri Mario Cossar, cioeÁ l'Epistolarioinedito del conte Stefano Carli (1726-1813) 109. Da esso emergono, ac-canto a quelli dei fratelli Carli, i nomi del parentino Filippo Gregis,canonico della basilica Eufrasiana, del triestino Andrea Giuseppe deBonomo, del capodistriano Giovanni Antonini, del pinguentino Ma-rio Paleocapa, figlio di un cancelliere di Capodistria. E il commentostesso a questo epistolario suggeriva ulteriori approfondimenti, a tut-
47
arte e informazione al servizio dell'equilibrio sopranazionale absburgico, «Quaderni Giu-liani di Storia », V, 1 (1984), pp. 55-57.
108 B. ZILIOTTO (a cura di), Trecentosessantasei lettere di Gianrinaldo Carli capodi-striano, cavate dagli originali e annotate, « Archeografo Triestino », s. III, IV-VII, Tip.Caprin, Trieste 1914.
109 COSSAR, L'epistolario inedito, cit.
t'oggi purtroppo non realizzati, sul recupero di altri epistolari sette-centeschi, tra i quali dovrebbe spiccare per ricchezza quello di Giro-lamo Gravisi, ora depositato presso la SocietaÁ istriana di archeologiae storia patria 110.
Altre relazioni epistolari furono documentate, per Gorizia, Trie-ste e la Carniola, dagli studi casanoviani di Carlo Leone Curiel 111;basta del resto, a tale proposito, leggere il capitolo conclusivo dellaHistoire de ma vie di Giacomo Casanova ± testo di agevole reperibi-litaÁ e consultazione ± per avvertire l'intensitaÁ dei rapporti personali eculturali nella regione nei primi anni Settanta del Settecento 112. EÁ
una constatazione che trova conferma anche dall'esame dei diaridel conte Zinzendorf, con riferimento pure alla penisola istriana 113;e giacche si eÁ accennato a Zinzendorf, non va dimenticato in questocontesto il carteggio Pittoni-Zinzendorf, edito nello scorcio del se-condo conflitto mondiale da Attilio Tamaro 114.
Nel 1961 veniva pubblicato su Ce fastu? da Elio Apih un articolotanto breve quanto stimolante sui Corrispondenti capodistriani dell'a-bate Giuseppe Bini, segnale di un rinnovato interesse critico per il pa-trimonio epistolare regionale 115, volto essenzialmente a presentareun fondo documentario di indubbia importanza per lo studio deirapporti culturali tra l'area friulana e la penisola istriana; e da lõÁ si
48
110 Si veda ora anche l'inventario a cura di S. DESCHMANN, M. DORSI, B. SABLICH, C.ZOCCONI, L'archivio Polesini. Lettere 1796-1798, SocietaÁ Istriana di archeologia e storia-Editreg, Trieste 2004.
111 C.L. CURIEL, Trieste settecentesca, Sandron, Napoli 1922; G. CASANOVA, Patrizi eavventurieri, dame e ballerine in 100 lettere inedite, o poco note, a c. di C.L. CURIEL e A.RAVAÁ , Corbaccio, Milano 1930.
112 G. CASANOVA, Storia della mia vita, tr. it., a cura di P. CHIARA e F. RONCORONI,III, Mondadori, Milano 1989, pp. 961-1016 (capp. XXXIV-XXXV).
113 C. PAGNINI (a cura di), Il periodo triestino dal diario inedito del conte Carlo deZinzendorf primo governatore di Trieste (1776-1777), « Archeografo Triestino », s. IV,XXXVIII (1978), pp. 7-247; ID., Un viaggio in Istria nel 1778 del governatore Zinzen-dorf, «Quaderni Giuliani di Storia », IV, 2 (1983), pp. 93-107; A. TRAMPUS, Economiae stato nel riforme nel Litorale Austriaco dal diario del conte Zinzendorf (1771), « Archeo-grafo Triestino », S. IV, L (1990), pp. 91-130.
114 TAMARO, Fine del Settecento, cit.115 E. APIH, Corrispondenti capodistriani dell'abate Giuseppe Bini, « Ce fastu? »,
XXXVII, 1-6 (1961), pp. 43-47.
scoprivano i nomi dei capodistriani Anteo e Giannandrea Barbabian-ca, di Domenico Manzioli, di Giuseppe Gravisi e, naturalmente, diCarli. Nel 1978 seguiva, per cura dello stesso Apih, un saggio su Ca-podistria nel '700 in alcune lettere inedite di Gianrinaldo Carli, risul-tato della ricognizione del carteggio Carli-Bini (1738-1739, ma con-tinuato anche negli anni successivi) 116.
Tra tutte queste indicazioni e proposte di ricerca, l'epistolario diGianrinaldo Carli ± oggi fortunatamente consultabile senza grandidifficoltaÁ , seppure non negli originali autografi ± costituisce certa-mente un'eccezione per imponenza e importanza, mentre paradossal-mente, rispetto alla sua rilevanza per la storia della cultura non sol-tanto istriana ma italiana ed europea, rimane in larga parte inesplo-rato e in condizioni di utilizzazione scientifica non migliore rispettoad altre situazioni 117.
Una corrispondenza con il goriziano Coronini, con i friulani Binie Bertoli, con il veneziano Alberto Fortis, con Cesarotti, Tiraboschi oZeno, con Goldoni o Spallanzani non fu, si noti, privilegio esclusivodi un personaggio di rilievo come Gianrinaldo Carli: fu invece impe-gno familiare ± a quanto risulta dalle testimonianze storiografiche ±di uomini come Gravisi, Polesini, de Piccardi; si tratta di altrettanteipotesi di lavoro che meritano conferma, o almeno indagini che pos-sano contribuire a illuminare alcuni di questi momenti storici.
Le ricerche che proseguono portano gradualmente ad apprezza-bili conferme e chiarificazioni, rivelando in qualche caso situazioniinsospettate, che attestano l'esistenza di costanti scambi culturalinon soltanto tra il Litorale Austriaco e l'Istria, ma in generale trale sponde dell'Adriatico, in un ampio arco che comprende Venezia,il Friuli, il Litorale Austriaco, la Carniola, l'Istria e la Dalmazia 118.
49
116 ID., Capodistria nel '700 in alcune lettere inedite di Gianrinaldo Carli, « Atti delCentro di ricerche storiche di Rovigno », IX (1978-1979), pp. 505-521.
117 Cfr. l'ampia panoramica offerta da F. SALIMBENI, Per l'edizione dei carteggi delDe Rubeis e degli intellettuali friulani e giuliani tra Sei e Settecento, «Quaderni Giulianidi Storia », VIII, 2 (1987), pp. 287-295.
118 Si vedano, in particolare, i lavori di C. PAGNINI, Un corrispondente triestino [diGiacomo Casanova]: Giuseppe Rossi, « L'IntermeÂdiaire des casanovistes », II (1985), pp.13-25; I. CAVALLINI, Presenze di musicisti pugliesi a Trieste nel XVIII secolo, in D. BOZZI,
Rimane da considerare un argomento tanto affascinante quanto alungo trascurato, quello cioeÁ della produzione e della circolazione li-braria. Per quanto riguarda la produzione editoriale settecentesca nelLitorale Austriaco e nell'Istria vi sono comunque alcuni censimentiche possono confortare sullo stato delle ricerche. Si puoÁ fare in que-sto caso valido riferimento al pur datato Saggio di bibliografia istria-na 119 ± privo peroÁ di qualsiasi apparato critico ± e al piuÁ recente erilevante catalogo della mostra goriziana del 1986 sull'arte della stam-pa in Friuli (con riflesso peroÁ anche al Litorale) tra XV e XIX seco-lo 120. Per ora, intanto, si puoÁ soffermare l'attenzione su qualche par-ticolare degno di maggiore interesse perche poco noto e indagato.
A Venezia, nel 1725, veniva diffusa la ristampa della Historia diTrieste di Ireneo della Croce risalente al 1698, per molto tempo l'u-nica fonte a stampa sulla storia dell'emporio adriatico 121; ma benpresto alle numerose pubblicazioni di interesse strettamente com-merciale o legale vennero aggiungendosi opere di carattere storicoo storico-politico, tra le quali spiccano le Riflessioni politiche soprail prospetto attuale della cittaÁ di Trieste di Antonio de Giuliani. Talelavoro era stato preceduto nel 1782 da una Historisch-statistischeBeschreibung der Stadt Triest 122, semplice « descrizione di Trieste
50
L. COSI, Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale tra Seicento e Settecento, Torred'Orfeo, Roma 1988, pp. 241-249; A. TRAMPUS, « Talent et eÂrudition »: Casanova nellelettere del barone Sigismondo Zois, « L'IntermeÂdiaire des Casanovistes », VII (1990),pp. 25-36; cfr. inoltre il meno recente E. APIH, Un carteggio inedito tra Gian RinaldoCarli e l'abate Giuseppe Bini, « Pagine Istriane », s. IV, XII (1962), pp. 37-44 e i moltispunti contenuti in Da Maria Teresa a Giuseppe II. Gorizia, il Litorale, l'Impero, Istitutoper gli incontri culturali mitteleuropei, Gorizia 1981. Altri riferimenti, infine, in VENTU-
RI, Settecento riformatore, V/2, cit., pp. 347-429, che dedica ampie pagine alla vita cul-turale dell'Istria e della Dalmazia.
119 C. COMBI, Saggio di bibliografia istriana, Tondelli, Capodistria 1864.120 M. DE GRASSI, Prodotto libro. L'arte della stampa in Friuli tra XV e XIX secolo,
Provincia di Gorizia, Gorizia 1986; A. GROSSI, Annali della tipografia goriziana del Set-tecento, Biblioteca Statale Isontina, Gorizia 2001.
121 Su questa operazione editoriale cfr. ora S. DI BRAZZANO, La Historia di Triested'Ireneo della Croce (1698) e il suo rilancio sul mercato librario da parte di AlmoroÁAlbriz-zi (1725), « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », LIII/2n.s. (2005), pp. 315-344.
122 H. MOLL, Historisch-statistische Beschreibung der Stadt Triest und ihres Gebietes,Moll, Triest 1782; cfr. pure DE LUGNANI, La cultura tedesca, cit., p. 17.
del Moll scritta in tedesco, [...] lavoro meschino, che poco ci puoÁistruire e si puoÁ dire piuÁ una speculazione dell'autore ch'era nellostesso tempo lo stampatore » 123 e che aveva peroÁ il merito di rendereaccessibile il contenuto ai commercianti di lingua tedesca; inoltre ini-ziava a prosperare l'Arcadia, dalla quale provennero lavori di erudi-zione storica di indubbio interesse e serietaÁ di intenti, come gli scrittidi Rodolfo Coronini, di Pier Francesco Scati e di Andrea Giuseppede Bonomo, sui quali torneremo in altro capitolo 124.
Nell'Istria l'attivitaÁ editoriale non fu certo di minori dimensioni esi sviluppoÁ prevalentemente, in modo abbastanza organico, nel cam-po dell'erudizione archeologica e dell'antiquaria, probabilmente perimpulso degli scritti giovanili ± dedicati all'Istria e a Capodistria ± diGianrinaldo Carli. Inoltre, particolarmente vivi furono i dibattiti tragli intellettuali sulle storie municipali e su tematiche di volta in voltaaffrontate in appassionati certami, come la disputa circa il sito del-l'antica Emona 125.
Per quanto riguarda, infine, il tema della circolazione libraria eÁda rilevare la quasi totale assenza di studi sull'argomento, essendomancati fino ad oggi spogli analitici e sistematici delle pubblicazionicontemporanee per verificare almeno la ricorrenza e la consistenzadelle citazioni. Da qualche indicazione, il piuÁ delle volte incidental-mente rilevata 126, si puoÁ intuire che in linea generale non vi fu sem-pre un costante aggiornamento nella conoscenza della letteratura sto-rica e critico-letteraria; poiche mancano, come in precedenza accen-nato, studi sistematici sulla consistenza delle biblioteche private epubbliche, ci si trova nell'impossibilitaÁ di disporre almeno di dati
51
123 MINIUSSI, Prolusione sulla storia letteraria della cittaÁ di Trieste, ms. in BCTs,segn. R.P. MISC. 2-43, cc. 91r.-101r. Pubblicato in A. TRAMPUS, Storia della cultura estoria della storiografia: la `Trieste letterata' di Lorenzo Miniussi, «Quaderni Giulianidi Storia », XII, 1-2 (1991), pp. 63-71 (la citazione si riferisce alla c. 94r).
124 Se ne veda il catalogo in appendice a DE FRANCESCHI, L'Arcadia romano-sonzia-ca, cit., pp. 217-225.
125 Si veda quanto esposto infra, cap. IV.126 Si vedano ad esempio infra cap. IV a proposito della conoscenza e della diffu-
sione delle opere dell'abate Alberto Fortis, sul quale cfr. G. PIZZAMIGLIO, Introduzione aA. FORTIS, Viaggio in Dalmazia, a cura di E. VIANI, Marsilio, Venezia 1987, pp. XI-XXXI.
di partenza per ulteriori ipotesi di lavoro. Qualche informazione sievince dallo spoglio degli epistolari, ma si tratta nella maggior partedei casi di situazioni o di verifiche circoscritte a singole tematiche 127.
Alcuni interessanti contributi per la riscoperta di tale patrimonioculturale sono derivati, ma limitatamente alla cittaÁ di Trieste, dallemanifestazioni organizzate nel 1989 dall'Assessorato comunale alleAttivitaÁ culturali sul tema «Neoclassico a Trieste », culminate inuna ampia rassegna espositiva corredata da un importante catalo-go 128. Anche in questo caso finalmente, e con notevole sensibilitaÁ ,eÁ emersa l'esigenza di promuovere nuovi studi sulla cultura triestinatra Settecento e Ottocento, al di laÁ del semplice accostamento ± chenon sempre si eÁ rivelato possibile ± di una cultura classica o classici-sta ad espressioni neoclassiche nel campo dell'architettura e dell'ur-banistica 129.
Per l'Istria, molto rimane da lavorare sui complessi avvenimentiche portarono, dopo i preliminari di Leoben e il trattato di Campo-formido, alla caduta della Serenissima e all'assegnazione di quei ter-ritori all'Austria. Il trauma dell'evento politico, se turbava la coscien-za civile di qualche intellettuale, non parve riverberarsi con pari in-tensitaÁ sulla vita quotidiana degli abitanti e studi recenti hannodimostrato che, come peraltro avvenne anche a Venezia, vi fu conti-
52
127 Segnalo la mia nota su La circolazione delle « Turbolenze di Polonia » a Triestenei secoli XVIII e XIX, « L'IntermeÂdiaire des Casanovistes », VIII (1991), pp. 32-33.
128 F. CAPUTO (a cura di), Neoclassico. Arte, architettura e cultura a Trieste, cit., delquale interessa qui particolarmente la sezione Letteratura e vita letteraria curata da ElvioGuagnini. Nel volume vi sono importanti contributi, alcuni dei quali veramente originalirispetto alla tradizione storiografica locale, tra cui meritano segnalazione quelli di E.GUAGNINI, Minerva nel regno di Mercurio (pp. 43-47), C. BOÈ HM, La comunitaÁ scientifica(pp. 59-63), I. CAVALLINI, Ricezione della musica classica e cultura a Trieste (pp. 65-71),F. COSSUTTA, Classicismo e «Neoclassicismo » in Domenico Rossetti (pp. 105-113), F. SA-LIMBENI, La prima serie dell'« Archeografo Triestino » (1829-1837). Una rivista di eruditoimpegno civile (pp. 115-119).
129 Vi sarebbe in effetti molto da discutere sul rapporto tra cultura classicista e arteneoclassica, che spesso a Trieste non eÁ simmetrico o risulta difficilmente leggibile a causadi alcuni ritardi culturali. Il primo forse ad analizzare questo tema in modo ampio e do-cumentato eÁ stato P. TREMOLI, Intorno alla cultura classica nella Trieste dell'Ottocento, inA.E. CAMMARATA (a cura di), Scritti in onore di Camillo de Franceschi, « Annali Triestini »a cura dell'UniversitaÁ di Trieste, UniversitaÁ degli Studi, Trieste 1951, pp. 63-151.
nuitaÁ di assetti sociali ed economici al di laÁ del 1797 e almeno finoalla nascita del Regno d'Italia nel 1806 130. Scompariva peroÁ nelle ter-re venete dell'Istria un quadro di riferimento culturale rappresentatoda un rassicurante passato; anche nelle cittaÁ istriane si convocarono,nello spazio di poche ore, i comizi elettorali per dare vita alle nuovemunicipalitaÁ provvisorie. Ma chi si assunse poi l'impegno di narrarequelle ore, spiegoÁ l'iniziativa non con la necessitaÁ di colmare il vuotolasciato dal potere veneziano assecondando i venti di libertaÁ , bensõÁ
con l'opportunitaÁ di non lasciarsi trascinare « dalla effimera demo-cratica vertigine di novitaÁ » 131. La « gallicana rivoluzione » diventava« infelice movente della caduta del veneto governo », anche se la nuo-va situazione permetteva di « correggere gli abusi introdotti da un'ar-bitraria oligarchia di poche famiglie ». Rimaneva su tutto l'orgogliomunicipale e la fiducia di poter ottenere dal nuovo governo quel ti-tolo di cittaÁ al quale molte localitaÁ istriane avevano lungamente aspi-rato ma che Venezia non aveva mai voluto concedere 132.
La storia della cultura nel Litorale e nell'Istria del Settecento nonsempre rivela, in prospettiva di una complessiva valutazione, figureche si imposero all'attenzione nazionale, con tutto il relativismoche puoÁ esprimere per il Settecento il concetto di « nazione ». Il Li-torale Austriaco e l'Istria furono peroÁ terre di confronti e di appas-sionati dibattiti culturali ed eruditi, animati da intellettuali piuÁ o me-no impegnati che si dimostrarono sensibili alla vivacitaÁ dell'epoca eaperti al confronto e ai rapporti interpersonali. CioÁ mostra la misuracerto non disprezzabile in cui la storia della cultura in questa regionenel XVIII secolo appare in connessione con quella di paesi immedia-tamente comunicanti, cioeÁ con buona parte dell'Europa meridionalee continentale.
Nella trattazione piuÁ volte appaiono, sullo sfondo del panoramatratteggiato, due intellettuali di eccezione, rilevanti a livello europeo,
53
130 M. GOTTARDI, L'Austria a Venezia, FrancoAngeli, Milano 1993. Vedi anche FA-
BER, Vom Schicksalsverlauf einer Grenzregion in der Neuzeit, cit., pp. 283-326.131 VERGOTTIN, Della antica origine, cit., p. 235.132 VERGOTTIN, Della antica origine, cit., pp. 236-237.
come il triestino Antonio de Giuliani 133 e l'istriano GianrinaldoCarli 134.
EÁ utile e interessante verificare quanto queste personalitaÁ incise-ro sull'impegno civile e culturale degli operatori giuliani e istriani: maquesti due personaggi, proprio perche di eccezionale rilevanza nelpiuÁ ampio contesto delineato, sfuggono in certa misura alla omoge-neitaÁ di un corpo sociale ± quello degli intellettuali eruditi ± in pro-gressiva trasformazione. E se si vuole arricchire il concetto di « uma-nitaÁ della storia », per non limitarlo solo alle pur fondamentali vicen-de degli uomini d'eccezione, puoÁ essere utile proseguire le ricercheanche su queste altre realtaÁ .
54
133 Su Antonio de Giuliani si veda innanzitutto B. CROCE, Introduzione a A. DE
GIULIANI, La cagione riposta delle decadenze e delle rivoluzioni, Laterza, Bari 1934, pp.I-XXVIII; C. PAGNINI, Introduzione a DE GIULIANI, Scritti inediti, cit., pp. 9-60; G. NE-
GRELLI, L'illuminista diffidente. Giuseppismo e Restaurazione nel pensiero di Antonio deGiuliani, il Mulino, Bologna 1974.
134 La bibliografia su Carli si eÁ notevolmente arricchita negli ultimi anni, dopo ilclassico lavoro di E. APIH, Rinnovamento e illuminismo nel '700 italiano. La formazioneculturale di Gian Rinaldo Carli, Deputazione di Storia patria per la Venezia Giulia, Trie-ste 1973 e ID., Carli Gian Rinaldo, voce in Dizionario biografico degli italiani, 20, Istitutodella Enciclopedia Italiana, Roma 1977, pp. 161-167. Si veda la rassegna da me pubbli-cata con il titolo Nuovi orientamenti metodologici e prospettive storiografiche nella ricercasulla vita e l'opera di Gianrinaldo Carli, « Archeografo Triestino », s. IV, LI (1991), pp.275-295 nonche il numero monografico su Gianrinaldo Carli nella cultura europea delsuo tempo, «Quaderni Giuliani di Storia », XX, 1-2 (2004) che raccoglie gli atti del con-vegno svoltosi a Trieste e a Venezia il 28 e 29 ottobre 2002 con molti aggiornamenti bi-bliografici.
II. - I PRIVILEGI ANTICHI E LE LIBERTAÁ MODERNE: LACULTURA TRIESTINA TRA SETTECENTO E OTTO-CENTO
Cronaca di un anno: nell'estate 1800 Napoleone Bonaparte, PrimoConsole, sconfigge a Marengo l'esercito austriaco e i suoi alleati; nel-l'inverno successivo il generale Victor Moreau batte a Hohenlinden,in Baviera, l'armata absburgica capeggiata dall'arciduca Giovanni.
16 gennaio 1801: a Treviso viene sottoscritto l'armistizio che ob-bliga gli austriaci a retrocedere sino al Tagliamento, cedendo ai fran-cesi Mantova, Peschiera e Legnano.
9 febbraio 1801: a LuneÂville, in Lorena, la casa d'Austria firmacon Napoleone il trattato di pace che porta la Francia oltre i confininazionali e riconferma le cessioni territoriali decise a Campoformioquattro anni prima.
Due protagonisti della vita settecentesca commentavano a di-stanza le grandi vicende europee e le piccole rivoluzioni che stavanoavvenendo nel porto franco: a Trieste il barone Pietro Antonio Pit-toni (1730-1807), da poco in pensione e prima direttore di poliziaper oltre trent'anni, fra il 1766 e il 1800; a Vienna, invece, il conteKarl von Zinzendorf (1739-1813), Ministro di Stato nel Consigliodi Stato per l'Interno, giaÁ presidente della Camera Aulica dei Contie prima ancora, fra il 1776 e il 1782, governatore di Trieste.
Pittoni a Zinzendorf, 1 febbraio 1801: « nonostante l'armistiziosiamo percorsi da grande inquietudine; eÁ attesa una flotta inglesecol pretesto che proteggeraÁ il nostro commercio, che non faraÁ altro
55
che provocare e Dio sa quale scusa troveranno i francesi per apriredelle ostilitaÁ . [...] Nonostante tutto cioÁ si danza, si canta e ci si preparaall'apertura del nuovo teatro con un'opera magnifica. I cantanti e iballerini piuÁ famosi d'Italia sono stati giaÁ ingaggiati, e si pensa cheuna gran parte del pubblico viennese verraÁ a Trieste per profittarne ».
Pittoni a Zinzendorf, 28 febbraio 1801: « ci prepariamo all'aper-tura del nostro nuovo teatro per Pasqua, con grande magnificenza.Marchesi, la Bertinati [recte Bertinotti], David, la celebre danzatriceDell'Oro arriveranno successivamente, Salieri e Mayr sono i maestridi musica. Si vede una grande quantitaÁ di pubblico viennese. Dio vo-glia che anche Lei possa essere fra questo! ».
Ancora Pittoni a Zinzendorf, 18 marzo1801: « dopo l'armistizioTrieste eÁ diventata una piazza d'armi. Abbiamo nel nostro piccoloterritorio otto battaglioni, tutti i depositi delle artiglierie di Mantova,Legnago e Verona, Ancona e Ferrara, le riserve di truppe che eranostate lõÁ di stanza, un ospedale pieno di 1.500 malati ecc. [...]. Dopoaver celebrato la nostra Pasqua speriamo di poterci consolare altri-menti con Marchesi, la Bertinati [Bertinotti], la Dell'Oro e diciamo:Es ist Frieden! EÁ la pace! » 1.
21 aprile 1801: il Teatro Nuovo di Trieste, poi chiamato `̀ Giu-seppe Verdi'', viene solennemente inaugurato alla presenza dellamassime autoritaÁ civili e militari. Nella sala, l'ampia platea e sei ordinidi palchi, per complessive 154 logge, ospitano la societaÁ triestina rac-colta per assistere alla rappresentazione della Ginevra di Scozia diMayr. Il nostro Pittoni si trova nell'ultimo ordine di palchi, da dovepuoÁ volgere lo sguardo alla platea e all'emiciclo, fra le logge illumina-te dai fanali a muro, dalla luce delle candele e dai molti lumini. PuoÁcosõÁ scorgere immediatamente il pubblico e con esso la fisionomiadella cittaÁ nuova: nei palchi al pianterreno, con le mogli, si trovanoi commercianti Giovanni Tabisco, Enrico Trapp, Ignazio Hagenauer,Pietro Sartorio, Giuseppe Rossetti, Antonio Vicco, Ignazio Verpoor-ten, Alvise Perinello; tra loro stanno, isolati nel palco n. 6, i baroniFrancesco de Zanchi e Giuseppe de Marenzi. Nelle logge del primoordine, le piuÁ costose perche in posizione migliore, il barone Pietro
56
1 TAMARO, Fine del Settecento a Trieste, cit., pp. 307-309.
de Burlo, i commercianti Demetrio Carciotti e Francesco EmanueleBaraux, il console di Spagna Carlo Alessandro de Lellis, il consolepontificio Carlo de Maffei. Sempre al primo piano, al palco n. 28,il commerciante Matteo Giovanni Tommasini, finanziatore del tea-tro, mentre l'ex gran doganiere d'Egitto Antonio Cassis Faraone oc-cupa con la moglie il palco n. 19. Al palco n. 25 i consiglieri di go-verno, al palco n. 4 Ignazio de Capuano in rappresentanza del Co-mune, e poi altri commercianti, Ciriaco Catraro, DomenicoPlenario, Michele Andrulachi, Ignazio Gadolla, Stefano Risnich, Sa-lomone Parente. Nell'ultimo ordine il nostro osservatore Pittoni, ilnotaio Gerolini, l'avvocato Giuseppe Lucchese, il medico AndreaGobbi. Al centro dell'emiciclo, nella barcaccia al primo piano cheeÁ anche l'unico spazio riscaldato da una stufa, l'anziano governatorePompeo de Brigido con la moglie Teresa della Torre Valsassina 2.
Come eÁ noto, il nuovo teatro di Trieste veniva inaugurato congrande ritardo rispetto alla data prevista per la consegna dell'edificio.I primi progetti risalivano al 1776 ed erano stati caldeggiati propriodal governatore Zinzendorf e da Pittoni; negli anni successivi le ri-chieste per un edificio piuÁ ampio, piuÁ capiente e piuÁ prestigiosodel vecchio teatro San Pietro si erano infittite, ma solo nel 1796 il pia-no definitivo era stato approvato, giusto in tempo per vederlo minac-ciato dai rivolgimenti politici legati alla discesa di Napoleone in Ita-lia. La consegna era stata fissata per il 27 giugno 1800: doveva rap-presentare simbolicamente, quindi, la conclusione del secolo cheaveva visto il decollo dell'emporio e l'ingresso trionfale in quelloche si apriva. Poi, di rinvio in rinvio, era slittata all'aprile 1801 3.
57
2 La descrizione della serata, che si basa sulle cronache dell'epoca, eÁ fornita da G.STEFANI, Il Teatro Verdi di Trieste 1801-1951, I.G.O.P.P., Trieste, 1951, pp. 47-49. Ri-sale a quello stesso periodo, peraltro, il ritratto marmoreo di Brigido posto originaria-mente nei locali dell'Arcadia romano-sonziaca e oggi conservato presso la Biblioteca ci-vica di Trieste, sul quale M. MESSINA, Un episodio di collezionismo archeologico nel primo'800 e gli interventi di Sigismondo Dimech « scultore e restauratore » maltese, « Atti deiCivici Musei di storia ed arte di Trieste », 18 (2001), pp. 273-316.
3 Un'accurata descrizione delle vicende progettuali e architettoniche dell'edificio sitrova in P. UGOLINI BERNASCONI, Il Teatro `̀ G. Verdi'' di Trieste. Le origini neoclassiche ei restauri attraverso i secoli, B&MM Fachin, Trieste, 1988, pp. 21-73, nonche in STEFANI,Il Teatro Verdi, cit., pp. 9-40.
La cronaca dell'inaugurazione attira il nostro interesse, nel con-testo della storia culturale triestina, principalmente per il fatto chesintetizza le aspettative di un'epoca e di un'intera generazione: l'epo-ca ± corrispondente all'ultimo quarto del Settecento ± che era statavista come l'etaÁ dello sviluppo del porto franco e la generazioneche aveva consolidato le fortune imprenditoriali e aveva contribuitoa fondere in una straordinaria miscela di nazionalitaÁ , di culture, direligioni differenti le varie anime della cittaÁ nuova.
Si tratta di un processo lungo e faticoso, intrapreso all'ombradelle provvidenze absburgiche e dei privilegi concessi all'emporio,che aveva trasformato completamente la societaÁ e la cultura triestine.Su questi temi, e in particolare sulle fortune economiche e sulle inno-vazioni istituzionali, molto eÁ stato scritto negli ultimi due secoli 4. Unpo' meno, invece, sulla cultura a Trieste e nel Litorale Austriaco; solopiuÁ recentemente il panorama storiografico si eÁ arricchito di moltinuovi contributi e ricerche, sia sul versante italiano sia su quello au-striaco, che hanno notevolmente ampliato e arricchito le nostre cono-scenze sulla vita intellettuale tra Settecento e Ottocento. Essi confer-mano in larga misura quanto era stato segnalato da chi scrive alla finedegli anni Ottanta del Novecento, e cioeÁ che le radici della culturadel ceto mercantile triestino affondano nel XVIII secolo, nel mondodell'Antico Regime, e che la societaÁ triestina di primo Ottocentonon puoÁ essere considerata semplicemente come espressione di unmomento di rottura legato all'affermarsi di un'ideologia borghese,ma deve essere studiata in termini di continuitaÁ rispetto all'esperien-za settecentesca 5.
58
4 EÁ in caso di segnalare il fatto che i contributi piuÁ significativi allo studio delle vi-cende economiche e istituzionali del porto franco giungono oggi dall'approccio di tipocomparativo, come ha fatto ± ponendo a confronto Livorno con Trieste ± D. BAGGIANI,Livorno e la polizia del commercio: formula politica, prassi istituzionale (1737-1748), in A.CONTINI, M.G. PARRI (a cura di), Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII,Olschki, Firenze 1999, pp. 589-620.
5 A. TRAMPUS, Gli interessi teatrali e musicali di F.E.J. Baraux e la cultura triestina traSette e Ottocento, in I. CAVALLINI (a cura di), La Civica Cappella di San Giusto. 450 dimusica a Trieste 1538-1988, Comitato per le celebrazioni dei 450 anni della Cappella Ci-vica, Trieste 1989, pp. 199-211. L'idea della continuitaÁ e della possibilitaÁ di racchiuderela storia della societaÁ triestina in un unico ciclo che va dalla dichiarazione del porto fran-
In altri termini, le nuove basi del vivere civile all'inizio dell'Otto-cento erano il frutto di trasformazioni che si erano verificate giaÁ dallametaÁ del secolo precedente, a partire dal fondamentale settore dell'e-ducazione. La soppressione della compagnia di GesuÁ nel 1773 avevaportato in tutt'Europa ± e anche a Trieste e Gorizia ± alla chiusuradegli antichi collegi, ormai considerati simbolo del mondo antico,della tradizione classica e umanistica, dell'inadeguatezza del vecchiosistema culturale dinanzi alle nuove esigenze della societaÁ settecente-sca. Nell'intero continente il sapere dei gesuiti, concentrato sull'inse-gnamento della grammatica, della retorica, della poesia, dei classici,aveva messo clamorosamente in rilievo l'assenza e il disinteresseper tutte le nuove discipline che erano ormai al centro dell'opinionepubblica: l'economia, il diritto, la scienza della politica. Il bisogno dinuove professionalitaÁ al servizio dell'amministrazione degli Stati siera scontrato inesorabilmente con l'organizzazione dei collegi risalen-te all'epoca dello zelo controriformistico e al progetto di riconquistacattolica dell'Europa minacciata dall'eresia protestante 6.
CioÁ nonostante, giaÁ da lungo tempo il collegio dei gesuiti a Trie-ste non era piuÁ un'istituzione riservata ai patrizi, espressione del solocorpo nobiliare e nemmeno era rimasto soltanto un modello di tra-smissione del patrimonio culturale umanistico. Basta addentrarsi nel-l'organizzazione della scuola e nella lettura dei documenti che la ri-guardano, per accorgersi del fatto che proprio le peculiaritaÁ dell'em-porio la spingevano giaÁ da anni verso una modernizzazione. Daglianni Cinquanta del Settecento gli allievi non erano piuÁ solo giovaninobili, ma anche figli di commercianti e persino di artigiani. L'am-missione al collegio non era piuÁ vincolata al privilegio e al fatto di ap-
59
co (1719) alla prima guerra mondiale eÁ anche alla base della sintesi di A. ARA, C. MAGRIS,Trieste. Un'identitaÁ di frontiera, Einaudi, Torino 19872 e peraltro non preclude di rico-noscere momenti di rottura istituzionale, come si vedraÁ piuÁ oltre, nel cap. V.
6 Sull'inadeguatezza del sistema educativo dei collegi gesuitici cfr. P. GOUBERT, D.ROCHE, L'Antico Regime, II, Cultura e societaÁ, Jaca Book, Milano 1984, pp. 251-259; perl'area absburgica le stesse problematiche sono messe in rilievo da G. KLINGENSTEIN, L'a-scesa di casa Kaunitz. Ricerche sulla formazione del cancelliere Wenzel Anton Kaunitz e latrasformazione dell'aristocrazia imperiale (secoli XVII e XVIII), intr. di C. MOZZARELLI, Ro-ma, Bulzoni, 1993, pp. 133-177.
partenere all'ordine nobiliare, ma si basava su una nuova ideologialegata alla ricchezza economica, alla possibilitaÁ di pagare le rette egli strumenti didattici (come l'acquisto di manuali) necessari per glistudi. Di fatto, il principio del merito, legato alle fortune economi-che, giaÁ portava ad allentare i tradizionali rapporti sociali, e a far se-dere fianco a fianco il figlio di un ricco commerciante e quello di unnobile impoverito. Non a caso proprio il municipio triestino ± doveera rappresentato il patriziato ± avrebbe introdotto il primo sistemadi sussidi e borse di studio per i giovani, anche nobili, maggiormentebisognosi di aiuto economico 7.
Questo spiega perche a Trieste la presenza culturale degli ex-ge-suiti continuoÁ a farsi sentire ben oltre la soppressione della compa-gnia avvenuta nel 1773, confermando del resto un fenomeno di rile-vanza europea 8. Questa attivitaÁ era rafforzata anche dall'esistenzadella scuola nautica, fondata negli anni Cinquanta del Settecento sul-la scia delle riforme educative che avevano attribuito sempre maggio-re importanza alle scienze economiche; un'istituzione che, come rive-la la documentazione archivistica, era stata modellata sull'esempiofrancese delle scuole di idrografia 9. Il corso, della durata di due anni,era stato aperto nel 1753 per iniziativa del gesuita Francesco SaverioOrlando (1723-1784), originario di Fiume 10. Orlando, che era statonominato docente di idrografia e che insegnava ± secondo i costumidell'epoca ± sulla base delle proprie dispense manoscritte, aveva pro-seguito l'attivitaÁ fino al 1773 quando, per effetto dello scioglimento
60
7 Sulla storia del collegio dei gesuiti cfr. G. CERVANI, Note sulla storia del collegiodei gesuiti a Trieste, in Italia del Risorgimento e mondo danubiano-balcanico, cit. e, peril XVII secolo, V. CUNJA ROSSI, I Gesuiti, Trieste e gli Asbugro nel Seicento, SocietaÁ diMinerva, Trieste 2006. I registri degli allievi del collegio triestino sono oggi custoditipresso l'Archivio diplomatico di Trieste.
8 TRAMPUS, I gesuiti e l'Illuminismo, cit., pp. 72-73.9 E. FABER, Die Nautische Schule in Triest (1753 bis 1773), in Zur Ausweitung des
Horizonts, «Das achtzehnte Jahrhundert und OÈ sterreich. Jahrbuch der oÈ sterr. Gesell-schaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts », 13 (1998), pp. 207-232.
10 B. FRANUSICÂ , Francesco Saverio Orlando, fondatore delle prime scuole nautiche del-l'Adriatico, in S. GALIMBERTI, M. MALY (a cura di), I gesuiti e gli Asburgo. Presenza dellaCompagnia di GesuÁ nell'area meridionale dell'Impero asburgico nei secoli XVII-XVIII, Lint,Trieste 1995, pp.189-200.
dell'Ordine dei gesuiti, era tornato a Fiume, portando con se la bi-blioteca e la strumentazione scientifica. Zinzendorf aveva ottenutonel 1777 la restituzione dei libri e degli strumenti e da allora l'inse-gnamento era ripreso per cura dell'ex-gesuita Luigi de Capuano,che aveva poi inaugurato nel 1783 la Scuola di Matematica e Nautica,il futuro Istituto Nautico 11. Alla fine del Settecento, cosõÁ, numerosifunzionari del governo di Trieste inviavano i figli a studiare nellascuola nautica, che, in assenza di altre istituzioni scolastiche, assolve-va in parte anche alla necessitaÁ di preparare professionalmente i fu-turi impiegati dello Stato 12. Questo fa capire anche perche il gover-natore Zinzendorf guardasse con particolare attenzione alla scuola eperche nel testamento del 1807 e nel codicillo del 1812 destinoÁ unaparte del suo patrimonio alla creazione di una `̀ Fondazione Zinzen-dorf'' presso la Scuola Nautica, con lo scopo di dare borse di studio astudenti bisognosi 13.
Una vera e propria rivoluzione nella cultura e nella societaÁ citta-dine era stata poi determinata dalla riforma dell'istruzione primaria,sul cui faticoso avvio studi recenti hanno gettato nuova luce 14.
Le quattro scuole primarie o triviali (dal tedesco Trivialschulen)che esistevano a Trieste dal 1761 erano state completamente trasfor-mate per effetto della Allgemeine Schulordnung del 1774, introdotta
61
11 M. MARZARI, L'accademia di commercio e nautica, in CAPUTO (a cura di), Neoclas-sico, arte, architettura e cultura, cit., pp. 404-429; cfr. anche ISTITUTO NAUTICO `̀ TOMMASO
DI SAVOIA DUCA DI GENOVA'', 250 di studi nautici a Trieste. Contributi per il duecentocin-quantenario, Italo Svevo, Trieste 2005; sulla sua biblioteca cfr. T. DE CANZIANI JAKSÏ ICÂ ,ZacÏeci javnoga knijzÏnicÏarstva u Rijeci, in E. DUBROVIc (a cura di), Temelji moderne Rijeke1780-1830. Gospodarski i drusÏtveni zÏivot, Muzej Grada Rijeke, Rijeka 2006, pp. 100-113.
12 Sull'importanza della scuola nautica nella Trieste settecentesca si veda infra cap.III.
13 L'atto di costituzione della Fondazione Zinzendorf, datato 1 febbraio 1820, sitrova in ASCTS, Atti di fondazione n. 21. La Fondazione Zinzendorf continuoÁ ad ope-rare fino al 1918 e venne sciolta con il passaggio di Trieste all'Italia. La Fondazione Zin-zendorf eÁ stata ricostituita a Trieste nella primavera del 2000 presso l'Istituto TecnicoNautico, erede dell'antica Scuola nautica, e ha ripreso a erogare borse di studio.
14 Si veda anche, a tal proposito, D. DE ROSA, Le scuole pie e normali della nazioneebraica di Trieste (XVIII e XIX secolo), «Quaderni Giuliani di Storia », XVII, 1 (1996),pp. 7-39; per le scuole ebraiche L.C. DUBIN, The Port Jews of Habsburg Trieste. Abso-lutist Politics and Enlightenment Culture, Stanford University Press, Stanford 1999,pp. 95-104.
a Trieste con ordinanza dell'Intendenza Commerciale del 28 marzo1775. L'effettiva esecuzione di questo provvedimento era avvenutatuttavia solo con l'arrivo del governatore Zinzendorf, che nel novem-bre 1776 aveva imposto l'obbligo di avviare tutti i bambini maschi efemmine alla scuola pubblica fino all'etaÁ di sei anni, assoggettando imaestri privati al controllo del direttore delle scuole normali e con-sentendo l'istruzione privata per i figli dei nobili solo a condizioneche il precettore venisse sottoposto al previo esame del direttore del-le scuole 15.
L'istruzione pubblica obbligatoria stentava tuttavia ad affermarsie nel 1776 le scuole elementari private, in tutto il territorio triestino,erano ancora ben tredici. Godevano di sovvenzioni attraverso il fon-do di studi costituito con le rendite o la vendita dei beni ex-gesuiticie attraverso questo stesso fondo venivano spesso stipendiati anche imaestri. Vi si insegnava a scrivere, leggere, l'aritmetica, la religione ealle ragazze anche il cucito. L'educazione nella scuola pubblica, e conessa il riconoscimento per tutti i bambini in etaÁ scolare del diritto al-l'istruzione gratuita, incontroÁ quindi l'opposizione non solo di questescuole private, che correvano il rischio di essere chiuse, ma anchedelle scuole religiose di dottrina cristiana, in particolare quella gestitadagli ex-gesuiti 16.
La scuola superiore, detta anche scuola normale, era entrata in-vece in funzione nel dicembre 1775 nell'edificio dell'ex-seminario deigesuiti nella cittaÁ vecchia. Era costituita da quattro classi ed era sot-toposta al controllo di un direttore e di una commissione scolasticaappositamente costituita, di cui facevano parte il vescovo, un consi-gliere di governo, un giudice della cittaÁ e il direttore della scuola stes-sa. L'anno scolastico durava otto mesi e al termine del primo gli alun-ni sostenevano un esame generale di catechismo, lettura, scrittura e
62
15 D. DE ROSA, Libro di scorno, libro d'onore. La scuola elementare triestina durantel'amministrazione austriaca (1761-1918), Del Bianco, Udine 1991. Per un confronto conl'area goriziana F. TASSIN, L'istruzione popolare e gli Asburgo: la contea di Gorizia e Gra-disca (1774-1855), Centro studi politici, economici e sociali `̀ Sen. A. Rizzatti'', Gorizia2001, in particolare pp. 13-38.
16 ASTS, Cesareo Regio Governo del Litorale, busta 126, carte non numerate, letteradell'amministratore dei beni ex gesuitici Luigi de Giuliani, datata 19 agosto 1776.
aritmetica, al quale assisteva un consigliere di governo o lo stesso go-vernatore. Nel secondo biennio l'istruzione veniva approfondita at-traverso lo studio di testi italiani, francesi e tedeschi, lo studio dimeccanica, fisica e geografia. L'insegnamento si svolgeva in linguaitaliana e a partire dal secondo anno gli alunni cominciavano ad ap-prendere la lingua tedesca. Dall'ottobre 1776 vennero istituiti dueispettori scolastici, la cui nomina giaÁ rispecchiava i nuovi equilibri so-ciali nel porto franco: uno era un rappresentante del governo, il fisca-le Tommaso Ustia, l'altro un rappresentante del ceto mercantile, ildirettore di borsa Giuseppe Bellusco. Dal marzo 1777, poi, in segui-to alle proteste e alle richieste delle comunitaÁ religiose minori, erastato introdotto l'insegnamento, alternativo a quello della lingua ita-liana, della lingua `̀ illirica'' o slava 17. Nello stesso mese ± infine ±Zinzendorf aveva concesso ai rappresentanti della comunitaÁ grecadi stipendiare un loro maestro e di lõÁ a poco la medesima autorizza-zione venne rilasciata alla comunitaÁ ebraica 18. Nel territorio, la primascuola elementare venne aperta solo nel 1778 a Servola, il villaggiopiuÁ popolato, con una filiale a Santa Maria Maddalena inferiore,mentre negli altri villaggi cioÁ accadde soltanto a partire dal 1784.
A completare questo quadro vanno aggiunte alcune osservazionisull'assenza, nella storia triestina, di un'istituzione di livello universi-tario. Come noto, per tutto il periodo del governo degli Asburgo(1382-1918) il Litorale Austriaco, cioeÁ la regione storica del portofranco triestino, non ebbe una propria universitaÁ , che venne istituitaappena nel 1938. Gli studi universitari venivano compiuti prevalente-mente a Graz e a Padova nella facoltaÁ di legge, ove si otteneva la lau-rea in utroque iure (diritto civile e diritto canonico). Occorre tuttaviaricordare che ± come abbiamo visto nel capitolo precedente ± proprio
63
17 Il tema meriterebbe maggiori approfondimenti; per un primo sondaggio si vedatuttavia P. MERKUÁ , La realtaÁ plurilinguistica a Trieste dal tardo Medioevo alla fine del'600: documenti storici in positivo e in negativo, in Presenza e contributo della cultura slo-vena a Trieste, IRRSAE Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1988, pp. 33-40 e ancora ID., Lapresenza slovena nella cittaÁ preemporiale, in R. FINZI, G. PANJEK, Storia economica e so-ciale di Trieste, I, Lint, Trieste 2001, pp. 273-292.
18 ASTS, Cesareo Regio Governo del Litorale, busta 126, note di Zinzendorf datate20 marzo e 10 maggio 1777.
alla fine del XVIII secolo cominciarono ad essere presentate richiesteper l'istituzione di un'universitaÁ che potesse servire agli studenti delLitorale, dell'Istria e della Carniola. In questo senso un gruppo dicommercianti, membri della deputazione di Borsa, presentoÁ sin dalluglio 1774 all'Intendenza Commerciale un'istanza per l'apertura diun'universitaÁ a Trieste 19 e progetti analoghi continuarono a essereinoltrati per tutta la fine del Settecento e nel corso dell'Ottocento 20.
Le notizie sin qui riportate ci avvertono sul fatto che, nel mo-mento in cui si vuole studiare la storia culturale della cittaÁ di Trieste,bisogna guardarsi dal ridurre il significato e la portata di queste tra-sformazioni istituzionali e sociali al solo ambito del porto franco. Percapire le reali dimensioni di questi fenomeni non ci si puoÁ limitarecioeÁ al solo spazio urbano. Sottrarsi alla forza suggestiva delle riformeconcentrate sul porto franco consente di non perdere di vista il con-testo piuÁ ampio, che eÁ quello della regione storica che faceva riferi-mento all'emporio, cioeÁ il Litorale Austriaco, con l'Istria interna e l'a-rea limitrofa della contea di Gorizia e Gradisca.
Occorre tuttavia precisare a cosa si fa riferimento, nel momentoin cui si vuole studiare la regione storica del Litorale. Benche infattiTrieste sia stata sempre considerata una cittaÁ « di fondazione », inquanto disegnata politicamente e urbanisticamente dai sovrani ab-sburgici, il contesto statale nel quale venne a collocarsi non era anco-ra, almeno sino alla fine del XVIII secolo, quello dello Stato centraliz-zato, dotato di una moderna struttura amministrativa. Questo signi-fica che non si puoÁ considerare la societaÁ triestina come un esempiodi societaÁ urbana, alla stregua del modello largamente utilizzato nellostudio degli spazi urbani di Antico Regime che si basa (come nel casofrancese) sul dualismo centro/periferia 21. Se si volesse inseguire que-
64
19 TAMARO, Documenti di storia triestina del secolo XVIII, cit., p. 369.20 Sull'insegnamento giuridico e sulle istanze universitarie settecentesche, un nuovo
contributo di riflessione eÁ giunto negli ultimi anni da DI SIMONE, La questione universi-taria, cit., pp. 487-508.
21 Un approccio simile eÁ ora suggerito anche da D. FRIGO, Trieste, Venezia e l'equi-librio italiano nel Settecento: uomini, territori, traffici, in D. ANDREOZZI, C. GATTI (a curadi), Trieste e l'Adriatico. Uomini, merci, conflitti, Edizioni UniversitaÁ di Trieste, Trieste2005, in particolare pp. 13-33.
sta prospettiva si cadrebbe nella tentazione di utilizzare il modellourbano come strumento per comprendere la nascita e la moltiplica-zione delle istituzioni della cultura e del vivere civile, come accadevanelle capitali, ove peroÁ esisteva una corte principesca o dove eranopresenti antiche istituzioni di tipo accademico 22.
A Trieste, invece, nulla di tutto questo. Tra la fine del Settecentoe l'inizio dell'Ottocento si assiste all'importazione e al continuo adat-tamento nel nuovo contesto di formule culturali non originarie, maderivate dall'esperienza di cittaÁ vicine, estranee persino al nesso ter-ritoriale asburgico: l'accademia dall'Istria costiera, la societaÁ agrariada Gorizia, il teatro da Venezia, la scuola nautica da Fiume. Dal pun-to di vista della storia culturale, quindi, la prospettiva localistica cheparte dallo spazio urbano per ricostruire i processi sociali, giuridici eculturali per la formazione di un moderno ceto borghese deve essererovesciata, per muovere dallo studio dei diversi fenomeni culturali esociali che vi confluirono per dare luogo ad una sintesi e alla creazio-ne di uno spazio culturale del tutto originale 23.
La vita teatrale e musicale puoÁ fornire in questo senso alcuniesempi significativi. Era stata sporadica e occasionale fino al 1751,forse anche perche comunque fino al 1773 sia a Trieste, sia a Gorizia,c'era ancora la concorrenza dei gesuiti, che eseguivano rappresenta-zioni di argomento sacro ma anche profano all'interno dei loro col-legi; i rari libretti teatrali venivano stampati a Venezia, perche da lõÁ
provenivano le compagnie e perche Trieste non aveva una tipografia.
65
22 Sul rapporto fra centro e periferia e sulla funzione dei modelli culturali urbaninella societaÁ di Antico Regime si soffermano GOUBERT, ROCHE, L'Antico Regime, cit.,pp. 249-250. EÁ da notare che tale riflessione sull'assenza di una capitale o di una corte,nell'ambito della storia culturale del Litorale e dell'Istria, eÁ alla base anche dell'ampio edocumentato volume di CAVALLINI, Musica, cultura e spettacolo in Istria, cit.
23 Questa consapevolezza ha consentito di attribuire dignitaÁ e rilievo storiografico afenomeni culturali che in passato, nella storiografia regionale, erano stati quasi del tuttotrascurati, come dimostra il volume curato da I. CAVALLINI, Itinerari del classicismo mu-sicale. Trieste e la Mitteleuropa, Libreria Musicale Italiana, Lucca 1992; si vedano a pro-posito anche le riflessioni di M. GIRARDI, recensione a Itinerari del classicismo musicale,« Rivista italiana di musicologia », XXVIII/2 (1993), pp. 383-385, che opportunamentesottolinea il rapporto tra le forme di classicismo musicale nella Trieste settecentescacon quelle dell'Europa centrale e balcanica (Polonia, Moravia, Croazia).
L'attivitaÁ teatrale era divenuta piuÁ regolare e intensa solo negli anniSessanta dopo la creazione dell'Intendenza Commerciale e grazie allapresenza dell'Intendente conte Niclas Hamilton. Il repertorio, comenoto, era quasi sempre di provenienza veneta e assai scarse erano leprime rappresentazioni e l'esecuzione di opere di autori tedeschi, che± quando giungevano ± venivano conosciute spesso in traduzione ita-liana. L'arrivo del governatore Zinzendorf, nel 1776, aveva portatoad una intensificazione delle attivitaÁ , ma il repertorio era rimastoquello tradizionale proveniente da Venezia, da Bologna e da altre cit-taÁ italiane.
Accanto alle rappresentazioni teatrali, vi erano peroÁ anche altreoccasioni per fare musica: anzitutto nella cattedrale, grazie all'orche-stra e al coro della cappella comunale 24. E poi nelle rappresentazionidomestiche e nelle « accademie di musica », piuÁ frequenti nelle casedella nobiltaÁ di Gorizia, ma presenti anche a Trieste. Giacomo Casa-nova, negli anni del suo soggiorno a Trieste dal 1772 al 1774, curoÁ luistesso l'allestimento di piccole commedie francesi e il diario del conteZinzendorf documenta molte di queste rappresentazioni domestiche,nelle quali gli attori erano gli stessi membri delle famiglie nobili.
Le vicende musicali e teatrali mostrano anche come la letturadella storia culturale triestina alla fine del XVIII secolo non possa pre-scindere da un confronto attento con quella della vicina Gorizia. Edel resto, in questa direzione, si eÁ mossa giustamente gran parte dellaricerca degli ultimi anni: le ricerche sul repertorio melodrammati-co 25, sulle rappresentazioni domestiche e sulle accademie musicali 26
hanno evidenziato i forti legami tra l'esperienza culturale della cittaÁisontina e quella del porto franco. Si tratta di una serie di relazionidocumentate dalle vicende dell'accademia arcadica, sulla quale ci sia-mo soffermati pure nel primo capitolo, e persino dalla presenza edalle attivitaÁ degli ex-gesuiti, i cui progetti educativi ed editoriali ven-nero ideati proprio a Gorizia per essere trasferiti a Trieste nel penul-
66
24 Cfr. CAVALLINI (a cura di) La Civica Cappella di San Giusto, cit.25 Sul teatro di Gorizia, con notizie anche sul teatro di Gradisca, A. ARBO, Il melo-
dramma al teatro `̀ Bandeu'', « Studi Goriziani », LXXI (1990), pp. 8-37.26 A. ARBO, Euterpe sonziaca. Personaggi e vicende della vita musicale a Gorizia dal
Medioevo al Settecento, « Studi Goriziani », LXXVII (1993), pp. 7-36.
timo decennio del Settecento 27. Questo spiega in parte anche la sin-golare vivacitaÁ della vita musicale goriziana e il fatto che, spesso, re-pertori e compagnie teatrali passavano per la cittaÁ isontina prima digiungere a Trieste; cosõÁ avvenne ad esempio nel caso di Lorenzo DaPonte, il librettista di Mozart, venuto nel 1779 a vivere a Gorizia, poial servizio della corte di Vienna e di nuovo tornato in queste regioninegli anni Novanta 28. Le fasi e i tempi di elaborazione della sua tra-gedia Mezenzio, rappresentata in prima assoluta a Trieste nel 1792ma iniziata a scrivere a Gorizia dieci anni prima, possono ben rappre-sentare il quadro di influenze reciproche fra le due cittaÁ giuliane 29.
Il teatro e la vita musicale rappresentano peroÁ soltanto una delleforme di espressione della vita culturale triestina fra Settecento e Ot-tocento, che comunque giaÁ sin d'ora ci appare molto legata a una di-mensione non formalizzata, cioeÁ a luoghi governati da regole createnon sul rigido schema dell'istituzione accademica di Antico Regime,ma su forme piuÁ flessibili della sociabilitaÁ , come lo erano il teatro, icaffeÁ , le librerie come luogo di riunione 30. A Trieste infatti si facevamusica non solo nel teatro, ma anche nelle case private e nei caffeÁ ,che erano allo stesso tempo luoghi di socializzazione, di lettura digiornali e di intrattenimenti musicali 31. Zinzendorf stesso nel suodiario ricorda numerosi di questi caffeÁ e in particolare quello chesi trovava vicino al palazzo del governo, al pianoterra della LocandaGrande: non di rado i cantanti che passavano per Trieste cantavano
67
27 TRAMPUS, I gesuiti e l'Illuminismo cit., pp. 47-48.28 L. DA PONTE, Memorie e altri scritti, a cura di C. PAGNINI, Longanesi, Milano,
1971.29 L. DA PONTE, Il Mezenzio. Tragedia nuovissima in cinque atti, a cura di L. DELLA
CHAÁ , Il Polifilo, Milano 2000.30 Un caso di studio eÁ offerto ora da A. LILTI, Le monde des salons. Sociabilite et
mondanite aÁ Paris au XVIIIe sieÁcle, Fayard, Paris 2005.31 P. COVRE, Svizzeri grigioni a Trieste, « Archeografo Triestino », s. IV, l (1990),
pp. 159-180; inoltre si veda il catalogo della mostra Le insegne dell'ospitalitaÁ. Due secolidi esercizi pubblici a Trieste, Camera di Commercio I.A.A., Trieste 1988. Per riferimentidi carattere piuÁ generale S. PINCUS, `̀ Coffee Politicians Does Create''. Coffeehouses andRestoration Political Culture, « Journal of Modern History », 67 (1995), pp. 807-834 ein particolare, per il caso veneziano che suggerisce molti elementi di contaminazionecon quello triestino, F.M. PALADINI, SociabilitaÁ ed economia del loisir. Fonti sui caffeÁ ve-neziani del XVIII secolo, « Storia di Venezia-Rivista », 1 (2003), pp. 153-281.
al caffeÁ anziche al teatro 32. Del resto il governatore piuÁ volte ebbemodo di interessarsi direttamente della gestione dei caffeÁ e degli in-teressi dei caffettieri, che a Trieste costituivano una categoria econo-mica piuttosto forte, appartenevano quasi tutti alla comunitaÁ lutera-na e provenivano prevalentemente dalla Svizzera.
Il luogo di riunione preferito dalla nobiltaÁ e dalla ricca borghesiatriestina era peroÁ il casino detto « dei nobili », ospitato nei locali dellaLocanda Grande, sulla piazza principale della cittaÁ, di fronte al teatroSan Pietro. Vi si leggevano le gazzette, si faceva conversazione, si gio-cava a carte secondo l'uso veneziano. Gli statuti del casino nobile risa-livano al 1763, quindi al periodo dell'intendente Hamilton, coinciden-te con il rilancio dell'attivitaÁ del teatro San Pietro. Dai pochi documen-ti rimasti risulta che il casino, attivo fino al periodo della primaoccupazione francese di Trieste (1797), pur avendo degli statuti chedisciplinavano l'ammissione dei soci, non aveva le caratteristiche diun'istituzione retta da regole particolarmente rigide e nemmeno tenevariunioni con cadenza regolare 33. Il diario di Zinzendorf eÁ molto riccodi informazioni a tale riguardo; ci informa che vi erano ammessi sia gliuomini sia le donne, che agli incontri partecipavano sia membri dellanobiltaÁ cittadina, di origine antica, sia le persone nobilitate piuÁ recen-temente. Numerosi erano anche i commercianti e gli esponenti del cle-ro. Il vescovo stesso talvolta faceva visita, pur senza partecipare ai gio-chi di societaÁ. Frequente era la presenza dei consoli stranieri e di ospitiprovenienti da altre cittaÁ , austriache, italiane e straniere. Molte infor-mazioni sulla vita di societaÁ che si svolgeva nel casino di Trieste pro-vengono anche dall'Histoire de ma vie di Giacomo Casanova 34. Rac-
68
32 Annotazione di Zinzendorf nel diario del 6 luglio 1777, in PAGNINI (a cura di), Ilperiodo triestino, cit., p. 61.
33 Si veda l'opuscolo anonimo, ma in realtaÁ curato da P. KANDLER, In memoria delprimo secolo compiuto di vita della SocietaÁ del Casino detto il Vecchio di Trieste in occa-sione della prima festa secolare, Tip. del Lloyd Austriaco, Trieste 1863; inoltre il mano-scritto Memorie storiche della societaÁ del Casino Vecchio, in ADTS, segn. 1/2 A14. Suglisviluppi ottocenteschi di questa istituzione cfr. M. CATTARUZZA, Tra logica cetuale e so-cietaÁ borghese: il `̀ Casino Vecchio'' di Trieste (1815-1867), «Quaderni Storici », 26(1991), pp. 419-450, ripubblicato in EAD., Trieste nell'Ottocento. Le trasformazioni diuna societaÁ civile, Del Bianco, Udine 1995.
34 CASANOVA, Storia della mia vita, III, cit., pp. 962-1016.
conta che il casino nobile fungeva sia da luogo di ritrovo fra le famiglienobili e gli ospiti stranieri, sia da luogo di intrattenimento in cui si svol-gevano piccole esecuzioni musicali, per lo piuÁ al cembalo. Inoltre era ilposto in cui si incontravano, al di fuori dell'ufficialitaÁ , i commerciantidel porto franco con i funzionari di governo (come il consigliere Pa-squale de Ricci), discutendo di questioni legate al miglioramento delcommercio e alle prospettive economiche del porto di Trieste 35.
Il casino dei nobili era quindi un luogo di socializzazione model-lato piuÁ sul tipo delle societaÁ di lettura e dei KaffeehaÈuser di area ab-sburgica che non su quello delle accademie e delle societaÁ letterariedi area italiana, contraddistinte da una maggiore specificitaÁ negli in-teressi letterari, scientifici e culturali. CioÁ dipendeva in larga misuraanche dal fatto che a Trieste ± a differenza di Gorizia, di Capodistriae di altre cittaÁ dell'Istria veneta ±, non esisteva una vera e propria tra-dizione accademica (l'ultima accademia aveva cessato le attivitaÁ all'i-nizio del Seicento). Nella vicina Gorizia, assiduamente frequentatada Zinzendorf, sin dall'inizio del Settecento le accademie erano stateinvece piuÁ numerose. Era nata nel 1744 l'Accademia detta dei Filo-meleti, fondata dal conte Sigismondo d'Attems, e nel 1765 era stataaperta una SocietaÁ di Agricoltura 36. Sempre lõÁ, alla metaÁ degli anniSettanta del XVIII secolo, esistevano numerose tipografie, librai, ungiornale. Nel 1779 alcuni nobili goriziani, tra cui Antonio Leopoldoconte d'Attems, il conte Alfonso Antonio di Porcia, assieme al cano-nico di Lubiana Giovanni Antonio Ricci, fondarono una societaÁ chia-mata Nobile societaÁ dei Cavalieri dell'Ordine di Diana cacciatrice, chetenne la sua prima riunione il 21 febbraio di quell'anno 37. Avevaun'organizzazione che per diversi aspetti ricordava quella delle logge
69
35 Vedi anche E. FABER, Fremd- und Anderssein im 18. Jahrhundert. Eine Variationzum Thema am Beispiel von Triest, «Das Achtzehnte Jahrhundert und OÈ sterreich », 12(1997), pp. 29-58.
36 COSSAR, La cultura goriziana e l'accademia settecentesca dei Filomeleti, cit., pp. 51-117.
37 R.M. COSSAR, La `̀ Nobile SocietaÁ de' Cavalieri dell'Ordine di Diana Cacciatrice'',« Studi Goriziani », XXV (1959), pp. 71-78. EÁ sostanzialmente un sunto di questo saggiol'articolo di G. COSSAR, La Nobile SocietaÁ dell'Ordine di Diana Cacciatrice, in Ottocentodi frontiera. Gorizia 1780-1850 Arte e cultura (catalogo della mostra, Gorizia 1995),Electa, Milano 1995, p. 294.
massoniche: si richiamava alla tradizione cavalleresca, imponeva lacerimonia del giuramento per potervi entrare, assegnava ai membriuna divisa e un emblema, un gioiello da portare sull'abito per farsiriconoscere. A capo aveva un «Gran Maestro », funzione che venneofferta nella riunione del 6 novembre 1780 al principe Johann KarlDietrichstein-Proskau; ad essa potevano essere ammesse le donne.Nel 1784 il principe Dietrichstein-Proskau aveva la carica di « granmaestro sostituto », mentre quella di gran maestro era stata conferitaa Ferdinando IV di Borbone re delle Due Sicilie, la cui moglie, la re-gina Maria Carolina, era uno dei soci 38.
Non meraviglia quindi che il modello dell'accademia e, piuÁ in ge-nerale, il gusto per queste forme di socializzazione culturale giunges-sero a Trieste proprio dalla vicina Gorizia, soprattutto negli anni incui era governatore Zinzendorf. CosõÁ nel 1780 l'ex-gesuita romanoGiuseppe de Coletti, che giaÁ era membro dell'Arcadia di Roma eche era nipote dell'ultimo padre generale della compagnia di GesuÁLorenzo Ricci, ebbe l'idea di fondare a Gorizia un'accademia sul mo-dello dell'Arcadia romana alla quale diede il nome di «Accademiadegli arcadi romano-sonziaci ». TrovoÁ la collaborazione del conteGuidobaldo Cobenzl, di altri nobili goriziani, soprattutto di quelliche piuÁ si interessavano e scrivevano di storia e di letteratura, cioeÁil conte Marzio Strassoldo, il conte Rodolfo Coronini Cronberg, i no-bili Carlo Morelli e Alessandro de Fin, l'abate ex gesuita Pietro An-tonio de Codelli e l'abate Lorenzo Da Ponte. La prima riunione av-venne l'8 agosto 1780 nella sala dell'ex collegio dei gesuiti e l'inaugu-razione solenne avvenne l'8 settembre successivo nel palazzoCobenzl 39. I soci si intrattenevano nella lettura e nella conversazione,scrivevano poesie, pubblicavano opuscoli, organizzavano festeggia-menti pubblici, come quello del 2 febbraio 1781 alla presenza del ge-nerale Anton von EszterhaÂzy, comandante del presidio militare diGorizia. Vi erano ammessi sia nobili sia borghesi, ma il numero
70
38 Il primo elenco degli associati apparve nel 1779: Liste alphabeÂtique de tous ceuxqui composent aÁ Gorice la Noble SocieÂte de Diana Cacciatrice depuis l'eÂpoque de son in-stitution originaire en Frioul, le 21 fevrier 1779, de Valerj, Gorice 1779.
39 Sulla storia dell'Arcadia di Gorizia si veda DE FRANCESCHI, L'arcadia romano-son-ziaca, cit., pp. 97-114.
dei membri era molto basso. Tutti usavano uno pseudonimo ispiratoalla letteratura arcadica. Proprio dall'accademia di Gorizia nacquequalche anno piuÁ tardi, nel 1784, quella di Trieste, resa possibiledal fatto che Giuseppe de Coletti si era trasferito nel porto francoe aveva iniziato un'importante attivitaÁ giornalistica. E se si va a guar-dare la composizione sociale dell'arcadia triestina negli anni Ottantae Novanta del Settecento, si puoÁ vedere chiaramente come avesse ab-bandonato definitivamente il modello di societaÁ nobiliare per trasfor-marsi in uno spazio nel quale erano presenti tutte le componenti so-ciali del porto franco, cioeÁ i membri dell'antico patriziato, quelli dellanobiltaÁ piuÁ recente, i commercianti all'ingrosso, i funzionari di gover-no, i membri del clero, gli esercenti altre attivitaÁ e professioni liberalicome i medici, i notai, gli architetti. Si concretizzava cosõÁ il caratterepeculiare della societaÁ triestina, che riusciva a dare contenuti nuovi,sia dal punto di vista culturale sia nell'organizzazione sociale, a spazie luoghi tipici dell'Europa moderna, utilizzando proprio le logichestesse dell'Antico Regime. L'esempio dell'Accademia arcadica diTrieste eÁ calzante: contenuti e societaÁ nuovi entro uno schema antico.
Questa contraddizione solo apparente veniva esplicitata, diecianni piuÁ tardi, all'atto della fondazione della prima biblioteca pubbli-ca, costituita attraverso un fondo librario donato alla cittaÁ dall'acca-demia. Con l'istituzione della biblioteca ± nel 1793 ± veniva allestitaanche una galleria di sei ritratti di « fondatori », formata da una seriedi dipinti ad olio raffiguranti alcuni personaggi giaÁ membri dell'arca-dia; in realtaÁ , come vedremo piuÁ avanti, la scelta dei soggetti ritrattinon era affatto casuale, ne rappresentativa della composizione socialedell'accademia o del numero degli effettivi fondatori della biblioteca,ben piuÁ numerosi. Si trattava dell'autorappresentazione di un cetopolitico, espressione dei vecchi e dei nuovi poteri che si erano forma-ti nella cittaÁ adriatica.
Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento le attivitaÁ cul-turali e quelle teatrali divennero sempre piuÁ legate, come si puoÁ im-maginare, allo sviluppo dell'industria tipografica e libraria. La cittaÁ diTrieste aveva avuto una propria stamperia appena nel 1624, quandoil tipografo Antonio Turrini vi si era stabilito stipulando con il Co-mune un contratto di tre anni per la pubblicazione di documenti uf-ficiali, tra cui gli Statuti comunali. Nei vent'anni di esercizio (morõÁ nel
71
1645) aveva pubblicato appena una ventina di opere, per lo piuÁ pic-coli opuscoli, prediche e poesie d'occasione. Da cioÁ si puoÁ capire co-me in realtaÁ la sua attivitaÁ prevalente dovette essere quella di libraio.Dopo il 1645 Trieste non aveva ospitato piuÁ una tipografia fino al1756, quando il viennese Johann Thomas von Trattner aveva apertouna filiale della propria stamperia, affidandola al genero Franz Winc-kowitz, che si era stabilito a Trieste e che aveva ottenuto dall'Inten-denza Commerciale il privilegio per la stampa dei documenti gover-nativi 40. Alla tipografia Trattner-Winckowitz si era aggiunta nel1774 la tipografia della comunitaÁ armena, fondata dai padri mechita-risti costretti nel 1773 a lasciare l'isola di San Lazzaro a Venezia perstabilirsi a Trieste, dove avevano ottenuto il privilegio di aprire unatipografia con caratteri orientali e occidentali 41. Dal 1781 comincioÁinoltre la propria attivitaÁ , prima attraverso la tipografia Winckowitze poi in proprio, Christian Hieronymus Moll, un tedesco che era sta-to proprietario del teatro di Presburgo e che peroÁ giaÁ nel 1782 ab-bandonoÁ Trieste per ritornare in patria.
Altre tipografie esistevano nella vicina Gorizia e servivano ancheper le pubblicazioni del comune e del governo di Trieste. GiaÁ neglianni Cinquanta del Settecento aveva iniziato la sua attivitaÁ il venezianoGiuseppe Tommasini che, dopo la sua morte avvenuta nel 1777, ven-ne continuata dal figlio Giacomo. Egli si mise in societaÁ con Giuseppede Coletti 42 e assieme ottennero il 9 luglio 1778 un privilegio venten-nale per pubblicare i documenti governativi di Gorizia; nel 1783 ac-quisirono anche il privilegio decennale per la stampa dei documentidel governo di Trieste al posto di Winckowitz e allora il de Colettisi trasferõÁ a Trieste aprendo una filiale della stamperia goriziana.
72
40 U. GIESE, Johann Thomas Edler von Trattner. Seine Bedeutung als Buchdrucker,BuchhaÈndler und Herausgeber, « Archiv fuÈ r Geschichte des Buchwesens-BoÈ rsenblattfuÈ r den Deutschen Buchhandel », 16 (1960), pp. 2153-2366.
41 Sulla comunitaÁ armena di Trieste si veda T. CATALAN, Cenni sulla presenza arme-na a Trieste tra fine Settecento e primo Ottocento, in FINZI, PANJEK (a cura di), Storia eco-nomica e sociale di Trieste, I, cit., pp. 603-612, con riferimenti alla bibliografia preceden-te.
42 Su Giuseppe de Coletti rinvio ancora a DE FRANCESCHI, Giuseppe de Coletti tipo-grafo e giornalista, cit., pp. 4-48 e a ZILIOTTO, Lorenzo Da Ponte e Giuseppe de Coletti,cit., pp. 117-173.
A Gorizia, accanto alla stamperia Tommasini, nel 1773 Valeriode Valerj aveva trasferito da Cividale la propria tipografia, che avreb-be continuato l'attivitaÁ per oltre venticinque anni; ottenne un privi-legio per la stampa di documenti governativi e dall'anno successivoavrebbe iniziato a pubblicare anche un giornale.
Il capitolo sui giornali presenta una ricchezza e una varietaÁ a pri-ma vista insospettabili. Conferma anzitutto che per studiare la storiaculturale di Trieste e del Litorale non si puoÁ ragionare secondoun'impostazione meramente quantitativa della produzione intellet-tuale, cioeÁ andando ad esaminare solo quanti e quali giornali si stam-pavano, quali autori venivano pubblicati, quali e quanti erano gli ele-menti di originalitaÁ . EÁ orientamento ormai consolidato nella storio-grafia europea quello di studiare tali fenomeni anche in termini diconsumo culturale, andando cioeÁ a indagare sulla circolazione dellegazzette, sulle pratiche di lettura, sulla ricezione delle opere di autoripiuÁ noti e sulla rielaborazione delle loro idee nell'ambito della bassaletteratura 43.
Compiere questo passo, dal punto di vista metodologico, con-sente non solo di attribuire dignitaÁ a fenomeni prima trascurati,ma anche di scoprire lo straordinario gioco delle letture e della circo-lazione dei testi nel Litorale di fine Settecento che fa comprenderequanto ampia fosse la diffusione delle idee a fronte di una produzio-ne libraria locale relativamente contenuta. Ci si puoÁ accorgere, cosõÁ,che a Trieste erano diffuse e venivano lette le principali gazzette del-l'epoca, che si potevano trovare al casino dei nobili o nei principalicaffeÁ . Altri periodici giungevano per iniziativa di singole persone,che poi li passavano alla lettura di amici e conoscenti; cosõÁ il gover-natore Zinzendorf si faceva spedire dalla Francia il Journal eÂncyclopeÂ-dique, le EpheÂmeÂrides du citoyen e dall'ambito tedesco le Ephemeri-den der Menschheit. Si ha notizia anche della circolazione di fogli pe-riodici manoscritti che si potevano ottenere per abbonamento, tra cuii Bullettins de Versailles, che Casanova riceveva negli anni del suo
73
43 Le monde comme repreÂsentation, « Annales E.S.C. », numero monografico, XLIV
(1989); D. ROCHE, Une deÂclinaison des LumieÁres, in J. P. RIOUX, J. F. SIRINELLI (a curadi), Pour une histoire culturelle, EÂ ditions du Seuil, Paris 1997, pp. 21-49.
soggiorno triestino e faceva poi leggere agli amici e intellettuali diTrieste e Lubiana, tra cui Sigmund Zois von Edelstein 44.
Per quanto riguarda invece i giornali e i periodici stampati diret-tamente nel Litorale, possediamo un panorama ormai quasi comple-to. Il primo giornale venne stampato a Gorizia a partire dal 30 giu-gno 1774 dal tipografo Valerio de' Valerj con il titolo di «Gazzettagoriziana ». Era settimanale, stampato su due colonne, di piccolo for-mato, e uscõÁ fino al 20 giugno 1776. Sempre il de Valerj pubblicoÁ nel1774 a Gorizia il primo Schematismus, cioeÁ un almanacco contenentela situazione del personale del governo nella contea 45. A Trieste, ilgovernatore Zinzendorf incaricoÁ invece con decreto del 24 dicembre1776 il Magistrato di SanitaÁ Andrea Giuseppe de Bonomo di compi-lare regolarmente gli elenchi in italiano delle portate, cioeÁ dei carichidei bastimenti che approdavano nel porto di Trieste. Questi elenchivenivano poi copiati a mano e distribuiti ai commercianti e dal gen-naio 1777 queste Portate cominciarono ad essere stampate dalla tipo-grafia Winckowitz 46.
A partire dal 28 febbraio 1781 Christian Hieronymus Moll, cheaveva cominciato a lavorare nella tipografia Winckowitz, inizioÁ apubblicare ± come giaÁ accennato nel capitolo precedente ± un gior-nale in lingua tedesca, con il titolo « Triester Welt-Korrespondent ».Di esso sono rimasti pochissimi esemplari, tuttavia sappiamo cheusciva il lunedõÁ e il giovedõÁ in quattro pagine e l'abbonamento annuocostava 5 fiorini. Le pubblicazioni continuarono peroÁ solo fino al1782, anno in cui Moll fece ritorno a Presburgo, in tempo peroÁper curare ancora la pubblicazione, a Graz presso la tipografia Wid-mann, del volume Triester Kaufmanns-Almanach fuÈr das Jahre 1782.Solo nel 1784 ripresero le pubblicazioni di un giornale in lingua te-desca, la « Triester politische und Handlungs-Zeitung », uscita dallatipografia Trattner-Winckowitz a partire dal 5 gennaio 1784 e durata
74
44 TRAMPUS, `̀ Talent et eÂrudition'', cit., pp. 25-36 e infra, cap. VIII.45 Per la pubblicazione e le serie di Schematismus per il Litorale (Trieste e Gorizia)
e la Carniola (Lubiana) si veda il volume a cura di ZÏ ONTAR, HandbuÈcher und KartenzurVerwaltungsstruktur bis 1918, cit.
46 Le notizie piuÁ complete sulla storia dei giornali di Trieste e di Gorizia sono statefornite ancora da PAGNINI, I giornali di Trieste, cit.
circa due anni 47. Dal 3 luglio 1784, infine, Giuseppe de Coletti tra-sferitosi da Gorizia a Trieste, iniziava a pubblicare il giornale in lin-gua italiana « L'Osservatore Triestino », durato fino al 1933.
Da tutto cioÁ si puoÁ trarre conferma del fatto che nella Trieste difine Settecento, rispetto ad una produzione locale ancora relativa-mente esigua, circolavano soprattutto giornali e libri d'importazione,provenienti non soltanto dall'area italiana (e veneta soprattutto), maanche da quella francese e tedesca. Occorre ricordare tuttavia che ingran parte d'Europa, e nelle regioni della monarchia absburgica inparticolare, il problema della libertaÁ di stampa era ancora largamentecondizionato da un'istituzione tipica della societaÁ di Antico Regime,come la censura, sia ecclesiastica sia statale 48. Il Litorale Austriaconon sfuggiva certo a questo ordine di cose. Tuttavia l'opinione del go-vernatore Zinzendorf, che giaÁ dal 1776 nel suo diario manifestava ilparere di non impedire a Trieste la circolazione e la lettura dei libriproibiti, ci fa capire come la tendenza fosse giaÁ quella di allentarela pressione esercitata dal locale ufficio di censura, che di fatto si li-mitava per lo piuÁ a registrare le comunicazioni e gli elenchi di libriproibiti che giungevano da Vienna, operando invece di rado dei se-questri. Quando, nel 1781, Giuseppe II riformoÁ l'intero sistema dellacensura austriaca, concedendo una parziale libertaÁ di stampa e isti-tuendo un'organizzazione censoria centralizzata, la direzione di poli-zia a Trieste non fu costretta a sostanziali cambiamenti nel suo atteg-giamento verso i tipografi e i giornali locali. Questo spiega perche unesame della documentazione dell'archivio di polizia, conservata pres-so l'Archivio di Stato di Trieste, non rivela alcun particolare accani-mento censorio, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto
75
47 Sui giornali triestini di lingua tedesca altre notizie in DE LUGNANI, Il giornalismotedesco a Trieste, cit., pp. 55-74; EAD., La cultura tedesca a Trieste, cit.
48 La letteratura sull'argomento eÁ amplissima; per i numerosi riferimenti alle regionieuropee di lingua tedesca, che interessano anche il Litorale, mi limito a citare il recenteintervento di E. TORTAROLO, Censorship and the Conception of the Public in Late Eigh-teenth-Century Germany: Or, are Censorship and Public Opinion Mutually Exclusive? inD. CASTIGLIONE, L. SHARPE (a cura di), Shifting the Boundaries. Transformation of theLanguages of Public and Private in the Eighteenth Century, University of Exeter Press,Exeter 1996, pp. 131-150.
riguarda il commercio dei libri. Gli atti di governo conservano soltan-to gli elenchi dei libri proibiti trasmessi da Vienna o note informativeche venivano comunicate da Stati esteri, ma scarseggiano le notizie disequestri di libri importati dall'estero o pubblicati nel Litorale.
Purtroppo per la cittaÁ di Trieste ancora troppo poco si eÁ indaga-to sulla consistenza delle biblioteche pubbliche e private tra fine Set-tecento e inizio Ottocento 49. Eppure il materiale documentario nonmanca. Consiste anzitutto nelle annotazioni restituite dagli inventaripost mortem, cioeÁ dagli elenchi di beni redatti in occasione delle pra-tiche di successione aperte e istruite dal Tribunale commerciale emarittimo dopo la morte di commercianti. In quell'occasione venivasteso un inventario completo delle proprietaÁ del defunto, tra cuiquello dei libri, elencati secondo il loro valore, che veniva attribuitoda un perito giurato. EÁ evidente, e cioÁ dipende dalla natura stessadella fonte, che questi inventari sono talvolta imprecisi, mostranola situazione della biblioteca alla data della morte del proprietarioe non ci fanno capire a quando risaliva l'acquisto del volume; talvol-ta, persino, i libri di poco valore sono indicati per lotti senza preci-sare il titolo. Tuttavia sappiamo che a Trieste, negli ultimi anni delXVIII secolo, circolavano i classici della cultura dei lumi, dall'Espritdes lois di Montesquieu al Contrat social di Rousseau, dall'EncylopeÂ-die nell'edizione di Livorno del 1774 alle opere narrative e teatrali diAlbrecht Haller, di Lessing, assieme a molta letteratura francese, an-che di argomento erotico. Gli inventari delle biblioteche dei com-mercianti Johann Heinrich Frohn (morto nel 1794), di Johann BuÈhe-lin (morto nel 1800) e di Alvise Perinello (morto nel 1805) appaionoda questo punto di vista di straordinario interesse 50. Molte interes-santi notizie provengono poi dal catalogo dei libri e dall'elenco delleletture di Pasquale de Ricci, uno dei protagonisti della vita settecen-tesca nel Litorale, artefice ed esecutore di gran parte delle riforme
76
49 Vale la pena di segnalare che per il Friuli veneto esistono invece alcune utili ri-cerche: U. ROZZO (a cura di), Nel Friuli del Settecento, biblioteche, accademie e libri, Artigrafiche friulane, Udine 1996, 2 voll.; D. RAINES, La famiglia Manin e la cultura librariatra Friuli e Venezia nel '700, Arti grafiche friulane, Udine 1997.
50 ASTS, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 137 ex 1794, busta 138, n. 8 ex1800; busta 139, n. 1342 ex 1805.
economiche e amministrative, le cui letture spaziavano dai classicidella fisiocrazia francese alle opere dei maggiori mercantilisti euro-pei 51. Un'altra fonte importante eÁ quella delle biblioteche massoni-che private ± sulle quali ritorneremo piuÁ avanti in un capitolo succes-sivo -, che documentano la circolazione e il possesso di libri smerciatianche al di laÁ dei controlli di polizia.
Tuttavia, rispetto alle scarse notizie di cui si poteva disporre finoa una decina di anni fa, conosciamo oggi meglio una realtaÁ piuÁ spe-cifica, che eÁ di grande importanza per la storia della cultura giulianafra '700 e '800, cioeÁ il catalogo del fondo originario della BibliotecaCivica di Trieste. La biblioteca pubblica, nata come si eÁ giaÁ accenna-to nel 1793, venne costituita principalmente attraverso il dono di vo-lumi offerti dai membri dell'arcadia romano-sonziaca. Uno studio av-viato in occasione del secondo centenario dell'istituzione, e soltantoin parte giunto a termine 52, ha permesso di individuare e ricostruireil nucleo di 2296 titoli che andarono a comporre la fisionomia origi-naria della biblioteca.
Da questa indagine sono emersi dei dati estremamente significa-tivi ai fini del nostro discorso. In primo luogo la conferma che a Trie-ste, a differenza di altre cittaÁ europee e austriache, le biblioteche deiconventi e degli ordini religiosi ± soppressi negli anni Ottanta ± nonconfluirono nella biblioteca comunale ma andarono irrimediabilmen-te perdute. Questa dispersione ci ha sottratto molte conoscenze sulleletture e sulla circolazione dei libri nella Trieste di etaÁ moderna. Insecondo luogo si eÁ potuto constatare che nella fisionomia originariadella biblioteca predominava la cultura di lingua tedesca, a fronte diuna minore rappresentanza di quella italiana e francese e della quasitotale assenza della lingua inglese.
77
51 BIAGI, Giuseppe Pasquale Ricci, cit. Su Ricci si veda peroÁ anche E. FABER, La con-tea dell'Istria in una relazione del consigliere dell'Intendenza Pasquale de Ricci (1762),«Quaderni Giuliani di Storia », XX, 2 (1999), pp. 221-244 e D. ANDREOZZI, Tra centroe periferia: Pasquale Ricci e la Commissione sulle manifatture e fabbriche del Litorale1763-1776, in ANDREOZZI, GATTI (a cura di), Trieste e l'Adriatico, cit., in particolarepp. 126-145.
52 R. MASIERO, In una biblioteca, a Trieste, in La fondazione della Biblioteca civica`̀ Attilio Hortis'' cit., pp. 9-44.
Se ci inoltriamo nella lettura del catalogo 53, si possono ricono-scere alcuni settori di particolare rilievo: il fondo donato dall'ex ge-suita e vescovo Sigmund von Hohenwart, nel momento in cui lascioÁTrieste per diventare arcivescovo di Vienna (1791), e quello donatoda Andrea Stadler, docente alla scuola nautica. Fra i testi, accanto aun buon numero di classici latini e a qualche decina di libri di poesia(il genere romanzesco scarseggia), prevalgono gli almanacchi, i dizio-nari e le grammatiche, nonche i testi di argomento scientifico e po-litico-giuridico. Moltissime, come si eÁ detto, le opere in lingua tede-sca. L'impressione generale che se ne trae eÁ quella di trovarsi di fron-te ad una biblioteca con testi destinati non tanto all'ornamento, allarappresentazione e al prestigio della comunitaÁ triestina, quanto allaconsultazione e all'uso pratico. In altre parole, la dotazione originariadella biblioteca comunale doveva servire da corredo alla formazioneculturale e alle esigenze quotidiane dei commercianti e dei funziona-ri, e come tale andava ad affiancare le altre biblioteche « di servizio »esistenti nel Litorale 54.
Chi voleva acquistare libri doveva rivolgersi principalmente ai ti-pografi locali, che oltre all'officina tipografica avevano anche unapiccola libreria. Naturalmente spesso occorreva ordinare i libri aVienna o all'estero, anche se l'attesa durava molti mesi e l'arrivodel libro non veniva garantito. PercioÁ erano largamente utilizzatimeccanismi alternativi, primo fra tutti quello del prestito. Il diariodi Zinzendorf documenta molti esempi di libri dati o ricevuti in pre-stito da amici o da nobili locali. Questa pratica avveniva anche con icorrispondenti di altre cittaÁ , come nel caso del commerciante e lette-rato Sigmund Zois von Edelstein, che da Lubiana inviava spesso aZinzendorf libri francesi e tedeschi 55. L'alternativa era quella di pro-
78
53 Il catalogo, di 120 pagine dattiloscritte, non eÁ ancora apparso a stampa. Devo lapossibilitaÁ di averlo studiato alla generosa disponibilitaÁ della dott.ssa Anna Rosa Ruglia-no.
54 Sulle biblioteche di servizio e per alcune notizie su quella degli uffici di governo edegli uffici giudiziari cfr. P. DORSI, C. BIANCO, La biblioteca dell'I.R. Corte d'Appello aTrieste, « Archeografo Triestino », s. IV, XLVIII (1988), pp. 147-158.
55 A. TRAMPUS, All'orizzonte degli Slavi del sud: Sigismondo Zois e Karl von Zinzen-dorf, «MuÈnchner Zeitschrift fuÈ r Balkankunde », 9 (1993), pp. 45-52 e infra, cap. IV.
curarsi i volumi direttamente, facendoli acquistare e poi spedire daqualche amico o corrispondente. CosõÁ faceva Zinzendorf negli annidella sua permanenza e, quando non poteva trovare a Vienna i libriche desiderava, li comprava ± come emerge dalle annotazioni del dia-rio ± a Lipsia tramite amici o a Marsiglia grazie al console austriacoJakob Kick.
Rimane invece poco comprensibile la scarsa attenzione dedicataagli sviluppi della massoneria nel Litorale Austriaco di fine Settecen-to, soprattutto di fronte alla grande tradizione di studi europei chegiaÁ da tempo ha individuato nelle logge uno dei luoghi pubblicipiuÁ importanti per la diffusione della cultura dei lumi e per la crea-zione di nuove forme di sociabilitaÁ 56. Gli studi condotti sulla figura esull'attivitaÁ di Francesco Emanuele Giuseppe Baraux, al quale eÁ de-dicato il capitolo X di questo volume, mostrano almeno in parte qua-le fu il rapporto fra le logge triestine e la muratoria europea.
Nelle grandi linee, questa era dunque la situazione complessivadella cultura nel Litorale Austriaco. L'immagine che ci viene conse-gnata dalle fonti e dalle ricerche condotte negli ultimi anni restituiscecosõÁ un quadro della societaÁ locale che si pone a pieno titolo in quellopiuÁ ampio della societaÁ europea di etaÁ moderna. Tutto cioÁ porta adue riflessioni di carattere piuÁ generale: la prima in ordine al modoin cui si puoÁ studiare e interpretare la storia cittadina a cavallo traSette e Ottocento, la seconda sulla specialitaÁ o meno della situazionetriestina rispetto ad un contesto europeo piuÁ generale.
EÁ evidente, infatti, che per indagare utilmente sulla societaÁ e sullacultura del porto franco tra Settecento e Ottocento non si puoÁ ragio-nare in termini di discontinuitaÁ e di rotture, assumendo la societaÁ e lacultura di primo Ottocento quali esempi di un mondo nuovo, ma oc-corre utilizzare una dimensione temporale piuÁ lunga, e fare riferi-mento alle logiche dell'Antico Regime. Non a caso, peraltro, oggisi tende a posporre i limiti della periodizzazione della storia moderna
79
56 Si vedano, tra le opere piuÁ recenti, M.C. JACOB, Massoneria illuminata, tr. it., Ei-naudi, Torino 1995; G. GIARRIZZO, Massoneria e Illuminismo nel Settecento europeo,Marsilio, Venezia 1994; si vedano anche A. TRAMPUS, La massoneria in etaÁmoderna, Ro-ma-Bari, Laterza, 20062 e G. M. CAZZANIGA (a cura di), Massoneria, in Storia d'Italia.Annali 21, Einaudi, Torino 2006.
al 1848 57, mentre eÁ noto che a Trieste e nel Litorale ± come del restoin gran parte dell'ambito germanico ± le conseguenze della Rivolu-zione francese furono alquanto tenui. Studiare la storia del Litoralenel primo Ottocento apprezzandone le continuitaÁ con il mondo set-tecentesco non significa affatto emarginare o sottovalutare l'origina-litaÁ della cultura e della societaÁ triestine rispetto ad un piuÁ vasto qua-dro europeo. Viceversa, se ci si avvicinasse alla storia del Litorale set-tecentesco muovendo da concettualizzazioni proprie del maturoOttocento, cioeÁ dell'etaÁ delle rivoluzioni liberali che presuppongonogiaÁ l'esistenza di un'ideologia borghese e il consolidamento di unanuova sfera pubblica e politica 58, molti dei fenomeni che abbiamoesaminato rimarrebbero incomprensibili.
La societaÁ triestina fra Settecento e Ottocento, almeno fino a tut-ta l'epoca della Restaurazione, conserva infatti molte caratteristichedella societaÁ per ceti o ordini dell'Antico Regime, assieme alle strate-gie culturali tipiche dell'Europa della fine del XVIII secolo, ove giaÁ sicercava di realizzare ± pur utilizzando gli antichi abiti istituzionali ±una nuova ideologia del talento e del merito. Questo spiega percheÂnel Litorale il processo di modernizzazione avvenne gradualmenteproprio grazie all'utilizzo delle strutture di Antico Regime, e percheÂla nuova aristocrazia del denaro, motore di questi cambiamenti, ven-ne a inserirsi all'interno del mondo antico, utilizzandone i meccani-smi, rivendicando privilegi e rilegittimando, in questo modo, spazie istituzioni che altrove stavano scomparendo.
Non eÁ quindi affatto paradossale constatare che la nuova classemercantile utilizzoÁ fino alla metaÁ dell'Ottocento logiche di tipo ce-tuale per affermare la propria rappresentativitaÁ . Questo si puoÁ benvedere nel momento in cui si voglia andare a esaminare il concettodella « cittadinanza », come veniva inteso nella Trieste di fine XVIII
80
57 Cfr. C. CAPRA, Storia moderna 1492-1848, Le Monnier, Firenze 2004, in partico-lare le pp. I-XIII in cui si chiariscono i problemi di periodizzazione.
58 Mi riferisco alla possibilitaÁ di riprodurre, nel caso triestino, le prospettive di ri-cerca che puntano a riconoscere la nascita di un moderno ceto economico borghese al-l'interno di fenomeni di forte polarizzazione e differenziazione sociale. EÁ un'ipotesi nonestranea al modello storiografico proposto da J. HABERMAS, Storia e critica dell'opinionepubblica, tr. it., Laterza, Roma-Bari 1988 (prima edizione tedesca 1962).
e di inizio XIX secolo 59. Come eÁ noto, l'idea della cittadinanza nellastoria moderna ± e cosõÁ anche nella storia triestina ± non era quellalegata alla rivendicazione di una serie di diritti politici, che sarebberostati richiesti soltanto con le rivoluzioni del 1848. Era piuttosto l'ideatipicamente settecentesca della cittadinanza come condizione sociale egiuridica di chi aspirava alla rivendicazione e alla conferma delle liber-taÁ economiche concesse agli abitanti non nobili della cittaÁ . Del resto,basta guardare alle Grundlage des Naturrechts (Basi di diritto naturale)di Johann Gottlieb Fichte (1796) per chiarire come, soprattutto nellospazio tedesco, il concetto di cittadinanza fosse di natura giuridica, piuÁche politica. Fichte infatti ben spiegava che il principio della cittadi-nanza serviva a rivalutare il diritto locale (o municipale, BuÈrgerrecht)per individuare i limiti da porre all'intervento politico e giuridico delloStato, che si esprimeva sia attraverso il diritto pubblico, sia attraversoil diritto delle genti (Staatsrecht, Menschenrecht). Il BuÈrgerrecht, cherappresentava quindi il complesso delle leggi vigenti nelle cittaÁ , e ilBuÈrgerstand, cioeÁ la condizione di cittadino, esprimevano la vis politi-ca, la forza dei ceti urbani (BuÈrgertum) a difesa degli ordinamenti cit-tadini rispetto allo Stato centralizzatore e alle norme giuridiche da essoemanate 60. A Trieste, peroÁ , esistevano due cittaÁ : quella nuova soggettaalle leggi dello Stato a protezione dei negozianti e quella antica, sog-getta alle leggi municipali che tutelavano l'antica aristocrazia. Ragioneper la quale, come vedremo nel prossimo capitolo, sin dalla metaÁ delSettecento andarono formandosi due concetti di cittadinanza in con-correnza tra loro, uno riferito alla garanzia delle libertaÁ economiche,l'altro riferito alla conservazione dei privilegi comunali.
I commercianti che giungevano nell'emporio e diventavano « cit-tadini » aspiravano alla prima forma di cittadinanza attraverso la
81
59 Un approccio a questo tema in A. MILLO, Dalla comunitaÁalla cittaÁ. Stato, mercatoe borghesia a Trieste nel Settecento, «Neoclassico », 7-8 (1995), pp. 5-20.
60 La trattazione piuÁ chiara sulla condizione giuridica del cittadino e sul concetto dicittadinanza in etaÁ moderna, che vengono distinti chiaramente dai caratteri dell'ideolo-gia borghese di metaÁ Ottocento, eÁ fornita ora da M. STOLLEIS, Staat und StaatraÈson in derfruÈhen Neuzeit. Studien zur Geschichte des oÈffentlichen Rechts, Suhrkamp, Frankfurt amMain 1990 (tr. it. Stato e ragion di stato nella prima etaÁ moderna, il Mulino, Bologna,1998).
« naturalizzazione », e miravano a raggiungere la condizione di sud-diti austriaci, che li poneva all'interno del sistema di regole e di pro-tezioni giuridiche assicurate dallo Stato. Presso l'Archivio di Stato diTrieste giacciono ancora molte di queste pratiche. Invece non inte-ressava loro la diversa condizione giuridica di « cittadino » che preve-deva un assoggettamento alle norme e agli statuti comunali, meno fa-vorevoli; il fatto che il ceto mercantile si insediasse nel cosiddetto« distretto camerale » fuori dalle antiche mura, dando vita alla cittaÁnuova 61, che sin dall'origine era sottratta alla giurisdizione del Co-mune tergestino, non li poneva certo in una condizione di extrater-ritorialitaÁ , ma sicuramente in una situazione di specialitaÁ , in quanto lagiurisdizione su di loro era affidata direttamente al governo.
Queste caratteristiche del ceto mercantile triestino, che privilegioÁil legame con lo Stato rispetto a quello con il municipio e costruõÁ lapropria identitaÁ nel piuÁ ampio contesto dei paesi ereditari della mo-narchia absburgica, mostra anche come la cultura e gli atteggiamentipolitici della societaÁ triestina non possano essere in alcun modo com-parati con quelli delle borghesie di altre cittaÁ europee nelle quali esi-stevano tradizioni di autonomia, come ad esempio quelle tedeschedell'area anseatica. LõÁ la rivendicazione delle libertaÁ cittadine signifi-cava respingere le idee di apertura e di tolleranza, difendere gelosa-mente il bando religioso come segno della propria autoritaÁ rispettoall'Impero, impedire la costruzione dello Stato moderno e, non di ra-do, giungere a gravi collassi economici 62. Il mito delle cittaÁ anseati-che culle della tolleranza, della libertaÁ di opinione e della coscienzatedesca eÁ un'invenzione del XIX secolo, creata per mascherare ± come
82
61 Un profilo sociale e demografico si puoÁ ricavare dai saggi di M. BRESCHI, A.KALC, E. NAVARRA, La nascita di una cittaÁ. Storia minima della popolazione di Trieste secc.XVIII-XIX e di C. VISINTINI, La crescita urbana, in FINZI, PANJEK, Storia economica e so-ciale di Trieste, I, cit., rispettivamente alle pp. 69-238 e 239-270.
62 H. SCHILLING, Corti e alleanze. La Germania dal 1648 al 1763, tr. it., il Mulino,Bologna 1999, pp. 164-165; per il diverso profilo del Litorale cfr. E. FABER, Il problemadella tolleranza religiosa nell'area alto-adriatica nel secondo Settecento, in F. AGOSTINI (acura di), Veneto, Istria e Dalmazia tra Sette e Ottocento. Aspetti economici, sociali e reli-giosi, Marsilio, Venezia 1999, pp. 105-124.
hanno dimostrato gli storici ± i conflitti religiosi, le limitazioni dellelibertaÁ cittadine e il rigido legame fra Stato e chiesa luterana 63.
All'interno di questo quadro, i processi di elevazione sociale e dimutamento di status o condizione rimanevano essenzialmente legati almondo dell'Antico Regime e ai criteri che si erano affermati in tut-t'Europa nel XVIII secolo. Gli abitanti della cittaÁ nuova, a Trieste, aspi-ravano in primo luogo alla nobilitazione, cioeÁ volevano accedere agliordini privilegiati, e per raggiungere questo scopo utilizzavano i nuovicriteri del talento e del merito rappresentati dalla ricchezza economi-ca. Quasi tutti i facoltosi negozianti triestini del Settecento riuscironoad acquisire il titolo di conte o di barone e a costituire quindi il corpodella nobiltaÁ piuÁ recente che andoÁ ad affiancarsi, e poi a sostituirsi,all'antico ceto patrizio. CosõÁ il ceto aristocratico, nella Trieste di fineSettecento e di primo Ottocento, non scomparve semplicemente, co-me avvenne in altri ambiti urbani, ma si trasformoÁ e si rinnovoÁ , sosti-tuendo alla vecchia nobiltaÁ di sangue la piuÁ recente noblesse de robe,la nobiltaÁ di servizio. Questo spiega perche nel 1776 e poi ancora nel1808 vennero cooptati nel Consiglio dei patrizi numerosi commer-cianti giaÁ nobilitati e solo l'occupazione francese del 1809 riuscõÁ a sop-primere quest'organo di governo. Ma non saraÁ un caso che, alla Re-staurazione, proprio un erede del ceto mercantile e rappresentantedella nobiltaÁ nuova, Domenico Rossetti, si impegneraÁ per la ricostitu-zione del Consiglio e per la restituzione dei privilegi antichi 64.
83
63 SCHILLING, Corti e alleanze cit., p. 165; J. WHALEY, Religious Toleration and So-cial Change in Hamburg 1529 bis 1819, Cambridge University Press, Cambridge 1985.Diverse sono le conclusioni cui giunge M. CATTARUZZA, Cittadinanza e ceto mercantile aTrieste 1749-1850, in EAD. (a cura di) Trieste, Austria, Italia tra Settecento e Novecento.Studi in onore di Elio Apih, Del Bianco, Udine 1996, pp. 57-84, dove suggerisce di esten-dere alla societaÁ triestina del Settecento considerazioni che muovono da una prospettivatipicamente ottocentesca, giaÁ illustrate in EAD., Trieste nell'Ottocento, cit., in particolarealle pp. 11-58. Sull'argomento l'a. eÁ poi ritornata, opportunamente in termini piuÁ pro-blematici, in EAD., Il primato dell'economia. L'egemonia politica del ceto mercantile(1814-1860), in R. FINZI, C. MAGRIS, G. MICCOLI (a cura di), Storia d'Italia. Le regionidall'UnitaÁ a oggi. Il Friuli-Venezia Giulia, I, Einaudi, Torino 2002, pp. 148-162
64 P. KANDLER, Storia del consiglio dei patrizi, Tip. del Lloyd Austriaco, Trieste 1858(nuova edizione con introduzione di G. CERVANI, Lint, Trieste 1976). Una significativaconferma sui meccanismi e sui processi di elevazione sociale perduranti nell'Ottocentotriestino viene dalla ricerca di T. CATALAN, Ordini cavallereschi e notabilato triestino dal
Un discorso analogo va fatto per quanto riguarda le vicende e lafunzione della Borsa mercantile, istituita nel 1755 come organo dirappresentanza dei commercianti. Era il punto di contatto fra lo Sta-to e i mercanti, serviva a rivendicare il privilegio dei commercianti aessere consultati nelle decisioni piuÁ importanti assunte dal governo,ad essere giudicati da una magistratura speciale (il Tribunale com-merciale e marittimo), a rendere riconoscibile la loro condizione an-che a mezzo di uniformi e appositi abiti cerimoniali. I capi della de-putazione di Borsa facevano parte delle commissioni governative, tracui quella per l'ispezione nelle scuole, ed erano frequentemente con-sultati quando il governo doveva assumere decisioni di natura econo-mica e politica 65. La Borsa, che ebbe dal 20 giugno 1755 il primoregolamento approvato da Maria Teresa, manteneva gli elenchi deinegozianti, dei sensali, dei capitani marittimi e dei trasportatori lacui attivitaÁ era autorizzata dal governo; vi si trovavano inoltre glielenchi delle merci che arrivavano via mare (le portate dei bastimenti)e il registro dei noleggi. Per iscriversi alla Borsa i commercianti do-vevano versare una cauzione di 1000 fiorini; l'assemblea dei commer-cianti discuteva e votava le questioni riguardanti la vita economicainterna del ceto mercantile, la navigazione, le richieste da inoltrareal governo; il direttore e il vicedirettore venivano eletti dall'assembleae la loro nomina veniva poi ratificata dal governo 66. Potevano essereammessi alla Borsa solo i commercianti di religione cristiana, cattoli-ca, ortodossa o protestante; non vi erano ammessi i commerciantiebrei di Trieste, che pure avevano visto abolita giaÁ nel 1769 la Leib-maut o Leibsteuer, cioeÁ la tassa che ogni ebreo doveva pagare nei
84
1814 al 1914, in L. PONZIANI (a cura di), Le Italie dei notabili: il punto della situazione,Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001.
65 Sulla Borsa mercantile di Trieste vedi P. GASSER, Triestiner Handel vor 1790,«Mitteilungen des oÈ sterreichischen Staatsarchivs », 24 (1972), pp. 245-279; U. TUCCI,Die Triester Kaufmannschaft im 18. Jahrhundert. Ihre Ausrichtung, ihre Gutachten, inBeitraÈge zur Handels- und Verkehrsgeschichte. Grazer Forschungen zur Wirtschafts- undSozialgeschichte, 3, Graz 1978, pp. 121-132; U. COVA, La Borsa mercantile triestina, ri-flessioni sulla sua funzione di organo consultivo, in Da Maria Teresa a Giuseppe II, cit.,pp. 65-70.
66 Il testo del primo regolamento della Borsa di Trieste eÁ pubblicato in P. KANDLER,Emporio e portofranco, Tip. del Lloyd Austriaco, Trieste 1864, pp. 217-219.
paesi ereditari austriaci per poter entrare in una cittaÁ diversa dallapropria 67. Solo negli ultimi anni del governatorato di Zinzendorf sicomincioÁ a discutere della possibilitaÁ di ammettere anche i commer-cianti ebrei, seppure senza diritto di voto; dal 1780 la Borsa ebbe ildiritto di eleggere una deputazione, cioeÁ due deputati, che la rappre-sentasse presso gli organi di governo. La deputazione non si presen-tava quindi come un'organizzazione neocorporativa (e del resto lecorporazioni a Trieste sarebbero state abolite appena dopo il1809), ma era invece un organo di rappresentanza cetuale che ri-spondeva alle regole e alle esigenze tipiche della societaÁ settecentesca.
All'interno di questo stesso quadro puoÁ essere oggi ricollocatoun aspetto tipico della societaÁ triestina del XVIII e del XIX secolo,che consiste nel suo carattere cosmopolita 68 e nella sua vocazionepluriconfessionale. EÁ sin troppo noto il fatto che il cosmopolitismo,termine reinventato da Guillaume Postel nel 1544, si presenta stori-camente come un fenomeno tipicamente settecentesco, e che non sitrattava semplicemente di una moda culturale ma di una tensione eti-ca e civile, che non a caso trovava la sua massima espressione nelmondo massonico e in quello dei lumi. Il celebre racconto autobio-grafico di Louis-Charles Fougeret de Montbron Le cosmopolite, ou lecitoyen du monde (1750) rappresentava, nella cultura del XVIII secolo,la rivendicazione dell'intellettuale ad una indipendenza assoluta neiconfronti dei vincoli politici del proprio paese e nei confronti di ognimorale, secondo la stessa linea di pensiero che venne riproposta daImmanuel Kant dalle pagine della « Berlinische Monatsschrift » del
85
67 ASTS, Cesareo Regio Governo del Litorale, busta 83, copia delle franchigie con-cesse da Maria Teresa agli ebrei di Trieste nel 1769 e confermate con editto del 19 aprile1771 e inoltre istanze dei capi della comunitaÁ ebraica a Zinzendorf dell'autunno 1776 edel 21 febbraio 1777. Sulla condizione degli ebrei triestini vedi L.C. DUBIN, Les liaisonsdangereuses. Mariage juif et eÂtat moderne aÁ Trieste au XVIIIe sieÁcle, « Annales HSS », 5(1994), pp. 1139-1170.
68 Sul tema del cosmopolitismo triestino, con riferimento alla sua dimensione set-tecentesca, si vedano i saggi di F. SALIMBENI, Variazioni storiografiche e culturali suuna `̀ cittaÁ nuova'': Trieste tra Sette e Ottocento, A. TRAMPUS, Dal cosmopolitismo europeoal cosmopolitismo triestino: convergenze o divergenze?, e I. CAVALLINI, Gli intellettualitriestini e la musica del periodo classico, tutti in CAVALLINI (a cura di), Itinerari del classi-cismo musicale cit., rispettivamente alle pp. 63-80, 81-94 e 95-104.
1784, quando discusse i lineamenti di una storia universale dal puntodi vista cosmopolita (weltbuÈrgerliche Zustand) 69. Nella cultura delSettecento appellarsi al cosmopolitismo significava soprattutto riven-dicare i diritti di libertaÁ senza dover dipendere dalle istituzioni e dalriconoscimento dei diritti di cittadinanza.
Ecco perche il ceto mercantile triestino rivendicava il proprio ca-rattere cosmopolita, preferendo la naturalizzazione nel quadro dellamonarchia absburgica piuttosto che la cittadinanza tergestina. Per lasocietaÁ triestina di fine Settecento e di inizio Ottocento, definirsi co-smopolita significava ± sulla scia della tradizione illuminista ± appro-priarsi di una dimensione politica che la legittimava socialmente di-nanzi allo Stato absburgico e di fronte alle magistrature comunali.Tutt'altra cosa saraÁ il cosmopolitismo triestino di metaÁ Ottocento: sa-raÁ la memoria storica di un'esperienza ormai confluita nell'identitaÁborghese del secolo delle rivoluzioni liberali costituzionali.
Specchio di questa natura cosmopolita e dei valori di tolleranzache vi erano connaturati appaiono le vicende e gli atteggiamenti del-l'Illuminismo ebraico a Gorizia e a Trieste sul finire del XVIII secolo.EÁ merito di alcuni recenti contributi italiani e stranieri l'aver appro-fondito la dimensione culturale del problema della tolleranza nel Li-torale Austriaco 70. Oggi possediamo conoscenze molto piuÁ precisenon soltanto sulle vicende interne delle comunitaÁ religiose, ma anchesui rapporti culturali da esse intrattenuti col resto d'Europa. Il casodella comunitaÁ ebraica eÁ di grande interesse. Esso ci conferma anzi-tutto che la promozione e l'elevazione sociale venivano ricercate al-l'interno delle logiche della societaÁ settecentesca, tanto che nel Lito-rale i provvedimenti emancipatori di Giuseppe II, nel 1781, vennero
86
69 W. FRIJHOFF, Cosmopolitismo, in FERRONE, ROCHE (a cura di), L'Illuminismo. Di-zionario storico, cit., pp. 21-30.
70 E. FABER, Riforme statali nel Litorale austriaco nel secondo Settecento, in F. AGO-
STINI (a cura di), L'area alto-adriatica dal riformismo veneziano all'etaÁ napoleonica, Mar-silio, Venezia 1998, pp. 423-448; EAD., Il problema della tolleranza religiosa nell'area al-to-adriatica nel secondo Settecento, in F. AGOSTINI (a cura di), Veneto, Istria e Dalmaziatra Sette e Ottocento. Aspetti economici, sociali e ecclesiastici, Marsilio, Venezia 1999, pp.105-124. Gli studi di Eva Faber, avviati con il suo volume Litorale Austriaco, cit., sonooggi di fondamentale importanza per comprendere le dinamiche dell'emporio nella se-conda metaÁ del XVIII secolo.
accolti con sfavore e furono seguiti da forme di resistenza, in quantodi fatto limitavano i privilegi che gli ebrei triestini e goriziani giaÁ go-devano dagli anni Sessanta 71. Tutto questo non impedõÁ ad ogni mo-do la straordinaria ricezione dell'Illuminismo ebraico, dell'Haskalah,all'interno della comunitaÁ ebraica locale, grazie anche ai rapportistretti con quella di Gorizia e con i maggiori rappresentanti della cul-tura ebraica europea, tra i quali Moses Mendelssohn 72. Si realizzavacosõÁ anche nel porto franco triestino quell'evoluzione e maturazionedall'idea di tolleranza religiosa verso quella di tolleranza civile, cheavrebbe contribuito alla nascita di una nuova etica, di una nuova cul-tura politica 73.
La contrapposizione, tanto sottolineata nell'Ottocento dallo sto-rico triestino Pietro Kandler, fra « cittadini » e « borghigiani » cioeÁfra abitanti della cittaÁ antica e abitanti della cittaÁ nuova, al di laÁdel suo impatto polemico nei confronti dell'arretrata organizzazionemunicipale, oggi fa soprattutto sorridere. Certamente non puoÁ piuÁvenire assunta a paradigma storiografico per comprendere le dinami-che del ceto mercantile triestino fra la seconda metaÁ del XVIII secolo e
87
71 E. FEHRENBACH, BuÈrgertum und Liberalismus 1770-1815, in E. BRUCKMUÈ LLER,BuÈrgertum in der Habsburgermonarchie, I, BoÈhlau, Wien-KoÈ ln-Weimar, 1990, pp. 1-62; A. MILLO, Das triestiner BuÈrgertum. Kollektive Verhalten, politische Beteiligung, kul-turelle IdentitaÈt, in H. Stekl (a cura di), `̀ Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtig-keit''. BuÈrgertum in der Habsburgermonarchie, II, BoÈhlau, Wien-KoÈ ln-Weimar 1992,pp. 69-81. PiuÁ ampiamente T. CATALAN, La comunitaÁ ebraica di Trieste (1781-1914), po-litica, societaÁ e cultura, Lint, Trieste 2000, pp. 199-203, che mette bene in luce le diverseaspirazioni della comunitaÁ ebraica settecentesca rispetto a quelle espresse nel secolo suc-cessivo. Riferimenti anche in E. BRUCKMUÈ LLER, Triest und OÈsterreich im 18. Jahrhundert,«OÈ sterreichische Osthefte », 3 (1985), pp. 300-327.
72 Sul tema ora M. DEL BIANCO COTROZZI, Un incontro fra letterati alla fine del Set-tecento: il carteggio di Elia Morpurgo con Giovanni Bernardo De Rossi, « Annali di storiaisontina », 4 (1991), pp. 35-64; L.C. DUBIN, Trieste and Berlin: the Italian Role in theCultural Politics of Haskalah, in J. KATZ (a cura di), Toward Modernity: The EuropeanJewish Model, New Brunswick, NJ-Oxford 1987, pp. 189-224, ma anche M. GRUSOVIN,L'haskalah e la trasformazione dell'ebraismo nell'Europa illuminista, «Kadmos-Studi mit-teleuropei », I (2001), pp. 25-44.
73 DUBIN, The Port Jews of Habsburg Trieste, cit., in particolare le pp. 95-154. Sivedano anche le riflessioni di G. KLINGENSTEIN, Modes of Religious Tolerance and Into-lerance in Eighteenth-Century Habsburg Politics, « Austrian History Yearbook », XXIV
(1993), pp. 1-16.
la metaÁ di quello successivo, come del resto autorevolmente venivascritto giaÁ quarant'anni fa da chi criticava « il quadro pittoresco,ma spiritualmente piuÁ povero, di una cittaÁ frequentata da affaristidi ogni nazione » 74.
Liberatisi infine delle vecchie istituzioni, il vecchio commerciantee massone Francesco Emanuele Giuseppe Baraux poteva polemizza-re con Domenico Rossetti, che nel 1814 voleva ristabilire gli antichiprivilegi e le attribuzioni del Consiglio dei patrizi. Secondo Baraux,Domenico Rossetti « per i suoi principi anteporrebbe all'utilitaÁ delcommercio gli antichi privilegi ed alcune rancide e futili prerogative,e dei vani e inconcludenti diritti che neppure sono piuÁ adatti ne aitempi in cui viviamo, ne agl'usi e costumi presenti, ne al sistema at-tuale del governo austriaco » 75. E ancora: « il corpo mercantile, contutto quello che vi eÁ occorso, che vi eÁ addetto, che ne dipende e viveda questo, comprende piuÁ di nove decimi della popolazione di Trie-ste; e con tutto cioÁ una classe cosõÁ numerosa e cosõÁ interessante, sitrova nonostante senza rappresentanza e senza influenza ». Per l'an-ziano protagonista della vita commerciale e massonica settecentescanon era piuÁ il tempo di rivendicare i privilegi antichi, ma di tradurrein concreti atti di governo il contenuto delle libertaÁ moderne, trasfor-mando i vecchi organi di rappresentanza cetuale in nuove sedi dellarappresentanza politica.
La societaÁ triestina che si trovoÁ riunita, il 21 aprile 1801, nellasala del Teatro Nuovo rappresentava cosõÁ tutti i caratteri, tutta la ric-chezza e tutte le apparenti contraddizioni, ormai assorbite, in cui eracresciuta la cittaÁ nuova. Una societaÁ cresciuta civilmente ed etica-mente all'interno di strutture e di formule politiche e culturali eredi-tate dall'Antico Regime, che peroÁ aveva saputo rinnovare dall'inter-no, avvicendandosi all'antico ceto patrizio nella partecipazione allavita della cittaÁ .
88
74 E. APIH, Una protesta della borsa mercantile di Trieste (1789), « Annali Triesti-ni », a cura dell'UniversitaÁ di Trieste, XXI (1951), pp. 3-12 (la citazione eÁ da p. 3).
75 F.E.J. BARAUX, Alcune rimarche sopra le meditazioni storico analitiche sulle fran-chigie della cittaÁ e portofranco di Trieste del Dottore Domenico Rossetti nobile de Scander,manoscritto in BCTs, segn. R.P. MS MISC. 87/XVII. Il testo eÁ in parte riprodotto infra,cap. X.
III. - LA PREPARAZIONE DELLA «HAUPTRESOLUTION»(1749): MERCANTILISMO E CAMERALISMO IN UNMEMORIALE SUL PORTO FRANCO
Nell'autunno del 1748 Trieste vedeva il breve soggiorno di unacommissione speciale, nominata da Maria Teresa e presieduta dalpresidente del Direttorio Commerciale, barone de Chotek, incaricatadi verificare la situazione politica, amministrativa ed economica dellacittaÁ ; la commissione invioÁ a tale riguardo, nel mese di ottobre, unarelazione (con relativo protocollo) alla Corte di Vienna, che fu poialla base della nota Hauptresolution del 19 novembre 1749 cheavrebbe consentito la piena attuazione del porto franco 1.
EÁ giaÁ stato rilevato da altri 2 come tale relazione, considerata la
89
1 Su questi temi cfr. D. TORBIANELLI MOSCARDA, Vicende giuridico-amministrative aTrieste da Carlo VI a Leopoldo II, GiuffreÁ , Milano 1971, pp. 50-52; U. COVA, Le vicendeistituzionali, in Maria Teresa, Trieste e il porto, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Ve-nezia Giulia, Udine 1980. Si vedano peroÁ anche le considerazioni di G. CERVANI, LitoraleAustriaco e contea di Gorizia. Riflessi locali della politica austriaca di riforme nel XVIII se-colo, ora in ID., Momenti di storia e problemi di storiografia giuliana, Del Bianco, Udine1993, pp. 261-277 e di E. FABER, Il ruolo dell'Austria interiore nella politica commerciale diCarlo VI, « Cheiron », 21 (1995), pp. 161-186; EAD., Riforme statali nel Litorale austriaconel secondo Settecento, in AGOSTINI (a cura di), L'area alto-adriatica, cit., pp. 423-448; U.COVA, Trieste e il suo hinterland in epoca austriaca. Rapporti economici, istituzionali conCarinzia, Stiria, Carniola, Gorizia, Istria e Venezia, Del Bianco, Udine 2005, pp. 21-49.
2 F. CUSIN, Le condizioni economico-giuridiche di Trieste e le riforme dell'ammini-strazione comunale nella prima metaÁ del secolo XVIII, « Archeografo Triestino », s. III,XVII (1932), pp. 151-154.
troppo breve permanenza a Trieste della commissione (nove giorni),fosse in realtaÁ il frutto di una non breve inchiesta politico-ammini-strativa sullo stato della cittaÁ promossa giaÁ dall'Intendente baronedi Flachenfeld (nominato il 7 febbraio 1748), che si era valso soprat-tutto dell'opera del barone Antonio Marenzi, Capitano sostituto e fe-dele suddito della Sovrana. Possiamo cosõÁ presentare due circostan-ziati rapporti inediti di Marenzi, riferiti in generale alle condizionipolitiche ed economiche di Trieste nella metaÁ del secolo XVIII e in-teressanti per comprendere, in particolare, la lunga opera di prepa-razione in sede locale degli eventi che portarono all'emanazione dellarisoluzione sovrana nota come Hauptresolution nel quadro della mo-dernizzazione amministrativa ed economica dello Stato asburgico 3.
L'autore dei due scritti, il barone Antonio Rodolfo Marenzi deMahrenzfeld e Scheneck 4, nacque a Trieste il 23 gennaio 1687, figlioprimogenito di Francesco Antonio e lontano parente di quel Gabrie-le che nel 1719 peroroÁ presso l'imperatore la concessione del portofranco alla cittaÁ adriatica. I documenti sono abbastanza avari di no-tizie su Antonio Marenzi, anche su quelle solamente biografiche. Ag-gregato al Consiglio dei Patrizi fin dal 1706, completati gli studi, siera inserito nei ranghi dell'amministrazione statale, tanto che nel1713 era segnalato come addetto all'Ufficio Capitaniale di Gradiscad'Isonzo. In quell'epoca, e probabilmente in quella stessa localitaÁ ,egli si unõÁ in matrimonio con Terenzia di Francesco Antonio barone
90
3 Per un inquadramento di queste dinamiche si vedano i classici lavori di R.J.W.EVANS, Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica 1550-1700, tr. it., il Mulino, Bo-logna 1981, in particolare pp. 161-208; SCHILLING, Corti e alleanze, cit., pp. 363-419 (de-dicate alla monarchia asburgica); J. BEÂ RANGER, Storia dell'impero asburgico 1700-1918, tr.it., il Mulino, Bologna 2003, pp. 83-100. A questi testi eÁ indispensabile oggi aggiungereanche VOCELKA, Glanz und Untergang der hoÈfischen Welt, cit., specialmente alle pp. 353-366, dedicate alle riforme amministrative teresiane.
4 I brani autografi sono conservati in ADTs, segn. 14 E 2, cc. 162-175, 177-179.Non sono firmati, ma l'esame calligrafico con altre carte sottoscritte da Marenzi, in par-ticolare in ADTs, Incarichi speciali al bar. A. Marenzi, segn. 1/1 F 9 non lascia dubbi disorta. Pure lo stile e il fraseggio corrispondono ad altri brani giaÁ pubblicati da CUSIN, Lecondizioni, cit. I manoscritti appartengono a tre gruppi distinti, redatti in epoche diver-se: uno di essi, il primo in probabile ordine cronologico, risulta mutilo.
de Lothieri 5; dal matrimonio nacquero dieci figli, la maggior partedei quali morti in tenera etaÁ 6.
Lo ritroviamo a Trieste nel 1726, quale estensore di un rapportosul funzionamento del neocostituito Tribunale Mercantile 7 e daquell'epoca la sua carriera continuoÁ con costante progresso fincheÂnel maggio 1746 assunse la direzione del governo locale, quale Capi-tano sostituto in assenza del titolare conte d'Herberstein 8. In quantorivestito di tale carica, Marenzi esercitava tutti i poteri attribuiti alCapitano, con esclusione peroÁ di quelli militari; era un « luogotenen-te stabile di un Capitano titolare assente o impedito », rappresentan-te quindi dello Herberstein a differenza del barone Andrea de Finche, pure nominato «Capitano sostituto » alcuni anni prima, avevasvolto invece le funzioni di rappresentante del sovrano 9.
Rimase in tale carica fino al 1748 quando, non sappiamo in qualemese, sembra venisse sostituito col barone Andrea de Fin a causa deiforti disaccordi avuti con il Consiglio dei Patrizi 10. Dopo il giugno1749 ritornoÁ a occupare la carica di Capitano sostituto prima conFlachenfeld e poi con il barone WiesenhuÈ tten finche , a seguito dellariorganizzazione dell'Intendenza Commerciale stabilita dall'art. 55della Hauptresolution del 29 novembre 1749, divenne Consiglieredell'Intendente « esperto del politico » 11.
91
5 Nata a Gradisca nel 1689 e deceduta a Trieste il 10 ottobre 1758.6 Le notizie biografiche sono date da L. DE JENNER, Genealogie triestine, vol. II, ms.
in ADTs, segn. 1/1 B 2. De Jenner aggiunge ancora qualche altra notizia minima, comela cessione dei beni di Odolina in usufrutto al fratello Giuseppe a beneficio dei nipoti exfratre Rodolfo (1738) e l'affitto del suo giardino « in S. Caterina » per dieci anni a lire115 annue al console bavarese Giuseppe Maurizio (1754).
7 Cfr. G. BUSSOLIN, Della Compagnia orientale nel secolo scorso, Tip. Herrmanstor-fer, Trieste 1882, p. 14 e CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., pp. 112 e 131 n. 23.
8 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit. p. 137 e 161 n. 39 CosõÁ R. PAVANELLO, L'amministrazione giudiziaria a Trieste da Leopoldo I a Maria
Teresa, I, L'etaÁ anteriore al portofranco, Deputazione di storia patria per la Venezia Giu-lia, Trieste 1982, p. 28 n. 16. Si veda pure ID., Tradizione storica e rinnovamento istitu-zionale nell'Austria del Settecento: il capitanato della cittaÁ di Trieste, in CATTARUZZA (acura di), Trieste, Austria, Italia, cit., pp. 5-56.
10 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 146.11 « Primo loco haben Wir den Baron Antonio Marenzi welcher vorhin als einige-
mahl Substituirt gewester Intendente und Capitaneo Civile, vielen guten Eifer bezeugt,und besonders in dem StaÈdtischen Weesen sich experimentirt gemacht hat [...] als Con-
Antonio Marenzi venne giubilato il 29 maggio 1753 per raggiuntilimiti d'etaÁ 12 e morõÁ nella propria cittaÁ il 24 gennaio 1760, venendopoi sepolto nella cattedrale di San Giusto 13.
Marenzi scriveva in lingua italiana, ma il suo stile, rispetto anchea quello dei contemporanei in Trieste, appare particolarmente pesan-te e faticoso. Prevalgono i toni aspri, le consonanti dentali, le allitte-razioni, tanto da far supporre, come giaÁ venne notato 14, una suamaggiore dimestichezza con la lingua tedesca, anziche con quella ita-liana. Caratteristica dovuta, probabilmente, alla sua formazione cul-turale giovanile in ambiente non triestino.
I tre brani esaminati, benche uno soltanto di essi sia datato, pos-sono essere inquadrati cronologicamente con sufficiente approssima-zione. Il primo scritto, muÁ tilo (cc. 172-175), per il tono di vivace po-lemica nei confronti del precedente Intendente de Herberstein e deireggitori comunali, potrebbe essere stato scritto subito dopo l'allon-tanamento di Marenzi dalla carica di Capitano sostituto, provocatoall'inizio del 1748 dai violenti contrasti con i membri del governo co-munale 15. Il secondo brano, recante il titolo Disordini che non solloritardano il progresso del comertio maÁ anco che distruggono li principjdella sua esistenza per le conseguenze che ne risultano (c.162 e cc.177-179), dovrebbe risalire, per univoci riferimenti alla situazione politicae trattandosi anche di una memoria piuÁ approfondita, al dicembre1748; ipotesi che potrebbe essere suffragata da quanto riferito daCusin 16, cioeÁ che il 16 dicembre 1748 l'Intendente Flachenfeld no-tificava ai Giudici e Rettori che Marenzi aveva l'incarico di informareil governo intorno allo stato della cittaÁ . Per il terzo scritto non sussi-
92
sigliere der Intendenza gnaÈdigst ernennet »; cfr. P. KANDLER, [Text der k. Patente vom29. Novembris 1749] Seiner Excellenz F.M. von Burger, Lit.-Art. Abtheilung des oÈ ster-reichischen Lloyd, Triest 1862, p. 27.
12 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale (1748-1776), busta 125 (ex n. 1669), cc.40r-40v, sub 29.5.1753.
13 DE JENNER, Genealogie, ms., cit. Antonio Rodolfo Marenzi era figlio di FrancescoAntonio (1666-1737) e di Maria nata dell'Argento (1665-1705); cfr. L. DE JENNER, Fami-glia Marenzi, ms. in ADTs, segn. 9 G 4/7.
14 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., pp. 143 e 162 n. 9.15 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., pp. 137-162.16 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 150.
stono problemi di datazione poiche vi eÁ indicata la data del 20 di-cembre 1748.
I brani di Marenzi qui analizzati costituiscono nell'insieme unmemoriale sulle condizioni politiche ed economiche di Trieste alla vi-gilia dell'arrivo della commissione Chotek. Il tono dello scritto eÁ for-temente critico verso gli esponenti del governo aristocratico cittadinoe cioÁ rispecchia un ben noto atteggiamento di Marenzi, paladino del-la politica sovrana e fiero nemico degli oppositori locali, manifestato-si fin dai primi anni della sua carriera. Questo funzionario governa-tivo era pure fortemente intransigente nei confronti dell'operato diun suo superiore, il barone de Herberstein, che fino a poco tempoprima aveva ricoperto la carica di Intendente 17.
Ne emerge un fiero atto di accusa al modo con cui era stata at-tuata in precedenza a Trieste la politica impostata da Carlo VI e con-tinuata da Maria Teresa; vengono messe in luce le inefficienze, si po-ne in risalto la generale disapplicazione delle direttive sovrane, si sot-tolinea l'atteggiamento dei triestini volto ad ostacolare l'espansionedell'emporio. E questo sconfortante tratteggio della cittaÁ settecente-sca trova pure eco in altre fonti, pressoche contemporanee ma diprovenienza politica totalmente differente, come in quella Descrizio-ne della piazza di Trieste di anonimo scrittore veneziano databile1750 che notava fra l'altro ± come abbiamo visto nel primo capitolo± come i patrizi fossero « cosõÁ contrari al foresto et al commercio checon l'ochio vorrebbero il tutto anichilire » 18.
Il memoriale di Antonio Marenzi, tuttavia, non rimane al livellodi sterile polemica o di mero spasso intellettuale. Lo scritto eÁ densodi nuove idee, di proposte concrete per una riorganizzazione ammi-nistrativa indispensabile al rilancio della funzione commerciale della
93
17 Su queste vicende si veda anche FABER, Litorale Austriaco, cit., pp. 96-148, conlargo utilizzo della documentazione degli archivi viennesi.
18 Cfr. TUCCI, Una descrizione, cit., pp. 95-113 e supra, cap. I, p. 41. Il pensiero del-l'estensore veneto presenta interessanti analogie con le idee di Marenzi; eÁ curioso peroÁche l'anonimo descriva Marenzi come « d'etaÁ avanzata, il quale in tutto il tempo di suavita ad altro non ha atteso se non all'economia della sua casa, il ricavato della quale laconsumma giornalmente in lavorare alla fossõÁna per arivare alla pazzia di ritrovare il mo-do di formare il lapis philosophorum » (p. 99).
cittaÁ , nel pieno rispetto di quanto provveduto dai sovrani di casad'Asburgo.
CosõÁ, anche se talvolta il tono si fa un poco irruento e mal con-tenuto, emerge con sufficiente evidenza, come d'altronde eÁ giaÁ statogiustamente notato in altra occasione 19, l'immagine di un uomo« che sembra in buona fede convinto difensore dei diritti del portofranco e poco amante dei cavilli giuridici, di cui invece i reggitori trie-stini avevano sempre a disposizione una riserva per ogni evenienza ».
Marenzi difendeva con fermezza la legislazione di Carlo VI; com-batteva, lui stesso un patrizio, gli aristocratici triestini per favorire almassimo la nuova forza di Trieste, quel ceto mercantile che ancorastentatamente si stava formando. Era avverso al particolarismo muni-cipale, nemico degli inutili dazi e gabelle che scoraggiavano l'intra-prendenza dei negozianti. Disprezzava il console della nazione greca« che senza saper ne leggere ne scrivere si eÁ intruso in tal officio, co-metendo vari inganni alli mercanti greci » 20 ma proponeva allo stessotempo miglioramenti, innovazioni, costruzioni di opere pubbliche.
L'atteggiamento piuÁ critico era nei confronti dell'Intendente,mai espressamente nominato, conte Giovanni Sigfrido d'Herbersteinche era stato chiamato a reggere il governo della cittaÁ nell'aprile1741 21. Herberstein lascioÁ Trieste, pur continuando a mantenerela carica di Capitano Cesareo, nel 1746 forse perche chiamato alla Vi-cepresidenza della Rappresentanza Camerale, Commerciale e Politi-ca di Lubiana 22.
Il Capitano Cesareo (« Intendente » in quanto a capo di quel pri-mo organo governativo creato nel 1731) 23, si era reso non meno col-pevole dei triestini ± secondo Marenzi ± nel danneggiare con la pro-pria condotta gli interessi sovrani. GiaÁ nel 1744 aveva lasciato intrave-
94
19 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 143.20 Il console della nazione greca ed ottomana a Trieste era dal 1723 Liberale Baseo
(1671-1749), dal 1732 console anche a Fiume, accusato giaÁ nel 1743 di illecita concor-renza nel mestiere di sensale e di confusione tra le funzioni di console e di sensale. Cfr.G. STEFANI, I greci a Trieste nel Settecento, Monciatti, Trieste 1960, pp. 20-25.
21 PAVANELLO, L'amministrazione giudiziaria, cit., p. 28 n. 16.22 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 137.23 COVA, Note per una storia, cit., pp. 4-5.
dere, a vantaggio del Comune cittadino, un « rilassamento » all'appli-cazione della Patente sovrana del 21 gennaio 1733 che, concedendo aiforestieri l'importazione del vino per uso proprio e di famiglia, avevaspezzato il monopolio su tale prodotto goduto fino allora dai triestini.
Herberstein, immagina Cusin 24, doveva avere agito per un finepolitico piuÁ generale ma il suo allontanamento da Trieste e il conse-guente avvento dell'intransigente Marenzi come Capitano sostitutoavevano fatto svanire queste piuÁ o meno giustificate aspettative.
Antonio Marenzi giudicava l'Intendente colpevole di generaleinosservanza e disapplicazione delle principali disposizioni contenutenelle patenti sovrane: privilegi a favore dei commercianti stranieri,esenzione fiscale e dall'acquartieramento di truppe militari, inviolabi-litaÁ del domicilio ecc. A tutto cioÁ , dopo che i triestini « per il loro par-tito videro dichiarato l'Intendente », si era aggiunta la prolungata as-senza dalla cittaÁ del garante della legge e questo, per l'autore del me-moriale, aveva comportato un vero abbandono del governo aitriestini giaÁ rivelatisi « contrarij et alienni del comertio ».
Fatto eÁ , comunque, che il precedente atteggiamento di Herber-stein veniva invocato dal governo comunale a sostegno delle proprieaspirazioni 25 contro il rigido comportamento di Marenzi, che si at-teggiava a fedele garante della volontaÁ sovrana in cittaÁ .
L'atteggiamento del nostro personaggio nei confronti dell'Inten-dente, per quanto fortemente severo e maturato nel tempo, non erastato reso palese, si noti bene, prima della partenza di Herberstein ecertamente non lo aveva spinto, in quel momento, al punto di pro-muovere un giudizio di accusa nei confronti del Capitano Cesareo;questo rilievo induce quindi a far ritenere, a meno di una tardiva eimprobabile presa di coscienza di Marenzi, che le accuse, per quantogravi, non fossero sostenute in realtaÁ da argomentazioni abbastanzavalide per essere prodotte davanti ad una superiore autoritaÁ . Il chenon contraddice evidentemente il carattere impulsivo di Marenzi equindi lascerebbe ascrivere l'accusa politica a un giustificabile ecces-so di zelo.
95
24 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 140.25 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 143.
Tale severa critica, peroÁ , non veniva presentata da Marenzi asemplice fine di sterile polemica o per acquistare prestigio; al contra-rio, notando i difetti di un precedente funzionario egli indicava i mi-gliori requisiti per un futuro Intendente: capacitaÁ e intelligenza nelfar rispettare le leggi, conoscenza delle carenze e delle necessitaÁ dellacittaÁ , esperienza in materie economiche, abilitaÁ nell'avvalersi dellaforza derivante dal commercio e dall'unione dei negozianti: « il pre-tendere far tutto in una volta, eÁ un volere far nulla, il trascurare lepiccole cosse eÁ un non curarsi delle grandi, il volere aÁ forza di speseriuscire nel impresa eÁ indizio di pocho ingegno ». Requisiti, come sipuoÁ vedere, piuÁ che altro ideali e difficilmente presenti tutti in unasola persona; anche tra i successivi Intendenti commerciali ve ne do-vettero essere pochi che soddisfacessero i desideri del Nostro 26.
Come accennato, cioÁ che Marenzi soprattutto lamentava comeconseguenza dell'atteggiamento assunto da Herberstein (il quale ad-dirittura avrebbe considerato inapplicabili molte Risoluzioni percheÂritenute tacitamente abrogate per desuetudine) era il mancato rispet-to dell'art. 5 dell'Instruzione datata Vienna 19 dicembre 1725 con-cernente l'esenzione dai dazi delle merci trasportate via mare (conte-nuto richiamato dal par. 4 della Patente di stessa data 27 cui l'istruzio-ne era annessa), l'inosservanza dell'art. 9 della Patente datata Vienna11 novembre 1730 riguardante i privilegi del ceto mercantile e la di-sapplicazione della Risoluzione datata 21 gennaio 1733, limitatamen-te al disposto che concedeva sei mesi di franchigia per l'importazione
96
26 Scriveva infatti l'anonimo relatore veneziano a metaÁ del Settecento che « tutti icommandanti che sono stati in Trieste dopo ch'egli eÁ stato nominato porto franco, i qua-li furono il baron de Fin, il conte Galinberg, il conte Gabbata, il conte Herberstein, ilbaron Flochinfeld, il baron Weisnider [recte WiesenhuÈ tten] et il presente conte Hamil-ton, questi sono comparsi nel loro commando senza che del commercio ne avessero unprincipio di cognizione, e quando principiavano a prenderlo per l'esperienza dei lorofalli, venivano questi promossi con levargli da Trieste, e questa eÁ la causa per cui la piaz-za di Trieste mai ha avuto un regolamento di negozio, e mai vi saraÁ se batteranno l'istessastrada » (TUCCI, Una descrizione, cit., p. 99).
27 Instruzione in qual modo li Nostri comandanti et Officianti d'ambi nostri portifranchi maritimi dell'Austria Interiore Trieste e Fiume [...] abbiano a contenersi versi liTrafficanti, Negozianti, Manifattori ecc., Tip. Mayr, Lubiana 1730; riprodotta in KAN-
DLER, Emporio e portofranco, cit., pp. 120-124. La patente datata Vienna 19 dicembre1725 eÁ pubblicata ivi alle pp. 118-120.
a Trieste di vini dall'Istria e dal Friuli austriaco. Oltre a cioÁ , i triestiniavevano tentato ripetutamente di acquisire la giurisdizione sul Di-stretto Camerale in violazione delle leggi sovrane, commettendo cosõÁ
« un delitto ben grande » per « non haverle graditte, ne eseguitte ».L'art. 5 della Instruzione citata stabiliva infatti che « quelle merci,
che capitano per Mare, ed iteratamente vengono condotte fuori perMare, sono da tutte le altre Gabelle, e Dazij totalmente franche » 28:viceversa, osservava Marenzi, non solo tale disposto non veniva ri-spettato, attraverso imposizioni non dovute, ma gli stessi dazi espres-samente posti a carico delle merci provenienti per terra dall'AustriaInteriore 29 venivano riscossi in modo irrazionale, con grave disagioper i negozianti. Infatti « le tariffe de datij [...] sovente si accrescono,overo diminuiscono et poi di novo s'accrescono, con esigersi il datiohora in un loco, hora in un altro ». CosõÁ, nell'auspicare il ritorno allalegalitaÁ , egli coglieva anche l'occasione per suggerire la riduzione deidazi di transito per le merci percorrenti la strada di Trieste e l'abo-lizione del dazio cosiddetto « della pesa et misura della biada farina »del quale, in particolare, veniva criticata la riscossione in modo nonconforme al chiaro disposto degli Statuti comunali, con nuovi « pre-giudizievoli abusi » per i cittadini 30; infine, Marenzi proponeva lasoppressione del fondaco comunale, ridotto ormai a monopolio del-l'autoritaÁ municipale 31.
L'art. 9 della Patente datata Vienna 11 novembre 1730, di cui pu-re veniva lamentata una solo parziale attuazione, conteneva uno deiprincõÁpi fondamentali del porto franco, sancito dalla promessa del So-vrano: « a tutti e cadauno i Negozianti, Manifatturieri, ed Artieri diqualunque Nazione sieno, che vorranno fissarsi in Trieste, liberazioneperpetua da ogni imposta personale, alloggiamenti militari, guardie
97
28 Testo riassunto in italiano in KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 119.29 Art. 2 e art. 4 dell'Instruzione cit., in KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p.
120.30 Cfr. c. 164 del ms. cit., e Statuti di Trieste, lib. IV, rub. 5 (nell'edizione stampata
dai fratelli Gallici, Udine, 1727 alle pp. 282-287).31 Che sarebbe stato abolito soltanto nel 1796; cfr. A. VIDON, « Funticus comunis
Tergesti ». Indagine su un'istituzione annonaria, «Quaderni Giuliani di Storia », VII, 1(1986), pp. 114-115.
ed altre imposte, e che saranno considerati come ospiti » 32. Proprioquesto disposto ± veniva rilevato ± che avrebbe dovuto costituire ilprincipale incentivo per lo stabilimento degli stranieri a Trieste, eradisatteso non solo col pretendere dai commercianti varie imposizionifiscali giaÁ accennate, ma anche col volere imporre l'acquartieramentodelle truppe militari, coi conseguenti oneri finanziari a carico degliabitanti derivanti dalle spese per il vettovagliamento e altro.
Infine la Risoluzione datata 21 gennaio 1733, riguardante l'im-portazione dei vini 33, era rimasta lettera morta nella parte in cui con-cedeva agli abitanti della cittaÁ nuova l'introduzione del vino « este-ro » per proprio uso personale, senza dovere ricorrere all'acquistodei vini locali gravati da imposizioni fiscali. Il mancato rispetto di taleimposizione era giaÁ stato lamentato, infatti, nel marzo del 1747 allaRappresentanza Camerale e Commerciale di Lubiana 34 in una letterafirmata da dodici commercianti a nome di tutto il ceto mercantile. Aquesta aveva fatto seguito, in data 6 maggio 1747, altra lettera dellostesso Marenzi in cui si ribadiva che « quanto piuÁ va crescendo inquesta CittaÁ il Comertio, tanto piuÁ pare che vadano crescendo gl'in-toppi per farlo cadere; gl'istessi cittadini et quelli che si dicono Ret-tori congiurano ad esterminio del mede[si]mo » e si rendeva noto unillegale sequestro di vino veneto operato per ordine di Giudici e Ret-tori a danno di alcuni negozianti 35.
In effetti, nell'esaminare il contenuto della Hauptresolution del29 novembre 1749, appare evidente che tali istanze, in un modo onell'altro, trovarono accoglimento presso la Corte di Vienna. L'art.2 stabiliva un alleggerimento delle tariffe stradali (« eine aussgebigeErleichterung ») 36 mentre l'art. 36 imponeva all'Intendente la sorve-
98
32 Si veda il testo in KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 133.33 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., pp. 31-32.34 Che aveva competenza su « tutti gli affari di diretto intervento governativo della
regione, e quelli riguardanti piuÁ specialmente gli interessi commerciali e marittimi, che sivenivano concentrando nei due porti di Trieste e Fiume » (cfr. CUSIN, Le condizioni giu-ridiche, cit., p. 137).
35 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., pp. 196-198.36 Per il testo in lingua tedesca cfr. KANDLER, Seiner Excellenz, cit., p. 3; per la tra-
duzione italiana in riassunto KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 178. Sul tema dellecomunicazioni viarie cfr. E. FABER, Neue Straûen, neue Welt. InneroÈsterreichische Kom-
glianza « sull'abbondanza e sul buon prezzo dei viveri, facendo chel'entrata sia agevolata, impedite le collusioni dei venditori, sorvegliatili provvisori, provveduto di grani il Fontico del quale farsi diligenteesame » 37. Quanto all'importazione dei vini, infine, l'art. 29 confer-mava un diritto giaÁ sancito, concedendo l'uso di vino estero a nego-zianti, manifatturieri ed artigiani per solo consumo proprio e conesclusione del vino veneto.
Altro tema particolarmente curato da Marenzi era quello dellariserva di giurisdizione stabilita a favore del ceto mercantile. L'ema-nazione, il 20 maggio 1722, dell'editto di Cambio estendente all'Au-stria Interiore la Wechsel Patent del 1717 aveva portato alla costitu-zione a Trieste di tribunali di Cambio mercantile e consolato di ma-re 38, di prima istanza e d'appello. Detti tribunali vennero adintaccare cosõÁ la giurisdizione esclusiva fino ad allora esercitata dagliorgani comunali, sottraendo loro la cognizione delle cause in materiadi commercio ed aventi come parti negozianti, commercianti all'in-grosso, banchieri, societaÁ mercantili, consoli ed agenti di Stati esteriecc. 39. Un tanto era giaÁ stato preannunciato nell'art. 6 della Patentedel 18 marzo 1719 istitutiva del porto franco 40.
Fin dalla loro istituzione, peroÁ , i Tribunali mercantili (o di com-mercio) avevano incontrato difficoltaÁ nel loro corretto funzionamen-to, causa non ultima la palese opposizione delle magistrature muni-cipali. Di tale situazione si era reso interprete lo stesso Antonio Ma-renzi giaÁ nel 1726, quando aveva scritto in un rapporto al CapitanoCesareo che « il giudizio mercantile di poco istituito ha ben poco dafare; li giudici della cittaÁ con un cancelliere che non sa scrivere neÂformare un decreto suppliscono a tutto » 41. Le buone intenzioni,
99
merzialstraûen im 18. Jahrhundert, «Das Achtzehnte Jahrhundert und OÈ sterreich », 11(1996), pp. 99-120.
37 Cito dalla traduzione italiana di KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 180; te-sto in lingua tedesca in ID., Seiner Excellenz, cit., pp. 20-21.
38 Cfr. COVA, Note per una storia, cit., p. 10.39 TORBIANELLI MOSCARDA, Vicende giuridico-amministrative, cit., pp. 20-22.40 R. PAVANELLO, Sugli organi giurisdizionali a Trieste nella prima metaÁ del secolo
XVIII, « Archeografo Triestino », s. IV, XXXI-XXXII (1969-1970), p. 67.41 CUSIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 131.
in quell'occasione, non erano valse a migliorare la situazione ed eccoche a distanza di vent'anni Marenzi nuovamente interveniva col de-nunciare l'esasperante lentezza nello svolgimento delle cause e il tra-visamento degli statuti propri del Tribunale, che prescrivevano il giu-dizio sommario a tutto vantaggio delle parti in causa.
Marenzi proponeva una semplificazione della procedura: aboli-zione della vecchia struttura giudiziaria, con conservazione dei suoiregolamenti, e istituzione di un Giudizio mercantile di prima istan-za 42; questo, a differenza del Tribunale Mercantile di prima istanza,avrebbe dovuto essere costituito da cinque persone ed un attuario.Quattro consiglieri avrebbero dovuto essere scelti tra i componentidel ceto mercantile (di essi venivano fatti anche i nomi 43) mentrela carica di presidente doveva spettare a un funzionario di governo(il cui nome pure era indicato 44); all'attuario sarebbero state riserva-te anche le funzioni di addetto al protocollo.
100
42 Il Tribunale Mercantile di prima e seconda istanza, secondo quanto stabilito dal-la Patente sovrana, doveva essere costituito da « sette oÁ almeno sei Mercanti abili, et ho-norati [...] altrimenti vi possono essere impiegate altre Persone abili dei Nostri Consi-glieri, e Ministri. Questo Magistrato dunque consisteraÁ in un Preside, e in cinque oÁsei Assessori »; cfr. Editto di Cambio della Sacra Cesarea e Cattolica MaestaÁ datato 20maggio 1722, nell'edizione italiana stampata da G. P. van Ghelen, Vienna 1730; in par-ticolare cfr. Del Magistrato di Cambio, la prima, la seconda ed ultima istanza, tit. I, par. 1«Della prima Istanza del Magistrato oÁ consolato di Cambio » (p. 28). L'edizione in lin-gua tedesca e la sua collocazione sono indicate da PAVANELLO, L'amministrazione giudi-ziaria, cit., p. 74 n. 71. La stessa patente, peroÁ , stabiliva che per Trieste la prima istanzafosse composta di sei persone (presidente compreso) e un notaio, la seconda di sette per-sone (presidente compreso) piuÁ un notaio. Cfr. Editto di Cambio, cit., tit. I, par. II, p.30.
43 Giovanni Giussani, da Milano, commerciante (morto circa nel 1770); GiuseppeBelusco, commerciante (Milano 1718-Trieste 1790), a Trieste dal 1740, console della re-pubblica di Ragusa; Giovanni Giorgio Dumreicher, commerciante originario di Kemp-ten (morto nel 1780), console di Danimarca e poi anche dal 1756 delle Province Unite aTrieste; Giovanni Adamo Wagner, commerciante (Norimberga 1721-Trieste 1781), aTrieste dal 1740, negoziante di Borsa (su di loro vedi P. TOMASIN, Codice epigrafico diTrieste e dell'Istria, I, p. 236, ms. in ADTs, segn. 1/1 C 6; O. DE INCONTRERA, Vita trie-stina del Settecento, « La Porta Orientale », XXIX (1959), p. 337; NA, Staten-Generaal,4.12.1780, c. 8rv; « L'Osservatore Triestino », 3.4.1790, p. 297).
44 Francesco Saverio Bonomo (1718-1787), ingegnere del Genio, capitano nel 1748(DE INCONTRERA, Vita triestina del Settecento, cit., « La Porta Orientale », XXVI (1956),p. 236.
La seconda istanza doveva essere presieduta dall'Intendente (ecioÁ in evidente parallelismo con quanto era stato stabilito per il tribu-nale mercantile di seconda istanza il cui presidente era il CapitanoCesareo), mentre era prevista la presenza di soli quattro consiglieri,scelti all'uopo di volta in volta dall'Intendente stesso per deciderequanto fosse « di giustizia ».
Marenzi avrebbe voluto quindi una procedura semplificata, manon forniva altri dettagli sulla sua proposta; precisava soltanto cheil giudizio di prima istanza avrebbe dovuto riunirsi almeno due voltealla settimana 45. Non chiariva, peroÁ , i limiti che avrebbero condizio-nato la proposizione dell'appello, limiti che, stante l'obiettiva diffi-coltaÁ di costituire e riunire di volta in volta una commissione adhoc, avrebbero dovuto caratterizzarsi per notevole rigore, e comun-que riservati a fattispecie di particolare gravitaÁ e di manifesta rilevan-za. L'Editto di Cambio, all'inverso, poneva un limite testuale stabilen-do che non si potesse adire in grado d'appello per cause di valoreinferiore ai duecento fiorini 46. Infine, Marenzi non accennava mini-mamente all'istanza di revisione, che dunque, secondo quanto stabi-lito dall'Editto, sarebbe spettata in sede di ulteriore ricorso al Consi-glio Intimo dell'Austria Interiore 47.
Marenzi suggeriva ancora la riaffermazione del principio dellacognizione sommaria e orale, non ammettendo « scritture, ne disseriede dottori, ne altre legalitaÁ se non in caso di gran bisogno e necessi-taÁ ».
In effetti, l'art. 44 della Hauptresolution 48 venne ad innovare lamateria in questione: fu decretata la fusione dei due tribunali, dicommercio e di cambio, in uno solo « provveduto di esperti sogget-
101
45 Proponeva dunque un numero minimo di riunioni del Tribunale, mentre l'Edittodi Cambio dichiarava semplicemente che i « giorni giudiziali » sarebbero stati « duoi allasettimana, LunedõÁ e GiovedõÁ » (cfr. par. III, p. 32).
46 L'appello era ammesso « a bocca stante pede dopo la pubblicazione della senten-za », oppure entro otto giorni successivi (Editto di Cambio, cit., tit. I, par. 9 e tit. II, par.2 e par. 3); cfr. PAVANELLO, Sugli organi giurisdizionali, cit., pp. 67-68.
47 Cfr. Editto di Cambio, cit., tit. III, par. 1 e par. 3, nonche PAVANELLO, Sugli or-gani giurisdizionali, cit., p. 68.
48 Si veda per il testo in lingua tedesca KANDLER, Seiner Excellenz, cit., p. 23 e per ilriassunto in lingua italiana ID., Emporio e portofranco, cit., p. 180.
ti » e composto da un Presidente, quattro Consiglieri o Assessori, as-sistiti da un Segretario; veniva garantita una procedura « sommarissi-ma » e orale, « senza troppe scritture di Avvocati e Nodari » 49.
Altro problema, infine, oggetto dell'attenzione di Antonio Ma-renzi e non meno importante rispetto a quelli in precedenza esposti,era quello riguardante le risorse finanziarie del governo locale. All'at-to di istituire la Cesarea Regia Suprema Intendenza Commerciale, nel1731, si era ritenuto di curare questo punto e, pertanto, la patentesovrana del 26 maggio di quello stesso anno aveva disposto la crea-zione di un fondo commerciale, alimentato principalmente dai pro-venti delle tasse riguardanti il lazzaretto, la pesa erariale, le baracchedella fiera del porto franco ecc. 50.
Tali risorse, che avrebbero dovuto servire al potenziamento dellestrutture portuali e allo sviluppo del commercio, si erano rivelate pe-roÁ ben presto insufficienti, considerati non solo la mole e l'alto costodei lavori previsti, ma anche il mancato gettito di molte imposte. Perquesto motivo Marenzi proponeva la creazione di un altro fondo, dacostituirsi mediante lieve tassazione del tonnellaggio delle imbarca-zioni che giungevano in porto (« due carantani per migliaro ») 51. Aquesta imposizione, da Marenzi ritenuta modesta ed equa, avrebbedovuto aggiungersi l'acquisizione dei fondi presso il borgo SantiMartiri che, a detta del nostro autore, giaÁ sarebbero dovuti apparte-nere al Distretto Camerale ex lege e che invece erano stati lasciati « in
102
49 CosõÁ KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 180. Il testo originale in lingua te-desca suonava: « In den Verfahrung solle bey diesel Gerichten Sommarissime, und soviel nur moÈglich muÈndlichen, ohne vielen Advocaten, und Notarien-Schreyberein miteyfriger Administrirung der Justiz procediret, auch in via appelationis auf den Fuss ge-halten werden, wie es bereits vorhin decidirt ist » (KANDLER, Seiner Excellenz, cit., p. 23).Del resto, sommarietaÁ e oralitaÁ erano caratteristiche del processo giaÁ stabilite dell'Edittodi Cambio; cfr. in questo senso PAVANELLO, Sugli organi giurisdizionali, cit., p. 67.
50 I. IACCHIA, I primordi di Trieste moderna all'epoca di Carlo VI, « ArcheografoTriestino », s. III, VIII (1919), p. 109; la patente datata 26 maggio 1731 eÁ citata da CU-
SIN, Le condizioni giuridiche, cit., p. 131.51 Non saprei dire, in veritaÁ , se quanto disposto nell'art. 26 della Hauptresolution
(«Non approviamo la tassa proposta per ogni collo di mare, la quale sarebbe di pesoal commercio ») faccia riferimento alla proposta di Marenzi o ad altra analoga, trattan-dosi di termini troppo generici, pur se evidentemente riferiti a qualche determinato pro-getto.
libertaÁ delli triestini »; oltre che alla costruzione delle necessarie in-frastrutture portuali, detti terreni avrebbero potuto anche essereconcessi in affitto a privati cittadini, a tutto vantaggio della cassa go-vernativa. Infatti si considerava avocabile il dazio cosiddetto dell'al-borazo 52, goduto in quel tempo dai triestini ma destinato, ex StatutisCivitatis, a beneficio del porto e quindi esigibile dell'Intendenza, chesul porto aveva competenza economica e giurisdizionale.
L'amministrazione finanziaria dell'Intendenza avrebbe dovutoessere posta sotto il diretto controllo del « Presidente delle Regie Fi-nanze », con indipendenza da ogni altro dicastero. Da ultimo Maren-zi suggeriva anche l'istituzione di una lotteria nazionale, sull'esempiodi quanto giaÁ esisteva in Austria 53.
La Hauptresolution venne indubbiamente a chiarire il delicatoproblema delle finanze; oltre ad una puntuale regolazione delle tassee dei dazi, venne rafforzato il fondo commerciale (art. 14) e vennerodate disposizioni per l'amministrazione del borgo dei Santi Martiri(art. 18); non si accennava invece alla lotteria.
Presentato cosõÁ l'inedito, si puoÁ tentare di tracciare un profilo in-tellettuale del suo autore, onde poterlo inquadrare nella cultura, nonsolo regionale, della metaÁ del Settecento. Abbiamo visto che eglicompõÁ regolarmente i primi studi presso il collegio dei Gesuiti a Trie-ste, all'epoca sede di istruzione preferita per i rampolli delle famigliepatrizie e di quelle borghesi piuÁ agiate; in esso Marenzi entroÁ nel1695, all'etaÁ di otto anni, per uscirne nel 1700 a tredici 54: vi rimasequindi cinque anni, saltando il primo anno di corso forse perche giaÁaveva beneficiato di qualche insegnamento privato 55. Nulla sappia-mo invece di suoi studi ulteriori; tuttavia, considerando gli alti uffici
103
52 Dazio dei nocchieri o dell'alboraggio (Datio nautarum); cfr. Statuti di Trieste, lib.IV, rubr. 10 (pp. 294-295 nell'ed. del 1727).
53 La lotteria era uno dei rimedi preferiti per risanare i bilanci dello Stato senza do-ver ricorrere a prestiti esterni; cfr. C.A. MACARTNEY, L'impero degli Asburgo, tr. it., Gar-zanti, Milano 1976, p. 59.
54 ADTs, Catalogus studiosorum collegii Tergestini Societatis Iesu 1619-1809, segn. 2D 18; entroÁ nel 1695 come parvista (c. 116r), nel 1696 era principista (c. 117v), nel 1697grammatista (c. 119v), nel 1698 syntaxista (c. 121r), nel 1699 poeta (c. 123r) e nel 1700rhetor (c. 125r).
55 Non figura, infatti, nel primo anno di studi come minimista.
che venne in seguito a ricoprire in seno all'amministrazione statale ela sua conoscenza del diritto pubblico austriaco, forse non acquisitasemplicemente attraverso la pratica nella sua lunga carriera, potrem-mo supporre, non senza un ampio margine di incertezza, che avessecompiuto studi universitari di tipo legale.
Fatto eÁ , comunque, che Antonio Marenzi si dimostra individuodi cultura non comune, certamente superiore a quella di molti suoiconcittadini contemporanei, anche occupati in altre cariche pubbli-che.
Egli si rivela buon utilizzatore della cultura tardosecentesca e deiprimi anni del Settecento, epoca coincidente con la sua maturazioneculturale. Conosceva e citava l'opera di Ferdinando Ughelli, Italia sa-cra, edita per la prima volta nel 1640 ma piuÁ volte ristampata e di cuisi conosce una importante edizione di dieci volumi in folio stampataa Venezia tra il 1717 ed il 1722 56. E di quest'opera Marenzi dovevaavere letto quantomeno la parte riguardante Trieste, da lui citata,compresa nei titoli Tergestinae ecclesia et reliquiae, Ejusdem annuicensus, Tergestinus Episcopus comitis titulo 57.
Marenzi sembra soprattutto un ammiratore e attento osservatoredella cultura francese e in particolare di quei movimenti di idee piuÁmoderne e preludenti alla vasta corrente riformatrice settecentesca.Per quanto riguarda la politica economica, eÁ abbastanza evidentein quale misura egli tenesse presente, piuÁ o meno inconsapevolmentee forse mutuandola attraverso autori austriaci, la politica economicadella Francia colbertista: attraverso il riordinamento dell'economialocale e nazionale, la regolamentazione del commercio, la ridistribu-zione di dazi ecc., tutto al servizio del sovrano in funzione della suapotenza 58.
Era attento, quindi, a quelle istanze che venivano riassunte nelmercantilismo, i cui princõÁpi erano stati ripresi e si stavano diffonden-do in Austria ad opera di autori come Johann Joachim Becher, Phi-
104
56 F. UGHELLI, Italia sacra sive De Episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebu-sque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem. Opus singulare, Tip. S.Coleti, Venezia 1717-1722.
57 UGHELLI, Italia sacra, cit., V, p. 575 ss.58 P. DEYON, Il mercantilismo, tr. it., Mursia, Milano 1971.
lipp Wilhelm von HoÈ rnigk e Wilhelm von SchroÈder, che posero lebasi del cameralismo, sostenendo la necessitaÁ di una riforma delloStato in senso assolutistico 59. Non eÁ escluso, in questo senso, cheMarenzi conoscesse anche i numerosi progetti che fin dal 1670 Be-cher aveva presentato alla Corte di Vienna per uno sviluppo dei traf-fici commerciali dell'Austria, via mare, con i paesi nordici e proprioattraverso Trieste individuata come uno dei principali porti del Lito-rale 60.
Tali idee si ritrovano anche in un altro autore che Antonio Maren-zi dimostrava di conoscere e di apprezzare: FrancËois FeÂnelon Salignacde la Mothe (1651-1715), precettore del Delfino di Francia LuigiXIV, che aderendo anch'egli alle teorie giusnaturalistiche come igiaÁ ricordati Becher, von HoÈ rnigk e von SchroÈder 61, venne conside-rato dai riformatori del Settecento come un precursore e un maestro.
Di FeÂnelon Marenzi doveva avere letto le maggiori opere politi-che scritte per educare il duca di Borgogna ma pubblicate appena trail 1712 ed il 1718, Les aventures de TeÂleÂmaque, i Dialogues des mortse L'examen de conscience par un roi. Da esse aveva fatto proprie mol-te idee, che contribuiscono cosõÁ a porlo tra i piuÁ fermi difensori delporto franco settecentesco: una politica di pace e di giustizia, il cultodella legge e del dovere sentito sia dal sovrano che dal popolo, un
105
59 Cfr. M. R. DI SIMONE, Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento, Bul-zoni, Roma 1984, p. 41; si veda peroÁ anche K. TRIBE, Governing Economy: the Reforma-tion of German Economic Discorse 1750-1840, Cambridge University Press, Cambridge1988, che osserva l'assenza, nel cameralismo tedesco, di quei princõÁpi giusnaturalistici efisiocratici che avrebbero consentito in Inghilterra e in Francia l'evoluzione verso il libe-rismo; percioÁ il pensiero economico germanico sarebbe caratterizzato da spazi di auto-nomia e maggiore peculiaritaÁ rispetto a quanto comunemente si ritiene.
60 Su Becher cfr. H. HASSINGER, Becher Johann Joachim, Kameralist, voce in NeueDeutsche Biographie, II, Berlin 1953, pp. 689-690; sui suoi progetti per il commercio at-traverso Trieste cfr. A. BEER, Die oÈsterreichische Handelspolitik unter Maria Theresia undJoseph II, « Archiv fuÈ r oÈ sterreichische Geschichte », 86 (1898), pp. 174-176 e H. VON
SRBIK, Der staatliche Exporthandel OÈsterreichs von Leopold I. bis Maria Theresia, Brau-muÈ ller, Wien und Leipzig 1907, pp. 66-67 oltre a A. TAMARO, Storia di Trieste, a curadi G. CERVANI, II, Lint, Trieste 19762, p. 98. Si veda anche H. RUMPLER, Economia e po-tere politico. Il ruolo di Trieste nella politica di sviluppo economico di Vienna, in FINZI,PANARITI, PANJEK (a cura di), Storia economica e sociale di Trieste, II, cit., pp. 155-124.
61 DI SIMONE, Aspetti della cultura, cit., p. 41-42.
intelligente temperamento dell'assolutismo monarchico, l'indicazionedel commercio e dell'agricoltura come fonti prime del benessere eco-nomico e morale; cosõÁ nel memoriale: « due cosse costituiscono la ri-cheza d'una cittaÁ et suoi habitanti: l'una si eÁ l'esercizio dell'agricoltu-ra, l'altra l'impiego nel comertio » 62.
Come FeÂnelon si rivolgeva al suo principe, alla fine del Seicento,denunciando l'irresponsabilitaÁ dei ministri che avevano stravolto iprincõÁpi sui cui si reggeva la monarchia, incuranti del benessere deigovernati, spadroneggiando nelle rispettive amministrazioni, eserci-tando violenza, oppressione e altre forme di ingiustizia 63, cosõÁ Anto-nio Marenzi si rivolgeva idealmente alla propria Sovrana denuncian-do l'inefficienza dell'Intendente, sprezzante delle disposizioni sovra-ne, attentatore dell'avvenire commerciale della cittaÁ , alleato deitriestini oppositori della politica imperiale.
Esaminando piuÁ analiticamente le posizioni di Marenzi a con-fronto con le teorizzazioni di FeÂnelon, nel testo espressamente richia-mate, emergono tuttavia sfumature e temperamenti.
Marenzi era portato ad accettare l'assolutismo monarchico e agiustificare, in funzione del suo rafforzamento, il contenimento delpotere delle autonomie locali; non si poneva alcun problema sulla le-gittimitaÁ , sui limiti e sugli obblighi del potere sovrano, quando invecenell'opera di FeÂnelon, a lui nota, si giungeva a riconoscere un limiteall'assolutismo, attraverso il potere dei ceti garantito da una sorta dicontratto naturale 64. CosõÁ pure, nel riemergere del ricorrente conflit-to tra potere (sovranitaÁ) dello Stato e potere (autonomia) locale,quindi tra l'interesse generale e il particolarismo locale, Marenzi si li-mitava a denunciare le responsabilitaÁ dei funzionari, colpevoli di ave-
106
62 MARENZI, ms. cit. Su FeÂnelon politico si veda il classico A. CHEÂ REL, FeÂnelon auXVIIIe sieÁcle (1715-1820). Son prestige, son influence, Hachette-Champion, Paris 1917 (ri-stampa Slatkine, GeneÁve 1970); L. GUERCI, LibertaÁdegli antichi e libertaÁdei moderni. Spar-ta, Atene e i « philosophes » nella Francia del Settecento, Guida, Napoli 1979, pp. 20-22.
63 C. CANTUÁ , Storia universale, V, Pomba, Torino 18527, pp. 1338-1342.64 Cenni di carattere generale sul rapporto tra mercantilismo e cameratismo si pos-
sono trovare in A. BERTOLINO, Storia del pensiero economico, La Nuova Italia, Firenze1950, p. 160; R. CAMERON, L. NEAL, Storia economica del mondo, I, il Mulino, Bologna1993, pp. 230-231.
re disatteso le direttive sovrane, quasi volendo ignorare l'ulteriorepasso di FeÂnelon che implicava il coinvolgimento diretto del sovranostesso, chiamato alle sue stesse responsabilitaÁ nel cattivo governo del-lo Stato 65.
I temperamenti piuÁ significativi alle teorizzazioni di FeÂnelon sinotano invece nell'analisi della funzione dell'agricoltura, che per FeÂ-nelon assolveva a un fine economico e a una funzione sociale, tantoper ragioni morali quanto per ragioni di ordine pubblico, tanto che,proprio in ragione di questa maggiore attenzione all'agricoltura ri-spetto al commercio, molti frequentemente lo avvicinano ai teoricidella fisiocrazia 66.
Il memoriale di Marenzi rivela invece particolare attenzione econsiderazione per il commercio e per l'economia ad esso collegata;il nostro personaggio non ignorava la funzione importante dell'agri-coltura in un sistema sociale, ma sembrava riequilibrare i due ele-menti (agricoltura e commercio), interpretando restrittivamente alcu-ni princõÁpi di FeÂnelon e cercando di applicarli alla realtaÁ triestina. Ri-duceva cosõÁ la funzione sociale dell'agricoltura a occupazione unica ±tipica ± dei triestini indigeni, caricando di maggior valore l'asserzionedi FeÂnelon secondo la quale il commercio eÁ occupazione e materiaeconomica riservata ai soli commercianti, quindi non ai triestini ori-ginari 67. Ne stupisce, allora, il richiamo diretto di Marenzi alle pro-posizioni di FeÂnelon che maggiormente caratterizzavano, a ben vede-re, quei punti del suo pensiero definiti premercantilisti 68: « Accoglie-
107
65 BERTOLINO, Storia del pensiero economico, cit., p. 163.66 BERTOLINO, Storia del pensiero economico, cit., pp. 174-175, 192-198 e 206-214.
Si veda ora anche J. H. DAVIS, FeÂnelon, Twayne, Boston 1979; H. HILLENAAR (a cura di),Nouvel eÂtat preÂsent des travaux sur FeÂnelon, Rodopi, Amsterdam 2000.
67 BERTOLINO, Storia del pensiero economico, cit., p. 181; Ch. URBANI, FeÂnelon.EÂcrits et lettres politiques, Bossard, Paris 1920, pp. 123-125. Importanti indicazioni inV. BECAGLI, La diffusione della fisiocrazia nell'Italia del Settecento. Note per una ricerca,in P. BARUCCI (a cura di), Le frontiere dell'economia politica. Gli economisti stranieri inItalia, dai mercantilisti a Keynes, Edizioni Polistampa, Firenze 2003, pp. 63-82.
68 BERTOLINO, Storia del pensiero economico, cit., pp. 214-216. Sull'influenza delpensiero economico di FeÂnelon negli autori settecenteschi vedi CHEÂ REL, FeÂnelon auXVIIIe sieÁcle, cit.; M. ALBERTONE, Fisiocrati, istruzione e cultura, Fondazione Luigi Ei-naudi, Torino 1979, p. 34.
te cortesemente tutti i forestieri; concedete loro nei vostri porti agio esicurezza, e pienissima libertaÁ [...]. Procurate di essere benvoluto datutti i forestieri, anche a costo talvolta di soffrirne qualche svantaggio[...]. Sieno facili e semplici ma sempre costanti le regole del commer-cio e dai vostri popoli inviolabilmente osservate; badate a punire conseveritaÁ non solamente la frode, ma la trascuraggine ancora [...]. Cir-ca a' forestieri dovete persuadervi che il comodo solamente e il van-taggio li alletta a venire nei vostri porti: onde se rendete loro il com-mercio meno comodo, o meno utile, a poco a poco si ritireranno, pernon venire piuÁ » 69.
Le parole che FeÂnelon rivolgeva al proprio sovrano riecheggiava-no cosõÁ nel memoriale di Marenzi alla vigilia della Hauptresolution.
La constatazione che Marenzi, pur conoscendo il pensiero delfrancese e pur citandone l'opera, ne temperava alcuni toni, interpre-tandoli in diverse occasioni alla luce di concezioni manifestamentenon piuÁ tardosecentesche, induce a far ritenere che, al di laÁ dell'espli-cito richiamo, il funzionario triestino fosse interessato soprattutto autilizzare ± con una certa abilitaÁ ± la fonte francese per recuperarneun efficace schema retorico e dialettico, onde adattarlo alle piuÁ mo-derne e contingenti esigenze. E la conferma di questa impressionegiunge proprio dall'esame del memoriale, dal quale emergono in ul-tima analisi predominanti connotazioni mercantiliste e cameraliste.
Si coglie infatti, fin dalle prime pagine, la significativa adesione diMarenzi alle dottrine assolutistiche; cosõÁ il funzionario triestino si di-mostrava fautore del rafforzamento del potere statuale in materia fi-scale e commerciale auspicava il ridimensionamento delle autonomielocali per favorire il consolidamento del governo centrale. Si tratta diposizioni ben note e diffuse nell'Austria e nell'area germanica dellaprima metaÁ del Settecento, favorite anche nell'ambiente universita-rio, ove diritto naturale e teorie mercantiliste trovano frequente ar-monizzazione e sempre maggiore fortuna 70. Alla luce di questa con-
108
69 Cito da FEÂ NELON, Le avventure di Telemaco figliuolo d'Ulisse, tr. it., Gravier, Na-poli 1778, p. 78. Cfr. anche C. PERROTTA, G. FORGES DAVANZATI, La nascita del mercan-tilismo in Italia, in BARUCCI, Le frontiere dell'economia politica, pp. 31-62.
70 Sul punto cfr. R. KINK, Geschichte der kaiserlichen UniversitaÈt zu Wien, I/1, Ge-rold, Wien 1854, pp. 463-482 e anche DI SIMONE, Aspetti della cultura, cit., pp. 46-47.
statazione, quindi, l'ipotesi che nella formazione culturale di Marenzinon fosse stato del tutto estraneo l'ambiente universitario di Viennao di Graz sembra acquistare maggiore credibilitaÁ , pur mancando ri-scontri immediati.
Se, come appare ampiamente documentato, il mercantilismo eÁ ilsistema economico corrispondente all'assolutismo, considerate le po-sizioni ora esaminate non si trova difficoltaÁ nell'accostare le idee e lafigura di Marenzi al vasto movimento politico, filosofico ed economi-co ± il mercantilismo appunto ± in quell'epoca molto diffuso. Tutta-via, poiche Marenzi operava nell'ambiente austriaco, il riferimento alcameralismo appare necessario. In questo caso, peroÁ , le posizioni diMarenzi, se raffrontate ai lineamenti generali del pensiero camerali-sta, sembrano sfumate e meno facilmente individuabili, anche percheÂla stessa distinzione tra mercantilismo e cameralismo eÁ suscettibile diinterpretazioni differenti 71. Certo eÁ che, ove si considerino il feno-meno del cameralismo e la sua definizione con il maggiore rigore (in-dividuando cioeÁ precise delimitazioni cronologiche e di contenuto),distinguendo mercantilisti e cameralisti in base alla considerazioneche i primi erano attratti piuÁ dall'aspetto economico-finanziario delfenomeno politico che dalla sua globalitaÁ 72, appare indubitabileche nelle posizioni di Marenzi siano riconoscibili molti elementi ri-conducibili al cameralismo « puro », che superano quindi un riferi-mento al cosiddetto mercantilismo « imperiale » 73. Acquistano rilie-
109
71 Vedi anche P. SCHIERA, Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismoe l'assolutismo tedesco, GiuffreÁ , Milano 1968 e J. BRUÈ CKNER, Staatswissenschaften, Kame-ralismus und Naturrecht. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft imDeutschland des spaÈten 17. und fruÈhen 18. Jahrhunderts, UniversitaÈ t MuÈnchen, MuÈnchen1977, pp. 65-80. Per Becher, oltre alla voce nella Neue Deutsche Biographie citata, vedi ilprecedente e approfondito studio di H. HASSINGER, Johann Joachim Becher (1635-1682).Ein Beitrag zur Geschichte der Merkantilismus, Holzhausen, Wien 1951.
72 Sul punto cfr. le voci di P. SCHIERA, Cameralismo e di M. AMBROSOLI, Mercantili-smo in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, Dizionario di politica, UTET, Torino 1976, rispettiva-mente alle pp. 123-127 e 571-573.
73 Sul concetto di mercantilismo « imperiale » cfr. SCHIERA, Cameralismo, cit., p.124; per gli importanti sviluppi di queste teorie vedi J. BEÂ RANGER, Resistenza dei ceti alleriforme dell'Impero, R. GHERARDI, Itinerario di una « Staatswerdung ». Il patrimonio au-striaco di modernizzazione tra XVII e XVIII secolo e G. KLINGENSTEIN, Riforma e crisi:la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Tentativo di un'interpretazione,
vo cosõÁ l'accennato equilibrio di Marenzi in materia economica nelbilanciamento di agricoltura e commercio, l'attenzione del memoria-le per la politica fiscale e per il sistema delle finanze locali e dello Sta-to, con una tendenza a superare taluni aspetti estremi dell'accentra-mento riaffermando il principio della separazione della giustizia dal-l'amministrazione e ammettendo una certa articolazione degli organidello Stato preposti al governo della cittaÁ , in vista soprattutto di unloro riordinamento per favorirne il completo funzionamento.
Si tratta comunque, come eÁ dato a vedere dagli elementi noti, diuna posizione complessa e non facilmente riconducibile ad un'ideo-logia unitaria o suscettibile di univoca interpretazione. Del resto que-sta interpretazione trova riscontro ± con riguardo, appunto, alla pos-sibilitaÁ di una complessiva definizione intellettuale ± ad altri livellinell'esaminare le figure di Justi e di Sonnenfels 74.
Si assiste, in ultima analisi, alla convergenza di idee anche diffe-renti tra loro, che confluiscono nel memoriale (unica opera finora no-ta di Marenzi) modulandone il contenuto e caratterizzandone l'anda-mento, pur nella prevalenza di toni fortemente polemici caratteristicidell'autore.
Il ritrovamento e il breve esame di questo manoscritto rendonopercioÁ possibile ± almeno in parte ± una valutazione sul contributodelle autoritaÁ governative locali ai lavori preparatori di quella com-missione la cui relazione sarebbe stata alla base della Hauptresolution(1749), gettando inoltre un po' di luce sulla situazione politica e cul-turale nella Trieste della prima metaÁ del Settecento, epoca tradizio-nalmente considerata di semplice preparazione al definitivo avviodel porto franco, quasi che i lenti e in veritaÁ non numerosi progressieconomici e istituzionali di quel periodo fossero dovuti esclusiva-mente ad impulsi provenienti dall'esterno e, nella specie, dagli alti di-casteri dello Stato. Dall'esame del memoriale, inoltre, si trae l'impres-
110
tutti contributi apparsi in P. SCHIERA (a cura di), La dinamica statale austriaca nel XVIII eXIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, il Mu-lino, Bologna 1981, pp. 19-129.
74 Cfr. infatti E. DITTRICH, Die deutschen und oÈsterreichischen Kameralisten, Wis-senschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1974, pp. 103-115 e anche DI SIMONE,Aspetti della cultura, cit., p. 108 nonche SCHIERA, Cameralismo, cit., p. 126.
sione ± suscettibile del resto di ulteriori verifiche attraverso nuove in-dagini sul materiale documentario disponibile ± che il primo cin-quantennio del Settecento fosse per la storia culturale e politica diTrieste meno arido di quanto la storiografia tradizionale (spesso sug-gestionata dal semplice problema della contrapposizione tra classemercantile e patriziato 75) lo abbia finora prospettato. Alcune corren-ti di pensiero trovarono invece ascolto, almeno episodico allo statoattuale delle ricerche, ma ben prima del piuÁ vasto e potente rinnova-mento culturale della seconda metaÁ del Settecento.
EÁ opportuno d'altronde precisare che la figura di intellettuale re-cuperata alla memoria storiografica con l'esame di questo manoscrit-to, se entro un ambito geograficamente limitato come quello del Li-torale puoÁ rivestire un ruolo non indifferente, appare nella prospetti-va piuÁ ampia della storia della cultura e della diffusione delle idee nelSettecento come uno degli elementi tipici del sistema politico e cultu-rale dell'assolutismo illuminato 76. Si conferma cosõÁ, in una piuÁ ampiavisione storiografica, l'inscindibilitaÁ delle vicende locali da quelle del-la compagine statuale cui si riferirono, nel delicato momento che ve-deva l'erosione dell'autonomia cittadina in vista di piuÁ generali inte-ressi e la sua riduzione a « semplice autonomia amministrativa », incui gli organi di governo cittadino venivano costretti « alle ordinariefunzioni di un consiglio comunale negli Stati del Settecento » 77.
111
75 EÁ una concezione che affonda le proprie radici nella storiografia ottocentesca,ben rappresentata in questo da KANDLER, Storia del consiglio dei Patrizi, cit., pp. 248-250.
76 Per un altro esempio, seppure un po' piuÁ tardo, di echi della cultura cameralistacfr. A. LEONARDI, L'opera di un cameralista italiano. L'economia dell'Austria Teresiana ele sue potenzialitaÁ nell'elaborazione di Antonio Pellegrini, in B. MAZOHL-WALLNIG, M.MERIGGI (a cura di), OÈsterreichisches Italien-Italienisches OÈsterreich? Interkulturelle Ge-meinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des ErstenWeltkrieges, Verlag der OÈ sterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999,pp. 411-498.
77 G. DE VERGOTTINI, Profilo politico della storia di Trieste, in ID., Scritti di storia deldiritto italiano, a cura di G. ROSSI, II, GiuffreÁ , Milano 1977, p. 1371.
IV. - LA FORMAZIONE DEL FUNZIONARIO IN ETAÁ
TERESIANA
Poche regioni della monarchia asburgica si trovarono ad avere,nel corso del Settecento, un'identitaÁ politica tanto indefinita quantoil Litorale Austriaco: area geografica stretta fra i domini della Repub-blica di Venezia, la cui rilevanza era schiacciata da quella del portofranco di Trieste, che sembrava assorbire ed esaurire in se tutte le ca-ratteristiche del piccolo territorio. Il Litorale rimase per lungo tempouna semplice entitaÁ amministrativa e giuridica, dai confini incerti,spesso modificati, dove le istituzioni e i suoi responsabili cambiavanofrequentemente, denotando un senso di precarietaÁ e nello stesso tem-po l'ansia del rinnovamento e della modernizzazione.
A partire dagli anni Cinquanta del XVIII secolo il Litorale co-mincioÁ a rappresentare sul versante adriatico cioÁ che era la Lombar-dia all'altro capo dei domini italiani di casa d'Asburgo: un laborato-rio economico e politico, in cui la monarchia si impegnava nella sfidadi fornire il porto franco ± istituito giaÁ nel 1719 ± degli strumenti am-ministrativi e giuridici che ne avrebbero favorito i destini economi-ci 1. In tale contesto gli organi di governo viennesi dovettero dotare
112
1 Per i lineamenti istituzionali e amministrativi CERVANI, Il Litorale austriaco, cit.;ZÏ ONTAR, HandbuÈcher und Karten, cit.; FABER, Litorale Austriaco, cit. Per un confrontosu questi temi si vedano anche i contributi di R. PAVANELLO, Da magistrati a pubblici im-piegati. L'amministrazione civica a Trieste tra conservazione e riforme, di E. GARMS-COR-
NIDES, FunktionaÈre und Karrieren im Italien Karls VI, di C. CAPRA, Pietro Verri a Vienna,
i nuovi uffici, prima quelli della Cesarea Regia Suprema IntendenzaCommerciale istituita nel 1748 e poi quelli del Cesareo Regio Gover-no, succeduto nel 1776, di funzionari preparati e capaci, di un cetoimpiegatizio completamente nuovo, che potesse rispondere alla dina-micitaÁ delle iniziative emporiali e rimediare alle inefficienze delle an-tiche magistrature municipali. Riforme legislative, istituzioni, organidi governo avrebbero incoraggiato invece solo in un secondo tempola lenta costruzione di una identitaÁ culturale, formata dal concorso diquanti ± italiani, tedeschi, slavi, greci, armeni ± venivano a stabilirsinel Litorale attratti dalle favorevoli situazioni economiche, politiche esociali.
PuoÁ essere pericoloso, oltre che metodologicamente improdutti-vo, fissare preliminarmente una nozione o una tipologia del funziona-rio (Beamte) che alla metaÁ del Settecento presentava in Austria con-torni ancora vaghi e indefiniti. Soltanto con le grandi riforme del-l'amministrazione teresiana il termine di Beamte assunse unsignificato piuÁ preciso per indicare soltanto gli impiegati dello Stato,escludendo cosõÁ molti incaricati di un ufficio pubblico (officia publi-ca, come i notai, i procuratori e cosõÁ via) e tutti gli impiegati privati 2.
Attraverso la riorganizzazione degli organi di governo nel Litora-le settecentesco eÁ possibile riconoscere un fenomeno nuovo nello svi-luppo delle carriere dei funzionari in etaÁ teresiana, vale a dire la re-gionalizzazione nei meccanismi di reclutamento del personale, pre-supposto per l'istituzione di scuole professionali, per l'affermazionedi nuovi requisiti fondati sulla professionalitaÁ e sul merito, preludiodella nascita di una figura professionale moderna. Le pagine che se-guono intendono percioÁ introdurre un tema di indagine che, se per
113
Pietro Verri e Vienna (1764-1771) e di E. FABER, Beamtenkarrieren im Litorale Austriacodes 18. Jahrhunderts ± von Wien nach Triest, tutti in MAZOHL-WALLNIG, MERIGGI (a curadi), OÈsterreichisch Italien ± Italienisches OÈsterreich, cit., rispettivamente alle pp. 139-156,207-226, 227-250, 331-348.
2 I. BEIDTEL, Geschichte der oÈsterreichischen Staatsverwaltung 1740-1848, Wagner,Innsbruck 1896-1898, 2 voll. Ancora all'inizio dell'Ottocento J.C. ADELUNG, Gramma-tisch-kritisches WoÈrterbuch der Hochdeutschen Mundart, I, Pichler, Wien 1807, p. 773,scriveva che «Es ist dieses Wort [cioeÁ Beamte] eigentlich das Participium passivumvon dem Verbo beamten, mit einem Amte versehen, welches im Oberdeutschen sehrgebraÈuchlich ist, im Hochdeutschen aber wenig gehoÈ ret wird ».
altre realtaÁ europee eÁ da tempo oggetto di feconda riflessione storica,rimane tuttavia ancora quasi del tutto sconosciuto per quella locale.
Come si vedraÁ , nel Litorale la regionalizzazione nei meccanismidi reclutamento dei funzionari venne sollecitata non tanto da istanzeesterne e meramente politiche, quanto da situazioni di necessitaÁ og-gettiva. Il trasferimento verso Trieste di personale giaÁ reclutato aVienna, a Graz o presso altri organi di governo regionali servõÁ infattisolo in parte a soddisfare le esigenze della neoistituita IntendenzaCommerciale, e riguardoÁ soprattutto gli incarichi di maggiore re-sponsabilitaÁ 3. Ben presto divennero piuÁ forti le esigenze di coprirei posti di responsabilitaÁ subalterni e di affrontare gli specifici caratterilinguistici della regione, ove l'idioma in uso negli uffici era quello te-desco, mentre la lingua franca nei rapporti fra la popolazione era ildialetto di tipo veneziano 4. Il percorso che, nel Litorale, portoÁ allanascita del funzionario quale figura professionale moderna si puoÁpertanto ricostruire esaminando alcune questioni salienti: il tentativodi istituire una scuola professionale, la diversa estrazione sociale degliimpiegati statali rispetto a quelli municipali, la necessitaÁ di individua-re nelle conoscenze linguistiche un nuovo requisito di professionalitaÁ ,il riordinamento del sistema delle retribuzioni e delle pensioni. Sonoquesti gli elementi al centro dell'attenzione del conte Zinzendorf nelperiodo del suo governatorato nel Litorale (1776-1782), che ci con-sentono poi di verificare se, e in quale misura, i funzionari in questaregione ebbero consapevolezza del proprio ruolo e come eventual-mente lo rappresentarono verso l'esterno, cercando di fornirne unaimmagine quanto piuÁ possibile definita.
EÁ noto che con la nascita di una burocrazia moderna, nel corsodel XVIII secolo, vennero acquisendo sempre maggiore importanza irequisiti della professionalitaÁ e del merito 5. La possibilitaÁ di dare ef-
114
3 FABER, Litorale Austriaco, cit., passim.4 Sull'uso della lingua a Trieste e sulla storia del dialetto si puoÁ vedere ancora util-
mente M. DORIA, Storia del dialetto triestino, con una raccolta di 150 testi, Italo Svevo,Trieste 1978. Inoltre i saggi di R. PELLEGRINI, Per un profilo linguistico e di R. FINZI,La base materiale dell'italofonia di Trieste, entrambi in FINZI, PANJEK (a cura di), Storiaeconomica e sociale di Trieste, I, cit., rispettivamente alle pp. 293-316 e 317-332.
5 Sulla figura del funzionario in etaÁ moderna cfr. C. CAPRA, Il funzionario, in M.
fettivo riconoscimento ad essi incideva non poco sulla tradizione: de-terminava l'allentamento del legame personale con il sovrano o conla corte posto a base del potere discrezionale di nomina e rendevanecessaria, all'opposto, la creazione di istituzioni educative e di scuo-le professionali attraverso le quali preparare i nuovi servitori delloStato 6.
Anche se in Austria la definitiva riorganizzazione delle carrieredei funzionari pubblici sarebbe avvenuta soltanto durante il regnodi Giuseppe II 7, con la fissazione dell'obbligo degli studi universitariper l'accesso a molte cariche statali, i primi segni della nascita di unafigura professionale nuova possono essere individuati piuÁ indietro neltempo. Le disposizioni con cui, nel 1766, venne posto il requisitodella conoscenza di nozioni di scienze di polizia e camerali (Polizei-und Kameralwissenschaften) per l'ammissione agli uffici, ad esempio,non fecero che recepire istanze precedenti e reiterati tentativi di im-postare nuovi corsi di studio, tanto attraverso l'universitaÁ , quanto at-traverso scuole di tipo speciale 8.
In Francia l'istituzione di scuole professionali risaliva giaÁ agli an-ni quaranta del Settecento, con l'EÂcole des ponts et chausseÂes, la Scuo-la della Marina e la Scuola del Genio 9. A Vienna, il collegio Teresia-
115
VOVELLE (a cura di), L'uomo dell'Illuminismo, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 353-398;A.-M. PATAULT, Les origines reÂvolutionnaires de la fonction publique: de l'employe aufonctionnaire, « Revue historique de droit francËois et eÂtranger », 63 (1986), 389-406.
6 Per l'introduzione di nuove forme di selezione ben rappresentato eÁ il caso pie-montese in V. FERRONE, I meccanismi di formazione delle eÂlites sabaude: reclutamentoe selezione nelle scuole militari del Piemonte nel Settecento, in P. ALATRI (a cura di), L'Eu-ropa tra illuminismo e restaurazione. Scritti in onore di Furio Diaz, Bulzoni, Roma 1993,pp. 157-200.
7 P.G.M. DICKSON, Monarchy and Bureaucracy in Late Eighteenth-Century Austria,« English Historical Review », 1995, pp. 323-367, offre un quadro di storia sociale rife-rito agli alti dicasteri nel periodo del regno di Giuseppe II. Qualche riferimento anche inC. LEBEAU, L'administrateur: vecteur de l'AufklaÈrung?, in W. SCHNEIDERS (a cura di), TheEnlightenment in Europe / Les LumieÁres en Europe / AufklaÈrung in Europa. Universityand Diversity / Unite et Diversite / Einheit und Vielfalt, Berliner Wissenschafts-Verlag,Berlin 2003, pp. 241-256.
8 W. HEINDL, Gehorsame Rebellen. BuÈrokratie und Beamte in OÈsterreich 1780 bis1848, BoÈhlau, Wien-KoÈ ln-Graz 1991, pp. 98-100.
9 CAPRA, Il funzionario, cit., 376; L. BLANCO, Stato e funzionari nella Francia del Set-tecento: gli « ingeÂnieurs des ponts et chausseÂes », il Mulino, Bologna 1991.
no, benche non ancora scuola professionale, pote servire in parte asoddisfare anche queste nuove esigenze, benche l'accesso fosse riser-vato ai membri della nobiltaÁ 10. Nel Litorale, mancando del tuttoun'universitaÁ , la situazione culturale di partenza era ben diversa.L'antico collegio dei Gesuiti soddisfaceva l'istruzione primaria delpatriziato locale e dei pochi non nobili che vi potevano accedere.Poi, chi voleva proseguire gli studi, per conseguire la laurea in utro-que iure o in medicina, frequentava le universitaÁ di Vienna o piuÁspesso di Graz. EÁ comprensibile quindi che l'emigrazione studente-sca verso le cittaÁ universitarie bastasse solo in parte a preparare uo-mini adatti alle necessitaÁ dell'Intendenza, anche perche la possibilitaÁdi compiere gli studi e di soggiornare a Vienna o a Graz dipendevadalle condizioni economiche ± spesso precarie ± della nobiltaÁ locale.
Pochi anni quindi dopo l'istituzione dell'Intendenza Commercia-le, veniva creata a Trieste una scuola nautica, affidata alla direzione algesuita Francesco Saverio Orlando 11. Lo scopo era quello di soddi-sfare le esigenze del porto franco, garantendo la formazione professio-nale di piloti e di operatori marittimi attraverso un corso biennale cheprevedeva l'insegnamento al primo anno di aritmetica, algebra, geo-metria e trigonometria piana, nonche al secondo anno di trigonome-tria sferica, astronomia, geografia matematica e idrografia 12. Tuttavial'originaria funzione della scuola doveva ben presto essere ampliata.Con editto dell'Intendenza Commerciale del 10 settembre 1756 veni-va chiaramente affermato che: « il preciso Volere di Sua MaestaÁ s'eÁ
116
10 M. CSAKY, A. LANZER (a cura di), EÂtatisation et bureaucratie. Staatswerdung undBuÈrokratie, VWGOÈ , Wien 1990.
11 EÁ interessante notare che l'iniziativa asburgica eÁ quasi contemporanea ad unaanaloga veneziana; cfr. M. COSTANTINI, L. FLORIAN, La scuola nautica di Venezia, inM. COSTANTINI, Una repubblica nata sul mare. Navigazione e commercio a Venezia, Mar-silio, Venezia 2006, pp. 92-137.
12 Per la storia di questa istituzione cfr. La sezione nautica dell'I. R. accademia diCommercio e nautica di Trieste nel centocinquantesimo anniversario della sua istituzione,Sezione nautica dell'i.r. Accademia, Trieste 1904 (ristampa anastatica: Italo Svevo, Trie-ste 2005); M. POGLIACCO, L'istituto tecnico nautico « Tommaso di Savoia Duca di Geno-va » nel bicentenario della sua istituzione 1754-1954, Tip. Moderna, Trieste 1957; MAR-
ZARI, L'accademia di Commercio e nautica, in CAPUTO (a cura di), Neoclassico. Arte, archi-tettura e cultura a Trieste 1790-1840, cit., pp. 404-409.
che massimamente quelli del Litorale apprendano li princõÁpi dellescienze suddette, per farsi maggiormente capaci del Sovrano e Pub-blico servizio, che fu ed eÁ il primario fine ed oggetto per il quale s'eÁcompiaciuta la MaestaÁ Sua di instituire e mantenere tale Studio quiin Trieste, con dichiarar espressamente che in avvenire a niuno nel Li-torale saraÁ accordato alcun Regio Impiego o Carica sia civile o milita-re, il quale non l'abbia appreso; all'incontro quelli che si saranno di-stinti nell'apprenderlo verranno riguardati con Clementissimo Mater-no Occhio e preferiti ad altri nelle occasioni di posti vacanti » 13.
Una prima conferma dell'allargata destinazione della scuola sipuoÁ trarre scorrendo i nomi degli studenti e verificandone i succes-sivi destini professionali. Nel 1755 risultavano iscritti quindici stu-denti, di cui la metaÁ triestini e l'altra metaÁ provenienti dalle conteedi Gorizia e Gradisca, dall'Istria e dalla Dalmazia 14. L'etaÁ mediaera di circa ventiquattro anni, piuttosto elevata per l'epoca. Gli elen-chi specificano anche lo status sociale (« condizione », come venivaindicata) e il tipo di studi precedentemente compiuti. Undici studen-ti erano nobili 15, due erano cittadini, un plebeo, di un altro mancanoindicazioni. Quanto agli studi precedenti, tutti erano stati allievi deipadri gesuiti nei collegi di Trieste, di Fiume o di Gorizia e uno sol-tanto aveva giaÁ conseguito la laurea in utroque iure. Negli anni suc-cessivi almeno tre sarebbero entrati al servizio dello Stato, due al ser-vizio dell'amministrazione civica, due nell'esercito, uno nell'avvoca-tura 16. Anche negli anni Sessanta la scuola continuoÁ a preparare
117
13 Acta des Studium Nauticum im Littorali betr. de anno 1753 ad 1762, ASTs,C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 436, c.49r.
14 Ivi, c.14r.15 Il dato relativo alla condizione di nobiltaÁ va tuttavia scomposto, perche rivela dif-
ferenti situazioni sociali. Degli undici studenti nobili, infatti, cinque appartenevano alpatriziato triestino e potevano considerarsi nobili di spada, uno apparteneva alla nobiltaÁprovinciale della Stiria, tre erano nobili del Sacro Romano Impero e due appartenevanoalla nobiltaÁ di toga di piuÁ recente origine.
16 Domenico Francol (1734-1819), priore al lazzaretto di S. Teresa; Antonio Was-sermann (1739-1795), attuario del governo; Giovan Battista Zucconi (1735-post 1807),priore del lazzaretto di S. Carlo; Antonio de Baiardi (1723-1811), scrivano alla Cassa ci-vica; Giovanni Paolo de Baiardi (1725-1800), provisore del Comune; Giovanni Giacomode Baiardi (1728-post 1788), tenente del reggimento di fanteria Palfy; Francesco Nico-letti (m. 1808), tenente del reggimento Caroli, poi general maggiore; Pietro Gobbi
uomini destinati alla pubblica amministrazione: il triestino Andreanobile de Camnich, studente nel 1760, sarebbe divenuto negli anniOttanta deputato di sanitaÁ a Grignano presso Trieste 17; i gradiscaniGiuseppe Sticotti e Andrea barone de Boselli, l'uno nel 1760 e l'altronel 1768, sarebbero divenuti rispettivamente vice cancelliere di Sani-taÁ a Trieste e Kreis- und KonfinkomissaÈr a Gorizia 18. Il fiumano An-tonio nobile de Monaldi, studente nel 1760, sarebbe divenuto giudi-ce regio in patria 19.
L'ammissione alla scuola avveniva per capacitaÁ e per meriti scola-stici, indipendentemente dalla condizione sociale ed economica degliallievi, grazie ad un efficace sistema di sussidi economici. La cittaÁ diTrieste accordava giaÁ dal primo Settecento sussidi per il compimentodi studi giuridici a Graz e di studi medici a Vienna, la cui erogazionevenne regolamentata nel 1765 attraverso la richiesta di certificati diiscrizione, di frequenza e di profitto 20. Un sistema di sussidi (stipen-dia), ciascuno di 100 fiorini annui, venne istituito anche per frequen-tare la scuola nautica 21. Nel 1773, infine, venne creato uno specialesistema di sussidi statali, in base al quale venivano erogate due borsedi studio per la formazione universitaria di altrettanti studenti triesti-ni 22. Il funzionamento della scuola nautica subõÁ comunque modifica-zioni nel corso degli anni: nel 1758 un nuovo editto dell'IntendenzaCommerciale ricordava ancora che l'assolvimento di quegli studiavrebbe costituito titolo di preferenza nella carriera statale, raccoman-dando « che tutti li suddetti padri di famiglia, tuttori e curatori ave-
118
(1728-1797), avvocato. Cfr. L. DE JENNER, Genealogie triestine, I, ms., in ADTs, segn. 1/1 B 3, c.10r., 34r., 36r., 97r., 393r., 422r., 439r.
17 ASTs, C.R. Governo del Litorale (1776-1809), busta 318.18 « L'Osservatore Triestino », n. 6, 19.1.1788, 97; FABER, Litorale Austriaco, cit., p.
147.19 G. KOBLER, Memorie per la storia della liburnica cittaÁ di Fiume, III, Mohovich,
Fiume 1896, p. 172.20 Ms. Stipendi della cittaÁ accordati alli studiosi triestini 1765-1795, ms. ADTs, sgn.
10 D 4, carte non numerate.21 Acta des Studium Nauticum, ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 436,
c.45r.22 ADTs 7 G 11/5, istanza di Francesco Antonio Santonini datata Trieste 16 giugno
1774 per l'ottenimento di una borsa di studio per frequentare la facoltaÁ legale dell'uni-versitaÁ di Vienna.
ranno la premura di secondare la sovrana graziosissima intenzione colfar frequentare il mentovato studio matematico-nautico » 23. Ma giaÁall'inizio degli anni Sessanta la scuola comincioÁ a specializzarsi nel set-tore marittimo 24 e dal 1761 la concessione dei sussidi venne subordi-nata alla idoneitaÁ fisica a compiere il tirocinio per mare 25.
Negli uffici del Litorale, quindi, nonostante la parentesi dellascuola nautica, si continuoÁ ad avvertire per molto tempo il problemadell'assenza di un'adeguata preparazione professionale. Vi sopperiva-no l'esperienza personale e la pratica dell'amministrazione, e si cerca-va di fornire nel corso del tempo ai funzionari giaÁ assunti gli strumen-ti per migliorare la loro preparazione 26. Questi problemi si possonoriconoscere anche studiando un caso specifico, cioeÁ la composizionedella commissione per le costruzioni (Commissione alle fabbriche /Baucommission, poi Ispezione alle fabbriche o Bauinspektion) tra il1752 ed il 1782. I membri erano inizialmente ingegneri militari o co-munque tecnici formatisi nelle scuole militari della monarchia. Quan-do poi, negli anni Settanta ed Ottanta, fu avviato il meccanismo dellacooptazione a livello regionale, molti nuovi membri della commissio-ne non avevano compiuto un regolare curriculum di studi, ma aveva-no acquisito una esperienza pratica come capi mastri muratori, cheveniva loro riconosciuta attraverso il conferimento del titolo di archi-
119
23 Acta des Studium Nauticum, ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 436,c.123r.v., editto del 9 settembre 1758.
24 Acta des Studium Nauticum, ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 436,c.199r., nota dell'Intendenza del 13 settembre 1760: « EÁ intenzione della Sovrana che isoggetti i quali hanno compito il corso dello studio matematico nautico in Trieste e quel-li particolarmente che vi hanno tratto profitto si impieghino nella navigazione per ag-giungere la pratica alla teoria ».
25 Acta des Studium Nauticum, ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 436,c. 241r., comunicazione al p. Francesco Saverio Orlando, direttore della scuola; sulla suafigura cfr. B. FRANUSICÂ , Francesco Saverio Orlando, fondatore delle prime scuole nautichedell'Adriatico, in GALIMBERTI, MALY, I gesuiti e gli Asburgo, cit., pp. 189-200.
26 Manca la possibilitaÁ , purtroppo, di ricostruire l'origine e la consistenza delle co-siddette « biblioteche d'ufficio », in particolare di quella della Cesarea Regia SupremaIntendenza Commerciale (1748-1776). Pochissimi testi risultano poi confluiti nella bi-blioteca della I. R. Luogotenenza del Litorale, oggi depositata presso l'Archivio di Statodi Trieste. Cfr. ivi K.K. STATTHALTEREI-BIBLIOTHEK, BuÈcher-Katalog; qualche cenno sulle« biblioteche d'ufficio » nell'Ottocento in DORSI, BIANCO, La biblioteca dell' I.R. Tribu-nale d'Appello del Litorale, cit., pp. 147-158.
tetto regio. Era notevole quindi il divario fra questo sistema, che cer-cava comunque di assumere la professionalitaÁ ed il merito quali cri-teri distintivi, e quello posto a base della cooptazione nella carica co-munale di ispettore civico alle fabbriche, divenuta invece di naturaesclusivamente politica e assegnata nell'ambito del Consiglio dei Pa-trizi sovente a soggetti privi di qualsiasi competenza tecnica, che sivedevano percioÁ costretti a ricorrere alla consulenza retribuita degliispettori governativi 27.
La diversa estrazione sociale dei nuovi funzionari di fronte aduna tradizione fortemente municipalistica assume in questo contestogrande rilevanza, soprattutto poiche Trieste vantava un ceto patriziodi antica origine, saldamente insediato nelle magistrature comunali,geloso rivendicatore dei propri privilegi e della propria autonomia,che esprimeva anche nel rifiuto di imparare la lingua tedesca e di ab-bandonare l'uso di un dialetto friulaneggiante che stava comunqueper essere soppiantato dalla parlata veneziana. Questo atteggiamentodi chiusura, proprio nel momento in cui lo Stato assoluto erodeval'autonomia comunale, precludeva di fatto ai rappresentanti della no-biltaÁ locale ± con qualche rara eccezione ± l'accesso alle carriera sta-tale. Gli uffici venivano affidati non a patrizi triestini ma a membridella nobiltaÁ provinciale della contea di Gorizia e Gradisca o dellaCarniola, oppure a esponenti del mondo economico che poi, dopoalcuni anni, venivano nobilitati in riconoscimento dei servizi prestati.
Puntuali riscontri di questa situazione si possono trovare scor-rendo i nomi dei funzionari componenti il personale subalterno del-l'Intendenza negli anni 1750-1780. Il segretariato italiano rimase af-fidato fino al 1776 a Franz Xaver Voxilla de WuÈ stenau, originariodell'Istria austriaca, e il segretariato tedesco a Johann Lukas von Rai-gersfeld, nato a Trieste nel 1735 e formatosi al Collegio Teresiano frail 1746 ed il 1748; a lui subentroÁ Joseph Sigismund Kappus von Pi-chelstein, della nobiltaÁ lubianese, giaÁ Konzepist a Milano. L'incarico
120
27 P. DORSI, Il Litorale nel processo di modernizzazione della monarchia austriaca.Istituzioni ed archivi, Del Bianco, Udine 1994, pp. 99-105; qualche cenno anche in F.CAPUTO, R. MASIERO, Trieste e l'Impero. La formazione di una cittaÁ europea, Marsilio, Ve-nezia 19883, pp. 102-107.
di responsabile del protocollo venne affidato dapprima al ricordatoVoxilla de WuÈ stenau poi, dal 1763, al goriziano Johann NepomukGruÈnfeld e infine a Ignaz Franz Frossard. L'ufficio di « cancellista »(Kanzlist, cioeÁ addetto alla cancelleria), una delle posizioni miglioriper iniziare la carriera in seno all'amministrazione dello Stato 28, furicoperto per molti anni da Franz Karl Cratey, affiancato poi da Do-minik KoÈnigsberger, Joseph Anton Paschka e Francesco Vito deZanchi. Queste stesse persone si alternavano anche negli altri incari-chi: in quello di Registrator ritroviamo dal 1753 Voxilla de WuÈ stenaue poi Frossard, mentre in quello di Expeditor Joseph A. Paschka epoi GruÈ nfeld. Dal 1772 entrambe le cariche vennero riunite e confe-rite ad Augustin Klivisier.
Fra tutto il personale di governo degli anni 1749-1776, rappre-sentato complessivamente da 52 persone, troviamo, a riprova di que-sta situazione, solo cinque patrizi triestini, cioeÁ Antonio Marenzi con-sigliere dell'Intendenza (1749-1753), Francesco Vito de Zanchi (ad-detto alla cancelleria nel 1756-59 e poi Kommerzialkassier 1760-1776), Antonello Felice de Francolsberg (addetto alla cancellerianel 1764), Francesco de Piccardi (praticante di cancelleria e Registra-tor 1766-1767), e infine Giuseppe Maria Schiavuzzi (praticante dicancelleria 1768-1769).
Nella realtaÁ , gli effetti della creazione della scuola professionalevennero raccolti solo in parte e ancora negli anni Ottanta del XVIIIsecolo i meccanismi di reclutamento del personale degli uffici gover-nativi non erano stati uniformati, tanto che molte disposizioni inno-vatrici erano rimaste prive di applicazione. Benche infatti fin daglianni Cinquanta « nozioni legali, pratica forense, elementi di dirittopubblico austriaco, princõÁpi di buon governo, di pubblico ordine,e di tutto cioÁ che puoÁ contribuire alla pubblica felicitaÁ dello Stato »± scriveva verso il 1790 un alto funzionario goriziano ± fossero dive-nuti « le nozioni necessarie per coloro, che aspirare volessero a' pub-blici impieghi », la realtaÁ appariva immutata: «Molte leggi sortironosotto i regni di Maria Teresa e di Giuseppe II, le quali prescrivonocome requisito necessario per qualunque candidato in qualunque
121
28 FABER, Litorale Austriaco, cit., pp. 159-164.
pubblico uffizio, gli attestati dell'esame sostenuto sõÁ nelle disciplinelegali, che nelle scienze del governo. Da cioÁ non dee la posteritaÁ de-durre, che i mentovati editti sieno stati posti in esecuzione » 29. Il ca-so di Antonio de Wassermann, membro della nobiltaÁ provinciale diGorizia e giaÁ studente alla scuola di nautica, puoÁ apparire emblema-tico. Quando nel 1756 presentoÁ istanza di assunzione all'IntendenzaCommerciale, precisoÁ di provenire da famiglia nobile ammessa al pa-triziato della Stiria ma priva di adeguati mezzi economici (tanto cheaveva potuto studiare grazie ad un sussidio), e ammise la propria pre-parazione incompleta, avendo dovuto apprendere gli elementi del di-ritto e della lingua tedesca, prima a lui sconosciuta, da semplice auto-didatta 30. Ciononostante venne assunto come praticante nella can-celleria dell'Intendenza e negli anni successivi continuoÁ la carrieracome uditore al Cesareo Regio Tribunale Mercantile di prima istanza(1758), come attuario dello stesso tribunale dal 1763, come segreta-rio effettivo del governo del Litorale dal 1777 31. Nel 1766 venne an-che ammesso nel Consiglio maggiore dei Patrizi di Trieste.
Se nel primo periodo di funzionamento dell'Intendenza i posti ne-gli uffici vennero coperti prevalentemente mediante il trasferimento difunzionari da altre regioni della monarchia 32, il reclutamento succes-sivamente avviato su base regionale continuoÁ a seguire gli schemi con-solidati nell'Antico Regime, avvenendo cioeÁ per chiamata o per nomi-na e non per concorso. Solitamente la nomina veniva effettuata tra co-loro che avevano presentato semplice domanda di assunzione, inqualche altra occasione l'ufficio veniva offerto a un soggetto qualificato
122
29 C. MORELLI DI SCHOÈ NFELD, Istoria della contea di Gorizia (1790), III, Paternolli,Gorizia 18552, p. 144.
30 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 66, cc. 61r-62v., datato 24 luglio1756.
31 Dal 3.2.1759 aggiunto attuario del tribunale, effettivo dal 15.1.1763; dal 1766responsabile della commissione per le coltivazioni ad Aquileia, dal 30 aprile 1776 segre-tario italiano presso il C.R. Governo del Litorale, dal 26 marzo 1777 segretario effettivocon stipendio di 800 fiorini, elevato a 1000 fiorini con decreto dell'1 marzo 1782. Eranato a Gonars nel 1739 e morõÁ a Trieste nel 1798; cfr. DE JENNER, Biografie triestine,ms. in ADTs, segn. 1/1 B 4, c. 51v.
32 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, buste 66-67, Personale dell'Intendenza,1754-1756.
che giaÁ operava sul territorio, ma era esclusa, ad ogni modo, la venalitaÁdelle cariche 33. La carica di consigliere di commercio venne offerta, adesempio, nel 1750 al livornese Pasquale de Ricci, un non nobile, mem-bro di una famiglia nota in Toscana per le sue attivitaÁ economiche 34.Da quel momento la sua carriera in seno all'amministrazione dello Sta-to proseguõÁ brillantemente fino al pensionamento: divenne presidentedel Tribunale di Cambio mercantile di prima istanza, « provvisore »del Magistrato di SanitaÁ, reggente ad interim del governatorato di Trie-ste prima dell'arrivo del conte Zinzendorf, assessore al Consessus incausis summi principis, e, dopo il 1776, presidente della commissionein publicis et oeconomicis, il ramo dell'amministrazione politica piuÁ im-portante nell'ambito delle competenze del Cesareo Regio Governo.Nel 1766 aveva ottenuto il rango di nobile e nel 1776 il titolo di liberobarone dell'Impero, trasmissibile in linea maschile e femminile; nel1779 venne pure ammesso al patriziato triestino 35.
Tutto cioÁ non significa che nelle assunzioni o negli avanzamentidi carriera mancassero gli elementi e la volontaÁ di provvedere a unavalutazione del merito. Ogni eccezione veniva comunque motivata edocumentata. Nel 1758, cosõÁ, dovendosi cooptare un assessore delTribunale di Cambio mercantile di seconda istanza, l'anziano Danie-le de Francol veniva ritenuto idoneo « sia perche milita a suo vantag-gio la presunzione di sua sufficienza merceÁ la laurea dotorale, di cuiper molti scorsi lustri eÁ insignito, sia per la prattica di questi tribunaliqual'avocato giurato », anche se « remoto eÁ il tempo delli studi anti-
123
33 Per un confronto G.P. BRIZZI, Aux origines du systeÁme de meÂrite. Formation, re-crutement et seÂlection des officiers de chancellerie de quelques grandes magistratures publi-ques italiennes XVIIe-XVIIIe sieÁcle, in D. JULIA (a cura di), Aux sources de la compeÂtenceprofessionnelle. CriteÁres scolaires et classements sociaux dans les carrieÁres intellectuelles enEurope XVIIe-XIXe sieÁcle, numero speciale di « Paedagogica Historica », 30 (1994), pp.249-265.
34 Un tentativo di profilo di Ricci si deve a BIAGI, Giuseppe Pasquale Ricci, cit., oveperoÁ si confonde la figura di Giuseppe Pasquale Ricci, vicario civile originario di Grot-tammare (Stato Pontificio) con quella di Pasquale Ricci da Livorno; cfr. TUCCI, Una de-scrizione di Trieste, cit., p. 100.
35 Quanto alla remunerazione, sappiamo che nel 1764 percepiva uno stipendio di1500 fiorini annui, rispetto ai 5000 che riceveva l'Intendente conte von Auersperg e i300 che riceveva un attuario; ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 67, Verzeich-nis samtlicher Besoldung in Litorali Austriaco (1764), cc. 40r-41v.
chi del Francoll medemo, che sessagenario resta dispensato dallaprodotta, ne si puoÁ demandargl'hoggi l'attestato o sia calculum emi-nentiae o sia la nota di prima classis, come prescritto viene con gra-ziosissima Risoluzione di Corte delli 6 luglio corrente » 36. Per la no-mina di un nuovo cancelliere di sanitaÁ , nel 1759, vennero individuatiben quattro possibili candidati e il vincitore fu preferito perche alservizio dello Stato ± seppure gratuitamente ± da un maggiore nume-ro di anni e perche noto per il suo zelo e per le sue capacitaÁ 37.
La documentazione archivistica rivela comunque il tentativocontinuo da parte degli organi di governo di istituire nelle assunzionimeccanismi di controllo piuÁ efficaci, che, se anche non assumevanoancora la forma del pubblico concorso, prevedevano almeno una ra-tifica sovrana dell'operato delle commissioni giudicatrici, avente ca-rattere ricognitivo della legalitaÁ del procedimento e della assenza diarbitrõÃ. Nel caso del diciottenne Leopoldo Civrani, per esempio, l'i-stanza di assunzione come praticante di cancelleria era stata da luipresentata all'Intendenza unitamente ad una lettera del padre, alla fi-ne del gennaio 1773 38 e, quando venne assunto, bisognoÁ attenderefino al 18 marzo l'approvazione sovrana perche , rammentava il con-sigliere dell'Intendenza barone von Schell, vigeva la regola che « keinPraktikanten bey dem Kanzleyen ohne allergnaÈdigste Bewilligungaufgenommen werden solle » 39.
La preoccupazione di introdurre forme di controllo piuÁ efficaci e direprimere possibili abusi eÁ rivelata anche dalle prime, embrionali formedi concorso interno per la promozione a mansioni superiori, comequelli di segretario e di addetto al protocollo. Un caso esemplificativorisale al 1773 in relazione alle cariche di Konzepist und Cassa-Contro-
124
36 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 177, c. 72r. lettera del GiudizioCambio Mercantile di seconda istanza del 21.7.1758.
37 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 177, cc. 143r-144v, relazione di Pa-squale de Ricci sui quattro candidati, tra cui il designato Andrea Giuseppe de Bonomo,dal 1757 addetto al reclutamento militare della cittaÁ , nonche assessore al Tribunale mer-cantile di prima istanza. Il de Bonomo venne poi nominato Cancelliere di sanitaÁ con re-scritto del 6 agosto 1759.
38 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, c. 62rv.39 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, cc. 64rv., 70rv.
leur, rese vacanti per la promozione del titolare dell'ufficio a consiglierepresso la Commercial-Hof-Buchhaltery. Quasi subito, con risoluzionedatata Vienna 2 agosto, veniva resa pubblica la disponibilitaÁ dell'ufficioe venivano invitati tre funzionari subalterni (Joseph Poschl,Wenzel vonScio e Pietro de Modesti) a presentare domanda di partecipazione alconcorso 40. Successivamente, il 21 agosto, l'invito veniva esteso al pra-ticante dell'Intendenza Carl Joseph von Schimmelpfenning 41. Formatala commissione giudicatrice, presieduta dal consigliere barone vonSchell, nella seduta del 25 agosto 1773 vennero presi in esame i titolidei quattro candidati e cioeÁ gli studi compiuti, il servizio pregresso inseno all'amministrazione statale e le attestazioni di capacitaÁ professio-nale prodotte. Nella stessa seduta vennero esaminati i titoli presentatiper il posto di Cassa-Controllor Stelle cui concorrevano l'Expeditor Au-gustin Klivisier, i cancellieri Venino, Cratey e il GuterbestaÈtter (ammi-nistratore di beni camerali) Corradini 42. Le nomine dei vincitori (ri-spettivamente Schimmelpfenning e Venino) vennero poi perfezionatecon Risoluzione datata Vienna 27 settembre 1773 43.
Nello stesso tempo, venivano introdotte forme di controllo an-che sul rendimento e sulla responsabilitaÁ dei funzionari giaÁ assunti:le eventuali sanzioni andavano dal semplice richiamo o ammonizione,alla sospensione dallo stipendio o dallo stipendio e dall'ufficio, casoche si verificoÁ nei confronti di Valentino de Modesti, divenuto con-sigliere dell'Intendenza, nell'aprile 1774, resosi responsabile di gravifatti di rilievo penale e la cui responsabilitaÁ venne riconosciuta in esi-to a un vero e proprio procedimento disciplinare 44.
125
40 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, Copia Resolutionis dd. Wienden 2ten Augusti 1773, c. 116r.
41 AST, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, c. 120r., comunicazione delconsigliere Schell.
42 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, Votum in betrefft der zu ersezun-den Concepiste und Cassa Controllors Stelle, cc. 130r-133v., si tratta del verbale dellacommissione firmato Schell, altra copia cc. 152r-154v.
43 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, Copia Resolutionis datata Wienden 27 7ber praes. den 11ten 8ber 773, c. 144r. e 138rv.
44 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, c. 244r., comunicazione datataVienna 5 aprile 1774, firmata Leopold von Kollowrat; scrittura difensiva di Modesti da-tata 31 maggio 1774 c. 261r.
Le possibilitaÁ di carriera in seno all'amministrazione dello Statoerano comunque condizionate dal possesso del requisito della cono-scenza della lingua tedesca, richiesto ai funzionari provenienti daogni ordine sociale. Nel 1773 un commerciante di origine greca,Agostino Nicolantini, presentando istanza di assunzione, si preoccu-poÁ di vantare la propria « abilitaÁ nel commercio, il fondamento del-l'aritmetica, ed il possesso della lingua tedesca, italiana, latina, ed an-co della francese mediocremente » 45. Analogamente, GiannantonioTognana de Tonnefeld, giaÁ ufficiale nel reggimento Gaisrugg, sotto-lineava in quegli stessi anni la propria perfetta conoscenza delle lin-gue italiana e tedesca 46. Tutta la corrispondenza con gli organi di go-verno centrali si svolgeva infatti in tedesco e proprio per questo mo-tivo era stato creato presso l'Intendenza, sin dalla sua istituzione, unsegretariato per la corrispondenza italiana, incaricato delle traduzioninei rapporti con i cittadini. Fu proprio l'ignoranza della lingua tede-sca a limitare, almeno fino agli anni Settanta del Settecento, le possi-bilitaÁ per i funzionari di madrelingua italiana di proseguire la carrierain altre regioni della monarchia. Il barone Antonio Marenzi, consi-gliere dell'Intendenza, venne messo a riposo nel 1754 proprio percheÂnon conosceva il tedesco; il barone Pasquale de Ricci, per lo stessomotivo, non pote ottenere la carica di governatore che nel 1776 avevaretto soltanto ad interim. Solo il barone Pompeo de Brigido (1729-1811), formatosi a Vienna nel collegio Teresiano, pote divenire primacapitano circolare della Carniola inferiore, poi commissario per la re-golazione dei confini del Litorale, consigliere di governo della Gali-zia, dal 1770 presidente del Banato di Temesvar e dal 1778 al 1782governatore a Lemberg. Fu Brigido a sostituire dal 1782 il conte Zin-zendorf come governatore del Litorale, carica che mantenne per bentrent'anni unendo ad essa il titolo di consigliere intimo di Stato 47.
Con l'organizzazione degli uffici dell'Intendenza si pensoÁ anche aregolare le retribuzioni secondo criteri di uniformitaÁ e di equitaÁ . Alla
126
45 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, c. 112r.v. istanza presentata il20 luglio 1773.
46 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 80, c. 11r.v.47 « L'Osservatore Triestino », 68, Trieste 24.8.1811; DE JENNER, Genealogie triesti-
ne, ms. cit. in ADTs, segn. 1/1/ B 3, carte non numerate.
metaÁ degli anni Cinquanta, essendo i ranghi del personale ancora ri-dotti, accadeva di frequente che molti funzionari cumulassero piuÁfunzioni e piuÁ stipendi. Il cancelliere di sanitaÁ Ignazio Andrea de Bo-nomo, deceduto nel 1759, aveva svolto ad esempio anche le funzionidi attuario del Tribunale Mercantile di prima istanza e di Cancellierecesareo regio de' Consigli, percependo una retribuzione complessivaannua di 700 fiorini, ma con l'onere di dover pagare personalmenteun segretario che gli costava 120 fiorini all'anno 48.
A parte queste situazioni, gli stipendi erano sempre proporzio-nati all'importanza dell'incarico e alle responsabilitaÁ connesse. Ne-gli incarichi superiori le retribuzioni erano alquanto elevate. Nel1763 i consiglieri dell'Intendenza percepivano una retribuzione di1.500 fiorini annui 49. L'anno successivo la situazione appariva inva-riata. Da una tabella del 1764 risulta che era stato adottato un siste-ma di retribuzione simile per tutti coloro che occupavano lo stessolivello in seno all'amministrazione. L'intendente conte Auerspergguadagnava ben 5.000 fiorini, mentre i consiglieri dell'Intendenzaricevevano fra i 1.200 e i 1.500 fiorini annui. A queste retribuzionisi aggiungevano altre somme a titolo di indennitaÁ per incarichi svol-ti anche occasionalmente, come nel caso del Ricci, gratificato conRisoluzione del febbraio 1757 di 200 fiorini « a titolo d'aggiunta »in considerazione del buon servizio prestato ricoprendo anche l'in-carico di Provisore effettivo alla sanitaÁ 50. Si trattava di emolumenticonsiderevoli, visto che nello stesso periodo un giudice regio perce-piva solo 500 fiorini annui 51, e di molto inferiori alle retribuzioni
127
48 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 177, cc. 143r.-144v. L'occasionedella nomina di un nuovo Cancelliere consentõÁ la creazione di una carica ufficiale di vi-cecancelliere o segretario con 170 fiorini annui, mentre la retribuzione del Cancellierevenne fissata in 320 fiorini annui.
49 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 610, Specification in der Besoldung,1763, c. 200r.
50 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 66, c.96r., comunicazione al Magi-strato di SanitaÁ datata 18 marzo 1757 in cui si rende noto il contenuto della Risoluzionesovrana del 25 febbraio 1757.
51 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 698, c. 10r., lettera del 15 marzo1756 il Vicario e Giudice dei Malefici Marco Mattei chiede lo stesso salario godutodal suo predecessore.
stabilite in quello stesso periodo per i funzionari della Cancelleriaaulica, dove un consigliere riceveva annualmente 5.000 fiorini eun Konzepist circa 500 fiorini 52. Nel Litorale le spese straordinarieincontrate nell'assolvimento della carica venivano normalmenterimborsate dall'Intendenza e potevano essere anticipate solo suistanza dell'interessato 53.
I funzionari subalterni, anche se investiti di responsabilitaÁ , rice-vevano stipendi piuÁ bassi, pari o inferiori ai 500 fiorini annui: l'addet-to al protocollo Voxilla, assunto nel 1753, aveva uno stipendio di 500fiorini, rimasto invariato almeno fino al 1767 54, che peroÁ era comun-que superiore a quella del suo collega barone Pietro Antonio Pittoni,appena giunto a Trieste da Segna (Zengg) ove era stato assessore dipolizia, che pote ottenere un aumento soltanto con la nomina ad as-sessore della Commissione di polizia e per le manifatture, a mezzo dirisoluzione sovrana del 27 gennaio 1766 che portoÁ lo stipendio da300 a 600 fiorini annui 55. Da una tabella delle retribuzioni del1765 risulta che i segretari dell'Intendenza guadagnavano invecefra i 400 e i 500 fiorini annui, mentre il personale della cancelleriafra i 300 ed i 400, a seconda dell'anzianitaÁ di servizio 56. Si trattadi stipendi rimasti sostanzialmente invariati fino alla creazione delCesareo Regio Governo del Litorale nel 1776 57.
128
52 HEINDL, Gehorsame Rebellen, cit., p. 161.53 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 67, c. 91r. Pasquale Ricci all'Inten-
denza Commerciale chiese il 3 gennaio 1766 un anticipo sulle spese di viaggio per recarsia Londra in « disimpegno della commissione conferitami daÁ Sovrani rescritti »; gli ven-nero assegnati 375 fiorini il giorno successivo.
54 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 66, cc. 2r-3v, Risoluzione del 17febbraio 1753; c. 177r. Status salariorum des Canzley Personalis bey der Intendenza zuTriest, 1767.
55 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 67, Verzeichniss samtlicher Besol-dung in Litorali Austriaco, 1764, cc. 40r-41v. e c. 96r., comunicazione a Pittoni dell'In-tendenza datata 1 febbraio 1766.
56 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 67, Verzeichnis Samstlicher Besol-dung 1765, c. 40r. Il cancelliere Antonello Felice de Francolsperg, neoassunto e giaÁ al-lievo della scuola nautica, aveva uno stipendio di 300 fiorini, mentre il cancelliere FranzCarl Cratey, con una anzianitaÁ di servizio di dieci anni, riceveva 400 fiorini annui.
57 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta 67, Status salariorum des CanzleyPersonalis bey der Intendenza zu Triest, wie solcher aÁ 1a Aprilis dieses Jahres 1767 anzu-fangen haÈtte, c. 177r.
Ad ogni avanzamento di carriera corrispondeva comunque unaumento della retribuzione, anche se non basata su criteri di automa-ticitaÁ . Antonio Wassermann, per fare un altro esempio, entrato negliuffici governativi alla metaÁ degli anni Cinquanta, percepiva nel 1764come attuario effettivo una retribuzione annua di 300 fiorini; nel1777, come effettivo segretario di governo riceveva annualmente800 fiorini, elevati a 1.000 con decreto del marzo 1782 58.
Le pensioni venivano calcolate senza un sistema fisso ma, in ge-nere, erano determinate in ragione di un terzo circa rispetto all'ulti-ma retribuzione goduta dall'interessato, come quando nel gennaio1776 venne collocato a riposo il Mittels-SekraÈter Kappus von Pichel-stein, la cui pensione venne calcolata in base all'ultimo stipendio cheera stato di 1.000 fiorini, e venne quantificata in 300 fiorini annui 59.
Fu sostanzialmente questa la situazione incontrata dal conte Zin-zendorf quando giunse a Trieste nel 1776, come governatore del Li-torale, per rimanervi fino al 1782. Il suo diario giornaliero fornisceindicazioni preziose sui suoi rapporti con molti dei personaggi primaricordati e, in generale, sul suo atteggiamento nei confronti del grup-po di persone con cui si trovoÁ a dover lavorare 60. I suoi sforzi furonocostantemente indirizzati nella valorizzazione di quei funzionari che,pur assunti per nomina, avevano proseguito la carriera eclusivamentein base a professionalitaÁ e a merito. CioÁ vale nel caso di Wassermann,le cui opinioni Zinzendorf tenne sempre in alta considerazione e peril quale si impegnoÁ in prima persona al fine di ottenere riconoscimen-to dei suoi meriti professionali 61. I rapporti con Ricci invece, nono-stante la riconosciuta capacitaÁ del funzionario, furono piuttosto fred-
129
58 DE JENNER, Biografie triestine, ms. cit. in ADTs, segn. 1/1 B 4, c. 51v.59 ASTs, C.R.S. Intendenza Commerciale, busta, c. 433r.v, nota del barone Schell
datata Trieste 20 gennaio 1776.60 Cfr. anche E. FABER, Auf dem Weg zur Adria. Reiseberichte uÈber InneroÈsterreich
aus den Jahren 1780-1810, in H. EBNER, P.W. ROTH, I. WIESFLECKER-FRIEDHUBER (a curadi), Forschungen zur Geschichte des Alpen-Adria-Raumes. Festgabe fuÈr em.o.Univ.-Prof.Dr. Othmar Pickl zum 70. Geburtstag, Leykam, Graz 1997, pp. 119-142.
61 Cfr. per esempio HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher,sub 18.3.1780, c. 48r.: «Wasserman dõÃna ici, il croit que les marchandises expedieÂespar l'echelle de Trieste il y sont encheris d'environ 9% de frais et provinces diffeÂrentes,ce qui feroit un beÂneÂfice annuel de plus d'un million pour le port ». Sub 14.8.1780, c.
di e cioÁ soprattutto a causa del rancore provato dal livornese, cheaveva retto ad interim il governatorato di Trieste prima dell'arrivodi Zinzendorf aspettandosi di ottenere la nomina a governatore. PeroÁla conoscenza solo passiva e non attiva della lingua tedesca e la suaappartenenza alla nobiltaÁ di toga e non a quella di spada gli avevanoprecluso il proseguimento della carriera 62. Quanto infine ai rapportidi Zinzendorf con Brigido, essi furono di natura quasi esclusivamen-te istituzionale ed anche l'avvicendamento nel governatorato del Li-torale nel 1782 si risolse in uno scambio di corrispondenze, visto cheZinzendorf era giaÁ tornato a Vienna per divenire presidente della Ca-mera aulica dei Conti (Hof-Rechen-Kammer). Le poche annotazionidel diario al riguardo denotano, tuttavia, un atteggiamento criticonei confronti del personaggio e l'identificazione in Brigido di un rap-presentante tipico del vecchio ordine aristocratico, la cui carriera erafondata sui privilegi e non sui meriti professionali 63.
Zinzendorf fu peroÁ estremamente sensibile al problema della for-mazione professionale. Durante gli anni del suo governo nel Litoralefu assiduamente impegnato nella organizzazione e nella cura delleistituzioni scolastiche locali, e regolarmente si recava nelle scuole cit-tadine per assistere alle lezioni e agli esami di profitto degli studenti.Ancora in tarda etaÁ ± come abbiamo visto ± mantenne memoria dellascuola nautica di Trieste e nel suo testamento, steso nel 1807, destinoÁun capitale di quasi diecimila fiorini alla costituzione di un fondo disussidi annuali il cui beneficiario avrebbe dovuto essere ogni anno« ein SchuÈ ler der Nautic- oder Schiffarts und Schiffbaukunde » 64.
130
155r.: « Je fus chez le Chancelier Cte Auersperg [...]. Il traitoit Pittoni de feu, mais pourWassermann et Grenek il me donna lieu d'esperer ».
62 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, sub 10.7.1779, c.146v.: « Ricci me donna un meÂmoire, ouÁ il pretend eÃtre deÂdommage de l'arrha qu'onlui demande actuellement ». Sub 2.9.1779, c. 204v.: « Je recËus un paquet de Trieste rem-pli de difficulteÂs de Ricci au sujet de la prise francËoise ». Sub 6.12.1780, c. 222v.: « SanMartino vint me parler de la caisse et de son administrateur des fonds de la catheÁdrale,ouÁ Ricci a fait des irregulariteÂs ».
63 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, sub 24.10.1779, c.237v.: « Pompeo Brigido est un pauvre homme qui ne sait pas eÂcrire, le freÁre a beaucoupplus de talent ».
64 Par. 7 del testamento datato 22 febbraio 1807, con codicillo del 5 marzo e del 30
La Fondazione Zinzendorf, destinata ad aiutare studenti di « eviden-te profitto ed integritaÁ di costumi », di « qualunque ceto, stato e re-ligione », rimase in vita fino al primo conflitto mondiale e, grazie al-l'aumento del capitale, riuscõÁ a erogare nei primi anni del Novecentoanche piuÁ di quattro borse di studio 65.
Da quanto esposto e dall'esame delle riforme introdotte nei mec-canismi di reclutamento e di selezione degli impiegati nel LitoraleAustriaco, si evince che l'etaÁ teresiana rappresentoÁ sostanzialmenteun periodo di transizione, in cui ancora faticava ad emergere la nuo-va figura del funzionario moderno. Tuttavia i problemi affrontati espesso positivamente risolti nella fase piuÁ intensa delle riforme mo-strano che all'esigenza della professionalizzazione cominciava a corri-spondere anche la necessitaÁ di individuare in modo piuÁ preciso i trat-ti caratteristici della nuova professione. Viene da interrogarsi, quindi,sul grado di consapevolezza maturato da questi uomini e sull'imma-gine che vollero dare di se . Sul finire del XVIII secolo, ormai, nume-rosi addetti ai pubblici uffici, anche con incarichi di alta responsabi-litaÁ , vivevano la condizione di funzionari in uno stato di disagio, ecercavano di accreditare invece verso l'esterno una immagine di eco-nomista, di letterato, di uomo di scienza.
Almeno fino agli anni Settanta del Settecento i funzionari dell'In-tendenza sembravano avere ancora scarsa consapevolezza del pro-prio ruolo; molti aspiravano al conferimento di un titolo nobiliare,mezzo tipico di elevazione sociale nell'Antico Regime, come nel casodi Pasquale de Ricci, la cui nobilitazione venne rappresentata versol'esterno attraverso il possesso di vasti terreni, non nel circondario,ove erano le campagne del vecchio patriziato, ma al limitare della cit-taÁ , vicino al cuore dell'emporio. Altri funzionari cercavano di trovareuno spazio nella repubblica delle lettere: il barone Pittoni, direttoredi polizia, si vantava dell'amicizia di Casanova che nella Histoire dema vie lo avrebbe ricordato come « spirito adorno di cultura lettera-
131
ottobre 1812, riprodotto in apertura dell'atto costitutivo della « Fondazione Zinzendorfper stipendi scolastici », in ASCTs, Atti di fondazione, n. 21.
65 Cfr. i par. 6 e 7 dell'atto di fondazione del 1 febbraio 1820; l'ultima modificaall'atto di fondazione risale al 17 agosto 1914.
ria » 66. Andrea Giuseppe de Bonomo, cancelliere di sanitaÁ , tentavadi affermare un proprio ruolo di erudito corrispondente di Gianri-naldo Carli e collaboratore delle AntichitaÁ italiche 67. Gli esempi po-trebbero continuare, senza peroÁ offrire sostanziali variazioni. Lamancanza di un'identitaÁ definita trova conferma anche nell'indeter-minatezza del lessico burocratico 68, e nello scarso rilievo di partico-lari forme di socializzazione, come il cosiddetto casino di San Pietroo dei Nobili, fondato nel 1763, che riuniva probabilmente soprattut-to la nobiltaÁ di spada, ma sul quale mancano del tutto ricerche spe-cifiche 69. Neppure l'acquisto o l'affitto di palchi al teatro sembravarispondere ad una strategia di tipo cetuale, e rappresentava semplice-mente l'ostentazione di un raggiunto stato di benessere economico.
Qualche segnale diverso tuttavia non manca e merita ulterioriconsiderazioni. CosõÁ, ad esempio, eÁ significativo che nuovi funzionaricominciassero ad avviare anche i propri figli alla carriera amministra-tiva, cercando di assicurare per loro quella preparazione professiona-le di cui avvertivano la mancanza. Joseph Anton Voxilla de WuÈ ste-nau, segretario per la corrispondenza italiana dell'Intendenza, man-dava nel 1760 il figlio Francesco Saverio a studiare nella scuolanautica 70. Anche Franz Karl Cratey, responsabile della cancelleriadal 1753 al 1776, avvioÁ il figlio Antonio, nato nel 1760, alla carrieradel funzionario, facendolo laureare in legge e consentendogli cosõÁ didivenire segretario dell'imperial regio Giudizio Civico Provinciale 71.
132
66 CASANOVA, Storia della mia vita, cit., p. 962; per il carteggio Pittoni-Zinzendorfcfr. TAMARO, Fine del Settecento a Trieste, cit., pp. 7-426, nonche TRAMPUS, All'orizzontedegli slavi del sud, cit., pp. 45-52.
67 Cfr. infra, cap. VII.68 Cfr. E. GRANZER, Die oÈsterreichische Kanzleisprache. Verdeutschung der wichtig-
sten fremdsprachigen KanzleiausdruÈcke im Verwaltungsdienste und Gerichtswesen,OÈ sterr. Druck- und Verlagsgesellschaft, Wien 19172.
69 Mancano studi recenti sulla composizione sociale nel Settecento del casino diSan Pietro o dei Nobili, per cui bisogna ancora fare riferimento ai vecchi testi di KAN-
DLER, In memoria del primo secolo cit., e E. CASATI, Il casino vecchio di Trieste, Tip. delLloyd austriaco, Trieste 1872, che tuttavia offrono assai scarse notizie. Per il periodosuccessivo cfr. invece CATTARUZZA, Tra logica cetuale e societaÁborghese, cit., pp. 419-450.
70 Cfr. L'Istituto tecnico-nautico, cit., p. 167.71 DE JENNER, Biografie triestine, II, ms. cit. in ADTs, sgn. 1/1 B 4, carte non nu-
merate.
Questi stessi funzionari, negli anni Ottanta del XVIII secolo, comin-ciavano cosõÁ a riconoscersi poi in un milieu culturale nuovo, contrad-distinto da un ethos particolare (Beamtenethos) 72, che esprimeva unsenso di appartenenza allo Stato notevolmente diverso dal cosmopo-litismo che animava gli affari dell'emporio 73 e che trovava corrispon-denza nella variante « burocratica » del patriottismo (buÈrokratischerPatriotismus), teorizzata da intellettuali come Joseph von Sonnenfelsnel suo UÈber die Liebe des Vaterlandes.
Apparentemente di tutto cioÁ rimanevano poche tracce a livellosociale, mancando una trattatistica originale e forme di autorappre-sentazione attraverso specifici organismi di tipo culturale o di tipocetuale, di cui invece potevano servirsi i commercianti attraverso laDeputazione di Borsa. Ma le sorprese non mancano. Nel 1793 venivafondata a Trieste la prima biblioteca pubblica, costituita attraversoun fondo librario donato alla cittaÁ dall'Accademia arcadica. Con l'i-stituzione della biblioteca si allestiva anche una galleria di sei ritrattidi « fondatori », costituita da una serie di dipinti ad olio raffigurantialcuni personaggi giaÁ membri dell'Accademia; in realtaÁ , la scelta deisoggetti ritratti non era affatto casuale, ne rappresentativa della com-posizione sociale dell'Accademia o del numero degli effettivi fonda-tori della biblioteca, ben piuÁ numerosi. Mancava fra i ritratti persinoquello di Giuseppe de Coletti, il responsabile della biblioteca, veroanimatore dell'ambiente culturale, fondatore dell'Arcadia gorizianae di quella triestina, responsabile del giornale « L'Osservatore Trie-stino ». In realtaÁ , attraverso un attento gioco di inclusioni ed esclusio-ni operato su una preesistente serie di dipinti 74, la galleria trasmette-va alla societaÁ triestina un preciso messaggio politico e culturale. I
133
72 H. KLUETING, « BuÈrokratischer Patriotismus ». Aspekte des Patriotentums im the-resianisch-josephinischen OÈsterreich, « AufklaÈrung », 4 (1991), pp. 37-52.
73 Vi sono profonde differenze, e non solo sotto il profilo ideologico, fra i caratteridel cosmopolitismo nel Litorale, tipico della societaÁ triestina, e le prospettive etiche epolitiche delle idee cosmopolite nell'Europa settecentesca; per un piuÁ approfondito esa-me cfr. A. TRAMPUS, Dal cosmopolitismo europeo al cosmopolitismo triestino: convergenzeo divergenze? in CAVALLINI (a cura di), Itinerari del classicismo musicale, cit., pp. 81-93.
74 D. DONZELLI, Un po' di luce attorno a questo mistero, in I ritratti dei fondatoridella Biblioteca Civica di Trieste, Lint, Trieste 1994, pp. 7-22.
personaggi raffigurati ± benche membri dell'accademia ± rappresen-tavano la piramide sociale del potere politico, alternativa a quelloeconomico dominante nell'emporio: l'imperatore Francesco II, l'arci-vescovo Sigmund von Hohenwart, il governatore di Trieste Pompeode Brigido, il capitano provinciale di Gorizia Raimondo della Torre,il consigliere giudiziale Ferdinando dell'Argento e l'attuario di borsaGiacomo de Gabbiati 75.
Uscendo dall'ombra in cui era stato confinato, il funzionario delLitorale cominciava lentamente a cercare una sua collocazione socia-le, per affermare una propria identitaÁ in quella Trieste che « andoÁ dase formandosi in mezzo alle piuÁ aperte contraddizioni » 76.
134
75 A. TRAMPUS, Die GruÈndung einer neuen Stadt. Aufbruchstimmung im Triest des18. Jahrhunderts, «Das achtzehnte Jahrhundert und OÈ sterreich », 9 (1994), pp. 47-54.
76 A. DE GIULIANI, Riflessioni politiche sopra il prospetto attuale della cittaÁ di Trieste,Fratelli Gay, Vienna 1785, pp. 9-10.
V. - KARL VON ZINZENDORF TRA MARIA TERESA EGIUSEPPE II
Pietro Leopoldo, noto per i giudizi severi sui propri interlocuto-ri, ancora granduca di Toscana ne lascioÁ due su Karl von Zinzen-dorf 1. Il primo nel 1779, quando Zinzendorf era governatore del Li-torale: « ottimo soggetto, capace, abile, pieno di talento e cognizioni,di ottime massime di finanze, gran lavoratore sommamente attivo ecapace ». Poi nel 1784, quando era divenuto a Vienna presidente del-la Camera Aulica dei Conti, accennoÁ al carattere del personaggio:« uomo di talento ed abilitaÁ , grandissima abilitaÁ , gran faticante, eche ha moltissime vedute in materia di finanze; ma siccome il mede-simo eÁ molto fermo nei suoi sentimenti, e non cambia parere, cosõÁ
passa per testardo, ha poco credito, ed eÁ moltissimo mal vedutodal pubblico; e siccome tutti gli altri impiegati non lo amano, percheÂne sa piuÁ di loro e perche eÁ un nemico di tutte le privative e prepo-tenze dei padroni contro i contadini ecc., cosõÁ lo hanno fatto credereautore di tutte le operazioni odiose [...] contro le quali aveva sempreprotestato ». CosõÁ scriveva il futuro sovrano Leopoldo II.
Nipote di Nikolaus, fondatore-ordinario della comunitaÁ evange-
135
1 A. WANDRUSZKA, Pietro Leopoldo e le sue riforme in Toscana (dal diario inedito delconte Carlo Zinzendorf), « Archivio storico italiano », CXVII, 1 (1960), pp. 286-287, cheriporta i giudizi di Pietro Leopoldo in traduzione italiana. I documenti originali si tro-vano in HHStA, Familienarchiv, SammelbaÈnde 15-16.
lica dei Fratelli Moravi 2, Karl von Zinzendorf aveva compiuto la pro-pria formazione giuridica all'universitaÁ di Jena, facendo seguire adun'istruzione scolastica dominata dagli influssi del pietismo una solidapreparazione scientifica 3. Particolarmente interessato alle materiestorico-giuridiche e alla scienza politico-cameralista, era stato educatoalla scienza dello Stato dal magistero di JoachimGeorg Darjes, docen-te di diritto naturale, il fondatore della scuola cameralistica a Jena egiaÁ allievo di Wolff 4. Poi, negli anni successivi, l'incarico di consiglie-re commerciale a Vienna fu per lui occasione di numerosi viaggi di la-voro attraverso l'Europa, che gli diedero modo di approfondire la co-noscenza delle scienze economiche e politiche con lo studio dei fisio-crati francesi e inglesi 5. La sua preparazione completa e solida si
136
2 Su Nicolaus Ludwig von Zinzendorf si veda la scheda biografica di P. ALVERDES,Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, in Neue Deutsche Biographie, II, PropylaÈen-Ver-lag, Berlin 1956, pp. 80-91; M. GIERL, Pietismus und AufklaÈrung. Theologische Polemikund Kommunikationsreform der Wissenschaft am Ende des 17. Jahrhunderts, Vanden-hoeck und Ruprecht, GoÈ ttingen 1997. Per la letteratura piuÁ recente M. MEYER, Realisie-rung statt Annihilierung des Protestantismus. Eine transatlantische Zusammenarbeit vonLudwig Feuerbach und Friedrich Kapp uÈber die Herrnhuter, in D. MEYER (a cura di), Pie-tismus, Herrnhutertum, Erweckungsbewegung, Festschrift fuÈr Erich Beyreuther, Rhein-land-Verlag, KoÈ ln 1982, pp. 362-411; ID., Dietrich Bonhoeffers Impulse durch Zinzendorfund die BruÈdergemeine, in R. MOHR (a cura di), 'Alles ist euer, ihr aber seid Christi'.Festschrift fuÈr Dietrich Meyer, Rheinland-Verlag, KoÈ ln 2000, 919-957; E. BEYREUTHER,Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Brunnen-Verlag, Giessen 2000; M. BRECHT, P. PEUC-
KER, Neue Aspekte der Zinzendorf Forschung. Vandenhoeck und Ruprecht, GoÈ ttingen2005; M. CASSESE, Herkunft der Herzensreligion von N.L. von Zinzendorf, « Interdiszipli-naÈre Pietismusforschungen », 1 (2005), pp. 187-199.
3 Per la biografia E. G. VON PETTENEGG, Ludwig und Karl Grafen und Herren vonZinzendorf. Ihre Selbstbiographien, BraumuÈ ller, Wien 1879, pp. 165-272; sulla formazio-ne giovanile ora anche H. BEGUSCH, Ein Protestant unter Protestanten in Wien. Studienzum Tagebuch von Karl von Zinzendorf und Edition des Textes, 1.1.1762-31.3.1762, Di-plomarbeit Geistenwissenschaftliche FakultaÈt, Karl-Franzens-UniversitaÈt Graz, Graz2000.
4 Sull'insegnamento di Darjes e sulla rilevanza della sua opera per la cameralisticatedesca cfr. M. STOLLEIS, Geschichte des oÈffentlichen Rechts in Deutschland, I, Reichspu-blizistik und Policeywissenschaft 1600-1800, Beck, MuÈnchen 1988, pp. 376, 378, 380.
5 Assai vasta eÁ la bibliografia sui viaggi commerciali (Kommerzialreisen) del conteZinzendorf; fra gli studi piuÁ recenti cfr. G. WALTER KLINGENSTEIN, Spanien im Horizontder oÈsterreichischen AufklaÈrung. Zinzendorfs Kommerzialreise nach Spanien im Jahre1767, in Geschichtsforschung in Graz, Institut fuÈ r Geschichte an der Karl-Franzens-Uni-versitaÈt Graz, Graz 1990, pp. 115-126.
riveloÁ poi determinante per una brillante carriera al servizio dello Sta-to e dei sovrani Maria Teresa, Giuseppe II, Leopoldo II e Francesco I.
Il diario inedito di Zinzendorf, che da oltre un secolo conduce aVienna gli storici della cultura europea del Settecento ma che attendeancora indagini complete e sistematiche 6, rappresenta in questa pro-spettiva il filo conduttore per lo studio del riformismo illuminato in Au-stria e nei domini italiani di casa d'Asburgo 7. Per quanto riguarda lastoria della cultura nel Litorale Austriaco e nell'Istria rappresentauna fonte di straordinaria ricchezza, che documenta letture e circolazio-ne di libri, avvenimenti teatrali e musicali, dibattiti economici e politici,rapporti con intellettuali italiani ed europei. Si tratta di cinquantasei vo-lumi manoscritti, stesi tra il 1752 ed il 1813, per una piccola parte inlingua tedesca e per la maggior parte in lingua francese. Esso costituiscepertanto una fonte di primaria importanza per la storia della cultura eu-ropea e le annotazioni relative all'epoca del governatorato nel Litorale(1776-1782) forniscono anche un interessante contributo per studiarela personalitaÁ e la cultura di uno fra i piuÁ alti funzionari della monarchianella transizione dal regno di Maria Teresa a quello di Giuseppe II.
Le tappe fondamentali della carriera di Zinzendorf sono oltre-modo significative: consigliere del Consesso commerciale dell'Au-stria Interiore dal 1762, consigliere aulico nel 1770, presidente delConsiglio aulico di commercio nel 1776, governatore nel Litorale Au-striaco dal 1776 al 1782, presidente della Camera Aulica dei Conti
137
6 Il progetto di edizione critica dei diari del conte Zinzendorf, che comprende quel-li relativi agli anni del suo governatorato a Trieste (1776-1782), eÁ stato avviato nel 1990per cura della Kommission fuÈ r Neuere Geschichte OÈ sterreichs e del BundesministeriumfuÈ r Wissenschaft und Forderung, sotto la direzione di Grete Klingenstein, ed eÁ giuntoora nella sua fase conclusiva. Il primo volume eÁ giaÁ stato pubblicato per cura di M.BREUNLICH, M. MADER, Karl Graf von Zinzendorf. Aus den JungendtagebuÈchern1747,1752-1763, Wien-KoÈ ln-Weimar, BoÈhlau, 1997. Il progetto, con le sue fasi di rea-lizzazione, eÁ consultabile nel sito web www.gewi.kfunigraz.ac.at/hi/projekte/zinzen-dorf.html; alcune indicazioni anche in A. TRAMPUS, Dalla storia delle idee alla storia dellamusica: il diario del conte Zinzendorf come fonte per una ricerca interdisciplinare, « Recer-care », V (1993), pp. 153-169.
7 Le edizioni parziali piuÁ importanti: H. WAGNER (a cura di), Wien von Maria The-resia bis zur Franzosenzeit. Aus den TagebuÈchern des Grafen Karl von Zinzendorf, Biblio-philen Gesellschaft, Wien 1972 (antologia di brani tradotti in lingua tedesca) e PAGNINI
(a cura di), Il periodo triestino, cit., p. 7-246.
dal 1782, Ministro di Stato nel Consiglio di Stato per l'Interno dal1790, Maresciallo regionale dell'Austria inferiore nel 1800 e infine di-rigente Ministro di Stato e delle conferenze dal 1808 alla morte, av-venuta a Vienna nel 1813.
Le difficoltaÁ connesse alla mancanza di un'edizione organica e cri-ticamente affidabile del diario, per la quale solo di recente ci si sta im-pegnando, hanno consentito un utilizzo della fonte soltanto parziale, eprevalentemente nell'ambito della storia politica ed economica au-striaca e ungherese 8. Il diario eÁ invece maggiormente noto agli storicidella musica e del teatro, sin dagli anni Trenta del Novecento 9. L'u-tilizzazione piuÁ sistematica eÁ avvenuta grazie alle ricerche di OttoErich Deutsch 10 sulla giovinezza di Mozart, soprattutto perche la vi-cenda biografica del musicista salisburghese si svolse interamente en-tro l'arco di vita di Zinzendorf che ne fu, percioÁ , prezioso testimone:fin dal 9 ottobre 1762 quando, nel palazzo viennese del conte Collal-to, veniva notato « un petit garcËon qu'on dit n'avoit que 5 ans et demijoua du Clavecin [...] » 11; e pochi giorni dopo, risentendo il piccolo
138
8 Tra gli studi piuÁ informati E.H. BA LASZ, Karl von Zinzendorf et ses reÂlations avec laHongrie aÁ l'eÂpoque de l'absolutisme eÂclaireÂ, Budapest, AkadeÂmiai Kiado , Budapest 1975che accenna anche (p. 9) alle relazioni tra Zinzendorf e Hume che peroÁ furono, a quantopare, assai superficiali; H.P. LIEBEL-WECKOWICZ, Free Trade and Protectionism underMaria Theresa and Joseph II, « Canadian Journal of History / Annales canadiennes d'hi-stoire », XIV (1979), pp. 355-373.
9 Tra i primi C.L. CURIEL, Vita musicale e drammatica nel Settecento italiano: il tea-tro San Pietro di Trieste 1690-1801, Archetipografia, Milano 1937, che non attinse diret-tamente ai diari ma si avvalse della collaborazione di Gustav Gugitz. Si veda inoltre J.WITZENETZ, Le theÂatre francËais de Vienne, « E tudes francËaises de L'Institut francËais del'universite de Szeged », VII (1932), pp. 37-52; U. HERBECKE, Das Tagebuch des GrafenKarl von Zinzendorf als theatergeschichtliche Quelle, Diss. UniversitaÈ t KoÈ ln, KoÈ ln 1969;O. MICHTNER, Das alte Burgtheater als OpernbuÈhne: von der EinfuÈhrung des Singspiel(1778) bis zum Tod Kaiser Leopolds II. (1792), in Theatergeschichte OÈsterreichs, I, BoÈh-lau, Wien 1970; J. A. RICE, Antonio Salieri and Viennese Opera, University of ChicagoPress, Chicago 1999, pp. 38, 65, 175; T. DE NORA, Beethoven and the Construction ofGenius: Musical Politics in Vienna 1792-1802, University of California Press, Los Ange-les 1997, pp. 22, 47, 219; A. RICHARDS, The Free Fantasia and Musical Picturesque, Cam-bridge University Press, Cambridge 2001, pp. 101, 241.
10 O.E. DEUTSCH, Mozart in Zinzendorfs TagebuÈchern, « Schweizerische Musikzei-tung / Revue musicale suisse », CII, 1962, pp. 211-218.
11 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, bd. 7, 14 ottobre1762. Cfr. DEUTSCH, Mozart in Zinzendorfs TagebuÈchern, cit., p. 212. La trascrizione del
Mozart nella casa del conte Thurn-Valsassina, Zinzendorf avrebbescritto che laÁ « le petit Enfant de Salzbourg et Sa soeur jourent du cla-vecin. Le pauvre petit joue a merveille, c'est un Enfant Spirituel, vif,charmant, sa Soeur joue en maitre, et il lui applaudit » 12.
Vent'anni piuÁ tardi Zinzendorf sarebbe divenuto uno dei princi-pali sottoscrittori dei concerti del salisburghese, partecipe pure delleconversazioni in cui Giuseppe II discuteva dell'antagonismo fra Mo-zart e Clementi, e assiduo frequentatore delle esecuzioni mozartiane(tra il 7 maggio e il 24 ottobre 1788 assistette a ben sei rappresentazio-ni del Don Giovanni); infine, dopo il 1791, su invito della stessa Kon-stanze Weber («M.me Mozart a passe a ma porte », 30 marzo 1795),fu sottoscrittore degli ultimi concerti in memoria del defunto 13.
Zinzendorf, tuttavia, non si limitoÁ solo a registrare, con metodicaprecisione, gli avvenimenti ai quali giornalmente assisteva. Con fre-quenza, infatti, affidava al diario riflessioni o giudizi suggeriti dellequotidiane letture e le impressioni suscitate in lui da qualche rappre-sentazione teatrale, a Vienna come a Trieste o a Venezia. Il valore ditali annotazioni va naturalmente rapportato alla cultura del personag-gio in materia musicale. Benche infatti interessato alla musica e al tea-tro, Zinzendorf non aveva una specifica preparazione in materia; siha notizia che nella prima giovinezza, fino ai dodici anni circa, assie-me ai fratelli completoÁ la prima formazione con un insegnante priva-to di musica 14; ma si trattoÁ tuttavia di un'educazione sommaria, limi-tata alle nozioni elementari di teoria, solfeggio e di storia della musi-ca, ne eÁ documentata l'applicazione ad alcuno strumento. Unapersona dalla preparazione musicale tanto superficiale avrebbe potu-to percioÁ essere facilmente influenzata o, ancor piuÁ , dominata nei gu-
139
testo in questa e nelle pagine seguenti osserva i criteri di edizione adottati dalla Kommis-sion fuÈ r neuere Geschichte OÈ sterreichs per risolvere in Zinzendorf l'uso spesso scorrettodel francese, con errori ortografici e grammaticali e con una accentazione arbitraria.
12 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, bd. 7, 17 ottobre1762. Cfr. DEUTSCH, Mozart in Zinzendorfs TagebuÈchern, cit., p. 212.
13 Tutti i passi sono riportati da DEUTSCH, Mozart in Zinzendorfs TagebuÈchern, cit.,pp. 212-218.
14 M. BREUNLICH, Die Jugend des Grafen Karl von Zinzendorf und Pottendorf (1739-1761), «Mitteilungen des oÈ sterreichischen Staatsarchiv », XXXVII (1984), pp. 149-171.
sti e negli orientamenti dalle tendenze e dalle mode del tempo, se unasolida preparazione culturale ed una spiccata autonomia di giudizionon l'avessero sottratta, almeno in parte, al condizionamento degliambienti musicali e teatrali piuÁ spesso frequentati.
Sarebbe d'altra parte arduo, se non addirittura pretestuoso, cer-care nel diario traccia di un interesse particolare per alcuni problemiteorici pure all'epoca discussi molto appassionatamente come peresempio, nell'ambito della tragedia, il dibattito sulla verosimiglianza,il confine tra verosimile e vero e le relative categorie aristoteliche 15.E allo stesso modo bisogna rilevare la ritrosia di Zinzendorf a impe-gnarsi, anche nelle circostanze piuÁ favorevoli, in discussioni di argo-mento musicale o teatrale con amici e commensali o con persone chepur avrebbero potuto soddisfare curiositaÁ o interessi.
Una conferma indiretta di questo atteggiamento viene dai rapportidi Zinzendorf con Rousseau. Quando Zinzendorf fu ospite del ginevri-no a Brot-Dessus, per un'intera giornata il 7 settembre 1764, si intrat-tenne a lungo con lui a discutere della Nouvelle HeÂloõÈse, di Voltaire,delle finanze francesi e di vari altri argomenti a colazione, a pranzo,a passeggio nei boschi vicini 16, ma non invece di musica o di teatro 17.
140
15 EÁ un tema su cui si eÁ soffermato ampiamente J. SCHERER, La drammaturgie clas-sique en France, Nizet, Paris 1951.
16 Per i rapporti di Zinzendorf con Rousseau vedi A. LAVAL, Zinzendorf aÁ Paris. Enfeulletant Zinzendorf. Visites aÁ J.J. Rousseau et aÁ Voltaire, « Le Temps », Paris 2 aprile1924 e 14 agosto 1924; F.S. EIGELDINGER, Rousseau et le comte Zinzendorf: une lettreineÂdite, « Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau NeuchaÃtel-Bullettin d'infor-mation », XXXII (1984), pp. 1-8.
17 Dell'argomento Zinzendorf fece cenno in tutt'altra occasione, due giorni piuÁ tar-di a La Caux-de-Fonds riferendosi alla figlia del locale albergatore: «A dõÃner je parloisbeaucoup, senseÂment et meÃme des oeuvres de Rousseau avec une jolie fille de l'auberge.Elle avoit lu Julie. Ce sont de bien bonnes gens, que ces montagnons. Rousseau en parledans sa Lettre sur le spectacle ». Manca purtroppo, sia in questi passi del diario sia nellabreve corrispondenza intrattenuta da Rousseau con Zinzendorf dopo quell'incontro,qualsiasi riferimento specifico a temi e problemi di interesse musicale e teatrale. Meritacomunque ricordare ± a parziale chiarimento del contesto in cui quell'incontro si svolse± che la comunanza di interessi tra Zinzendorf e Rousseau aveva per oggetto soprattuttoalcune teorie politiche: Zinzendorf, pur non accettando l'idea del contratto sociale, con-divideva numerosi punti del pensiero rousseauiano, soprattutto riguardanti il fondamen-to del diritto di proprietaÁ . Inoltre l'attenzione di Zinzendorf fu costante anche per l'o-pera pedagogica e letteraria del ginevrino. Si veda F.S. EIGELDINGER, Le journal de Zin-
Allo stesso modo non sembra riconoscibile un'autonoma posi-zione di Zinzendorf rispetto al dibattito contemporaneo sul rapportotra musica e linguaggio 18, o rispetto al Rousseau autore dell'Essai surl'origine des langues e quindi all'idea di una degradazione delle linguerispetto a un originario principio lirico. Da questo punto di vista Zin-zendorf, benche dimostrasse predilezione per l'opera buffa e per l'u-so dell'italiano nel ristabilimento dell'equilibrio tra musica e linguasuggerito dal modello rousseauiano, sembrava voler comunque rico-noscere nella gerarchizzazione delle funzione delle lingue rispetto allamusica, dopo l'italiano, un rango superiore al francese, relegando iltedesco all'ultima posizione. Si tratta di un atteggiamento interessan-te, che attende ancora ulteriori approfondimenti anche alla luce del-l'edizione critica del suo diario.
Le idee estetiche di Zinzendorf si possono evincere, invece, daalcuni ulteriori passi del diario che riportano giudizi personali, comequelli espressi nell'occasione degli incontri con Gottfried van Swie-ten: « Swieten m'ennuja aÁ parler avec une eÂternelle critique des ron-deaux et de la langue francËoise. Il soutint la theÁse la plus ridicole, qu-'un homme qui par son application devient parfait dans quelque cho-se, ne sauroit eÃtre homme de genie et ne sauroit avoir de lasensibilite , sans quoi il manqueroit la patience. Il decida la dessousavec une suffisance horrible et moi que tout affecte; cette sottocon-duite m'attrista » 19. Evidentemente le posizioni di van Swieten sul-l'uso dei rondoÁ e della lingua francese, collegabili alla sua politicaculturale di divulgazione a Vienna della musica di Bach e di HaÈndel,non riscuotevano l'approvazione di Zinzendorf che in altra occasio-ne, nel febbraio 1781, avrebbe scritto: « Swieten disserta die Musikist mir fuÈ r das Ohr, je n'y eÂtois pas absolument aÁ mon use » 20.
141
zendorf et Rousseau, « Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau NeuchaÃtel-Bullet-tin d'information », XXXIII (1985), pp. 1-12.
18 C. KINTZLER, Rameau e Voltaire: la posta in giuoco teorica di una collaborazionetempestosa, in L. BIANCONI (a cura di), La drammaturgia musicale, il Mulino, Bologna1986, pp. 351-358.
19 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, 24 agosto1780, cc. 161v.-162r.
20 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 26, 24 febbraio
Le posizioni di Zinzendorf dovrebbero essere ricondotte quindiverso una precisa scelta di campo connessa alla sua predilezione per imodelli italiani e per l'opera buffa, nonche all'apprezzamento delmodello francese rafforzato dall'assidua frequentazione del Burg-theater. Egli riteneva evidentemente poco persuasivo il programmaculturale di van Swieten, fondato sul recupero della tradizione con-trappuntistica nonche sulla scelta polemica della lingua tedesca 21.
D'altra parte la sua critica appare specchio di una posizione este-tica piuttosto che politica. Egli condivideva, infatti, il programma dieducazione civile promosso dagli Asburgo, individuandone peroÁ glistrumenti di attuazione, a differenza di van Swieten, in base alle in-dicazioni degli intellettuali francesi e in particolare degli enciclopedi-sti, che sottolineavano il valore storico della tragedia greca per l'im-pegno civile, in quanto la funzione della musica era quella di esaltarele passioni. Egli faceva proprie quelle idee sulla funzione del drammanell'opera e nella tragedia moderna, con l'esaltazione delle passioni econ la preferenza, a scopi anche etici, per il lieto fine attraverso le« nuances delicates » e la commozione dell'animo umano: « Lu avecplaisir l'article Tragedie dans le Journal encyclopeÂdique. Les trageÁdiesdes anciens ne paroissoient point avoir du but moral, les crimes pro-venoient de la volontaÁ irreÂsistible des Dieux. Le lieu immense ou onjouoit la claret du jour, les masques et le cothurne excluoit toutes lesnuances delicates, qui font le plus d'impression sur nos coeurs » 22.
142
1781, c. 32v. Per i rapporti tra van Swieten e Zinzendorf vedi anche WAGNER, Wien vonMaria Theresia, cit., p. 135. EÁ difficile accertare se nell'insofferenza dimostrata da Zin-zendorf verso le idee professate da van Swieten si possa ritrovare anche l'eco del dibat-tito sul rapporto tra musica e linguaggio.
21 Per l'attivitaÁ di van Swieten vedi D.E. OLLESON, Gottfried van Swieten, patron ofHaydn and Mozart, « Proceedings of the Royal Music Association », LXXXIX (1962-1963), pp. 63-72; ID., Gottfried van Swieten in F. BLUME (a cura di), Die Musik in Ge-schichte und Gegenwart, XII, BaÈrenreiter, Kassel-Basel 1965, coll. 1786-1787; S. SADIE (acura di), The new Grove dictionary of music and musicians, XVIII, Macmillan, London1980, pp. 414-415; L. ZOPPELLI, Modello neoclassico e classicismo viennese, in CAVALLINI
(a cura di), Itinerari del classicismo musicale, cit., pp. 25-32.22 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 24, 27 gennaio
1779, cc. 16v-17r. Sul Journal encyclopeÂdique cfr. J. WAGNER, Le Journal encyclopeÂdique(1756-1794), in J. SGARD (a cura di), Dictionnaire des journaux 1600-1789, I, Universitas,Paris 1991, pp. 670-673.
Zinzendorf doveva trovare indubbiamente piuÁ consona ai suoipersonali interessi culturali la funzione della tragedia accentuatadal modello francese. CioÁ corrispondeva pure ad un atteggiamentoin favore dell'impegno civile sotteso alla tragedia e in favore di unteatro popolare, giaÁ caldeggiato da Diderot, che trovava un seguitonell'esigenza di un impegno pedagogico sentita sia da Gluck (con l'a-desione del vecchio Rousseau) sia dagli enciclopedisti, ma non da LaHarpe e da Marmontel 23. Il nostro diarista sembrava voler ritrovareproprio questo tipo di impegno civile, ritenuto compatibile con ilprogramma educativo degli Asburgo, nei caratteri del teatro musicaledi Gluck, specie quando i protagonisti dell'opera seria venivano pro-posti come modelli di virtuÁ 24.
Nel febbraio 1781, annotava Zinzendorf nel suo diario, a SchoÈn-brunn « je trouvois Gluk chez le comte Rosenberg, qui me fit uncompliment flatteur, on deÂlibera sur l'IphigeÁnie » 25; Gluck si era in-contrato con Franz Xaver Rosenberg, direttore del Burgtheater eOberstkaÈmmerer e, benche manchino ulteriori indicazioni nel diario,eÁ probabile che l'accenno vada riferito al momento in cui fu decisa lapremieÁre viennese della IphigeÂnie en Tauride, giaÁ rappresentata a Pa-rigi nel 1779 ma da Gluck sensibilmente rielaborata per il pubblicodi Vienna, con la versione del testo in lingua tedesca e con la revisio-ne delle parti vocali e di numerosi punti della partitura. EÁ probabilepercioÁ che in quell'incontro si fosse discusso anche dei contenuti del-la tragedia, pur se il diarista non ne era a conoscenza. Evidentemen-te, peroÁ , l'allora governatore del Litorale aveva preso nota della con-versazione mosso anche da un interesse per l'opera di Gluck. Larappresentazione a Vienna della IphigeÂnie, infatti, agli occhi di Zin-zendorf veniva a costituire una manifestazione evidente della riformaGluck-Calzabigi in favore di un teatro patetico-tragico, riferito a fortipassioni, in cui la musica atta a esprimere il sentimento non riuscivasubordinata alla poesia e quindi alla ragione. Nell'orientamento del
143
23 E. FUBINI, Gli enciclopedisti e la musica, Einaudi, Torino 19912, pp. 227-230.24 CosõÁ Kurt Klinger citato in F. DEGRADA, Il palazzo incantato: studi sulla tradizione
del melodramma dal barocco al romanticismo, I, Discanto, Fiesole 1979, p. 122.25 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 26, 24 febbraio
1780, c. 45v.
nostro personaggio quella riforma, con la valorizzazione dell'espres-sivitaÁ della musica, rappresentava la realizzazione migliore delle istan-ze pedagogiche e popolari caldeggiate, come giaÁ accennato, dagli en-ciclopedisti.
Tale orientamento condiziona quasi tutti i giudizi riportati neldiario, soprattutto quando Zinzendorf cercava di riconoscere in unarappresentazione teatrale traccia di un impegno morale, quindi diper se apprezzabile, che ne giustificasse la messa in scena. CosõÁ nelgennaio 1778 al teatro di Corte di Vienna: « Le soir au spectacle.Hen-riette. Mauvaise pieÁce la plus mauvaise morale, tireÂe de l'Eloise deRousseau, d'Eugenie, du PeÁre de famille » 26. E ancora per disprezzareogni attacco contro quei philosophes le cui idee sembrava condividere,come nella reazione a un omaggio del conte Buquoy di Praga, nelmarzo 1778: «M. de Buquoi m'envoya le Bureau d'esprit, comeÁdieen cinq actes, satyre contre M. Geoffrin, le M. de Condorcet, M. d'A-lembert, Arnaud, Suard, Marmontel et de la Harpe, et en grande par-tie contre M. de Voltaire. Plus de mechancete que d'agrement » 27.
In altra occasione si soffermava invece sul problema del linguaggioe della comunicazione con il pubblico per lamentare del primo attore,assistendo ad una versione tedesca della tragedia Il conte di Essex alBurgtheater di Vienna il 30 aprile 1778, « qu'il ne parle jamais le lan-gage ordinaire de la conversation. Mais voilaÁ ce que l'on exigeoit au-trefois dans la trageÂdie, ainsi la chose est pardonnable » 28. Occorre pe-roÁ accennare al significato che per il nostro personaggio doveva assu-
144
26 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 23, 6 gennaio1778, c. 13r.
27 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 23, 7 marzo1778, c. 47v. Il testo era Le bureau d'esprit. ComeÂdie en cinq actes en prose. P[ar] M.le C[hevalier] R[utlegde] G[entilhomme] A[nglais], London 1777. Cfr. British Museumgeneral catalogue of printed books to 1955, XXII, Readex Microprint Corporation, NewYork 1967, p. 268. Per la biografia del conte (Zinzendorf erra ritenendolo barone) Jo-hann Buquoy von Loquenval cfr. C. VON WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiser-thums OÈsterreichs, II, Verlag der Typographisch-literarisch-artistischen Anstalt, Wien1857, pp. 210-211.
28 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 23, 30 aprile1778, c. 94v. Non ci eÁ noto se si trattasse di un rifacimento della tragedia dallo stessotitolo di Thomas Corneille.
mere la nozione di pubblico. Rimanendo ancora a favore di un usoprevalente nel melodramma della lingua francese e della lingua italia-na, anche per le rappresentazioni nei teatri viennesi, a fronte delle pro-poste a favore della lingua tedesca di van Swieten, Zinzendorf restavalegato a una nozione del pubblico intesa in senso ancora elitario.
La preferenza per la lingua italiana non dipendeva da una sem-plice moda. Fin dagli anni giovanili egli aveva avuto modo di compie-re lunghi viaggi non solo in Francia ma anche nella penisola italiana;tra il 1764 e il 1766 ne aveva intrapreso uno attraverso Parma (dovepoco tempo prima aveva sostato anche Gluck) verso Roma, Napoli,Palermo e, al ritorno, Siena, Livorno, Firenze, Lucca, Ferrara e Bo-logna. Questo soggiorno, che ancora non eÁ stato oggetto di studi spe-cifici 29, aveva rafforzato in lui l'interesse per l'opera buffa, reso evi-dente nella predilezione per le opere di Cimarosa (tra cui L'italianain Londra) 30; in altra occasione, invece, ascoltando La vendemmiaavrebbe giudicato il lavoro di Gazzaniga « assez peu inteÂressant » 31,rivelando cosõÁ un proprio gusto personale rispetto al pubblico vien-nese che trovava invece in Gazzaniga uno degli autori di opere italia-ne piuÁ frequentemente rappresentate 32.
I gusti di Zinzendorf per la musica strumentale sembrano invecenon immediatamente interpretabili. Ebbe occasione di ascoltare spes-so la musica di Beethoven, direttamente suonata dal compositore, do-po il ritorno a Vienna nel 1782. Nell'aprile del 1795 lo sentõÁ suonare alpianoforte in casa della contessa Razumovsky e nel 1798 in casa delconte Lobkowitz, assieme al violinista Kreutzer. Ma a teatro, il 28marzo 1801, la nuova musica di Die GeschoÈpfe des Prometheus (Le
145
29 Un cenno in M.T. MORREALE, La cittaÁ di Parma negli itinerari dei viaggiatori tede-schi dei secoli XVIII e XIX, con particolare riferimento alla Reisebeschreibung inedita del-l'architetto assidano F.M. Hesemer, in M.E. D'AGOSTINI (a cura di), La letteratura di viaggio:storia e prospettive di un genere letterario, Guerini e associati, Milano 1987, p. 205.
30 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 26, 26 settem-bre 1781, c. 169v.
31 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 24, 26 dicem-bre 1778, c. 261v.
32 Si veda F. PIPERNO, Venezia e Vienna: produzione e circolazione dello spettacolooperistico, in M.T. MURARO (a cura di), L'opera italiana a Vienna prima di Metastasio,Olschki, Firenze 1990, p. 122.
creature di Prometeo) non gli piacque affatto, diversamente dal ballet-to 33. Benche questo passo del diario non basti a qualificare il suo giu-dizio come definitivo, eÁ da ritenere che anche nelle sue opinioni si ri-producessero le fratture ideali giaÁ note in altri intellettuali, di maggio-re o di minore rilievo, determinate dall'avvento beethoveniano dopol'egemonia haydniana. La posizione di Zinzendorf appare tanto piuÁinteressante in quanto vissuta in un intellettuale a stretto contattocon i salotti viennesi piuÁ importanti, da quello degli Schwarzenberga quello dei Lubomirski, dei Lobkowitz, del banchiere Fries.
Con maggior piacere ascoltoÁ invece il 4 marzo 1799 l'oratorioDie SchoÈpfung di Haydn 34; eÁ stato ipotizzato che in esso egli « sicherden Text des Barons Gottfied van Swieten beigetraten hat, da er derreligioÈ sen Einstellung des Grafen entsprach » 35, ma tale idea ± tenu-to conto dello scarso valore letterario del libretto e ancor piuÁ del notoatteggiamento critico nei confronti di van Swieten ± non pare acco-glibile. Sembra preferibile interpretare il giudizio di Zinzendorf co-me apprezzamento per la sola musica, piuttosto che per il libretto.
PiuÁ difficile eÁ valutare i suoi atteggiamenti verso la produzionedrammaturgica di fine secolo e di primo Ottocento. Se nel 1796avrebbe annotato che il nuovo pezzo di Kotzebue Falsche Scham« liess mich wie ein Schlosshund weinen », nel 1802 al Burgtheaterrinunciava a ogni giudizio su Giovanna d'Arco di Schiller, che pur ri-conosceva come tragedia romantica, uscita dalle maglie della censuracon i tagli e le manomissioni del drammaturgo August Iffland 36.
Le osservazioni fatte sin qui sugli interessi teatrali e musicali diZinzendorf sono importanti perche ci introducono alla cultura delpersonaggio e consentono di capire non solo la sua personalitaÁ , maanche il tipo di sensibilitaÁ culturale che portoÁ a Trieste negli annidel suo governatorato, fra il 1776 e il 1782.
Zinzendorf era giaÁ stato a Trieste dal 15 al 17 settembre 1766 edal 19 al 21 settembre dello stesso anno, nel corso del suo primo viag-
146
33 WAGNER, Wien von Maria Theresia, cit., p. 105.34 Per i rapporti tra Zinzendorf e Haydn cfr. D.E. OLLESON, Haydn in the diaries of
Count Karl von Zinzendorf, «Haydn Jahrbuch », II (1963-1964), pp. 45-62.35 WAGNER, Wien von Maria Theresia, cit., p. 185.36 WAGNER, Wien von Maria Theresia, cit., pp. 103, 106.
gio italiano che lo aveva condotto a Venezia. E tornoÁ nella cittaÁ adria-tica una seconda volta, cinque anni piuÁ tardi, per un soggiorno desti-nato a durare poco meno di un mese. Partito da Vienna il 7 luglio1771, dopo aver fatto visita ad alcuni parenti a GfoÈ ll aveva attraver-sato la Stiria per fermarsi, dal 21 luglio al primo agosto, a Graz eper ripartire di lõÁ alla volta di Marburg (attuale Maribor in Slovenia)e Klagenfurt. Il 14 agosto giunse a Gorizia, il giorno dopo a Triestedove sostoÁ fino all'8 settembre, per ripartire alla volta di Fiume, Se-gna, Karlstadt in Croazia e per tornare di lõÁ a Vienna. Con la consuetaattenzione anche questa volta annotoÁ nel diario persone e luoghi chevisitava. Alcuni dei personaggi incontrati a Gorizia e a Trieste gli era-no giaÁ noti, come Carlo Morelli 37, altri sarebbero divenuti suoi consi-glieri negli anni successivi del governatorato. A Gorizia, dopo aver vi-sitato il territorio circostante, Zinzendorf prestoÁ attenzione soprattut-to ai problemi economici e fiscali, osservando lo stato dell'industriamanifatturiera, studiando questioni fiscali e doganali, seguendo l'atti-vitaÁ del Consiglio di commercio. Senza trascurare l'apprezzamentoper il paesaggio isontino, si concentroÁ sull'esame dell'opera di bonifi-ca delle paludi di Aquileia e fu guidato da Morelli al riordinato archi-vio del governo, informandosi sulla storia di Gorizia anche presso ilconte Coronini 38. Impressionato un po' dagli atteggiamenti spesso di-simpegnati della nobiltaÁ locale, Zinzendorf ebbe invece un'ottima im-pressione dell'arcivescovo Carlo Michele d'Attems 39. Quanto invecealla situazione amministrativa, rilevoÁ soprattutto l'applicazione elasti-
147
37 Sulla figura di Carlo Morelli eÁ indispensabile fare oggi riferimento al volume cu-rato da S. CAVAZZA, P. IANCIS, D. PORCEDDA, Studi e documenti su Carlo Morelli e l'« Isto-ria della Contea di Gorizia », Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2003, pubblicatoa completamento della ristampa anastatica della Istoria e che raccoglie molte nuove in-formazioni sul personaggio e sulla genesi della sua opera.
38 Il diario di questo viaggio eÁ stato pubblicato in A. TRAMPUS, Economia e statodelle riforme nel Litorale Austriaco dal diario del conte Zinzendorf (1771), « ArcheografoTriestino », s. IV, L (1990), pp. 76-106.
39 Per la personalitaÁ di Attems e per la situazione goriziana di quegli anni eÁ indi-spensabile oggi fare riferimento ai contributi raccolti nel volume a cura di L. TAVANO,F.M. DOLINAR, Carlo Michele d'Attems primo arcivescovo di Gorizia (1752-1774) fra Cu-ria romana e Stato asburgico, Istituto di Storia sociale e religiosa-Istituto per gli Incontriculturali mitteleuropei, Gorizia 1990.
ca e non immediata delle direttive sovrane e l'inadeguatezza di deter-minate disposizioni fiscali e doganali alla situazione locale.
A Trieste, dopo aver trovato alloggio alla Locanda grande, fu ac-compagnato dal barone Pittoni attraverso la cittaÁ Teresiana, per intrat-tenersi poi con l'Intendente, con le alte cariche dell'amministrazionecittadina, con i rappresentanti della borghesia mercantile. Venne infor-mato sull'amministrazione finanziaria della cittaÁ , sulle leggi municipali esul regolamento del Tribunale di commercio. Nei giorni successivi vi-sitoÁ con piuÁ attenzione la cittaÁ e i dintorni, recandosi fino a Corgnalee a Lipizza e a assistette ad una seduta del Tribunale di commercio.
Le annotazioni del 1771 sul Litorale fanno intravedere lo spiritocon il quale cinque anni piuÁ tardi, nel 1776, il nostro personaggio sisarebbe preparato ad assumere le redini del governatorato, cioeÁ anzi-tutto quello di studioso dei fenomeni economici e dei problemi del-l'amministrazione. Furono infatti essenzialmente due le linee d'azioneche guidarono la sua opera politica e culturale negli anni del governotriestino: in materia economica, l'adesione alle teorie fisiocratiche le-gate alla cultura francese; in ambito politico-giuridico, cioeÁ dellascienza dello Stato, l'attenzione per i modelli giusnaturalistici nellapartecipazione ai programmi di riforma della monarchia assoluta.
I viaggi giovanili e le letture francesi lo avevano messo in contattocon il gruppo dei fisiocratici che aveva aderito ai princõÁpi dei Lumi eche si riconoscevano nel magistero di Quesney e di Victor de Mira-beau. Studioso attento del pensiero di quest'ultimo e amico persona-le del fratello, Zinzendorf consolidoÁ la propria esperienza scientificafrequentando durante il soggiorno parigino del 1767 Turgot, Neckere Forbonnais 40. Negli anni successivi, mentre continuoÁ a seguire laloro opera, si dimostroÁ sensibile all'esperienza economica e politicainglese legata alle dottrine economiche di Adam Smith, che matura-rono nell'Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nationsdel 1776 41. E con lo studio di questi autori, non sempre convenien-
148
40 Cfr. BAÂ LASZ, Karl von Zinzendorf, cit; LIEBEL-WECKOWICZ, Free Trade and Protec-tionism, cit., pp. 355-373.
41 Tale interesse era nato in occasione del suo viaggio in Inghilterra su cui si vedaG.O. GUÈ RTLER, Impressionen einer Reise. Das England-Itineraire des Grafen Karl vonZinzendorf 1768, «Mitteilungen des Instituts fuÈ r OÈ sterreichische Geschichtsfor-
temente letti nel mondo culturale austriaco, rafforzoÁ le proprie ideesulla fisiocrazia. Cauto di fronte all'esaltazione dell'utilitarismo eco-nomico, fu piuÁ aperto alla diffusione del liberismo. Forte di attenteletture, fece propria una rappresentazione dell'individuo il cui ruoloveniva definito da una tensione economico-sociale all'interesse comu-ne composto nella societaÁ , somma degli individui e realizzazione de-gli interessi dei singoli 42.
Superando i limiti di talune elaborazioni teoriche del mercantili-smo, in particolare l'assenza di un rapporto piuÁ diretto fra i program-mi economici e finanziari e fenomeni politici nella scienza dello Sta-to 43, Zinzendorf diede un contributo importante alla diffusione e al-l'applicazione delle dottrine economiche liberiste nella monarchia.Pur mantenendosi nell'ambito di una concezione ormai consolidatadello Stato patrimoniale, si distinse rispetto ai fautori del camerali-smo « accademico » tedesco, inteso quale astrazione teorica finalizza-ta ad una dottrina globale dello Stato 44. Venne, quindi, assumendoposizioni vicine alle dottrine politiche di Justi e di Sonnenfels, che sulfinire del secolo avrebbero conosciuto piuÁ larga diffusione. In campoeconomico fu, pertanto, un convinto assertore di un liberismo nutri-to dell'indirizzo fisiocratico francese, alieno dall'esasperazione siste-matizzante della scuola cameralistica tedesca e proiettato, piuttosto,verso i nuovi orizzonti socio-economici individuati dalla scienza delloStato austriaca.
CioÁ risulta chiaramente scorrendo le osservazioni di Zinzendorfsulle letture fatte a Trieste nel corso del 1780. Rimeditava gli scritti de-gli economisti riproposti dalle gazzette tedesche, come le osservazionidi Smith sulle colonie americane pubblicate dalla Gazette de commer-
149
schung », XCIII, 3-4 (1985), pp. 333-369, che peroÁ ignora completamente i tratti dellacultura politico-economica di Zinzendorf. Menziona invece Smith H. LIEBEL-WECKO-
WICZ, Count Karl von Zinzendorf and the Liberal Revolt against Joseph's II. EconomicReforms 1783-1790, in H.U. WEHLER (a cura di), Sozialgeschichte Heute. FestschriftfuÈr Hans Rosenberg zum 70. Geburtstag, Vandenhoeck und Ruprecht, GoÈ ttingen1974, p. 71.
42 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 18r sub 1febbraio 1780.
43 BRUÈ CKNER, Staatswissenschaften, Kameralismus, cit.44 Per un inquadramento del tema cfr. SCHIERA, Dall'arte di governo, cit.
ce 45. Soprattutto, peroÁ , lo affascinavano i sei volumi delle Rechercheset consideÂrations sur les finance de France di Forbonnais che postillava,cogliendo a pretesto di riflessione la storia economica francese: comefece il 4 marzo 1780, quando espresse la considerazione che « le leÂgi-slateur a tort d'intervenir dans une convention qui devoit eÃtre libre desa nature. Il ne doit point donner de loix que les hommes ayent inteÂreÃta ne point executer » 46. Altre riflessioni gli suscitoÁ la lettura della tra-duzione tedesca dell'Inquiry di Adam Smith, che lo assorbõÁ per tutta laprima metaÁ del 1780. Trascrisse anzi un passo del capitolo II del libroIV: « die RatschlaÈge der Regierung sollten nie nach dem ungestuÈmenAnliegen des Privat-Eigennuzes, sondern von einer weitsehenden Ab-sicht auf die allgemeine Wolfart geleigt worden ». E commentoÁ infrancese: « superbe penseÂe, plut aÁ Dieu que les gouvernemens suivi-rent toujours ce plan » 47. Analoghe espressioni di ammirazione destoÁin lui la lettura delle opere di FrancËois Quesnay, che annotoÁ commen-tandole con il suo interlocutore triestino preferito, il barone Pittoni 48.
Se, da una parte, furono questi per lui i riferimenti e i motivi ispi-ratori nelle dottrine economiche, piuÁ articolata appare la strutturadel suo pensiero politico. Qui il collegamento fra gli economisti fran-cesi e i teorici austriaci della scienza dello Stato puoÁ essere individua-to nell'opera di d'Holbach, l'autore del SysteÁme de la nature, diffuso-re del materialismo illuminista, che Zinzendorf annoverava tra le sueletture piuÁ interessanti nel periodo triestino 49. Il governatore, che eralegato alla massoneria, piuÁ che esaltare il cosiddetto ateismo materia-lizzante del filosofo francese ± problema senz'altro non facilmente ri-solvibile nella coscienza di un convertito al cattolicesimo 50 ± ne ap-
150
45 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 195r,sub 10 ottobre 1780.
46 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, cc. 39v-40r, sub 4 marzo 1780.
47 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 25r, sub9 febbraio 1780.
48 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 18r, sub1 febbraio 1780.
49 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, cc. 30r-31r, sub 16 febbraio 1780.
50 Vedi C. LEBEAU, La conversion de Karl von Zinzendorf: affaire d'eÂtat ou affaire de
prezzava le equilibrate riflessioni sull'essere umano, sul concetto diindulgenza, sulla natura socievole dell'individuo e sulla felicitaÁ uma-na espressa nella societaÁ universale 51. Particolare attenzione dovettemanifestare per la teorizzazione holbachiana del rapporto tra moralee politica e il riconoscimento della necessitaÁ che fosse la morale a de-terminare le forme della politica 52. CosõÁ, ne poteva condividere leprecise riflessioni sul concetto di ordine, centrale nella ricostruzionepolitica e filosofica del francese, perche momento di composizionedelle forze individuali e di superamento dell'opposizione tra indivi-duo e societaÁ 53. Il significato delle letture holbachiane nel pensieroe nell'azione politica di Zinzendorf eÁ stato del tutto trascurato dallacritica moderna, mentre pare certamente degno di approfondimento.
Una posizione altrettanto interlocutoria su temi religiosi si riveloÁnell'occasione dell'incontro fra Zinzendorf e Lessing a Vienna il 28settembre 1780, in occasione di uno dei viaggi annuali del governa-tore nella capitale per riferire sulle condizioni del Litorale e per visi-tare la famiglia. Si era a pochi mesi dalla morte del drammaturgo e,riportando nel proprio diario il contenuto di quel colloquio, Zinzen-dorf non esitoÁ ad avanzare osservazioni critiche sulle idee di Lessingsul regno celeste e sulla risurrezione: « Lessing dit que Jesus Christusne parla que d'un royame visibile qu'il ne preÂdit rien de sa resurrec-tion, que sa mort inopineÂe porta ses disciples a forger le nouveau sy-steÁme d'un redempteur spirituel martyrise , que le teÂmoignage d'E-tienne et de Pierre de la resurrection d'est rien moins que concluant.Que le parti eÂtoit puis de se faire proclamer rois des Juifs, que lesdeux Couins Jean et Jacques s'exaltoient l'un l'autre, fesant semblantde ne pas se connoitre. Le royame du Ciel eÂtoit un royame terrestre.
151
famille? «Revue de syntheÁse », IV s., 3-4 (1993), pp. 473-495 e EAD., Aristocrates etgrands commis aÁ la Cour de Vienne (1748-1791). Le modeÁle francËais, CNRS, Paris1996; per i temi holbachiani A. MINERBI BELGRADO, Paura e ignoranza. Studio sulla teoriadella religione in d'Holbach, Sansoni, Firenze 1983.
51 F. BRUNETTI, D'Holbach: l'intellettuale tra « philosophie » e « engagement », in L.SOZZI (a cura di), Il principe e il filosofo. Intellettuali e potere in Francia dai « philoso-phes » all'« affaire » Dreyfus, Guida, Napoli 1988, pp. 99-134.
52 P.H. D'HOLBACH, SysteÁme de la nature, II, s.t., Londres 1778, p. 19; cfr. HHStA,Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 55v., sub 26 marzo 1780.
53 D'HOLBACH, SysteÁme de la nature, I, cit., p. 50.
La seconde apparition de Jesus Christi a manqueÂ, l'eÂpoque preÂcise-ment annonceÂe en est passe depuis seise sieÁcles en devantage » 54.
Sul piano filosofico, politico e giuridico le idee di Zinzendorf, nu-trite del giusnaturalismo tedesco fin dagli anni della formazione uni-versitaria, si identificarono ben presto, come accennato, con l'elabo-razione della scienza dello Stato in Austria. In cioÁ egli fu uno dei piuÁconvinti fautori dell'evoluzione dello Stato di polizia in Stato di dirit-to. AppoggioÁ un programma di rafforzamento dell'apparato statale insintonia con i princõÁpi dell'assolutismo illuminato, da realizzare, peroÁ ,con il decentramento organico per un migliore funzionamento del-l'amministrazione 55. In questa materia le sue posizioni certamentedovettero riuscire rafforzate dalla stima e dall'amicizia personalecon Sonnenfels e dall'esperienza politica acquisita prima con i viaggidi studio e poi con il governatorato nel Litorale Austriaco.
Sensibile agli ideali etici e filosofici dell'Illuminismo e allineatocon gli orientamenti progressisti della migliore tradizione del riformi-smo illuminato austriaco, Zinzendorf non poteva non approvare ladottrina politica di Sonnenfels, comprendendone le premesse teori-che, il riconoscimento della funzione sociale del contratto naturalee la cauta diffidenza verso il contrattualismo sociale, pur ribadendola necessitaÁ di piuÁ ampie basi sociali nel consenso politico 56. Meritaaccennare, inoltre, al fatto che gli studiosi svizzeri dei rapporti traZinzendorf e Rousseau, sulla base della loro breve corrispondenzae delle annotazioni contenute nel diario, hanno dovuto constatarela mancanza di interessi politici comuni e la prevalente attenzione
152
54 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 186r.,sub 28 settembre 1780.
55 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, passim, eLIEBEL-WECKOWICZ, Count Karl von Zinzendorf, cit.
56 Si veda il rapido accenno a Sonnenfels in BAÂ LASZ, Karl von Zinzendorf, cit., p. 6.Per Sonnenfels cfr. D. LINDNER, Der Mann ohne Vorurteil. Joseph von Sonnenfels 1732-1817, OÈ sterreichischer Bundesverlag, Wien 1983. Particolarmente interessante per ilrapporto con altri intellettuali noti a Zinzendorf eÁ R. BAUER, « Luxus » in OÈsterreich: Jo-seph von Sonnenfels zwischen Jean-Jacques Rousseau und Adam Smith, in OÈsterreich imEuropa der AufklaÈrung. KontinuitaÈt und ZaÈsur in Europa zur Zeit Maria Theresias undJosephs II., I, OÈ sterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1985, pp. 319-334, con ampi riferimenti bibliografici.
di Zinzendorf per l'opera pedagogica e letteraria del ginevrino. SipuoÁ osservare, tuttavia, che l'opera politica di Rousseau ± come quel-la di Montesquieu ± non rimase del tutto estranea al suo orizzontecritico e che registroÁ puntualmente nel diario le discussioni dell'epo-ca, come quando annotoÁ che « le Prince [Kaunitz] dit que Rousseauavoir la folie de croire tout le mond occupe celui faire des riches, quel'Esprit des loix est un livre qui a fait plus de bruit qu'il ne vout, qu'ily a des belles penseÂes, mais beaucoup de creÁme fouetteÂe et de pau-vreteÂs, que l'auteur du Contrat social ne s'intendoit pas lui meÃme » 57.
Va rilevato che la posizione di Zinzendorf nel dibattito sulla scienzadello Stato e sul riformismo illuminato era, tuttavia, profondamente di-versa da quella di gran parte dei riformatori italiani, anche di quantioperavano nei domini peninsulari di Casa d'Austria. Ne eÁ esempio lacritica serrata di Zinzendorf, proprio nel 1780, alla teorizzazione del di-ritto di proprietaÁ contenuta in L'uomo libero di Gianrinaldo Carli, ri-spetto al quale manifestoÁ opinioni certamente piuÁ aperte e illuminate 58.
Vi eÁ poi da fare un'altra considerazione importante, che riguardal'appartenenza al mondo massonico: mentre certamente Carli non fumassone (ma semmai amico di massoni e moderatamente interessatoalla cultura massonizzante del suo tempo) 59, fu invece massone Zin-zendorf, come Sonnenfels 60. E non occorre insistere in questa sede
153
57 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 26, carte nonnumerate, sub 6 aprile 1781. Per i rapporti di Zinzendorf con Rousseau cfr. EIGELDIN-
GER, Rousseau et le comte Zinzendorf, cit., p. 6, e ID., Le journal de Zinzendorf, cit., p. 8.Sul viaggio svizzero di Zinzendorf si veda anche A. MOIOLI, Lo spazio economico elveticosecondo i resoconti di viaggio di Karl von Zinzendorf (1764), in F. PIOLA CASELLI (a curadi), Regioni alpine e sviluppo economico. Dualismi e processi d'integrazione (secc. XVIII-XX), Milano, Franco Angeli, 2003.
58 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 61r sub9 aprile 1780 e cc. 72r.-v., sub 1 maggio 1780; il brano in questione eÁ analizzato in A.TRAMPUS, L'Illuminismo e la « nuova politica » nel tardo Settecento italiano: « L'uomo li-bero » di Gianrinaldo Carli, « Rivista Storica Italiana », CVI, 1 (1994), pp. 108-109. Cfr.anche infra, cap. VII, p.
59 A. TRAMPUS, Gianrinaldo Carli e il processo a Cagliostro (lettere di Alessandro Ver-ri), « Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno », XX (1989-1990), pp. 333-350;ID., L'Illuminismo e la « nuova politica », cit., p. 106.
60 Per l'appartenenza di Zinzendorf alla massoneria eÁ oggi chiarificatore H. WATZ-
LAWICK, Die friedlichen Fahrten eines Deuschenordensritters auf den KriegsschiffendesMalteser-Ritter-Ordens, in C. STEEB-B. STRIMITZER, Der SouveraÈne Maltesers-Ritter-Orden
sulla funzione della cultura massonica settecentesca nella circolazionedelle idee, nella monarchia asburgica e anche nel Litorale, ove piuÁintensa proprio in quegli anni diveniva l'attivitaÁ culturale.
La sua levatura intellettuale, quindi, ben fa comprendere le ra-gioni di una brillante e lunga carriera al servizio di quattro sovraniasburgici. Formatosi, infatti, nella fase piuÁ felice della scuola politicaaustriaca, fu onorato della profonda considerazione di Maria Teresae seppe portare alla monarchia, sin dagli anni giovanili, un preziosocontributo. Nel delicato momento della storia culturale dei dominiitaliani di Casa d'Austria che vedeva la crisi della collaborazionetra principi e intellettuali, evidente soprattutto nella Lombardia au-striaca 61, Zinzendorf fu destinato al governo del Litorale che guidoÁcon fermezza e senza traumi politici ed economici verso un modernoordine amministrativo, economico e culturale 62.
Servitore convinto e capace di Maria Teresa, fu ricambiato dallasovrana da una sincera stima; lo conferma la lettura delle cronachedelle udienze concessegli a SchoÈnbrunn nel 1780, nei quattro mesiche ne precedettero la morte. Tali resoconti fanno intravedere infattirapporti che superarono la rigiditaÁ del cerimoniale e l'obbligo di re-lazione. CosõÁ il 9 agosto, dopo aver esposto le condizioni del LitoraleAustriaco, Zinzendorf prolungava il colloquio con Maria Teresa rac-cogliendo le sue considerazioni sulla politica di Caterina II e le suepreoccupazioni per Giuseppe II, impegnato in una difficile missionepolitica 63. Il 14 agosto, ritornato a corte per ricevere istruzioni poli-
154
in OÈsterreich. Im Auftrag des Grosspriorates von OÈsterreich, Leykam, Graz 1999, pp. 93-120; tale appartenenza era stata giaÁ intuita da K. GUTKAS, Freimaurer, in OÈsterreich zurZeit Kaiser Joseph II. Mitregent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und LandesfuÈrst, Niede-roÈ sterreichische Landesregierung, Wien 1980, p. 591. Rimangono tuttavia da verificare irapporti di Zinzendorf con il mondo massonico tedesco, specialmente sassone, sul qualesi veda P.-Y. BEAUREPAIRE, L'espace des francs-macËons. Une sociabilite europeeÂnne auXVIIIe sieÁcle, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003, pp. 151-179.
61 Si veda il quadro offerto da VENTURI, Settecento riformatore, 5/1, L'Italia dei lu-mi, cit., pp. 425-834.
62 Per i mutamenti politici, sociali e culturali nel Litorale durante questo periodorimane illuminante la sintesi offerta nel volume Da Maria Teresa a Giuseppe II, cit.
63 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 150v.-151r., sub 9 agosto 1780. Si trattava del viaggio di Giuseppe II in Russia.
tiche, dovette resistere alle insistenze di Maria Teresa che voleva af-fidare solo a lui la composizione di una delicata controversia in ma-teria doganale nel Tirolo, per non trascurare l'impegno nel Litora-le 64. E, per aggiungere una nota di colore, uscito dagli apparta-mentiimperiali pote intrattenersi a lungo con l'anziano Metastasio in uncolloquio, cosõÁ scrisse, assai affabile.
La stessa atmosfera quasi cordiale fu vissuta all'udienza del 1 set-tembre. « L'ImpeÂratrice de bonne humeur » ± scrisse Zinzendorf ±« se plaignit de son man... de respiration, me dit qu'elle viendroit voirmon freÁre, demand... s'il avoit en beaucoup de plaisir de voir sa fil-le » 65. Lo stesso avvenne nell'udienza privata del 20 settembre. Il 22,scrisse invece nel suo diario, dopo reiterate insistenze « Sa MajesteÂme dispensa d'aller aÁ preÂsent en Tyrol, ajoutant treÁs gracieusement,que comme j'eÂtois la seule persone, dans l'impartialite de la quelleElle eut la confiance a cet eÂgard ». Ritornato poi a Trieste, annotoÁil 6 novembre che « l'ordinaire me porta une lettre de Sa MajesteÂl'ImpeÂratrice Reine du 25 octobre contenant des expressions treÁsflatteuses aÁ mon eÂgard » 66.
Risalgono al 4 dicembre due osservazioni il cui diverso tono sot-tendono i sentimenti del nostro personaggio: « l'ordinaire d'aujourd'-hui me porta des lettres du comte Rosenberg et de ma belle-soeur du29, dont le conteÂnu me persuade que la triste nouvelle repandue icihier, que notre bonne maõÃtresse, l'ImpeÂratrice-Reine Marie TheÂreÁse acesse de vivre le 29 a six heures et demi de soir, peut treÁs bien eÃtrevraye ». Qualche ora piuÁ tardi aggiunse: « Je ne sortis pas; les Maffei,le consul de Venise, le lieutenant colonel Pittoni e toient chez moi,lorsqu'aÁ 7 h du soir arriva l'estafette avec un rescript aÁ moi du nou-veau Souverain, qui m'annonce que l'ImpeÂratrice-Reine Marie TheÂ-reÁse est morte le 29 de novembre avant 9 h du soir. L'Empereur Jo-seph II me confirme dans mon poste avec tous les Tribunaux et per-sonnes qui me sont subordonneÂs » 67.
155
64 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 154v.65 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 167v.66 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 209v.67 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 221r.-v.
Negli anni precedenti, i rapporti del governatore con GiuseppeII erano rimasti prevalentemente formali. Il nuovo monarca sicura-mente aveva notizia delle capacitaÁ di Zinzendorf che, a propria volta,aveva conosciuto il suo carattere dai colloqui con Maria Teresa 68.
Quando ritornoÁ a Vienna alla fine di dicembre, Zinzendorf ven-ne immediatamente ricevuto da Giuseppe II per il consueto rapportosul governo del Litorale; ma tutto si svolse in un'atmosfera stretta-mente formale 69. Chi per primo riuscõÁ ad attenuare l'iniziale pruden-za di Zinzendorf nei riguardi del nuovo sovrano fu, al casino nobiledi Vienna nella mattinata del 27 dicembre, Joseph von Sonnenfels.Gli narroÁ le ultime ore di vita di Maria Teresa, gli riferõÁ dell'affida-mento che ella aveva fatto sul letto di morte nella figura del figlio,gli raccontoÁ dell'impegno manifestato dal nuovo sovrano, fin dai pri-mi giorni di regno. Infine, dopo aver ricordato i progressi della mo-narchia guidata da Maria Teresa, gli prospettoÁ i futuri traguardi dellapolitica giuseppina per il miglioramento dello Stato 70.
Questa iniziale prudenza di Zinzendorf, che potrebbe sembrarestrana visto che Giuseppe II era stato co-reggente fin dal 1765, furicambiata peroÁ dal nuovo sovrano. EÁ significativo che questi, quan-do nel marzo 1781 decise di conoscere meglio il nostro personaggio,si rivolse al fratello Pietro Leopoldo. E lui, che di Zinzendorf avevagiaÁ apprezzato le qualitaÁ , lo rassicuroÁ confermandone i sani princõÁpi eaggiungendo che doveva essere considerato tra i piuÁ capaci funziona-ri dello Stato 71. Quindi, proprio la nomina di Zinzendorf a presiden-te della Camera aulica dei conti nel 1782 rappresentoÁ la conferma diquelle parole e del nuovo rapporto di collaborazione con il sovrano.
EÁ evidente, allora, che se da una parte Zinzendorf dimostroÁ gran-de acume nell'adattarsi alla politica asburgica mantenendo una so-
156
68 Cfr. per esempio HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher,Bd. 25, c. 150v., sub 9 agosto 1780.
69 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 233r.,sub 26 dicembre 1780.
70 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 234r.,sub 27 dicembre 1780.
71 BAÂ LASZ, Karl von Zinzendorf, cit., p. 19; cfr. anche LIEBEL-WECKOWICZ, Free Tra-de, cit., pp. 355-373.
stanziale coerenza con i princõÁpi etici e politici, dall'altra egli riconob-be sostanziale continuitaÁ tra la politica teresiana e l'azione riformatri-ce del giuseppinismo 72. Si tratta di un atteggiamento interessante,che trova oggi un riscontro alla luce degli orientamenti storiograficipiuÁ recenti sulla figura sovrano e sulla sua politica 73.
Nel merito, tacendo dell'ambito ecclesiastico, alle cui riforme Zin-zendorf in quegli anni non appare direttamente interessato, fu certamen-te sostanziale l'identitaÁ di vedute nell'attuazione del centralismo ammini-strativo e nel proseguimento delle riforme economiche, benche questenon costituissero l'elemento piuÁ originale nell'azione politica di Giusep-pe II. Pur apprezzando nel giuseppinismo l'impostazione finalizzata albenessere sociale dei sudditi, Zinzendorf sembroÁ limitare il pieno con-senso per la nuova politica sovrana al vasto piano di razionalizzazione bu-rocratica e amministrativa 74. Per quanto riguarda, invece, il campo eco-nomico, viene da riflettere che uno statista della sua preparazione nonpoteva che rimanere prudente di fronte allo strano amalgama di teoriemercantiliste e fisiocratiche che contraddistinse il suo regno. A livellostrettamente politico, poi, Zinzendorf certamente avvertõÁ la progressivaerosione della base dell'incondizionata devozione popolare alla monar-chia, che, nella prospettiva teresiana e dei teorici della scienza dello Stato,appariva uno dei presupposti necessari alla prosperitaÁ della nazione 75.
Al periodo triestino di Zinzendorf risalgono anche numeroseamicizie e molti contatti intellettuali dei quali rimane traccia sia nei
157
72 Si veda G. KLINGENSTEIN, Revisions of Enlightened Absolutism: « The AustrianMonarchy is like no other », « The Historical Journal », XXXIII, 1 (1990), pp. 155-167 e, in precedenza, EAD., OÈsterreich und Europa 1780, in OÈsterreich im Europa derAufklaÈrung, I, cit., pp. 19-28 e J. BEÂ RANGER, Die Habsburgermonarchie als StaÈndestaat:ZaÈsur und KontinuitaÈt zur Zeit Maria Theresias mit besonderer BeruÈcksichtigung Ungarnse D. BEALES, Die auswaÈrtige Politik der Monarchie vor und nach 1780: KontinuitaÈt oderZaÈsur, entrambi in OÈsterreich im Europa der AufklaÈrung, I, cit., rispettivamente alle pp.437-445 e 567-573.
73 A. TRAMPUS, Riforme, giuseppinismo e lumi nella monarchia asburgica: nuovi studisulla figura del cancelliere Kaunitz, « Rivista Storica Italiana », CX (1998), pp. 985-1004.
74 Si veda a proposito F.A. SZABO, FuÈrst Kaunitz und die AnfaÈnge der Josephinismus,in OÈsterreich im Europa der AufklaÈrung, I, cit., pp. 525-545.
75 G. KLINGENSTEIN, Riforma e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giu-seppe II. Tentativo di un'interpretazione, in SCHIERA (a cura di), La dinamica statale au-striaca, cit., pp. 118-123.
diari sia nel carteggio superstite. Tra questi merita attenzione il rap-porto con Sigismondo Zois (1747-1819), figura di letterato e mecena-te nella Slovenia del XVIII secolo che giaÁ aveva attirato l'attenzionedi storici austriaci e sloveni e che di recente eÁ tornato al centro dellacritica 76, sia per quanto riguarda la sua produzione poetica e lettera-ria, sia per quanto attiene ai suoi interessi eruditi ed accademici 77.
Esponente tipico della borghesia tardo settecentesca di recentenobilitazione, Zois fu impegnato professionalmente nell'industriaestrattiva e lavorativa del ferro 78, curando l'amministrazione dei pro-pri possedimenti e delle miniere nella Carinzia e mantenendo cosõÁ
stretti contatti personali e professionali con gli ambienti economicidell'Austria interiore e dell'Italia settentrionale, dove si era formatoin gioventuÁ . La ditta « Sigmund Zois & Co. » per il commercio di mi-nerali ferrosi, con sede a Lubiana, poteva giovarsi di avviate filiali aVenezia e a Trieste che rendevano necessari frequenti viaggi del tito-lare nel territorio veneto e nel Litorale Austriaco. Inoltre le vicendedella casa di commercio, dalla sua fondazione ad opera del caposti-pite Michele Angelo Zois, alle prime attivitaÁ nel Litorale sino all'a-pertura della filiale veneziana 79, riflettono lo sviluppo economicodella Slovenia nella seconda metaÁ del Settecento, specie per quantoriguarda il commercio di esportazione ed il monopolio del ferro 80.
Conclusa l'educazione a Reggio Emilia 81 e rientrato a Lubianadopo la morte del padre nel 1777, Sigismondo Zois fu sempre piuÁassorbito dagli impegni di negozio 82, fino al mutamento delle pro-
158
76 S. BONAZZA, Literarische Beziehungen zwischen Sigmund Zois und Pavle Solaric,«MuÈnchner Zeitschrift fuÈ r Balkankunde », 6 (1990), pp. 79-92; ID., Sigmund Zois als UÈber-setzer von Pavle Solaric, «MuÈnchner Zeitschrift fuÈ r Balkankunde », 7-8 (1991), pp. 55-74.
77 Si veda piuÁ oltre, nel cap. VIII, sulle relazioni fra Zois e Casanova.78 F.X. RICHTER, Sigmund Zois Freyherr von Edelstein, Gassenberg, [Laibach] 1820;
WURZBACH, Biographisches Lexikon, cit., 60 (1891), pp. 243-246.79 RICHTER, Sigmund Zois, cit., pp. 5-6.80 ASTs, C.R.S. Intendenza commerciale, busta 311, sub 1765, carte non numerate;
altre notizie in ASTs, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 127, reg. nr. 162, fz. II,carte non numerate.
81 M. KACIN, L'infanzia e l'adolescenza di Sigismondo Zois, « Ricerche Slavistiche »,V (1957), pp. 142-158; BONAZZA, Literarische Beziehungen, cit., p. 81.
82 RICHTER, Sigmund Zois, cit., pp. 7-8.
spettive economiche verso gli ultimi anni del secolo, preludente lacrisi dell'etaÁ napoleonica. A nulla sarebbe servito, nel 1812, l'estremotentativo di risollevare le sorti delle sue attivitaÁ 83, tanto che trascorsegli ultimi anni di vita in condizioni sicuramente non agiate.
Zois aveva conosciuto Zinzendorf fin dal settembre 1771, quan-do questi stava per concludere la sua terza visita nella cittaÁ adriatica elo aveva interpellato per conoscere le sue idee sul problema delle co-municazioni fra Trieste e Lubiana: « Zoys de Laubach 84, de retourde la foire de Sinigaglia vint me parler au sujet de cette impresa pourle prix de volture entre ici et Laybach 85 ». L'amicizia tra i due per-sonaggi da allora andoÁ ben presto rafforzandosi, anche grazie ai co-muni interessi culturali, e si consolidarono ulteriormente con il tra-sferimento definitivo di Zinzendorf nel Litorale nel 1776. Ai rapportidi amicizia e alle relazioni epistolari, documentati anche da qualchelettera superstite 86, seguõÁ un intenso scambio librario, documentatoancora una volta dal diario 87, che illumina sui modi e sui tempi dellacircolazione delle idee fra l'Austria interiore, la Slovenia e il Litoralenel tardo Settecento. Una lettera superstite, conservata fra le carte diZinzendorf allo Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna 88, riferiscedei preparativi per la visita a Trieste del granduca Paolo Petrovichdi Russia, figlio di Caterina II e zar dal 1796, assieme alla moglie So-
159
83 M. PIVEC-STELEÂ , La vie eÂconomique des Provinces Illyriennes (1809-1813), Bos-sard, Paris 1930, p. 71.
84 Trascrizione fonetica per « Laibach ».85 TRAMPUS, Economia e stato delle riforme, cit., p. 97.86 Si veda anche l'elenco della corrispondenza registrata da Zinzendorf nel diario:
HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 23, sub 5.10.1778,18.11.1780 ecc.
87 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 27, c. 26r.:« Sigimond Zois m'envoye le second volume de l'Oryctographia Carniolica ». Il libroera Oryctographia carniolica, oder physikalische Erdbeschreibung des Herzoghtums Krain,Istrien, und zum Theil der benachbarten LaÈnder di Balthasar Hacquet, Breitkopf, Leipzig1781. Zinzendorf aveva letto il primo volume nel 1780, cfr. HHStA, Kabinettskanzlei,Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher. Bd. 25, c. 57r, sub 31.3.1780: « Lu ensuite avec plaisirdans l'Oryctographie sur la creÂation de la terre ».
88 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, Nr. 8 Note und Briefen an K.Maria Theresia und K. Josef II: sonstige Korrespondenz, carte non numerate, datata Lubia-na 25 dicembre 1781, edita in TRAMPUS, All'orizzonte degli slavi del sud, cit., pp. 49-50.
phia Dorothea di WuÈ rtemberg. Il loro soggiorno nel Litorale era pre-visto per il 14 gennaio 1782 come tappa di un viaggio in incognitoverso Venezia sotto lo pseudonimo di conte e contessa del Nord.Zinzendorf aveva ricevuto il 24 dicembre 1781 una comunicazionedel presidente della Cancelleria aulica, il conte von Blumegen, conte-nente le istruzioni per l'occasione 89 e con la raccomandazione di ri-solvere il problema dell'alloggio per gli illustri ospiti, data la carenzadi alberghi di livello a Trieste. Zinzendorf pote risolvere il problemaproprio grazie alla disponibilitaÁ del palazzo triestino di Zois: « Zoysm'offre sa maison pour le Conte du Nord », scriveva nel diario il27 dicembre 1781, aggiungendo pochi giorni dopo, il 7 gennaio1782, che « Pittoni vint, nous parlaÃmes de la manieÁre de faire descen-dre la grande Duchesse a couvert devant la maison de Zois » 90.
Il rapporto di Zinzendorf con il commerciante lubianese fu ac-compagnato peroÁ anche, come accennato, da intensi scambi librari.Proprio in quella stessa epoca Zois invioÁ al governatore il secondo to-mo dell'Oryctographia di Hacquet de la Motte. L'interesse per quest'o-pera dipendeva soltanto in parte dall'ambito geografico in essa esami-nato; nella Slovenia e nel Litorale cominciava piuttosto a farsi stradaun interesse nuovo per le scienze naturali, non piuÁ limitato a specificisettori disciplinari, ma attento a cogliere il rapporto fra innovazionescientifica, conoscenza del territorio e uso della politica. Nell'Orycto-graphia carniolica Hacquet, sulle orme di Gerhard van Swieten, venivaattuando un progetto di descrizione naturalistica della monarchia at-traverso il quale la ricerca scientifica veniva caricata di non dissimulatevalenze politiche, che servivano in primo luogo a legittimare sul pianoscientifico, geografico e orografico l'appartenenza dei domini ereditariverso l'Adriatico al patrimonio della scienza naturale austriaca 91.
La lettera prima ricordata documenta anche l'interesse di Zin-zendorf e Zois per gli scritti di Bonnet e per il dibattito scientificodel tempo. Proprio in quegli anni, nell'Italia settentrionale, l'attenzio-
160
89 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 26, sub 24.12.1781.90 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd., 27, c. 5r.91 OÈsterreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950, II, BoÈhlau, Graz-KoÈ ln 1959,
pp. 132-133; E. ZOÈ LLNER, Geschichte OÈsterreichs, Verlag fuÈ r Geschichte und Politik,Wien 19842, pp. 381-382.
ne per il neonaturalismo e per il concetto di catena degli esseri avevasollecitato le traduzioni e le lezioni di Spallanzani alla cattedra pave-se. L'idea profetica dell'immutabilitaÁ di un disegno divino di frontealla dinamica della natura affascinava sempre piuÁ un pubblico euro-peo attento ad ogni novitaÁ nel dibattito fra scienza e natura 92.
Dopo il rientro di Zinzendorf a Vienna nel 1782 i rapporti tra idue non si interruppero e continuarono sia grazie al tramite di PietroAntonio Pittoni, sia per iniziativa personale dello stesso Zinzen-dorf 93. Ne diede prova nel 1792 quando, divenuto Ministro di statoe delle conferenze per gli interni, tornando in viaggio nel LitoraleAustriaco volle fermarsi a Lubiana appositamente per incontrareZois e trovare nuovamente occasione per appassionate discussionidi argomento letterario e scientifico 94.
A quell'epoca l'entusiasmo di Zinzendorf era chiaramente mag-giore per Leopoldo II, il suo discreto mentore degli anni Settanta,nel cui impegno vedeva piuÁ stretta la coerenza con il lungo regno te-resiano. In campo economico vedeva in lui una piuÁ decisa adesionealla fisiocrazia con l'obiettivo della massima estensione del liberoscambio fra gli Stati ereditari; in ambito politico, con l'intelligentetemperamento dei programmi di accentramento amministrativo,con il riconoscimento di alcune specificitaÁ regionali, che portoÁ all'a-brogazione di non poche disposizioni giuseppine 95.
Un altro punto del programma politico di Leopoldo II avrebbetrovato in Zinzendorf un convinto sostenitore: il costituzionalismofondato sulla separazione dei poteri ispirata a Montesquieu e la sen-sibilitaÁ all'idea di autodeterminazione del popolo in materia tributa-ria, o almeno alla possibilitaÁ che il popolo potesse tutelarsi di fronteagli arbitri del governo 96. Sonnenfels stesso, che fu tra i massimi teo-
161
92 J. MARX, Charles Bonnet contre les lumieÁres 1738-1850, « Studies on Voltaire andthe Eighteenth Century », CLVI, Voltaire Foundation, Oxford 1976, 2 voll. Per gli spaziitaliani FERRONE, I profeti dell'Illuminismo, cit., pp. 87-90.
93 TAMARO, Fine del Settecento, cit., p. 55.94 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 37, c. 127, sub
29 maggio 1792.95 A. WANDRUSZKA, Leopold II., Herold, Wien 1963-1964, 2 voll.96 MACARTNEY, L'impero degli Asburgo, cit., p. 161.
rici dell'assolutismo illuminato negli anni del regno di Giuseppe II,non solo aveva riconosciuto il valore delle idee di Montesquieu,ma ne aveva ripreso alcuni spunti sull'equilibrio dei poteri per rein-terpretarli alla luce della concezione assolutista 97. Rispetto a taliorientamenti Zinzendorf fu forse meno rigido e un po' piuÁ moderno.In cioÁ si riconoscono alcuni tra gli elementi piuÁ originali del suo pen-siero, maturato probabilmente dall'esperienza nell'amministrazionedel Litorale settecentesco. Fu proprio questa consapevolezza dei li-miti delle astrazioni e delle teorizzazioni politiche a rendere il gover-natore del Litorale particolarmente apprezzato agli occhi dei sovraniasburgici. Del resto, gli studiosi contemporanei sono oggi piuÁ pru-denti nell'esaltare la filosofia riformatrice di Sonnenfels e nel valutarel'incidenza effettiva delle sue teorie nelle vicende politiche e ammini-strative dell'Austria settecentesca 98. Zinzendorf, invece, fu l'intellet-tuale e statista che in quella giornata del 27 dicembre 1780, dopol'incontro con Sonnenfels a un mese dalla morte di Maria Teresa, ri-portava con orgoglio nel diario quanto aveva appreso sull'ultimo col-loquio della sovrana morente con il figlio Giuseppe: « sa dernieÁreconfeÂrence avec Joseph II., ouÁ elle doit lui avoir deÂcrit chaque pro-vince seÂparement, de manieÁre qu'il s'eÂcria qu'il n'y avoit qu'un Mon-tesquieu qui puà t faire des observations pareilles, en pleine sante , etl'ImpeÂratrice n'avoit que deux fois vint quadre heures aÁ vivre » 99.
La definitiva partenza per Vienna, nel 1782, e la sua sostituzionecon il conte Pompeo de Brigido, patrizio triestino sino ad allora go-vernatore di Lemberg / Lvov 100, venne a rappresentare non soltantouna svolta nell'esperienza personale del governatore, ma una vera epropria cesura per la storia della regione. Troppo spesso le vicende
162
97 STOLLEIS, Geschichte des oÈffentlichen Rechts, cit., pp. 181-182.98 K.H. OSTERLOH, Joseph von Sonnenfels und die oÈsterreichische Reformbewegung
im Zeitalter des aufgeklaÈrten Absolutismus, Matthiesen, LuÈbeck 1970; G. KLINGENSTEIN,AkademikeruÈberschluss als soziales Problem im aufgeklaÈrten Absolutismus, «Wiener Bei-traÈge zur Geschichte der Neuzeit », V (1978), pp. 165-204.
99 HHStA, Kabinettskanzleri, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, cc. 233r.-234v., sub 27 dicembre 1780.
100 Una curiosa rappresentazione di Brigido eÁ offerta da Saverio Scrofani quindicianni dopo; cfr. D. PORCEDDA, Nota sul soggiorno triestino di Saverio Scrofani, «QuaderniGiuliani di Storia », XXIX, 2 (2003), pp. 287-295, in particolare p. 292.
del Litorale settecentesco sono state lette in termini di sostanzialecontinuitaÁ , dalla dichiarazione del porto franco nel 1719 sino al crol-lo dell'impero asburgico nel 1918. Invece la fine del regno di MariaTeresa e il trasferimento di Zinzendorf rappresentarono il passaggioda un'epoca nella quale lo sviluppo del Litorale era avvenuto in con-dizioni di sostanziale autonomia verso una fase di sempre maggioreaccentramento politico e amministrativo, coerente con le trasforma-zioni in seno alla monarchia. Uno degli artefici di questo processo fucertamente il cancelliere Wenzel Anton von Kaunitz le cui direttiveper la riorganizzazione dell'amministrazione e della giustizia venneroin gran parte eseguite. Nel 1782 il Friuli orientale, Aquileia, Gorizia eGradisca vennero unite amministrativamente al porto franco di Trie-ste e costituite in provincia del Litorale. L'anno dopo venne introdot-ta una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, ispirata dal-l'Allgemeine Gerichtsordnung del 1781, che comportoÁ l'abolizione dimolti organi di giustizia locale quali la luogotenenza a Gorizia, il Tri-bunale civile a Trieste, il Consessus in causis summi Principis di Trie-ste e Gorizia e il Judicium delegatum in causis Consiliariorum et Offi-cialium 101. Tutti questi organi vennero riuniti in una nuova magistra-tura, il Giudizio civile, soggetto al governatore. Nello stesso periodoanche in altri domini italiani di Casa d'Asburgo vennero introdotteanaloghe riforme, come per esempio a Milano, dove tra il 1784 e il1786 venne istituito un nuovo consiglio di governo.
Il programma economico di Giuseppe II e di Kaunitz, basato suun rafforzamento della produzione interna e su una riduzione delleimportazioni dall'estero, venne realizzato invece solo parzialmente;comprometteva troppo gli interessi commerciali e marittimi del por-
163
101 M.L. IONA, Il C.R. Consiglio Capitaniale delle unite contee di Gorizia e Gradisca,« Rassegna degli Archivi di Stato », 23 (1963), pp. 391-396; R. PAVANELLO, La costituzio-ne goriziana in etaÁ settecentesca, in Maria Teresa e il Settecento Goriziano (catalogo dellamostra), Tipografia sociale, Gorizia 1982, pp. 94-95; P. DORSI, Il sistema dei giudizi localinel Goriziano tra XVIII e XIX secolo, «Quaderni Giuliani di Storia », IV (1983), pp. 7-62; R. PAVANELLO, Sulle riforme giudiziarie giuseppine nelle province austriache, con par-ticolare riguardo alla cittaÁ di Trieste e alle unite contee di Gorizia e Gradisca, « Clio », 29(1993), pp. 161-172.
to franco e trovoÁ accesi oppositori proprio in Zinzendorf e nei suoiantichi collaboratori, orientati invece verso forme di liberismo 102.
Senza voler ripercorrere la storia di tutti i rapporti tra Kaunitz eZinzendorf, che risalivano agli anni Sessanta del Settecento 103, eÁ inte-ressante notare che sin dall'inizio degli anni Ottanta l'atteggiamentodel governatore del Litorale nei confronti del cancelliere divenne re-lativamente critico, come mostrano numerosi passi del diario. I motividi dissenso riguardavano sia gli orientamenti culturali sia le scelte po-litiche; giaÁ nelle pagine precedenti si eÁ avuto modo di ricordare le os-servazioni di Zinzendorf a proposito dei giudizi di Kaunitz sull'Espritdes lois e sul Contrat social. Le divergenze del governatore investivanoperoÁ anche le direttive di Kaunitz sul commercio triestino. MentreZinzendorf si adoperava per promuovere il commercio marittimo diTrieste giungendo alla costituzione, nell'agosto del 1781, della SocieÂteÂimpeÂriale pour le commerce asiatique de Trieste et d'Anvers, Kaunitzinvece interpretava gli orientamenti della corte di Vienna frenandoogni iniziativa locale per ricondurre il commercio con le Indie sottoil controllo degli organi centrali 104. Lo stesso console veneziano aTrieste riferiva nel febbraio 1782 al doge che la posizione di Zinzen-dorf incontrava sempre maggiore opposizione a Vienna e che persinogli esponenti del patriziato locale, nella speranza di reimpadronirsi delgoverno cittadino, si erano rivolti a Kaunitz chiedendo l'allontana-
164
102 G. LUZZATTO, Il portofranco di Trieste e la politica mercantilistica austriaca nel'700, « Annali Triestini », XXII (1953), pp. 1-15; W. MARKOV, Die Triestiner OstindienKompanie (1775-1785) und die Nordsee-Adria Konkurrenz, Berlin 1961; ID., La compa-gnia austriaca di Trieste, « Studi storici », 2 (1961), pp. 3-28; F. BABUDIERI, L'espansionemercantile austriaca nei territori d'oltremare nel XVIII secolo e suoi riflessi politici ed eco-nomici, GiuffreÁ , Milano 1978; P. GASSER, Triests Handelsversuche mit Spanien und dieProbleme der oÈsterreichischen Schiffahrt in den Jahren 1750-1800, «Mitteilungen desOÈ sterreichischen Staatsarchiv », 36 (1983), pp. 150-172 e 37 (1984), pp. 172-197; U. CO-
VA, Commercio e navigazione a Trieste e nella monarchia asburgica da Maria Teresa al1915, Del Bianco, Udine 1992. Per una testimonianza ottocentesca sugli esiti delle rifor-me giuseppine cfr. J. LOÈ WENTHAL, Geschichte der Stadt Triest, I, Triest von der aÈltestenZeit bis zum Jahre 1790, Triest 1857, pp. 213-214.
103 KLINGENSTEIN, Spanien im Horizont der oÈsterreichischen AufklaÈrung, cit., p. 117.104 W. KALTENSTADLER, Der oÈsterreichische Seehandel uÈber Triest im 18. Jahrhun-
dert, « Vierteljahresschrift fuÈ r Sozial und Wirtschaftsgeschichte », 55 (1968), pp. 482-497; 56 (1969), pp. 1-104.
mento del governatore e la sua rimozione dall'incarico. Avevano fattopresente a Kaunitz che si trattava di un pericoloso innovatore, orien-tato verso l'introduzione di un sistema di libero scambio e che percioÁun uomo cosõÁ « illuminato » e « colto » avrebbe potuto essere di mag-giore utilitaÁ per risolvere i grandi problemi politici ed economici nellacapitale, piuttosto che in una piccola cittaÁ come Trieste 105.
Fu allora che Zinzendorf venne richiamato a Vienna, per esserenominato pochi mesi dopo presidente della Camera aulica dei conti.Prima di partire scrisse una lunga relazione del suo governo a Giu-seppe II, trasmettendone una copia anche a Kaunitz, nella quale ri-vendicava con orgoglio il fatto di aver amministrato per sei anni lacittaÁ seguendo il principio che il commercio non doveva essere frena-to regolandone nel dettaglio ogni aspetto 106. E sarebbe stato Giu-seppe II stesso a rimandare a Trieste una copia di questa relazione,come allegato alle istruzioni per il nuovo governatore Pompeo deBrigido. CosõÁ si chiudeva la vicenda triestina di un intellettuale euro-peo che, formatosi alla scuola politica teresiana e divenuto uno deimassimi statisti della monarchia, seppe intrecciare la sua esperienzaculturale con la crescita del porto franco 107.
165
105 Il console veneziano trasmise copia di questa lettera anche all'amico Zinzendorf,che la conservoÁ tra le sue carte; cfr. HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf,Fasz. 21, lettera del 23 febbraio 1782. Una copia moderna eÁ in ADTs, Fondo Tamaro,segn. 142 C, carte non numerate.
106 ASTs, Cesareo Regio Governo del Litorale (1776-1809), busta 1121, copia dellarelazione di Zinzendorf datata 30 settembre 1782, carte non numerate.
107 Si veda la reazione di Zinzendorf alla morte di Giuseppe II, descritta da BA LASZ,Karl von Zinzendorf, cit., p. 20, sulla base delle annotazioni del diario: « Zinzendorf neparla ni de la guerre turque, ni des changements fondamentaux survenus dans les condi-tions politiques de l'Europe, raisons finales de la chute du systeÁme. Mais dans son journaldu 21 feÂvrier 1790 on peut lire la neÂcrologie suivante de Joseph II, qui fut, sans aucundoute, la plus grande figure de l'absolutisme eÂclaireÂ: Joseph Celer, le Presse est deÂceÂde».Si veda anche quanto riportato da WAGNER, Wien von Maria Theresia, cit., pp. 40-41.
VI. - LE SUGGESTIONI NATURALISTICHE IN STEFANOCARLI E IL DIBATTITO SULLE ORIGINI DI CITTA-NOVA D'ISTRIA
Mentre nel porto franco triestino si infittivano gli interventi e idibattiti sui nuovi rapporti sociali, fioriva in Istria l'impegno eruditoin dispute letterarie e storiografiche, tra cui quella sulle origini miti-che di Cittanova che vide protagonista Stefano Carli.
Fratello minore del piuÁ celebre Gianrinaldo, fu certamente unodegli animatori della cultura istriana del Settecento e come tale sem-pre eÁ stato ricordato 1. EÁ una valutazione da condividere, che trovaconferma nei piuÁ recenti studi sul personaggio dai quali si coglie la ri-corrente contrapposizione sul piano culturale tra Gianrinaldo e Stefa-no, che si risolve nella opposizione tra cultura preilluministica di re-spiro nazionale e cultura erudita di carattere provinciale 2. Contrastofrequente, come noto, nel mondo culturale settecentesco e che trovacorrispondenza, nel nostro specifico caso, in rapporti personali all'in-terno di un legame di sangue: due fratelli, uno proteso verso orizzonticulturali di notevole estensione, l'altro sempre limitato, pur con ap-prezzabili tentativi di apertura, ai confini della « piccola patria ».
Il profilo biografico mette bene in luce i meriti e le contraddizio-
166
1 ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli, cit., p. 275.2 Un contrasto che trova corrispondenza anche sul piano dei rapporti personali tra i
due fratelli, cfr. ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli, cit., p. 287.
ni in Stefano Carli, ma pure ha reso evidente quanto risulti difficilesintetizzare l'attivitaÁ culturale di un personaggio il cui lavoro eÁ notosoltanto in parte, poiche di lui eÁ conosciuta una sola opera 3.
La figura che ne risulta eÁ quella di un capodistriano, nato nel1725, che studioÁ presso gli Scolopi della cittaÁ natale, che visse alcunianni a Costantinopoli apprendendo lingue orientali e che, dopo avercompiuto studi superiori ed universitari, dispersivi e non regolari, di-venne nel 1763 Sovrintendente ai boschi dell'Istria. Una figura cheappare sempre condizionata, prima in modo positivo e poi in modonegativo, dall'ombra del fratello maggiore Gianrinaldo; al confrontosembra avesse dimostrato maggiore individualitaÁ il terzo fratello Ge-rolamo 4, che nella cultura illuministica settecentesca lascioÁ maggioretraccia dedicandosi a studi giuridici, in particolare di diritto penale, epubblicando anche un'opera attinente al diritto canonico e agli impe-dimenti dirimenti il matrimonio 5.
Poco conosciuta eÁ, nei contenuti, l'attivitaÁ culturale di Stefano Car-li, e in modo comunque insufficiente per un'esauriente valutazione cri-tica. A parte alcune poesie d'occasione prive di valore letterario ed unagenerica collaborazione editoriale con Gianrinaldo, limitata peraltro abreve spazio di tempo 6, del nostro personaggio eÁ ricordata solamentel'Erizia, una tragedia dedicata a Voltaire e a Rousseau pubblicata a Ve-
167
3 S. CELLA, Carli Stefano, in Dizionario biografico degli italiani, 20, Istituto della En-ciclopedia Italiana, Roma 1977, pp. 175-176. Qualche nuovo documento eÁ stato portatoda E. IVETIC, Stefano Carli, intellettuale di periferia. Note per una ricerca sulla nobiltaÁ ca-podistriana del Settecento, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di archeologia e storiapatria », XLVI n.s. (1998), pp. 215-253, che ha esaminato i manoscritti superstiti dell'ar-chivio di Stefano Carli conservati a Pisino e a Parenzo. Un cenno in I. CAVALLINI, Genio,imitazione, stile sentimentale e patetico. Gianrinaldo Carli e Tartini: le prospettive dellacritica tartiniana nella seconda metaÁ del Settecento, in A. BOMBI, M. NEVILLA MASSARO,Tartini. Il tempo e le opere, il Mulino, Bologna 1994, pp. 229-246, in particolare p. 233.
4 Gerolamo Carli, nato a Capodistria nel 1728, si laureoÁ in giurisprudenza a Padovanel 1759 e visse poi a Milano ove raggiunse, al termine della sua carriera, l'incarico diconsigliere aulico del supremo Tribunale di giustizia; morõÁ a Milano nel 1792. Cfr. CEL-
LA, Carli Stefano, cit., p. 176 e L. BOSSI, Elogio storico del co. Gian Rinaldo Carli, Palese,Venezia 1797, p. 228.
5 G. CARLI, Del diritto di stabilire gl'impedimenti dirimenti il matrimonio e di con-cedere le dispense, s.t., Cremona 1784.
6 ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli, cit., p. 280; CELLA, Carli Stefano, cit., p. 175.
nezia nel 1765. Un non meglio precisato interesse per argomenti storicied eruditi eÁ stato poi individuato nel fatto che il capodistriano parteci-poÁ in qualche modo nel 1786 ad una polemica sull'Istria antica 7.
Viene ad arricchire oggi questo quadro bio-bibliografico l'inedi-to che qui analizziamo, esistente presso l'Archivio diplomatico diTrieste 8, relativo alle origini di Cittanova d'Istria e steso in formaepistolare nel 1781 quale confutazione ad un saggio del cittanoveseBartolomeo Rigo sulle origini della propria cittaÁ .
Poche sono le notizie biografiche su questo Rigo. Fu membrodella ben nota famiglia nobile di Cittanova che diede alla culturaistriana letterati di qualche fama; la contessa Giovanna Maria Rigonata Marcello fu poetessa di un certo valore e partecipoÁ all'attivitaÁdell'Accademia degli Agiati di Rovereto, di quella dei Risorti di Ca-podistria e di quella letteraria di Vienna 9; un Giandomenico fu auto-re di melodrammi (rimasti inediti) e sembra avesse ospitato in casapropria ± cosõÁ la tradizione ± Pietro Metastasio 10.
Bartolomeo Rigo, invece, eÁ ricordato come cancelliere di Cittano-va almeno dal 1754, quando fu riordinatore degli statuti quattrocen-teschi della cittadina istriana; ricopioÁ il codice statutario premetten-dovi un significativo avviso al lettore 11 e aggiungendovi di propria ini-ziativa un volume contenente la collazione di altre leggi municipali,fino a quell'epoca disperse 12. Sembra ancora che fosse responsabiledell'archivio municipale di Cittanova 13 ed eÁ noto che nel 1790 predi-spose la propria tomba nella chiesa della Madonna del Popolo 14. Non
168
7 CELLA, Carli Stefano, cit.8 ADTs, segn. 12 B 4/16; si tratta di un quaderno di mm 286 x 194, di cc. 39 che
reca sulla copertina un'annotazione ottocentesca di Pietro Kandler: «Dono al Gentiluo-mo Stefano Conti in cui Podestaria si formoÁ l'archivio diplomatico ± 1865, Kandler ».
9 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 61; ID., Aspetti di vita politica ed economica nel-l'Istria del Settecento, cit., p. 23.
10 ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 61; per notizie piuÁ ampie sulla famiglia Rigocfr. G. RADOSSI, Stemmi di Rettori e di famiglie notabili di Buie, « Atti del Centro di ri-cerche storiche di Rovigno », XIV (1983-1984), p. 301.
11 L. PARENTIN, Statuti di Cittanova, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di ar-cheologia e storia patria », XIV n.s. (1966), pp. 105-107.
12 ADTs, segn. û EE 25.13 L. PARENTIN, Cittanova d'Istria, Centro culturale «G.R. Carli », Trieste 1974, p. 254.14 PARENTIN, Cittanova d'Istria, cit., p. 255.
eÁ provato che si fosse laureato in legge e, in ogni caso, il suo nome noncompare nell'elenco degli studenti triestini e istriani dell'universitaÁ diPadova 15, ateneo preferito dai giovani della regione.
Verso la metaÁ del 1780 Rigo fece pervenire a Stefano Carli, affin-che desse un parere, il proprio saggio dal titolo Memorie dell'anticaEmonia da altri Antichi chiamata Eraclia, da altri Novizio, e finalmen-te ora Cittanova, che poi non venne dato alle stampe e che sembraperduto; Carli rispose con la confutazione che abbiamo rintracciata,da lui stesso intitolata Lettera critica sopra un chirografo intitolato:«Memorie dell'antica Emonia da altri Antichi chiamata Eraclia, da al-tri Novizio, e finalmente ora Cittanova, raccolte da me Bortolamio Ri-go » del Conte Stefano Carli al Signor Bartolomeo Rigo, e datata Ca-podistria, 8 marzo 1781.
Questo inedito eÁ l'unica sua opera di argomento storico finorainteramente nota e permette di verificare, attraverso la breve analisiche compiremo, il valore dell'autore e il fondamento dell'ipotesi pro-spettata da alcuni studiosi, sull'influenza che l'opera di Gian Vincen-zo Gravina pote avere nell'attivitaÁ del nostro personaggio 16.
Sui rapporti personali tra Stefano Carli e Bartolomeo Rigo ci il-lumina qualche passo della Lettera critica; la forma epistolare, diffusain quel tempo anche per la stesura di dissertazioni storiche quale lanostra, di per se non fornisce indizi utili ma vi eÁ premesso un amicocarissimo cui fanno seguito, in chiusura, alcuni riferimenti alla fami-glia Rigo che inducono ad ipotizzare una certa frequentazione ami-chevole tra i due autori 17.
L'occasione che diede avvio al dibattito fu probabilmente il sino-do diocesano di Cittanova celebrato tra il 27 e il 28 agosto 1780 18,
169
15 Cfr. A. COSTA, Studenti foroiuliensi, triestini e istriani all'universitaÁ di Padova,« Archeografo Triestino », s. II, XXI (1896-1897), pp. 185-248.
16 Come si vedraÁ piuÁ avanti, Stefano Carli stesso nel 1753 si professava ammiratoredi Gravina e dei giusnaturalisti. Questa vicinanza di pensiero eÁ sottolineata da ZILIOTTO,Del conte Stefano Carli, cit., p. 279 e anche nei suoi materiali preparatori (ADTs, Sche-dario Ziliotto, senza segnatura, cc. non numerate) che la accosta al contenuto di una let-tera di Stefano Carli, giaÁ esistente presso l'archivio Gravisi di Capodistria, nella qualel'autore dichiarava di aver deciso di andare a studiare diritto a Padova.
17 S. CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 1r., c. 37r.18 Gli atti vennero pubblicati nel volume Synodus dioacesana Aemoniensis habita in
durante il quale il vescovo Gian Domenico Stratico ebbe ad accenna-re al problema delle origini di Cittanova, suscitando per qualche mo-tivo non noto le polemiche degli studiosi locali 19. Il dibattito in que-stione certamente non dovette essere limitato alle sole persone del Ri-go e del Carli; eÁ da ritenere che fosse l'eco, se non proprio l'oggettospecifico, delle discussioni di quell'epoca nell'Accademia capodi-striana dei Risorti 20. L'appartenenza e l'attiva partecipazione di Carliall'Accademia eÁ ben nota, come pure consta che la frequentavano al-cuni membri della famiglia Rigo, tra i quali la giaÁ menzionata contes-sa Maria Giovanna Marcello-Rigo, il di lei marito Domenico e unal-tro membro della famiglia, Giampietro Rigo 21; che la frequentasseanche Bartolomeo eÁ a questo punto quantomeno ipotizzabile. Gli ar-gomenti storici, del resto, non erano estranei agli interessi culturali diquell'accademia, almeno nel periodo considerato.
I Risorti di Capodistria erano rimasti inizialmente poco sensibilialla celebre esortazione di Muratori contenuta nella lettera Ai gene-rosi letterati d'Italia (1703), ove si auspicava la messa al bando degliargomenti « leggieri », degli sproloqui poetici, delle « bagattelle cano-re » a vantaggio delle trattazioni scientifiche ed erudite, e comunquedegli studi di maggiore impegno 22; tale insensibilitaÁ alla modernaprospettiva muratoriana era ascrivibile solo in parte alla lontananzageografica della provincia e ai notevoli spazi temporali che normal-mente erano necessari per la diffusione di nuove idee: era dovuta in-vece alla persistente scarsa apertura delle accademie di provincia allenuove istanze, ai segnali di modernitaÁ e di rinnovamento, situazionein cui versava la stessa accademia di Capodistria.
170
Ecclesia cathedrali, Deo in honorem S.S. Martyrum Massimi et Pelagii dedicata, diebus 27,28, 29 augusti anni 1780, sub illustriss. et reverendiss. D. D. Fr. Ioanne Dominico Stratico,Tip. Seminarii, Padova 1781.
19 Ne scrisse anche Gianrinaldo Carli in una lettera del 20 settembre 1780 a Giro-lamo Gravisi, cfr. ZILIOTTO, Trecentosessantasei lettere, cit., p. 282.
20 Per la storia dell'accademia capodistriana si veda ZILIOTTO, Salotti e conversaricapodistriani, cit., pp. 317-340 e ID., Accademie e accademici, cit., pp. 117-279.
21 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., p. 206.22 A. VECCHI, La nuova accademia letteraria d'Italia, in Accademie e cultura. Aspetti
storici tra Sei e Settecento, Olschki, Firenze 1979, pp. 46-47.
Non eÁ un caso che l'Accademia dei Risorti avesse mantenuto, pertutta la prima metaÁ del Settecento, contatti assai poco frequenti conle istituzioni venete consorelle 23 e neppure eÁ un caso che il rinnova-mento sembra avvenisse soltanto con il principato di GianrinaldoCarli il quale, vincendo la sua insofferenza per il chiuso provinciali-smo di Capodistria, lascioÁ la cattedra di scienza nautica a Padova perfare ritorno nella cittaÁ natale nel 1757 24.
Da quell'epoca, mutate con la presenza dei nuovi animatori leprospettive culturali, ebbe inizio nuova eÂra per l'accademia capodi-striana che ebbe cosõÁ per guida colui che era stato il principe dell'Ac-cademia dei Ricovrati di Padova 25. E se anche puoÁ destare perples-sitaÁ il fatto che nella storia dell'Accademia padovana GianrinaldoCarli sembra avesse ricoperto un ruolo del tutto marginale 26, il sin-tomo del rinnovamento a Capodistria eÁ dato dai titoli rimastici degliargomenti trattati nelle riunioni accademiche.
Notevole attenzione ebbero infatti i temi di carattere storico, chepiuÁ rispecchiavano i personali interessi di Gianrinaldo Carli, soprat-tutto riguardanti l'umanesimo e il protestantesimo istriano e la storiaantica: cosõÁ Quale sia stata la principale ragione dell'apostasia di PierPaolo Vergerio, In che consistesse principalmente la sua Eresia e Qualifossero i suoi seguaci e quanto grande il suo partito (1758), o ancora Isaturnali o La scienza e l'arte della guerra nell'antichitaÁ (1760) o infineLa navigazione delli Antichi, dissertazione letta dallo stesso Gianri-naldo Carli e udita ed apprezzata da Pietro Verri a Capodistria nel1761 27.
171
23 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., pp. 164-180.24 APIH, Rinnovamento e illuminismo, cit., pp. 171-175.25 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., pp. 181-203; cfr. sui Ricovrati ora E.
RIONDATO (a cura di), Dall'Accademia dei Ricovrati all'Accademia galileiana. Atti del con-vegno storico per il quarto centenario della fondazione 1599-1999, Accademia galileiana discienze, lettere ed arti, Padova 2001.
26 In effetti Gianrinaldo Carli non eÁ nemmeno menzionato nel pur breve saggio diM.L. NICHETTI SPANIO, Accademie padovane nel Sei e Settecento, in Accademie e cultura,cit., pp. 211-221, ove risulta peraltro che la prima metaÁ del Settecento fu per l'Accade-mia dei Ricovrati un'epoca, tutto sommato, di decadenza (pp. 219-220).
27 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., pp. 184 e 203; APIH, Rinnovamento e il-luminismo, cit., p. 180.
Il successivo principato di Girolamo Gravisi vide confermato que-sto nuovo corso e vennero dibattuti molti argomenti storici affini alproblema sulle origini di Cittanova: cosõÁ la Dissertazione sopra un passodi Strabone che riguarda la corografia di Aquileia e la relativa replica, laDissertazione sopra un passo di Strabone riguardante l'antico commerciodi Aquileia co' popoli del Danubio, risalenti agli anni 1762-1769 28.
Non furono quindi estranei agli interessi dell'accademia capodi-striana gli argomenti di carattere storico, e il dibattito sulle origini diCittanova sorto nel 1780-1781 probabilmente non fu altro che unaripresa di tematiche affrontate dieci e quindici anni prima; l'attivitaÁdei Risorti nel periodo tra il 1778 ed il 1787 eÁ tuttavia assai poco co-nosciuta, mancando persino un elenco completo degli argomentitrattati. EÁ una lacuna di informazione che non corrisponde ad un pe-riodo di inattivitaÁ 29; Ziliotto opina che quel periodo fosse dedicatoper lo piuÁ « alla soluzione di problemi pratici » 30, relativi cioeÁ al ma-turato interesse per problemi agricoli e meccanici. Si ha anche noti-zia, peroÁ , di un confronto tra Gian Paolo Polesini e Girolamo Gravisisull'interpretazione di un passo di Plinio riguardante la diffusionedell'acero in Istria; in realtaÁ l'Accademia dei Risorti era giunta auna fase di decadenza, ove agli interessi diffusi non corrispondevanopiuÁ alti livelli di erudizione; neppure si trattava di attivitaÁ qualificabilicome «miste » nell'ottica di quella struttura istituzionalizzata che era-no venute assumendo molte accademie italiane 31.
In questo complesso quadro si inseriva il dibattito sulle origini diCittanova d'Istria.
Il problema storico, che puoÁ considerarsi oggi forse risolto 32, eb-
172
28 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., p. 207.29 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., pp. 228-230; l'autore dedica a quel perio-
do appena due pagine, ma tale incompletezza pare dovuta soprattutto all'assenza di fontidocumentarie, essendo cessata la reggenza di Girolamo Gravisi, i documenti del qualerappresentano la fonte primaria per la ricostruzione di Ziliotto.
30 ZILIOTTO, Accademie e accademici, cit., p. 230.31 Si veda a proposito A. QUONDAM, La scienza e l'Accademia, in BOEHM, RAIMONDI,
Accademie e societaÁ scientifiche, cit., pp. 54-55.32 Senza addentrarsi nella complessa tematica e nelle conclusioni della storiografia
piuÁ recente, giova ricordare sul tema i contributi di C. DE FRANCESCHI, Quando e comeCittanova d'Istria venne denominata Emona, « Atti e Memorie della SocietaÁ istriana di
be notevole fortuna tra gli studiosi e gli eruditi del Sei e del Settecen-to; ebbe origine, come eÁ noto, dalla pubblicazione della famosa operadi Ludwig SchoÈnleben Carniola antiqua et nova avvenuta nel 1681 aLubiana 33. Nel capitolo intitolato Emona vindicata l'autore, sulla ba-se degli itinerari tardo-antichi e contro le testimonianze dei classici,aveva sostenuto che la romana Emona dovesse identificarsi non giaÁin Cittanova d'Istria, come allora comunemente si riteneva, ma inLubiana o in localitaÁ vicina; da lõÁ, nell'alto Medioevo, sarebbero statitrasportati a Cittanova la sede vescovile e il culto martiriale 34.
L'opera di SchoÈnleben divise gli studiosi in due correnti, entram-be vivaci per tutto il Settecento; una « legittimista », sosteneva le ra-gioni di Cittanova, l'altra, « riformista », concordava nell'identifica-zione di Emona con Lubiana. Quasi tutti gli studiosi, si noti, assun-sero posizioni intransigenti onde dimostrare la dipendenza storica diuna cittaÁ dall'altra ed escludendo la possibilitaÁ dell'esistenza di duecentri romani con lo stesso nome.
Tra i numerosi autori che nel Settecento parteciparono al dibat-tito storico, Gianrinaldo Carli ebbe ad occuparsi del problema in duescritti di etaÁ giovanile; anzitutto nel libro quarto del saggio Della spe-dizione degli Argonauti in Colco (1746), In cui si confuta l'opinione:che i Colchi siano stati i Progenitori degl'Istriani 35.
173
archeologia e storia patria », XIX (1971), pp. 101-175; M. P. BILLANOVICH, BernardinoParenzano e le origini di Capodistria, in EAD., G. MIZZON, Capodistria in etaÁ romana e ilpittore Bernardino Parenzano, « Italia medioevale e umanistica », 14 (1971), pp. 266-272;G. FEDALTO, Cittanova Eracliana e le origini di Venezia, « Studi veneziani », n.s., II(1978); nonche le puntualizzazioni di M.P. BILLANOVICH, nella sua recensione al volumecit. di Fedalto, «Archivio Veneto », s. V, CXIX, 165 (1988), pp. 125-126.
33 L. SCHOÈ NLEBEN, Carniola antiqua et nova, sive incliti Ducatus Carniolae annalessacroprofani, Mayr, Labaci 1681.
34 Sull'argomento vedi G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, De-putazione di storia patria per la Venezia Giulia, Trieste 1979, pp. 325-335; B. MARUSIc,Il castello Neapolis-Novas alla luce delle fonti archeologiche e G. CUSCITO, Antiche testi-monianze cristiane a Cittanova d'Istria, ambedue in «Atti del Centro di ricerche storichedi Rovigno », XIX (1988-1989), rispettivamente pp. 9-42 e 57-73.
35 G. CARLI, Della spedizione degli Argonauti in Colco, Recurti, Venezia 1745, ri-stampato in ID., Delle opere, X, I.R. Monastero di S. Ambrogio, Milano 1785, pp.305 e segg. Sul tema ora F. MICELLI, Gianrinaldo Carli e la spedizione degli Argonauti,in TRAMPUS (a cura di), Gianrinaldo Carli nella cultura europea, cit., pp. 173-183.
EÁ questo l'intervento ove con maggiore completezza eÁ presentatala sua teoria; l'autore compõÁ un'analisi in senso inverso rispetto aglialtri autori contemporanei che partivano con la convinzione di dimo-strare le ragioni di una determinata cittaÁ , condizionando cosõÁ la pro-pria interpretazione. Egli comincioÁ analizzando il passo delle Argo-nautiche di Apollonio Rodio ove si sosteneva che Emona fosse statafondata dagli Argonauti e, in base ai dati in proprio possesso, si ac-cinse a identificare la cittaÁ contestata. Fu questo diverso procedimen-to metodologico a condurlo ad alcune personali conclusioni: era esi-stita quella Emona romana, non era stata fondata dagli Argonautipoiche il passo di Apollonio era da considerarsi apocrifo, non potevaessere identificata ne in Cittanova d'Istria ne in Lubiana ma proba-bilmente in Gemona del Friuli 36. Con cioÁ quindi non aderiva allaproposta di SchoÈnleben; ammetteva l'esistenza di un'Emona pressoLubiana e riconosceva che anche Cittanova d'Istria si fosse chiamataEmona in epoca romana ma sosteneva che non si trattava della Emo-na menzionata nell'apocrifo, la quale neppure era stata fondata dagliArgonauti: «Non vorrei peroÁ che il mondo credesse qui aver io in-tenzione di distruggere l'Emona de' Romani [...] . Pretendo io dir so-lamente: ch'ella non fu opera degli Argonauti », tornava a puntualiz-zare 37.
Gianrinaldo Carli ritornoÁ ancora sull'argomento, con notazionianche polemiche, nell'opuscolo Dell'antico vescovato emoniese(1754), ove tentoÁ di giustificare la qualifica di Emoniesi assunta daivescovi di Cittanova 38; da allora non ebbe piuÁ occasione di trattareil problema in modo approfondito.
Alla metaÁ del 1780, come si eÁ visto, l'interesse per la questionevenne riaccendendosi dopo gli interventi del vescovo Stratico e nesono prova, oltre agli scritti di Stefano Carli e di Bartolomeo Rigo,
174
36 CARLI, Delle opere, cit., X, pp. 337-339. Ritorna ora su questi temi G. CUSCITO,Gianrinaldo Carli studioso delle antichitaÁ dell'Istria, « Atti e Memorie della SocietaÁ istria-na di archeologia e storia patria », XLV n.s. (1997), pp. 37-38.
37 CARLI, Delle opere, cit., X, p. 336.38 G. CARLI, Dell'antico vescovato emoniese, in A. CALOGERAÁ (a cura di), Raccolta
d'opuscoli scientifici e filologici, 50 (1750), p. 223 segg. e ristampato in CARLI, Delle ope-re, cit., XV, pp. 317-356.
anche il saggio di Girolamo Gravisi Dissertazione sopra l'antica cittaÁdi Emonia 39 e la successiva opera di Gian Girolamo Carli, quasiomonimo del capodistriano, Sull'impresa degli Argonauti e i posteriorifatti di Giasone e Medea 40.
A questo punto si inserisce la polemica fra Stefano Carli e Barto-lomeo Rigo, affidata a due libelli che non vennero mai dati alle stam-pe. L'iniziativa l'ebbe certamente Rigo che, dopo il discorso del vesco-vo Stratico, scrisse le sue Memorie dell'antica Emonia trasmesse in co-pia a Stefano Carli; il manoscritto sembra perduto; eÁ certo comunqueche Rigo fosse uno dei sostenitori dell'identificazione di Emona conCittanova. Si era probabilmente nel settembre 1780; appena ricevutolo scritto, Carli, che era tra quanti appoggiavano SchoÈnleben, si impe-gnoÁ nella ricerca del materiale documentario per la stesura della pro-pria confutazione. Ne eÁ prova la risposta, risalente al 18 ottobre1780 41, ad una lettera che invioÁ al canonico De Werth di Lubiana,giaÁ bibliotecario al vescovado di quella cittaÁ ; Carli andava alla ricercadi documenti che comprovassero il fondamento dell'ipotesi di SchoÈn-leben e aveva probabilmente domandato se nella biblioteca lubianesefosse conservato qualche documento a tale riguardo. De Werth rispo-se invece affermando che personalmente mai aveva visto alcun docu-mento riguardante la romana Emona e precisando che, essendo la da-ta di fondazione del vescovato di Lubiana il 1460 ed essendo statoscritto dell'episcopus aemoniensis ben prima di quell'epoca, necessa-riamente Emona doveva essere identificata in Cittanova d'Istria.
La polemica Carli-Rigo si inserisce quindi in uno dei dibattiti sto-riografici all'epoca piuÁ accesi, in cui i due protagonisti riflettono pro-prio le opposte interpretazioni assunte dagli studiosi del tempo.
Stefano Carli si muove nella scia degli studi giaÁ compiuti dal fra-tello, soprattutto per quanto riguarda l'argomento al centro della suaattenzione e cioeÁ il passo di Apollonio Rodio, la cui interpretazione siprestava a fornire, all'occorrenza, argomenti a favore dell'una o del-
175
39 G. GRAVISI, Dissertazione sopra l'antica cittaÁ di Emonia, s.t., Venezia 1785.40 G.G. CARLI, Sull'impresa degli Argonauti e i posteriori fatti di Giasone e Medea,
Mantova 1785. Le osservazioni di Gianrinaldo Carli in CARLI, Delle opere, cit., X, pp.387-400.
41 COSSAR, Epistolario inedito, cit., pp. 267-268.
l'altra tesi. Al nostro personaggio interessava sempre, come al fratel-lo, poter dimostrare che il passo delle Argonautiche era apocrifo equesto non tanto per procedere ad ulteriori riflessioni come Gianri-naldo ma per dimostrare semplicemente che, non potendo Apollonioriferirsi a Cittanova d'Istria, necessariamente avrebbe dovuto allude-re a Lubiana. La disamina di Stefano Carli, cosõÁ, riproduce quasi pe-dissequamente l'opera del fratello Della spedizione degli Argonauti inColco, rivelando sõÁ rigore scientifico e padronanza della metodologiastorico-erudita, ma dimostrandosi priva di originalitaÁ ; il testo risultaperaltro appesantito da un'eccessiva e ripetitiva documentazione e dauna certa prolissitaÁ delle citazioni.
L'intervento del nostro autore non recoÁ , sostanzialmente, alcuncontributo decisivo al dibattito storiografico ma eÁ invece il documen-to piuÁ evidente del suo metodo di lavoro e dello stato dei suoi rap-porti personali con il fratello Gianrinaldo che, nonostante vedessesaccheggiata la sua opera, non veniva mai menzionato nella trattazio-ne, nemmeno con un semplice riferimento bibliografico.
Questo, in linea generale, per quanto riguarda i contenuti; nonmancano tuttavia alcuni brani nei quali maggiormente si rivela la per-sonale interpretazione dell'autore, ove si individua il suo modo diprocedere e si puoÁ cogliere il pensiero del capodistriano. Sono questii passi che ci permettono di valutare, limitatamente a questo scritto, ilfondamento dell'ipotesi secondo cui il pensiero di Stefano Carli fossestato influenzato in qualche modo dall'opera di Gravina.
Che avesse letto e ammirasse Gravina eÁ testimoniato da lui stesso,che giaÁ nel 1753 andava scrivendo: « io leggo Gravina De origine juriscivilis e ne faccio l'estratto; e cosõÁ faroÁ di tutti i migliori naturalisti chedi mano in mano androÁ leggendo, avendo giaÁ risolto d'interessarmipiuÁ che potroÁ in questa materia che conosco assai migliore e piuÁ ne-cessaria e piuÁ utile di quante altre mai » 42. Qualche tempo dopo, sti-molato sempre dalle stesse letture, si dichiarava intenzionato a fre-
176
42 ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli, cit., p. 279. Sulla diffusione di Gravina nell'a-rea veneta, attraverso l'ampia sintesi che ne fece Scipione Maffei nel «Giornale dei Let-terati d'Italia » nel 1711, cfr. ora S. MAFFEI, Ristretto del Origine Juris Civilis di Gianvin-cenzo Gravina, a cura di G. DE MARTINO, La cittaÁ del Sole, Napoli 1999.
quentare le lezioni di diritto all'universitaÁ di Padova 43; eÁ dunque l'a-nalisi del saggio sulle origini di Cittanova, suscettibile peraltro dicompletamento attraverso uno studio sistematico dell'opera di Stefa-no Carli, che puoÁ fornire utili elementi alla nostra indagine. L'esame eÁtanto piuÁ interessante, in quanto al momento della stesura del lavorosu Cittanova erano trascorsi ormai trent'anni dalle prime letture gra-viniane e Gianrinaldo Carli stesso era ormai giunto a ripudiare Gra-vina attraverso la condanna degli enciclopedisti che riteneva fosserostati influenzati negativamente dallo storico e giurista napoletano 44.
L'impostazione complessiva della Lettera critica riprende il mo-dello offerto dalle Origines juris civilis nella parte in cui dominanoil razionalismo, il metodo critico, l'idea del primato della ragione eun'impostazione della ricerca erudita rafforzata da un notevole ap-porto interpretativo, che corrispondeva alla nuova concezione del sa-pere mutuata da Francesco d'Andrea 45. In Stefano Carli, come inGravina, si ritrova sostenuta implicitamente anche la necessitaÁ dellapreparazione filologica e della conoscenza delle lingue classiche 46,greco e latino, lingue che il nostro autore dimostrava di padroneggia-re in modo certo non superficiale. Ancora, si nota nello studioso ca-podistriano la consapevolezza della necessitaÁ di esaminare e di vaglia-re criticamente le fonti letterarie sulla base degli strumenti ausiliariofferti dalla cronologia e dalla geografia storica, due scienze che han-no una parte importante nella Lettera critica e che, rivalutate dall'U-manesimo, erano molto apprezzate nel corso di tutta la prima metaÁdel Settecento. Infine, Stefano Carli richiama esplicitamente l'operadi Philippe Cluver Introductio in universam geographiam 47, la cui let-
177
43 Cfr. supra, nota 3, p. 168.44 Il giudizio appartiene ad una fase avanzata del pensiero di Gianrinaldo Carli,
quando ormai veniva assumendo atteggiamenti nettamente conservatori, cfr. APIH, Rin-novamento e illuminismo, cit., p. 221.
45 C. GHISALBERTI, Gian Vincenzo Gravina giurista e storico, GiuffreÁ , Milano 1962,p. 27.
46 GHISALBERTI, Gian Vincenzo Gravina, cit., p. 28. Su questi temi anche F. LOMO-
NACO, Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo Gravina, Edizioni di Storia e Letteratura,Roma 2006.
47 P. CLUVER, Introductio in universam geographiam tam veterem quam novam libri6, Elzevira, Ludguni Batavorum 1624; cfr. CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 7v. Di Cluver
tura era consigliata da Gravina assieme al Rationarum temporum diDenis Petau 48.
Le dissonanze tra l'impostazione graviniana e la ricerca di StefanoCarli cominciano ad avvertirsi peroÁ sul piano dei contenuti e giaÁ nel rap-porto tra erudizione e interpretazione, che evidenzia i limiti del capodi-striano. La ricerca erudita, che Gravina considerava non tanto in sensomeramente sussidiario quanto in senso strumentale perche privilegiavacomunque l'apparato critico e interpretativo 49, rimaneva per Carli ilprincipale obiettivo, del quale non ipotizzava il superamento. Il metodoerudito-antiquario, che per Gravina appare giustificato nella prospetti-va utilitarista di cui si eÁ detto, in Carli veniva invece ulteriormente raf-forzato mediante una serrata struttura di passaggi logici che lo facevanoapparire fine a se stesso. Dove Gravina era giunto alla condanna delladegenerazione della casistica 50, Carli era ancora portato a indulgervi.
Una differenza significativa tra le posizioni di Gravina e quella diStefano Carli si rileva ad esempio in una considerazione del capodi-striano sul valore delle testimonianze dei poeti antichi: «Dovremoforse, dalla semplice loro asserzione fiancheggiati ciecamente crede-re? [...] No certamente. Imperocche Voi mi concederete che quandoi Poeti si oppongono diametralmente agli storici, si debbono semprealle poetiche immagini le descrizioni istoriche preferire. Anche Ome-ro e Virgilio quanti viaggi e quante strane vicende non ci rappresen-tano e dell'accorto Ulisse e del profugo Enea, che non solo ai fatti,ma eziandio alla Ragione disconvengono? Dunque alle loro fantasti-che rappresentazioni si dovraÁ cieca credenza prestare? » 51.
178
Stefano Carli conosceva anche l'Italia antiqua, opus tabulis geographicis aere expressis il-lustratum, Elzever, Ludguni Batavorum 1624, citata nella stessa Lettera critica, c. 2v.
48 D. PETAU, Rationarii temporum pars secunda, quae est technike, hoc est Cronolo-giae methodum, & historicorum temporum argumenta probationesque continet, Cramoisy,Parisiis 1636. Per l'interesse di Gravina per tali opere cfr. GHISALBERTI, Gian VincenzoGravina, cit., p. 42.
49 GHISALBERTI, Gian Vincenzo Gravina, cit., pp. 36, 39.50 GHISALBERTI, Gian Vincenzo Gravina, cit., pp. 48-49.51 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 9v. Il problema del ricorso alla poesia e dell'au-
toritaÁ di Omero era stato peraltro ampiamente affrontato da G. VICO, Principi di scienzanuova [1744], a cura di F. NICOLINI, Ricciardi, Milano-Napoli 1953, pp. 6 e 371 e se-guenti (si tratta del libro terzo: Della discoperta del vero Omero).
EÁ una considerazione netta che, pur essendo in parte attenuatanella sua categoricitaÁ dal significato dell'avverbio « ciecamente »,sembra ignorare la complessa teoria estetica di Gravina sulla poesiae, in particolare, sulla funzione della poesia antica nella didattica del-la storia: visione che portava al superamento della semplicistica con-trapposizione, ancora presente in Stefano Carli, fra storia e poesia eche accentuava invece il rapporto dialettico fra le due arti 52.
Appena piuÁ oltre si ritrova invece un'altra asserzione, che rifletteevidentemente la personale convinzione del nostro autore rivelandouna concezione antiquata in contraddizione intima con lo stesso me-todo critico-filosofico che apparentemente voleva perseguire. Discor-rendo del fiume Quieto afferma infatti: «Donde si possa trarre la eti-mologia di Quieto, lascio investigare agli Astrologhi: lo studio etimo-logico dipende per lo piuÁ dal capriccio e dall'azzardo, che non eÁ dallaragione, e dal fatto » 53.
« Ragione » eÁ quindi un termine che ricorre frequentemente inqueste pagine dedicate alle origini di Cittanova, in apparente coeren-za con l'impostazione complessiva del lavoro e certamente in osse-quio con la moda generalmente diffusa della cultura dei lumi: l'eti-mologia non eÁ « dettata dalla ragione » 54, e quindi non eÁ una scienza,i racconti di Omero e Virgilio « disconvengono alla ragione » 55 inquanto non paiono verificabili, e cosõÁ via.
Del tutto scontato eÁ invece un atteggiamento ricorrente cheoscilla fra paternalismo e retorica indulgendo anche alla banalitaÁ , co-me nel caso del principio solennemente affermato secondo cui « leasserzioni degli scrittori debbono essere anche daÁ fatti storici confer-mate » 56 e come il seguente passo in cui l'autore si rivolge diretta-
179
52 A. QUONDAM, Cultura e ideologia in Gianvincenzo Gravina, Mursia, Milano 1968,pp. 84-87 e 159-162. Si noti che il dibattito sull'uso della poesia e delle favole come fontistoriche fu assai vivace nella prima metaÁ del secolo e vide partecipi ad esempio, con Gra-vina, anche Giambattista Vico e numerosi esponenti del gruppo gravitante attorno a Ce-lestino Galiani. Si veda anche V. FERRONE, Scienza, natura, religione. Mondo newtonianoe cultura italiana nel primo Settecento, Jovene, Napoli 1982, pp. 378-382.
53 CARLI, Lettera critica, ms. cit., cc. 2v.-3r.54 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 3r.55 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 8v.56 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 17r.
mente a Rigo rimproverandolo per l'insistenza sull'identificazione diEmona con Cittanova: «Vi compatisco, perche non saprei se gli uo-mini troppo accecati dallo zelo per la propria patria sieno piuÁ ammi-rabili sacrificando o la vita stessa per diffenderla o la veritaÁ per esal-tarla » 57.
CioÁ puoÁ essere sufficiente per ritenere che, per quanto Carli sifosse dichiarato in un certo periodo della sua vita ammiratore di Gra-vina, certamente trent'anni dopo la lettura dell'opera del giurista estorico napoletano pochi erano gli spunti tratti da quelle letture an-cora riconoscibili nei suoi scritti sull'Istria. Si trattava per lo piuÁ diuna generica propensione per un metodo storico, in realtaÁ spesso an-che male interpretato, che si ricollegava alla metodologia della scuolaculta dell'Umanesimo, e che attraverso Gravina veniva forse rafforza-ta. Nulla piuÁ , quindi, che suggestioni, nel senso cioeÁ di un fenomenopsicologico per cui un convincimento o un'idea si era imposta allacoscienza di Stefano Carli per azione diretta o indiretta di un'altrapersonalitaÁ intellettuale.
Manca, a questo punto, un'analisi dell'altra sua opera nota, unatragedia, che potrebbe fornire elementi utili per completare il quadroe valutare la personalitaÁ del capodistriano. La tragedia in questione,intitolata Erizia, venne scritta intorno al 1753, quindi proprio all'epo-ca in cui leggeva Gravina, e venne pubblicata a Venezia nel 1765 58.Baccio Ziliotto, al quale si devono gli studi piuÁ completi sulla proble-matica carlina, accennoÁ soltanto a quell'opera riservandosi di com-pierne un esame dettagliato in altra occasione che peroÁ non si presen-toÁ . Ebbe modo di notare soltanto l'influenza che certamente dovetteesercitarvi Gianrinaldo Carli (all'epoca della stesura i rapporti tra idue fratelli erano ancora buoni), che sin dal 1746 aveva scritto unsaggio sull'Indole del teatro tragico moderno: uno scritto nel quale so-no stati ravvisati i segnali del rinnovamento dell'estetica e della dram-maturgia, contemporaneamente ad una rottura rispetto ai modellitradizionali, come si deduce anche dall'asserzione secondo cui « l'in-
180
57 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 33r.58 S. CARLI, La Erizia, tragedia nuova... dedicata alli Signori De Voltaire e Rousseau,
s.t., Venezia 1765.
dole del nostro teatro eÁ di cercare la commozione del cuore », conl'avvertenza che « di comune con l'antico abbiamo solo i sentimentiinnati, il pianto e il riso » 59.
Questi erano i motivi ispiratori dell'Erizia, che nonostante il di-scostarsi dalla precettistica aristotelica e l'indulgere ad elementi natu-ralistici (come del resto molta parte della produzione drammaturgicadell'epoca), sembra allontanarsi ancora una volta dal modello gravi-niano dove sono molto piuÁ presenti invece le tematiche classiciste.L'argomento dell'Erizia, una vicenda ambientata nel mondo musul-mano ove una giovane divenuta schiava dell'assassino di suo padrepreferisce morire piuttosto che sottomettersi, venne suggerito, comeeÁ stato tramandato, dallo stesso Gianrinaldo Carli. Stefano lo svilup-poÁ anche sulla base delle esperienze maturate durante il soggiorno aCostantinopoli 60. L'interesse per il mondo orientale, anche nel cam-po musicale, eÁ del resto caratteristico di quel periodo ± basti ricorda-re le Lettres persanes di Montesquieu 61 ± e ben si comprende il giu-dizio positivo sull'Erizia dato da Gaspare Gozzi, che ne mise in luceproprio il carattere orientaleggiante 62.
L'inedito di Stefano Carli sulle origini di Cittanova conferma al-lora sostanzialmente, attraverso l'analisi condotta, il valore dello stu-dioso che giaÁ era venuto delineandosi in precedenti indagini, fornen-do l'immagine di un erudito certo non originale nel suo pensiero, ditemperamento anche polemico 63 e indulgente al gusto per il ragiona-mento logico e alle mode del tempo.
181
59 ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli, cit., p. 286; I. CAVALLINI, Musica sentimentale eteatro della commozione. La poetica del melodramma nelle «Osservazioni sulla musica » diGianrinaldo Carli, « Recercare », 2 (1990), pp. 5-34, poi in ID., I due volti di Nettuno. Studisu teatro e musica a Venezia e in Dalmazia dal Cinquecento al Settecento, LIM, Lucca 1994.
60 CELLA, Carli Stefano, cit., p. 175.61 Un'idea sulla diffusione di questi interessi nell'ambito musicologico si ricava da I.
CAVALLINI, Musica e strumenti turchi in alcune fonti europee del XVIII secolo e l'«Histoi-re » di Charles de Blainville (1767), in Restauro, conservazione e recupero di antichi stru-menti musicali, Olschki, Firenze 1986, pp. 257-373.
62 ZILIOTTO, Del conte Stefano Carli, cit., p. 289.63 Nel manoscritto si trova pure un accenno polemico al saggio di F. ALMERIGOTTI,
Dell'estensione dell'antico Illirico ovvero della Dalmazia, in F. MANDELLI, Nuova raccoltad'opuscoli scientifici e filologici, XXVII, Occhi, Venezia 1775; cfr. CARLI, Lettera critica,ms. cit., c. 14r.
Quest'inclinazione si trasformava poi in un vero e proprio proget-to culturale, laddove in altri brani della Lettera critica il nostro autoreenunciava i suoi obiettivi progetti di ricerca, sempre riguardanti l'I-stria e Cittanova: «Da storici, da geografi, dagl'itinerari e da iscrizionisaraÁ la nostra ipotesi fiancheggiata riguardante l'antica Emona. Dellostesso calibro saranno pure tutti quegli altri materiali, coi quali nonsiamo lontani d'ultimare quell'edifizio che avraÁ per titolo: Lettera apo-logetica d'otto articoli proposti dal Co. Stefano Carli sopra la Orazionpanegirica fatta in lode di S. Pelagio da NiccoloÁ Bonicelli cittadino diZara, e sopra le annotazioni nella medesima inserite. Io ho destinatodi espor questa Apologetica, ma anonima, alla pubblica luce: e comesi rende necessario di premettersi alla medesima, per farne i dovuticonfronti, anche la Lettera critica (e questa pure senza nome) che dal-l'erudito Signor Bonicelli ai miei proposti articoli fuÁ fatta, cosõÁ deside-ro di sapere se per pubblicarla aver egli qualche obbietto potesse » 64.
Non era questo l'unico ambizioso progetto che, se mai vennerealizzato, non venne dato alle stampe; altrove il nostro autore ringra-ziava addirittura Rigo per avegli dato occasione, dovendo stendere laLettera critica, di distrarsi dalla sua occupazione principale relativa a« un'opera che ho quasi ordita la quale saraÁ intitolata: Dell'origine eprogressione dei nomi Italico ed Illirico, con cui si dimostreraÁ quali fu-rono i piuÁ antichi abitatori della nostra Italia, quali le loro leggi, i lorocostumi, quali nomi avesse l'Italia prima d'esser chiamata Italia; sistabiliraÁ la vera epoca del nome Italico: quale fu il primo luogoche questo nome assumesse, quale il tempo e il modo con cui sinoall'Arsa si estese, dal che ne risulteraÁ l'inganno di tanti illustri scrittorimorti e viventi, i quali hanno creduto che col nome Italia sia statosempre chiamato il bel Paese » 65.
Un lavoro impegnativo, che pare fosse stato portato a terminepoiche ad esso dovrebbe essere riferita una critica apparsa su « L'Os-servatore Triestino » a firma di tale Pietro Bachiocco 66. Invano Ste-
182
64 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 10r.65 CARLI, Lettera critica, ms. cit., cc. 35v.-36r.66 P. BACHIOCCO, Sopra l'antica Istria, « L'Osservatore Triestino », 1786, pp. 387-
389 e 583-584.
fano Carli avvertiva, come sempre dimentico della modestia, che « inquesta vasta e faticosa impresa qualche sbaglio prenderoÁ facilmenteanch'io; ma mi consolo che scrivo sopra materie nelle quali tanti altriprima di me hanno i loro inutili e mediocri genj impiegati; e per con-seguenza le loro opinioni esaminando e combinando potroÁ a quegliscogli sottrarmi, ne' quali pur troppo inavvedutamente essi urtarono.Mi dichiareroÁ peraltro moltissimo riconoscente e grato verso chiun-que si compiaceraÁ di manifestar anche i miei errori. Tutte le letterarieapplicazioni ad altro oggetto tender non debbono che ad iscuprirepiuÁ che si puoÁ quella veritaÁ , la quale quanto dall'amor proprio, dal-l'orgoglio e dal puntiglio si confonde e si offusca. Altrettanto gli ani-mi degli uomini ragionevoli dolcemente elettrizza, convince ed affe-ziona » 67.
Uno dei passi piuÁ interessanti della Lettera critica, che anche laconclude, contiene una valutazione dell'opera dell'abate AlbertoFortis 68, sinora sconosciuta. EÁ interessante notare, peroÁ , che a Stefa-no Carli i saggi di Fortis furono noti appena una decina di anni dopola pubblicazione e questo fatto, se accertato, rappresenterebbe un'ul-teriore conferma della marginalitaÁ di Capodistria rispetto ai circuitieditoriali e librari del tempo. Il brano tuttavia costituisce un raro do-cumento dell'accoglienza incontrata dall'opera di Fortis nell'ambien-te istriano e, nel caso particolare, in un lettore come Stefano Carli:« Per giunger al termine della mia Lettera apologetica mi mancano an-cora i due articoli VI e VII i quali sono dal mio Antagonista impu-gnati col rimettermi alla Dissertazione sopra Cherso ed Osero de Si-gnor Abate Fortis. Per dir il vero, questa dissertazione io non ho lettamai e per quanto l'abbia qui ricercata, non mi fu possibile di trovarla;sicche ho dovuto scrivere a Venezia perche mi si spedisca. Per soste-ner i detti miei due articoli mi sono giaÁ di tutti gli occorrenti materialiproveduto: ma prima di prevalermi di questi, desidero leggere la sug-
183
67 CARLI, Lettera critica, ms. cit., c. 36r.68 A. FORTIS, Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero, Milocco, Venezia
1771 e ID., Viaggio in Dalmazia, Milocco, Venezia 1774. Per il saggio su Cherso e Osserocfr. F. SURDICH, Il « Saggio di osservazioni sopra l'isola di Cherso e Osero » di Alberto For-tis, « Pagine Istriane », 1-2 (1987), pp. 49-58; per il Viaggio in Dalmazia si veda la riedi-zione di A. FORTIS, Viaggio in Dalmazia, a cura di E. VIANI, Marsilio, Venezia 1986.
gerita dissertazione per fare sopra della medesima que' riflessi che sa-ranno da me creduti i piuÁ necessari onde maggiormente dalle tenebrela veritaÁ si disgombri. Per dir il vero il Signor Abate Fortis eÁ un sog-getto di gran merito: scrittore brillante e purgato, di vasta erudizione,raro interprete della natura, che diletta ed istruisce. Pochi giorni so-no che ho letto, e con infinito piacere, il suo Viaggio in Dalmazia, ilquale da tutti gli uomini di buon senso deve esser, e giustamente, insommo pregio avuto. Ma finalmente tutti siamo uomini e per conse-guenza non dobbiamo dalla nostra opinione lasciarsi tanto inebriareda credersi infallibili; sicche non saraÁ da meravigliarsi se anche il Si-gnor Abate Fortis nell'accennata dissertazione si avraÁ su qualchepunto ingannato » 69.
Quest'impressione di Carli eÁ interessante, sia perche in parte dis-sonante dalle generali reazioni negative seguite alla pubblicazionedell'opera di Fortis 70, sia perche denota ancora una volta quell'inte-resse per il naturalismo che lo portava a sottolineare nell'autore ve-neziano il « raro interprete della natura », lo studioso cioeÁ che inda-gando sulla Dalmazia poneva attenzione per le tradizioni, i caratteridella popolazione, gli aspetti linguistico-dialettologici ma anche, di-versamente da quanto andava professando il nostro autore, la topo-nomastica e l'etimologia 71.
Dall'esame dell'inedito di Stefano Carli risultano cosõÁ altri ele-menti utili per una ricostruzione dell'ambiente culturale istriano difine Settecento: emerge l'interesse per il problema delle origini diCittanova, cioeÁ per un tema giaÁ intensamente studiato quarant'anniprima ma che continuava ancora ad appassionare gli eruditi locali;illumina sulla cultura di Capodistria alla fine dell'etaÁ veneta, un pe-riodo considerato di stasi culturale, che vedeva pochi intellettuali
184
69 CARLI, Lettera critica, ms. cit., cc. 36v-37r.70 CosõÁ G. PIZZAMIGLIO, Introduzione a FORTIS, Viaggio in Dalmazia, ed. a cura di
VIANI, cit., pp. XXI-XXII.71 Sugli interessi naturalistici di Fortis eÁ fondamentale oggi fare riferimento a L.
CIANCIO, Autopsie della terra. Illuminismo e geologia in Alberto Fortis (1741-1803),Olschki, Firenze 1995, con un'amplissima bibliografia alle pp. 293-372 e a L. WOLFF,Venezia e gli Slavi: la scoperta della Dalmazia nell'etaÁ dell'Illuminismo, tr. it., il Veltro,Roma 2006.
concentrati sulle patrie memorie e relativamente isolati dal contestoveneziano e dal resto della penisola.
Non mutano sostanzialmente questo quadro le poche notiziesull'affiliazione massonica di Stefano Carli; una fratellanza a dire ilvero piuttosto tarda, risalente all'epoca della seconda dominazionefrancese all'inizio dell'Ottocento. Il suo nome compare infatti neglielenchi dei membri di una loggia costituita a Capodistria per inizia-tiva del Grande Oriente d'Italia e oggetto di inquisizione da partedella polizia austriaca nel 1806 72. Tuttavia, a parte la difficoltaÁ dirintracciare informazioni sulle attivitaÁ di quella loggia che parrebbepiuÁ un'iniziativa occasionale che non il segnale di specifici interessiculturali (le fonti concordano sul fatto che era assai poco frequenta-ta), il nome dell'ormai anziano Carli compare soltanto in una o dueoccasioni e soprattutto per sottolineare il suo sentire antiaustriacoderivante da una condotta irriverente manifestatasi attraverso poesiee altri interventi.
Nel complesso, pur avendo limitato la nostra analisi a questobreve scritto, rimane l'impressione di uno studioso sovrastato dallafigura del piuÁ celebre fratello Gianrinaldo e legato ancora ad interessie metodi interpretativi antichi, dietro i quali rimaneva debole tracciadi temi ed entusiasmi giovanili per l'impegno non solo storiograficoma anche civile di Gian Vincenzo Gravina.
185
72 A. TAMARO, La loggia massonica di Capodistria (1806-1813), « Atti e Memoriedella SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », XXXIX (1928), pp. 108-111.
VII. - GIANRINALDO CARLI CONTRO LODOVICO AN-TONIO MURATORI: IL MEDIOEVO GORIZIANO,TRIESTINO E ISTRIANO NELL'OPERA DI ANDREAGIUSEPPE DE BONOMO
Di fronte all'ampia messe di studi riavviati a partire dagli anniNovanta del Novecento, il vasto epistolario di Gianrinaldo Carli eÁ ri-masto praticamente inesplorato 1. Tuttavia la storiografia italiana hariacquistato da tempo consapevolezza dell'importanza delle edizionidi fonti e, in particolare, degli epistolari settecenteschi, che rappre-sentano uno strumento prezioso per la ricostruzione dei complessirapporti fra gli intellettuali e per uno studio non piuÁ frammentarioed episodico della circolazione delle idee 2. Negli ultimi tre decennisi eÁ assistito con sempre maggiore frequenza ad iniziative sistemati-che di recupero del patrimonio epistolare, a partire dall'edizione, tut-tora in corso, dei carteggi di Muratori per iniziativa del Centro di stu-
186
1 Lo studioso al quale si deve il maggior contributo alla conoscenza di Carli nelcontesto della cultura italiana dei lumi eÁ Franco Venturi, che di lui ha trattato ampia-mente nei volumi del Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria, Einaudi, Torino1969 e V/1, La Lombardia delle riforme, Einaudi, Torino 1987. Su questa scia si eÁ mossoFERRONE, I profeti dell'Illuminismo, cit., pp. 305-308 e 420 che (nonostante ne dichiariun'origine dalmata) lo ha proposto assieme agli illuministi settentrionali quale figura diconfronto con la cultura meridionale nel quadro della nuova stagione politica degli anniOttanta del Settecento.
2 Si veda il quadro offerto in POSTIGLIOLA (a cura di), Epistolari e carteggi del Set-tecento, cit., in particolare alle pp. 7-24.
di muratoriani di Modena 3. Si tratta di progetti che dovrebbero es-sere estesi anche ad altri contesti storici, riferibili sempre al XVIII se-colo, pure di ambito regionale; e che potrebbero sopperire alla ne-cessitaÁ di ricorrere ancora troppo spesso a documenti dispersi enon facilmente accessibili, con il conseguente ricorso a metodologiee iniziative « artigianali » 4. Le edizioni di carteggi e di epistolari delSettecento, che per Trieste e l'Istria continuano a mancare, potrebbe-ro rimediare all'episodicitaÁ che si riscontra ancora nelle pubblicazionilocali di fonti e riuscirebbero a fornire un quadro molto piuÁ chiarodei rapporti degli intellettuali della regione con la cultura del lorotempo.
Il caso Carli rientra a pieno titolo in questo quadro e si avvia adiventare paradigmatico. Si tratta infatti del patrimonio documenta-rio riguardante una figura di spicco del Settecento italiano che non sipresta certo a semplici regionalismi e che, anzi, contribuisce a illumi-nare l'opera di molti protagonisti della cultura europea dei lumi.
Da una parte, infatti, i suoi carteggi sono stati ampiamente riva-lutati e utilizzati nel corso del Novecento, dapprima sulla scia del cli-ma culturale di stampo patriottico e irredentistico che all'indomanidel primo conflitto mondiale sollecitava la riscoperta delle patrie glo-rie e la necessitaÁ di documentare il legame stretto fra la cultura giu-liana e istriana e quella della penisola. L'edizione del carteggio fraGianrinaldo Carli e Girolamo Gravisi, curata da Ziliotto tra il1908 e il 1913 5, e quella del carteggio fra Carli e Pietro Verri, pro-posta da De Stefano nel 1933 6, non sono che alcuni esempi di questadinamica, cui va ad aggiungersi l'interessante carteggio fra Carli e ilcancelliere Kaunitz edito nell'immediato secondo dopoguerra ± non
187
3 Il primo volume del carteggio venne pubblicato nel 1975 e contiene il carteggio diMuratori con Francesco Arisi; l'ultimo pubblicato eÁ F. MARRI (a cura di), Carteggio conBotti... Bustanzo, Olschki, Firenze 2003.
4 SALIMBENI, Per l'edizione dei carteggi, cit., pp. 287-295; a lui si deve un primo bi-lancio delle edizioni e degli studi sui carteggi nella regione.
5 ZILIOTTO, Trecentosessantasei lettere, cit.6 F. DE STEFANO, Cinque anni di sodalizio tra Pietro Verri e Gian Rinaldo Carli
(1760-1765). Con ventiquattro lettere inedite di Pietro Verri, « Atti e Memorie della So-cietaÁ istriana di archeologia e storia patria », XLIV (1933), pp. 43-103.
a caso mentre la questione di Trieste e dell'Istria rimaneva ancora di-battuta ± da Umberto Marcelli 7. Coronamento di queste e di altreiniziative, nonche nuovo stimolo per ulteriori indagini, fu poi la pun-tuale e analitica ricerca di Elio Apih sugli anni della formazione cul-turale del capodistriano, avviata sulla scia delle suggestioni offerte daFranco Venturi che aveva incluso un ritratto del personaggio nellaraccolta da lui curata sugli Illuministi italiani 8. Infine, nel 1979, altrepiccole parti dell'epistolario carliano vennero pubblicate dallo stessoApih 9.
Dall'altra parte, questo fervore di iniziative si eÁ confrontato, pertutta la seconda metaÁ del Novecento, con le vicissitudini del lascitoCarli giaÁ depositato presso l'Archivio antico del municipio di Capo-distria, che ne hanno limitato fortemente l'accessibilitaÁ . Le vicendedell'archivio, esposto ai pericoli del secondo conflitto mondiale, ri-masero collegate a quelle della cittaÁ di Capodistria, passata nel1945 sotto l'amministrazione provvisoria jugoslava e definitivamente,dal 1954, sotto la sovranitaÁ della Repubblica Federativa di Jugoslavia.Depositato a Venezia presso il locale Archivio di Stato, eÁ rimasto alungo materia di contenzioso fra lo Stato italiano e la Jugoslavia primae la repubblica di Slovenia poi, assieme a gran parte delle opere d'artetrasferite in altre zone d'Italia durante il conflitto e non piuÁ tornatenei luoghi originari. Con la conseguenza che il materiale documenta-rio originale rimase ± e rimane ancora oggi ± inaccessibile agli studio-si, che solo dagli anni Settanta hanno cominciato a poterne consultareuna copia in microfilm presso l'Archivio di Stato di Trieste.
GiaÁ questi problemi oggettivi, legati ad un passato e ad un pre-sente politico spesso travagliati, fanno comprendere le difficoltaÁ cui
188
7 U. MARCELLI, Il carteggio Carli-Kaunitz (1765-1793), « Archivio storico italiano »,CXII, 3 (1955), pp. 388-407 e pp. 552-581; CXIV, 1 (1956), pp. 118-135; 4 (1956), pp.771-788.
8 F. VENTURI (a cura di), Illuministi italiani, VII, Riformatori piemontesi, lombardi etoscani, Ricciardi, Milano-Napoli 1967.
9 Il riferimento eÁ a APIH, Un carteggio inedito fra Gian Rinaldo Carli e l'abate Giu-seppe Bini, cit:, ID., Rinnovamento e illuminismo, cit. Si veda anche la piuÁ recente e piuÁcompleta anche se sintetica voce biografica di ID., Carli Gian Rinaldo in Dizionario bio-grafico degli italiani, voce cit., pp. 161-167.
sono andati incontro gli editori del carteggio di Carli. Va tenuto con-to peroÁ anche del fatto che da un punto di vista archivistico l'episto-lario carliano pone ulteriori problemi nella consultazione e nell'utiliz-zazione, essendo distinto in due parti; quella delle lettere originali eautografe, di Carli e dei suoi corrispondenti, e quella della Corrispon-denza scientifico-letteraria, che consiste in un ampio copialettere nelquale vennero trascritte gran parte delle missive in vista di un'edizio-ne a stampa, con la conseguente dispersione degli originali. A questodato si aggiunge il fatto che le lettere trascritte nella Corrispondenza,come eÁ stato accertato, recano alterazioni, modifiche e falsificazioni« d'autore » di varia natura, formale e sostanziale 10. Infine occorrericordare anche che, come sovente accade per i fondi archivistici co-stituiti direttamente dagli interessati, tutta l'attuale consistenza dell'e-pistolario eÁ il risultato di una selezione compiuta da Carli stesso invita 11.
Ora, se i carteggi Verri-Carli e Carli-Kaunitz si rivelano utili so-prattutto per studiare l'opera letteraria e l'attivitaÁ amministrativa delcapodistriano, e se soltanto l'epistolario con Girolamo Gravisi, essen-do sostanzialmente omogeneo e non presentando particolari lacune,ci puoÁ restituire un quadro sufficientemente completo degli interessisulla storia dell'Istria di Carli, lo stesso non si puoÁ dire per quantoriguarda invece altri settori d'indagine del nostro personaggio. Le let-tere sinora pubblicate, ad esempio, poco o nulla ci dicono sulla ge-nesi e sugli echi delle Lettere americane 12 o sui posteriori interessieruditi di Carli che avrebbero portato alla compilazione delle Anti-chitaÁ italiche. Le preziose edizioni delle lettere all'abate Bini e dell'u-
189
10 Su questo punto richiamava l'attenzione giaÁ APIH, Rinnovamento e illuminismo,cit., pp. 221-222; piuÁ specificamente A. TRAMPUS, Tra assolutismo e lumi: l'Antico Regi-me e il regno delle discontinuitaÁ, una premessa, in ID. (a cura di), Gianrinaldo Carli nellacultura europea del suo tempo, cit., pp. 7-14.
11 EÁ appena il caso di notare che evidentemente Carli ebbe tutto l'interesse a con-servare e a far trascrivere solo le lettere di elogio o il cui contenuto non poteva comun-que ledere la sua fama di studioso.
12 A tale proposito si veda l'edizione G. CARLI, Delle lettere americane, a cura di A.ALBONICO, Bulzoni, Roma 1988 e in particolare l'utilizzazione del carteggio nell'ampiosaggio introduttivo dedicato a L'America, il mondo antico e il buon governo in Gianrinal-do Carli (pp. 11-121).
nica conosciuta a Muratori, curate da Apih 13, riguardano un periodoanteriore al 1770 e mancano quindi ancora riferimenti precisi, trattidall'epistolario, utili per inquadrare meglio l'attivitaÁ e le opere del ca-podistriano dopo gli anni Settanta del Settecento, cioeÁ dopo la gran-de stagione del dibattito politico che accompagnoÁ la pubblicazionedell'Uomo libero e il pensionamento di Carli dall'amministrazionemilanese.
Un contributo alla conoscenza di queste vicende, che documentai rapporti di Gianrinaldo Carli con gli intellettuali giuliani e svela inparte la fitta rete di corrispondenze che precedette la « nascita e l'in-fanzia » delle AntichitaÁ italiche 14, viene dallo studio di un carteggiominore ± pubblicato in appendice ± quale quello fra il triestino An-drea Giuseppe de Bonomo e il giaÁ celebre autore di saggi sulla que-stione monetaria. Si tratta di una parte di un carteggio originariamen-te piuÁ ampio, che si eÁ conservata attraverso le trascrizioni della Cor-rispondenza scientifico-letteraria e che eÁ composta, allo stato attuale,dalle sole lettere di Bonomo. Mancano quindi le risposte di Carli,ciononostante i documenti gettano un po' di luce sui rapporti del ca-podistriano ± ormai da lunghi anni divenuto milanese ± con Trieste 15
e sul contributo degli eruditi della regione alla raccolta di documen-tazione per la stesura delle AntichitaÁ italiche. Un contributo che ridu-ce ulteriormente l'immagine di una Trieste settecentesca cultural-mente isolata e che consente di indagare sul rapporto fra intellettualied eruditi, dove per erudizione si intende ± crocianamente ± un usodella storia non limitato alla semplice idea di documentare cronolo-
190
13 Le lettere di Carli a Bini risalgono agli anni 1738-1739, quella a Muratori eÁ del 16febbraio 1742; cfr. APIH, Capodistria nel '700, cit., pp. 514-520; ID., Un carteggio ineditofra Gian Rinaldo Carli e l'abate Bini, cit., e ID., Corrispondenti istriani dell'abate G. Bini,cit. Altri riferimenti in ID., Sui rapporti tra Istria e Friuli nell'etaÁmoderna, « Atti del Cen-tro di ricerche storiche di Rovigno », V (1974), pp. 129-138.
14 SESTAN, Le «AntichitaÁ italiche », cit., p. 26.15 Tracce di rapporti di Carli con altri esponenti dell'ambiente culturale ed econo-
mico del Litorale si rinvengono occasionalmente nell'epistolario; cosõÁ in una lettera, ine-dita, del conte Enrico di Auersperg datata Trieste 1767 nel citato fondo Carli (carte nonnumerate) e ancora in una corrispondenza del dicembre 1768-gennaio 1769 con Pasqua-le de Ricci; di contatti con il barone Pietro Antonio Pittoni, direttore di polizia, si trovatraccia nelle lettere qui pubblicate in appendice.
gicamente e acriticamente i secoli precedenti, ma volto a riordinareconsapevolmente il passato, dandogli una fisionomia che doveva ser-vire a comporre l'identitaÁ di una regione, il Litorale Austriaco, e diuna cittaÁ , come Trieste, di recente fondazione.
Un ulteriore elemento di riflessione riguarda gli echi dell'operapolitica e storiografica di Carli, che restano ancora da indagare siste-maticamente ma che appaiono, giaÁ da queste prime fonti, di un certointeresse e depongono senz'altro in favore di un ambiente cultural-mente vivace, nel quale erano note non solo le opere storiche del ca-podistriano. Lo stesso governatore del Litorale, Karl von Zinzendorf,ebbe modo di leggere a Trieste L'uomo libero, lasciandone un giudi-zio critico di notevole interesse: « 1. de May. J'ai fini hier l'ouvragedu comte Carli de Milan L'uomo libero. Dans le dernier chapitreVIeÁme LibertaÁ naturale-diritto di proprietaÁ, il attaque les eÂconomisteset encense le systeÁme reglementaire bien maladroitement. Il preÂtendque la proprieÂte naturelle, la libre disposition des produits de mesterres ne peut s'eÂtendre qu'aÁ mes besoins personel. Que ma proprie -te aÁ l'eÂgard de tout ce qui passe mes besoins physiques n'est pointnaturelle, mais seulement leÂgale, c'est aÁ dire sujete aux dispositionsdu gouvernement, qui peut limiter ma libre disposition de mes pro-duits, lorsque le bien public paroit l'exiger. Si l'auteur avoit vouluanalyser mieux son ideÂe, l'aprofondir davantage, il n'eut pas deÂrai-sonne de la sorte. Il eut vuà que la nature a pourvuà aussi par ses loixeÂternelles aÁ la distribution de cette partie de mes revenus qui passemes besoins physiques, sans que les rois soyent chargeÂs de ce soin,et que si par malheur la nature avoit manque aÁ cette taÃche, aucun le-gislateur n'est d'y suppleÂer. Les rois gouvernent ordinairement si malleurs propres affaires, comment seroient ± ils chargeÂs de diriger endeÂtail les affaires des autres » 16.
Ad un intellettuale come Zinzendorf, maturato culturalmente traJena e Vienna 17, non poteva certo sfuggire l'esito della teorizzazionecarliana del diritto di proprietaÁ , che ai suoi occhi finiva per trasfor-
191
16 HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, TagebuÈcher, Bd. 25, c. 72r.-v.,sub 1 maggio 1780.
17 Sulla personalitaÁ di Zinzendorf si veda quanto scritto nel cap. V.
mare lo Stato patrimoniale del principe in una sorta di Stato di po-lizia 18.
Se questa fu una reazione all'opera politica del capodistriano, di-versa fu la natura dei rapporti tra Carli e Andrea Giuseppe de Bono-mo, un personaggio di statura culturale ben diversa da Zinzendorf,limitato sostanzialmente da una carriera tutta svolta in sede locale,ma lodato e stimato da Carli e divenuto per lui il riferimento piuÁ im-portante, al di fuori dell'Istria, per le ricerche documentarie nell'areagiuliana.
Andrea Giuseppe de Bonomo-Stettner 19 era nato a Trieste il 21novembre 1723 da Cristoforo, appartenente ad antica e nobile fami-glia cittadina 20, e Margherita Lichstock de Lichtenein; aveva studia-to dapprima nella propria cittaÁ con la guida dei padri gesuiti dal 1734al 1739 21 e successivamente ± a quanto riferiscono, concordi, le fonti± aveva studiato giurisprudenza laureandosi, forse a Vienna, in utro-que jure nel 1743 22. Tornato nella cittaÁ natale fu praticante nello stu-dio dell'avvocato Antonio dell'Argento 23 e nel 1748 venne ammesso
192
18 Per i princõÁpi informatori del sistema giuridico che giustificava in quest'ottical'assolutismo illuminato cfr. C. GHISALBERTI, Dall'antico regime al 1848, Laterza, Ro-ma-Bari 1987, pp. 31-60 che, non a caso, cita espressamente l'opera di Carli e inoltreA. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico, Giuf-freÁ , Milano 1979, pp. 296-302.
19 Si firmoÁ correntemente Andrea Giuseppe de Bonomo o soltanto Andrea Giusep-pe Bonomo e cosõÁ saraÁ nel prosieguo indicato; la forma piuÁ estesa del cognome nascedall'aggiunta del nome della famiglia Stettner nella metaÁ del Cinquecento a seguitodel matrimonio di Giuseppe Maria de Bonomo (1533-1572) con Maria di Andrea deStettner, ultima discendente della sua famiglia (cfr. DE JENNER, Genealogie delle XIII Ca-sade, I, ms. cit. in ADTs, segn. 1/1 B1).
20 Notizie biografiche dettagliate su Bonomo e la sua famiglia, prive peroÁ di indi-cazione delle fonti, sono fornite da L. DE JENNER, Biografie triestine, ms. in ADTs, segn.1/1 B 4, cc. 146r-v; si sa per certo, comunque, che de Jenner pote accedere verso il 1845a documenti familiari conservati da discendenti in linea femminile.
21 CosõÁ DE JENNER, Biografie triestine, ms. cit.; cfr. anche Annuae Collegij Tergestini1722-1772, ms. in ADTs, segn. 2 D 17, carte non numerate.
22 CosõÁ ancora DE JENNER, Biografie triestine, ms. cit. e ID., Genealogie delle XIII Ca-sade, I, ms. cit.; si veda ancora P. BONOMO, I Bonomo, Collegio araldico, Roma 1935, p.56 e ID., Florilegio gentilizio, Tip. del Seminario, Padova 1956, p. 54.
23 DE JENNER, Genealogie delle XIII Casade, ms. cit. Causa della dispersione dei do-cumenti e dell'archivio di Bonomo, nonche della sua biblioteca composta da un migliaiodi volumi, non fu soltanto l'insensibilitaÁ dei discendenti, ma anche l'abnorme modo di
nel Consiglio maggiore dei Patrizi 24. Fino al 1754 circa fu alle dipen-denze del Comune e dopo tale data inizioÁ la carriera in seno all'am-ministrazione dello Stato, dapprima presso il Capitanato civile e mi-litare e Intendenza Commerciale, poi presso il Cesareo Regio Gover-no del Litorale, istituito nel 1776 25. Dal 1755 fu membro del collegiodel Tribunale mercantile di prima istanza, nel 1760 divenne cancel-liere e giudice cesareo, nel 1769 attuario presso il Tribunale mercan-tile di seconda istanza, nel 1770 aggiunto Provisore di SanitaÁ . Nel1776 raggiunse il culmine della carriera come Magistrato di SanitaÁe morõÁ celibe il 2 gennaio 1797, facendo estinguere con se la sua ca-sata 26.
Benche coetaneo di Carli, Bonomo non ebbe modo di conoscer-lo prima della maturitaÁ ; sicuramente non lo frequentoÁ in gioventuÁ neÂnegli anni dello studio universitario, perche mentre sappiamo cheCarli si laureoÁ a Padova, molta incertezza rimane circa l'ateneo incui studioÁ Bonomo, che non fu Padova ma probabilmente Vienna 27.In realtaÁ , conosciamo pochissimo sulla gioventuÁ e sulla formazione diBonomo; le notizie mancano prima del 1754 e scarseggiano fino al
193
operare degli studiosi di storia locale nell'Ottocento. L'esempio si ha in Luigi de Jenner(circa 1850) quando scrisse che Bonomo « copriva le cariche enunciate con tutt'attivitaÁ ,nemico del fasto; non peroÁ privo d'una grande ambizione (solita passione degli uominidi carica) e troppo credulo alli racconti per tradizione: motivo per cui in alcune sue me-morie sulle famiglie da lui scritte (che divennero preda del fuoco per mia volontaÁ) rav-visai un monte di menzogne e falsitaÁ , che stimai dannoso di tramandare memoria pernon addossargli dei nemici sul suo sepolcro e cioÁ lo feci di certa scienza avendone presaconoscenza dell'origine ed azioni d'ognuna delle famiglie fin dal suo principio di domi-cilio in questa cittaÁ . CioÁ lo scrivo se a caso sortisse alla luce qualche altro parto consimilea quello, ovvero copia su tal particolare. Concludo per fine che la sua opinione era, odalmeno faceva credere, essere la sua famiglia l'unica degna di lode ed onore; ed eÁ benfacile che abbia voluto che in lui si estingua vivendo celibe, onde nessuno partecipi odevii da' suoi antenati » (L. DE JENNER, Famiglia Bonomo, ms. in ADTs, segn. 22 C 1,cc. 49-51).
24 Si veda anche il Liber aureus Civitatis Tergesti ab anno 1582, ms. in ADTs, segn.û A 2, carte non numerate.
25 Sul tema COVA, Nota per una storia, cit., p. 5.26 Il testamento datato 17 agosto 1796 eÁ in ASTs, Archivio Notarile, Testamenti,
busta 579, nr. 573.27 Il suo nome non risulta infatti fra quelli dei triestini laureati a Padova, cfr. COSTA,
Studenti foroiuliensi, cit., pp. 185-248.
1775 circa. Non sappiamo nemmeno quali e quante lingue, da impie-gato dell'amministrazione asburgica, conoscesse, anche se alcuni rife-rimenti nei suoi scritti lasciano intendere che praticasse la lingua te-desca 28. A fronte di tale scarsitaÁ di testimonianze, apprendiamo peroÁche la sua attivitaÁ erudita non fu quantitativamente disprezzabile eche egli godette in vita di numerosi e pubblici riconoscimenti 29. Nel-l'Ottocento, invece, la sua opera venne quasi completamente dimen-ticata, a differenza di quella piuÁ modesta del coetaneo Aldrago dePiccardi, se si escludono i brevi riferimenti dati da Pietro Kandler 30.Soltanto nella seconda metaÁ del Novecento gli eÁ stata dedicata nuovaattenzione e, dopo i primi accenni di Giulio Cervani 31, gli studiosihanno riconosciuto proprio in Bonomo l'iniziatore degli studi localisull'alto e basso Medioevo 32.
Bonomo diede la prima dimostrazione di attitudine per la ricercastorico-erudita dopo che gli venne conferito l'incarico di riordinarel'antico archivio comunale, detto della Vicedomineria, a seguito dellariorganizzazione delle strutture municipali avvenuta con la Hauptre-
194
28 Sostiene l'ignoranza della lingua tedesca P. KANDLER, Discorso sulle storie di Trie-ste, in SCUSSA, Storia cronografica di Trieste, cit., p. 186; diversamente peroÁ si veda A.G.DE BONOMO, Sopra le monete de' vescovi di Trieste, Stamperia del governo, Trieste 1788,pp. 29-30.
29 Si veda ad esempio R. CORONINI DE CRONBERG, Operum miscellaneorum tomusprimus, Zatta, Venezia 1769, p. XI, nota d. Nel 1791, inoltre, in riconoscimento dellasua attivitaÁ di studioso la cittaÁ di Trieste gli cedette gratuitamente un terreno vicino allasua villa, cfr. E. PAVANI, Il podere di Triestinico ed i Bonomo, « Archeografo Triestino »,s. II, XIV (1888), pp. 328-329.
30 Kandler scrisse su Bonomo oltre che nel Discorso sulle storie di Trieste, cit., an-che in alcune note che pose in apertura del manoscritto originale di Bonomo sui dirittiaustriaci sull'Istria (ADTs, segn. 12 B 4/1) e di un manoscritto sulla storia della famigliaBonomo (ADTs, segn. û CC 12). Da segnalare anche un breve cenno biografico in P.STANCOVICH, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, III, Marenigh, Trieste 1829, pp.221-222. Per la figura di Piccardi vedi infra, cap. VIII.
31 G. CERVANI, Appunti per una storia della storiografia triestina, « Annali Triesti-ni », XIX, 1-2 (1949), pp. 67-73.
32 M.L. IONA, Il Codice diplomatico istriano: realtaÁ e problemi, in F. CROSARA (a curadi), Studi kandleriani, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, Trieste 1975, p.132. Un riferimento a Bonomo era stato fatto giaÁ da G. ROSSI SABATINI, L'interpretazionedel medioevo nella storiografia triestina dell'Ottocento, in Scritti in onore di Camillo deFranceschi, cit., p. 155.
solution del 1748 33. PortoÁ a termine l'impresa con l'aiuto di Aldragode Piccardi redigendo alla fine, di proprio pugno, un Inventario dellescritture esistenti nelle Segrete dell'Archivio Pub[lic]o 34 che ancora siconserva.
Vi sono descritti sommariamente i documenti pergamenacei ecartacei, assieme ai dati relativi alla collocazione data da Bonomo ePiccardi. Il riordino sembra essere stato compiuto casualmente, senzaun criterio diplomatico, tanto che oltre un secolo dopo Pietro Kan-dler avrebbe scritto che i due avevano « disposto con metodo bizzar-rissimo, seppure poteva dirsi sistema », al punto da supporre che « ladisposizione materiale recava la prova che gli ordinamenti [...] non fu-rono portati a compimento » 35. L'impressione di Kandler eÁ certa-mente riduttiva perche appare plausibile che l'opera di Bonomo e Pic-cardi si fosse limitata ad una semplice ricognizione e inventariazionedel materiale esistente, compiuta senza alterare la disposizione origi-naria ± quella sõÁ forse casuale ± dei documenti. Non si spiegherebbealtrimenti il fatto che ancora vent'anni piuÁ tardi, nel 1771, Bonomo ePiccardi vennero chiamati a dare nuova relazione di quei lavori, ondepoter iniziare a « ridurre in miglior ordine l'archivio medesimo » 36.
Anche se quel riordinamento non dovette essere di grande rilievoarchivistico, esso tuttavia fu di ben altro valore e significato per lamaturazione culturale di coloro che vi si erano impegnati. PortoÁ in-fatti in Bonomo e Piccardi una maggiore consapevolezza dell'impor-tanza della ricerca e della conservazione delle fonti manoscritte, non-che del loro uso critico. Al punto che Piccardi compiloÁ per le propriericerche quel Codice Piccardi che ancora oggi eÁ noto agli studiosi delMedioevo triestino per i documenti che vi sono trascritti 37, mentre
195
33 Sinteticamente PAVANELLO, Sugli organi giurisdizionali, cit., pp. 71-73.34 Il manoscritto eÁ in ADTs, segn. û E 8.35 P. KANDLER, L'archivio diplomatico, in ID., Raccolta delle leggi, ordinanze e rego-
lamenti speciali per Trieste (conosciuta anche come Raccolta Conti), Tip. del Lloyd Au-striaco, Trieste 1861, p. 2.
36 Documento conservato in copia in ADTs, segn. 18 F 6, Protocollo dell'Inclita Ce-sarea Regia Economica Comissione, datato 27 luglio 1771.
37 Il codice ms. reca il titolo Privilegij, consegli, instromenti, lettere, informationi,agiustamenti etc., in ADTs, segn. a B 4.
Bonomo preparoÁ per proprio uso una raccolta che riuniva copie didocumenti risalenti al periodo fra il 911 e il 1463 38. Quest'ultima sipresenta come un codice, privo di titolo, contenente la semplice tra-scrizione non commentata (e a volte in realtaÁ anche scorretta) degliantichi diplomi esistenti nell'archivio che aveva riordinato. Privacom'eÁ di note critiche o esplicative non rivela molto, a dire il vero,sugli effettivi interessi eruditi e sulle capacitaÁ analitiche di Bonomo.PuoÁ essere interessante tuttavia notare il fatto che la compilazioneavveniva a pochi anni di distanza dalla pubblicazione delle murato-riane Antiquitates Italicae Medii Aevii, opera sicuramente nota altriestino, che l'avrebbe indicata a modello negli scritti degli annisuccessivi.
Se si eccettuano un estemporaneo saggio poetico 39 e l'attivitaÁsvolta nell'esercizio della professione 40, sembra che il completamen-to della formazione culturale di Bonomo giungesse con la fondazionedell'accademica degli Arcadi Romano-Sonziaci, cioeÁ con la nascitadella prima istituzione culturale dell'area goriziana e triestina. In real-taÁ , la frequentazione dell'accademia servõÁ a Bonomo soprattutto co-me occasione di stimolo intellettuale e di divulgazione delle propriericerche, fornendogli quello spazio pubblico che fino ad allora eramancato. Accolto il 25 aprile 1784 con il nome accademico di Orni-teo Lusanio, Bonomo si impegnoÁ in un'intensa attivitaÁ che gli con-sentõÁ, nonostante fosse giaÁ noto in ambito regionale per i suoi interes-si storici, di trovare nuovi interlocutori 41.
196
38 Ms. autografo senza titolo, con alcune aggiunte di Domenico Rossetti, in ADTS,segn. a B 3, composto di 37 cc.
39 BONOMO, I Bonomo, cit., p. 57 gli attribuisce il libretto Per le auspicatissime nozzedel conte Faustino Martinelli con la gentile Tullia Bonomo. Il Mazzolino (anacreontica,due madrigali e tre sonetti), Tip. Castion, Portogruaro 1756 che non ho potuto rintrac-ciare. L'attribuzione eÁ fatta sulla base di G. VALENTINELLI, Bibliografia del Friuli, Tip. delCommercio, Venezia 1861, p. 288.
40 Bonomo fu compilatore nel 1777 di un foglio periodico edito dal governo localecon il titolo Portate de' bastimenti (cfr. PAGNINI, Il periodo triestino, cit., p. 161), mentreCOMBI, Saggio di bibliografia istriana, cit., p. 302 gli attribuisce un Almanacco ecclesiasti-co, storico, politico, commerciale di Trieste, Stamperia del governo, Trieste 1791.
41 La sua iscrizione fra i soci dell'accademia eÁ annotata con il numero 99 nel qua-derno che si conserva ms. in BCTs, segn. R. P. MS 3-26/1.
GiaÁ in quello stesso anno ebbe modo di partecipare alle discus-sioni accademiche attraverso un saggio che venne pubblicato pochimesi dopo (1785) inserito nell'opera di Rodolfo Coronini, Dell'anticamoneta goriziana 42. Nella premessa l'editore ringraziava Bonomo,« antico conoscente ed amico », che aveva dato «motivo a Sua Eccel-lenza il signor Rodolfo Coronini conte di Cronberg di compilare lapresente dissertazione epistolare » 43, nella quale trovavano quindiposto i puntuali interventi del triestino, accurati e informati dal pun-to di vista bibliografico, su argomenti storici e in particolare numi-smatici. CosõÁ Bonomo legava il proprio nome a quella che eÁ ricono-sciuta come la prima pubblicazione in ambito regionale sulla mone-tazione antica e sulla numismatica goriziana 44, avvicinandosi ad unaormai consolidata tradizione di studi storici ed economici sulle mo-nete che tanta fortuna aveva nel Settecento 45.
Di maggior impegno eÁ il suo successivo studio Sopra l'origine de-gli antichi Conti di Gorizia 46, edito pure nel 1785 e anch'esso proba-bilmente concluso giaÁ l'anno precedente, tanto che il 27 febbraio1785 nella riunione a Gorizia del « Saggio collegio dell'arcadica nostraAccademia », « distribuiti furono, tra i comuni applausi, gli esemplaridell'opera dell'inclito ed erudito Orniteo Lusanio signor Andrea Giu-seppe Bonomo nostro accademico dimorante in Trieste Sopra l'origi-ne degli antichi conti di Gorizia, dedicata all'inclito, magnanimo ederudito nostro Vice-custode », cioeÁ il conte Guidobaldo Cobenzl 47.
197
42 R. CORONINI, Dell'antica moneta goriziana, lettera prima dedicata all'illustrissimosignore Guidobaldo conte di Cobenzl, Tommasini, Gorizia 1785. Il promemoria e la let-tera di Bonomo sono alle pp. 73-82.
43 CORONINI, Dell'antica moneta, cit., p. 73.44 I. AHUMADA SILVA, Le monete dei conti di Gorizia e del Tirolo del Museo Provin-
ciale di Gorizia, « Annali di storia isontina », 1 (1986), p. 77.45 Ampi riferimenti sul tema in VENTURI, Settecento riformatore, I, cit., pp. 443-522.46 A.G. BONOMO, Sopra l'origine degli antichi conti di Gorizia, Stamperia del gover-
no, Trieste 1785. Il testo venne pubblicato anonimo ma un esemplare con aggiunte ma-noscritte dell'autore si trova presso in BCTs, segn. R.P. MISC. 3-3483. Il libretto venneristampato in «Archeografo Triestino », s. I, III (1831), pp. 343-383 (cfr. pure COMBI,Saggio di bibliografia istriana, cit., p. 160, che indica erroneamente come autore il nomedi Giuseppe Brignoli).
47 CosõÁ da un foglio volante a stampa (Tip. Tommasini, Gorizia 1785) di cui si con-serva un esemplare in BCTs, segn. R. P. MS 3-26/10.
Saldezza ed ampiezza dell'argomentazione, capacitaÁ di impostaree di svolgere un delicato e complesso problema critico sono i caratteriprincipali di questo lavoro che intendeva dare un contributo al dibat-tito storico ± nemmeno oggi del tutto risolto ± sull'origine degli anti-chi conti di Gorizia nell'XI secolo. Del resto giaÁ in apertura l'autoredichiarava onestamente, e anche un po' ingenuamente, di voler pro-porre una proposta chiarificatrice « fondata sopra ragionevoli conget-ture » 48; affermazione alquanto autoriduttiva, poiche in realtaÁ l'espo-sizione rivela piuÁ di quanto l'apertura promette. Anche qui si dimo-stra puntuale la conoscenza delle fonti bibliografiche, emergel'utilizzo accorto della documentazione d'archivio; i richiami piuÁ fre-quenti sono alle opere di Coronini e di Bernardo Maria De Rubeis,due autori di notevole risonanza nell'ambito regionale. Molto citata,conformemente alla tradizione erudita, l'opera storica di Muratori,secondo un uso retorico che si ripete in altri contesti 49, e che ben fan-no comprendere l'interrogativo, problematico e provocatorio, sull'in-fluenza o semplice presenza di Muratori in questi autori periferici 50.
Si affacciava peroÁ all'orizzonte culturale degli eruditi accademiciisontini, e nell'opera di Bonomo, una nuova figura di studioso che, seanche non poteva avere la forza di eguagliare Muratori, veniva a rap-presentare un interessante punto di riferimento: Gianrinaldo Carli.Non il Carli amministratore e studioso della politica, ne certamenteil padre delle AntichitaÁ italiche, ancora nella mente dell'autore. Piut-tosto il Carli storico dell'Istria negli anni giovanili, citato talora diret-
198
48 BONOMO, Sopra l'origine, cit., p. 6.49 Indicativo al riguardo G. BENZONI, Pensiero storico e storiografia civile, in G. AR-
NALDI, M. PASTORE STOCCHI (a cura di), Storia della cultura veneta, 5/2, Il Settecento, NeriPozza, Vicenza 1986, p. 90. Sul contesto regionale nel quale avveniva il recupero aglistudi dell'antichitaÁ romana e medioevale si vedano oggi anche i saggi di Gian DomenicoBertoli e la cultura antiquaria del '700, « Bollettino del Gruppo Archeologico Aquileie-se », XI, 11 (2001).
50 A. DUPRONT, L.A. Muratori et la socieÂte europeÂenne des preÂs-lumieÁres. Essai d'in-ventaire et de typologie d'apreÁs l'Epistolario, Olschki, Firenze 1976, pp. 1-17. Sui conti diGorizia si veda anche M. STANISCI, I conti di Gorizia e il patriarcato di Aquileia, Del Bian-co, Udine 1979, pp. 7-25 e i saggi di S. CAVAZZA, La formazione della contea asburgica eL'ereditaÁmedievale: nobili, rappresentanze, Stati provinciali, in ID. (a cura di), Divus Ma-ximilianus. Una contea per i goriziani 1500-1619 (catalogo della mostra), Edizioni dellaLaguna, Mariano del Friuli 2001, rispettivamente alle pp. 129-142 e 143-157.
tamente e talora mediatamente, attraverso un riferimento a De Ru-beis che aveva pubblicato documenti fornitigli dal capodistriano 51.Comunque, l'uso retorico di questi riferimenti restituiva al Litoralee all'Istria l'intellettuale che tanto onore aveva fatto alla terra d'origi-ne e la cui fama si era diffusa in Europa. Citarlo poteva essere un ti-tolo di vanto, in un contesto nel quale persino De Rubeis scriveva diaverlo desiderato come conterraneo e concittadino 52.
Diverse sono le caratteristiche di un altro saggio di Bonomo, ela-borato sin dal 1771 ma edito postumo nel 1831. Il lavoro Della giu-stizia de' diritti austriaci carintiani sopra l'Istria rimase inedito forseproprio per la natura dei rilievi che conteneva, tanto da invitare l'au-tore alla prudenza nella pubblicazione temendo che un pubblicoconfronto su temi di riflesso politico potesse nuocergli. GiaÁ il titolodel saggio compendia efficacemente il tema controverso e l'imposta-zione dell'opera, che assume un particolare significato rispetto al re-sto della produzione erudita di Bonomo. Con questa dissertazione,infatti, Bonomo abbandonava la ricerca puramente archivistica e di-plomatica per avventurarsi invece su altri terreni; il tema apparestrettamente collegato a quello del libretto sull'origine dei conti diGorizia, nel quale era stata sviluppata peroÁ essenzialmente l'indaginecronologica, mentre invece ora l'analisi si sposta sul piano storico-giuridico e politico. Il titolo stesso peraltro introduceva il tema dellagiustizia de' diritti, cioeÁ un'indagine critica diretta all'accertamentodella fondatezza dei diritti goduti dalla Repubblica di Venezia su ter-ritori dell'Istria ma rivendicati storicamente da Casa d'Austria. Bono-mo intendeva cioeÁ dimostrare la legittimitaÁ dei diritti dinastici e ter-ritoriali affermati nel Medioevo dai duchi di Carinzia sull'Istria dopola cessione di parte della penisola al patriarcato d'Aquileia e quindialla Serenissima 53. A questo scopo, l'analisi si incentrava sull'esamestorico e giuridico della validitaÁ dell'atto con il quale nel 1230 Ottonedi Merania aveva rinunciato ai propri diritti sul marchesato d'Istria in
199
51 BONOMO, Sopra l'origine, cit., p. 6.52 CosõÁ anche BENZONI, Pensiero storico, cit., p. 91.53 Su questi temi cfr. anche R. HAÈ RTEL, Personalunion oder mehr? Zum Werden der
Grafschaft GoÈrz im Hochmittelalter, «Histoire des Alpes / Storia delle Alpi / Geschichteder Alpen » 10 (2005), pp. 57-74.
favore del fratello, il patriarca Bertoldo di Aquileia 54. Bonomo inten-deva dimostrarne la nullitaÁ , sulla base del pregiudizio che recava alleprerogative dinastiche dei duchi di Carinzia. In sostanza, secondo iltriestino, Ottone di Merania non aveva compiuto un atto formale dirinuncia, ne aveva assunto atteggiamenti sostanzialmente incompati-bili con l'esercizio di questi diritti in modo da far supporre una ri-nuncia tacita ad essi. Ne seguiva la conclusione secondo cui ancoranella seconda metaÁ del Settecento i sovrani di casa d'Asburgo, inquanto successori dei duchi di Carinzia, conservavano pieno dirittoalla rivendicazione della sovranitaÁ sull'Istria veneta.
Occorre peroÁ anche rilevare, per comprendere l'effettivo valoredelle argomentazioni di Bonomo, che l'atto sul quale si era soffermatal'attenzione del triestino era sostanzialmente irrilevante dal punto divista politico. Si era trattato di una rinuncia formale a diritti che il pa-triarca di Aquileia aveva goduto legittimamente, e indisturbato, sin dal1208, in quanto attribuitigli direttamente dall'imperatore, il solo chegodeva del potere di disporre circa l'assegnazione dei feudi 55. L'arti-colato saggio di Bonomo, quindi, piuttosto che recare un contributoeffettivo al dibattito storiografico, si presenta oggi essenzialmente co-me un esercizio filologico e assume, nel nostro quadro, un rilievo so-prattutto quale documento degli interessi culturali del nostro autore.
Il lavoro, come giaÁ accennato, non venne stampato mentre l'au-tore era in vita e forse l'ipotesi che con tale atto Bonomo volesse sot-trarsi al dibattito pubblico su un tema spinoso acquista credibilitaÁconsiderando che in nessun'altra sua opera, edita o inedita 56, egli
200
54 Il saggio venne pubblicato postumo da Domenico Rossetti in «ArcheografoTriestino », s. I, III (1831), pp. 369-383, assieme a quello giaÁ citato sull'origine dei contidi Gorizia e ad una breve nota di presentazione, sotto il titolo generale Due opuscoli diAndrea Bonomo-Stetner. Il documento del 1230 qui ricordato eÁ pubblicato in P. KAN-
DLER, Codice diplomatico istriano, nuova edizione a cura di F. COLOMBO, R. ARCON, T.UBALDINI, II, Tip. Riva, Trieste 1986, pp. 436-437.
55 L'argomentazione G. DE VERGOTTINI, Lineamenti storici della costituzione politicadell'Istria durante il Medio Evo, SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria, Trieste1974, pp. 76-86.
56 Nel corso delle ricerche abbiamo rinvenuto i seguenti altri manoscritti di Bono-mo, ritenuti perduti: Il conte di Soisson. Storia galante tradotta dal francese da A[ndrea]B[onomo] D[e] S[tettner], in BCTs, segn. R.P. MS 1-2; Genealogia della nobilissima Pro-
volle impegnarsi su temi cosõÁ controversi. Bonomo si dimostra cosõÁ
esponente tipico di quel tipo di eruditi, diffusi in tutta l'Europa,che concepirono la passione e lo studio della storia come un'attivitaÁsostanzialmente avulsa dai grandi dibattiti politici, filosofici o eticidel loro tempo. Mancava cioeÁ in lui una sensibilitaÁ per i compiti ela missione dell'intellettuale quale quella tratteggiata sin dal 1753da d'Alembert nell'Essai sur la socieÂte des gens de lettre set desgrands 57, ma era assente in lui anche quel tipo di impegno culturaleche nella stessa Trieste, fra suoi amici e conoscenti come Zinzendorf,veniva mantenuto nel costante confronto con l'attualitaÁ e con la pra-tica dell'amministrazione.
Coerente con l'impostazione appena descritta eÁ l'opera di Bono-mo piuÁ nota, sempre riguardante il Medioevo, apparsa nel 1788 conlo pseudonimo arcadico di Orniteo Lusanio: la dissertazione Sopra lemonete de' vescovi di Trieste 58, lodata dai contemporanei, nota aglistorici dell'Ottocento e pure oggi non dimenticata. Particolarmenteelogiativa era una recensione anonima (ma con tutta probabilitaÁ do-vuta alla penna di Giuseppe de Coletti, segretario dell'arcadia e com-pilatore del giornale) apparsa su «L'Osservatore Triestino » in data 7marzo 1789: Bonomo, vi si scriveva, « il quale in materia d'istoria escienza diplomatica si eÁ giaÁ reso celebre per diverse erudite produzio-ni, aÁ nuovamente arricchito il mondo letterario con una opera [...] laquale dimostra certamente l'acutezza di uno spirito sublime ed unainstancabile applicazione. Questa opera, abbenche non molto volu-minosa, eÁ peroÁ intieramente decorata con eleganze tipografiche, con-tiene una profonda erudizione e pone, nella maggior chiarezza, og-getti che finora affatto sconosciuti o almeno inviluppati stettero frauna tetra caligine. [...] Molti de' primari letterati aÁnno giaÁ all'autore
201
sapia de' Bonomo della cittaÁ di Trieste, ms. in ADTs, segn. û CC 12; Albero genealogicodella famiglia Bonomo, in ADTs, segn. 22 C 1. Brevi scritti vennero pubblicati da PietroKandler nella rivista « L'Istria » (Incursione dei turchi vicino Trieste, nr. 50-51, 1847 e Ildoge Enrico Dandolo, ibidem).
57 J.B. D'ALEMBERT, Saggio sui rapporti tra intellettuali e potenti, tr. it., Einaudi, To-rino 1977.
58 [A.G. BONOMO], Sopra le monete de' vescovi di Trieste. Dissertazione, Stamperiadel governo, Trieste 1788. Il ms. autografo eÁ in ADTs, segn. 9 G 6/3.
di quest'opera contestata la maggior ammirazione con le loro letteree gli aÁnno impartite le piuÁ sublimi lodi con le piuÁ lusinghiere espres-sioni; anzi S[ua] M[aestaÁ] I[mperiale] medesima, che non tralasciamai di favorire col benefico sguardo qualunque gran talento, si eÁ de-gnata di onorare questo rispettabile autore con un graziosissimo au-lico decreto di lode » 59.
Ritornando al tema prediletto delle monete, Bonomo riprendeval'analisi storico-erudita sulle vicende del Medioevo triestino esami-nando criticamente fonti edite e inedite e non disdegnando ancorauna volta l'analisi giuridica: cosõÁ, ad esempio, nel valutare l'attocon il quale nel 1226 il vescovo Giovanni aveva ceduto i propri dirittigiurisdizionali sulla cittaÁ al Comune, o ancora nella serrata dimostra-zione della falsitaÁ di un noto documento del 949, attribuibile vicever-sa al XIII secolo 60. In chiusura dell'operetta veniva pubblicata ancheun'Appendice de' documenti, occasione per trascrivere « varie carte,quantunque non servano all'argomento, per conservarne la memo-ria » 61 e per dimostrare ancora una volta le proprie capacitaÁ di ricer-catore. Anche nel saggio Sopra le monete de' vescovi di Trieste, e inparticolare nell'appendice che rappresenta a Trieste il primo esempiodi edizione cronologicamente ordinata di documenti medioevali,autori moderni hanno rilevato limiti e difetti 62. EÁ maturata, d'altraparte, la consapevolezza che l'opera di Bonomo, tanto apprezzatanell'Ottocento da uno studioso come Pietro Kandler fino a conside-rarla anticipatrice del Codice diplomatico istriano 63, ebbe un'impor-tanza soprattutto per aver risvegliato in sede locale l'interesse sul Me-dioevo, avviando una tradizione di studi che doveva colmare una la-cuna su temi in precedenza spesso trascurati. Alla luce quindi diqueste notizie, che arricchiscono gli accenni giaÁ noti ai suoi rapporti
202
59 Nella rubrica Letteratura, « L'Osservatore Triestino », 19, 7 marzo 1789, pp.297-298.
60 Cfr. ora DE VERGOTTINI, Scritti di storia del diritto italiano, III, cit., pp. 1375-1392.
61 BONOMO, Sopra le monete de' vescovi di Trieste, cit., p. 3.62 In questo senso IONA, Il Codice diplomatico istriano, cit., pp. 132-133.63 Si veda la Prefazione alla nuova edizione di KANDLER, Codice diplomatico istriano,
cit., pp. XXXI-XXXII.
con i letterati goriziani e istriani tra cui Francesco Almerigotti e Gi-rolamo Gravisi 64, il ruolo di Bonomo nella cultura del Litorale nelsecondo Settecento appare maggiormente delineato. Ci restituiscela figura di uno studioso certamente estraneo ai grandi circuiti intel-lettuali della sua epoca e racchiuso nei propri interessi, ma niente af-fatto isolato rispetto al contesto territoriale nel quale viveva e anziconsapevole dell'importanza e dell'utilitaÁ delle relazioni culturali epersonali.
Fu probabilmente Girolamo Gravisi, studioso con il quale Bono-mo era in corrispondenza 65 e cugino di Gianrinaldo Carli, a metterein contatto il triestino con il capodistriano trasferito a Milano, nell'e-poca in cui questi attendeva alla compilazione delle AntichitaÁ italiche.Ad un personaggio, quale Carli, impegnato in ricerche tanto arduequanto vaste per la preparazione di un'opera storica sulle fonti epi-grafiche mancava ancora un corrispondente giuliano che, oltre a rac-cogliere documentazione in sede locale, potesse fungere in qualchemodo da aiuto al cugino Gravisi, suo principale referente per l'areaistriana 66. Per Bonomo, invece, l'essere in corrispondenza con il fa-moso Carli dovette costituire indubbiamente un titolo di alto onore,da rendere pubblico nel piccolo mondo culturale triestino.
Si sviluppoÁ , cosõÁ, nell'arco di circa un quinquennio un'interessan-te corrispondenza, che si eÁ conservata purtroppo in minima parte eche rende conto, in parallelo, di iniziative editoriali milanesi, quale lapubblicazione delle AntichitaÁ italiche, e triestine, quale la stampa delsaggio sulle monete dei vescovi. Ne emerge un garbato confrontonon solo fra Bonomo e Carli ma anche tra due modelli storiograficiche venivano presentandosi all'erudito triestino, quello cioeÁ del Mu-ratori delle Antiquitates italicae e quello del Carli delle AntichitaÁ ita-liche stesse. E di Bonomo Carli serboÁ certamente buona memoria,come dimostrano i ripetuti cenni di ringraziamento nella sua opera
203
64 Notizie di questi rapporti in VENTURINI, Il casato dei marchesi Gravisi, cit., p. 316.65 Due lettere di Bonomo a Girolamo Gravisi sono pubblicate in COSSAR, Epistola-
rio inedito, cit., pp. 270-273.66 Cfr. ora anche V. VEDALDI IASBEZ, Gianrinaldo Carli fra erudizione e storia: le
«AntichitaÁ italiche », in TRAMPUS (a cura di), Gianrinaldo Carli nella cultura europea,cit., pp. 218-238.
per le varie notizie ricevute. A Carli il triestino, a sua volta, invioÁ conentusiasmo il proprio lavoro sulle monete dei vescovi a mano a manoche i fogli freschi di stampa uscivano dalla tipografia. Tanto che Car-li, con un certo divertito fastidio, scrisse a Gravisi che la posta «mifaceva pagare in Milano due paoli ogni lettera ».
Al di laÁ della testimonianza su queste forme di collaborazione, inumerosi riferimenti a Bonomo contenuti nelle AntichitaÁ italichedanno soltanto una prima idea dell'impegno del triestino; a leggerecon piuÁ attenzione quelle pagine ci si rende conto invece della quan-titaÁ di materiali e di fonti pervenute grazie a lui nelle mani di Carli.CosõÁ nel primo volume viene pubblicato il disegno raffigurante unalapide romana di Trieste trasmesso da Bonomo «dotto cavaliere diquella cittaÁ , a cui debbo la comunicazione di molte antichitaÁ » 67;piuÁ oltre vi eÁ la notizia di un fregio romano con colonne, esistentepresso la cattedrale di San Giusto, con la nota che « il dotto signorAndrea Giuseppe Bonomo suppone quelle colonne un resto di pro-stilo di qualche tempio » 68. Nel secondo volume altro ringraziamen-to per il disegno di una lapide rinvenuta a Trieste nel 1787 69, noncheÂper il testo di un'iscrizione latina esistente nella chiesa di San Canzia-no al Timavo 70. Analoghe espressioni si riscontrano nel terzo volu-me 71. Da osservare ancora, nel primo volume, un riferimento a undisegno « ch'egli medesimo mi fe' tenere nel 1770 (sic!) » 72. Nel ter-zo volume delle AntichitaÁ italiche Bonomo trovoÁ quasi il coronamen-to delle proprie fatiche investigative e intellettuali: accanto alle operedi De Rubeis e di Muratori, accanto ai nomi dei maestri tante volterichiamati, vedeva citato il proprio saggio sulle monete dei vescovitriestini 73.
Il breve carteggio fra Bonomo e Carli, che si pubblica in appen-
204
67 G. CARLI, Delle antichitaÁ italiche, I, Monastero di S. Ambrogio maggiore, Milano17932, p. 87.
68 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., I, p. 186.69 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., II (1794), p. 49.70 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., II, p. 138.71 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., III (1794), pp. 143, 147, 150, 161, 226, 231.72 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., I, p. 159.73 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., III, p. 315.
dice, copre un arco di tempo compreso fra l'ottobre 1787 e il settem-bre 1789; si tratta di trascrizioni contenute nel copialettere della Cor-rispondenza scientifico-letteraria 74, per cui eÁ impossibile allo stato at-tuale fare un confronto con degli originali che non sono conosciuti etanto meno eÁ agevole capire se la trascrizione eÁ integrale oppure, co-me talvolta accade per l'epistolario carliano, soffre di qualche omis-sione. Ad ogni modo, esso curiosamente contiene solo notizie di ca-rattere storico-erudito e nessun riferimento all'attualitaÁ , pur risalen-do ad un periodo segnato da importanti avvenimenti politici,primo fra i quali la Rivoluzione francese. EÁ per questo che le lettererappresentano soprattutto il documento di un'amicizia personale e diun metodo di lavoro, quale quello utilizzato da Carli per il reperi-mento delle fonti delle AntichitaÁ italiche. L'ultima lettera, come ac-cennato, eÁ del settembre 1789; i rapporti fra i due personaggi peroÁcontinuarono, anche se sono scarsamente documentati. Soltanto dauna lettera di Carli a Gravisi del luglio 1792 75 si apprende che inquell'epoca Bonomo ricevette in dono, proprio tramite Gravisi,una copia del discorso carliano Della disuguaglianza fisica, morale ecivile fra gli uomini 76. La Rivoluzione e i suoi effetti, cosõÁ accurata-mente tralasciati nelle discussioni erudite, rientravano prepotente-mente nella quotidianitaÁ e difficilmente Carli avrebbe fatto dono del-la sua operetta politica se giaÁ non ne avesse immaginato un'accoglien-za favorevole da parte del suo antico corrispondente triestino.
205
74 Cfr. Corrispondenza scientifico-letteraria in AmC, fasc. 1471, cc. 72 e seguenti.75 ZILIOTTO, Trecentosessantasei lettere, cit., p. 15.76 G. CARLI, Della disuguaglianza fisica, morale e civile fra gli uomini, ossia ragiona-
mento sopra l'opera di Rousseau, Tip. del Seminario, Padova 1792. Da segnalare ancoral'esistenza di tredici lettere di Bonomo a Daniele Giovanni de Hochepied, viceconsoleaustriaco a Smirne nonche console olandese in quella cittaÁ , conservate in Den Haag,NA, Eerste Afdeling, Legatie Smirna, inv. nr. ij. Le lettere risalgono agli anni 1782-1787 e riguardano l'epidemia di peste allora diffusa e interessano quindi soltanto l'atti-vitaÁ professionale di Bonomo quale Magistrato di SanitaÁ .
VIII. - MINERVA E MERCURIO NEL TEMPIO DI CIBELE.ACCADEMIE E GAZZETTE, INTELLETTUALI EDERUDITI TRA LE SPONDE DELL'ADRIATICO
Scavando nella cantina di casa propria, nel centro dell'anticaTergeste, il sacerdote ed erudito Aldrago de Piccardi rinvenne pocodopo il 1750 le vestigia di una costruzione d'epoca romana, che iden-tificoÁ in un tempio di Cibele, dea della terra feconda. Metaforica-mente, in pieno Settecento fecero ingresso nel tempio di Cibele Mi-nerva, protettrice delle arti e delle scienze, e Mercurio, protettore delcommercio e dell'industria; si vedraÁ come.
Per addentrarci nel ricco e variegato mondo delle pratiche cultu-rali tra il Litorale e l'Istria nel Settecento eÁ necessario peroÁ compiereuna breve indagine su un concetto fondamentale per le vicende di que-ste regioni, divenuto un vero e proprio mito storiografico: il cosmopo-litismo, esperienza nella quale viene identificata una borghesia moder-na, cosmopolita perche plurietnica e consapevole della funzione e delruolo europeo di Trieste; una borghesia, viene aggiunto, che peraltro« non ha elaborato una propria ideologia e una nuova cultura » 1.
Il concetto di cosmopolitismo eÁ per sua natura tendenzialmentegenerale e generico, e nell'astrattezza ben puoÁ essere riferito a situa-zioni sociali, confessionali, economiche di realtaÁ che si collocano intempi diversi o, nel caso dell'utopia, fuori dal tempo storico. La
206
1 Cfr. ARA, MAGRIS, Trieste, cit., pp. 36, 38.
sua vocazione universalistica giustifica una prima definizione di dot-trina che respinge ogni distinzione di nazioni e di razze, consideran-do tutti gli uomini come cittadini di una sola patria o comunitaÁ 2.
EÁ noto che il cosmopolitismo settecentesco, come ideale utopicodi tolleranza, universalismo religioso e cristianesimo ragionevole,trasse origine dalla cultura filosofica tardoseicentesca, per essere for-giato nel primo Settecento grazie al contributo di Locke, di Leibniz,di Barbeyrac e di Bayle. Leibniz teorizzava la distinzione fra cosmo-politismo e universalismo ecclesiastico; il suo allievo Christian WolffindividuoÁ uno jus cosmopoliticum nel diritto delle genti 3. Parallela-mente, analoghe riflessioni confluirono nell'elaborazione, fertile pertutto il Settecento, dei progetti utopici per la pace universale, daSaint-Pierre a Rousseau, fino a Kant 4.
Alla metaÁ del XVIII secolo l'idea di cosmopolitismo risultavaciononostante tutt'altro che definita, nei contenuti e nella terminolo-gia. Ne sono prova l'accezione ancora prevalentemente negativapresso molti philosophes francesi, la resistenza ad accogliere una vocespecifica nell'EncyclopeÂdie, che riservoÁ al cosmopolitismo poche ri-ghe dal contenuto del tutto generico. Voltaire nel Dictionnaire philo-sophique l'ignoroÁ del tutto, e si era giaÁ nel 1769 5 quando lui stesso
207
2 G. RICUPERATI, Cosmopolitismo in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a curadi),Dizionario di politica, Tea-UTET, Torino 1990, pp. 241-249; in precedenza F. VENTURI,Les ideÂes cosmopolites en Italie au XVIIIe sieÁcle. Perspectives europeÂennes du cosmopolitismeau XVIIIe sieÁcle, Centre EuropeÂen Universitarie, Nancy 1957; C. DEDEYAN, Le cosmopoliti-sme sous la ReÂvolution et l'Empire, Sedes, Paris 1976, pp. 3-21. PiuÁ recentemente cfr. l'at-tenta analisi di J.-R. SURATTEAU, Cosmopolitisme et patriotisme au sieÁcle des lumieÁres, «An-nales historiques de la ReÂvolution FrancËaise », LV (1983), pp. 234-385 e la voce di W. FRIJ-
HOFF,Cosmopolitismo, in FERRONE, ROCHE, L'Illuminismo. Dizionario storico, cit., pp. 21-30.3 P. HAZARD, Cosmopolitisme, in MeÂlanges d'histoire litteÂraire et compareÂe offerts aÁ
F. Baldensperger, I, Champion, Paris 1930, pp. 354-364. Si veda anche la critica all'ideadi cosmopolitismo proposta da Hazard in La penseÂe europeenne au XVIIIe sieÁcle fatta daD. CANTIMORI, Studi di storia, III, Critici, rivoluzionari, utopisti e riformatori sociali. Com-menti, letture, aporie [1959], Einaudi, Torino 1976, p. 569.
4 Si veda l'antologia curata da D. ARCHIBUGI, F. VOLTAGGIO, Filosofi per la pace,Editori Riuniti, Milano 1991.
5 F. VENTURI, Le origini dell'Enciclopedia, Einaudi, Torino 1963. Osserva giusta-mente H.A. STAVAN, Cosmopolitisme et xeÂnophobie aÁ la cour de FreÂdeÂric II, landgravede Hesse-Cassel, in G.-L. FINK (a cura di), Cosmopolitisme, patriotisme et xeÂnophobieen Europe au sieÁcle des LumieÁres, Universite des Sciences Humaines, Strasbourg 1987,
ormai non appariva del tutto insensibile all'esperienza « borghese » ealle istanze del Terzo Stato nella Francia di Antico Regime. Voltaire,anzi, appariva un convinto sostenitore di un'etica dell'uguaglianzagiuridica e della libertaÁ che lui stesso riteneva indispensabili per edu-care la borghesia ad un nuovo ruolo sociale 6.
A una obiettiva incertezza circa l'accoglimento e la diffusione deltermine corrispondeva in realtaÁ , nella cultura francese, una riflessio-ne ormai abbastanza avanzata che delineava un'idea che, pur se nonrivestita ancora della definizione di cosmopolitismo, si puoÁ coglierenell'EncyclopeÂdie scorrendo le voci Philosophie, Patrie, EÂconomie, Fa-natisme 7 e nell'opposizione dell'idea cosmopolita alla XeÂnophobie.Denis Diderot, d'altra parte, giaÁ nel 1765 additava come libero co-smopolita il frequentatore del salotto di d'Holbach, individuandoquei caratteri distintivi del cosmopolitismo che piuÁ tardi, nel 1774,avrebbe ricordato anche nel Voyage en Hollande riconoscendo nellavita politica e sociale della Repubblica delle Province Unite le libertaÁcivili, politiche e religiose. Anticipava cosõÁ in qualche misura il con-nubio settecentesco fra l'esperienza del viaggio e la vocazione cosmo-polita e dopo Diderot furono poi Bernardin de Saint-Pierre e d'A-lembert a diffondere l'uso del termine 8.
Si eÁ accennato al suo significato prevalentemente negativo finoalla metaÁ del secolo in quanto nella prima formulazione il cosmopo-litismo veniva presentato nelle architetture utopiche della prima metaÁdel Settecento in opposizione o comunque in alternativa all'idea dipatria. D'altra parte, fino a quell'epoca i philosophes percorrevano
208
p. 133: « le terme `cosmopolite' ou `cosmopolitain' eÂtait consideÂre par l'EncyclopeÂdiedans un premier temps comme une plaisanterie pour signifier un homme qui n'avaitpoint de demeure fixe ou qui n'eÂtait e tranger nulle part ». Cfr. anche VOLTAIRE, Diction-naire philosophique, Garnier, Paris 1967.
6 P. GAY, Voltaire's Politics. The Poet as Realist, Yale University Press, New Haven-London 19882 (tr. it., Voltaire politico. Il poeta come realista, il Mulino, Bologna 1991, p.328).
7 RICUPERATI, Cosmopolitismo, cit., p. 246.8 D. DIDEROT, Voyage en Hollande, in ID., Oeuvres completes, a cura di J. ASSEZAT e
N. TOURNEY, XVII, Garnier, Paris 1876; tr. it., Viaggio in Olanda, a cura di L. SOZZI,Ibis, Como 1989, p. 38; D. DIDEROT, Scritti politici, con le voci politiche dell'EncyclopeÂ-die, a cura di F. DIAZ, UTET, Torino 1967.
generalmente una via che legava indissolubilmente il loro impegno diilluministi ad un realismo dettato dalla volontaÁ di collaborare con iprincipi, per educare la nazione e dare impulso al movimento rifor-matore dell'assolutismo illuminato. Entro questi limiti non vi eraquindi piena coincidenza tra le aspirazioni universalistiche del co-smopolitismo e il radicamento sul territorio degli uomini delle rifor-me. Alla sintesi di questi ideali si sarebbe giunti piuÁ tardi, negli anniSettanta, con il fallimento dei programmi di riforme politiche e con lariappropriazione, da parte dei philosophes, delle utopie universalisti-che, per il raggiungimento di un nuovo cosmopolitismo filosoficoche, preparando le coscienze agli esiti del 1789, si sarebbe radicatoanche nella coscienza tedesca con Lessing e con Herder 9.
EÁ evidente che tutta la problematica del cosmopolitismo settecen-tesco eÁ strettamente connessa alle discussioni sul rapporto tra societaÁe Stato, sul passaggio dalla CittaÁ degli uomini di Diderot alla Cosmo-polis, la repubblica universale dei fratelli massoni, idealizzata anche inErnst und Falck. GespraÈche fuÈr Freymaurer (1778) di Lessing. Moltielementi del pensiero cosmopolita si rinvengono infatti nelle tesi e nel-le riflessioni della massoneria speculativa caricate ± soprattutto primadella radicalizzazione dello scontro politico negli anni Ottanta ± diuna connotazione sostanzialmente estranea al concetto di Stato o na-zione, in obbedienza ai princõÁpi di eguaglianza civile e di tolleranzareligiosa (l'universalism del linguaggio massonico inglese) 10.
Si tratta di un argomento di notevole importanza anche per lostudio della societaÁ cosmopolita del Settecento triestino, le cui rela-zioni con i programmi etici e politici della libera muratoria sono statericonsiderate solo recentemente, dopo la riscoperta dei rapporti fra icommercianti triestini e la massoneria francese e poi con quella dellaStretta Osservanza.
209
9 Indicazioni piuÁ generali sul rapporto fra letteratura di viaggio e cosmopolitismosono offerte da F. KNOPPER-GOURON, Cosmopolitisme et xeÂnophobie chez les voyageursallemands en Allemagne du sud et en Autrice, in FINK (a cura di), Cosmopolitisme, patrio-tisme, cit., pp. 227-239.
10 J.-J. CHEVALIER, Histoire de la penseÂe politique, II, L'eÂtat-nation monarchique: versle deÂclin, Payon, Paris 1979; tr. it., Storia del pensiero politico, II, L'etaÁ moderna, il Mu-lino, Bologna 1989, pp. 369-372.
EÁ significativo che proprio dagli anni Settanta del Settecento co-minciarono a mutare gli elementi costitutivi e i soggetti del cosmopo-litismo: da un lato, con la lenta trasformazione del sentimento pa-triottico nell'idea di nazione, dall'altro con la diffusione del cosmo-politismo stesso come fattore di identitaÁ culturale oltre la cerchiadei philosophes, fino alla borghesia.
Sul primo punto c'eÁ da osservare che giaÁ nell'EncyclopeÂdie erastato istituito un significativo confronto fra il concetto di cosmopoli-tismo e quello di patria; cosõÁ aveva fatto anche Voltaire, che interpre-tava il cosmopolitismo come limite all'amor di patria. D'altra parte, ladiffusione della nuova idea dissimulava una rinnovata interpretazionedi questo secondo concetto, che non si limitava piuÁ ai confini terri-toriali ma veniva intesa sempre piuÁ spesso come comunitaÁ nazionalesuperiore ai confini statuali, base per la realizzazione della Grandenation francese e per la trasfigurazione del cosmopolitismo nell'ideadi Stato nazionale 11.
Questa evoluzione dell'idea di cosmopolitismo verso quella dipatria e di Stato nazionale, che giaÁ attirava l'attenzione di Meineckein un celebre scritto non a caso proposto al pubblico italiano attra-verso la traduzione di un triestino, Aldo Oberdorfer 12, eÁ alla basedi attente rimeditazioni in atto nella storiografia europea. Nel 1989la SocietaÁ tedesca di studi settecenteschi vi ha dedicato un fascicolomonografico della propria rivista, dedicando speciale attenzione alPatriotismus e al rapporto fra Nationalgeist e Kosmopolitismus nelclassicismo letterario, in Lessing, Wieland e Herder 13 mentre in se-guito il tema eÁ stato ripreso anche per gli spazi italiani 14.
210
11 R. POMEAU, L'Europe des LumieÁres. Cosmopolitisme et unite europeÂenne auXVIIIe sieÁcle, Stock, Paris 1966; R. BARNY, Montesquieu patriote?, «Dix-huitieÁme sieÁ-cle », XXI (1989), pp. 83-95.
12 F. MEINECKE, WeltbuÈrgertum und Nationalstaat. Studie zur Genesis des deutschenNationalstaats, Oldenbourg, MuÈnchen 19226; tr. it., Cosmopolitismo e stato nazionale.Studi sulla genesi dello stato nazionale tedesco, a cura di A. OBERDORFER, La Nuova Italia,Perugia-Venezia 1939.
13 G. BIRTSCH (a cura di), Patriotismus, numero monografico di «AufklaÈrung », IV/2 (1989); C. WIEDEMANN, Zwischen Nationalgeist und Kosmopolitismus. UÈber die Schwie-rigkeiten der deutschen Klassiker, einen Nationalhelden zu finden, ivi, pp. 75-101.
14 Si veda il capitolo su Patria o nazione? Il patriottismo repubblicano e costituzio-
Si eÁ giaÁ accennato ad un altro fenomeno, che consiste nella dif-fusione degli ideali cosmopoliti verso la cultura dei ceti dirigenti edella borghesia, in una base sociale piuÁ larga rispetto al gruppo ri-stretto dei philosophes. Tale tendenza fu piuÁ evidente dapprima incoloro che partecipavano all'amministrazione del potere, ad esempionel mondo dei funzionari, dove spesso veniva reinterpretata attraver-so un'idea di patria intesa come identitaÁ culturale superiore alla fram-mentazione delle singole realtaÁ statali 15. Questo fu ad esempio il co-smopolitismo dei riformatori italiani e soprattutto di coloro che simuovevano entro la sfera d'influenza degli Asburgo 16. Come non ri-cordare l'articolo Della patria degli italiani scritto da GianrinaldoCarli per Il CaffeÁ? Verri e Beccaria, Carli, Genovesi e Filangieri incar-narono l'equivalente del philosophe in una penisola ove mancava an-cora la presenza di un'identitaÁ statuale forte 17. Si trattava di un con-cetto di patria ± ampiamente ripreso anche nello spazio asburgico at-traverso gli scritti di Joseph von Sonnenfels ± profondamente diversoda quello di nazione risorgimentale, che sarebbe stato modellato in-vece su una base piuÁ marcatamente linguistica ed etnicizzante. Tut-
211
nale degli illuministi italiani in V. FERRONE, La societaÁgiusta ed equa. Repubblicanesimo ediritti dell'uomo in Gaetano Filangieri, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 159-222.
15 Sull'originaria appartenenza del concetto di cosmopolitismo ai ceti sociali piuÁelevati, specie gli intellettuali provenienti dalla nobiltaÁ e dall'alta borghesia, rispetto al-l'estraneitaÁ di questa idea per il popolo, piuÁ sensibile a quella di patria, insiste SURAT-TEAU, Cosmopolitisme et patriotisme, cit., p. 380. Si vedano la rilevanza e la funzione del-le rappresentazioni utopiche descritte da B. BACZKO, L'utopia. Immaginazione sociale erappresentazioni utopiche nell'etaÁ dell'Illuminismo, tr. it., Einaudi, Torino 1979, pp.19-31.
16 Per l'incubazione del cosmopolitismo italiano prima del 1715, che segna la finedell'epoca della crisi della coscienza europea, cfr. F. VENTURI, L'Italia fuori d'Italia, in R.ROMANO, C. VIVANTI (a cura di), Storia d'Italia, III, Dal primo Settecento all'UnitaÁ, Ei-naudi, Torino 1973, pp. 1014-1018.
17 P. CASINI, Introduzione all'Illuminismo, I, Scienza, miscredenza e politica, Laterza,Roma-Bari 1980, pp. 231-241, che individua in Magalotti e Fardella due antesignani delcosmopolitismo inteso come « resistenza al rischio di chiusura provinciale minaccianteormai gli scienziati e i filosofi italiani ». Sul periodo si veda anche la sintesi di D. CARPA-
NETTO, G. RICUPERATI, L'Italia del Settecento. Crisi, trasformazioni, lumi, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 99-119 e in precedenza F. VENTURI, Illuminismo italiano e illuminismoeuropeo, in M. FUBINI (a cura di), La cultura illuministica in Italia, ERI, Torino 1964,pp. 13-22.
tavia l'insidia dell'equivoco rimane costante ± testimone anche la sto-riografia giuliana del Novecento ± ed eÁ stata bene avvertita da studio-si come Federico Chabod prima e come Norbert Jonard, che piuÁ re-centemente eÁ tornato sull'argomento in occasione delle celebrazioniteresiane del 1980 su Cosmopolitismo e patriottismo nel CaffeÁ18.
I riformatori italiani, fossero lombardi, toscani o napoletani nonriproducevano quindi in maniera automatica l'immagine del philoso-phe cosmopolita francese. Altri erano i problemi sollecitati dalla spe-cifica situazione storica e politica della penisola e assai piuÁ variegateerano le suggestioni culturali che provenivano da contaminazioni cul-turali legate alla presenza straniera in Italia.
Da questa breve indagine si puoÁ ben comprendere come l'e-spressione « cosmopolitismo » abbia mantenuto in etaÁ modernauna natura polisemica e come i suoi significati siano andati mutan-do nel corso del tempo ± in modo peraltro simile a tanti elementidel lessico politico europeo ± in rapporto al momento storico, aglispazi geografici e alle influenze culturali. Il problema del cosmopo-litismo va quindi attentamente contestualizzato. Si scrive infatti fre-quentemente di esso, ad esempio, quale fattore identificante la so-cietaÁ triestina e assieme quale elemento caratterizzante, dal punto divista socio-economico, lo sviluppo del porto franco. Si tratta tutta-via di affermazioni che necessitano di verifiche e di approfondimen-ti, sia dal punto di vista storiografico, sia dal punto di vista docu-mentario.
La difficoltaÁ di fissare cronologicamente le origini del cosmopo-litismo appare evidente fin dalle indagini ottocentesche, come ebbe
212
18 F. CHABOD, L'idea di nazione, a cura di A. SAITTA e E. SESTAN, Laterza, Bari 1961,nonche l'analisi di G. SASSO, Gli studi di storia delle dottrine politiche e di storia delleidee, con le Correlazioni di H. HELBLING e N. MATTEUCCI e la relativa discussione inB. VIGEZZI (a cura di), Federico Chabod e la « nuova storiografia » italiana dal primo alsecondo dopoguerra (1919-1945), Jaca Book, Milano 1984, pp. 247-307. Per Il CaffeÁcfr. N. JONARD, Cosmopolitismo e patriottismo nel CaffeÁ, in A. DE MADDALENA, E. ROTEL-
LI, G. BARBARISI (a cura di), Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'etaÁ di MariaTeresa, II, il Mulino, Bologna 1982, pp. 93-95; VENTURI, Settecento riformatore, I, cit.,pp. 726-729. Interessa soprattutto la letteratura, ma con una trattazione un po' impres-sionistica, V. KAPP, XeÂnophobie et cosmopolitisme en Italie au sieÁcle des lumieÁres, in FINK
(a cura di), Cosmopolitisme, patriotisme, cit., pp. 57-68.
modo di osservare Giulio Cervani giaÁ in un intervento del 1950 19.Infatti, se da una parte era stato facile riconoscere nella Trieste set-tecentesca un cosmopolitismo economico e confessionale o linguisti-co, espresso nel liberalismo economico e nella tolleranza dei culti, piuÁgrave appariva la difficoltaÁ di analizzare le eventuali e corrispondentiespressioni culturali 20.
Le prime manifestazioni di un cosmopolitismo culturale triestinofurono poi fatte risalire alla metaÁ dell'Ottocento, all'epoca della dif-fusione delle gazzette letterarie, dei circoli di lettura, di scritti a carat-tere prevalentemente memorialistico ad opera di chi aveva vissutodopo la Restaurazione l'aurea stagione dell'emporio adriatico.
Un esempio significativo di tale interpretazione, non di rado re-sa estrema, si ritrova in Fabio Cusin, che negli anni Trenta del No-vecento riservoÁ al mito del cosmopolitismo specifiche riflessioni, os-servando come « lungi dall'essere la quintessenza dello spirito di varipopoli qui riuniti, rappresenta invece peso morto di gente prove-niente da tutte le nazioni e ammassata davanti al suo porto »; per ag-giungere poi che « le varie nazioni avevano sõÁ portato qui i loro usi ecostumi piuÁ caratteristici, ma non grandi correnti di idee e di pen-siero » 21.
Considerazioni di una tale gravitaÁ erano dettate indubbiamente,nello studioso triestino, anche dalla temperie politica dell'epoca incui viveva, quando l'orientamento personale lo portava ancora a esal-tare la tensione `etica' di un nazionalismo che si voleva nato dal fal-
213
19 G. CERVANI, Intorno al cosmopolitismo triestino: le Memorie di Giovanni Guglie-mo Sartorio, « Annali Triestini », a cura dell'UniversitaÁ di Trieste, XX (1950), p. 18; G.NEGRELLI, Appunti di storia austriaca: l'esperienza « borghese » di Trieste, in S. ROTA GHI-
BAUDI, F. BARCIA, Studi politici in onore di Luigi Firpo, III, Ricerche sui secoli XIX-XX,FrancoAngeli, Milano 1990.
20 Si tratta di problemi storiografici che investono anche altre realtaÁ cittadine chepresentano caratteristiche analoghe a quelle di Trieste. Per un confronto cfr. D. CESARA-
NI (a cura di), Port Jews: Communities in Cosmopolitan Maritime Trading Centres 1550-1950, Frank Cass., London-Portland OR 2002; ID., G. ROMAIN (a cura di), Jews and PortCities 1590-1990: Commerce, Community and Cosmpolitanism, Vallentine Mitchell, Lon-don 2006.
21 F. CUSIN, Appunti alla storia di Trieste [1930], con saggio introduttivo di G. CER-
VANI, Del Bianco, Udine 19832, p. 342.
limento del cosmopolitismo. Si trattava, inoltre, di condizionamentilargamente dipendenti dalla specificitaÁ dei precedenti studi dellostesso autore, volti a indagare quasi esclusivamente gli aspetti econo-mici del porto franco settecentesco 22. Ma la radice andava ricercataaltrove, e cioeÁ in uno stereotipo della cultura letteraria triestina, for-matosi quasi per accidente in Scipio Slataper (come ha dimostratoacutamente Cesare Pagnini) 23 ma consegnato irrimediabilmente allaletteratura e alla storiografia del Novecento.
Le posizioni di Cusin appaiono inadeguate soprattutto percheÂdifettano di sistematiche verifiche testuali e non prendono in consi-derazione quelle testimonianze della Trieste settecentesca che purelui stesso aveva rintracciato e che trovano un chiaro riscontro (anchese inedito fino al 1969) in un osservatore cosmopolita e disincantatocome Antonio de Giuliani, che nel 1803 espressamente aveva riven-dicato al ceto mercantile un impegno culturale originale 24.
L'opinione di Cusin non appariva certo isolata e dipendeva ine-vitabilmente, come ben intuõÁ Sestan, da comprensibili problemi diaccessibilitaÁ alle fonti 25; e infatti tutta la documentazione allora stu-diata, invero non abbondante, in cui era data a riconoscere traccia diun impegno in senso `cosmopolita' sembrava risalire prevalentemen-te al maturo Ottocento. Si tratta di condizionamenti interpretativiche non avrebbero mancato di riflettersi ancora su alcune ricerchedei primi anni del secondo dopoguerra.
Solo a partire dagli anni Cinquanta comincioÁ ad emergere il nu-cleo centrale del problema storiografico, quale si pone oggi in tutta lasua complessitaÁ : verificare, cioeÁ , se nel caso triestino eÁ corretto par-lare di piuÁ cosmopolitismi, uno economico, uno confessionale, unolinguistico e un altro culturale, non coincidenti nel tempo; oppure
214
22 G. CERVANI, Gli «Appunti alla storia di Trieste » di Fabio Cusin e il problema sto-rico del particolarismo triestino, in CUSIN, Appunti, cit., p. 52. Per gli studi precedentidello stesso autore cfr. F. CUSIN, I precedenti storici di concorrenza tra i porti del maredel Nord e i porti dell'Adriatico, « Annali della R. UniversitaÁ di Trieste », IV (1932).
23 C. PAGNINI, Trieste non ha tradizioni di cultura?, « Archeografo Triestino », s. IV,XLIII (1983), pp. 5-18.
24DE GIULIANI, Scritti inediti, cit., p. 310; la citazione eÁ riportata nel cap. I, p. 45.
25 SESTAN, Venezia Giulia, cit., pp. 78-79.
se, come appare preferibile anche da un punto di vista intuitivo, eÁpreferibile concepire dal punto di vista storico l'unitaÁ e la continuitaÁdel fenomeno cosmopolita, considerando allora le sue ritardate ma-nifestazioni come esito ottocentesco di una corrente di pensiero tipi-camente settecentesca 26.
Si puoÁ notare, peraltro, come quest'ultima prospettiva non siaestranea ad altri contesti geografici e politici, per lo studio dei qualisi eÁ fatto validamente ricorso al tema della circolazione delle idee on-de misurare precocitaÁ e ritardi culturali, veri o presunti tali; si pensiad esempio al caso ungherese dove, nonostante l'assenza di un dibat-tito sul cosmopolitismo, la circolazione delle idee fu assai piuÁ intensadi quanto si potesse supporre 27.
Le conseguenze cui possono portare le opposte interpretazioninon sono di poco rilievo per la storia del Litorale Austriaco. Se infattiil cosmopolitismo culturale triestino fosse considerato indipendente-mente dai fenomeni economici e sociali, come si eÁ ragionato per lun-go tempo in certa parte della storiografia, le conclusioni finali, allaluce dell'esperienza europea, non potrebbero che deporre nel sensodi un'esperienza incerta e indefinita, ma soprattutto fuori tempo e re-trospettiva, visto che si sarebbe espressa compiutamente mezzo seco-lo dopo le vicende del cosmopolitismo europeo 28. Qualora il ragio-namento fosse portato alle sue estreme conseguenze, l'esito sarebbeancora piuÁ severo. Se infatti quel cosmopolitismo fosse visto comefenomeno tipico della societaÁ triestina moderna, ne deriverebbe an-che un giudizio di complessivo ritardo di gran parte della culturatriestina dell'Ottocento, senza piuÁ alcuno spazio per le necessarie sfu-mature e distinzioni.
215
26 Sulla societaÁ triestina di fine Settecento cfr. ancora APIH, La societaÁ triestina, cit.,pp. 69-77 e ID., Trieste, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 13-15.
27 E. MARTONYI, Extra Hungariam... ou le cosmopolitisme impossible en Hongrie aÁ lafin du XVIIIe sieÁcle, in FINK (a cura di), Cosmopolitisme, patriotisme, cit., pp. 107-114.
28 EÁ la conclusione, ad esempio, di A. STELLA, Trento, Bressanone, Trieste. Sette se-coli di autonomia ai confini d'Italia, UTET, Torino 1987, pp. 157-163. Per una piuÁ am-pia proiezione temporale cfr. invece G. BATTISTI, Cosmopolitismo e municipalismo qualifattori di identificazione della comunitaÁ triestina, in Atti del XXIII congresso geograficoitaliano, II/2, UniversitaÁ di Catania, Catania 1983, pp. 269-278.
Certamente non bisogna dimenticare che il concetto di cosmopo-litismo appare metaforicamente come un contenitore vuoto, cui noncorrisponde dappertutto nel continente europeo identitaÁ di contenutie di periodizzazioni. Per restituire la complessitaÁ di questi fenomeni enon ridurre la storia del Litorale a facili semplificazioni, occorre quin-di ripartire dalle fonti e dai soggetti, cioeÁ dagli attori di questo proces-so. Tali soggetti sono non solo i singoli personaggi che animarono lavita dell'emporio ma anche la stessa borghesia immigrata e pluricon-fessionale nel suo insieme e le pratiche culturali che contribuirono adefinirla. Probabilmente solo questo tipo di indagine puoÁ servire afar riconoscere le caratteristiche autentiche della cultura borghese ecosmopolita nel Litorale, da porre in relazione con il piuÁ ampio feno-meno della circolazione delle idee nell'Europa moderna.
La particolare struttura della societaÁ triestina del Settecento sug-gerisce inoltre precise ipotesi di lavoro. Infatti, la netta prevalenzanumerica della borghesia di recente immigrazione su una nobiltaÁ in-digena in completa decadenza non favorõÁ certo la presenza di intel-lettuali `di professione' come quei philosophes che forgiarono il co-smopolitismo nella Francia prerivoluzionaria o nella Lombardia delleriforme. Antonio de Giuliani, l'illuminista triestino piuÁ rilevante nelcontesto europeo, fu in realtaÁ un libero pensatore legato alla cittaÁ na-tale ormai soltanto da ragioni anagrafiche, come ha sottolineato Be-nedetto Croce, pur se le giovanili Riflessioni politiche sopra il prospet-to attuale della cittaÁ di Trieste meriterebbero nuova attenzione.
CioÁ che caratterizza la civiltaÁ cosmopolita dell'emporio eÁ invece ilceto mercantile stesso, la borghesia settecentesca formata da com-mercianti provenienti da Oriente e da Occidente. EÁ il soggetto stori-co, autentico attore dello sviluppo economico e sociale, elemento di-namico nel porto franco, vero laboratorio politico in quanto cittaÁ difondazione nella quale si voleva realizzare, a livello istituzionale e so-ciale, quegli ideali di tolleranza, di cristianesimo universale e di ugua-glianza giuridica presenti nei programmi dell'utopia cosmopolita deiphilosophes 29.
216
29 EÁ curioso ricordare che della necessitaÁ di una rilettura della storia triestina mo-derna avvertõÁ giaÁ con la consueta efficacia, ma senza immediato successo, un intellettuale
Il concetto di cosmopolitismo esprime in se anche le inevitabilicontraddizioni di luoghi reali o ideali nei quali convergono esperien-ze culturali di origine diversa che spesso, ma non sempre, possonoconfluire in breve tempo in atteggiamenti o sensibilitaÁ frutto di me-diazione culturale. Per fare piena luce sulla ricchezza e sulla specifi-citaÁ dell'esperienza borghese della Trieste settecentesca occorre risa-lire quindi ai differenti archetipi culturali, individuali e collettivi, del-le diverse « colonie » (quella tedesca, quella francese, quella olandese,quella inglese, quella greca e cosõÁ via) che animarono l'emporio. Soloallora potranno essere convenientemente individuati e analizzati i di-versi aspetti letterari, politici, musicali e artistici di questa civiltaÁ .
Se adottiamo questa prospettiva, il cosmopolitismo europeo con-verge in quello triestino che non appare come fenomeno originale macome risultato di una grande opera di mediazione culturale 30.
Tra quanti si sono interessati criticamente, nel corso del Nove-cento, al Litorale e all'Istria in questa prospettiva merita attenzione,per i contributi di analisi e per lo studio delle fonti, Cesare Pagnini 31.
217
come S. BENCO, Trieste e l'Austria dopo la Restaurazione, « Il Piccolo di Trieste », 5 set-tembre 1942, p. 3, quando criticoÁ l'immagine storiografica di « una Trieste del primoOttocento [...] repellente da tutto quello che turbasse la sua vita di commerciante, dellaquale aveva goduto nel Settecento i primi agi e le prime dolcezze. Pareva positivitaÁ ilrappresentarsi questa Trieste positiva, sempre ringhiosa contro chi venisse a insidiarela regolaritaÁ delle sue digestioni ».
30 Sul punto C. DIONISOTTI, Francesco Petrarca nella cultura triestina: Rossetti e Hor-tis, « Studi Petrarcheschi », n.s. IV (1987), pp. 1-2.
31 Sulla figura di Pagnini cfr. A. TANDURA, Tre mesi di spionaggio oltre Piave. Ago-sto-ottobre 1918, Soc. Ed. Longo & Coppelli, Treviso 1934 (ristampa Cooperativa Ser-vizi Culturali, Treviso 1993); A. TRAMPUS, Settant'anni di attivitaÁ storiografica di CesarePagnini, «Quaderni Giuliani di Storia », IX, 2 (1988), pp. 257-270, con la bibliografiadegli scritti; ID., Cesare Pagnini, « Archivio Veneto », CXXII (1991), pp. 179-182; F. SA-LIMBENI, Cesare Pagnini, « Archeografo Triestino », s. IV, LI (1991), pp. 475-495; F. SA-LIMBENI, Prefazione a C. PAGNINI, Risorgimento e Irredentismo nella Venezia Giulia, a cu-ra di A. TRAMPUS, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, Gorizia 1994,pp. 5-8; G. e L. MARSON, L'immagine in attesa. Una visita alla storia d'Europa attraversoil Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, H. Kellermann Editore, Vittorio Veneto1997, p. 45. Nato a Trieste nel 1899, Pagnini si accostoÁ giovanissimo alla storia giuliana,stimolato dalla lettura delle opere di Giuseppe Caprin e dalle assidui visite alla vedovaCaterina Croatto. Chiamato nel 1917 alle armi nell'esercito austroungarico, svolse atti-vitaÁ di spionaggio militare in favore della III e VIII Armata italiana, venendo decoratocon la croce di SS. Maurizio e Lazzaro. Laureato in giurisprudenza a Padova con Nino
Gli studi che hanno confermato il rilievo della sua opera nella culturaeuropea sono stati soprattutto quelli riguardanti Lorenzo Da Ponte,il librettista di Wolfgang Amadeus Mozart che soggiornoÁ a Gorizia ea Trieste negli anni Ottanta del Settecento. Di lui Pagnini aveva co-minciato ad interessarsi sin dal primo conflitto mondiale per giunge-re, dopo lungo lavoro, all'edizione Rizzoli delle Memorie e poi a quel-la accolta nella collana dei « Cento Libri » Longanesi, giudicata dallacritica italiana e straniera la piuÁ completa esistente, tanto da valerglinel 1980 il premio «Giovanni Comisso » 32. La stessa passione per lostudio e la ricerca portoÁ Pagnini ad approfondire quella importantefigura di intellettuale e di avventuriero che fu Giacomo Casanova:dal lungo sodalizio con Pietro Chiara e dai rapporti intensi con la So-cie te des Casanovistes (della cui rivista Pagnini fu uno degli editori)derivarono importanti contributi sul periodo triestino e goriziano delveneziano e una conoscenza del personaggio tanto profonda da farconsiderare Pagnini uno dei maggiori casanovisti in Europa. Ugualefama gli procurarono la riscoperta e l'edizione critica degli atti delprocesso criminale per l'uccisione a Trieste (1768) del padre del neo-classicismo Johann Joachim Winckelmann. All'edizione italiana neseguõÁ una in lingua tedesca e il curatore venne invitato con tributodi onori a Stendal, dove ricevette la medaglia Winckelmann, e all'u-niversitaÁ di Halle-Wittenberg dove gli fu conferito il diploma d'ono-re 33. Diede contributi pionieristici su altri temi di grande importan-za, prima quasi inesplorati, come sulla storia del giornalismo triesti-no, sugli scritti inediti di Antonio de Giuliani, che per primo riportoÁalla luce dopo le segnalazioni di Benedetto Croce, e sui diari del con-te Zinzendorf.
218
Tamassia nel 1924, divenne procuratore legale (1930), avvocato (1933), consultore co-munale sostituto del podestaÁ (1935-1940), vice commissario del Comune di Trieste(1941-1942) e podestaÁ (1943-1945). Nel dopoguerra, parallelamente alla professione fo-rense, fu impegnato nella costituzione e nella promozione delle principali istituzioni cul-turali della regione.
32 L. DA PONTE, Memorie, a cura di C. PAGNINI, Rizzoli, Milano 1960; ID., Memorieed altri scritti, a cura di C. PAGNINI, Longanesi, Milano 1971.
33 C. PAGNINI, Mordakte Winckelmann. Die Originalakten des Kriminalprozesses ge-gen den MoÈrder Johann Joachim Winckelmanns (Triest 1768), traduzione tedesca a curadi H.A. STOLL, Akademie Verlag, Berlin 1965.
Abbiamo ricordato l'attivitaÁ di Pagnini nel secondo dopoguerra,dopo aver citato quella di Cusin, per mostrare in che modo la storio-grafia giuliana ± grazie anche ad una forte attenzione per la dimen-sione europea dei problemi storici ± si sia sempre piuÁ orientata versol'indagine sugli strumenti e sulle forme di trasmissione del sapere(giornali, epistolari, memorialistica) della fine dell'Antico Regime.Lo studio delle pratiche culturali nella seconda metaÁ del Settecentoe nella prima metaÁ dell'Ottocento, proseguito negli anni, confermasenz'altro l'importanza di questo percorso.
Quando infatti, nella seconda metaÁ del XVIII secolo, venne af-fermandosi il ruolo egemone dell'emporio marittimo nell'alto Adria-tico, mentre nell'Istria veneta si manifestava con sempre maggioreevidenza il decadimento delle arti di Capodistria che aveva vantatoil primato culturale nella regione, venne « dedotta » a Trieste, da Go-rizia, la colonia arcadica di cui abbiamo avuto giaÁ occasione di scri-vere. L'Accademia degli Arcadi Romano-Sonziaci divenne elementodi coesione degli sforzi eruditi di quanti, numerosi e relativamenteisolati, operavano in campo culturale senza la disponibilitaÁ di un am-biente nel quale discutere, intrattenersi, confrontarsi.
Strana davvero questa accademia triestina. Non soltanto per lacomposizione, poiche riuniva nobili, uomini di governo, borghesi,sia del Litorale Austriaco sia dell'Istria; nacque nel 1784, quasi cen-t'anni dopo l'Arcadia romana, con la condanna di estinzione pratica-mente giaÁ segnata e non avrebbe proseguito i lavori oltre il 1797,continuando a boccheggiare fino al 1809. Eppure fu questa istituzio-ne a fondare, nel 1793, la prima biblioteca pubblica della cittaÁ , futuraBiblioteca Civica; da questa accademia fu espressa una sensibilitaÁnuova per le realtaÁ circostanti, contro la cieca chiusura negli studi an-tiquari. Fu il primo segnale di una nuova coscienza della funzione so-ciale dell'attivitaÁ intellettuale e della comprensione del rapporto traarti e industria. Non da ultimo, fu essa stessa, morente, a determinareper reazione il rinnovamento degli studi nell'Ottocento.
L'opinione che nel Litorale Austriaco settecentesco quasi nessu-no avesse avuto occasione di preoccuparsi dell'avvenire dell'emporio,perche totalmente coinvolto in un'epoca di prosperitaÁ economica,trova significative smentite. In accademia ben presto ai temi di di-scussione piuÁ disimpegnati vennero sostituendosi altri maggiormente
219
legati alle situazioni politiche ed economiche della regione 34. CosõÁ,verso la metaÁ del 1787, in Arcadia venne organizzata una sorta dicompetizione letteraria consistente nello svolgimento di una disserta-zione scritta sul tema Qual ramo di commercio convenga a questa piaz-za di Trieste, che sia ad un tempo il piuÁ favorevole all'industria delleprovince di Gorizia e Gradisca. Quindi quali siano li mezzi piuÁ proprionde dargli il massimo possibile incremento 35. Vi fu un vincitore, an-che se il confronto, come ebbe a riconoscere il goriziano Rodolfo Co-ronini Cronberg, non diede del tutto i risultati desiderati, soprattuttoperche la maggior parte delle dissertazioni risultoÁ insufficientementedocumentata e poco persuasiva. Vinse Pier Francesco Scati, « publi-co professore di chirurgia ed arte ostetricia nel Ginnasio goriziano » egiaÁ autore di un Compendio di educazione fisica e morale per allevare ifigliuoli sani, robusti, durevoli e virtuosi 36, con una Memoria sullascelta di un ramo di commercio il piuÁ favorevole alla piazza di Trieste,ed il piuÁ favorevole alle province di Gorizia e Gradisca 37. Vi si solle-
220
34 L'interesse per i temi di ordine economico quale chiave di lettura per l'attivitaÁdell'accademia triestina eÁ ora intuito da F. DONAÁ , La pagina neoclassica. « Incliti ed eru-diti » dell'Arcadia triestina, in CAPUTO (a cura di), Neoclassico, cit., pp. 280-285.
35 BCTs, segn. R.P. MISC. 3-26/7, carte non numerate.36 P.F. SCATI, Compendio di educazione fisica e morale per allevare i figliuoli sani,
robusti, durevoli e virtuosi, Cesarea regia stamperia dell'eccelso governo, Gorizia-Trieste1784. Come avverte la prima pagina, il volume fu « letto ed approvato dal Saggio Col-legio della Colonia arcadica degli Arcadi Romano-Sonziaci il dõÁ 8 febbraio 1784 ».
37 Pubblicata appena nel 1795, dopo essere stata ripresentata e premiata in Arcadia:P.F. SCATI, Memoria sulla scelta di un ramo di commercio piuÁ conveniente alla piazza diTrieste ed il piuÁ favorevole alle provincie di Gorizia e di Gradisca, Tipografia governativa,Trieste [1795]. Viene frainteso da DONAÁ , La pagina neoclassica, cit., p. 280, il giudizio ne-gativo che della Memoria diede Pietro Antonio Pittoni, direttore di polizia; giudizio chesecondo questa autrice sarebbe rivelatore di una « comprensibile diffidenza per le letteredi un capo di polizia e membro dell'Accademia con funzioni piuÁ che altro decorative »,mentre dovrebbe essere interpretato piuÁ correttamente, a mio avviso, come semplice ma-nifestazione di dissenso sul contenuto dello scritto. Per Pittoni e per la piena compren-sione della sua personalitaÁ , anche dal punto di vista culturale, cfr. i riferimenti infra, cap.II. Gustoso il ritratto di Pittoni che viene fornito da Giacomo Casanova nella Storia dellamia vita, III, cit., p. 962: « era persona amabile e faceta, aveva uno spirito adorno di cul-tura letteraria ed era privo di pregiudizi. Nemico di ogni economia, non condivideva ilprincipio del questo eÁ tuo e questo eÁ mio e aveva affidato completamente la cura dellasua casetta al domestico che lo derubava, ma non trovava che cioÁ fosse una cattiva azione,dal momento che ne era a conoscenza. Scapolo per principio, esaltava con enfasi il celi-
citava l'aumento del commercio di transito nel Litorale, il potenzia-mento dell'industria manifatturiera, l'attuazione di un potente siste-ma di interscambio economico tra il porto e l'entroterra. Consideravache « non si potraÁ mai gloriare una nazione di essere ricca, secondo ilpresente sistema dell'Europa, quando non abbia un ben frequentatoporto di mare; ne un porto di mare avraÁ mai gran fondo di reale opu-lenza, qualora nelle sue province e campagne non si raccolgano, me-diante una ben sistemata agricoltura, quelle materie prime, che attesono al sostentamento, sõÁ degli uomini, che degli animali e delle ma-nifatture; come altresõÁ al concambio o vendita pecuniaria delle mede-sime a quelle genti, che di tali generi scarseggiano » 38. E FrancescoMaria de Steffaneo, in Arcadia « Filindo Locrense », nello stendere ilparere favorevole alla pubblicazione della Memoria, citava a confortodelle proprie osservazioni gli « Atti della reale societaÁ delli Georgofi-li » di Firenze (1758), la History of Trade of England di John Cary, laHistoire de l'Accademie des Sciences de Paris (1779) e le Istruzioni ele-mentari di agricoltura di Angelo Fabroni 39.
PiuÁ tardi, nell'aprile 1796, quando giaÁ trovavano larga eco le ge-sta delle armate francesi in Italia, Francesco Antonio Guadagnini(1728-1814), consigliere magistratuale 40, presentava in Arcadia unTrattato sul commercio di Trieste, considerato nel suo reale ed attualevalore, corredato di riflessioni dimostrative sul futuro di lui ingrandi-mento; testo purtroppo perduto, ma che sembra fosse accolto conmolto favore 41. Nello stesso 1796 veniva presentato uno scritto dal
221
bato. Galante, come eÁ ovvio, col bel sesso, era amico e protettore di tutti i libertini. Pigroe indolente, andava soggetto a distrazioni imperdonabili che gli facevano molto spessocorrere il rischio di dimenticare affari importantissimi, anche se strettamente legati allasua carica. Si diceva che mentisse volentieri, ma non era vero: non diceva la veritaÁ soltantoperche , avendola dimenticata, non poteva dirla. Tutti questi tratti del suo carattere sonotali quali ebbi modo di rilevarli circa un mese dopo aver fatto conoscenza con lui. Diven-tammo infatti ben presto buoni amici e lo siamo tuttora ». Le lettere di Pittoni a Casanovasono state pubblicate da P. MOLMENTI, Carteggi casanoviani, Sandron, Napoli 1919.
38 SCATI, Memoria, cit., p. 11.39 SCATI, Memoria, cit., pp. 31, 33, 35.40 Su Guadagnini si vedano i documenti in ASTs, Cesareo Regio Governo del Lito-
rale, busta 131/1780 e ivi pure la busta 44/1792; inoltre ADTs, segn. 7 G 14/2.41 DE FRANCESCHI, L'arcadia romano-sonziaca, cit., p. 152. Nello stesso saggio, alle
pp. 214-225, eÁ riportato l'elenco completo delle dissertazioni accademiche.
titolo programmatico Quale sia il ramo di commercio marittimo checonverrebbe render stabile e continuo in Trieste. Quale l'utilitaÁ che de-riverebbe dallo stabilirlo e coltivarlo. Quali mezzi piuÁ facili e meno pe-ricolosi per conseguire l'intento 42. Ne era autore Samuele Vital daZante, un arcade che si era occupato per trent'anni a Venezia, dal1758, di commercio marittimo e di assicurazioni e che si era stabilitoa Trieste nel 1788 spinto « dall'attaccamento per la cittaÁ » 43, e da unrimunerato impiego di segretario alla Camera d'assicurazioni. Vital,che si sarebbe fatto apprezzare di lõÁ a poco, nel 1797, per la pubbli-cazione di alcune Riflessioni sulle assicurazioni marittime e loro pro-gressi in Trieste 44, suggeriva il potenziamento delle strutture portualie lo sviluppo del « commercio assicurativo », che riteneva di grandeimportanza per una cittaÁ marittima.
Non tutte queste trattazioni accademiche ebbero diretta influen-za sulle decisioni delle autoritaÁ governative locali; molte, anzi, stenta-rono a superare il carattere di impegno estemporaneo, indirizzato piuÁalla riflessione teorica che alla pratica attuazione. Appare peroÁ suffi-cientemente evidente la positiva influenza prodotta nel mondo eco-nomico cittadino dall'opera politica di Antonio de Giuliani, cheper primo, nel 1785, aveva richiamato l'attenzione sul rapporto traeconomia e scienza dello Stato nelle Riflessioni politiche sopra il pro-spetto attuale della cittaÁ di Trieste.
All'Arcadia eÁ legata pure la nascita delle prime gazzette della re-gione. Mentre Gorizia ± come abbiamo visto nei precedenti capitoli± pote vantare fin dal 1774 la pubblicazione della «Gazzetta Gorizia-na » di Valerio de' Valeri, editore in quello stesso anno della Storiadelle turbolenze di Polonia di Casanova, a Trieste fu necessario atten-dere il consolidamento dell'economia portuale per avvertire piuÁ fortel'esigenza di mettere a disposizione del pubblico, e anzitutto dei ne-gozianti, un valido strumento di informazione economica e politica.Dal gennaio 1777, a seguito delle disposizioni del governatore von
222
42 BCTs, segn. R.P. MS MISC. 3-26/7.43 Ms. cit., ibid., c. 35r.44 S. VITAL, Riflessioni sulle assicurazioni marittime e loro progressi in Trieste, Stam-
peria del governo, Trieste 1797.
Zinzendorf, come giaÁ accennato, venne pubblicato settimanalmenteun foglio dal titolo « Portate dei bastimenti », per cura del Magistratodi SanitaÁ Andrea Giuseppe de Bonomo, contenente note sulle navi esulle merci che entravano nel porto di Trieste 45, seguito dal « Trie-ster Weltkorrespondent » di Moll, l'intraprendente autore-editoredella Historisch-statistische Beschreibung der Stadt Triest, il primo si-gnificativo esempio di iniziativa editoriale concepita come servizioper la collettivitaÁ 46. In entrambi i casi l'uso della lingua tedesca ri-spondeva potenzialmente alle esigenze di mettere un buon mezzodi comunicazione a disposizione di un'ampia fascia di operatori com-merciali e di favorirne la diffusione in tutta la monarchia. Il giornale,di quattro pagine, veniva pubblicato ogni lunedõÁ e giovedõÁ e nelle in-tenzioni dell'editore-direttore avrebbe dovuto contenere non soltan-to le indispensabili notizie di carattere economico e statistico, ma an-che aggiornate informazioni su avvenimenti culturali italiani. EÁ signi-ficativo che giaÁ si intendesse dare notizia di iniziative culturali: segnoche i destinatari di quel periodico non erano privi di sensibilitaÁ cul-turale ma avvertivano anzi la necessitaÁ di forme di comunicazione piuÁcomplete possibili. Purtroppo non soltanto risultano sconosciuti inomi dei collaboratori all'iniziativa di Moll, ma pure non eÁ stata an-cora ritrovata una raccolta completa del giornale. Ne sono note duesole copie (del 5 aprile 1781 e del 26 settembre 1781), per cui ogniulteriore considerazione rimane confinata alla lettura del programmaeditoriale presentato dal tipografo 47.
Nel 1782 lo stesso Moll diede poi alle stampe il volume TriesterKaufmannsalmanach fuÈr das Jahre 1782, che non ebbe peroÁ seguitoimmediato. Cessate le pubblicazioni del « Triester- Weltkorrespon-
223
45 PAGNINI, I giornali di Trieste, cit., pp. 20-22.46 Sui giornali in lingua tedesca cfr. DE LUGNANI, La cultura tedesca, cit., pp. 15-17.
Della Historisch-statistische Beschreibung di Moll esiste oggi una traduzione italiana conil titolo Descrizione storico-statistica della cittaÁ di Trieste e del suo territorio (1782) a curadi S. DEGLI IVANISSEVICH (Italo Svevo, Trieste 1992) che, sulla scorta di un'affermazione(peraltro vaga) di KANDLER, Discorso sulle storie di Trieste, cit., p. 186 la attribuisce er-roneamente ad Andrea Giuseppe Bonomo, contro le testimonianze coeve (cfr. anche A.TRAMPUS, Storia della cultura e storia della storiografia. La `̀ Trieste letterata'' di LorenzoMiniussi, «Quaderni Giuliani di Storia », 1-2 (1991), p. 68).
47 Cfr. ancora PAGNINI, I giornali di Trieste, cit., pp. 21-22.
dent » nel 1782 e a parte l'effimera esperienza (probabilmente duratasoltanto pochi mesi) della « Triester politische und Handlungs-Zei-tung » 48, seguõÁ nel 1786 un nuovo giornale in lingua tedesca con iltitolo «Nachrichten und Vorfallenheiten der See ± und HandelsstadtTriest » (= «Notizie e accadimenti della cittaÁ marittima e commercia-le di Trieste ») durato circa un anno. Ne era nota una sola copia, la n.23 del 2 agosto 1786 49, ma ne abbiamo rintracciato il primo numero,del primo marzo 1786 50, contenente varie notizie politiche e com-merciali, comunicati e decreti ufficiali, l'elenco dei bastimenti entratinel porto di Trieste, ma anche notizie di carattere storico, in partico-lare sull'origine delle prime gazzette europee e tedesche.
Dal luglio 1784, peroÁ , era nato il primo periodico in lingua ita-liana, destinato a vita lunga (fino al 1933) e fondato da Giuseppede Coletti, il pastore arcade segretario e « deduttore » dell'ArcadiaRomano-Sonziaca a Gorizia e a Trieste 51. Non piuÁ precariamente, al-le notizie ufficiali, politiche e commerciali si alternarono fin dai primianni le informazioni di carattere culturale. Argomenti di moda e diattualitaÁ , come un Discorso sopra il lusso di questo secolo nel numerodel 4 febbraio 1786 52 o l'edizione di Aneddoti sopra la vita privata diFederico il Grande nel numero del 23 dicembre 1786 53. Componi-menti arcadici, come il Sonetto in morte di M. Levi, di Paolo Pede-
224
48 PAGNINI, I giornali di Trieste, cit., p. 2549 PAGNINI, I giornali di Trieste, cit., pp. 25-30.50 ASTs, Cesareo Regio Governo del Litorale, busta 561, prot. 1347/1786, carte non
numerate.51 Una rassegna delle cronache del giornale, limitata quasi esclusivamente alle no-
tizie della vita quotidiana, eÁ stata pubblicata da DE INCONTRERA, Vita triestina del Sette-cento, cit., in molte puntate apparse nel periodico «La Porta Orientale » tra le annateXXII (1953) e XXIII (1963) per il periodo 1784-1792. Alla produzione delle gazzettesi riferisce inoltre, nonostante il titolo assai piuÁ generale, il breve saggio di N. CARBONI
TONINI, L'editoria a Trieste dal 1780 al 1840, in CAPUTO (a cura di), Neoclassico, cit., pp.311-312; si veda anche EAD., Il giornalismo a Trieste dal 1780 al 1840. Informazioni ecultura, « Archeografo Triestino », s. IV, LI (1991), pp. 205-237.
52 « L'Osservatore Triestino », n. 5, 4 febbraio 1786, pp. 65-67. Giungeva eviden-temente anche nel Litorale Austriaco l'eco della polemica sul lusso, che aveva dato ori-gine a molti dibattiti in Francia e nella penisola italiana. Per un'introduzione al tema cfr.C. BORGHERO (a cura di), La polemica sul lusso nel Settecento francese, Einaudi, Torino1975.
53 « L'Osservatore Triestino », n. 41, 23 dicembre 1786, p. 663.
monti nel numero dell'11 febbraio 1786 54 o i sonetti degli arcadi An-tonio Carpaccio di Trieste La Gallia a noi disserra l'urna de' Mali... edi Giulio Gravisi istriano L'Italia al Generale francese Buonaparte nelnumero del 19 agosto 1796, nel quale pure ci si affrettoÁ a pubblicarela Stanza 76, canto XX, della Gerusalemme Liberata del Tasso « con-dannata con Decreto del Parlamento di Parigi » 55. Oppure, ancora,si diedero notizie storico-erudite, sulla paleocristiana chiesa dei SantiMartiri di Trieste, nel numero del 22 aprile 1786 56 e su L'estensionedell'antico Illirio da una dissertazione del capodistriano FrancescoAlmerigotti, nel numero del 24 giugno dello stesso anno 57. O infineannunci editoriali, come quello della grammatica italiana e tedescadel triestino Francesco Champion, « la sola che sia per abilitare laNazione italiana ad apprendere con fondamento, e facilitaÁ la linguatedesca ormai necessaria per ogni europeo », nel numero del 2 set-tembre 1786 58, o dell'edizione postuma della Storia della contea diGorizia di Carlo Morelli (« tomi VI in 8vo. gr. ») presso la tipografiaWage, Fleis e C. di Trieste, con un lungo Manifesto degli editori nelnumero del 26 ottobre 1796 59.
Dalla metaÁ del XVIII secolo piuÁ fertile divenne allora il terrenosul quale si cimentarono gli intellettuali della regione, quasi sempreimpegnati non professionalmente nella letteratura e nella ricerca sto-rica. Non che in precedenza, nei primi anni del secolo, vi fosse undeserto assoluto, ma i non molti operatori individuati ± oltre chedi relativo interesse per il valore scarso dell'impegno erudito ± si pre-sentavano del tutto isolati prima di esperienze come quella di Anto-nio Marenzi, giaÁ ricordato. Trascorsa la grande stagione tardosecen-tesca dell'erudizione cronachistica, che vide per Trieste la Historia(1698) di padre Ireneo della Croce, per la Carniola Die Ehre des Her-zogthums Krain (1689) di Valvasor e Carniola antiqua et nova (1688)di Ludwig SchoÈnleben, per l'Istria la Corografia ecclesiastica di Giu-
225
54 «L'Osservatore Triestino », n. 6, 11 febbraio 1786, p. 78.55 « L'Osservatore Triestino », n. 69, 19 agosto 1796, pp. 1234-1235.56 « L'Osservatore Triestino », n. 16, 22 aprile 1786, p. 212.57 « L'Osservatore Triestino », n. 25, 24 giugno 1786, p. 335.58 « L'Osservatore Triestino », n. 35, 2 settembre 1786, p. 712.59 « L'Osservatore Triestino », n. 91, 28 ottobre 1796, pp. 1634-1638.
stinopoli (1700) di Naldini 60, nonche un pari numero di altri autori(Scussa per Trieste, Tommasini e Petronio per l'Istria e altri) recupe-rate dagli studi storici dell'Ottocento e del Novecento, sembroÁ chepoco o nulla fosse da aggiungere alle ricostruzioni storico-antiquariedi questi personaggi.
Se ne trae l'impressione considerando l'attivitaÁ ± che puoÁ definir-si di « studioso » solo in senso lato ± svolta dal triestino AntonioScussa, pronipote di don Vincenzo Scussa autore della Storia crono-grafica di Trieste scritta nel 1695.
Nato nella cittaÁ adriatica proprio nel 1695 e ivi morto nel dicem-bre 1749, Antonio Scussa fu ordinato sacerdote e divenne cappellanosulla nave « Santa Elisabetta ». Poi svolse l'attivitaÁ di sacerdote nellacittaÁ natale presso la chiesa della Madonna del Mare e infine al con-vento delle monache benedettine 61. Non fu personaggio di culturaprofonda o particolarmente apprezzabile, ma dovette acquisire qual-che esperienza, anche culturale, con le letture inerenti il suo ufficio.Nelle sue mani era giunto il manoscritto inedito dello zio don Vin-cenzo, fatto che dovette stimolarlo in qualche modo negli interessistorici. CosõÁ si determinoÁ alla compilazione di una cronaca che potes-se aggiornare la Storia cronografica, dal titolo Scritti de brevi annota-zioni de cose seguite nella CittaÁ di Trieste..., piuÁ semplicemente cono-sciuta come I diari.
Giacomo Braun, che nel 1929 curoÁ l'edizione a stampa di questidiari 62, suggerõÁ l'ipotesi che tale lavoro fosse stato iniziato dal sacer-dote quando ancora esercitava il suo ufficio in mare, concependolocome sorta di « giornale di bordo »; pure, eÁ evidente come Scussa do-vette ispirarsi direttamente alla narrazione dello zio la quale, pur ri-guardando la storia di Trieste dalle origini al XVII secolo (compren-dendo quindi un arco temporale assai lungo) fu chiaramente redattain forma cronachistica e annalistica. CosõÁ Antonio Scussa limitoÁ il suo
226
60 NEGRELLI, Comune e impero, cit., pp. 3-65.61 Per la biografia cfr. DE JENNER, Biografie triestine, ms. cit., ADTs, segn. 1/1 B 4,
carte non numerate.62 G. BRAUN, I diari di Antonio Scussa, I (1732-1738), « Archeografo Triestino », s.
III, XV/1 (1929-1930) con introduzione critica alle pp. III-XVII e II (1739-1749), « Ar-cheografo Triestino », s. III, XV/2 (1931).
compito alla registrazione meticolosa degli accadimenti cittadini dal1732 al 1749, anno della morte, non curando aspetti stilistici e forma-li e intendendo soltanto documentare un determinato periodo dellastoria della cittaÁ natale. Per il suo riferirsi implicito ma non tanto in-diretto alla tradizione diarista secentesca rimase sostanzialmente unoperatore modesto e isolato, da non ignorare peroÁ nella ricostruzionecomplessiva dell'ambiente degli eruditi della regione.
Di diverso valore fu invece l'attivitaÁ di Aldrago de Piccardi. Coa-diutore di de Bonomo nel riordinamento dell'archivio della Vicedo-mineria di Trieste, de Piccardi nacque nella cittaÁ marittima nel 1708da famiglia patrizia originaria di Verona e morõÁ nel 1789 63. Compiu-to il consueto cursus studiorum presso i Padri Gesuiti con l'appren-dimento della grammatica, della retorica, della filosofia e della teolo-gia, de Piccardi fu ordinato sacerdote nel 1731 e negli anni successiviandoÁ coltivando gli interessi storici e la passione per la tradizione an-tica e medioevale, l'archeologia e la diplomatica. Nella carriera eccle-siastica fu promosso alla dignitaÁ di decano capitolare fin dal 1759 edivenne vescovo di Pedena in Istria nel 1767. Signore di Gologorizza(Moncalvo, nell'Istria austriaca) e consigliere cesareo, de Piccardi fusoprannominato, per il suo vivere con semplicitaÁ , « il vescovo dellenocciole », in quanto con il modesto reddito percepito riceveva in ag-giunta dal Comune locale un'offerta in nocciole 64. Non rinuncioÁ tut-tavia agli studi e alla ricerca, impegnandosi addirittura nello scavodella cantina nella sua abitazione di Trieste ove rinvenne le vestigiadel tempio romano di Cibele e un'antica ara, poi descritta dai suoiamici, l'aquileiese Gian Domenico Bertoli e Gianrinaldo Carli 65.
Trasferito nel 1783 al vescovato di Segna e Modrussa, de Piccar-di vi rimase per cinque anni, fino alla soppressione decretata dalle ri-forme giuseppine. Indi ritornoÁ a Trieste, immergendosi sempre piuÁ
227
63 I dati biografici sono forniti da DE JENNER, Genealogie, ms. cit., ADTs, segn. 1/1B 4, c. 156 e da DE INCONTRERA, Vita triestina, cit., « La Porta Orientale », XXVI (1956),p. 325 e XXVIII (1958), pp. 229-230.
64 L. DE JENNER, Del Vescovo di Pedena Aldrago Antonio de Piccardi, « L'Istria », V,44 (1850), p. 301; B. HACQUET, Abbildung und Beschreibung des suÈdwest- und oÈstlichenWenden, Leipzig 1808.
65 CARLI, Delle antichitaÁ italiche, cit., III, p. 56.
negli studi di erudizione. Dal 1787 fu, per breve tempo fino alla mor-te, membro dell'Arcadia Romano-Sonziaca.
Benche molto noto agli storici del Litorale nell'Ottocento, tra cuiKandler, non pubblicoÁ alcuno scritto, fatta eccezione per una letteradi argomento archeologico edita postuma a San Vito nel 1836, assie-me ad altre di Francesco Florio e di Gian Domenico Bertoli 66. Lamemoria di lui eÁ affidata soprattutto, anche presso i moderni cultoridi storia istituzionale del Comune medioevale, al cosiddetto CodicePiccardi. EÁ una raccolta di documenti, diplomi, rescritti, ecc. del Me-dioevo, frutto di paziente opera di trascrizione di fonti (non sempre,peroÁ , in lezione corretta) oggi parzialmente perdute 67, che si puoÁconsiderare il precedente storico del Codice diplomatico istriano cu-rato nel secondo Ottocento da Pietro Kandler. Manca invero nel Co-dice Piccardi qualsiasi apparato critico, peroÁ esso documenta pursempre gli interessi storiografici del copista e una sensibilitaÁ all'epocanon comune per l'etaÁ medioevale e per il sistema delle fonti.
Diversa e singolare fu la vicenda di Pasquale de Ricci, homo no-vus dell'emporio teresiano, sul quale si eÁ soffermata Maria GraziaBiagi 68. Nacque a Livorno nel 1721; il padre Giovan Pietro, impor-tante commerciante nella cittaÁ toscana, aveva acquistato fama nel1738 presentando al governo lorenese un progetto per la riforma del-la Camera di Livorno. Il fratello Giuliano fu per tre volte gonfalonie-re di quella cittaÁ e autore di alcune memorie di argomento economi-co e commerciale. Incerti restano comunque alcuni dati biograficisulla formazione culturale di Pasquale de Ricci. Sembra che esercitas-se per qualche tempo la professione di commerciante nella cittaÁ na-tale e poi, nel 1750, a Trieste. Qui peroÁ fu chiamato alla carica di vi-cario civile del Comune, per la quale era richiesta la cittadinanza stra-niera e la laurea in giurisprudenza, il che farebbe ritenere che si fossepure laureato in legge. Nel 1754 divenne consigliere del commerciodella Cesarea Suprema Intendenza Commerciale nel Litorale e nel
228
66 Lettere inedite. Per nozze Gattorno-De Rocco, Pascatti, San Vito, 1836.67 Il codice si trova in ADTs, segn. a B 4 ed eÁ stato descritto supra, cap. VII, p. 195.68 BIAGI, Giuseppe Pasquale Ricci, cit.; sul personaggio inoltre DE INCONTRERA, Il
barone Pasquale de Ricci, cit.
1776 consigliere effettivo in commercialibus presso il Cesareo RegioGoverno. Quindi, fino al pensionamento (nel 1783, morõÁ nel1791), ebbe incarichi di consigliere governativo, di presidente dele-gato in publicis et oeconomicis e di direttore della Cancelleria gover-nativa.
Studioso accorto di scienze economiche e giuridiche, de Riccinon diede alle stampe alcuno scritto, lavorando prevalentemente inseno agli organi governativi come funzionario pubblico, ma stenden-do una quantitaÁ notevole di pareri e di memorie tecniche che lo qua-lificarono come uno dei piuÁ avveduti amministratori del porto fran-co. Ammiratore delle dottrine mercantilistiche e attento studioso delcolbertismo, fu autore del primo progetto per l'Editto di Marina eNavigazione per i bastimenti mercantili (1758-1760), ispirato alla ce-lebre Ordonnance de la marine promossa da Colbert (1681). CompiloÁil regolamento della neoeretta Borsa mercantile di Trieste, stese unprogetto per l'Istituto dei pegni e per una compagnia di assicurazio-ni. Sostenitore tempestivo delle teorie genovesiane delle Lezioni dicommercio, discusse criticamente i principi degli EleÂmens du Com-merce di Forbonnois, dimostroÁ conoscenza e apprezzamento per ta-lune massime di Montesquieu, appassionandosi pure nei dibattiticontemporanei sul lusso. Nella sua biblioteca si trovavano le operedi Rousseau, di Verri, di Beccaria.
Fu pure in buoni rapporti con Gianrinaldo Carli, documentatida una sua missiva al capodistriano, presidente del Supremo Consi-glio di Economia. Dichiarava (lettera del 16 gennaio 1769) la sua am-mirazione sottolineando che « da lungo tempo la stimo e la rispetto, eche mi pregio della sua padronanza », augurandosi « di esercitare inqualche incontro di suo servizio la mia insufficienza » 69. Chi si valsedella sua opera, e in particolare il conte Zinzendorf durante il gover-natorato triestino (1776-1782), mantenne un atteggiamento critico 70.Del resto sin dai primi anni del soggiorno triestino un osservatore ve-neto aveva scritto di lui che « eÁ in etaÁ giovanile, il quale dovrebbeavere qualche principio di lume pel commercio per essere stato rile-
229
69 AmC, Fondo Carli, reg. 1501, cc. 111-112.70 PAGNINI, Il periodo triestino, cit., p. 43-50, 87-96 e passim.
vato sotto il suo genitore in Livorno, Pietro Ricci, il quale eÁ stato uo-mo di gran cognizione nel negozio, ma egli a tutt'altro attende che afissare nelle sue incombenze » 71.
Mentre tra il Litorale e l'Istria si svolsero gli studi di Aldrago dePiccardi e tra Livorno e Trieste operoÁ Pasquale de Ricci, nella conteadi Gorizia e di Gradisca fu impegnato Alessandro de Fin, uno deiprimi Arcadi goriziani. Triestino di nascita (1751), figlio del baroneFrancesco de Fin (antica famiglia di origini bergamasche) e della con-tessa Antonia de Clary, fu viennese di educazione avendo studiato alTheresianum, il noto collegio riservato ai rampolli della nobiltaÁ 72.Rientrato in patria fece carriera in seno all'amministrazione dello Sta-to, divenendo nel 1789 aggiunto circolare dell'Ufficio circolare dellecontee di Gorizia e di Gradisca. Fu arcade della prima ora, di aiutoa de Coletti nella formazione dell'Accademia goriziana, nel cui « ser-batojo » lesse sovente le proprie composizioni poetiche in lingua la-tina, in lingua tedesca e in quella italiana. Alcune sue « dissertazioniaccademiche » furono ricordate da Codelli nella sua operetta Gliscrittori friulano-austriaci degli ultimi due secoli, come quella Soprai dizionari portatili e l'altra Sopra l'infelice fine de' poeti, « entrambescritte con molta leggiadria e con molta erudizione ». Al volumetto dide Codelli eÁ affidata quindi la memoria dell'attivitaÁ letteraria di deFin, morto a Gradisca verso il 1797, che come scrittore « friulano-au-striaco » fu autore di composizioni che « hanno avuto non poco in-contro nell'accademia eretta l'8 agosto 1780 in questa cittaÁ [Gorizia],delle cui sregolate radunanze avrei molto da dire, se a cuor suo nonmi fosse il non offender alcuni saggi » 73. Resta inoltre a stampa, di deFin, il componimento su foglietto volante dal titolo Empfindungenbei dem Tode der groÈssten, und unsterblichen Monarchin Theresens,A.F. de F. unter den GoÈrzer Arcadiern Rebiscus Medoneus, in mortedi Maria Teresa 74.
230
71 TUCCI, Una descrizione di Trieste, cit., pp. 99-100.72 Dati biografici in DE JENNER, Genealogie, ms. cit., in ADTs, segn. 1/1 B 4, c. 171.73 P. CODELLI, Gli scrittori friulano-austriaci degli ultimi due secoli, Tommasini, Go-
rizia 1785.74 Il sottotitolo recita Geschrieben den 4ten Christmonates in GoÈrz, und gedruckt bei
Jacob Tommasini k.k. privilegirten Land- und Schul- Buchdruckern, 1780.
Tornando alle pubblicazioni arcadiche goriziane e triestine, meritaancora ricordare brevemente che all'Accademia goriziana fu « aggre-gato » Lorenzo Da Ponte (con il nome arcadico di «Lesbonico Pega-sio »), il librettista di Mozart legato al Litorale Austriaco anche per al-tri motivi, in quanto piuÁ tardi amico personale di Domenico Rosset-ti 75. Da Ponte pubblicoÁ a Gorizia Il Capriccio, poemetto eroicomico(presso Valerio de Valerj, Gorizia 1780), Il Conte di Varvic. Tragediain cinque atti portata dal francese (presso Valerio de Valerj, Gorizia1780) e Alla SantitaÁ di Pio VI Pontefice Massimo nella sua venuta aVienna. Sonetti (SchoÈnfeld, Gorizia s.d.). Tra gli altri, poi, eÁ utile ricor-dare Lorenzo Rondolini, poi tra i fondatori della SocietaÁ del Gabinet-to di Minerva a Trieste e tra i primi a rendere noto nella regione l'in-nesto del vaiolo con la Dimostrazione al popolo della utilitaÁdell'innestodel vajuolo (Tip. Magistratuale, Trieste 1797), mentre il giaÁ ricordatoSamuele Vital avrebbe piuÁ tardi dato alle stampe, sempre qualifican-dosi come pastore arcade, l'opuscolo Dell'utile istituzione de' convogliprivati in tempo di guerra (Stamperia del Governo, Trieste 1799).
Legata all'attivitaÁ dell'Arcadia triestina fu in qualche modo anchel'opera di Girolamo Gravisi, il cugino e grande amico di GianrinaldoCarli, nato a Capodistria nel 1720 e lõÁ morto, ultranovantenne, nel1812 76. Gravisi eÁ figura centrale nella storia della cultura istrianadel Settecento, in quell'ambito piuÁ ancora forse di Carli che, anchesenza mai recidere il legame con la terra natale, in realtaÁ operoÁ e vissequasi sempre lontano dall'Istria. Gravisi, invece, pur non raggiun-gendo il livello culturale di Carli, visse e lavoroÁ nella penisola diven-tando il maggior animatore dell'attivitaÁ culturale nell'Istria e riferi-mento fondamentale per quanti, come Carli, mantenevano da lonta-no il legame con la patria d'origine.
Compiuti gli studi a Capodistria e laureatosi a Padova, GravisirientroÁ nella cittaÁ natale e fu « principe » dell'Accademia dei Risorti,lavorando inizialmente con Gianrinaldo Carli e poi, dopo il 1770,
231
75 ROSSETTI, Scritti inediti, II, cit., pp. 445-613.76 VENTURINI, Il casato dei marchesi Gravisi, cit., pp. 296-346; P. STANCOVICH, Bio-
grafia degli uomini distinti dell'Istria, II, Marenigh, Trieste 1829, pp. 171-175; G. QUA-
RANTOTTO, Settecento poetico capodistriano, « Pagine istriane », s. I, VI (1908), pp. 247-258.
con gli amici Gian Paolo Polesini e Stefano Carli. Pur sensibile allepiuÁ significative espressioni culturali del tempo, si specializzoÁ soprat-tutto nella storia antica, dimostrando attaccamento per la tradizionestoriografica, erudita e antichistica, che aveva affascinato Carli nellagioventuÁ . Scrisse sui traffici commerciali aquileiesi dell'antichitaÁ ver-so il Friuli, il Timavo e il Danubio (1775), pubblicoÁ un Esame criticodell'Illirico forojuliese (1789) e si soffermoÁ sulla storia di Parenzo, inappassionata polemica con Bartolomeo Vergottin (1796). Mantennepure una fitta rete di corrispondenze ± soltanto in parte studiate ±con alcuni tra i maggiori letterati italiani dell'epoca, come ApostoloZeno, Melchiorre Cesarotti e Girolamo Tiraboschi 77. Del resto note-vole eÁ l'impressione sul personaggio che si ricava dalla lettura del car-teggio intrattenuto per piuÁ decenni con il cugino Gianrinaldo Carli(che gli dedicoÁ le Lettere americane, nel 1780), anche se ancora devo-no essere pubblicate le sue lettere a Carli, a completamento di quelleinviategli dal cugino.
PiuÁ giovane, Gian Paolo (o Giampaolo) Polesini nacque a Mon-tona nel 1739 e visse oltre novant'anni, morendo a Parenzo nel 1829,quando Pietro Stancovich andava completando la Biografia degli uo-mini distinti dell'Istria 78. Dopo aver studiato a Parenzo e dopo essersilaureato in legge a Padova, rientroÁ in Istria, mantenendo le amiciziedel periodo padovano con intellettuali veneti e con Cesarotti in par-ticolare, del quale fu a lungo corrispondente. Pur non disprezzandogli argomenti storici istriani, Polesini si distinse rispetto ai compagnidell'accademia capodistriana ± forse maggiormente influenzato dallacultura propriamente veneta ± per l'attenzione specifica a tematicheeconomiche e agrarie. Fu autore nel 1792 di un saggio su Lo spiritodel commercio e, in quello stesso periodo, di uno scritto Della preser-vazione degli olivi nell'Istria. Succedendo a Gravisi, divenne « princi-pe » dell'Accademia dei Risorti e fu pure membro dell'Arcadia Roma-no-Sonziaca.
Sono documentate inoltre le sue relazioni epistolari con il me-dioevalista veneto Giovanni Brunacci, con Omobon Pisani docente
232
77 Qualche conferma in AmC, reg. 1486, c. 210 e segg.78 Su di lui STANCOVICH, Biografia, cit., III; ZILIOTTO, Storia letteraria, cit., p. 57.
di medicina a Padova, con Alberto Fortis e pure con GianrinaldoCarli 79.
A questo proposito, l'epistolario di Gianrinaldo Carli rivela conprecisione una delle caratteristiche piuÁ interessanti della sua com-plessa personalitaÁ culturale, cioeÁ il costante rapporto che mantenneper tutta la vita con gli intellettuali della penisola istriana. Svolsequindi un ruolo di mediatore culturale, contribuendo in misura rile-vante all'affrancamento della cultura istriana dall'intorpidimento incui versava, indotta ancora verso le tematiche classiche della tradizio-ne veneta secentesca. Verso l'Istria Carli corrispose con Maria Gio-vanna Rigo (1761), con il capodistriano Giacomo de Belli (1761),con il vescovo di Capodistria Bonifacio da Ponte (1781) e con Pietrode Gavardo (1785). Verso il Litorale Austriaco con Andrea Giusep-pe de Bonomo e, prima, con de Ricci e con l'Intendente commercialeHeinrich von Auersperg (1767). Verso la Dalmazia con Michele diSorgo (Sorkocevic), all'epoca della stesura delle AntichitaÁ italiche(1790); verso il Friuli con Angelo Cortenovis (1790) e, prima, conil vecchio precettore abate Bini e con Jacopo Stellini 80.
Un altro epistolario particolarmente interessante per la ricostru-zione della fitta rete di rapporti tra gli intellettuali delle sponde del-l'Adriatico e, piuÁ in generale, dell'Europa, eÁ quello di Giacomo Ca-sanova.
Nelle lettere del barone Sigismondo Zois a Casanova, risalentiagli anni 1773-1775 81, due sostantivi appaiono usati ricorrentementeper indicare la qualitaÁ del veneziano, apprezzate dallo scrivente e am-mirate da quanti lo avevano conosciuto nel Litorale: « talent » ed« eÂrudition ». Un carteggio, pur breve e isolato, come quello che
233
79 DE FRANCESCHI, Gian Paolo Sereno Polesini, cit., pp. 200-212.80 Cfr. l'epistolario di Carli in AmC, regg. 1500-1502; cfr. inoltre E. APIH, Il preil-
luminismo italiano dal Friuli all'Istria, in La filosofia friulana e giuliana nel contesto dellacultura italiana, Arti Grafiche Friulane, Udine 1972, pp. 165-169; ivi pure il saggio sulgradiscano Finetti di S. SARTI, Il presupposto filosofico della polemica tra Bonifacio Finettie G. B. Vico, pp. 171-186.
81 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr: 13/e/05, 13/e/07, 13/e/01, 13/e/02, 13/e/04, 13/e/03. Sono pubblicate in appendice e devo la cortesia delle copie all'amico Hel-mut Watzlawick di Vernier (Ginevra).
qui si esamina, acquista particolare rilevanza non solo per la comple-ta definizione dei rapporti di Casanova con personaggi e ambientidella Carniola e del Litorale Austriaco settecentesco, e non tantoper il numero delle lettere rispetto alla dimensione del corpus episto-lare 82, quanto per l'interesse che riveste ai fini della comprensionedei rapporti intellettuali nella regione 83.
D'altra parte, il suo stesso interlocutore, il barone SigismondoZois, ben puoÁ esemplificare il suo corrispondente tipico tra la bor-ghesia europea dell'epoca e tra il ceto emergente nel Litorale austria-co, cioeÁ la borghesia mercantile, recentemente nobilitata, tanto impe-gnata nei traffici commerciali quanto attenta alle espressioni dellacultura letteraria ed erudita del tempo.
Della figura di Sigismondo Zois ci siamo giaÁ occupati ampiamen-te nel capitolo quinto, quando ne abbiamo messo in luce i rapporticon Karl von Zinzendorf 84. Il personaggio appare in linea di princi-pio del tutto rispondente al carattere tipico di buona parte dei corri-spondenti di Casanova, e certamente singolare eÁ il ruolo di animatoresvolto per la cultura slovena e giuliana del Settecento, onde alla nonrara qualitaÁ di erudito e di mecenate veniva aggiungendosi quellaparticolare di mediatore tra la cultura italiana, tedesca e slava, non-che tra i ceti sociali differenti (alta borghesia e popolo) 85.
234
82 Per l'epistolario casanoviano cfr. G. CASANOVA, Epistolario, a cura di P. CHIARA,Longanesi, Milano 1969, nonche le indicazioni di F. LUCCICHENTI, Nota bibliografica inCASANOVA, Storia della mia vita, III, cit., pp. 1143-1152.
83 Si vedano i saggi di F. SALIMBENI, Trieste e la Francia, «Quaderni Giuliani di Sto-ria », VIII, 1 (1987), pp. 119-128 e di G. CERVANI, Trieste durante il periodo napoleonico.Le terre adriatiche del Litorale dalla pace di Presburgo alle Province Illiriche, in G. CASA (acura di), Trieste, Nodier e le Province Illiriche, Italo Svevo, Trieste 1989, pp. 11-24.
84 Cfr. infra, pp. 158-159.85 Su Zois, oltre alla bibliografia sopra citata, si veda anche M. KACIN, SÏe nekai o
Zoisovem sÏolanju v Reggio Emilia, in Izvestje sredenjih sÏol, Trst 1958. Una parte dell'e-pistolario di Zois fu pubblicata nei due volumi a cura di F. KIDRICÂ , Zoisova koresponden-ca 1808-1810, Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1939-1941. Per l'archivio per-sonale di Zois, oggi in massima parte conservato a Lubiana, cfr. Splosni pregles fondovdrzavnega arhiva L.R.S., s.e., Ljubljana 1960, pp. 166-167 e Zveza arhivskih delavcev Ju-goslavije, arhivski fondi in zbirke arhivih in arhivskih oddelkih v S.F.R.J., Savez drusÏtavaarhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1984, p. 73.
Quando precisamente Zois conobbe Casanova non eÁ noto; pur-tuttavia, risalendo la prima lettera nota al febbraio 1773 ed essendoviriferimenti a un rapporto di amicizia giaÁ consolidato, non pare chel'incontro fosse avvenuto a grande distanza di tempo dalla venutadi Casanova a Trieste, il 15 novembre 1772 86. Benche la Storia dellamia vita 87 sia priva di cenni sui rapporti con Zois, si puoÁ ipotizzarequale momento dell'incontro, facendo fede sulla narrazione autobio-grafica, la prima metaÁ del dicembre 1771, nei giorni cioeÁ in cui il ba-rone Pittoni, direttore di polizia a Trieste, fece conoscere a Casanovai maggiorenti della cittaÁ introducendolo pure nel circolo esclusivo delCasino dei Nobili 88. Viceversa non risulta difficile individuare le ra-gioni dell'amicizia di Casanova nella posizione sociale ed economicadel negoziante e nella possibilitaÁ di trovare altre vie, nella specie gra-zie all'estensione e alle filiali della casa di commercio Zois, per rista-bilire i rapporti con le autoritaÁ veneziane onde porre fine all'esilio.
L'esame del breve carteggio completa quindi il quadro delle re-lazioni epistolari e personali di entrambi e conferma l'incidenza dellapersonalitaÁ carismatica di Casanova sugli interlocutori, anche occa-sionalmente conosciuti nei suoi viaggi europei. EÁ una constatazionesuggerita indirettamente anche dalla preparazione e dal valore intel-lettuale di Zois, nonche certamente dalle espressioni di stima riserva-te al veneziano nelle lettere qui pubblicate in appendice.
D'altra parte non risulta pervenuta alcuna impressione critica diCasanova sul suo corrispondente lubianese. Ignorato del tutto nellaStoria della mia vita, Zois fu ricordato unicamente come fonte (ma-gari inconsapevole) di informazioni commerciali e politiche in unadelle relazioni di Casanova agli Inquisitori di Stato in Venezia 89.
Attento fin dagli anni giovanili alle piuÁ significative espressioniteatrali contemporanee, mentore di artisti e traduttore di libretti d'o-pera (curoÁ la versione in lingua slovena anche di alcune arie di operecelebri), Zois ebbe certamente un ruolo fondamentale per lo svilup-
235
86 Sul soggiorno triestino di Casanova cfr. PAGNINI, Casanova a Trieste, cit., e ID.,Casanova et Zinzendorf, cit., pp. 11-14.
87 CASANOVA, Storia della mia vita, cit., III, pp. 960-1010.88 PAGNINI, Casanova a Trieste, cit., p. 10.89 CURIEL, Trieste settecentesca, cit., pp. 84, 171.
po e per la tutela della cultura letteraria e scientifica nella Carniola(attuale Slovenia) e nel Litorale. La quantitaÁ e la qualitaÁ dei rapporticulturali, in alcuni casi inediti, tra le sponde dell'Adriatico, fra terraveneta e terra austriaca trova ora eco nelle lettere di Zois a Casanova,nelle quali sono ricordati intellettuali lubianesi, giuliani, veneti e dal-mati. Nella biblioteca lubianese di Sigismondo Zois v'eÁ poi un'altratraccia di rapporti culturali con Casanova continuati ben oltre la datadell'ultima lettera nota, del 1775; vi eÁ conservato il volumetto NeÂamori, ne donne ovvero la stalla ripulita, edito a Venezia nel 1782 edel quale eÁ nota la raritaÁ 90. Va rilevato che le lettere di Zois qui pub-blicate facevano parte in origine di un carteggio ben piuÁ ampio, la cuiconsistenza si puoÁ intuire dall'arco temporale coperto e dalla docu-mentata frequenza dei contatti nel corso del 1773. Non risultano esi-stenti le lettere di risposta di Casanova a Zois, ne sono note altre let-tere di quest'ultimo che possano completare la ricostruzione dei rap-porti tra i due personaggi.
Intensi furono i rapporti di Casanova con personaggi della regio-ne, soprattutto all'epoca della pubblicazione della Istoria delle turbo-lenze di Polonia, edita a Gorizia dal tipografo Valerio de Valerj, l'e-ditore della «Gazzetta goriziana », nel 1774 91. In quell'occasione eper seguire i lavoro editoriale il veneziano si valse dell'amicizia di altristudiosi della regione, tra cui il matematico Giuseppe Barzellini, delquale rimane una lettera inedita tra i documenti lasciati da Casanova
236
90 Dell'esistenza del libretto eÁ data notizia in F. KIDRIc, Zgodovina slovenskega slost-va od zacetkov do Zoisovem smrti, Slovenska matica, Ljubljana 1929-1930, p. 400. Dinotevole interesse pure le pagine (con riferimenti anche a Casanova) nel volume di S.SÏ KERLJ, Italijansko gledalisÏcÏe v Ljubljani v preteklih stoletjih, Slovenska Akademija znano-sti in umetnosti, Ljubljana 1973, pp. 343-345, 441-447. In tempi abbastanza recenti si eÁinteressato pure di Zois, con la pubblicazione di alcuni inediti di argomento poetico, A.GSPAN, Tri nova Zoisova slovenska pesemska besedila, « Slavistica revija », XVIII, 2(1969), pp. 119-181. Per l'operetta di Casanova NeÂamori ne donne ovvero la stalla ripu-lita nonche per indicazioni circa la raritaÁ cfr. J.R. CHILDS, Casanoviana. An annotatedworld bibliography, Nebehay, Vienna 1956, pp. 58-62.
91 Su Casanova storico e scrittore delle vicende di Polonia si veda anche G. BOZZO-
LATO, Casanova, uno storico alla ventura. Istoria delle turbolenze di Polonia, Marsilio, Pa-dova 1977. Una riedizione dell'opera risale agli anni Settanta del Novecento: G. CASA-
NOVA, Istoria delle turbolenze della Polonia, a cura di G. SPAGNOLETTI, Guida, Napoli1974.
nell'archivio di Dux in Boemia 92. Il caso della Istoria delle turbolenzedi Polonia eÁ assai interessante perche , trattandosi di un'opera estre-mamente rara in quanto stampata in pochissime copie, permette diricostruire percorsi editoriali e librari attraverso generazioni differen-ti nella Trieste sette e ottocentesca. Annotando ad esempio un rap-porto epistolare tra Sebastiano Ciampi, pistoiese (1769-1847) e Do-menico Rossetti, triestino (1774-1842) risalente agli anni 1826-1827in cui si parlava dell'esistenza, nella biblioteca rossettiana, di una co-pia in due tomi dell'opera, Cesare Pagnini aveva ipotizzato che fossepervenuta a Rossetti assieme alla biblioteca paterna, senza che egliavesse alcuna notizia sull'autore e sulla raritaÁ del testo 93. I documenticonservati presso l'Archivio di Stato di Trieste e provenienti dal ces-sato tribunale commerciale e marittimo raccontano con maggioreprecisione la storia e la circolazione di quei volumi, che infatti eranoappartenuti al commerciante Antonio Perinello (Trieste 1752-ivi1805) primo cugino di Domenico Rossetti. L'inventario dei beni ste-so alla sua morte riporta alla Rubrica IX. Libreria sotto il numero 176la Istoria valutata allora 3 carantani, pari a circa 3 euro attuali 94. Ere-de universale di Antonio Perinello fu la moglie Gioseffa Rossetti esuo procuratore il di lei fratello Domenico, appena divenuto avvoca-to; in ricordo di Perinello o in compenso per l'opera prestata, Rosset-ti dovette ricevere quindi i volumi di Casanova. Del resto il diario delgovernatore Zinzendorf documenta l'amicizia di Casanova con Zin-zendorf e di questi con i Rossetti e con i Perinello, legati sin dalla finedegli anni Settanta da rapporti di parentela; e proprio in una casaRossetti Casanova fece rappresentare una propria commedia (dal ti-tolo sconosciuto) nel 1773 95.
237
92 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr U/12/27, pubblicata in appendice. Giu-seppe Barzellini da Cormons, astronomo e matematico, pubblicoÁ alcune Effemeridi ar-cadiche nel 1783 con l'esatto calendario delle Olimpiadi e fu membro dell'Arcadia gori-ziana. Su di lui cfr. DE FRANCESCHI, L'Arcadia Romano-Sonziaca, cit., p. 107 e CURIEL,Trieste settecentesca, cit., p. 108.
93 PAGNINI, Casanova a Trieste, cit., p. 17.94 ASTs, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 139, prot. 1242/1805, carte
non numerate.95 PAGNINI, Casanova a Trieste, cit., p. 12.
Un quadro della vita triestina all'inizio degli anni Novanta delSettecento eÁ offerto dal diario di un viaggiatore olandese, JohanMeerman, in visita nel Litorale all'epoca del governatorato di Pom-peo de Brigido. L'inverno del 1791 era giaÁ inoltrato quando Meer-man lascioÁ la Carinzia per avvicinarsi all'Italia: «De sneeuw maakthen des winters voor achterhaaling beducht, doch de zomer is hunin dit opzicht gunstiger » 96. I viaggi furono uno dei suoi interessiprincipali, fin dagli anni dello studio giovanile a Lipsia e a GoÈ ttingen.Dapprima si mosse accompagnando il padre Gerard, Raad en Pensio-naris della cittaÁ di Rotterdam e poi senatore a Leiden, nei suoi spo-stamenti per ragioni di ufficio; poi da studente appena sedicenne (eranato infatti nel 1753 a Den Haag), prima della morte del padre, av-venuta nel 1771 97, viaggioÁ in compagnia del precettore.
La formazione culturale e lo spiccato interesse per le scienze sto-riche e letterarie lo resero ben presto un acuto osservatore dei paesiche attraversava. Dopo l'educazione giovanile a Leiden e a Rotter-dam nelle materie umanistiche e scientifiche (storia, archeologia, geo-grafia, scienze naturali e matematiche) e nelle lingue (francese, latino,spagnolo), Johan Meerman si laureoÁ in diritto a Leiden, pubblicandola tesi sui rapporti giuridico-internazionali e politici tra il Sacro roma-no impero e i Paesi Bassi dopo la pace di Augusta del 1548 98. Neglianni successivi continuoÁ i viaggi, dapprima attraverso la Francia, laSvizzera, l'Italia, l'Austria e l'area germanica (1775-1776), poi, dopoil 1784, in compagnia della moglie. Furono assieme in Inghilterra, in
238
96 J. MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische, oostenryksche en siciliaan-sche monarchieÈn, benevens sommise daar an grenzende staaten, I, van Cleef, 's Gravenha-ge 1793, p. 215.
97 Per la biografia cfr. H.C. CRAS, Elogium Johannis Meermanni, Den Hengst, Am-sterdam-Den Haag 1817; A.C. MOLLERUS, Biographische notizie omtrent de heer en Mr.Johan Meerman, s. t., 's Gravenhage [1817]. Qualche altra notizia biografica in J.H.KERNKAMP, Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en VanDanne aanwezig in het Museum Meermanno-Westrenianum, 's-Gravenhage 1948 e inJ. VAN HEEL, M. VAN OUDHEUSDEN, Brieven van Jakob Philipp Hackert aan Johan Meer-man uit de jaren 1779-1804 met enkele brieven van Johann Friedrich Reiffstein, 's-Gra-venhage 1988.
98 J. MEERMAN, Specimen juris publici inaugurale de resolutione vinculi, quod olimfuit inter S.R. Imperium et Foederati Belgii Respublicas, Ludguni Batavorum 1774.
Irlanda e in Scozia (1789), negli Stati tedeschi, nella penisola italianae a Malta (1791-1792), in Norvegia, Finlandia, Polonia e Russia(1797-1800) 99.
Pochi anni prima della morte si trasferõÁ a Parigi, ove assunse iltitolo di senatore di Francia, decedendo poi a Den Haag, nell'occa-sione di uno dei suoi frequenti rientri nella cittaÁ natale, nel 1815.Benche impegnato in incarichi al servizio dello Stato, non rinuncioÁmai agli interessi letterari e storici pubblicando, oltre a qualche lavo-ro di interesse giuridico ± tra cui l'edizione di alcuni testi di Gro-zio 100 ± i quattro volumi della Geschiedenis van Graaf Willem vanHolland Roomsch Koning 101, numerose traduzioni dalla lingua tede-sca delle opere di Klopstock 102 e, specialmente negli anni del Con-solato e dell'Impero, numerosi opuscoli di argomento politico e diintonazione filofrancese 103. Fu questo un periodo di notevole in-
239
99 Sui viaggi di Meerman si veda anche M. BLAAUBOER, Johan Meerman, impressievan een Grand Tourist in hart en nieren, « Incontri. Rivista europea di studi italiani »,XVII, 2 (2002), pp. 119-130. L'intero numero della rivista eÁ dedicato al tema De GrandTour-de reizen van Gerard en Johan Meerman in de achttiende eeuw.
100 H. DE GROOT, Parallelam rerumpublicarum liber tertius: de moribus ingenioquepopulorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum, uit een echt handschrift uitgegeeven,in `t Nederduitsch vertaald en met aanmerkingen opgebeleerd door Johan Meerman, A.Loosjes, Haarlem 1801-1802; ID., Epistolae ineditae quae, ad Oxenstiernas patrem et fi-lium, aliosque Greciae consiliarios e Gallia ninae ex authentico exemplari, quod in Biblio-theca LincoÈpiensi servatur, nunc prodeunt ex Musaeo Meermanniano, A. Loosjes, Haar-lem 1806.
101 J. MEERMAN, Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning, vanCleef, 's-Gravenhage 1783-1787; traduzione tedesca parziale con il titolo Geschichte desGrafen Wilhelm von Holland roÈmischen KoÈnigs, aus dem hollaÈndischen, Leipzig 1787-1788.
102 J. MEERMAN (a cura di), De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock, vanCleef, 's-Gravenhage 1803-1805, 4 voll. (una riedizione eÁ stata pubblicata a Berlinonel 1968); ID., Narede tot de Nederduitsche vertaaling van Klopstock's Messias, `s-Graven-hage-Amsterdam 1815.
103 J. MEERMAN, Discours preÂsente aÁ l'AcadeÂmie de ChaÃlons-sur-Marne en 1787, surla question: quells sont les meilleurs moyens d'exciter et d'encourager le patriotisme dansune monarchie, Leiden 1789; ID., De burgelyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vry-heid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit Ge-meenbest, Leiden 1793 (due edizioni nello stesso anno); ID., Merkwaardige overeÂeÂnstem-ming van de Decret der Fransche Nationaale Conventie van de zestienden met de Publi-catie der Staaten van Holland van de zeventienden October 1794 over de volks-societeiten, s.l., 1794; ID., Over de blijken der goddelijke vrijheid, welke de geschiedenis
fluenza sulla sua opera politica e civile ± ma stranamente quasi pernulla indagato ± proprio nel cuore del patriottentijd che lo vide tesofra le istanze degli organisti e quelle repubblicane 104.
L'attivitaÁ che lo rese piuÁ noto alla cultura letteraria della sua epo-ca e che costituisce ancora oggi uno dei motivi di maggiore interessestoriografico eÁ legata proprio ai suoi numerosi viaggi. Rientrando aDen Haag, Meerman curava la revisione dei suoi appunti di viaggiopreparandoli per la pubblicazione. CosõÁ avvenne per il diario delviaggio in Gran Bretagna, pubblicato nel 1787, per quello del viaggioin Germania, Austria e Italia degli anni 1791-1792, edito poi nel1793, e per quello nell'Europa orientale, pubblicato tra il 1804 edil 1806 in sei volumi 105.
Il diario manoscritto del primo viaggio in Italia, avvenuto tra il1775 ed il 1776, giaÁ eÁ stato fatto oggetto di uno studio specifico 106.Meerman era giunto nella penisola attraverso il Moncenisio con ilsuo precettore Johann Ludwig Erb e, dopo una sosta a Torino, avevavisitato Pisa, Genova, Livorno, Roma, Napoli, per poi risalire versoVenezia.
EÁ noto che il viaggio con il precettore costituiva una delle situa-zioni tipiche della letteratura di viaggio sei-settecentesca; tuttavia l'al-lievo o il tutelato, anche quando dotato di una spiccata personalitaÁ ,
240
oplevert. Eene voorlezing, gedaan in de Maatschappij Diligentia in 's-Gravenhage op 8April 1806, van Cleef, 's-Gravenhage 1806.
104 Notizie utili per un inquadramento del problema, anche in prospettiva di unapprofondimento delle ricerche su Meerman, sono fornite da C.H. DE WIT, De Neder-landse revolutie van de achttiende eeuw en Frankrijk 1780-1801, in Vaderlands verledenin veelvoud. Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500, II, M. Nijhoff, DenHaag 1980, pp. 1-24; E.O.G. HAITSMA MULIER, La storiografia sul tempo dei patrioti edei batavi, « Rivista Storica Italiana », 45 (1983), pp. 843-871.
105 J. MEERMAN, Eenige berichten omtrent Groot-Britannie en Ierland, van Cleef, 's-Gravenhage 1787; ID., Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Euro-pa, van Cleef, 's-Gravenhage 1804-1806, 6 voll. (traduzione tedesca Reise duch den Nor-den und Nordosten von Europa in den Jahren 1797 bis 1800, aus dem hollaÈndischen uÈber-setzt von Christian Friedrich RuÈhs, Weimar 1810, altra edizione Wien 1811, 3 voll.).
106 J. VAN HEEL, Johan Meerman op reis, in R. DE LEEUW (a cura di), Herinneringenaan ItalieÈ. Kunst en toerisme in de 18de eeuw, Waanders, Zwolle 1984, pp. 55-61, 250-251. Il diario manoscritto con il titolo Reisjournal door England, Frankrijk, Zwitserland,ItalieÈ, Oosternrijk en Zuid-Duitschland, in sei volumi, eÁ conservato in Den Haag, KB,segn. 133 G 13/1-6.
non godeva in quelle occasioni della libertaÁ di espressione e di pen-siero ± anche nella stesura di un diario ± che si puoÁ avere quando siviaggia da soli.
Nel 1791, durante il secondo viaggio in Italia, Meerman tornoÁinvece nella penisola in compagnia della moglie, figura femminileche eÁ quasi completamente assente nelle annotazioni diaristiche.CambioÁ anche l'itinerario: non piuÁ lungo la Svizzera ma attraversogli Stati ereditari della monarchia asburgica, provenendo dall'area te-desca. Dopo Dresda e l'Austria interna, attraversoÁ la Carinzia per di-rigersi, oltrepassata Lubiana, verso l'ultima cittaÁ austriaca innanzi alterritorio veneto, la prima sul mare: Trieste.
Come accadde per il precedente, anche questo secondo itinera-rio verso l'Italia venne documentato da annotazioni diaristiche: untesto che potrebbe rientrare, come tanti e senza dignitaÁ di indaginiparticolari, in quell'ampia memorialistica che affolla, spesso senzagrande originalitaÁ , il panorama della letteratura di viaggio settecente-sca. Eppure il documento presenta spunti di interesse non soltantoper lo storico della letteratura ma anche per lo storico della culturae della societaÁ settecentesche. La ricerca di elementi di originalitaÁnon deve essere limitata, percioÁ , alla sola provenienza geografica del-l'autore. Molti erano i viaggiatori olandesi, anche di vaglia, che ave-vano come meÂta la penisola italiana, soprattutto dopo gli anni Ses-santa del Settecento 107. Piuttosto, l'interesse del lettore deve essereriferito al particolare contesto e alla formazione culturale del diaristae, rispettivamente, agli atteggiamenti che in lui vennero determinatidal confronto con il contesto socio-culturale, profondamente diver-so, dei luoghi visitati.
Per quanto riguarda le caratteristiche del diario di viaggio del1791 rispetto alla personalitaÁ dell'autore, giaÁ altri hanno segnalatoche questo fu l'unico ad essere pubblicato, mentre il primo rimaseinedito 108. Questa circostanza si rivela importante anche dal puntodi vista linguistico e letterario, per la maggior cura nell'uso della lin-
241
107 R. DE LEEUW, Nederland op Grand Tour, in Herinneringen aan ItalieÈ, cit., pp.11-34.
108 VAN HEEL, Johan Meerman op reis, cit., p. 56.
gua e dello stile nel testo edito del 1791 rispetto al manoscritto del1775-1776. Inoltre nel diario del secondo viaggio, pur ricco di detta-gli nelle annotazioni, sono quasi completamente omessi i nomi propridi persone e i riferimenti ai luoghi, a parte l'indicazione delle cittaÁvisitate.
Oltre a cioÁ il diario del 1791, in quanto destinato alla pubblica-zione, rivela una presenza quantitativamente rilevante di giudizi mo-rali e, in genere, di interventi critici riferibili alle convinzioni e all'e-ducazione religiosa di Meerman, che appaiono invece meno frequen-ti nel testo del 1775. Educato infatti nella confessione protestante,Johan Meerman professava con convinzione la sua fede calvinista enegli anni successivi avrebbe partecipato anche ad alcuni sinodi rifor-mati 109. Nel diario del 1791 infine, oltre a riutilizzare parte delle no-tizie raccolte nel corso del precedente itinerario, Meerman preferõÁ
anche mantenere l'anonimato. Una circostanza che eÁ stata ritenutasegno del desiderio di una maggiore libertaÁ nell'esposizione 110, mache in realtaÁ deve essere ricondotta ad un mero vezzo letterario,sia perche il contenuto moralistico contrasta con l'ipotesi di una mag-giore libertaÁ dello scrittore, sia perche nella contemporanea traduzio-ne tedesca il nome invece appare 111.
Questi elementi, uniti alla particolare sensibilitaÁ del viaggiatoreper gli elementi storici ed artistici dei luoghi frequentati e per il ca-rattere delle persone conosciute, rendono il contenuto del diario par-ticolarmente interessante. E, se eÁ vero che con il Settecento la lette-ratura di viaggio diventoÁ un fatto di costume e di moda, tanto che « iviaggiatori sanno cosa cercare, che cosa conviene vedere e come bi-sogna descrivere tutto cioÁ » 112, eÁ anche vero che le pagine di Meer-
242
109 J. MEERMAN, Aanspraaken gedaan op de Gereformeerde Zuid-hollandsche Synodesvan 's-Gravenhage en Woerden, in July 1805 en July 1806, van Cleef, 's-Gravenhage1806; ID., Aanspraak, gedaan op de Gereformeerde Zuidhollandsche Synodes van Buurenen Breda, in July 1807 en July 1808, van Cleef, 's-Gravenhage 1808.
110 VAN HEEL, Johan Meerman op reis, cit., p. 56.111 J. MEERMAN, Reise durch Preussen, Oesterreich, Sicilien und einige an jene Mo-
narchien grenzende LaÈnder, aus dem hollaÈndischen uÈbersetzt vom Professor Lueder, Schul-buchhandlung, Braunschweig 1794.
112 A. MACZAK, Viaggi e viaggiatori nell'Europa moderna, tr. it., Laterza, Roma-Bari1992, p. IX.
man ci restituiscono in larga misura l'immediatezza e la spontaneitaÁdelle reazioni di chi provava sentimenti contrastanti di fronte a situa-zioni culturali nuove e comunque diverse da quelle abituali.
Queste reazioni sembrano particolarmente avvertibili nelle pagi-ne che descrivono l'ingresso di Meerman in Italia e il soggiorno aTrieste, cittaÁ nella quale sarebbe rimasto per quasi quattro mesi,tra l'inverno del 1791 e la primavera del 1792, prima di ripartire allavolta di Venezia.
Colpisce, innanzi tutto, il fatto che il testo, pur essendo struttu-rato in forma di diario di viaggio seppure non formalmente suddivisoper annotazioni quotidiane, non contenga alcun riferimento agli av-venimenti politici che in quel periodo stavano scuotendo l'Euro-pa 113. Il viaggiatore appare attento alla percezione dei contrasti: con-trasti fisici e geografici, come il passaggio da un altopiano dal climacontinentale come quello carsico alla costa dal clima mediterraneo;contrasti linguistici, come il passaggio dall'uso della lingua tedescae slava a quello della lingua italiana: « Boven op den berg wordende ooren niet dan door het hetonbevallige Krainsch smertelyk ange-daan; op eens maakt het zelve plaats voor de welluidende spraakevan het Schiereiland, daar dit Gebied tegen aanstoot, en van 20 In-wooners is er nauwelyks eÂeÂn di eden Hoogduitsche verstaat » 114.
Sarebbe indotto in errore chi ritenesse che simili preferenze lin-guistiche possano costituire l'indizio di un particolare gusto estetico.Si tratta invece di impressioni eminentemente soggettive; anche doveil diarista esprimeva uno spirito di tolleranza, osservando compiaciu-to ad esempio il concorso nell'emporio triestino di popoli, di culturee di religioni diverse 115, riemerge ben presto il carattere spiccato del
243
113 Considerazione che non esclude, evidentemente, la possibilitaÁ che Meermanavesse espunto dal diario altri passi in vista della pubblicazione.
114 «Mentre sulla montagna le orecchie vengono ancora dolorosamente offese dallasgraziata lingua cragnolina, verso la cittaÁ questa lingua viene improvvisamente sostituitada quella ben orecchiabile della penisola cui questa regione si accosta e, su venti abitanti,ce n'eÁ appena uno che capisca l'alto tedesco »; MEERMAN, Eenige berichten omtrent depruissische, oostenryksche..., I, cit., pp. 229-230.
115 La bibliografia sulle comunitaÁ linguistico-religiose di Trieste eÁ abbastanza am-pia; per uno sguardo d'assieme, bibliograficamente aggiornato, si vedano i saggi di T.CATALAN, Presenza sociale ed economica degli ebrei nella Trieste asburgica tra Settecento
personaggio. Ogni viaggiatore porta con se il proprio bagaglio cultu-rale e di pregiudizi. E cosõÁ avveniva per Meerman che, benche giaÁ alsecondo viaggio verso la penisola, non cessava di stupirsi di alcunicaratteri tipici della cultura teatrale italiana, divenuta ormai europea,con il predominio dell'opera buffa nel teatro cittadino 116.
Meerman si rendeva conto che l'affezione del pubblico triestinoper l'opera buffa non rappresentava un caso isolato: «Dat men teTrieÈst, daar de zeden van ItalieÈn volkomen de overhand hebben,in deeze schouwspellen genoegen neemen, en 20 avonden achtereÂeÂn,telkens vier of vyf uuren lang, in kleine LoÃges opgeslooten, het zelfdeMusiekstuk en byna dezelfde Balletten kunne zien uitvoeren, ver-wondert my weinig: maar dat de smaak voor deeze laage boerteryeÈnaan de voornaamste Hoven van Duitschland en zelfs in andere groo-te Steden zoo geweldig is doorgedrongen, in `t midden vane en over-vloed der schoonste en zedelykste Toneelstukken [...] heeft my zooveel bevreemding als morite gegeeven » 117.
Ancora una volta l'atteggiamento di distacco e di critica non eradettato in lui da impressioni meramente estetiche, tanto che sentivala necessitaÁ di precisare: « Ik veins hier geene overdreevene Zedekun-de. Wy hebben in een' meerderen of minderen graad een gevoel voorhet belagchelyke van den Schepper zelve ontvangen; en de muskelenvan ons aangezicht, die zich naar die indrukken beweegen, zyn onsniet zonder oogmerk geschonken: maar de mensch is tot edeler ei-dens bestemd, en met grooter vermogens uitgerust, dan om zich
244
e primo Novecento, O. KATSIARDI-HERING, La presenza dei greci a Trieste: tra economia esocietaÁ (metaÁ sec. XVIII-fine sec. XIX), P. DORSI, La collettivitaÁ di lingua tedesca, M. DO-
GO, Una nazione di pii mercanti. La comunitaÁ serbo-illirica di Trieste 1748-1908, CATA-
LAN, Cenni sulla presenza armena, cit., tutti in FINZI, PANJEK (a cura di), Storia economicae sociale di Trieste, I, cit., rispettivamente alle pp. 483-519, 519-546, 547-572, 573-602,603-612. Da vedere peroÁ anche P. DORSI, Stranieri in patria. La parabola del gruppo mi-noritario tedesco nella Trieste austriaca, « Clio », XXXIII, 1 (2001), pp. 5-58.
116 MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische, oostenryksche..., I, cit., pp.231-232.
117 « Poco mi meraviglia che a Trieste, dove predominano le abitudini italiane, ci siaccontenti di queste commedie per assistere alle quali ci si rinchiude in piccoli palchi,per vedere eseguire per venti serate di seguito in quattro o cinque ore lo stesso pezzodi musica e quasi gli stessi balletti »; MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische,oostenryksche..., I, cit., p. 231.
door verachtelyke possen uit den rang van redelyke weezens moed-willig uit te stooten » 118.
Di qui i motivi delle sue opinioni: « Ik zwyg nog van Gestes vanhandelingen in sommigen deezer Operas, die de zeden nog gevrien-der kwetsen, en vat het volkomen inmoreele oogmerk van allen » 119.
Ma non sempre Meerman consentiva che il suo senso critico ve-nisse sopraffatto da pregiudizi o da convinzioni religiose. Il problemadelle confessioni religiose, anzi, si intrecciava ai suoi occhi con quellodella tolleranza dei culti e con quello del plurilinguismo, che avver-tiva particolarmente vivi nella societaÁ triestina. Nel porto franco egliassistette per la prima volta, nel giorno di Natale del 1791, ad unapredica riformata in lingua italiana dove anche il rituale dell'UltimaCena si svolgeva in tale lingua anche se, osservava, davanti a una co-munitaÁ composta quasi esclusivamente da uomini e con dodici donnesoltanto.
CioÁ che vedeva o sentiva non era tuttavia sufficiente per mutarele sue convinzioni; anzi, i caratteri socio-demografici di un grandeporto commerciale mettevano nuovamente alla prova il suo sensodella morale e il suo sentimento religioso. E infatti, dopo aver osser-vato che le statistiche informavano come nella vicina cittadina di Go-rizia, nell'entroterra del Friuli austriaco, soltanto un bambino su cen-totredici dovesse considerarsi illegittimo, notava senza compiacimen-to che a Trieste ben un bambino su dieci non conosceva il propriopadre 120.
245
118 «Non fingo un'eccessiva moralitaÁ . Abbiamo ricevuto dal Creatore, in varia mi-sura, il senso dell'umorismo e non senza scopo siamo stati provvisti dei muscoli dellafaccia che si muovono a seconda di queste impressioni. L'uomo peroÁ eÁ destinato a finipiuÁ nobili ed eÁ dotato di piuÁ ampie capacitaÁ che non sia l'estraniarsi deliberatamente dal-la condizione di essere ragionevole con spregevoli atteggiamenti »; MEERMAN, Eenige be-richten omtrent de pruissische, oostenryksche..., I, cit., pp. 237-238. Un breve commentodelle posizioni di Meerman sull'opera buffa, in rapporto al repertorio teatrale del tempo,eÁ fornito da CAVALLINI, Presenze di musicisti pugliesi, cit., pp. 241-242.
119 « In alcune di queste opere ci sono inoltre dei gesti e degli atti che offendono inparticolare il sentimento morale, per non parlare poi dello scopo assolutamente immo-rale di tutto e di tutti »; MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische, oostenryk-sche..., I, cit., p. 238.
120 MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische, oostenryksche..., I, cit., p.229.
Meerman era anche un viaggiatore informato, che sapeva qualiattrattive una cittaÁ gli poteva offrire e che assumeva notizie sulle par-ticolaritaÁ artistiche e naturalistiche della zona. A Trieste sapeva dinon poter ammirare opere d'arte e di architettura preziose comequelle che, poche settimane piuÁ tardi, avrebbe avuto modo di vederea Venezia. Sul Carso si potevano visitare cave e grotte, ma esse pote-vano interessare, cosõÁ annotava, « slechts de beminaar der natuurlykegeschiedenis » 121, non lui. Andava alla ricerca, invece, dei vulcaniche qualcuno gli aveva descritto in patria ma, scriveva rammaricato,« geen bewyzen hoegenaamd van onderaardsche vuuren heeft menmy verzekerd, dat deeze streeken opleveren » 122.
In mancanza, l'attenzione del viaggiatore veniva attratta dalle fog-ge dei vestiti che denotavano la diversa origine etnica e nazionale, dainumerosi caffeÁ e casini, dall'andirivieni di carrozze lungo la marina.Meerman era attento alle forme del vivere in societaÁ , era un frequen-tatore delle accademie, come anche nella sua cittaÁ natale, delle qualiriconosceva la funzione non solo di intrattenimento ma anche di pro-mozione culturale 123. A Trieste poteva frequentare invece il Casinodei Nobili, « eene geslootene Societeit der fatsoendelyke lieden » 124,dove era possibile leggere le gazzette, giocare a biliardo o conversareamabilmente. E, alla domenica, poteva partecipare con la buona so-cietaÁ triestina ad alcune gite ± aperte a persone di entrambi i sessi ±nelle contrade suburbane, per divertirsi giocando o conversando 125.
Johan Meerman non era peroÁ soltanto un viaggiatore attento einformato; era anche l'intellettuale preparato sul tema specifico del-l'esperienza di viaggio, sia dal punto di vista letterario che da quellostorico. La sua preparazione lo rendeva consapevole del fatto che il
246
121 « Solo il cultore delle scienze naturali ».122 « In queste regioni non c'eÁ alcuna prova di attivitaÁ vulcanica, contrariamente a
quanto mi era stato riferito »; MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische, oosten-ryksche..., I, cit., p. 234.
123 Sulla funzione delle accademie olandesi nel tardo Settecento si vedano le indi-cazioni offerte da C. SINGELING, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genoot-schappelijkheid in Nederland 1750-1800, NEHA, Amsterdam 1991, pp. 128-150.
124 «Una societaÁ chiusa di gente perbene ».125 MEERMAN, Eenige berichten omtrent de pruissische, oostenryksche..., I, cit., p.
230.
significato di un viaggio puoÁ trascendere l'occasionalitaÁ di un'espe-rienza personale per trasformarsi in un avvenimento ricco di signifi-cati culturali ad uso di una comunitaÁ piuÁ vasta. Il viaggio poteva di-ventare strategia per un discorso letterario e politico, come avvenivain Kant 126 e come piuÁ chiaramente sarebbe avvenuto per lo stessoMeerman alcuni anni piuÁ tardi, quando avrebbe ricostruito il viaggiodi Pietro il Grande nei Paesi Bassi 127.
CioÁ spiega pure perche le Berichten di Meerman sul secondoviaggio in Italia rifuggano da ogni sorta di autobiografia, a parte lepagine che esprimono convinzioni morali o religiose dell'autore.L'osservatore si limitava a descrivere e a interpretare cioÁ che vedevae gli avvenimenti ai quali assisteva. La dimensione intima e personalee familiare (come la presenza / assenza della moglie) veniva relegataad una posizione del tutto subordinata e non pubblica.
Ben piuÁ tardi dei soggiorni triestini e goriziani di un Giacomo Ca-sanova o di un Meerman, l'ereditaÁ della cultura settecentesca si riveloÁanche negli scritti di una singolare figura di studioso e di intellettualeattivo fra l'Istria, Gradisca e Trieste. Giulio Gravisi nacque a Pinguentenell'Istria interna verso il 1750. StudioÁ a Vienna ove si laureoÁ in leggesposandosi poi con la vedova di un ricco banchiere viennese e, tornatonel Litorale, fece carriera nella magistratura. Fu per molti anni vice-pre-tore di Gradisca d'Isonzo ove visse fino al pensionamento, per trasfe-rirsi quindi a Trieste, cittaÁ nella quale morõÁ in tarda etaÁ nel 1827. Fuarcade, autore di alcuni Ricordi dell'arte poetica ad istruzione della gio-ventuÁpubblicati nel 1820 e di qualche scritto di archeologia (sulla portaaurea di Pola) pubblicati in «L'Osservatore Triestino » del 1826.
Quello che piuÁ interessa del personaggio eÁ una caratteristica co-mune ad altri operatori tardosettecenteschi della regione, cioeÁ l'esser-si interessato di cultura fin dagli anni giovanili potendo peroÁ manife-stare pienamente l'impegno letterario soltanto in etaÁ piuttosto matu-ra, al sorgere dell'Ottocento. CosõÁ Giulio Gravisi e altri rivelarono
247
126 T. BREMER, Il viaggio sulla carta. Viaggi come strategia di discorso in Kant, inD'AGOSTINI, La letteratura di viaggio, cit., pp. 63-73.
127 J. MEERMAN, Discours sur le premier voyage de Pierre le Grand principalement enHollande, Debure, Paris 1812.
appena negli ultimi anni di vita una formazione culturale prettamentesettecentesca, espressione tipica degli anni della loro maturazione mache rischiava di divenire, nel volgere del nuovo secolo, segnale diorientamenti retrospettivi.
Esempio paradigmatico di queste forme della cultura sono i Com-ponimenti lirici e drammatici di Giulio Gravisi, marchese di Pietrapelo-sa, giaÁ vice-pretore di Gradisca. Il titolo giaÁ rivendicava l'esperienza« cosmopolita » dell'autore, che dichiarando la nascita istriana (e l'ap-partenenza all'avito casato dei marchesi di Pietrapelosa) si professava« triestino » ma giaÁ vice-pretore della contea di Gorizia e di Gradisca.Il proemio del volumetto chiariva poi la vocazione dell'autore: « ungiurisprudente? Un uomo d'ufficio sovrano [...] nella sera dei suoidõÁ comparire sul teatro letterario in figura di poeta galante? O cheenigma! O che incongruenza! SciameraÁ taluno dei miei leggitori ».E cosõÁ proseguiva: « nacqui con genio per la poesia e d'averlo sortitomi convinsi avvicinando nella dominante di Vienna l'immortale Meta-stasio nei riservati momenti del suo poetico entusiasmo, in tempo chenel 1771 m'era colaÁ portato per gli studi di legge ». E spiegava le ra-gioni della tarda restituzione al mondo delle lettere, in quanto le pre-cedenti circostanze «mi vincolarono bensõÁ costante alla seria ed utileapplicazione della giurisprudenza, nel cui esercizio anco invecchiai ».
Mentre Giulio Gravisi tra gli incartamenti processuali meditavaodi e sonetti e mentre i pastori arcadi di Gorizia e di Trieste si affan-navano nella ricerca di nomi altisonanti (Nivildo Amarinzio, Cori-bante Tebanico, Carippo Megalense) per i nuovi aggregati e poiper le gentildonne, ammesse in ossequio ad un'apertura piuÁ vicinaa quella delle accademie viennesi che di quelle italiane (tra gli ArcadiRomano-Sonziaci vi furono ben quattordici nobildonne goriziane,con nomi gentili quali Aurisbe Tarsense o Fiordalisa Aufidense), altrisi dedicavano ad argomenti di diverso impegno e con alterna fortuna.
Benedetto Frizzi, medico mantovano nato a Ostiano in Lombar-dia nel 1756, laureato a Pavia e giunto a Trieste nel 1790, editore inquello stesso anno di un Giornale medico e letterario di Trieste, si tra-sformava nel 1791 in BenoõÃt Frizzi per tessere l'EÂloge funebre deMonsieur Richard maõÃtre de langue francËoise, un insegnante di linguafrancese (Louis-Antoine-Robert des Richards) originario di Chau-ment et Bassigny (Haute-Marne) morto nel porto franco il 16 feb-
248
braio di quell'anno. E prima di fare ritorno ad Ostiano, dove sarebbemorto nel 1844, Frizzi avrebbe fatto ancora in tempo a frequentare ilGabinetto di Minerva (fondato nel 1810) e laÁ « coi calzoni corti ed iltricorno, atteso in istrada dal servo con la lanterna cieca, leggeva Suivantaggi e sugli abusi della cavalcatura in medicina, quando in Triestesi contavano dieci equipaggi privati, pochissime carrozze da nolo peril servizio della cittaÁ e per il corso del carnevale » 128.
E di lõÁ a poco un altro « dilettante » si riscattava dagli affari di ne-gozio, il grigionese Andrea Griot, nato a Cellerina in Svizzera nel 1756,giunto a Trieste prima del 1780, commerciante e primo console sviz-zero nel Litorale Austriaco. Pure lui, ritiratosi dall'attivitaÁ, trascorren-do gli anni della vecchiaia nel podere alla periferia cittadina potevaesprimere una vocazione letteraria. E cantava in rima (1825): «Alfinrespiro e vivo a San Giovanni / agiato agricoltor umile e oscuro / difama, vita e proprietaÁ sicuro / senza pensier molesti e senz'affanni ».
Questo era, sostanzialmente, il quadro tracciato da Lorenzo Mi-niussi ± amico fraterno di Domenico Rossetti e suo compagno di studiall'universitaÁ ± nella sua Trieste letterata (1812), un testo completa-mente dimenticato negli ultimi due secoli. L'autore, nato a Monfalco-ne nel 1773, studente in legge con Rossetti a Vienna, notaio e poi pre-side del Magistrato civico, fu certamente una figura di secondo pianonella storia letteraria cittadina, anche se arcade e poi animatore dellaSocietaÁ di Minerva, creata in epoca napoleonica 129. L'opera intitolataTrieste letterata venne annunciata in una conferenza pubblica tenuta
249
128 Su Frizzi cfr. P. BERNARDINI, La sfida dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nel-l'etaÁ della Rivoluzione francese, Bulzoni, Roma 1996, pp. 74-80; D. NISSIM, ModernitaÁ divedute in un nostro illuminista: Benedetto Frizzi e le sue opere, « Rassegna mensile diIsrael », 5 (1968); L. C. DUBIN, The Sages as Philosophes: Enlightenment and Aggadahin Northern Italy, in Open Thou Mine Eyes. Essays on Aggadah and Judaica, Ktav,New Jersey 1992; G. LUZZATTO VOGHERA, Il prezzo dell'uguaglianza. Il dibattito sull'e-mancipazione degli ebrei in Italia (1781-1848), FrancoAngeli, Milano 1998, pp. 136-138, nonche T. CATALAN, La comunitaÁ ebraica di Trieste (1781-1914). Politica, societaÁ,cultura, Lint, Trieste 2000, pp. 11-57 che dedica i primi due capitoli del suo lavoro allacondizione degli ebrei triestini tra Settecento e Ottocento.
129 Manca una biografia di Lorenzo Miniussi, deceduto nel 1839, in mancanza dellaquale si deve fare ancora riferimento al profilo scritto da Cesare Pagnini in ROSSETTI,Scritti inediti, II, cit., pp. 30-32.
alla Minerva quando il porto franco ancora viveva la terza occupazio-ne francese (1809-1813) e il suo scopo andava al di laÁ di un intentomeramente compilatorio 130. Certamente non era quello di legittimarepoliticamente l'identitaÁ del porto franco ± come avrebbe fatto di lõÁ apoco Rossetti con laMeditazione storico-analitica sulle franchigie dellacittaÁ e portofranco di Trieste (1814) ± tuttavia rivelava l'esigenza di ri-visitare le vicende letterarie della cittaÁ e appariva il segno di voler in-dagare sulla sua identitaÁ culturale per proporre ai triestini un'idea dipatria che non fosse semplicemente risultato di provvidenze economi-che e politiche della monarchia asburgica 131. D'altra parte, pochi an-ni erano trascorsi dalla celebre orazione pavese di Ugo Foscolo sul-l'importanza delle storie patrie e proprio Rossetti, fin dal 1801, avevainvitato i concittadini a seguire l'attivitaÁ del poeta di Zante, colpito inparticolare dal Tieste, scritto da « un giovane di 19 anni. Che non pos-siamo sperare da lui quando avraÁ passato i 30 o i 40 anni? » 132.
L'opera di Miniussi, nella misura in cui puoÁ essere considerataespressione di una sensibilitaÁ culturale e di una riflessione storiogra-fica maturata nell'ambito della rossettiana SocietaÁ di Minerva, costi-tuisce il primo indizio di un'autocoscienza collettiva nella « rifonda-zione » di una letteratura municipale. Quando ormai Rossetti andavamaturando le scelte che, sul piano delle rivendicazioni politiche, loavrebbero portato a divenire il difensore dei diritti storici della cittaÁe nel momento in cui pure il programma culturale della neonata So-cietaÁ di Minerva (e poi dell'Archeografo Triestino, la rivista fondatanel 1829) voleva scuotere gli animi e la coscienza civile dei triestini,la ricostruzione di una storia della storiografia letteraria e politica
250
130 Il testo si trova nel volume manoscritto Passatempi di Minerva, I, in BCTs, segn.R.P. MS MISC. 2-43, cc. 91r-101r. L'originale autografo di Miniussi, che non presentadifferenze rispetto alla trascrizione, eÁ conservato in CMSA, Archivio della SocietaÁ di Mi-nerva, fasc. 1812. EÁ stato pubblicato in A. TRAMPUS, Storia della cultura e storia della sto-riografia: la « Trieste letterata » di Lorenzo Miniussi (1812), «Quaderni Giuliani di Sto-ria », 1-2 (1991), pp. 66-71.
131 Un cenno in G. NEGRELLI, Comune e impero negli storici della Trieste asburgica,GiuffreÁ , Milano 1968; cfr. anche M. ZORICÂ , Italia e Slavia. Contributi sulle relazioni let-terarie italo-jugoslave dall'Ariosto al D'Annunzio, Antenore, Padova 1989, pp. 142-171.
132 R. MARINI, Versi inediti, in ROSSETTI, Scritti inediti, I, cit., p. 272; cfr. inoltre G.GETTO, Storia delle storie letterarie, Sansoni, Firenze 1969, pp. 77-130.
della cittaÁ acquistava un nuovo significato rispetto alle vecchie crona-che municipali. L'iniziativa diventava rivelatrice, cioeÁ , del rapporto incui i nuovi intellettuali si ponevano con la tradizione erudita e parti-colaristica dei secoli precedenti e rappresentava la rivendicazione diun'autonomia di pensiero e di giudizio rispetto alle radici culturalidella cittaÁ antica.
Agli occhi di quei nuovi triestini la cittaÁ , che veniva chiaramenteindividuata come patria di elezione, proprio nella consapevolezzadelle diverse origini etniche e culturali, era da rifondare culturalmen-te attraverso un confronto tra le differenti esperienze intellettuali cheavrebbe consentito di proporsi dinanzi al governo francese (e poi algoverno austriaco) quali interlocutori qualificati, non solo dal puntodi vista giuridico o politico ma anche culturale.
« Trieste eÁ ormai una cittaÁ d'importanza, e se cent'anni or sonoella era sconosciuta a gran parte dell'Eruopa, ormai eÁ dessa nominataanche nell'America. Non eÁ da meravigliarsi percioÁ » ± scriveva Mi-niussi ± « se lo straniero vi arriva con un'idea grande della medesi-ma » 133. Ragione per la quale « perche non dovremmo anche noi cer-car di conservar la memoria di quei nostri concittadini che ci lasciaro-no qualche frutto de' loro studi, ai quali forse non si oppose null'altroa diventare uomini celebri nelle scienze ed arti che il semplice caso dinon essere nati in una Vienna, in una Londra o Parigi, ove il consorziocon letterati d'ogni classe e la comoditaÁ di grandi biblioteche avrebbesviluppato i loro talenti ed avrebbe loro amministrato tutti quegli am-minicoli de' quali ha sõÁ sovente bisogno lo scrittore? » 134.
Miniussi intendeva percioÁ costruire un'opera articolata in cinqueparti: la prima dedicata ad un dizionario biografico e bibliografico ditutti coloro che a Trieste si erano impegnati nelle lettere o nelle arti;la seconda riservata ad un catalogo bibliografico di tutti gli scrittistampati nella cittaÁ ; nella terza e nella quarta avrebbe dato notiziadi tutte le opere contenenti riferimenti a Trieste e al Litorale, mentrela quinta « conterraÁ una serie di tutti i rami e prospetti sieno generalio di oggetti speciali di Trieste con indicazione di quanto riguarda la
251
133 TRAMPUS, Storia della cultura, cit., p. 67.134 TRAMPUS, Storia della cultura, cit., p. 69.
storia loro » 135. Anche se l'opera di Miniussi, sin dalla sua presenta-zione, appariva piuÁ come un work in progress che come un prodottofinito, essa tuttavia documenta un tipo di sensibilitaÁ sicuramente nonpiuÁ vincolata agli indirizzi tipicamente eruditi che avevano accompa-gnato la storia patria nel Seicento e nel primo Settecento. In essa, adesempio, la societaÁ letteraria era presentata con una funzione di ser-vizio e di educazione civile per la collettivitaÁ , e non piuÁ soltanto dimero intrattenimento; vi emergeva l'esigenza di procedere alla rico-gnizione della storia cittadina con spirito critico, superando l'impe-gno meramente documentaristico della vecchia erudizione; veniva ri-meditato il ruolo di Trieste alla luce della sua importanza nella pro-vincia del Litorale, rispetto ad altre cittaÁ e capitali culturali europee.
Un limite invece, che denunciava la tradizione settecentesca incui affondavano le radici intellettuali di Miniussi, era rappresentatodal metodo con cui risolveva l'approccio documentario, scegliendola prospettiva della cultura letteraria e della catalogazione bibliogra-fica, che riconducevano al modello proposto molto piuÁ indietro neltempo da Girolamo Tiraboschi 136.
Tardi ± anzi, troppo tardi ± il capodistriano Giuseppe de Lugna-ni (non certo, tra l'altro, uno dei migliori ingegni della regione) si sa-rebbe reso conto che a Trieste le arti e il commercio erano in strettorapporto e avrebbe avvertito l'esigenza di scrivere sul tema Della con-nessione che hanno tra loro le scienze ed il commercio (Trieste1817) 137. Sul terreno della riflessione teorica non gli rimaneva chel'imitazione di analoghi dibattiti settecenteschi nella Francia e nell'In-ghilterra. Sul piano della pratica dimostrazione poteva solo constata-re quanto gli era attorno.
252
135 TRAMPUS, Storia della cultura, cit., p. 71. L'opera Trieste letterata consta, allo sta-to di completamento in cui la lascioÁ Miniussi, in 238 carte numerate; il manoscritto eÁconservato in FSA, segn. G 49b.
136 M. MARI, Il genio freddo. La storiografia letteraria di Girolamo Tiraboschi, « Ber-gomum», LXXXV, 4 (1990), pp. 53-66.
137 Su de Lugnani si vedano P. TREMOLI, Cultura umanistica di Giuseppe De Lugnani,Trieste 1950; GUAGNINI, I doni di Minerva e di Mercurio a Cesare. Il neoclassicismo di Giu-seppe De Lugnani, in CAPUTO (a cura di), Neoclassico, cit., pp. 296-299; P. ZOVATTO, Giu-seppe De Lugnani (1793-1857) e il cattolicesimo fra Trieste e Capodistria, « Atti e Memoriedella SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », n.s. XLVI (1998), pp. 255-280.
IX. - LA PACE UNIVERSALE COME STATO DELLANATURA: DOMENICO A. AZUNI E TRIESTE
La particolare situazione politica, economica e sociale del Litora-le Austriaco rispetto agli altri Stati della penisola italiana, nell'epocain cui si rivelarono piuÁ intensi gli effetti della Rivoluzione francese,influenzoÁ in modi diversi l'opera di intellettuali europei che vi furonoattivi, anche per breve tempo. Come avvenne nel caso di DomenicoAlberto Azuni, giurista e politico sardo.
Nel Discorso preliminare posto in apertura del Sistema universaledei principj del diritto marittimo dell'Europa Azuni dichiarava la con-vinzione che aveva animato, come in seguito avrebbe guidato, la suaopera scientifica: « L'uniformitaÁ de' rapporti di tutti gli uomini collanatura ha stabilita la necessitaÁ assoluta d'una societaÁ universale e per-petua, composta di tutte le societaÁ particolari, che trovansi sparsesulla superficie del nostro globo. Cotesti rapporti, non essendo fon-dati sopra di speciali convenzioni, ma bensõÁ sulle leggi eterne, ed in-variabili della natura, non hanno potuto in alcuna guisa venir alteratida istituzioni particolari. [...] Tale considerazione fa ravvisare sullasuperficie della terra una sola nazione formata di quante la coprono,benche diverse in origine, in religione, in costumi, in bisogni, in co-lore, in linguaggio, ed in mille altri riguardi » 1.
253
1 D.A. AZUNI, Sistema universale dei principj del diritto marittimo dell'Europa, I,Wage, Fleis e C., Trieste 17962, pp. 5-7 (la prima edizione era stata stampata a Firenze
Ormai affermatosi con il Dizionario universale ragionato dellagiurisprudenza mercantile, degli anni 1786-1788 2, e maturata pureuna buona esperienza professionale, Azuni ± nato nel 1749 3 ± giaÁsi apprestava a nuove ricerche e allo sviluppo degli studi che avreb-bero poi garantito la sua fama.
Laureato in diritto a Sassari nel 1772, esercitoÁ l'avvocatura nellacittaÁ natale e a Torino, divenendo nella capitale piemontese applicatoall'Ufficio generale di finanza per essere poi destinato, nel 1780, a vi-ce intendente generale a Nizza. La buona preparazione giuridica eduna forte volontaÁ di distinguersi lo portarono nel 1782 alla carica digiudice del Consolato del commercio di Nizza, ufficio di determinan-te importanza per la sua maturazione professionale, nonche occasio-ne per la specializzazione in diritto commerciale e in diritto maritti-mo. Frutto dell'attivitaÁ a Nizza, i quattro volumi del Dizionario uni-versale ragionato della giurisprudenza mercantile contribuirono inmodo decisivo alla diffusione del suo nome e all'apprezzamento dellasua opera, non certo di pura dottrina e destinata essenzialmente allapratica giudiziaria. Nel 1789 fu chiamato a Torino dal re di Sardegnaper redigere il progetto di un nuovo codice di diritto marittimo; lõÁ fusorpreso dal precipitare degli eventi in Francia tanto che, sospettatodi giacobinismo e messo in difficoltaÁ da vicende private 4, dovette la-
254
nel 1795); ID., Droit marittime de l'Europe (ristampa anastatica della traduzione france-se), Bottega d'Erasmo, Torino 1972. Sul tema P. GARBARINO, Il diritto romano nel 'Droitmarittime de l'Europe' di Domenico Alberto Azuni, « Archivio giuridico », 222 (2002),pp. 569-604;
2 D.A. AZUNI,Dizionario universale ragionato della Giurisprudenza mercantile, Socie-taÁ tipografica, Nizza 1786-1788; G.S. PENE VIDARI, Cenni sulla codificazione commercialesabauda, in Studi in memoria di Mario Abrate, Giappichelli, Torino, 1986, pp. 693-706.
3 Per la biografia sono fondamentali i lavori di L. BERLINGUER, Domenico AlbertoAzuni giurista e politico (1749-1827). Un contributo bio-bibliografico, GiuffreÁ, Milano1966 e ID., Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808). Considera-zioni su un inedito di D.A. Azuni, GiuffreÁ, Milano 1970. Da aggiungere ID., D.A. Azuni egli Stati Uniti d'America, « Studi Senesi », 13, 2 (1964), pp. 151-196. Cfr. inoltre, sinteti-camente, F. LIOTTA, Azuni Domenico Alberto, voce in Dizionario biografico degli italiani, 4,Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1962, pp. 159-161 e M. CHIAUDANO, Azuni Do-menico Alberto, voce in Novissimo Digesto Italiano, II, UTET, Torino 1958, pp. 191-192.
4 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 111-118. A queste accuse si ag-giunse, d'altra parte, la circostanza che i beni della moglie (francese, il cui padre era statodecapitato) vennero confiscati dall'autoritaÁ francese di occupazione e invano Azuni si
sciare Nizza nel 1792 per un esilio che, negli anni successivi, lo avreb-be portato nelle maggiori cittaÁ dell'Italia centro-settentrionale, primadel soggiorno triestino. Da Modena si trasferõÁ a Firenze, dove prose-guõÁ l'attivitaÁ scientifica pubblicando la prima edizione del Sistemauniversale e il volumetto, di tutt'altro oggetto, contenente la Disserta-zione sull'origine della bussola nautica, destinato a un certo successoeditoriale 5.
Giurista e politico, prima che storico e filosofo, Azuni ebbe sin-golarmente non poca fama in vita e negli anni immediatamente suc-cessivi alla morte, per essere poi a lungo dimenticato prima che nuovie piuÁ approfonditi studi di quest'ultimo dopoguerra riproponesserola sua opera all'attenzione degli studiosi, rilevandone la sicura valen-za nella storia della cultura italiana ed europea tra l'etaÁ dei lumi e lafine dell'esperienza napoleonica 6.
Le posizioni di Azuni e le sue idee specialmente nel campo deldiritto pubblico marittimo, condizionate in misura non irrilevantedall'esperienza universitaria e pure segnate dalle particolari condizio-ni politiche e sociali della terra d'origine 7, trovarono significativacorrispondenza nell'azione politica, riformatrice ed assolutista, delsovrano Carlo Emanuele III 8. Azuni, formatosi presso una scuolagiuridica di livello certo non eccelso ma dotato di una personalitaÁparticolare per notevoli volontaÁ ed ambizione, sensibile d'altra partealle istanze della cultura francese, fu sostanzialmente contraddittorionella produzione scientifica, in cui alla bontaÁ e alla modernitaÁ delleidee non corrisposero sempre analoghe caratteristiche nelle realizza-
255
adoperoÁ per tornarne in possesso. Per l'inquadramento della politica europea nel Medi-terraneo, con speciale riferimento alla Sardegna, cfr. G. LIVET, Le trasformazioni politi-che dello spazio mediterraneo nel XVIII secolo e la Sardegna, in Storia dei Sardi e dellaSardegna, IV, L'etaÁ contemporanea, dal governo piemontese agli anni Sessanta del nostrosecolo, Jaca Book, Milano 1989, pp. 1-24.
5 D.A. AZUNI, Dissertazione sull'origine della bussola nautica letta alla Reale Accade-mia fiorentina, Appresso Filippo Stecchi, Firenze 1795; su quest'opera e sul soggiornofiorentino di Azuni cfr. ancora BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 156-159.
6 CHIAUDANO, Azuni, cit., p. 192.7 In particolare BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 15-47.8 Sul tema A. GIRGENTI, La storia politica nell'etaÁ delle riforme, in Storia dei Sardi e
della Sardegna, IV, cit., pp. 25-112.
zioni editoriali, prevalentemente finalizzate all'utilitaÁ pratica 9. Esem-plare, in tal senso, il Dizionario universale ragionato della giurispru-denza mercantile, frutto di attivitaÁ piuÁ compilatoria che esegetica econsistente in un riordinamento ragionato della migliore giurispru-denza commerciale e marittima nella prospettiva della formazione,come ricordava nella prefazione, di « una disciplina regolare » e diun « ordine semplice, e conciso » 10.
D'altra parte fu modernamente convinto, nell'epoca di una co-scienza codicistica ancora in formazione, dell'opportunitaÁ di dare spe-ciale autonomia al diritto marittimo all'interno di un corpo di leggi,distinguendolo cosõÁ dalla materia strettamente commerciale e antici-pando, fin dal 1791, istanze solo piuÁ tardi avvertite e nemmeno deltutto recepite nella redazione del napoleonico Code de commerce 11.Fu comunque, per ampiezza di interessi e per vastitaÁ dei campi di in-dagine, un intellettuale di impronta pienamente settecentesca, appas-sionato, oltre che delle scienze giuridiche, di materie tecnico-scienti-fiche, di filosofia, di storia e di poesia; ben ha colto l'importanza deisuoi contributi culturali chi osservoÁ come « la straordinaria capacitaÁdivulgativa, le comunicative doti semplificatorie trassero dal suo sensopratico maggior forza ed assicurarono il successo alle sue opere, sup-plendo al difetto di originalitaÁ e di profonditaÁ di pensiero, ed inseren-dole tempestivamente in quel movimento di divulgazione e di diffu-sione delle conoscenze giuridiche e della loro pratica utenza » 12.
In questa prospettiva l'attivitaÁ svolta da Azuni durante il suo sog-giorno triestino appare esemplificativa.
Se, come si eÁ accennato, il suo esilio fu causato da motivazioniessenzialmente politiche, furono invece di natura economica le circo-stanze che lo indussero a scegliere, quale ulteriore meÂta del suo pe-regrinare, la cittaÁ di Trieste. Dopo la fortunata pubblicazione dellaprima edizione del Sistema universale dei principj del diritto maritti-mo, Azuni fu contattato dalla tipografia editrice Wage, Fleis e C.
256
9 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 77-80.10 AZUNI, Dizionario, cit., I, p. 3.11 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 86.12 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 75.
di Trieste, nella persona del titolare Giovanni Ignazio Condutsch 13,per una collaborazione editoriale di vasto interesse e di reciprocovantaggio all'ombra delle provvidenze asburgiche, in terra cioeÁ nonancora interessata dalle campagne militari francesi. Per l'editore trie-stino, fino ad allora impegnato soprattutto nella pubblicazione diopere tedesche e francesi in traduzione italiana nonche di qualche te-sto originale 14, si presentava l'occasione per dare nuovo impulso eprestigio alla propria attivitaÁ . Per Azuni si prospettava un incaricoprofessionale che, almeno, avrebbe potuto produrre qualche vantag-gio economico. EÁ certamente significativo il fatto che un primo ac-cordo tra le parti, risalente agli ultimi mesi del 1795, fu raggiuntoper la pubblicazione di un'opera originale, quella che Azuni nel pro-prio programma scientifico considerava la piuÁ impegnata e importan-te: vale a dire il Progetto di Codice della legislazione marittima 15 e chenell'annuncio editoriale triestino di lõÁ a poco diffuso diveniva il Codi-ce delle leggi del Commercio marittimo e terrestre dell'Europa, in duevolumi di grande formato 16. L'iniziativa non raggiunse una fase dilavoro successiva al manifesto di edizione, causa probabilmente l'im-possibilitaÁ di provvedere ad un'opera di tanto impegno in tempi bre-vi; del resto il lavoro, benche completato, non pote essere pubblicatonemmeno a Parigi nel 1801, quando tutte le circostanze sembravanoormai favorevoli, tanto da restare da allora inedito 17.
L'editore triestino preferõÁ ripiegare, fin dal marzo 1796, su unameno impegnativa seconda edizione del Sistema universale, ormai
257
13 CioÁ si rileva dalla lettera dei fratelli Condutsch ad Azuni premessa al primo vo-lume del Sistema universale, cit., pp. XI-XII.
14 Un elenco delle opere stampate da quell'editore si trova in chiusura del volumeVita di Abelardo ed Eloisa, tr. it. a cura di A. METRAÁ , Wage, Fleis e C., Trieste 1795,pagina non numerata.
15 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 160.16 Ne fu stampato a Trieste nel 1796 un avviso editoriale in foglio unico volante,
mentre notizie piuÁ diffuse sull'iniziativa vennero date nel giornale veneziano «Notiziedel mondo », n. 13, 1796 e nella «Gazzetta universale » di Firenze, 19, 5 marzo 1796.Trieste peraltro vanta una tradizione nella materia; cfr. M.R. DI SIMONE, Un progettodi codice marittimo austriaco nel primo Ottocento, in CATTARUZZA (a cura di), Trieste, Au-stria, Italia, cit., pp. 85-112.
17 CosõÁ BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 102.
esaurito a Firenze, riuscendo comunque ad assicurarsi correzioni epostille dell'autore. Il 23 aprile 1796, elogiando l'iniziativa, Azuni in-vioÁ a Trieste i testi con una lunga lettera poi apparsa in apertura delprimo volume. CosõÁ, presso la tipografia Wage, Fleis e C., fu pubbli-cato nell'ottobre successivo il Sistema universale dei principj del dirit-to marittimo dell'Europa, nell'edizione seconda, riveduta ed aumentatadall'autore 18.
All'epoca il giurista sardo era giaÁ arrivato a Trieste per stabilirvi-si; vi era giunto da Firenze, dopo un breve soggiorno a Bologna, e viaveva trovato subito buona accoglienza. Al settembre 1796 risale lasua aggregazione alla declinante Arcadia triestina, retta dal bibliote-cario de Coletti e protetta dal governatore conte Brigido 19; l'aggre-gazione aiutoÁ certamente Azuni a stabilire contatti con l'ambienteculturale e letterario triestino e fu seguita, come consuetudine, daun dono di libri alla biblioteca pubblica. Nonostante sia arduo ten-tare di ricostruire oggi nel dettaglio la consistenza di quella donazio-ne, si puoÁ comunque affermare con una certa sicurezza che vi eranocompresi i due tomi della seconda edizione del Sistema universale,nonche il volumetto, stampato a Firenze nel 1783, contenente il Di-scorso filosofico-politico sopra la carcere dei debitori, di Cosimo Ami-dei (la cui prima edizione era del 1770) 20.
Come giaÁ accennato, l'attivitaÁ scientifica e culturale di Azuni du-rante il soggiorno triestino esemplifica i suoi vasti interessi e l'ampiaproduzione editoriale. Mentre infatti provvedeva in Venezia alla se-conda edizione della Dissertazione sull'origine della bussola nautica 21,
258
18 Due volumi in 8ë, rispettivamente di pp. 287 e 318. In apertura del primo volu-me eÁ posto il ritratto dell'autore.
19 Il diploma di aggregazione eÁ conservato presso la Biblioteca universitaria di Ca-gliari (BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 162 nota 143) benche il nome diAzuni non sia annotato nei registri accademici conservati presso la Biblioteca Civica `̀ At-tilio Hortis'' di Trieste.
20 C. AMIDEI, Discorso filosofico.politico sopra la carcere dei debitori, nuova edizionecon aggiunte, Della Rovere, Firenze 1783. L'esemplare eÁ conservato presso la BibliotecaCivica di Trieste dove reca l'antica collocazione Vv-6ë/13ë, immediatamente consecutivaa quella della copia del Sistema universale donata da Azuni.
21 D.A. AZUNI, Dissertazione sull'origine della bussola nautica letta alla Reale Acca-demia fiorentina il dõÁ 10 settembre dell'anno 1795, Zatta, Venezia 1797; si tratta della
pubblicata da Zatta prima ancora dell'occupazione francese, a Trie-ste si impegnoÁ in un'opera di scarso valore scientifico ± ma rispon-dente al criterio di utilitaÁ pratica da lui perseguito ± che lo gratificavaalmeno in prospettiva economica: si trattava del completamento delquinto tomo de Il mentore perfetto de' negozianti, ovvero guida sicurade' medesimi, rimasto incompiuto causa i contrasti tra l'editore e l'o-riginario autore, successivamente deceduto 22. Tanto fu il prestigiorecato dalla nuova collaborazione, che gli editori ± pur omettendoil nome di Azuni in frontespizio ± sottolinearono nella prefazione co-me « ci riuscõÁ alfine di ritrovare uno de' piuÁ celebri scrittori d'Italia,che se ne assumesse l'incarico, ed egli proseguõÁ la compilazione diquesto volume [...], unendo all'esattezza delle descrizioni la puritaÁdello stile » 23.
Non si puoÁ fare certo torto al giurista sardo dell'omissione dellafirma in un'opera che, oltre ad esulare del tutto dalla sua competenzascientifica, si limitava ad una semplice rassegna delle principali piazzedi commercio del mondo, con indicazioni di carattere strettamenteeconomico e commerciale e con riferimenti dettagliati a produzioniindustriali ed artigianali, al mercato dei cambi e alle procedure doga-nali: cognizioni vaste e specifiche, che suggerirebbero la collaborazio-ne esterna di uno o piuÁ esperti rimasti sconosciuti. Tutt'al piuÁ l'ap-porto personale di Azuni si puoÁ riconoscere laddove, trattando delleistituzioni politiche e amministrative di San Gallo, si considerava po-sitivamente la procedura essenzialmente orale presso quel tribunalecittadino, le cui sentenze erano assunte a modello di giudizio equo
259
seconda edizione dedicata dall'editore, certo non lasciando all'oscuro Azuni, « al Citta-dino Giovan Battista Sibille, Capitano di fregata e Comandante della marina francesenell'Adriatico » (pp. V-VIII).
22 L'autore era Andrea MetraÁ , morto quarantenne a Trieste il 12 marzo 1797 (cfr.«Gazzetta di Trieste », n. 34, 28 aprile 1797). Per i contrasti fra MetraÁ e la tipografiaWage, Fleis e C. si veda la Risposta di Andrea MetraÁ all'Avvertimento della Ditta Wage,Fleis e Comp., « L'Osservatore Triestino », n. 26, 28 marzo 1796, p. 444.
23 Il mentore perfetto de' negozianti, ovvero guida sicura de' medesimi ed istruzioneper rendere ad essi piuÁ agevoli, e meno incerte le loro speculazioni: trattato utilissimo divisoin cinque tomi, V, Wage, Fleis e C., Trieste 1797 (ivi, Gli editori a chi legge, p. V). Nellaprefazione si avverte che ad Azuni va attribuita la « compilazione di questo volume dal-l'articolo di Salonicco sino al compimento dell'opera », cioeÁ le pp. 189-586.
ed imparziale 24; oppure quando si accennava al tribunale mercantiledi Ancona per sottolineare che « la speditezza e giustizia colla qualevengono definite le cause in questo tribunale, meritano lode, ed imi-tazione » 25.
L'opera non dovette avere molto successo; certamente fu inferio-re a quello della riedizione del Sistema universale, tipograficamentepiuÁ accurata, e la sua limitata diffusione fu probabilmente una dellecause principali della poca risonanza e del rapido oblio 26.
A questo periodo della vita di Azuni, ad un momento cioeÁ di re-lativa quiete nel volgere degli accadimenti politici in Europa, risaleuno scritto originale rispetto alle tematiche prevalenti della sua pro-duzione scientifica che, se non fu proprio frutto della sua meditazio-ne triestina, almeno in parte venne ispirato dal breve soggiorno in unluogo d'osservazione sufficientemente distaccato dai grandi rivolgi-menti politici del momento 27: la Dissertazione sullo stato naturaledell'Uomo, del Senatore Domenico Alberto Azuni Patrizio Sassaresee Pisano, Socio di varie Accademie. EÁ da considerare certamente il la-voro piuÁ originale del periodo triestino di Azuni e fu il primo prodot-to di un suo interesse specificamente filosofico-politico, sviluppatosinegli anni successivi benche espresso in studi di relativa originalitaÁ ,che sono utili tuttavia per completare la biografia intellettuale delpersonaggio 28. Di fatto, tanto la Dissertazione quanto i successivi
260
24 Il mentore, cit., p. 200.25 Il mentore, cit., p. 222.26 Nel 1798, alla morte di Giovanni Ignazio Condutsch titolare dello stabilimento
tipografico, venne steso l'inventario dei beni giacenti nella tipografia e nella pertinentelibreria (ASTs, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 138, n. 3/1798), dal quale ri-sultavano invendute 1.088 copie del quinto volume di Il mentore, rispetto alle circa 170del Sistema (213 copie del primo volume e 160 copie del secondo).
27 Per la prima occupazione francese di Trieste (marzo-maggio 1797) cfr. G. QUARAN-
TOTTI, Trieste e l'Istria nell'etaÁnapoleonica, Le Monnier, Firenze 1954, pp. 41-68 e, piuÁ sin-teticamente, L. TASSINI, Il governo francese a Trieste (1797-1813): lineamenti storici, giuridi-ci, economici, «Archeografo Triestino », s. IV, VIII-IX (1945), pp. 435-485 e G. GIOSEFFI,Le tre occupazioni francesi di Trieste in G. CASA (a cura di), Atti del congresso del quindicen-nale `̀ Trieste e la Francia'' (7-10 novembre 1984), Italo Svevo, Trieste 1986, pp. 13-20.
28 Il manoscritto della Dissertazione sullo stato naturale dell'Uomo, del Senatore Do-menico Alberto Azuni Patrizio Sassarese e Pisano, Socio di varie Accademie si trova inBCTs, segn. MS MISC. 50.
scritti filosofici rimasero inediti l'autore mentre era in vita, anche sela destinazione pubblica risulta evidente. CioÁ vale sia per il mano-scritto triestino, sia per la successiva traduzione in lingua francese,commissionata da Azuni tra il 1798 ed il 1805, di uno studio filoso-fico-politico notevolmente rielaborato rispetto al testo elaborato aTrieste 29. La stessa Dissertazione appare compiuta e in versione de-finitiva, tanto che la sua provenienza ± dai documenti del tipografode Coletti 30 ± conferma la circostanza che l'edizione a stampa fu im-pedita dai mutamenti politici avvenuti a Trieste nel marzo 1797.
Se la stesura di questo lavoro risale effettivamente al gennaio o alfebbraio 1797, come dichiara l'autore in frontespizio e nel lungo te-sto dedicatorio al governatore Pompeo de Brigido, possiamo ancheescludere un collegamento diretto di tale opera con l'Accademia ar-cadica, la cui attivitaÁ , giaÁ notevolmente diradata al momento dell'am-missione di Azuni, era cessata del tutto in quel periodo 31.
La Dissertazione, articolata in due parti, eÁ preceduta da un'Intro-duzione che, attraverso un'apologia alla pace, presenta in sintesi i prin-
261
29 Manoscritto Dissertation sur l'eÂtat naturel de l'homme. Par le citoyen DominiqueAlbert Azuni, conservato nella Biblioteca universitaria di Cagliari (cfr. BERLINGUER, Do-menico Alberto Azuni, cit., p. 273). Di questo testo, ritradotto in lingua italiana, fu curataun'edizione da S. COCCO SOLINAS con il titolo Intorno alla pirateria; Sullo stato naturaledell'uomo / opere tradotte dal francese per cura di S. Cocco Solinas, la prima dall'edizionedel 1816 con aggiunte e correzioni tratte dalle postille fattevi dall'autore, la seconda dal ma-noscritto originale esistente nella R. Universita di Sassari, G. Dessi, Sassari 1892.
30 Il numero d'ingresso posto in calce all'ultima pagina del manoscritto (142339/1959) rinvia ai registri della Biblioteca Civica dove, alla data del 3 giugno 1959, il docu-mento eÁ dichiarato proveniente « dalla Biblioteca ». EÁ da ritenere che l'originaria collo-cazione fosse non giaÁ tra i documenti dell'Arcadia (come supposto da BERLINGUER, Do-menico Alberto Azuni, cit., pp. 280-281) che hanno sempre conservato una sostanzialeunitaÁ , ma piuttosto tra quelli di Giuseppe de Coletti, stampatore nonche segretario del-l'Accademia, pure conservati nella stessa Biblioteca.
31 Si veda, in chiusura del manoscritto, la « dedica da porsi dopo il frontespizio conlettere lapidarie »: « Al Nobilissimo e Ragguardevolissimo / Sig. Conte / Pompeo Brigi-do / Libero Barone di Marenfels ecc. ecc. / Consigliere Intimo di Stato di S. M. I. R. A. /Governatore della CittaÁ e Porto Franco / di Trieste / Padre Amoroso di Prole / Ama-bilissima / Ottimo Capo di Famiglia / Protettore del Commercio / e della Navigazione /Savio, Splendido, Affabile, Pietoso / Sincero / Amante de' buoni / e caro ad ognuno /Questa Dissertazione / In segno della piuÁ alta stima / Offre e consacra / Domenico Al-berto Azuni / ». Come si puoÁ notare, manca qualsiasi riferimento all'Arcadia di cui Bri-gido era protettore.
cipali riferimenti filosofici su cui poggia la riflessione dell'autore. Laguerra eÁ condannata perche elemento distruttore dell'economia dellenazioni, dei rapporti sociali, degli equilibri politici e giuridici dello Sta-to; la pace viene presentata come lo stato naturale dell'uomo e cioÁ sirivela nell'intimo giudizio dell'essere umano davanti al « tribunale dellaragione ». Proprio la coscienza-ragione, immanente, rivela come « lalegge di natura, che eÁ quella di giustizia, di probitaÁ , di sociabilitaÁ , dibeneficenza, di pace: la legge promulgata sul trono della coscienza,non eÁ dunque idea o potenza, ma interio senso, un senso indelebile,e la prima natura dell'uomo» 32. Vi ritroviamo un rifiuto deciso quin-di, giaÁ in apertura dello scritto, della teorizzazione hobbesiana sullostato perenne di guerra naturale e anche, risalendo nel tempo comesuggeriva Azuni stesso, di alcune proposizioni dei Discorsi di Machia-velli 33. PiuÁ evidente, invece, eÁ il richiamo alla tradizione aristotelicadell'uomo come animale sociale, applicata ai rapporti tra societaÁ e Sta-to e tra sovrano e governanti 34. Sin dalle prime pagine, quindi, le ri-flessioni di Azuni non appaiono caratterizzate da particolare novitaÁ,come in generale eÁ stato notato per l'intera sua opera filosofica 35, eneppure sembra del tutto inaspettato il richiamo ad un lavoro che egliancora riteneva anonimo, a quasi trent'anni dalla pubblicazione, cioeÁl'A.B.C., dialogue curieux (Ginevra 1769) di Voltaire 36.
In realtaÁ Voltaire non puoÁ certo essere considerato un punto diriferimento costante nell'opera politica e filosofica di Azuni. Egli di-
262
32 Dissertazione, ms. cit., c. 3r. Su questi temi in Azuni si vedano anche D. A. AZU-
NI, Elogio della pace, a cura di A. DELOGU, Regione autonoma della Sardegna, Cagliari1994; Discorso sui pericoli della libertaÁ di stampa, versione francese e italiana, a cura diA. CRISCI, Stamperia artistica, Sassari 1998; G. SPANU, Il problema della pace tra E. Kante D.A. Azuni, UniversitaÁ di Sassari, Sassari 2002.
33 Per alcuni caratteri dell'opposizione settecentesca alle idee di Machiavelli, conriferimento specifico all'opera di Voltaire, cfr. DIAZ, Dal movimento dei lumi, cit., pp.358-361.
34 Cfr. pure L. SOZZI, Il Principe e il Filosofo. Il dibattito sull'« homme de lettres »dall'EncyclopeÂdie alla Rivoluzione in ID. (a cura di), Il Principe e il Filosofo. Intellettualie potere in Francia dai « philosophes » all'« affaire » Dreyfus, Guida, Napoli 1988, pp. 45-98.
35 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 232-234.36 Cfr. E. TORTAROLO (a cura di), L'Illuminismo francese alla Fondazione Feltrinelli,
Sellerio, Palermo 1989, p. 304.
mostrava sõÁ di conoscere il tomo delle Oeuvres compleÁtes specifica-mente dedicato a Politique et legislation 37, e quindi pure il discorsoDe la paix perpetuelle ivi contenuto; ma appare chiaro come gli sfug-gisse l'evoluzione intera del pensiero di Voltaire, maturata attraversola voce Guerre contenuta nel Dictionnaire philosophique 38. LõÁ, infatti,rispetto all'originaria formulazione contenuta nell'A.B.C. ± citato daAzuni ± era stata sostituita nel 1771 una teoria della pace assai piuÁvicina ai postulati hobbesiani e fondata sulla constatazione realisticache, benche dotati di ragione, gli uomini non riescono ad affrancarsidalla condizione naturale degli animali, che eÁ quella di essere « per-petuamente in guerra » 39.
Il riferimento all'opera di Voltaire, fin dalle prime pagine dellaDissertazione, pare giaÁ una conferma del giudizio dei biografi moderni,alquanto severo, sull'importanza del pensiero di Azuni e delle sue fon-ti, specie se si accoglie l'ipotesi che la meditazione politico-filosofica diAzuni fosse in non poca misura tributaria di una formazione scolasticae in particolare dell'insegnamento universitario di RegonoÁ , autore dellaLibertatis humanae theoria 40. Del resto, un indizio della consapevolez-za che lo stesso Azuni mostrava nel ricollegarsi ad una piuÁ antica tra-dizione filosofica pare emergere dall'evidente sproporzione, dal puntodi vista quantitativo, tra la mole del breve capitolo primo, La Pace eÁ lostato naturale dell'uomo, e quella assai piuÁ ampia del capitolo secondo,La Guerra eÁ contraria ai dettami della natura. Quasi ritenesse non ne-cessario, nelle venti pagine del primo capitolo, soffermarsi in modo ec-cessivamente diffuso su concezioni che riteneva giaÁ acquisite.
Trattando infatti della pace come stato naturale dell'uomo, Azunirichiamava consolidate teorie sulla socialitaÁ dell'individuo, ricollegan-dosi alla piuÁ genuina tradizione giusnaturalistica e al De iure naturae
263
37 VOLTAIRE, Oeuvres compleÁtes, XXIX (Politique et leÂgislation), Tourneisen, Basle1786.
38 VOLTAIRE, Dizionario filosofico, tr. it., a cura di R. NAVES, I, Rizzoli, Milano 1979,pp. 260-264 e II, pp. 579-581.
39 VOLTAIRE, Dizionario filosofico, II, cit., p. 579.40 In questo senso, peroÁ con notevoli riserve circa l'effettiva incidenza di quel ma-
gistero, BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 40. Giuseppe RegonoÁ , gesuita ve-neziano, era docente di logica e metafisica all'universitaÁ di Sassari.
et gentium di Pufendorf 41. Prevedibili, considerate le premesse, leampie riserve sul contrattualismo rousseauiano, nel quale Azuninon mostrava di cogliere l'idea del carattere artificiale, e quindi po-litico, della vita sociale e della societaÁ 42, anche quando si voleva ri-mediare al conflitto degli interessi con la ragione. Tutt'al piuÁ potevaconcordare invece con il ginevrino nella condanna dell'opinione hob-besiana sulla natura malvagia dell'uomo 43.
Pur dimostrandosi sostanzialmente avverso all'individualismodegli illuministi, che considerava in modo negativo perche causa didisgregazione sociale, Azuni fondava parte notevole della propria ri-costruzione sul concetto di ragione, intendendola come una forza na-turale equivalente all'istinto 44 e riconoscendo che il vantaggio del-l'uomo sugli animali risultava costituito dal « soccorso dei lumi ». Ri-teneva quindi che l'essere umano non puoÁ « fare alcun progresso diqualunque sorta senza il concorso de' suoi simili. Concorso, che sup-pone la societaÁ : societaÁ , che esige indispensabilmente un certo ordi-ne: ordine che non puoÁ sussistere senza leggi: leggi, che non possonomantenersi se non da un governo, il quale concentri nella sua essenzale idee relative d'autoritaÁ e di subordinazione » 45.
Se per Rousseau le leggi civili, sostanzialmente estranee alla fasedella societaÁ naturale, apparivano conseguenza diretta dal patto so-ciale 46, per Azuni ± al contrario ± la costituzione della societaÁ civileorganizzata dipendeva da un sistema di leggi naturali derivato da unasola legge universale sulla concordia e sulla socialitaÁ degli uomini 47.In sintesi, dunque, lo studioso sardo dimostrava una maggiore vici-nanza alle posizioni moderate dei riformatori italiani di vent'anni pri-ma, rivelando un atteggiamento ancora retrospettivo e legato alla sua
264
41 Cfr. S. PUFENDORF, PrincõÁpi di diritto naturale, tr. it., a cura di N. BOBBIO, Paravia,Torino 1943, pp. 62-84 (De statu hominum naturali).
42 J.J. ROUSSEAU, Opere, tr. it., a cura di P. ROSSI, Sansoni, Firenze 1972, pp. XXVIe 294-295.
43 ROUSSEAU, Opere, cit., pp. 280-281.44 Dissertazione, ms. cit., c. 3r. e c. 6r.45 Dissertazione, ms. cit., c. 7r.-v.46 ROUSSEAU, Du contrat social, VI, in ID., Opere, cit., pp. 294-295.47 Dissertazione, ms. cit., c. 8r.-v.
formazione giovanile non estranea alla cultura dell'assolutismo 48. Laconferma di queste posizioni eÁ data da un rapido confronto tra lateorizzazione di Azuni e il modello di Grozio che, considerati gli in-teressi giuridici dello studioso sardo, doveva certamente essere statotenuto presente. E infatti pur ammettendo, con Grozio, l'esistenza diuna originaria societaÁ prestatuale legata alla condizione naturale del-l'uomo, Azuni negava che l'evoluzione da societaÁ naturale a societaÁcivile fosse determinata da un contratto sociale, ritenendola in ognicaso necessitata dalla forza della natura 49.
Posti quindi i riferimenti essenziali atti a dimostrare che La Pace eÁlo stato naturale dell'Uomo, Azuni si proponeva di chiarire nel secon-do capitolo che La guerra eÁcontraria ai dettami della natura 50. Si trat-ta anzitutto di una singolare professione di realismo, in cui lo studio-so sardo doveva riconoscere ± ancora una volta sulla scorta di Grozio± che « la guerra si ritrova collegata alla politica costituzione delle na-zioni » 51. Concepiva il diritto di guerra come un diritto naturale alladifesa in conseguenza dell'istinto naturale di conservazione, ricolle-gando tali formulazioni al concetto di vendetta pubblica e privata 52.Entro questi limiti la guerra appariva quindi giusta e indicava qualemezzo per la risoluzione delle controversie internazionali il ricorsoa « Tribunali o Magistrati a tal riguardo stabiliti » 53, lamentando l'as-senza di una suprema autoritaÁ soprannazionale competente a « sedarecon imparziale giudizio le cause d'una guerra intimata », pur se « untale meraviglioso progetto in vano uscõÁ dalla penna di piuÁ filosofi » 54.
265
48 Si confrontino le posizioni degli anticontrattualisti ora sintetizzate da FERRONE, Iprofeti dell'Illuminismo, cit., pp. 301-331, nonche S. ROTA GHIBAUDI, La fortuna di Rous-seau in Italia (1750-1815), Giappichelli, Torino 1961.
49 Dissertazione, ms. cit., cc. 9r.-10v. Per Grozio si veda A. CAVANNA, Storia del di-ritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico, GiuffreÁ , Milano 1979, pp. 326-327 e F. RUSSO, Alle origini della SocietaÁ delle nazioni. Pacificazione e arbitrato nella cul-tura europea del Seicento, Studium, Roma 2000, pp. 199-254, che rinvia all'amplissimabiografia su Grozio e sull'arbitrato internazionale.
50 Dissertazione, ms. cit., c. 12r.51 Dissertazione, ms. cit., c. 12v.52 Dissertazione, ms. cit., cc. 13r.-v.53 Dissertazione, ms. cit., c. 13v.54 Dissertazione, ms. cit., c. 14r.
Il diritto alla difesa, al quale di conseguenza collegava il potere di of-fesa, non era per Azuni destinato a garantire le libertaÁ dei cives, quan-to piuttosto a proteggere il diritto di proprietaÁ e la pubblica sicurez-za. Ancora una volta, cosõÁ, lo studioso sardo dimostrava di allinearsicon le posizioni politico-filosofiche dei riformatori italiani dei decen-ni precedenti 55. In particolare si dimostrava assai poco fiducioso, sulpiano dei rapporti internazionali, in merito all'opportunitaÁ di accordie di alleanze tra Stati in occasione di una guerra, ritenendo naturale lavittoria del singolo paese quando si fosse impegnato in una guerragiusta, e indicava quali esempi la Francia della guerra dei Trent'annie la monarchia asburgica nella guerra di successione austriaca. Tutta-via, pur avendo definito i caratteri di una guerra giusta e necessaria,Azuni negava autoritaÁ alla ragion di Stato intesa quale trasposizionesul piano politico dell'istinto di conservazione, ritenendo che si trat-tasse di un concetto vago e facilmente abusato per la dissimulazionedi « eccessi, di scelleratezze e di orrori » 56.
Le guerre, proseguiva Azuni, erano determinate essenzialmenteda un'errata interpretazione del diritto di difesa: « siccome la primadelle leggi di natura obbliga ciascuno di vegliare alla propria conser-vazione, accaderaÁ talvolta che gli orrori d'una guerra possano venirgiustificati dalla necessitaÁ sola di prevenire degli attacchi, per difen-dersi dai quali non v'era altro mezzo che la guerra » 57. La guerra, inconclusione, si rivelava contraria ai dettami della Natura perche vio-latrice della Pace, stato naturale dell'uomo, e perche causa di rovinaeconomica, di lutti e di indebolimento delle nazioni.
Proseguendo, Azuni si soffermava anche su una critica decisa allateoria dell'equilibrio di potenza (balance of power o, come lui stessoscriveva, bilancia dell'Europa). Ritornava cosõÁ implicitamente alla con-danna della teorizzazione hobbesiana sullo stato di guerra permanenteanche se affermava l'inutilitaÁ del cosiddetto « equilibrio del terrore » 58,
266
55 Dissertazione, ms. cit., cc. 14r.-v. Si ricordi quanta parte aveva la teorizzazionedel diritto di proprietaÁ nel pensiero dei riformatori, non soltanto italiani, del secondoSettecento.
56 Cfr. infatti Dissertazione, ms. cit., c. 2r. e c. 16v.57 Dissertazione, ms. cit., c. 9r.58 Dissertazione, ms. cit., c. 17r.
che per Hobbes non era altro che la riproduzione sul piano dei rapportisoprannazionali dello stato naturale di guerra permanente 59. Azuni ri-teneva piuttosto che un tale equilibrio, per le stesse premesse da cui na-sceva, « eÁ cosõÁ poco adattato a prevenire le guerre tralle Potenze d'Eu-ropa, che anzi par che serva di pretesto e d'occasione per accenderle, efarle sempre piuÁ rinascere appena estinte » 60.
In realtaÁ Azuni, pur preoccupandosi di giustificare come giusta enecessaria una guerra di difesa, eludeva sostanzialmente il problemadi fondo, cioeÁ quello di spiegare esattamente le ragioni di una guerrache non fosse di difesa quando, come nella premessa, aveva teorizza-to che la pace universale eÁ lo stato naturale dell'uomo. Questa con-traddizione rimaneva praticamente irrisolta, ne Azuni riusciva a su-perarla quando scriveva che « il diritto peroÁ competente alle nazioniper la loro naturale sicurezza e difesa eÁ talvolta inseparabile dalla ne-cessitaÁ d'assalire. Qualunque nazione, che voglia opprimere un'altradisponendosi ad invadere le altrui proprietaÁ , e ad ingrandir se stessacon pregiudizio d'un'altra, dev'essere rimirata come nemica » 61. An-cora una volta doveva avere presente Voltaire, che aveva criticato l'i-dea di Montesquieu secondo cui il diritto di difesa avrebbe autoriz-zato un popolo ad una guerra anche se le circostanze di una pace lun-ga avessero posto un altro popolo nella condizione meramentepotenziale di costituire una minaccia. Voltaire avvertiva che si potevaparlare di esercizio del diritto di difesa, con conseguente necessitaÁ dioffendere, soltanto quando si era certi dei preparativi dell'avversarioper un attacco. Quindi, aveva ribadito rivolgendosi idealmente aMontesquieu, « in questo caso saraÁ lui a cominciare la guerra, nonvoi; la vostra supposizione eÁ falsa e contraddittoria » 62.
Il manoscritto triestino sullo « stato naturale dell'uomo » si con-clude quindi con un'altra invocazione alla pace rivolta ai popoli della
267
59 Cfr. N. BOBBIO, L'equilibrio del terrore, « Storia e politica », XXIII (1984), pp.284-300 e ID., Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 1989. Per il progetto kantiano della pa-ce perpetua e per i riferimenti in esso all'opera di Hobbes cfr. I. KANT, Per la pace per-petua, a cura di N. BOBBIO, Editori Riuniti, Roma 1985.
60 Dissertazione, ms. cit., c. 17r.61 Dissertazione, ms. cit., c. 13v.62 VOLTAIRE, Dizionario filosofico, II, cit., p. 580.
terra e ai governanti; destinato alla stampa, come si eÁ accennato, nonfu pubblicato probabilmente a causa degli avvenimenti politici delmarzo 1797 che, con l'occupazione francese, rallentarono anche aTrieste molte iniziative editoriali: al termine dell'occupazione, un me-se piuÁ tardi, Azuni aveva lasciato Trieste per stabilirsi in Francia 63.
L'argomento affrontato da Azuni, allora di notevole attualitaÁ edegno di ulteriori approfondimenti, non sarebbe rimasto estraneo al-la sua attivitaÁ culturale e politica degli anni successivi. Lo riprese do-po il 1805 con il Discours sur la possibiliteÂd'eÂtablir une Paix maritimeuniverselle et perpeÂtuelle; un lavoro ± secondo le sue intenzioni ± dinotevole impegno e composto di una Introduction, e dei capitoli 1.La paix est le seul eÂtat naturel de l'homme, 2. De la neÂcessite moralede la sociabiliteÂparmi les hommes, 3. De la neÂcessiteÂphysique de l'eÂtatsociale parmi les hommes, 4. De l'origine de la guerre, seguiti, alla fine,da un progetto di pace marittima universale e perpetua. A parte lapremessa, l'opera non venne realizzata, tanto che l'argomento rimaseprivo di uno sviluppo che, ove elaborato, avrebbe arricchito la cono-scenza della biografia intellettuale di Azuni 64.
L'esame del sommario redatto nel 1805 conforta sull'opinione,giaÁ espressa da altri 65, che quel lavoro non sarebbe stato altro che,per larga parte, una rielaborazione del manoscritto triestino, nel qua-le sono accennati e giaÁ sinteticamente delineati quasi tutti gli argo-menti principali. La novitaÁ si sarebbe quindi limitata al progetto dipace universale.
Quando Azuni portoÁ a termine, nel 1797 a Trieste, la Dissertazio-ne sullo stato naturale dell'uomo, Kant aveva giaÁ pubblicato il notoopuscolo Zum ewigen Frieden (Per la pace perpetua, 1795); il filosofotedesco, a propria volta, era stato preceduto da una serie alquantonumerosa di pensatori che, dall'inizio del Settecento e con diverseprospettive di ricerca, si erano interessati all'argomento.
GiaÁ una semplice elencazione dei maggiori studiosi del problemavale a inquadrare la risonanza del tema: l'abate di Saint-Pierre con la
268
63 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 164-165.64 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 232-233.65 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 232 nota 72.
MeÂmoire pour rendre la paix perpeÂtuelle en Europe (Utrecht 1713);Leibniz, con le sue osservazioni sugli scritti di Saint-Pierre (1714);Rousseau, con l'Extrait du projet de paix perpeÂtuelle de M. l'abbeÂde Saint-Pierre (1761) e con il successivo Jugement sur la paix perpe-tuelle; Bentham, con un piano di pace universale e perpetua del1789 66. Lo stesso Voltaire, alla cui opera Azuni faceva generico rife-rimento, aveva trattato ampiamente De la paix perpetuelle 67. Dopo il1797, quindi, Azuni non era ne uno dei primi ne uno dei piuÁ originalistudiosi europei dell'argomento 68.
Per comprendere le posizioni dello studioso sardo sul tema dellapace universale bisogna quindi fare necessariamente riferimento allaDissertazione triestina; e ad essa dobbiamo dunque tornare alla lucedell'opinione di Del Vecchio, secondo il quale con Rousseau il dibat-tito culturale sul problema della pace venne spostato dal piano empi-rico-politico a quello giuridico razionale 69. La lettura del manoscrittoci mostra, a tale proposito, come Azuni rimase sempre legato alla tra-dizione filosofico-politica degli utopisti della metaÁ del XVIII secolo enon volle spostare l'analisi verso il terreno giuridico-internazionalistico.Il che, se da un lato puoÁ sorprendere considerata la formazione pret-tamente giuridica dello studioso sardo, sembra confermare d'altra par-te i giudizi severi sulla relativa originalitaÁ del suo pensiero politico 70.
Voltaire, studiando il progetto di pace perpetua dell'abate diSaint-Pierre, aveva criticato Rousseau colpevole di aver affrontato
269
66 Tutti questi testi sono brevemente ricordati, con rimandi bibliografici, da C.CURCIO, Progetti per la pace perpetua, Colombo, Milano 1946, pp. 3-20. Ampi brani sonoora raccolti in ARCHIBUGI, VOLTAGGIO, Filosofi per la pace, cit.
67 VOLTAIRE, De la paix perpetuelle. Par le docteur Goodheart, traduction de M.Chambon, in ID., Oeuvres compleÁtes, XXIX, cit., pp. 35-72.
68 Fu forse questo uno dei motivi che lo indussero a non pubblicare piuÁ quel testoin Francia. Per BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 234, Azuni forse non si sen-tiva « del tutto padrone della materia » o non si riteneva « soddisfatto dei risultati rag-giunti », mentre « il ricorso alla meditazione speculativa poneva in evidenza ± per l'essen-zialitaÁ della conclusione cui non poteva condurlo il discorso tecnico-giuridico ± la con-traddizione insanabile che derivava da certi presupposti ideologici ».
69 G. DEL VECCHIO, Il fenomeno della guerra e l'idea della pace, Bocca, Torino 1911.70 Sulla dimensione utopica dell'Illluminismo si veda B. BACZKO, L'utopia. Immagi-
nazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'etaÁ dell'illuminismo, tr. it., Einaudi, To-rino 1979, pp. 181-187.
il problema della pace limitandolo soltanto all'Europa e non a tuttal'umanitaÁ ; Azuni, che aveva apprezzato l'elaborazione voltairiana, ri-proponeva il tema dello stato dell'uomo in una prospettiva universa-lista, giungendo poi a ipotizzare une paix marittime universelle et per-peÂtuelle: ritornava ad una concezione generale, proiettata sul futurodell'umanitaÁ per svolgerla attraverso il filo di una disciplina partico-lare, come poteva essere il diritto marittimo.
Che del resto Azuni avesse ripreso alcune tematiche di Saint-Pierre, mutuandovi pure qualcosa da Voltaire, non appare dubbio.Con Saint-Pierre Azuni concordava nel ritenere che all'origine dellaguerra vi fossero l'insoddisfazione e l'ambizione umana, giudicandointeresse dei sovrani rinunciare alla guerra come strumento di solu-zione delle controversie internazionali. EÁ ben vero che lo studiososardo non accoglieva i termini del progetto per una pace che Saint-Pierre identificava in una societaÁ permanente legata all'alleanza trai sovrani; si rivelava qui la sua tendenza all'individualismo nella poli-tica internazionale, che lo aveva portato ad esaltare il singolo Statoattore di una guerra giusta e vincitore contro l'alleanza nemica 71. EÁ
anche vero, d'altra parte, che nell'opera di Azuni si ritrova, in ultimaanalisi, una generica fiducia sull'efficacia delle convenzioni e delleleggi internazionali, quando tratte dal diritto naturale, in armonia so-stanziale con i suoi interessi prevalenti giuridico-internazionalistici;cioÁ lo portava a riconoscere l'utilitaÁ di autoritaÁ supreme, riconosciutedagli Stati e garantite dalla loro volontaÁ , che fossero poste a dirimereconflitti di interessi, come giaÁ Saint-Pierre aveva proposto 72.
Quanto di positivo Azuni trasse da Saint-Pierre fu dunque fon-damentalmente suggerito dall'opera di Voltaire che, pur giudicandoseveramente quel progetto, ne aveva riconosciuto l'utilitaÁ 73. Interes-sa qui peroÁ notare come Azuni, mantenendosi su queste posizioni an-cora negli anni del triennio repubblicano, quando ormai era venutaaffermandosi un'impostazione egualitaria e antidispotica, riconfer-mava il suo impegno non di illuminista ma di moderato, riformista
270
71 Dissertazione, ms. cit., c. 15r-16r.72 Dissertazione, ms. cit., c. 14r.73 VOLTAIRE, De la paix perpetuelle, cit., p. 34 nota 1.
e girondino 74. Il che costituõÁ in un certo senso la sua fortuna perche ,pur non consentendogli di raggiungere alti livelli di originalitaÁ , servõÁ
ad un buon accoglimento della sua opera prima e dopo la virulenzagiacobina, garantendogli infine uno spazio nella costruzione dell'im-pero napoleonico 75.
Nel marzo 1797, quando Azuni ancora risiedeva a Trieste, ancheil porto franco adriatico fu occupato dalle truppe francesi, il gover-natore austriaco si rifugioÁ a Lubiana e, mutate le condizioni politiche,nuovi problemi si imposero all'attenzione degli amministratori. Traquesti ci fu un contenzioso, maturato nel mese di aprile, che vide op-posto il Magistrato civico ± organo comunale e allora rappresentantedegli interessi della cittadinanza ± alle forze di occupazione, in meritoalla sorte delle prede di guerra nel golfo. Con editto del 17 germinale(6 aprile) il capitano di fregata Sibille, comandante della divisione delmare Adriatico (conosciuto da Azuni, perche il suo editore aveva de-dicato proprio a Sibille la seconda edizione dello studio sulla bussolanautica 76) deferõÁ la « giudicatura delle prede » 77 al Tribunale Mer-cantile, organo della precedente amministrazione rimasto in attivitaÁ .Invitando lo stesso Magistrato a indicare un proprio patrocinatore,Sibille designoÁ quello giaÁ scelto dall'occupatore: « un uomo di talen-to, autore di varie opere sopra le leggi marittime dell'Europa, le quali
271
74 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., pp. 142-143.75 BERLINGUER, Sui progetti di codice, cit., passim.76 AZUNI, Dissertazione sull'origine della bussola nautica, cit., pp. V-VIII.77 «Gazzetta di Trieste », n. 29, 10 aprile 1797, p. 437, che riporta una lettera di
Sibille all'indirizzo del generale di divisione Dagua, comandante a Trieste. Si vedanoinoltre i documenti conservati in ADTs, Carte sparse sec. XVIII / Contribuzioni belli-che, non numerate: lettera di A. Vimal, ufficiale della marina francese datata Trieste 17germinale anno V (8 aprile 1797) con la richiesta della nomina a difensore del Magistra-to civico; lettera del Magistrato civico a Vimal datata 8 aprile 1797 con la comunicazionedella nomina di Domenico Pancera «membro di questo Magistrato »; lettera di Sibille alMagistrato civico del 21 germinale anno V (22 aprile 1797) riguardante il sequestro diuna nave, giaÁ noleggiata da un privato, presso Trieste. Da aggiungere altri documenticonservati a Parigi presso gli Archivi nazionali e segnalati da BERLINGUER, Domenico Al-berto Azuni, cit., p. 160, nota 139, e cioeÁ due lettere ad Azuni di Sibille datate Trieste 14e 17 germinale anno V (3 e 6 aprile 1797) e una di Vimal, datata Trieste 19 germinaleanno V (8 aprile 1797) in cui lo si prega di essere difensore della marina francese. Pocoprima Azuni aveva rifiutato l'incarico di arbitro nello stesso contenzioso.
onorano il di lui nome », cioeÁ Azuni. Questa fu probabilmente l'uni-ca occasione che lo studioso sardo ebbe di esercitare a Trieste l'atti-vitaÁ di giurista 78. Benche l'incartamento processuale sia andato per-duto, come pure risulta irreperibile la decisione o soltanto il disposi-tivo, notizie indirette rivelano che l'esito fu in favore della partefrancese di cui si riconobbe l'operato legittimo 79. Soltanto con ri-guardo ad un motivo specifico si diede ragione al ricorrente, ma« lo stesso Azuni difensore del Corsaro francese riconobbe per iscrit-to giusta la sucitata sentenza e dichiarato di non volersene appella-re » 80. Vana rinuncia, perche il 29 aprile 1797 Napoleone stesso,giunto a Trieste e in forza dei poteri attribuitigli, annulloÁ quella partedel dispositivo 81.
A Trieste, nei mesi intensi dell'occupazione, Azuni maturoÁ la de-cisione fondamentale per gli anni successivi, ancor piuÁ significativi eimportanti, della sua vita e della sua attivitaÁ scientifica 82: nel maggio1797 rientravano gli austriaci a Trieste e Azuni abbandonava l'Italiaper stabilirsi a Parigi, all'ombra del nascente astro napoleonico.
272
78 Secondo BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 160, che riprende un'in-dicazione di G. MANNO, Biografia degli italiani illustri, I, Venezia 1834, pp. 26-33, Azuniavrebbe soggiornato a Trieste « esercitandovi l'avvocazione...in cause marittime ». Nonsembra che si tratti di notizia da accogliere, perche l'esame dei repertori del TribunaleCommerciale e Marittimo di Trieste per il periodo considerato non ha rivelato il nome diAzuni. Il che non esclude, naturalmente, che avesse potuto svolgere un'attivitaÁ di con-sulente legale.
79 G. DE PERIBONI, Giornale della venuta dei francesi (1797), ms. in ADTs, segn. 7 G11/12, c. 34r.
80 DE PERIBONI, Giornale, ms. cit., c. 34v.81 Per il soggiorno di Napoleone nei giorni 29 e 30 aprile 1797 cfr. O. DE INCON-
TRERA, Napoleone a Trieste, « La Porta Orientale », II n.s. (1966), pp. 31-41 e il prece-dente, meno accurato, C. DE ANTONIO, L'occupazione francese e la visita di Bonapartea Trieste nel 1797, « Rassegna Storica del Risorgimento », IX (1922), pp. 307-314.
82 BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni, cit., p. 164.
X. - L'EREDITAÁ DEL SETTECENTO NELLA BORGHESIACOSMOPOLITA: F.E.J. BARAUX, LA MASSONERIAE IL COMMERCIO
L'immagine tradizionale dell'emporio triestino tra Settecento eOttocento eÁ quindi, come si eÁ visto, quella di una cittaÁ marittimadi estesi traffici commerciali, dall'intensa vita economica, dove effi-mere ricchezze si creavano e si dissolvevano in pochi anni, mentre al-tre grandi fortune si consolidavano. Palazzi e dimore signorili che an-cora dominano la cittaÁ rappresentano la memoria di quella stagioneche fu detta giustamente del « cosmopolitismo », per il verificarsi diquelle condizioni, uniche e affascinanti, in cui il concorso di popolidiversi, attirati dalle prospettive economico-sociali e dalla politica il-luminata del governo asburgico, si confusero creando attraverso lerispettive esperienze una cittaÁ nuova.
Abbiamo visto anche che la storiografia triestina del Novecentoha mantenuto a lungo l'opinione che la cittaÁ moderna fosse rimastasostanzialmente poco sensibile a qualsiasi manifestazione della cul-tura, limitandosi per lo piuÁ a curare aspetti esteriori come ad esem-pio la costruzione e la frequentazione del teatro. Si sarebbe trattato,insomma, della sconfitta dei princõÁpi « idealistici » di fronte agli in-teressi meramente materiali 1. La presenza delle nazioni avrebbeportato a Trieste usi e costumi ma non correnti di idee e di pensie-
273
1 TAMARO, Storia di Trieste, II, cit., p. 184.
ro 2, mitizzando e consolidando il cliche storiografico di « commer-cianti di varia nazionalitaÁ intenti esclusivamente ai loro affari » 3.
Il gran numero delle ricerche condotte negli ultimi vent'anni, dicui si eÁ dato conto nel primo capitolo, ha dato maggiore respiro allecaute affermazioni di chi scriveva che, tutto sommato, il commer-ciante « raggiunta una certa agiatezza non disdegna nemmeno di sol-levare il capo dal libro dei conti per accostarsi anche un po' alla cul-tura » 4, anche se identificata in « forme raffinate di edonismo » 5. EÁ
emersa la consapevolezza che il germe di questa nuova cultura co-smopolita venne in qualche modo portato dal nuovo ceto mercantilee non venne da questi semplicemente prodotto nella nuova patria 6.Constatata quindi la prospettiva troppo sommaria del secondo dopo-guerra e messo in discussione il suo fondamento, si eÁ tornati alla ri-cerca d'archivio e si eÁ potuto inquadrare piuÁ correttamente il feno-meno del cosmopolitismo triestino attribuendone l'origine non soload un determinato ceto sociale ± quello mercantile o borghese ±ma anche ad una precisa generazione di commercianti, che non fuquella dei nativi (quindi degli appartenenti alla seconda o terza gene-razione di immigrati) ma quella di coloro che per primi si stabilirononel porto franco 7.
274
2 CUSIN, Appunti alla storia di Trieste, cit., p. 242.3 STELLA, Trento, Bressanone, Trieste, cit., p. 155. La necessitaÁ di verificare peroÁ
queste rappresentazioni era stata giaÁ segnalata da E. APIH, Nota storica in S. SPADARO
(a cura di), Le istituzioni culturali a Trieste. Un'indagine sui problemi e sulle prospettive,Provincia di Trieste, Trieste 1980, pp. 17-29.
4 NEGRELLI, Comune e Impero, cit., p. 73.5 G. NEGRELLI, Introduzione a ID. (a cura di), La Favilla (1836-1846). Pagine scelte
della rivista, Del Bianco, Udine 1985, p. 17. In realtaÁ non si tratta di un'affermazioneoriginale in quanto lo stesso concetto era stato giaÁ sottolineato da APIH, La societaÁ trie-stina, cit., p. 75 e poi in ID., La societaÁ triestina tra il 1815 e il 1848, in TABACCO (a curadi), Italia del Risorgimento, cit., p. 28. La medesima impostazione peraltro ritorna pedis-sequamente, con riferimento alla vita teatrale e musicale, in M. PETRONIO, Spunti di vitamusicale a Trieste tra la fine del '700 e l'inizio dell'800, « Archeografo Triestino », s. IV,XL (1980), pp. 117-119.
6 CERVANI, Intorno al cosmopolitismo triestino, cit., pp. 144-146; ID., La borghesiatriestina nell'etaÁ del Risorgimento, Del Bianco, Udine 1969, pp. 40-43; NEGRELLI, Intro-duzione a ID. (a cura di), La Favilla, cit., p. 17.
7 EÁ appena il caso di avvertire che, come noto, il termine « borghesia » assume si-gnificati diversi a seconda del contesto storico e storiografico in cui viene utilizzato; per
Questo eÁ il primo risultato cui hanno portato gli studi negli ulti-mi anni rimettendo parzialmente in discussione la rappresentativitaÁdi campioni del cosmopolitismo triestino di metaÁ Ottocento comeGiovanni Guglielmo Sartorio e Pasquale Revoltella, o di iniziativeculturali come quella « favillatrice » del 1836, che rappresentanopiuÁ il traguardo del ciclo settecentesco che non l'alba della culturarisorgimentale 8.
Su questi temi vale la pena di sviluppare qualche riflessione: Sar-torio e Revoltella, esponenti tipici del contesto « borghese » dell'Ot-tocento triestino, furono uomini legati piuÁ all'ideale romantico chenon alla cultura del cosmopolitismo 9. Il primo era un triestino, natonel porto franco da un commerciante giaÁ immigrato; Revoltella eranato sõÁ a Venezia nel 1799, ma era giunto a Trieste da bambino, sen-za portarvi quindi ne imprenditorialitaÁ ne idee ma formandosi in unacittaÁ che aveva i destini economici e culturali giaÁ segnati. Gli anima-tori del giornale « La Favilla », che possono certo essere consideratitra i primi uomini di lettere in senso professionale (giornalisti e scrit-tori), erano certamente immigrati, per lo piuÁ di provenienza veneta,
275
il significato che viene attribuito nelle nostre pagine si veda supra, cap. II, pp. 81-82. Perun profilo sociale dei nuovi triestini si veda anche C. GATTI, Uomini e politiche nellaTrieste del Settecento, in FINZI, PANJEK (a cura di), Storia economica e sociale di Trieste,I, cit., pp. 359-380 e ID., Numeri, forse uomini. Riflessioni quantitative sulla Trieste dimetaÁ Settecento, in ANDREOZZI, C. GATTI (a cura di), Trieste e l'Adriatico, cit., in parti-colare pp. 48-65, nonche i cenni in R. FINZI, F. TASSINARI, Le piramidi di Trieste. Triestinie triestine dal 1918 a oggi. Un profilo demografico, in FINZI, MAGRIS, MICCOLI (a cura di),Storia d'Italia. Le regioni dall'UnitaÁ a oggi. Il Friuli-Venezia Giulia, I, cit., pp. 289-294.
8 Si vedano, oltre agli studi giaÁ ricordati, anche G. CERVANI, Il voyage en Egypte diPasquale Revoltella (1861-1862), ALUT, Trieste 1962 e ID., Revoltella Pasquale, in Oe-sterreichisches Biographisches Lexikon, VIII (1985), pp. 102-103) nonche ID., Stato e so-cietaÁa Trieste nel secolo XIX. Problemi e documenti, Del Bianco, Udine 1983. Si veda poiG. NEGRELLI, Trieste: dal piccolo mondo patrizio alla cittaÁ borghese, in Enciclopedia mo-nografica del Friuli-Venezia Giulia, III/1, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-VeneziaGiulia, Udine 1978, p. 273; G.G. SARTORIO, Memorie, a cura di G. STUPARICH, Edizionidello Zibaldone, Trieste 1949. Il percorso interpretativo di Cervani oggi eÁ peraltro cri-ticamente riconoscibile in ID., Momenti di storia e problemi di storiografia giuliana, DelBianco, Udine 1993, in particolare attraverso l'introduzione autobiografica alle pp. 5-26.
9 Si veda al riguardo il saggio di S. PARMEGIANI, Trieste neoclassica e cultura impren-ditoriale: Giovanni Guglielmo Sartorio, in CAPUTO (a cura di), Neoclassico, cit., pp. 308-311.
ma vennero chiamati a Trieste nel terzo decennio dell'Ottocento daquel ceto mercantile originario cui si deve la fondazione della cittaÁnuova 10.
Le ricerche e le fonti rivelano quindi una veritaÁ diversa da quellacara alla storiografia del Novecento che aveva bisogno di individuarenella metaÁ del XIX secolo i segnali di un « risorgimento » culturaleche coincidesse con il formarsi di una coscienza nazionale: non quin-di immigrati che avevano portato usi e costumi ma non correnti diidee e di pensiero, che si sarebbero formate quasi spontaneamenteal sorgere dell'Ottocento; ma immigrati che portarono in una cittaÁnuova dai paesi d'origine cultura e idee che si confrontarono e si fu-sero in una straordinaria sintesi di usi e di costumi. L'immagine ste-reotipata del commerciante intento esclusivamente ai propri danarositraffici, insensibile a manifestazioni culturali, musicali e artistiche diun certo impegno che comportassero una partecipazione attiva non eÁun'invenzione della storiografia recente; eÁ il retaggio, il condiziona-mento combattuto in varie forme e dettato da atteggiamenti psicolo-gici di antica origine, di testimonianze parziali provenienti da soggettiesclusi dal ceto mercantile, di devianti affermazioni o impressioni discrittori sette-ottocenteschi.
EÁ il risultato delle idee di un Lorenzo Miniussi, che ancora nel1801 riteneva che i commercianti fossero dediti al loro personale in-teresse e non avessero « il menomo gusto per la letteratura » (anchese poi fondarono con lui la SocietaÁ di Minerva) 11; delle impressionidi un Johann Gottlieb Seume, che nel 1802 accusava il ceto mercan-tile di solo vanto per il danaro e di disprezzo per l'arte 12; della gene-
276
10 Come si rileva da NEGRELLI, Introduzione a ID. (a cura di), La Favilla, cit., p. 18.Per una valutazione complessiva dell'apporto culturale dell'ambiente veneto alla Triestedel tempo cfr. F. SALIMBENI, Trieste tra Venezia e Vienna, « Archeografo Triestino », s.IV, XLIV (1984), pp. 47-52; B. MAIER, Letteratura giuliana, in Enciclopedia monograficadel Friuli-Venezia Giulia, cit., III/2, pp. 1160-1163.
11 CosõÁ scriveva Miniussi: « In una cittaÁ ove tutto il corpo degli abitanti consiste o inmercanti o in artigiani, e in conseguenza ove la maggior parte non pensa che all'interessee l'altra parte deve travagliare per procacciarsi il necessario alla vita, non eÁ possibile chesi trovi il menomo gusto per la letteratura », cfr. DE FRANCESCHI, L'Arcadia romano-son-ziaca, cit., p. 199.
12 « Le buone anime dei mercanti non si fanno problemi: ammazzatevi pure, sola-
rica affermazione di Pietro Kandler che, distinguendo tra commer-cianti ricchi e poveri, affermava che i piuÁ agiati « curavano qualchepoco le lettere, la musica » 13. Il contradditore peroÁ giaÁ esisteva edera Antonio de Giuliani, ormai slegato dai condizionamenti locali ein grado di inquadrare il fenomeno triestino in dimensione euro-pea 14, che avvertiva con penetrante semplicitaÁ intorno al 1803 che« eÁ ben vero che Trieste eÁ una cittaÁ semplicemente mercantile, manon per questo la cultura dello spirito si deve credere incompatibilecon la professione del negoziante » 15.
Se quindi aveva ragione almeno in parte Pietro Zaguri che nel1791 aveva scritto a Giacomo Casanova rammentandogli Trieste co-me « solita ad essere rifugio dei disgraziati » 16, eÁ altresõÁ vero che laprima generazione di commercianti giunse a Trieste intellettualmentegiaÁ formata e portando con se dai paesi d'origine non solo energia edambizione ma anche idee e cultura. Ed eÁ pure vero che nel portofranco non ci si dedicoÁ solo al profitto del capitale ma anche ad in-teressi culturali che videro i negozianti protagonisti e non semplicispettatori.
Occorre percioÁ insistere sull'opportunitaÁ di ricomporre la fram-mentarietaÁ solo apparente di un quadro che, nella realtaÁ , non soffreaffatto di scarsezza delle fonti documentarie, ma difetta principal-mente di approfondite ricerche archivistiche, di indagini che superi-no l'evidenza rassicurante dei testi a stampa, si tratti degli scritti me-morialistici o delle pionieristiche iniziative giornalistiche. Una traccia
277
mente pagateci in anticipo le nostre sardelle e i nostri panni turchi! [...] Anche i proprie-tari dei palchi [di teatro] pagano ogni volta l'ingresso: una forma particolare di vanto deldanaro! Il patriottismo potrebbe trovare un modo piuÁ civile di proteggere l'arte »; cfr.J.G. SEUME, L'Italia a piedi (1802), tr. it., a cura di A. ROMAGNOLI, Longanesi, Milano1973, p. 107.
13 KANDLER, Storia del Consiglio dei Patrizi, cit., p. 250.14 Ben lo rileva NEGRELLI, Introduzione a ID. (a cura di), La Favilla, cit., p. 18: « il
mondo intellettuale di un uomo che eÁ sõÁ triestino di nascita, ma viennese di elezione ecittadino d'Europa [...] per esperienze, influenze e vocazione spirituale ».
15 DE GIULIANI, Panorama politico della cittaÁ di Trieste in ID., Scritti inediti, cit., p.310.
16 G. ZAGONEL (a cura di), Lettere di Lorenzo Da Ponte a Giacomo Casanova, DeBastiani, Vittorio Veneto 1988, p. 144.
importante puoÁ essere ± in questa prospettiva ± quello dello studiodelle biblioteche private. GiaÁ nel secondo capitolo abbiamo segnala-to la possibilitaÁ di ricostruire un quadro della cultura settecentescaattraverso l'esame dei cataloghi di libri contenuti negli inventari stesipost mortem. Si tratta di uno strumento e di un metodo storiograficooggi ampiamente collaudati a livello europeo, che consentono di ca-pire molto ± con le dovute precauzioni e cautele suggerite dalla par-ticolaritaÁ della fonte ± non solo sulla personalitaÁ culturale del posses-sore di libri, ma anche sull'ambiente culturale, sul ruolo delle tipo-grafie e degli editori locali, sulla circolazione dei libri stranieri epersino sulle assenze, sulla mancata presenza di determinati testi ogeneri letterari.
Alcuni esempi possono essere di conforto. GiaÁ in precedenza ab-biamo accennato a Pasquale de Ricci e alla sua biblioteca. A lui pos-siamo aggiungere le figure di altri commercianti, come quella di Gio-vanni Enrico Frohn (Mannheim 1739-Trieste 1794), conoscitore dicinque lingue, che lascioÁ in morte una biblioteca contenente tra l'al-tro testi classici come le Metamorfosi di Ovidio, le opere di Goldoni,De l'esprit des lois di Montesquieu, le Riflessioni politiche di de Giu-liani, L'esame critico delle prove di religione, La luce del negozianteolandese, il Dizionario universale di commercio, il Trattato delle assi-curazioni marittime e il Regolamento giudiziario di Giuseppe II 17.
Giovanni BuÈhelin (Kempten 1765-Trieste 1800) lascioÁ una bi-blioteca contenente le opere di Machiavelli, quelle dell'Ariosto, ilDonquixote e Le parfaite intelligente du commerce 18.
Giuseppe Lazzaro Morpurgo (Gorizia 1759-Trieste 1836), unodei fondatori delle «Assicurazioni Generali », studioso di diritto, tra-dusse il Saggio sull'uomo di Pope, fu autore di un progetto di legisla-zione circa le assicurazioni e pubblicoÁ piuÁ tardi una Raccolta di osser-
278
17 Su Giovanni Enrico Frohn, come su altri protagonisti della vita commerciale cit-tadina, mancano studi particolari; notizie si trovano in DE INCONTRERA, Vita triestina, cit.,« La Porta Orientale », XXIX (1959), p. 341; TOMASIN, Codice epigrafico, cit., ms. inADTs, segn. 1/2 C 6, p. 258; ADTs, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 137/1794, carte non numerate.
18 Cfr. ASTs, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 138/1800, carte non nu-merate.
vazioni sulle assicurazioni 19. A loro potremmo aggiungere, per esten-dere l'esemplificazione, anche la figura del goriziano Giacomo Reyss(1735-1804), che non fu commerciante ma insegnante ex gesuita eche lascioÁ in morte una biblioteca di un migliaio di volumi oggi atten-tamente ricostruita 20.
Tra gli esponenti della borghesia cosmopolita del Litorale sette-centesco emerge un personaggio fino ad alcuni anni fa quasi scono-sciuto che per provenienza, per attivitaÁ e per condizione sociale puoÁben esemplificare il caso tipico di borghese immigrato nel porto fran-co nel XVIII secolo. Di formazione culturale settecentesca, attivo eintraprendente nel commercio, conoscitore dell'Europa e partecipeper breve periodo della vita pubblica triestina, fu studioso di storiadel commercio, di scienze naturali, di musica e di teatro.
FrancËois Emanuel Joseph Baraux nacque ad Anversa, cittaÁ ap-partenente ai Paesi Bassi austriaci e dai trascorsi splendori emporia-li 21, il 9 gennaio 1750 22. Non eÁ noto quali studi avesse compiuto ma
279
19 Su di lui STEFANI, Le Assicurazioni Generali, cit., pp. 37-42 e E. MASERATI, Mor-purgo Giuseppe Lazzaro in Oesterreichisches Biographisches Lexikon, VI (1975), p. 380,oltre al cenno bibliografico in F. SALIMBENI, Gli ebrei nel Litorale Austriaco-Venezia Giu-lia tra interdizione e emancipazione, in M. MORPURGO, Valdirose, memorie della comunitaÁebraica di Gorizia, Del Bianco, Udine 1986, p. 28. Altre figure attendono ancora di es-sere studiate. Fra queste il ben noto Francesco Taddeo Reyer (Malborghetto 1760-Trie-ste 1846) sul quale cfr. R. PAVANELLO, Reyer Franz Taddeus, in Oesterreichisches Biogra-phisches Lexikon, VIII (1985); U. COVA, Il ruolo decisivo della societaÁ di assicurazioni edel ceto mercantile di Trieste per la fondazione del Lloyd Austriaco, in 1836-1936. Il LloydTriestino dall'Adriatico al mondo, Trieste 1986, p. 34; A. KREKIC-M. MESSINA, I monu-menti funerari Reinelt e Reyer del cimitero cattolico di Sant'Anna a Trieste. Appuntiper una biografia familiare, « Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte », 21, 2005-2006,in corso di stampa. E il non ancora studiato Masino Levi (Ferrara 1795-Trieste 1879)su cui STEFANI, Le Assicurazioni Generali, cit., ad indicem e CERVANI, La borghesia,cit., p. 59.
20 E. DI GIUSTO, I gesuiti a Gorizia nel secondo Settecento: Giacomo Reyss professoree scienziato, tesi di laurea specialistica, UniversitaÁ degli studi di Udine, FacoltaÁ di Letteree filosofia, relatore Flavio Rurale, a.a. 2005-2006, in particolare pp. 143-242 in cui ripor-ta il catalogo della biblioteca commentato.
21 Per la storia di Anversa e le sue condizioni politiche ed economiche nel Settecentocfr. G. VAN CAUWENBERGH, Gids voor Oud Antwerpen, Standaard, Antwerpen 1982 e Fl.PRIMS, Het herfsttij van het corporativisme te Antwerpen, Standaard, Antwerpen 1945.
22 Antwerpen, StA, PR, Sint Jacob, nr. 59 (registro dei battesimi): « 1750, 12 Janua-ri Franciscus Emmanuel Josephus Baraux, f. Petrus Franciscus Baraux, Anna Francisca
ben presto si impegnoÁ nella professione di commerciante, comune adaltri membri della famiglia 23, che esercitoÁ nella cittaÁ natale fino al1780 24. In quell'anno, riconosciute in lui capacitaÁ e preparazione,fu chiamato a far parte del gruppo di negozianti guidato dal baroneCharles Proli di Anversa che, assieme all'inglese William Bolts, avevacostituito la Compagnia delle Indie austriaca in base a un privilegiodi Maria Teresa del 5 giugno 1775 25.
Come membro di quella Compagnia, che commerciava attraver-so Trieste dove era rappresentata dalla filiale Casa di commercio
280
De Amoris ». Il padre era qualificato come « primarius magister veredariorum» e morõÁad Anversa nel 1779; cfr. Antwerpen, StA, PR, nr. 300, Sint Jacob, Overlijdens 1779-1797, c. 13r.: « 10 Xbre 1779. Petrus Franciscus Baraux maritus Anna Francisca De Sa-moris et. 64 an. hora medio 4ta post meridiem et 12ma huius sepultus in ecclesia no-stra ». Un cenno sulla sua attivitaÁ professionale eÁ contenuto in Antwerpen, StA, SR1264, « Protochollum Scabinale de Anno 1778. Sub notario Jubiliario P. Gerardi »,vol. VIII, c. 200v.: « transportanten op den 22 8bris 1771 bij d'hr. Petrus FranciscusBaraux in der qualiteijt so hij compareerde voor huren schepenen deser Stad gegoeijtende geerft zijn ».
23 Cfr. Antwerpen, StA, SR 1288, 22 dicembre 1785, cc. 260r.-v., 261 r., atto ditransazione della «Veuve P. F. Baraux » Anna Francesca «Ne Desamoris », alla presen-za del figlio « Louis Baraux, officiale der heeren Staeten van Brabant ». L'altro fratello diFrancesco Emanuele Giuseppe, Michele Giuseppe, risultava abitante ad Anversa nel1781 « avec Sa MeÁre et famille » (Antwerpen, StA, SR 1276, cc. 348v.-349r., sub 11 mag-gio 1781 e cc. 357r.v. Nel 1785 era segnalato come « koopman alhier » (Antwerpen, StA,SR 1290, cc. 291v-292r, sub 19 settembre 1785).
24 Ne eÁ prova un documento riguardante la sua attivitaÁ conservato in Antwerpen,StA, SR 1271, cc. 156r.-157r., sub 19 luglio 1780, dove fra l'altro si scrive che «NousBourguemaõÃtres, Echevins et Conseil de la Ville d'Anvers, s'avoir faisons et certificËonsaÁ tous les hommes que le vingtieÁme jour du mois de juillet mil sept cent quatre vingtest personellement venu et a comparu devant Nous FrancËois Emanuel Joseph Barauxnatif et negociant de cette Ville, sujet de l'ImpeÂratrice Reine ».
25 Cfr. F.E.J. BARAUX, Del commercio e dell'industria, Picotti, Venezia 1828, pp.326-330. Baraux conosceva personalmente Bolts, sul quale cfr. F. BABUDIERI, L'espansio-ne mercantile austriaca nei territori d'oltremare nel XVIII secolo e suoi riflessi politici edeconomici, GiuffreÁ , Milano 1978. Inoltre H. HOUTMAN-DE SMEDT, Charles Proli, Ant-werps zakenman en bankier 1723-1786. Een biografisch en bedrijfhistorische studie, Ko-ninklijke Academie voor wetenschappen van BelgieÈ , Bruxelles 1983. Altri riferimenti inU. COVA, Uomini, capitali e iniziative dei Paesi Bassi austriaci per lo sviluppo economico diTrieste e Fiume nella seconda metaÁdel Settecento, in CATTARUZZA (a cura di), Trieste, Au-stria, Italia, cit., pp. 153-180; e in G. GILIBERT, Il mercante, il banchiere e l'imperatrice.L'avventura coloniale della Compagnia Asiatica di Trieste, in FINZI, PANARITI, PANJEK (acura di), Storia economica e sociale di Trieste, II, cit., pp. 3-20.
della privilegiata Compagnia di Trieste e Fiume, Baraux fu rappre-sentante degli interessi di quel gruppo in Svezia, ove probabilmentevenne iniziato alla massoneria di rito svedese, creato in quell'epo-ca 26. Il 31 ottobre 1781 Baraux e il collega Giovanni Enrico Frohnfurono nominati direttori della Casa di commercio della privilegiataCompagnia di Trieste e Fiume ed agenti-corrispondenti della Com-pagnia delle Indie a Trieste 27. Sposatosi ad Anversa il 2 aprile 1782,lascioÁ la cittaÁ natale e raggiunse Trieste sul finire di quello stesso an-no 28. Non esistono tuttavia sue notizie precise fino al 1784 e cioeÁfino al momento in cui divenne maestro della loggia massonica trie-stina: avvenimento che fu di grande rilievo nella vita della liberamuratoria della cittaÁ , perche diede nuovo corso alla loggia, tantoche molti sono stati indotti a ritenere che la nascita della prima log-gia triestina datasse appunto al 1784, mentre risaliva ad una decinadi anni prima. Baraux, secondo quanto eÁ stato scritto, si era presen-tato a Trieste munito di diplomi massonici svedesi e appariva unesperto conoscitore dei riti e della condizione della massoneriadel suo tempo 29.
281
26 CioÁ si evince da BARAUX, Del commercio, cit., passim e da G. GRATTON, Triestesegreta, Cappelli, Bologna 1948, pp. 21-22. Sul rito svedese, detto di Swedenborg,cfr. S. HUTIN, La frammassoneria in H.C. PUECH, Storia delle religioni, tr. it., Laterza,Bari 1977, p. 180. L'interesse e lo studio dell'opera di Swedenborg da parte di Barauxsono documentati anche dai volumi di quell'autore presenti nella sua biblioteca e dallelettere scambiate con Johann von Fekete.
27 BARAUX, Del commercio, cit., p. 329. Per la presenza economica del capitale fiam-mingo a Fiume si veda anche M. DASSOVICH, L'attivitaÁ della raffineria fiumana di zucche-ro negli anni 1756-1826. Qualche dato poco noto, «Quaderni Giuliani di Storia », XVIII,1 (1997), pp. 125-128.
28 Si sposoÁ il 2 aprile 1782 con Maria Anna Francesca Wouters, nata il 5 maggio1762, figlia di Cristiano Giuseppe Wouters e di Isabella Leocadia (cfr. Antwerpen,StA, Sint Jacob, Parochialregister nr. 224). La moglie si trasferõÁ da Trieste a Padova do-po la morte del marito per raggiungere la figlia e vi morõÁ nel 1838.
29 GRATTON, Trieste segreta, cit., pp. 21-22. Sull'importanza delle patenti e dei cer-tificati massonici, specialmente svedesi e danesi, per la circolazione delle persone nei di-versi paesi europei cfr. P.-Y. BEAUREPAIRE, FrontieÁre marittime et transferts culturels.L'accueil des eÂtrangers dans les loges macËonniques littorales en France au XVIIIe sieÁcle,in S. CURVEILLER, D. CLAUZEL, C. LEDUC (a cura di), Le deÂtroit: zone de rencontres ouzone de conflits. TroisieÁme colloque europeÂenne de Calais, « Bulletin historique et artisti-que du Calaisis », 173 (2001), pp. 181-191.
Ancora nel 1785 apponeva la propria firma come rappresentantedella direzione della Casa di commercio della privilegiata Compagniadi Trieste e Fiume 30, mentre nel 1786 costituõÁ una propria ditta dicommercio all'ingrosso con la ragione « F. E. J. Baraux e Compa-gni », specializzata « sia di compre e vendite di mercanzie, che in af-fari di spedizione, commissioni di sicurtaÁ , ed in qualunque altro affa-re di cui eÁ suscettibile questa piazza » 31. Nel 1789 si congedoÁ defini-tivamente dalla Compagnia di Trieste e Fiume e ottenne la registra-zione in Borsa per ditta propria.
In quello stesso anno seguõÁ un altro avvenimento per lui partico-larmente importante: la nomina a console degli Stati Generali delleProvince Unite, sollecitata dal barone de Haeften inviato olandesea Vienna, deliberata nel dicembre 1789 e riconosciuta dal governoasburgico con rescritto aulico del 14 marzo 1790. PercioÁ il CesareoRegio Governo di Trieste venne incaricato di riconoscere e far rico-noscere Baraux quale console generale in tutto il Litorale Austriaco e« ungarico » 32, cioeÁ anche per la regione di Fiume. Qualcuno insinuoÁ
282
30 ASTs, Cesareo Regio Governo del Litorale, busta 168/1785, carte non numerate.Sulle attivitaÁ di quella Compagnia cfr. i cenni in BABUDIERI, L'espansione mercantile, cit.,pp. 91-152 e P. KANDLER, Compagnia austriaca delle Indie, « L'Istria », II, 25 settembre1847, pp. 237-238.
31 ADTs, « Circolari delli Stabilimenti mercantili formalmente insinuati », segn. 1/2A 1, carte non numerate.
32 ASTs, Cesareo Regio Governo del Litorale, buste 437/1789 e 1164/1790, cartenon numerate; i documenti relativi all'incarico di Baraux, con le relazioni che invioÁ re-golarmente all'Aia, si trovano in Den Haag, NA, 2e Afdeling, Legatie-archieven, inv. n.250; Buitenlandse zaken voor 1813, inv. n. 251; Legatie-archieven, inv. n. 226. Cenni sulconsolato olandese, che riprendono in larga misura quanto pubblicato in A. TRAMPUS,Un commerciante di Anversa distintosi a Trieste: F.E.J. Baraux, Lint, Trieste 1984, pas-sim, sono riportati in A. COLLEONI, Il ruolo geopolitico dei consoli a Trieste, Italo Sve-vo-Edizioni UniversitaÁ di Trieste, Trieste 2006, pp. 909-915; le stesse pagine sono ripro-poste in M. P. PAGNINI, A. COLLEONI, Il ruolo geopolitica dei consolati a Trieste. Il con-solato d'Olanda 1756-2006. La figura e l'opera del console generale F.E.J. Baraux (1750-1829), La Mongolfiera, Trieste s.d. [ma 2006], che rappresenta un esempio tipico di co-me non scrivere una storia dell'istituzione consolare in quanto, oltre a limitare la storiadel consolato a 20 pagine di testo su un totale di 220 e a basarsi quasi interamente sullanostra ricerca del 1984, trascura del tutto l'ampia documentazione sul consolato delleProvince Unite esistente negli archivi olandesi e da noi descritta nella prima edizione(1990) di questo volume.
che Baraux avesse accettato la carica solo a fini di lucro e per soddi-sfare il suo amor proprio 33, sebbene in realtaÁ assolse l'incarico congrande impegno ottenendo successive riconferme nella carica.
Nell'ultimo quarto del Settecento egli svolse un ruolo fondamen-tale nella riorganizzazione della massoneria triestina, gettando le basiper piuÁ stretti rapporti con le logge austriache e tedesche.
Sulle origini della muratoria triestina si sa ancora molto poco.Negli anni Cinquanta del Settecento era massone l'intendente NiclasHamilton, membro della loggia viennese «Aux trois canons »; lostesso governatore Zinzendorf era massone, iniziato nel 1766 nellaloggia « La Candeur » di Strasburgo 34. Alla loggia provinciale di Pra-ga era affiliato dal 1774 il vescovo Michele L. Brigido, originario diTrieste e fratello di Pompeo Brigido. Ad ogni modo, sembra che lanascita della prima loggia a Trieste possa essere ricollegata a due fe-nomeni tipici della muratoria europea: la diffusione di un modellomassonico di tipo aristocratico, legato alla creazione di logge militariin area germanica ad opera di rifugiati o prigionieri di guerra francesie la presenza nell'area asburgica della tradizione rosacrociana ± cioeÁdi una tradizione alchemica e cabalistica risalente agli scritti seicente-schi di Christian Rosenkreutzer ± sulla quale venne a innestarsi il ritodella Stretta Osservanza, un sistema massonico che auspicava il ritor-no ai valori e alle regole originarie della muratoria scozzese.
Pare inoltre che la nascita della massoneria triestina risalga al1765 circa, ad opera di un parrucchiere francese, un certo CharlesBailly. Nel 1773, l'attivitaÁ di questa prima loggia veniva sostituitada quella chiamata «AÁ la concorde », autorizzata dalla loggia provin-ciale di Praga e promossa da un ufficiale della guarnigione, un certoThomas von Welz (o Walz). Il primo maestro venerabile sarebbe sta-to il tenente francese de Courten. Dalle poche notizie che si hanno,
283
33 G. STEFANI, Bonapartisti triestini, La Porta Orientale, Trieste 1932 e ID., Il cen-tenario delle Assicurazioni Generali, La Compagnia, Trieste 1936, p. 36.
34 WATZLAWICK, Die friedlichen Fahrten eines Deutschordensritters auf den Kriegs-schiffendes Malteser-Ritter-Ordens, in STEEB, STRIMITZER, (a cura di) Der SouveraÈne Mal-teres-Ritter-Orden in OÈsterreich, cit., pp. 93-120; per notizie sui rapporti tra l'ordine diMalta e Trieste cfr. Anche C. RAPOZZI, Il rifugio triestino dell'Ordine di Malta (luglio1798-luglio 1799), a cura di A. PANIZZOLI, Italo Svevo, Trieste 2005.
sembra che si trattasse di una loggia composta anche da militari, cheaveva dodici membri, tra cui il negoziante viennese Hochkofler, ilgiudice Giuseppe Maria Steffani e un piccolo gruppo di commer-cianti legati alla Compagnia degli zuccheri e alle Fiandre, cioeÁ il com-merciante Dede da Fiume, Johann Weber, Sebastian Fels, Jean Blan-chenay, Ignaz Hagenauer, l'italiano Cesare Pellegrini e il greco Ana-stasio Papaleca. Assieme a loro c'erano anche i militari Saint-Eloi ede Courten 35.
La riorganizzazione della massoneria triestina, a partire dal 1776,rimase legata peroÁ alla presenza di Baraux. Eletto nel 1784 maestrodella loggia ne mutoÁ gli orientamenti, promuovendo quello stesso an-no la federazione all'« Eklektischer Bund » (Alleanza Eclettica) inSvizzera e facendole assumere il nome «De l'harmonie et de la con-corde universelle » e per farla aderire nel 1785 alla gran loggia pro-vinciale austriaca, collegandola all'attivitaÁ della Stretta Osservanza diVienna e all'opera di Ignaz von Born 36. Nel 1789 il rappresentantedella loggia triestina, Johann von Fekete (1741-1803), partecipoÁ an-che alle feste massoniche di Francoforte che celebrarono l'unionedella Federazione eclettica alla massoneria di rito inglese.
Queste informazioni sono di grandissimo interesse per capire co-me la cultura massonica triestina fra Settecento e Ottocento si collo-casse a pieno titolo nello spazio della muratoria europea, travagliatoalla fine del XVIII secolo da una profonda crisi interna legata alle nuo-ve dimensioni della politica e alle conseguenze della rivoluzione ame-ricana e poi di quella francese. Gli interessi scientifici di Baraux, col-lezionista ed esperto di mineralogia, si inserivano perfettamente nellatradizione di studi massonici che ± dalla Francia all'Austria ± stavaportando alla costituzione, nell'ambito delle logge, di gabinetti natu-
284
35 L. ABAFI, Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich Ungarn, II, Aigner, Budapest1893, pp. 197-201; TAMARO, Documenti di storia triestina del secolo XVIII, cit., pp. 183-205; GRATTON, Trieste segreta, cit. Nulla dice sulle origini della massoneria nel Litoraleil volume a cura di G.M. CAZZANIGA, Storia d'Italia. Annali 21. La Massoneria, Einaudi,Torino 2006, all'interno del quale si segnala solo il saggio di T. CATALAN, Le societaÁ se-grete irredentiste e la massoneria italiana (pp. 611-633) che peraltro ± come recita il titolo± riguarda esclusivamente le vicende ottocentesche.
36 TRAMPUS, Un commerciante, cit.
rali e di musei scientifici. La loggia di Trieste, anzi, svolse un ruolonon secondario nella strategia politica e culturale della massoneriaviennese degli anni Ottanta, legata alla creazione di una grande log-gia nazionale e territoriale. Aloys Blumauer, massone viennese e fon-datore del Journal fuÈr Freymaurer, aveva in mente proprio questo di-segno quando scriveva al generale Johann von Fekete di stanza aTrieste per annunciargli questo progetto, che avrebbe dato omoge-neitaÁ a tutte le correnti massoniche « senza pregiudizio delle loro li-bertaÁ » 37.
Nuovi documenti emersi dagli archivi nazionali ungheresi, dovesono conservate 763 lettere di Johann von Fekete 38, illuminano sullapresenza massonica nel porto franco e sul ruolo di Baraux. Feketerimase a Trieste per sei anni, fino al 1785, intrecciando una nutritacorrispondenza con intellettuali, uomini di governo e di chiesa delLitorale e della repubblica di Venezia; ma la maggior parte dellasua corrispondenza con triestini, complessivamente undici lettere ri-salenti agli anni 1785-1801, riguarda i rapporti con Baraux e consta,in particolare, delle lettere che il commerciante fiammingo continuoÁad inviargli dopo la partenza e che sono lo specchio di come la loggiatriestina vivesse le grandi trasformazioni che agitavano la muratoriacontinentale negli anni della Rivoluzione francese.
Nel 1784 Fekete era oratore nella loggia diretta da Baraux ed eÁprobabile che vi fosse entrato qualche tempo prima, compiendo quiil suo apprendistato massonico 39. Tuttavia le informazioni piuÁ inte-ressanti che ci fornisce la corrispondenza riguardano la posizione diBaraux che sin dall'inizio si dimostroÁ un deciso partigiano della Stret-ta Osservanza e del rito scozzese, tanto da progettare la riorganizza-
285
37 GIARRIZZO, Massoneria e Illuminismo cit., p. 327; cfr. inoltre p. 329, ove si rac-conta dei dissensi fra la massoneria triestina e quella viennese negli anni successivi.
38 C. MICHAUD, LumieÁres, Franc-MacËonnerie et politique dans les eÂtats des Hab-sbourg: les correspondants du comte Fekete, «Dix-huitieÁme sieÁcle », 12 (1980), pp.327-379. Sull'importanza degli epistolari massonici settecenteschi cfr. P.-Y. BEAUREPAI-
RE, Au coeur de l'expansion macËonnique du sieÁcle des LumieÁres: la correspondance frater-nelle et ses reÂseaux, in P. ALBERT (a cura di), Correpondre jadis et nagueÁre. Actes du 120eCongresse national des SocieÂteÂs historiques et scientifiques, EÁ ditions du CTHS, Paris1995, pp. 337-347.
39 MICHAUD, LumieÁres, cit., p. 358.
zione della loggia secondo quelle regole: « Je compte d'eÂtablir 3 Ecos-sais. 1 ± Celui de St Andre du Chardon pour conduire au grade theÂo-rique et de laÁ aÁ tout autre systeÁme scientifique. 2 ± Celui de SueÁdepour conduire aux grades sueÂdois si je puis avoir les rituels en entirecome j'en ai quelque espoir. 3 ± Le 4e grade de la stricte observanceet l'inteÂrieur » (lettera del 27 settembre 1785) 40. Erano gli anni incui la muratoria europea viveva situazioni di grande disagio con-nesse alla trasformazione della vita delle logge, che da luogo di so-ciabilitaÁ diventavano sempre piuÁ spesso uno spazio percorso dallapolitica. Proprio nel 1785 la setta degli Illuminati di Baviera, un'as-sociazione paramassonica con scopi dichiaratamente politici scioltad'autoritaÁ nell'area germanica e in Austria, aveva reso evidenti i pe-ricoli legati all'infiltrazione di elementi radicali nelle logge 41.
Baraux aveva chiara la necessitaÁ di preservare l'unitaÁ della masso-neria e la purezza dei suoi scopi: « Il paraõÃt que la MacËonnerie est par-tout plus ou moins infecteÂe de quelque invention moderne. En Allema-gne, ce sont les IllumineÂs qui gagnent terrain par tout et particulieÁre-ment aÁ Vienne, en France le martinisme, en Angleterre le Sweden-burgisme et le theÂosophisme », scriveva nel novembre 1785 42; maera critico anche nei confronti di Knigge, un altro seguace degli Illumi-nati: il suo rito « n'est pas grand chose et je l'estime moins que l'UnioneÂclectique, puisque cette dernieÁre tend au moins aÁ une union geÂneÂraledans la Base de l'Ordre qui son le 3 premiers grades » 43.
EÁ questo il contesto culturale nel quale venne costituita la biblio-teca del commerciante e massone Baraux; un esempio straordinariodi raccolta massonica privata giunta fino a noi perche acquistata nel1829 dalla famiglia Sartorio e depositata oggi presso il Civico MuseoSartorio di Trieste. Segnalata da chi scrive all'inizio degli anni No-vanta del Novecento 44 e in seguito oggetto di una piuÁ approfondita
286
40 MICHAUD, LumieÁres, cit., p. 358 nota 88.41 GIARRIZZO, Massoneria e illumismo, cit., p.42 MICHAUD, LumieÁres, cit., p. 359.43 MICHAUD, LumieÁres, cit., p. 359.44 Nella prima edizione di questo volume: A. TRAMPUS, Tradizione storica e rinno-
vamento politico. La cultura nel Litorale Austriaco e nell'Istria tra Settecento e Ottocento,Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, Gorizia 1990, pp. 173-174.
schedatura 45, conserva una grande quantitaÁ di testi che mostrano nelmodo piuÁ evidente la dimensione europea nella quale si poneva lacultura triestina dell'epoca. Accanto alla raccolta completa e assai ra-ra del Journal fuÈr Freymaurer, la rivista organo della loggia « Zur wah-ren Eintracht » di von Born e Blumauer, essa presenta numeroseopere di mistica e di cabala, che rappresentano il versante esotericodella muratoria continentale. Si collegano a questo filone anche i trat-tati di Emanuel Swedenborg (1688-1772), conservati da Baraux, cheevidenziano gli aspetti dell'ideologia massonica di matrice cristiana,legati alle riflessioni sull'immortalitaÁ dell'anima e alla teoria ± presen-tata da Swedenborg negli Arcana coelestia posseduti da Baraux ± se-condo cui accanto al mondo reale esiste un mondo invisibile, popo-lato da uomini che hanno perduto solo il corpo e che continuano avivere con l'anima immortale in Cielo o nell'Inferno. Sono poi pre-senti testi rosacrociani nonche gli statuti e i regolamenti delle loggemassoniche di rito inglese e della Grande Loggia dell'Aja 46.
La corrispondenza di Baraux con von Fekete rimase intensa finoall'agosto 1787, e ci restituisce l'organizzazione della loggia triestina aquel tempo e il nome dei membri: Sebastiano Fels maestro Venera-bile, Lorenzo Giuseppe Wagner, tesoriere Plattner, oratore Giacomode Gabbiati, altri membri Nathaniel Green, Cesare Pellegrini, tali
287
45 C. MORGAN, La biblioteca della famiglia Sartorio, in L. RESCINITI, M. VIDULLI TOR-
LO (a cura di), I Sartorio, l'arte del dono, Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste 1999, pp.219-222.
46 La biblioteca massonica di Baraux venne acquistata nel 1829, dopo la sua morte,dalla famiglia Sartorio e il fondo librario, consiste in una trentina di volumi riconoscibilidalle annotazioni manoscritte e dall'originario numero di catalogazione. Vi si trovano ol-tre alle opere di Swedenborg e al « Journal fuÈ r Freymaurer » (che dalla corrispondenzacon von Fekete sappiamo acquistato direttamente da Baraux per sottoscrizione), volumicome Die theoretischen BruÈder oder zweite Stuffe der Rosenkreuzer und ihrer Instruktion(Athen 1785), Allgemeine und General Reformation der ganzen weiten Welt. BenebenFama Fraternitatis (Regensburg 1781), Der Geist der Maurerey (Berlin 1780), K.H. LO-
BREICH, Geoffenbarten Einfluss in das Allgemeine Wohl der Staaten der achten Freymau-rerey (Amsterdam 1779), G. BOTTARELLI, L'ordre des Franc-MacËons trahi et le secret desmopses (Amsterdam 1745), Histoire des francsmacËons aÁ Jerusalem (1748), De pligten,wetten of algemeene reglementen der vrye metzelaaren (`s-Gravenhage 1773) e Fama fra-ternitatis oft Ontdeckinge ban der Broederschap des hoflucken (Francfort 1615) il qualeultimo reca l'appunto, di mano di Baraux, « niet gemeyn en seer curieus » (non comunee assai curioso).
Rockert e Lorentz. Baraux vi svolgeva il compito di maestro delle ce-rimonie 47. Un anno piuÁ tardi, nell'aprile 1787, nuovi membri eranoentrati: Leonardo Vordoni, Antonio Rossetti de Scander, Johann vonWeber, Giuseppe Michele Hoffer, Koller, Combelle, e Conti 48. Benpresto peroÁ anche nella loggia triestina cominciarono a sorgere con-trasti, dovuti essenzialmente al mancato rispetto della disciplina mas-sonica e al timore di contraccolpi politici determinato dal nuovoorientamento, sempre piuÁ restrittivo, delle autoritaÁ governative. Jo-hann von Weber, il cui allontanamento era stato giaÁ chiesto da alcunifratelli nel gennaio 1786 a causa di un fallimento in cui era incorso,abbandonoÁ la loggia durante la primavera di quell'anno 49. Le attivitaÁsi diradano e le lettere di Baraux a von Fekete si interrompono nel-l'agosto 1787 per riprendere soltanto nel 1796 ma senza piuÁ alcunriferimento massonico e soltanto per esprimere i suoi interessi di stu-dioso di mineralogia 50. L'ultima eÁ dell'11 marzo 1801.
La situazione favorevole per l'attivitaÁ massonica era cominciata amutare quindi giaÁ all'epoca della repressione degli Illuminati di Ba-viera e conobbe ulteriori restrizioni con la morte di Giuseppe II,che per molti anni aveva protetto le logge. CosõÁ anche a Trieste il13 maggio 1793 il conte Pergen, presidente della direzione generaledi polizia, chiese al governatore Brigido l'elenco dei massoni triestini,ottenendo risposta negativa a causa dell'impossibilitaÁ di riceverlo daBaraux, assente dalla cittaÁ 51.
Al ritorno, egli si affrettoÁ a consegnare i nominativi con unita unalettera all'imperatore: «MaestaÁ . Per evitare qualunque possibile equi-voco o malinteso il sottoscritto consegna l'attuale stato della loggia
288
47 Lettera del 27 marzo 1786, in MICHAUD, LumieÁres, cit., p. 361.48 Lettera del 12 aprile 1787, in MICHAUD, LumieÁres, cit., p. 361.49 MICHAUD, LumieÁres, cit., pp. 363 e 365.50 MICHAUD, LumieÁres, cit., pp. 360-361.51 I documenti di seguito citati erano conservati originariamente nell'archivio vien-
nese della Polizeihofstelle e andarono perduti in un incendio del primo dopoguerra. So-no stati pubblicati tuttavia da TAMARO, Documenti di storia triestina, cit., « Atti e Memo-rie della SocietaÁ istriana di archeologia e storia patria », XLI, 1 (1929), pp. 184-205. Sul-la massoneria triestina, oltre a GRATTON, Trieste segreta, cit., si veda anche M. CECOVINI,La Massoneria, in Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia, II/2, cit., pp. 777-790.
triestina dei Franchi Muratori permessa in conformitaÁ e sotto la pro-tezione della sovrana decisione dell'11 dicembre 1785. Trieste, il 23novembre 1793, F.E.J. Baraux ». Il 13 dicembre giunse da Viennal'ordine di chiusura della loggia; il giorno successivo Baraux invioÁ al-tra lettera a Francesco II per informarlo che i membri della loggiatriestina avevano giaÁ deciso di loro volontaÁ , qualche tempo prima,l'interruzione di tutti i lavori massonici. Da queste notizie risultaquindi con evidenza, contrariamente a quanto asserito da alcuni,che Baraux mai nascose la propria appartenenza alla massoneria neÂil ruolo svolto nella loggia triestina; si puoÁ cogliere invece la sinceracoerenza del personaggio che, per obbedienza all'autoritaÁ , dichiaravasospesa ogni attivitaÁ , come effettivamente sarebbe avvenuto fino al1807 52.
Impegnato nell'attivitaÁ di negoziante e negli studi preferiti di mi-neralogia, Baraux non mancava di destare impressione favorevole inquanti lo avvicinavano anche occasionalmente; cosõÁ Johan Meermanpoteva scrivere nel 1791 che « presso il console delle nostre ProvinceUnite, il signor Baraux, [...] ho potuto godere, anche senza racco-mandazioni, di diverse prove di amicizia e ho trovato in lui un uomoabile ed esperto non solo nel ramo del commercio » 53.
Nuovi impegni attendevano il nostro personaggio negli anni suc-cessivi. Con l'occupazione francese del 1797, per ordine di Napoleo-ne (24 marzo 1797), venne formata una nuova deputazione di Borsa,per la quale si presentarono volontari quattro commercianti: AlvisePerinello, Giorgio Enrico Trapp, Johann von Weber e Baraux. Oggisappiamo, sulla base della documentazione della massoneria triesti-na, che tutti e quattro erano stati fratelli in loggia e possiamo quindicomprendere quali motivazioni, anche ideali, li spingessero ad accet-tare quell'incarico. Inoltre il primo maggio il Magistrato civico venneautorizzato dagli occupatori francesi ad istituire un tribunale di se-conda istanza per le cause civili e commerciali: Baraux venne nomi-
289
52 Non privo di ingenuitaÁ e di inesattezze sulla massoneria triestina di quegli anni eÁM. PACORIG, Pietro Nobile e la massoneria a Trieste (il controllo della polizia austriaca suicittadini filofrancesi e sugli affiliati alla massoneria), « Archeografo Triestino », s. IV, LII(1992), pp. 195-201.
53 MEERMAN, Eenige berichten, cit., p. 227.
nato assessore alle cause mercantili 54 e cosõÁ otteneva un altro ricono-scimento della sua esperienza in materia commerciale.
Erano gli anni in cui si faceva conoscere nella patria d'adozioneanche come uomo di non comuni interessi culturali. Frequentatoredel Casino dei nobili ± pur essendo borghese ± sin dal 1790, perquanto di evidenti sentimenti francofili e democratici non mancoÁdi stringere amicizia con gli esuli francesi rifugiatisi a Trieste dopola Rivoluzione, tra cui i conti More de Pontgibaud. Madame de Mo-re , in particolare, scriveva nel 1804 al figlio rimasto a Parigi che « s'ilvoulait avoir d'ici des deÂtails d'agriculture et y adresser son journal ilne pourrait sans doute mieux fair que d'entrer en commerci pour cetobjet avec le consul [Baraux] qui est, dit-on, un homme d'esprit, in-struit et qui lorsqu'il a habiteÁ le Dannemark avait du y entre corre-spondant de l'AcadeÂmie des Sciences de Paris » 55.
L'anno 1805, che segnoÁ per Baraux la perdita della carica di con-sole a causa dell'incorporazione del regno dei Paesi Bassi nell'imperonapoleonico, vide la seconda occupazione francese dell'emporioadriatico, durante la quale egli non ricoprõÁ incarichi pubblici di rilie-vo. Venne individuato anzi fra i trenta negozianti piuÁ abbienti dellacittaÁ da trarre in arresto e da condurre nel castello come ostaggi perottenere un riscatto. Liberato da quella detenzione, fu tra quanti pre-sero parte alle lunghe trattative con i commissari francesi per mitiga-re il rigore delle contribuzioni imposte alla cittaÁ . Il 7 marzo 1806, tregiorni dopo il ritiro delle truppe napoleoniche e la restaurazione delgoverno asburgico, Baraux si fece promotore di un intervento pressola Corte di Vienna per il ristabilimento del commercio nel Litorale efirmava assieme al collega Ignazio Gadolla una petizione in linguafrancese all'imperatore Francesco I: « I sottoscritti deputati al com-
290
54 ASTs, Deputazione di Borsa, Protocollo delle radunanze, n. 8 (1797), carte nonnumerate.
55 ADTs, Fondo Incontrera, segn. 21 D 3/7. La notizia dei suoi rapporti con l'Aca-deÂmie des Sciences non trova peroÁ conferma. Viceversa sono da escludere con certezzarapporti con la SocieÂte de geÂographie di Parigi, ipotizzati da altri autori, giacche il nomedi Baraux non compare nell'elenco degli iscritti fra il 1821 (anno della fondazione) e il1829 (anno della sua morte). Devo queste informazioni al prof. Marcel-M. Charter, se-gretario generale della societaÁ .
mercio triestino sono stati incaricati di esporre rispettosamente a Vo-stra MaestaÁ un compendio degli attuali mali di cui eÁ afflitta questacittaÁ e delle desolanti prospettive che l'avvenire le presenta. Sono sta-ti anche incaricati di sollecitare i provvedimenti per scongiurare la ro-vina da cui il suo commercio eÁ minacciato » 56. Nel memoriale si rias-sumevano le vicende degli anni precedenti e si proponevano nuovesoluzioni per assicurare l'avvenire emporiale della cittaÁ . « Trieste po-traÁ forse servire ancora d'asilo a quei negozianti offesi dai violenti ri-volgimenti politici, negozianti che cercano sempre la tranquillitaÁ [...].Si puoÁ ancora sperare che Trieste, dopo risanati i disastri sofferti, ri-prenda un'ascesa felice grazie alla speciale protezione e agli incorag-giamenti dei Sovrani dell'Augusto Impero d'Austria ».
L'iniziativa, se pote trovare l'appoggio del ceto mercantile, fugiudicata con sfavore dalle autoritaÁ del Litorale, primo fra tutti il go-vernatore LovaÁsz che nel febbraio 1807, in una lettera al presidentedel Dicastero aulico di polizia barone de Hager 57, protestava controil memoriale dei due negozianti che giudicava ancora piuÁ discutibilealla luce del loro contegno politico negli anni precedenti. E da quelmomento iniziarono con insistenza le indagini della polizia su Ba-raux, sulla sua attivitaÁ massonica e sui suoi sentimenti politici 58. Cer-to eÁ che il memoriale ottenne tuttavia l'effetto desiderato e l'impera-tore concesse al ceto mercantile di Trieste un prestito di tre milioni difiorini, grazie al quale le sorti dell'emporio poterono risollevarsi.
In quel tempo un'altra figura di primo piano della vita cittadinapreparava, con minore successo, un intervento presso il sovrano: Do-menico Rossetti redasse un'istanza all'imperatore che sottopose alladeputazione di Borsa ± tramite Baraux ± e che venne giudicata nega-tivamente a causa delle critiche che conteneva sull'operato del gover-natore e sull'inopportunitaÁ e illegittimitaÁ di alcuni suoi provvedimen-ti. Allora Rossetti scrisse un nuovo memoriale che invioÁ per un pare-
291
56 Copia del memoriale si trova in BCTs, Carte Tamaro, segn. R.P. MS. MISC. 142E, carte non numerate.
57 QUARANTOTTI, Trieste e l'Istria, cit., p. 204.58 Sul clima politico degli anni immediatamente precedenti la Restaurazione, con
riferimenti diretti allo spazio austriaco, si veda anche P.-Y. BEAUREPAIRE, L'Europe desfrancs-macËons XVIIIe-XXIe sieÁcles, Belin, Paris 2002, pp. 212-220.
re anche a Baraux. Il commerciante di Anversa mise tutta la sua espe-rienza a disposizione del trentenne avvocato triestino, soffermandosianaliticamente sui vari punti del memoriale e non risparmiando con-sigli al giovane giurista. AnnotoÁ taluni passi con considerazioni come« eÁ un poco forte e non conveniente », oppure « questo paragrafo po-trebbe essere riformato in termini piuÁ moderati ». Ma soprattutto os-servoÁ : «Non ho certamente preteso di censurare l'opera dell'eruditoed energico scrittore, ne opporre un'intempestiva e a me non naturalfreddezza al suo fuoco. La sola prudenza ha messo argine al mio; l'e-sperienza mi insegnoÁ in piuÁ incontri, che il troppo fuoco nuoce spes-so alla cosa, indisposa l'animo e produce un effetto contrario a quan-to si spera. EÁ lecito dire tutto, basta circonscrivere li termini ed il mo-do di esposizione » 59.
Sempre nel 1806 Baraux venne nominato membro della commis-sione incaricata della liquidazione dei crediti di guerra rimasti insolu-ti durante le prime due occupazioni francesi; e nel 1811, durante laterza e ultima occupazione, sarebbe stato nominato membro di ana-loga commissione presso cui sarebbero state versate tutte le obbliga-zioni rilasciate dal Comune verso somme mutuate per soddisfare lespese straordinarie durante le invasioni del 1797, del 1805 e del1809. Nel 1807 venne eletto assessore al Tribunale mercantile di pri-ma istanza, mentre ricominciava l'attivitaÁ massonica, tanto che nel1807 il governatore lo segnalava come uno dei firmatari delle istanzemassoniche per l'aggregazione di Trieste al Regno d'Italia 60.
Ancora piuÁ attenta divenne la sorveglianza da parte degli organidi polizia austriaca e da parte degli osservatori rimasti a Trieste du-rante la terza occupazione francese (1809-1813). Soprattutto quandoBaraux perse definitivamente la carica di console generale dei Paesi
292
59 Copia moderna delle sue Osservazioni sopra la Memoria del sig. de Rossetti[1806] si trova in ADTs, Fondo Incontrera, segn. 21 D 3/88, carte non numerate. Enfa-tizza un po' la modernitaÁ di Rossetti A. R. RUGLIANO, L'Illuminismo di un italiano del-l'Austria nella Trieste mercantile: Domenico Rossetti, «Neoclassico », 19 (2001), pp. 37-52.
60 ADTs, Segn. 17 G 1, carte non numerate; QUARANTOTTI, Trieste e l'Istria, cit., p.280. Dal 1808 egli divenne pure deputato effettivo di Borsa (cfr. ASTs, Deputazione diBorsa, Protocollo delle radunanze, n. 19, 1808, carte non numerate).
Bassi, che aveva riacquistato per breve tempo, e quando ± soppressala Deputazione di Borsa ± venne istituita la nuova Camera di Com-mercio. Nella direzione di questa Baraux entroÁ per ordine dell'inten-dente francese Arnault nel 1810, divenne vicepresidente nel 1811 efece funzioni di presidente per alcuni mesi nel 1812. Il 31 maggio1813, infine, venne eletto a larghissima maggioranza dei voti presi-dente della Camera di commercio, incarico nel quale venne riconfer-mato per altre quattro volte 61.
Risalgono a quel periodo tre elenchi della polizia austriaca dipersone ritenute partigiane della Francia: in essi il nostro personag-gio veniva indicato semplicemente come « hollaÈndischer Consul »,poi come «Meister vom Stuhl » 62 e da ultimo come « hollaÈndischerConsul in Triest. Jede Bemerkung waÈre zwecklos » 63.
Con la Restaurazione le cose volsero al peggio. GiaÁ verso la metaÁdel 1813 un rapporto della polizia segnalava Baraux come fervido so-stenitore del governo francese. Altro rapporto del 23 gennaio 1814precisava che il commerciante di Anversa « introdusse e promossequi la loggia framassonica, ossia dei franchimuratori, che peroÁ dopola proibizione sovrana si eÁ sciolta, e dispersa; si dimostroÁ egli semprequal di fatti era per genio, interesse ed orgoglio fanatico partitantefrancese, tale e conosciuto da tutti » 64. Il 31 marzo successivo Catta-nei, direttore di polizia, inviava a Vienna un lungo rapporto nel qualetra l'altro si affermava ± in riferimento all'epoca della seconda occu-pazione francese ± che « quest'uomo, che pretende di essere un eru-dito e uno scrittore, giaÁ allora [...] criticava [...] tutte le misure presedal Governo austriaco »; ogni sua azione, sosteneva il direttore di po-lizia, era stata diretta a seminare sfiducia, discredito e malcontento
293
61 ASTs, Deputazione di Borsa, Protocolli delle radunanze, n. 22 (1812) e n. 23(1813), carte non numerate.
62 «Maestro di loggia ».63 «Console olandese a Trieste. Ogni osservazione sarebbe superflua ». I rapporti
sono conservati in copia in ADTs, Carte Tamaro, segn. 142 E, carte non numerate. Del-l'argomento si eÁ interessato anche L. KAMMERHOFER, Jakobinismus in Triest, in G. CASA
(a cura di), Influenze ed echi della Rivoluzione francese a Trieste e nel Friuli maggio 1789-maggio 1797, Italo Svevo, Trieste 1991, pp. 39-56.
64 STEFANI, Bonapartisti, cit., pp. 478-479.
nei confronti del governo e inoltre Baraux veniva indicato come cor-ruttore del maire Maffei e grande amico del francofilo Crampagna,giaÁ presidente della Camera di Commercio. «Questo triumvirato »continuava Cattanei « deve venire sciolto, annientato. Ritengo [...]mio dovere di far pressioni in via ministeriale per l'esclusione del Ba-raux dall'importante posto di console generale d'Olanda, allo scopodi poter in qualunque caso non riconoscerlo come tale. [...] Anche alsovrano principe dei Paesi Bassi non puoÁ essere indifferente di averecome proprio console un individuo che si eÁ dichiarato tanto forte-mente e tanto apertamente per la causa della Francia, dalla quale eglinon si separeraÁ mai piuÁ e non lo puoÁ . Colui che verraÁ nominato aquesto posto dovraÁ essere persona assolutamente benpensante e for-nita delle necessarie istruzioni » 65.
Il 22 luglio 1814 il barone de Hager informava Cattanei che Ba-raux era stato privato ufficialmente della carica di console e che il go-verno dei Paesi Bassi aveva dato assicurazione che l'incarico sarebbestato conferito a persona piuÁ gradita alla Corte Imperiale 66. Eppure,nonostante tutti gli sforzi della polizia per impedirgli l'assunzione diqualsiasi carica pubblica, Baraux venne rieletto all'unanimitaÁ ± il 28febbraio 1814 ± presidente della Camera di Commercio e nuovamen-te, a larghissima maggioranza, venne riconfermato in agosto fino atutto il mese di novembre 67. Ma nel frattempo, venuto meno il go-verno provvisorio delle Province Illiriche e proclamata (23 luglio)l'incorporazione delle Province all'Impero d'Austria, veniva reintro-dotta la legislazione previgente e, soppressa la Camera di Commer-cio, veniva ristabilita la Deputazione di Borsa nella quale (22 ottobre1814) Baraux in nuove elezioni risultoÁ il secondo dei non eletti, re-gredendo alla carica di deputato aggiunto. CosõÁ si realizzavano gli au-spici del governo austriaco.
Paradossalmente proprio dal direttore di polizia Cattanei ± checon tanta decisione aveva attaccato Baraux ± giunse nel 1815 la ria-
294
65 STEFANI, Bonapartisti, cit., pp. 564-565.66 ADTs, Fondo Incontrera, segn. 21 D 3/12, carte non numerate.67 ASTs, Deputazione di Borsa, Protocollo delle radunanze, n. 22 (1813), carte non
numerate.
bilitazione pubblica del nostro personaggio. Il 10 maggio di quell'an-no, rispondendo al governatore sui sentimenti patriottici di ciascunmembro della Deputazione di Borsa, scriveva che « giaÁ il 31 marzo1814 ho esteso un esauriente rapporto sulle idee e sulle sospette ca-ratteristiche del Baraux, quando si trattava di nominarlo consoled'Olanda. PiuÁ tardi mi fu chiesto, con lettera del 15 aprile u.s. unesauriente rapporto circa i succitati Baraux e Crampagna anche dalgovernatore generale barone Lattermann, rapporto che inviai il 19aprile e del quale per precauzione allego copia. Per le considerazioniesposte in quei due rapporti ne il Crampagna ne il Baraux dovrebbe-ro avere piuÁ pubbliche funzioni di rappresentanza. Tuttavia credodoveroso richiamare Vostra Eccellenza sull'epoca in cui quei rappor-ti furono presentati e sulle mutate condizioni politiche » 68. Cattaneisi soffermava sull'opportunitaÁ di non impedire a queste persone,« traviate » dagli eccezionali avvenimenti dell'epoca, il ritorno « ingrembo alla famiglia statale » e consigliava di riconfermare i loro in-carichi pubblici, aggiungendo riguardo a Baraux: « eÁ giaÁ sufficiente-mente noto a Vostra Eccellenza. Egli ha giaÁ sofferto il pubblicosmacco di non essere stato, contro le sue stesse assicurazioni, confer-mato console d'Olanda; per questo motivo egli ebbe un violentissimoaccesso di podagra, che lo fece soffrire molto durante l'inverno. Delresto eÁ persona di oltre 60 anni e come sostituto non ha frequenti oc-casioni di prendere parte alle sedute di Borsa ».
Nell'attivitaÁ professionale, Baraux fondoÁ nel 1814 con PietroSartorio e Giacomo Rota il Banco di assicurazioni marittime 69, nelquale fu poi collega di Giovanni Guglielmo Sartorio ± succedutoal padre ±, sciolto nel 1823. ContinuoÁ pure a dirigere la propria casadi commercio, ritirandosi dagli affari appena nel 1826 per lasciarne laproprietaÁ ad altri soci 70.
Il rapporto di polizia prima citato fornisce anche un primo indi-zio sugli interessi culturali del nostro personaggio. A parte la fre-quentazione, giaÁ accennata, del Casino dei nobili, non risulta che egli
295
68 STEFANI, Bonapartisti, cit., pp. 567-568.69 ASTs, Tribunale Commerciale e Marittimo, busta 353/1814, carte non numerate.70 ADTs, Circolari delli stabilimenti, segn. 1/2 A, sub 1826, carte non numerate.
si fosse mai interessato all'Accademia arcadica o ad altre associazioniculturali, benche fosse nota la sua passione per il teatro e per le scien-ze naturali. Invece nel 1810 Baraux divenne socio fondatore, assiemea Domenico Rossetti, della SocietaÁ di Minerva 71, in seno alla quale sifece promotore nel 1811 di una SocietaÁ di pubblica beneficenza du-rata fino al 1816. Nel 1812 venne nominato direttore economo del-l'associazione e in quella veste, assieme a Rossetti, firmoÁ nel 1813 l'i-stanza per il riconoscimento della societaÁ da parte del governo au-striaco 72.
Alla SocietaÁ di Minerva diede in affidamento una considerevoleparte della propria raccolta di minerali, creata e studiata in ricerchepluridecennali che gli consentirono la schedatura di oltre ottomilapezzi 73. Nel dicembre 1813, probabilmente in conseguenza della si-tuazione personale e politica in cui era venuto a trovarsi, lascioÁ la ca-rica di direttore economo, rimanendo semplice socio fino al 1821,quando sarebbe divenuto « consultore » per restarlo fino alla morte 74.
Con pari impegno Baraux si dedicoÁ alle attivitaÁ della SocietaÁ delCasino vecchio, di cui fu socio fondatore nel 1816 assieme a Rossetti,al conte Demetrio Voinovich e a Francesco Taddeo Reyer e per laquale fu costantemente sollecito nel proporre nuove iniziative, acqui-sti di gazzette dai vari paesi europei e cosõÁ via 75.
296
71 Per la storia dell'associazione e per il ruolo svoltovi da Baraux cfr. A. GENTILE, Ilprimo secolo della SocietaÁ di Minerva 1810-1909, SocietaÁ di Minerva, Trieste 1910, non-che le riflessioni piuÁ recenti di DIONISOTTI, Francesco Petrarca nella cultura triestina, cit.,pp. 1-16, di E. GUAGNINI, Gli esordi del Gabinetto di Minerva, in CAPUTO (a cura di),Neoclassico, cit., pp. 287-289 e ID., Trieste: ponte tra culture / postazione di confine, inFINZI, MAGRIS, MICCOLI (a cura di), Storia d'Italia. Le regioni dall'UnitaÁ a oggi. Il Friu-li-Venezia Giulia, II, cit., pp. 956-958 e di SALIMBENI, La prima serie, cit., pp. 115-119. Non molto di piuÁ , rispetto all'analisi di Salimbeni, dice il saggio di G. MARUSSI,L'«Archeografo Triestino »-Prima serie (1829-1837), « Archeografo Triestino », s. IV,LVII (1997), pp. 11-111. L'attiva partecipazione di Baraux alle vicende della societaÁ eÁdocumentata pure dalle sue lettere in CMSA, Archivio della SocietaÁ di Minerva, fasc.1810-1828, carte non numerate.
72 ASTs, Imperial Regia Intendenza dell'Istria, busta 32/1813, carte non numerate.73 ADTs, Copialettere della Minerva, segn. 1/1 F 16, carte non numerate. Cfr. inol-
tre CAPRIN, I nostri nonni, cit., p. 12.74 GENTILE, Il primo secolo, cit., p. 99.75 ADTs, manoscritto senza titolo, segn. 1/2 A 4, carte non numerate.
Si rese inoltre benemerito per la donazione nel 1823 di quasi mil-le pezzi della sua collezione di minerali all'Accademia di Commercioe di Nautica 76, istituzione con la quale aveva avuto rapporti fin dal1817 in quanto nominato dalla Deputazione di Borsa commissarioagli esami « negli oggetti di scienze puramente mercantili » 77.
La passione per la mineralogia fu all'origine del saggio Circa ilnuovo sistema di mineralogia del sig. Mohs pubblicato in due puntatenella « Biblioteca Italiana » del 1821, in cui si attestava su posizionicritiche verso la nuova scala di Mohs, un sistema di classificazionemineralogica fondato sulla durezza dei materiali disposti in serie cre-scente 78.
Di grande interesse per la ricostruzione dell'attivitaÁ culturale diBaraux e per la storia del Litorale Austriaco sono anche i manoscrittiinediti di vario argomento che abbiamo ritrovato. Un esame degliinediti non puoÁ tuttavia prescindere dalla breve analisi della suapiuÁ importante opera, apparsa nel 1828 a Venezia con il titolo Delcommercio e dell'industria (ma portata sostanzialmente a terminenel 1816 e allora non pubblicata « per conseguenza di posteriori av-venimenti »), dalla quale si possono evincere i suoi modelli culturali epolitici.
Nella prefazione riassumeva la genesi del suo lavoro, indicando-ne obiettivi e limiti e chiarendo il rapporto fra la vocazione commer-ciale e quella culturale che trovava espressione nei suoi scritti: « Pro-curai di estrarre dalla vasta materia le piuÁ utili nozioni che potesserointeressare, sotto qualunque analogo aspetto, tutti quelli che periscelta, stato, o condizione a quella scienza attendono, come purele nozioni occorrenti per il maggior erudimento del negoziante, ag-giungendovi specificamente diversi e molteplici oggetti importanti
297
76 ASTs, Atti dell'Imperial Regia Accademia di Nautica, busta 5, carte non numerate.77 ASTs, Atti dell'Imperial Regia Accademia di Nautica, busta 3, carte non numerate.78 F.E.J. BARAUX, Circa il nuovo sistema di mineralogia del sig. Mohs, « Biblioteca
Italiana o sia giornale di letteratura, scienze, arti », VI, XXII (1821); il saggio gli eÁ attri-buito da P. STANCOVICH, Notizie sugli istriani illustri viventi nel 1829, a cura di F. GLE-
ZER, Coana, Parenzo 1884, p. 5. Sulla rivista e sul suo carattere filoaustriaco e conserva-tore cfr. R. BIZZOCCHI, La « Biblioteca Italiana » e la cultura della Restaurazione 1816-1825, FrancoAngeli, Milano 1979.
per chiunque abbia particolare interesse di essere piuÁ circostanzial-mente informato su cioÁ che riguarda l'Austriaco Impero. Tale essen-do l'origine, lo scopo e l'indole del mio lavoro, ho la fiducia di venireanche scusato da quelli che bramerebbero piuÁ puritaÁ di lingua, piuÁeleganza e uniformitaÁ di stile, miglior ordine e connessione di cose,e talvolta un maggiore sviluppo dei fatti, o una minor copia o prolis-sitaÁ di annotazioni. Se il cortese lettore prende in considerazione cheio miro soltanto a giovare altrui, che ho scritto nella lingua del paeseove mi sono stabilito e non nella mia propria 79, e che mi sono accin-to a ragionare su d'una materia quanto vasta altrettanto difficile adordinare e trattare a fondo da chi occupato in affari commercialinon puoÁ esserlo regolarmente nelle scienze e nelle lettere, non proce-deraÁ con troppa rigorosa critica alla disamina del mio travaglio » 80.
Cardine della trattazione, che ha lo scopo dichiarato di esporrein forma piuÁ accessibile all'operatore commerciale, per il miglioreesercizio della professione, una materia giaÁ sufficientemente studia-ta 81, eÁ la dimostrazione dell'influenza determinante che commercioe industria hanno avuto nella storia del progresso civile e politicodel genere umano; l'autore rende tutto cioÁ evidente attraverso un'a-nalisi comparata della storia civile ed economica dei piuÁ importantiregni antichi e degli Stati moderni, individuando alcuni valori fonda-mentali e alcune costanti nei vari processi storici. La corrente di ideecui attingeva il commerciante Baraux era figlia del liberismo econo-mico settecentesco, rinvingorita dalla sua esperienza personale. Ilcommercio era visto come principio generatore della civiltaÁ che « svi-
298
79 La lingua materna di Baraux era il neerlandese, come lui stesso dichiara nei suoirapporti consolari; conosceva naturalmente alla perfezione anche il francese e l'italiano eprobabilmente anche la lingua tedesca.
80 F.E.J. BARAUX, Del commercio e dell'industria, prospetto storico ossia cenni gene-rali sulla storia del commercio e sulla sorgente dell'industria e della prosperitaÁ delle nazio-ni, I (unico pubblicato), Picotti, Venezia 1828, pp. 424, in 8ë. Il volume eÁ anonimo mal'esemplare conservato presso la Biblioteca civica di Trieste (segn. R.P. 3-2253) reca unadedica autografa dell'autore a Domenico Rossetti. Il volume venne recensito in « L'Os-servatore Triestino » del 17 luglio 1828. Il testo eÁ riprodotto in PAGNINI, COLLEONI, Ilruolo geopolitico, cit., pp. 57-216, con l'attribuzione a Baraux ma senza alcuna spiegazio-ne della sua origine.
81 BARAUX, Del commercio, cit., p. 4, Prefazione.
luppa il genio, infonde attivitaÁ nello spirito, rende le nazioni sagge ecolte, le fa inventare e perfezionare le arti » 82, in opposizione quindialla fisiocrazia settecentesca che avevano sottolineato « l'anima dell'a-gricoltura, la quale certamente languisce, qualor non venga incorag-giata dal commercio » 83. Oltre a cioÁ il commercio si rivelava adatto aeliminare « quella eccedente ineguaglianza, frutto dell'oppressione edel potere de' tempi feudali ».
Molte erano sicuramente le fonti cui Baraux si ispirava, dimo-strandosi informato anche della nota polemica settecentesca sul lussoe i suoi effetti. Tuttavia il suo modello non pare tanto Rousseau,autore del Discours sur l'ineÂgalite che aveva ripreso FeÂnelon conside-rando negativamente il commercio come distruttivo e causa di vizi,ambizione e allontanamento dall'ideale stato di natura 84. Piuttosto,Baraux pare essersi ispirato alle ConsideÂrations sur les causes de lagrandeur des Romains et de leur deÂcadence di Montesquieu dove, seanche le potenze commerciali erano considerate di breve durata 85,tra le cause di decadenza di una civiltaÁ veniva individuato proprioil lusso, inteso come eccesso inutile della ricchezza 86, quello che Ba-raux definiva « il superfluo dell'opulenza » 87. In Montesquieu sem-brava apprezzare anche il teorico della separazione e del bilancia-mento dei poteri, al di laÁ della predilezione per una forma particolaredi governo (monarchico o repubblicano) come si poteva ritrovare nelparlamentarismo inglese, modello che Baraux ammirava sin dagli an-ni giovanili 88.
EÁ possibile riconoscere l'influenza di Montesquieu anche in altrimomenti del pensiero di Baraux, come ad esempio nell'aspirazione alriconoscimento del merito, comune nella borghesia settecentesca,
299
82 BARAUX, Del commercio, cit., p. 345.83 BARAUX, Del commercio, cit., p. 346.84 Cfr. ROUSSEAU, Opere, a cura di P. ROSSI, cit., p. XXXIII.85 MONTESQUIEU, Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro
decadenza, tr. it., a cura di M. MORI, Einaudi, Torino 1980, cap. IV, p. 22.86 MONTESQUIEU, Considerazioni, cit., cap. III, p. 16.87 BARAUX, Del commercio, cit., p. 348.88 BARAUX, Del commercio, cit., pp. 139-220 (sez. VIII, Commercio dell'Inghilterra e
sue colonie) e pp. 120-138 (sez. VII, Commercio dell'Olanda e sue colonie).
che gli offriva l'occasione per sottolineare la « considerazione chemerita la professione del negoziante » 89. Baraux riprendeva anchele affermazioni di Montesquieu circa l'opportunitaÁ di conferire il ti-tolo nobiliare quale premio per la ricchezza prodotta e per i meritiacquisiti operando per il benessere comune; si tratta di un atteggia-mento che rifletteva anche la sua condizione personale di borghesenon nobilitato in una Trieste non povera di nobiltaÁ priva di meriti 90.L'aspirazione ad un sistema meritocratico, d'altra parte, non era con-fortata solo dal pensiero di uomini come Montesquieu, ma anche daquello di Joseph von Sonnenfels, massone come Baraux. Sonnenfels,che era stato iniziato dal 1782 alla loggia « Zur wahren Eintracht »aderente alla Stretta Osservanza, come la loggia triestina, era tra ifondatori del « Journal fuÈ r Freymaurer » ± cui Baraux era abbonato± per il quale scrisse nel 1784 un articolo, che il nostro commerciantelesse segnandone passi e sottolineandone frasi, sull'influenza dellamassoneria sulla societaÁ civile (Von dem Einflusse der Maurerey aufdie buÈrgerliche Gesellschaft), esponendo alcune idee sulla funzionedella muratoria che Baraux evidentemente doveva condividere. Essadoveva operare per il miglioramento della comunitaÁ , per il perfezio-namento delle virtuÁ civiche nel quadro del benessere dello Stato, persollecitare il contributo di individui capaci ed illuminati, non vinco-lati da condizioni sociali ed economiche 91. E se anche Baraux nonsembrava condividere, nei comportamenti politici, le concezionipiuÁ assolutiste di Sonnenfels, questo interesse per le correnti di pen-siero dell'Austria settecentesca pare certamente significativo.
Altre tematiche emergono dal primo manoscritto inedito di Ba-raux che ci accingiamo ad esaminare 92, relativo ad argomenti teatrali
300
89 BARAUX, Del commercio, cit., p. 352.90 BARAUX, Del commercio, cit., pp. 395-396.91 Su queste posizioni di Sonnenfels cfr. DI SIMONE, Aspetti della cultura giuridica
austriaca, cit., pp. 143-153. Cfr. J. VON SONNENFELS, Von dem Einflusse der Maurereyauf die buÈrgerliche Gesellschaft, « Journal fuÈ r Freymaurer », I, 1 (1784), pp. 142-160.La copia del giornale appartenuta a Baraux si trova oggi presso il Civico Museo Sartoriodi Trieste e reca l'antica segnatura n. 0/1.
92 I manoscritti autografi di Baraux sono conservati fra i documenti del suo amicoGiuseppe de Lugnani, che probabilmente ne revisionava l'uso della lingua, in BCTs,segn. R.P. MS MISC. 87/XVII.
e musicali. EÁ databile al 1816 circa e vi si trova citata l'ultima edizio-ne delle opere di Metastasio pubblicata a Napoli da De Bonis pro-prio in quell'anno. Reca il titolo Articles du Dictionnaire de musiqueed eÁ sostanzialmente un estratto ragionato del Dictionnaire de musi-que che Rousseau aveva pubblicato a Ginevra nel 1767 sulle basi del-le voci tecniche sulla musica giaÁ scritte per l'EncyclopeÂdie di Diderote d'Alembert. Il manoscritto, distinto in due colonne di cui quella adestra recante gli estratti da Rousseau, riporta anche alcuni passi su-gli stessi argomenti tratti da un autore italiano, posteriore al 1780,non identificato.
Si tratta di un lavoro sicuramente non destinato alla pubblicazio-ne e da considerare, invece, come una sorta di esercitazione privata,documento del tipo di interessi musicali del commerciante Baraux.Vi emerge l'intendimento di un'indagine critica che, pur limitata, sievidenzia dal confronto fra i due testi, dove eÁ facilmente percepibilel'atteggiamento di Baraux nei confronti degli autori studiati. Di Rous-seau egli accettava le teorie estetiche e il suo atteggiamento verso laproduzione teatrale, dimostrando interesse per la querelle des bouf-fons, ossia per la polemica sul carattere del melodramma scoppiatanel 1752 che aveva visto l'opposizione di due partiti, quello favorevo-le al dramma buffo importato da Pergolesi (coin de la Reine) e quelloancora legato alla trageÂdie lyrique francese (coin du Roi) 93. Baraux di-mostrava di condividere la posizione di Rousseau, che del primo par-tito assieme agli enciclopedisti era stato uno dei paladini pubblicandonel 1753 la Lettre sur la musique francËaise e scrivendo un'operina adimitazione di quelle ben superiori di Pergolesi (Le devin du village).Risulta, quindi, una propensione di Baraux per l'opera italiana attra-verso un tentativo di approccio critico a una grande problematica sulmelodramma che lo orientava verso quelle posizioni riformiste cheavrebbero portato al rinnovamento dell'opeÂra-comique francese.
Questo atteggiamento riflette peraltro le posizioni degli illumini-sti italiani a partire da Francesco Algarotti, autore del Saggio sopra
301
93 E. RESCIGNO, La querelle des bouffons, in ID. (a cura di), Grande storia della mu-sica, II, Fabbri, Milano 1979, p. 209; F. DEGRADA, L'opera napoletana, in A. BASSO (acura di), Storia dell'opera, I, UTET, Torino 1977, pp. 237-332.
l'opera in musica (1754), che trovava ampia rispondenza tra gli intel-lettuali di mezza Europa nella seconda metaÁ del XVIII secolo 94. Laposizione di Baraux appariva tuttavia ± al sorgere dell'Ottocento ±retrospettiva e datata, nel senso che rimaneva profondamente anco-rata alla sua cultura settecentesca, come se gli fossero sfuggite leistanze dell'esordiente melodramma rossiniano e dei compositori del-l'etaÁ napoleonica (Cherubini, Spuntini ecc.) 95.
Coerente con l'impostazione appena descritta eÁ l'argomento delsecondo manoscritto intitolato Natura del dramma musicale che, dallericerche effettuate, eÁ risultato essere un estratto dall'opera di StefanoArteaga Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fi-no al presente, pubblicata a Venezia in tre volumi nel 1786 con la da-ta del 1785 96. Arteaga, scrittore dal temperamento indipendente edal piglio polemico, aveva pubblicato la prima edizione del suo lavo-ro nel 1783, suscitando vasto interesse e molte polemiche, ravvivatepoi dalla seconda edizione. Vicino per comunanza di interessi a pa-dre Martini, con il quale era in contatto 97, Arteaga resta significativocon la sua opera non tanto per i passi di erudizione storica, quantopiuttosto per le riflessioni, all'epoca causa dei dissensi, sul melodram-ma « riformato ».
Ritorna, nella genesi di quelle riflessioni, il punto di riferimentorappresentato da Pergolesi e dalla sua produzione, cui appartennequell'opera seria dal titolo Il prigionier superbo (1733) con gli inter-mezzi La serva padrona che, rappresentata a Parigi nel 1752, avevadato inizio alla querelle des bouffons e che costituiva uno dei modelliper il partito degli italofili e per lo stesso Rousseau. Nelle idee di Ba-
302
94 Si veda l'ancora fondamentale CURIEL, Il teatro San Pietro, cit., e V. LEVI, Cento-sessant'anni di vita artistica, in Il Comunale di Trieste, Del Bianco, Udine 1961, pp. 11-21; inoltre il rapido cenno in E. FERRARI-BARONI, Il melodramma negli altri centri nei se-coli XVII e XVIII in BASSO (a cura di), Storia dell'opera, cit., III, pp. 507-509.
95 E. RESCIGNO, Opera seria e opera buffa, in ID. (a cura di), Grande storia della mu-sica, cit., IV, pp. 36-37.
96 Arteaga Stefano, voce in Dizionario biografico degli italiani, III (1962), pp. 352-355.
97 Su padre Martini e sui caratteri della sua Storia della musica cfr. I. CAVALLINI,Padre G.B. Martini fra storia ed estetica: alcune osservazioni sulla « Storia della musica »,«Quadrivium », XXI (1980), pp. 169-183.
raux, che riteneva l'opera di Arteaga degna di tanta attenzione, si ri-trova dunque conferma della predilezione per l'opera italiana, per ilgluckismo e le teorie estetiche di Rousseau, desumibili anche dal ter-zo manoscritto, di poche pagine, dal titolo Quelques extraits sur lestheÂatres et les pieÂces dramatiques e che riteniamo di poter datare sem-pre al secondo decennio dell'Ottocento. Si trattava, evidentemente,di posizioni maturate attraverso autori del Settecento in un uomodel Settecento, che in quel secolo aveva vissuto la piena maturitaÁ fi-sica e intellettuale.
Ritornando specificatamente su questi manoscritti, Ivano Cavalli-ni ha osservato che « l'autore utilizza ad ampio raggio la trattatistica diRousseau, Arteaga e d'Alembert. Nel terzo manoscritto dopo l'esergovoltairriano (`̀ il faut se rendre aÁ ce palais magique''), induce agli idealipaideutici professati dall'Illuminismo, secondo una gradazione cheporta a scoprire il bello morale attraverso il bello fisico e intellettuale.Rivolgendosi specificamente alla musica in rapporto all'imitazione,Baraux individua le doti caratteristiche del dipingere e del commuove-re per mezzo di una mimesi naturalistica e simbolica. [...] Asserti chericorrono nel pensiero neoclassico di Carpani e Majer, i quali propon-gono gli accostamenti piuÁ vari tra arti figurative e musica. Ma la tem-pra razionalistica del testo in questione traspare nella opposizione alfatto che la musica possa rappresentare le idee; per Baraux essa eÁun semplice veicolo in grado di accrescere il potere emotivo della pa-rola, ma per se sostanzialmente vuota di significato. [...] Il tradiziona-lismo del fiammingo si evidenzia meglio allorquando deplora il `̀ pleo-nasma'' degli strumenti (sic), ossia l'introduzione massiccia di un ac-compagnamento orchestrale che conferisce al melodramma un esitoridondante. A questa considerazione vieta se ne accompagna un'altrameno scontata, con la quale Baraux riconosce essere avvenuta una`̀ modificazione del gusto'', grazie alle scuole strumentali tedesche.Per cui, senza mettere in dubbio il proprio retaggio intellettuale, egliritiene che la rivoluzione in atto abbia rovesciato il sistema dei valori,invertendo `̀ le facoltaÁ interne dell'uomo fino a creare in lui dei gustifittizi [...] diversi da quelli [...] conformi alla natura'' » 98.
303
98 CAVALLINI, Ricezione della musica classica e cultura a Trieste, cit., p. 68.
Abbiamo riportato questa lunga citazione perche conferma cheRousseau nelle teorie estetiche, come Montesquieu in quelle socialie politiche, eÁ il punto di riferimento nel panorama culturale di Ba-raux; non soltanto Rousseau musicista ma anche Rousseau educato-re, autore dell'EÂmile (1762) la cui lezione, influenzata da Montai-gne 99, risulta evidente nelle seguenti riflessioni manoscritte di Ba-raux che precedono un estratto sulla storia d'Inghilterra 100, intito-late Circa l'insegnamento e lo studio della storia:
«Nulla puoÁ riescire piuÁ infruttuoso che il modo di insegnare e distudiare la storia col caricare solamente la memoria con date, nomied evenimenti, ed il ripportare semplicemente queste cose eÁ da tallu-ni creduto sufficiente, cosõÁ un giovine vedendosi applaudito per laprontezza della sua memoria s'immagina giaÁ di essere un buon stori-co. Il vero uso della Storia non consiste nell'essere capace di fissareuna genealogia, di adure i fatti di un regno oscuro o la vera epoca diuna nascita contrastata, e la nozione de' fatti merita appena il nomedi scienza; il vero sapere consiste a distinguere e a rilevare gli efettidalle cause e chi giudica imparzialmente la Storia giudica ugualmentedegli uomini che ne sono gli ogetti. Il studiare la Storia ed il scruti-nare i motivi, le opinioni, le passioni degli uomini sviluppa i loro vizie le loro virtuÁ , l'impero delle passioni e le loro funeste conseguenze ».
« L'errore degl'instruttori eÁ di coltivare piuÁ la memoria de' loroallievi che il loro intendimento e la loro penetrazione, e di procurarglipiuttosto lodi per la prontezza di memoria che per un sano giudizio.Si considera di spesso la molteplicitaÁ de' fatti per un pascolo realedella mente e non come un oggetto proprio ad esercitare il giudizioparticolarmente quando le narrazioni sono piuÁ filosofiche che politi-che, ne risulta che la Storia serve allora ad eccitare la vanitaÁ promossadall'applauso degl'ignoranti ».
« Per ritrarre maggior vantaggio dalla storia ocorre di consultarei storici ne loro scritti originali e con discernimento per distinguere
304
99 Cfr. ROUSSEAU, Emilio, in ROSSI (a cura di), Opere, cit., soprattutto i libri II e IV,pp. 410 e 513-518 e M. DE MONTAIGNE, Saggi, tr. it., a cura di V. ENRICO, Casini, Roma1953, n. XXV (Dell'educazione), pp. 136-148, e n. XXVI (Dell'istruzione dei fanciulli),pp. 149-185.
100 Probabilmente una traduzione.
l'utile dall'inutile, per analizzare i diversi princõÁpi. Gli abbreviatori,compilatori, commentatori e critici sono in generale atti a empirela mente con cose aliene al vero scopo della storia e ad involgerelo spirito in ricerche inutili ed astratte ».
«Nell'immensitaÁ delle relazioni si deve scegliere i fatti che meri-tano di essere noti e che sevono all'istruzione. Lo scopo del lavoronon deve essere di conoscere in quall'anno pazzi o selvaggj hannocommesso le loro stravaganze ma bensõÁ con quali mezzi questi popolisi sono emersi dalla barbaria. EÁ anche necessario di conoscere le partiessenziali delle azioni che hanno costituito i migliori princõÁpi e diomettere e scordare quelle degl'ignoranti ed inerti che sembrano ad-dormentati nel rango al quale sono accidentalmente elevati; non eÁ lastoria dei reÁ , ma bensõÁ quella degli uomini che deve essenzialmenteinteressare, e questo si puoÁ soltanto acquistare dagli buoni autoricontemporanei che hanno descritto i fatti di quell'epoca ».
Di Baraux eÁ simpatico ricordare un episodio sempre legato allamusica e narrato da Alxander W. Thayer nella sua biografia di Lud-wig van Beethoven 101. Nel 1817 il grande compositore ebbe in donoun pianoforte dalla ditta John Broadwood di Londra, che venne in-viato al destinatario a Vienna via Trieste, in esenzione del dazio do-ganale su istruzione della Camera aulica. Il pianoforte rimase a Trie-ste per diverso tempo, in attesa dell'adempimento delle formalitaÁ bu-rocratiche, presso la ditta di F. E. J. Baraux. Molti anni piuÁ tardi,quando andava raccogliendo i materiali per la sua opera, Thayer tro-voÁ in un vecchio registro della ditta Broadwood di Londra l'annota-zione: «A 6 octave Grand P. R. Në 7362. tin and deal cases. ThoBroadwood Esq., marked VB care of F. E. J. Bareaux et Co. Trieste± a present to Mr. van Beethoven, Viene ».
Il nostro personaggio non fu peroÁ soltanto l'agiato borghese cheraggiunta la sicurezza economica e dopo un'ampia esperienza nellavita pubblica cittadina ebbe la possibilitaÁ di esprimere anche l'impe-gno culturale nel mondo delle lettere e delle arti. Per un altro motivopuoÁ essere individuato quale esponente tipico della borghesia tardo-
305
101 A.W. THAYER, Ludwig van Beethoven's Leben, II, Schneider, Berlin 1870, pp.80-82.
settecentesca nel Litorale Austriaco. Amico personale ed estimatoredi Domenico Rossetti, il difensore storico dell'autonomismo munici-pale nella prima metaÁ dell'Ottocento, Baraux ne divenne fiero con-traddittore sul piano intellettuale quando Rossetti diede alle stampeil manifesto della propria concezione politica, cioeÁ laMeditazione sto-rico-analitica sulle franchigie della cittaÁ e porto franco di Trieste 102.Un testo che aveva lo scopo di esporre le ragioni storiche che, nell'e-poca della Restaurazione, giustificavano il diritto della cittaÁ di Triestealla riconferma degli antichi privilegi statutari contro la politica degliAsburgo che consideravano invece la cittaÁ territorio di conquista.
Nelle corali manifestazioni di apprezzamento per quel volume, ilsolo che prese posizione contro il pensiero rossettiano fu Baraux. Ildocumento da lui preparato eÁ tanto piuÁ importante in quanto tradi-zionalmente le espressioni di una matura coscienza della borghesialocale sono state individuate nelle tarde Memorie (1863) di GiovanniGuglielmo Sartorio. Baraux espresse invece i medesimi concetti, voltiad un rinnovamento politico della cittaÁ e a respingere quelle che po-tevano essere interpretate come anguste chiusure legate all'ereditaÁstorica e municipalista, ben cinquant'anni prima di Sartorio.
CosõÁ, poco tempo dopo la pubblicazione delle Meditazioni rosset-tiane, Baraux prese a stendere un testo destinato alla stampa e poi ri-masto inedito forse a causa di un ripensamento dell'autore, con il titoloAlcune rimarche sopra le meditazioni storico-analitiche sulle franchigiedella cittaÁ, e portofranco di Trieste del Dottore Domenico Rossetti nobilede Scander, patrizio, ed avvocato triestino, membro dell'Accademia ita-liana, e dell'Arcadia Romano-Sonziaca, direttore e censore del Gabinettodi Minerva in Trieste, con alcuni estratti di quest'opuscolo per maggioreintelligenza de' lettori 103. Terminato nel 1816, trascritto da un copistae nuovamente corretto da Baraux, il testo non venne trasmesso alla ti-pografia e rimase fra le carte dell'amico Giuseppe de Lugnani.
Con abbondanza di documentazione e adottando il sistema reto-rico di utilizzare le stesse fonti proposte da Rossetti, Baraux si diede a
306
102 D. ROSSETTI, Meditazione storico-analitica sulle franchigie della cittaÁ e porto-fran-co di Trieste, Picotti, Venezia 1814.
103 Il manoscritto si trova in BCTs, segn. R.P. MS MISC. 87/XVII.
confutare con vigore passo a passo il contenuto delle Meditazioni,per dimostrare l'assoluta inconsistenza della teorizzata autonomiamunicipalistica, storicamente non necessaria e comunque non meri-tata dai triestini. Rivendicava alla borghesia, ai «mercanti » immigratinel Settecento, il merito di aver fondato la cittaÁ nuova dandole vita eimportanza mentre i triestini originari ± il cui governo Rossetti avreb-be voluto restaurare ± non solo erano rimasti arroccati su posizioniantiquate e retrospettive, ma anzi avevano combattuto le novitaÁ , ilprogresso, minacciando l'esistenza della cittaÁ e il suo ruolo europeo.
Baraux contestava cosõÁ la rappresentativitaÁ del Consiglio dei Pa-trizi, del quale Rossetti voleva il ripristino, osservando come non fos-se il difensore degli interessi dell'intera cittadinanza, ma soltanto diuna ristretta oligarchia che formava « la piccolissima, e quasi insigni-ficante parte della popolazione » 104. Replicava alle affermazioni ros-settiane, secondo cui nell'imminenza dei conflitti i commercianti fug-givano sempre dalla cittaÁ , dimostrando disaffezione verso la patria ac-quisita 105: «Quest'ultimo asserto eÁ smentito dal fatto, e si puoÁ contutta franchezza sfidare l'Autore a citarne dell'esempi nei Negoziantiall'ingrosso, tranne un solo vecchio, celibe e infermiccio che, ritiratosidal commercio, andoÁ a terminare i suoi giorni alla patria. La primaparte di questo paragrafo eÁ una maligna, pungente ed impropria al-lusione alli Negozianti emigrati da Trieste all'epoca dell'invasionefrancese; e gli abitanti non avrebbero mai potuto opporsi efficace-mente all'ingresso del nemico. Questi emigrati si rifugiarono quasitutti nelli Stati Austriaci, onde sottrarsi alle angarie, alle rapine, e si-stema spogliatore de' francesi. CosõÁ facendo, hanno conservato lamaggior parte delle sostanze seco loro portate, le quali sarebbero sta-te egualmente soggette alla rapacitaÁ francese, senz'alleggerir il pesoche gravita sopra la popolazione, poiche piuÁ danari, merci, effettied individui contribuibili i francesi avrebbero trovato, e piuÁ forti sa-rebbero state le contribuzioni. Questi emigrati hanno in'oltre salvati iloro figli dalla coscrizione militare e dal pericolo di combattere forsecontro il proprio legittimo sovrano. Sono poi tornati all'ingresso delle
307
104 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 4r.105 ROSSETTI, Meditazione storico-analitica, cit., p. 139.
truppe imperiali, o con la pace; e la loro dispendiosa emigrazione nonli ha percioÁ sottratto al peso delle contribuzioni, requisizioni etc. per-che al loro ritorno essi sono stati obbligati di pagare la loro tangenteal pari di tutti gl'altri abitanti. Oltre cioÁ , il Magistrato prende ancorale opportune misure per far pagare il piccolissimo numero d'emigratinon ritornati, quantunque fossero stabiliti nelli Stati esteri. L'Autoredeve saperlo meglio d'ogni altro, perch'egli eÁ uno de' piuÁ zelanti e piuÁattivi membri della Commissione ratatrice e liquidatrice ».
Poi commentava il rescritto del 1673 con il quale, per favorire ilcommercio dei triestini, era stato disposto « il congedo » di tutti glistranieri che operavano a Trieste:
« EÁ quasi certo che quest'impolitica misura fu promossa dall'in-vidia delli antichi triestini, li quali sperimentando in quelli forestieriun'industria, un'attivitaÁ , ed una perspicacitaÁ ch'essi sentivansi inca-paci d'imitare, hanno cercato d'allontanare questi pericolosi rivalisenz'avere lo spirito, ne il coraggio d'imitarli. Dopo cosõÁ numerosee parziali concessioni, esenzioni, privilegi, franchigie e favori accu-mulati sotto il progressivo reggime di quattordici Sovrani dell'Austrianel lunghissimo spazio di 335 anni; e dopo aver avuto costantementesott'occhio li inimitabili ed eccitanti esempi d'industria ed attivitaÁ , edel prodigioso ingrandimento del commercio e della navigazione de'veneziani, de' genivesi e de' toscani, cosa hanno fatto li patriarcali(espressione caratteristica, prediletta dell'Autore ch'egli replica invarj luoghi; che noi ripeteremo pure, e forse con eccedente affezione)triestini per tre interi secoli? Lo stato meschino della loro cittaÁ , il pic-colo numero della sua popolazione all'epoca del 1717 e la necessitaÁin cui si eÁ allora trovato l'Imperatore Carlo VI: di richiamare i fore-stieri, provano abbondantemente la loro perfetta nullitaÁ manifestatasinon solo nel commercio, nella navigazione e nell'industria, ma benanco nelle arti, nelle scienze e nella letteratura; ed erano per finomancanti de' necessari artisti » 106.
CosõÁ proseguiva: « Li triestini si sono concentrati nel loro nulla,contenti di godere tranquillamente ed in seno ad un ozio tutto pa-triarcale li beneficj ed i favori de' quale sono stati colmati, senza por-
308
106 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 6r.
tare allo Stato alcuno di que' vantaggi che questo avea diritto di ri-promettersi da una popolazione cosõÁ segnalatamente favorita in tuttili rapporti e come sarebbe avvenuto s'essa si fosse dedicata al com-mercio ed alla navigazione con quell'industria ed attivitaÁ che ne assi-curano il successo mediante una cosõÁ felice posizione geografica cheforma un punto centrale pel commercio fral vasto Impero Austriacoe l'ubertosa Italia, oltre le comunicazioni maritime, aperte con tutti lipaesi, mediante le quali lo Stato ricava li piuÁ importanti vantaggi perle occorrenti importazioni dall'origine e per lo sfogo nell'estero de'suoi prodotti industriali e naturali » 107.
Premesse queste osservazioni generali che chiarivano la sua posi-zione e indicavano pure lo spirito dei non pochi interventi pubblicida lui promossi negli anni precedenti in difesa della cittaÁ e del suocommercio, Baraux scendeva nell'analisi dei singoli problemi. Primofra tutti, ed eÁ comprensibile, quello del rapporto fra commercio ecultura e della loro pretesa inconciliabilitaÁ . Notava quanto scarsa fos-se stata fino a tutto il Seicento l'attenzione per le forme della culturada parte dei triestini: «Da cioÁ devesi arguire che i triestini abbianosempre avuta la stolta credenza che le lettere, le scienze, le arti edil commercio sian cose superflue ed inconcludenti per la vita civilee morale, e che basti applicarsi alle patriarcali cose domestiche ed al-l'economia rurale, sempre limitata peroÁ all'antica pratica, senza cu-rarsi nemmeno del modo di migliorarla » 108.
Quindi considerava la memoria e la sensibilitaÁ storica dei triestinirispetto alle concessioni sovrane: « L'Imperatore Carlo VI: sovranoilluminato, seppe conoscere ed apprezzare la felice situazione geogra-fica di Trieste per formare di questa cittaÁ il punto centrale d'un este-so commercio marittimo e continentale, da diramarsi in tutte le partidella Germania, dell'Ungheria, della Polonia ecc. ecc., onde sommi-nistrare a quelle contrade i prodotti del suolo e dell'industria germa-nica. Ma l'Imperatore Carlo VI dovea essere convinto dell'esperienzadi tre secoli e piuÁ che li triestini erano troppo inetti ed infingardi permettere a profitto tanti privilegi, franchigie e favori successivamente
309
107 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 7r.108 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 8r.
concessi e per corrispondere al loro scopo; percioÁ saggiamente si de-terminoÁ a richiamare a Trieste i forestieri dichiarandola porto francocon patente 2 luglio 1717: ma chi crederebbe poi che a tanto giun-gesse la non curanza dei triestini, che invece di conservare gelosa-mente l'originale di un documento tanto essenziale, interessante eprezioso, dovesse anzi andare smarrito; a segno tale che l'Autore del-le Meditazioni storiche, quantunque patrizio, avvocato ed anche ag-giunto al Presidente del governo provvisorio sotto il dominio france-se, non eÁ stato capace di rinvenire nemmeno una sola copia ne' pub-blici e privati archivi della cittaÁ : non sarebbe questo un segnoevidente del dispetto che li triestini provavano nel vedere il richiamode' forestieri e di nuovi favori di cui si sentivano incapaci di appro-fittare? » 109.
Qui Baraux giungeva al cuore dell'argomento che piuÁ gli interes-sava. Chi aveva fondato la nuova Trieste? Chi aveva fatto tesoro deiprivilegi sovrani? Chi aveva rischiato le proprie fortune e spesso lapropria vita, rinunciando alla terra d'origine per affrontare l'ignoto?Chi aveva sollecitato il progresso, il rinnovamento sociale e anche po-litico? Erano stati i «mercanti », rispondeva Rossetti, senza prosegui-re oltre. Allora Baraux: «Ma: chi erano questi mercanti? Certamentenessun patriarcale triestino, ma tutti forestieri. Essi stabilirono inoltrele tanto rinomate fabbriche di sapone, di rosolio, di filati rossi ad usodi Smirne; di cordaggi, di tele lunette; le raffinerie de' zuccheri edalcune fabbriche di minore importanza; cioeÁ quelle di maiolica aduso inglese, di biacca cremor tartaro e teracca ad uso di Venezia;di verderame e di verde eterno, di paste ad uso napoletano, di con-fetture e canditi ad uso genovese, di rum, delle concerie di pellamietc.; tutti generi d'industria, alle quali li patriarcali triestini non hannomai saputo pensare ed alli quali non ebbero ne arte, ne parte » 110.
Assai piuÁ grave e importante era peroÁ l'altro argomento partico-larmente sentito da Baraux, cioeÁ la tradizionale opinione che ai nobilispettasse vivere di rendita e ai borghesi competesse il commercio,senza possibilitaÁ di accedere ai gradi della nobiltaÁ . Per Baraux il tema
310
109 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 10r.110 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 11r.
non poteva essere trascurato: « per quanto sia vantaggioso e onorevo-le lo stato del negoziante e per quante risorse presenti il commerciodi Trieste, nulla valse per scuotere la patriarcale indolenza dei suoiantichi abitanti, ne per inspirare loro una nobile emulazione per con-tribuire alla prosperitaÁ , al lustro della loro patria, al bene della Mo-narchia e del sovrano medesimo, ed a migliorare nello stesso tempola loro piuÁ o meno mediocre fortuna. Infatti, eÁ quasi incredibile peroÁeÁ verissimo, che nessun individuo delle antiche famiglie triestine sitrova nel numero de' negozianti all'ingrosso e ne fa prova la matrico-la esistente presso il Tribunale mercantile e nell'officio di Borsa. Cre-devano forse, nella loro ignoranza, questi triestini che la condizionedi negoziante degradar potesse la loro condizione? Eglino avrebberoben potuto conoscere l'apposito decreto aulico, emanato da MariaTeresa li 19 novembre 1781, esteso ne' seguenti termini: `̀ Sua MaestaÁsi eÁ compiaciuta d'abassare la graziosissima dichiarazione che Ellaconsidera in generale non essere i negozi all'ingrosso sotto la dignitaÁdella primaria nobiltaÁ '' » 111.
Baraux era evidentemente sensibile al dibattito ancora diffusosulla natura e sulle funzioni della nobiltaÁ 112 e doveva avere letto pureil celebre scritto di Coyer su La noblesse commercËante del 1756; inpiuÁ si riferiva indirettamente anche alla propria condizione, ne si eÁlontani dal vero quando si afferma che lui stesso, che tanto aveva fat-to per una cittaÁ che sentiva come propria, avrebbe desiderato un ri-conoscimento delle sue fatiche in forma di titolo nobiliare. « Si vedo-no in tutti li Stati » ± proseguiva ± « de' negozianti che si sono distintinel commercio, inalzati dal Sovrano al grado di nobiltaÁ ed anche pro-gressivamente elevati alli gradi di barone e di conte, ma nulla sin'orapote risvegliare li antichi triestini dal loro vergognoso letargo, ne trar-li dalla loro nullitaÁ nella quale si trovavano insempiati » 113.
Criticava poi uno dei concetti rossettiani piuÁ dibattuti, anche nel-la storiografia recente, quello cioeÁ del commercio artificiale: « questo
311
111 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 15r.112 C. DONATI, L'idea di nobiltaÁ in Italia, secoli XVI-XVIII, Laterza, Roma-Bari
1988, pp. 291-366.113 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 16r.
commercio che l'Autore chiama artificiale eÁ unicamente conosciutoda tutta l'Europa sotto il nome di commercio d'ecconomia, che consi-ste nel supplire una nazione di cioÁ che gli occorre de' prodotti diun'altra e cosõÁ viceversa; e facendo contemporaneamente un estesocabotaggio, questo, e la pesca furono da bel principio il solo com-mercio dell'Olanda e fu quello che le aprõÁ la strada a quell'immensogrado di prosperitaÁ e di possanza che le procuroÁ ne' secoli passati ildominio del mare » 114.
Dal punto di vista politico il commerciante di Anversa giudicavairrealizzabile e inutile, nonche addirittura nocivo, il municipalismo diRossetti: « l'Autore per i suoi princõÁpj anteporrebbe all'utilitaÁ delcommercio gli antichi privilegi ed alcune rancide ed inutili preroga-tive, de' vani e inconcludenti diritti che neppure sono piuÁ adatte ne aitempi in cui viviamo, neÂagl'usi e costumi presenti, neÂal sistema attua-le del governo austriaco; ed ecco in che fa egli consistere l'anticivismoche produsse de' tristi effetti: e ne produrraÁ forse de' peggiori, senza pe-roÁ accennare quali siano questi funesti effetti e quali que' peggiori datemere. Dopo che l'Autore fece a pag. 186, 187 e 188 il piuÁ giustoencomio delle luminose viste di Giuseppe II, delli sentimenti piuÁ li-berali e dello spirito con qual'Egli volea far eseguire l'amministrazio-ne pubblica; dopo aver riconosciuto, ch'egli sempre agõÁ per l'unitaÁdel governo, qual base della forza dello Stato, che la sua principale ten-denza era di accomunare tra i sudditi suoi li diritti, i doveri ed i co-stumi e di ridurre ad un tutto sistematico; come l'Autore puoÁ sognar-si ancora di voler sempre ristabilire in Trieste l'antica sua costituzio-ne? » 115. L'iniziativa si sarebbe rivelata ancora piuÁ irrealizzabile inquanto « le basi di questo tanto celebrato vetusto Statuto che l'Auto-re vorrebbe ancora rivendicare consistono essenzialmente nelle anti-che attribuzioni del maggior Consiglio de' Patrizi » 116. Basi che rive-
312
114 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 17r. Queste osservazioni peraltro tradisco-no le letture liberiste del nostro personaggio e, in particolare, delle pagine di An Inquiryinto the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) di Adam Smith che nel pa-ragrafo V del secondo libro, sull'impiego dei capitali, si era soffermato specificamentesulla differenza tra commercio estero di consumo e commercio interno di economia.
115 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 21r.116 BARAUX, Alcune rimarche, ms. cit., c. 28r.
lavano nella loro natura l'incompatibilitaÁ con i tempi moderni, con iprincõÁpi del progresso sociale (non esclusi i fondamenti costituzionaliconquistati in Europa con la Rivoluzione francese) e con la necessitaÁsempre presente di superare ostacoli artificiosi che precludessero laproiezione di Trieste sulla realtaÁ europea.
Non pubblicoÁ Baraux queste sue Rimarche, che certamente per iltono e per i contenuti avrebbero causato grande scompiglio nella so-cietaÁ triestina del tempo, procurandogli l'inimicizia di molti. Il fattoperoÁ che le sue osservazioni furono scritte e meditate nel momento incui era piuÁ intenso il dibattito sull'avvenire della cittaÁ e del LitoraleAustriaco eÁ prova della sensibilitaÁ e della coscienza civile che stavamaturando nel ceto mercantile, motore di nuove forme di convivenzasociale.
313
XI. - CENSURA E POLITICA DOPO LA RESTAURAZIONE
Quanto potesse risultare ambiguo il rapporto tra censore ed editoree tra censore e lettore lo lasciava intendere giaÁ Malesherbes ± il direttoredella Librairie parigina ± nel 1775, quando incoraggiava la pratica delle« autorizzazioni tacite » per pubblicare libri che non era opportunoproibire, perche soddisfacevano i gusti della societaÁ francese, ma chenon era possibile autorizzare, per la severitaÁ della legge sulla stampa 1.
Se nella Francia prerivoluzionaria si era giunti ad un tale livellodi raffinatezza politica di fronte ad una censura divenuta ormai quasiesclusivamente di Stato 2, e mentre nella penisola italiana rimanevaancora la necessitaÁ di confrontarsi con il dualismo rappresentato dal-la coesistenza della censura ecclesiastica con quella civile, diversa sipresentava la situazione nella monarchia e nei domini italiani di casad'Austria. La censura preventiva venne in gran parte ridimensionatanell'etaÁ di Giuseppe II, aprendo l'epoca della cosiddetta « libertaÁ distampa » che sarebbe durata, con situazioni alterne, sino alla fine delsecolo 3. PuoÁ essere questo uno dei motivi per cui, rispetto alla sto-
314
1 R. CHARTIER, Le origini culturali della Rivoluzione francese, tr. it., Laterza, Roma-Bari 1991, p. 51.
2 Si vedano gli esempi forniti da A. DE BAECQUE, Le commerce du libelle interdit aÁParis(1790-1791) e da L. ANDRIES, Les imprimeurs libraires parisiens et la liberteÁ de la presse(1789-1795), «Dix-huitieÁme sieÁcle », 21 (1989), rispettivamente alle pp. 233-246 e 247-261.
3 Si veda sul periodo F. WERNIGG, Bibliographie oÈsterreichischer Drucke waÈhrendder « erweiterten Pressfreiheit » (1781-1795), Jugend und Volk, Wien-MuÈnchen 1973.
riografia francese ed italiana che si sono concentrate prevalentementesulla censura settecentesca, quella austriaca ha spostato piuttosto l'at-tenzione verso l'etaÁ della Restaurazione e il periodo del VormaÈrz 4.Nello spazio asburgico la materia venne riordinata con la Zensurord-nung del 1795 anche se, fino al secondo decennio dell'Ottocento,l'attenzione dei censori si diresse quasi esclusivamente verso la pro-duzione libraria esterna agli Stati ereditari. Solo dopo la caduta diNapoleone l'attivitaÁ degli uffici di censura interessoÁ piuÁ direttamenteuna produzione editoriale interna sempre piuÁ copiosa e politicamen-te piuÁ rilevante.
Ne sapeva qualcosa NiccoloÁ Tommaseo che, dalle pagine delDiario intimo, rivelava quanta cura avesse nell'intrattenere relazionipersonali e di amicizia con i censori veneti Brambilla e Pianton, neglianni intorno al 1840, nonostante i rapporti spesso conflittuali con leautoritaÁ di governo austriache 5.
Nei domini italiani di Casa d'Asburgo non ci si pote ad ogni mo-do giovare tanto rapidamente di atti legislativi simili alla legge fran-cese del 1828 o all'editto del marzo 1848 che soppresse la censurapreventiva in Piemonte 6. Anzi, dall'esame degli archivi di polizia sipuoÁ evincere che l'attivitaÁ repressiva fu intensa, al pari della censurapreventiva. Ciononostante l'argomento eÁ stato completamente igno-rato negli studi riguardanti il Litorale Austriaco, se si eccettuano in-dagini particolari relative peroÁ ad epoca piuÁ tarda ± soprattutto lametaÁ del XIX secolo 7 ± e singole situazioni giudicate di specifico in-teresse anche alla luce di avvenimenti politici piuÁ recenti. Tanto per ilXVIII secolo quanto per il XIX secolo si attendono ancora sondaggi
315
4 W. DUCHKOWITSCH, Die verhinderte Pressefreiheit: Privileg und Zensur als Instru-mente von Kommunkationspolitik vor 1848, in 200 Jahre Tageszeitung in OÈsterreich1783-1983. Festschrift und Ausstellungskatalog, Verband der OÈ sterr. Zeitungsherausge-ber und Zeitungsverleger, Wien 1983, pp. 55-86.
5 N. TOMMASEO, Diario intimo, in ID., Opere, a cura di M. PUPPO, II, Sansoni, Fi-renze 1968, pp. 826, 831, 838, 899.
6 G. RICUPERATI, I giornalisti italiani dalle origini all'UnitaÁ, in C. VIVANTI, R. ROMA-
NO (a cura di), Storia d'Italia. Annali 4, Intellettuali e potere, Einaudi, Torino 1981, p.1130.
7 Tipico il caso di G. QUARANTOTTO, « La Favilla » e la polizia austriaca, « Archeo-grafo Triestino », s. III, XVI (1931), pp. 199-214.
archivistici e interventi analitici che possano proficuamente rendereconto del considerevole patrimonio documentario e bibliografico.
In rapido esame delle situazioni specificamente attinenti al Lito-rale Austriaco e all'Istria, le vicende della censura politica ottocente-sca paiono di maggiore interesse rispetto a quelle del Settecento.Non che manchino del tutto ± per il XVIII secolo ± motivi di inda-gine storiografica; tuttavia la relativa limitatezza della produzioneculturale, concentrata soprattutto sugli scritti letterari e storici anzi-che su quelli politici, e il regime tutto sommato « liberale » della cen-sura nel Litorale in quel periodo indurrebbero a volgere l'attenzionestoriografica verso altri ambiti cronologici.
Censura e politica, viceversa, furono in stretta connessione dopola Restaurazione. Non solo per le mutate condizioni politiche si fece-ro sentire piuÁ penetranti i poteri dello « stato di polizia » (il Litoralefu considerato territorio di « conquista » e come tale limitato in quel-la autonomia che aveva goduto tra gli stati ereditari asburgici nel Set-tecento), ma pure venne a crearsi una situazione del tutto atipica ri-spetto alle tradizionali aree di influenza dell'amministrazione statale edelle stesse forme della cultura. Scomparsi infatti nell'Istria gli ultimiresidui del governo veneto e ricondotta la penisola all'unitaÁ ammini-strativa, cancellata dalla geografia politica l'egemonia della Repubbli-ca di San Marco per dare spazio, lõÁ pure, al dominio austriaco 8, leterre dall'Adige all'Isonzo all'Arsa vennero a trovarsi sotto il medesi-mo governo asburgico. Il Veneto, il Litorale Austriaco e l'Istria di-vennero parte di una stessa entitaÁ statale in cui coesistevano manife-stazioni della cultura, contrapposizioni regionali e tradizionali formedi incomunicabilitaÁ (tipico il caso di Venezia e Trieste, dovuto peroÁessenzialmente a motivi commerciali e non esente da luoghi comu-ni) 9. Queste e altre riflessioni sono state nuovamente sollecitate da
316
8 Negli ultimi vent'anni il periodo della dominazione austriaca nel Veneto e a Ve-nezia eÁ stato oggetto di nuova attenzione: cfr. A. ZORZI, Venezia austriaca 1796-1866, La-terza, Roma-Bari 1985; S. MARINELLI, G. MAZZARIOL, F. MAZZOCCA (a cura di), Il Venetoe l'Austria. Vita e cultura artistica nelle cittaÁ venete 1814-1866 (catalogo della mostra),Electa, Milano 1989; G. MONTELEONE, Aspetti economici e sociali di Padova durante ladominazione austriaca (1814-1866), « Archivio Veneto », V s., CXIX (1988), pp. 57-101.
9 Nuove puntualizzazioni in SALIMBENI, Trieste tra Venezia e Vienna, cit.
piuÁ recenti indagini che hanno fornito un nuovo contributo per lostudio dell'Ufficio centrale del R. Dipartimento di Censura, l'organoistituito dopo la Restaurazione per il controllo della censura nel Ve-neto, nel Litorale Austriaco e nell'Istria 10.
Creato nel 1815, l'Ufficio centrale del Regio Dipartimento diCensura di Venezia (dipendente dall'I.R. Governo) ebbe sottoposticensori provinciali a Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso e Udine purassumendo, per funzioni e finalitaÁ , caratteri di sovrintendenza rispet-to a tali organi periferici. La competenza per territorio non era limi-tata alle sole province venete. Fin dalla sua istituzione, infatti, l'uffi-cio ebbe competenza territoriale tanto sul Veneto quanto sul Friuli,sul territorio dell'antica contea di Gorizia e Gradisca, sul LitoraleAustriaco, sull'Istria giaÁ veneta e su quella interna, sulla Dalmazia.Veniva realizzato cosõÁ un disegno organizzativo fondato su un model-lo di accentramento, onde garantire un controllo qualitativamenteuniforme per tutto il territorio. Per quanto riguardava la censura po-litica, invece, esisteva un modello di decentramento a mezzo dei go-verni locali, onde assicurare un controllo capillare e tendenzialmentepiuÁ rigido. Giova ricordare, d'altra parte, che tale sistema trovoÁ ap-plicazione soltanto parziale a Trento, ove vigeva la patente imperialedel 1816 che attuava una forma di decentramento ancora piuÁ accen-tuata, probabilmente in omaggio all'antica tradizione del principatovescovile 11.
L'attenta distribuzione delle competenze realizzava un sistematendenzialmente completo. Poteva accadere, cosõÁ, che il Dipartimen-to di censura veneziano, ricevuto un manoscritto giudicato di argo-mento politico e ritenuta la propria incompetenza in materia, rinvias-se la decisione all'autoritaÁ di governo periferica, limitando ove occor-resse il proprio giudizio ai contenuti meramente storici o letterari.
Il procedimento per sottoporre alla censura veneziana i mano-scritti destinati alla stampa consisteva anzitutto nella presentazione
317
10 G. BERTI, Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione, Depu-tazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1989.
11 U. CORSINI, Il controllo dell'opinione pubblica, della diffusione delle idee e dottrineliberal-nazionali e comuniste nel Trentino negli anni 1831-1847, in Festschrift RichardBlaas, «Mitteilungen der oÈ sterreichischen Staatsarchivs », 31 (1978), pp. 196-208.
del manoscritto, in duplice o singola copia 12, all'Ufficio di Revisione,dal quale potevano essere formulati diversi giudizi. In senso positivo,con il semplice admittitur, con il permittitur (per la pubblicazione diopera con luogo di stampa estero o inesistente), con il tolleratur(quando la pubblicazione era ammessa ma se ne vietava l'annuncionei giornali). Mentre in senso negativo il giudizio era formulatocon il semplice non admittitur e con il typum non meretur (quandosi sindacava sul valore scientifico o letterario dell'opera). La pubbli-cazione poteva essere autorizzata, inoltre, con la condizione della ret-tifica di taluni passi: imprimatur omissis deletis, mutatis mutandis, cor-rectis corrigendis; tale procedura valeva tanto per le opere originaliquanto per le ristampe, anche se per queste nel tempo furono ema-nate diverse disposizioni 13.
Quanto alla competenza per materia, il controllo del Diparti-mento veniva esercitato su tutti gli scritti di argomento « letterario »,di interesse cioeÁ scientifico, storico, artistico e letterario in senso pro-prio. Particolarmente importante era il disposto dell'art. 11 del Pianodi censura, in cui si prevedeva che gli scritti di carattere politico, an-che quando ritenuti pubblicabili dal censore, dovevano essere sotto-posti al giudizio dell'Imperial Regio Governo, mentre nei casi piuÁgravi l'opera era inviata al Supremo Aulico Dicastero di Polizia edi Censura. Con tale struttura il governo austriaco della Restaurazio-ne venne a imporre un filtro alla cultura nel Veneto, nel Litorale enell'Istria con l'ottica di una politica paternalistica non estranea aistanze « illuminate » e « liberali », ma spiccatamente anti-illuministi-che e reazionarie, volte a rinsaldare il legame con l'etaÁ del dispotismoilluminato superando gli incidentali esiti del giacobinismo rivoluzio-nario. E a questo riguardo basta scorrere l'elenco degli autori dellecui opere era controllata la diffusione: Rousseau, Voltaire, Diderot,Beccaria, Condillac, ecc.
Assai diversa era invece la natura dell'intervento degli organi dipolizia, che assolveva non a una funzione preventiva ma repressiva.
318
12 BERTI, Censura, cit., pp. 1-76, dove spiega il funzionamento del Dipartimento diCensura.
13 BERTI, Censura, cit., p. 5.
In effetti, soprattutto nei territori come il Litorale, l'Istria e la Dalma-zia dove la produzione tipografica si mantenne entro livelli abbastan-za modesti fino al 1848, l'esercizio della polizia continuoÁ ad esserediretto soprattutto contro l'importazione di libri dall'estero. Si tratta-va, tra gli anni Venti e Trenta, per lo piuÁ di scritti carbonari ± diffu-sissimo era il Catechismo dei carbonari ± che giungevano in Dalmaziaper la via di Napoli 14. Cadevano nelle maglie della censura ancora iphilosophes francesi, da Montesquieu a Rousseau, da Voltaire a Mo-lieÁre, cosõÁ come gli autori del Romanticismo tedesco e le opere diMazzini, i cui testi figurano costantemente negli elenchi dei libri proi-biti dagli organi di governo periferici della Dalmazia 15.
Il settore della produzione libraria dalmata interessato per primodalla censura preventiva fu quello dell'erudizione storica. Un casoparticolare fu quello delle Memorie per la storia della Dalmazia diGiovanni Creglianovich Albioni, stampate in due volumi nel 1809,cadute nelle maglie della censura di polizia dopo la Restaurazioneperche ritenute pregne di idee francofile. Pure Francesco Zavoreo,come le sueMemorie statistiche (1821), Donato Fabianich, con i Cen-ni sulla scienza e letteratura de' secoli passati in Dalmazia (1841), Ni-coloÁ Giaxich, con il Saggio di memorie dalmatiche (1848) ed altriautori dovettero passare il filtro del censore politico di Zara, cui fu-rono rimandati dall'Ufficio di Censura veneziano, a dimostrazione diun controllo sempre piuÁ ferreo 16. Lo sapeva bene Tommaseo, pur
319
14 A. STIPCÂ EVICÂ , Libri dei carbonari italiani proibiti dalla censura austriaca in Dalma-zia, in G. PADOAN (a cura di), Istria e Dalmazia nel periodo asburgico dal 1815 al 1848,Longo, Ravenna 1993, pp. 69-74.
15 Cfr. I. PEDERIN, Odnos austrijske cenzure prema evropskim knijzÏevnostima, filozo-fij, novinstvu i politicÏkoj ideologiji (= I rapporti della censura austriaca con la cultura eu-ropea, con la filosofia e l'ideologia politica), « Zbornik Matice srpske za knijzÏevnost i je-zik », 32, 2 (1984), pp. 201-228; ID., Utjecaj austrijske cenzure na prodaju, sÏirenje i rek-lamiranje knijga 1810-1848 (=L'influenza della censura austriaca sul commercio, ladiffusione e la divulgazione del libro), « Bibliotekarstvo », 31 (1982), pp. 23-33; ID., Au-strijska cenzura od 1810. do 1848. i njezin utjecai na razvitak knijzÏmica u Dalmacij (= Lacensura austriaca tra il 1810 ed il 1848 e la sua influenza nello sviluppo delle biblioteche),« Vjesnik bibliotekara Hrvatske », 30 (1987), pp. 19-44; ID., Dalmatinski pisci, urednici icitateli u ocÏima austrijske cenzure (=Scrittori dalmati, curatori e redattori nell'occhio dellacensura austriaca), «Dubrovnik », 31, 3-4 (1988), pp. 5-22.
16 PEDERIN, Dalmatinski pisci, cit., p. 16.
oscillante nei giudizi tra la critica a una censura « stolida vessatrice »e l'idea di una censura sostanzialmente « liberale » 17. Apparentemen-te i pareri dei censori seguivano criteri consolidati. Mentre infatti al-cuni volumi dal contenuto non certo innovatore come quelli del ve-ronese, naturalizzato zaratino, don Pietro Bottura venivano approvatisenza riserve dalla censura veneta per la loro impostazione antimate-rialista 18, gravi difficoltaÁ incontroÁ invece Tommaseo nella pubblica-zione dei Nuovi scritti, presentati al censore fin dal 1837, e di Iskrice(= Scintille, 1845). Per quest'ultimo, dopo il non admittitur del cen-sore politico di Zara, Tommaseo pote fortunosamente approfittaredella « disattenzione » del censore greco-ortodosso di Budapest edottenere cosõÁ il visto per la stampa 19.
Conobbe viceversa vicende meno tempestose la pubblicazionedell'altro volumetto di Tommaseo, Intorno a cose dalmatiche e triesti-ne (1847), una raccolta di testi giaÁ apparsi negli anni precedenti epercioÁ giaÁ usciti dalle maglie della censura. Tanto che l'edizione fuassunta dalla tipografia del Lloyd Austriaco e il ricavato della venditavenne destinato a scopi di beneficenza 20.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'attenzione dei censori sisforzava di cogliere piuÁ che disegni politici evidenti, le tracce di cri-tiche larvate che potevano essere contenute in rievocazioni nostalgi-che del governo veneziano, anche se poi cioÁ non comportava neces-sariamente la reiezione dell'intera opera ma solo l'eliminazione deipassi incriminati 21. La situazione era destinata peroÁ a conoscere ra-pidi mutamenti tra la fine degli anni Venti e la metaÁ degli anni Qua-ranta. All'infittirsi della stampa periodica, con l'aumento notevole deiquotidiani, coincise una circolazione delle idee politiche non piuÁ li-
320
17 R. CIAMPINI, Un conflitto del Tommaseo con la censura e il discorso all'Ateneo diVenezia, « Rassegna Storica del Risorgimento », XXV, 3 (1983), pp. 692-695.
18 BERTI, Censura, cit., p. 428.19 I. ZINGARELLI, NiccoloÁTommaseo e la censura austriaca, « Rivista d'Italia », XXIX
(1926), pp. 170-189.20 N. TOMMASEO, Intorno a cose dalmatiche e triestine, scritti, Papsch & C.-Tip. del
Lloyd Austriaco, Trieste 1847.21 Sul punto si veda anche la recensione di C. GHISALBERTI a BERTI, Censura, cit.,
apparsa in «Clio », XXVII, 1 (1991), pp. 175-176.
mitata ai ceti colti ma diffusa in fasce sempre piuÁ ampie della popo-lazione. Di fronte all'allargarsi dell'opinione pubblica e all'incremen-to della produzione tipografica la censura preventiva venne perden-do spazio, per la difficoltaÁ di assolvere a compiti sempre piuÁ vasti. Adessa rimase affidato percioÁ soprattutto il controllo dei giornali politicie, in materia di libri, si rafforzarono invece le funzioni di repressioneconnesse all'esercizio della polizia. Si ha conferma, in ogni caso, cheil periodo qualitativamente piuÁ significativo dell'attivitaÁ censoriacoincise con i moti del 1848 e raggiunse in Dalmazia uno dei momen-ti di massima intensitaÁ negli anni Sessanta specie dopo lo scioglimen-to del Consiglio comunale di Spalato 22. Per il periodo compreso trail 1814 ed il 1848, invece, si possiedono elenchi dei libri proibiti, masi tratta quasi esclusivamente di titoli desunti dalle circolari inviate intutte le regioni dell'Impero e riguardanti opere stampate all'estero,che poco informano sulla produzione locale 23.
Nell'Ufficio di Censura a Venezia i censori, quattro fino al 1822e poi tre (fra essi un direttore), erano persone accuratamente scelteper capacitaÁ personali, per fedeltaÁ al governo austriaco e per compe-tenze in campo letterario. Potevano essere funzionari dello Stato odocenti universitari, in quanto la carica di censore era considerata« accessoria » e potevano svolgere il lavoro nella propria abitazione.PiuÁ spesso peroÁ erano ecclesiastici e anche a Trieste il censore poli-tico fu un sacerdote poi asceso alla cattedra vescovile 24. Tra i censoriveneti va anzitutto ricordato Bartolomeo Gamba, il primo direttore(dal 1815), sollevato dall'incarico nel 1824 per avere ammesso allastampa uno scritto di G. M. Contarini, giaÁ accusato di peculato dalla
321
22 L'eco di quegli avvenimenti sollecitoÁ pure l'attenzione della censura nel Litorale,specie verso l'opuscolo di G. DEGLI ALBERTI, Memoria intorno allo scioglimento del con-siglio di Spalato; cfr. ASTs, I. R. Luogotenenza del Litorale, Atti Presidiali, busta 64, prot.1/10.2 (1864).
23 Cfr. Zadar, HA, ms. 89, Indice dei libri proibiti dal 1814 al 1820. Questi elenchi,prima manoscritti e poi a stampa, si trovano frequentemente in tutti i fondi archivisticidegli organi di polizia e di governo e, per l'Austria, venivano pubblicati direttamentedall'I. R. Ministero di Polizia.
24 Per tale fenomeno si veda anche il classico A. ROTONDOÁ , La censura ecclesiastica ela cultura, in R. ROMANO, C. VIVANTI, Storia d'Italia, V/2, Documenti, Einaudi, Torino1973, pp. 1399-1492.
magistratura austriaca; fu in amicizia con Domenico Rossetti con cuiscambioÁ un'interessante corrispondenza concernente anche la censu-ra veneta 25. A Gamba successe Francesco Brambilla (dal 1824 al1844), che fu coadiuvato nell'impegno da altri censori come mons.Luigi Montan, censore dal 1830, e soprattutto l'abate Pianton, in ca-rica dal 1815 al 1848. Per Zara e Sebenico, inoltre, eÁ da tenere pre-sente il ruolo particolare svolto dal governatore Francesco Tomasich,i cui stretti rapporti con il conte Joseph Sedlnitzky, capo del Supre-mo Aulico Dicastero di Polizia e di Censura, determinarono gli indi-rizzi della politica censoria in quella regione 26.
All'ufficio veneziano dovettero anzitutto rivolgersi per le pubbli-cazioni gli intellettuali del Litorale e dell'Istria nella prima metaÁ del-l'Ottocento, quando nella loro attivitaÁ il rapporto tra cultura e poli-tica veniva acquisendo maggiore rilevanza. E ai censori veneti guar-darono sempre con una certa diffidenza, temendo piuÁ il loro giudizioche quello dei funzionari di governo nel Litorale. Le vicende di unopuscolo promosso dal Gabinetto di Minerva nel 1828 per celebrareil primo centenario del porto franco assumono carattere quasi esem-plificativo, rivelandosi cosõÁ di particolare interesse.
Nel settembre 1828 un gruppo di studiosi e di letterati triestinimembri del Gabinetto di Minerva, riuniti in solenne adunanza, cele-bravano il primo giubileo del porto franco di Trieste. Era una occa-sione per ricordare due importanti avvenimenti il primo secolo dellavisita di Carlo VI a Trieste e la ripresa dell'attivitaÁ di quel sodalizio,interrotta per ben otto anni e caratterizzante l'epoca del « nostro le-targo, nel quale perdemmo nulla meno che altri otto anni », come l'a-vrebbe definita poco piuÁ tardi Domenico Rossetti.
Il 5 dicembre 1828, nell'allocuzione per l'apertura delle conver-sazioni letterarie, lo stesso Rossetti avrebbe dichiarato: « Egli eradunque all'anno 1828, anno per altri riguardi memorabile, riserbatodi ravvivare la nostra Minerva col risarcirle mediante bel numero di
322
25 Il carteggio Gamba-Rossetti eÁ stato pubblicato per cura di Cesare Pagnini in ROS-
SETTI, Scritti inediti, II, cit., pp. 310-403. Sull'epistolario rossettiano si veda peroÁ ancheA. TRAMPUS, Fra Austria e Italia. L'epistolario inedito di Domenico Rossetti, « Archeogra-fo Triestino », s. IV, LII (1992), pp. 37-60.
26 PEDERIN, Utjecaj austrijske cenzure, cit., p. 24.
scelti soci attivi e zelanti le perdite degli anni anteriori, e col ripristi-nare l'onorevole e utile pratica delle accademiche nostre conversa-zioni » 27.
Fin dal febbraio 1828, in previsione dell'anniversario della visitadi Carlo VI, Rossetti aveva raccolto, come ricorda Attilio Gentile 28, idue colleghi della Direzione, Giambattista Kohen e Giuseppe Miche-le Hoffer, proponendo loro di aggregare nuovi soci ai pochi che era-no rimasti e quello stesso 18 febbraio 1828 essi decisero di indire uncongresso ordinario, fissato per il 26 giugno seguente.
L'idea originaria di Rossetti era di celebrare contemporaneamen-te il giubileo del porto franco e la posa della prima pietra dell'erigen-da chiesa di Sant'Antonio Nuovo. A questo scopo fin da giugno egliaveva dato tutte le disposizioni necessarie, invitando pure il Gover-natore ed il Preside del Magistrato.
Il 21 del mese egli poteva scrivere all'amico Pietro Nobile: « Ca-rissimo Nobile [...]; Vi serva di notizia che il collocamento solennedella prima pietra seguiraÁ ai 10 settembre venturo, essendo questoil giorno in cui Carlo VI visitoÁ personalmente Trieste nel 1728, aven-dovi stabilito il porto-franco. Questa duplice solennitaÁ riusciraÁ piuÁimportante ».
Solo due mesi piuÁ tardi, peroÁ , Rossetti doveva scrivere a Nobiledi aver ricevuto una comunicazione del Magistrato contenente « im-plicitamente il rifiuto pienissimo della festa secolare », che lo costrin-geva a dover posticipare la posa della prima pietra al 4 ottobre « ad-ducendo per ragione o per pretesto la probabile assenza del Gover-natore e del Preside il dõÁ 10 settembre »; il patrizio triestino, con laschiettezza che gli era propria e forse non senza una punta di sarca-smo, commentava: «mi astengo dal dare a quel rifiuto il vero nome;ma non posso a meno di desiderare che costõÁ sappiasi che sia da tac-ciarsi, se il dõÁ 10 settembre passa senza pubblica commemorazionedel vero, e sempre sacro giubileo triestino » 29.
323
27 D. ROSSETTI, Allocuzioni per le conversazioni letterarie della SocietaÁ del Gabinettodi Minerva (1810-1837), in ID., Scritti inediti, II, cit., pp. 487-488.
28 GENTILE, Il primo secolo, cit., p. 36.29 Entrambe le lettere sono pubblicate in A. TANZI (a cura di), Alcune lettere di Do-
menico Rossetti (carteggio Rossetti-Nobile), Richiedei, Milano 1879, pp. 140-153.
Era il primo di una serie di incidenti che avrebbero piuÁ voltecompromesso le celebrazioni del giubileo promosse da Rossetti edal Gabinetto di Minerva.
EÁ importante e necessario, a questo punto, riflettere sul motivoper cui il primo centenario del porto franco di Trieste venne celebra-to nel 1828. Al 1719 e non al 1728 risaliva l'importante rescritto diCarlo VI che dichiarava porti franchi Trieste e Fiume. EÁ possibileche nel 1819 il clima politico non fosse ancora favorevole ad una ce-lebrazione di tal genere, eÁ certo peroÁ che comunemente agli inizi delsecolo scorso come data effettiva dell'istituzione del porto franco sipreferiva indicare il 1728, anno della visita di CarloVI a Trieste; daquel momento infatti iniziarono lentamente l'espansione urbanisticae l'avviamento dei traffici commerciali.
Il 10 settembre 1828, quindi, con un tempo « quasi perfettamen-te sereno e bellissimo » 30, nella sala del Gabinetto di Minerva si ce-lebroÁ solennemente l'importante avvenimento. Domenico Rossetti,direttore censore, lesse una introduzione, alla quale seguõÁ il discorsoCenni sulla prosperitaÁ e sulle speranze di Trieste del direttore archivi-sta Giambattista Kohen; il professore Giuseppe de Lugnani declamoÁun Carme secolare e il giovane Pietro Kandler lesse un Saggio sullastoria del commercio di Trieste. Seguirono il Discorso circa il mododi consolidare e perpetuare la prosperitaÁ di Trieste del consultore An-tonio Nobile, la Epigrafe storico-onoraria latina ed italiana del dottorLorenzo Rondolini e la descrizione ed illustrazione di una medagliacelebrativa del porto franco, ideata e promossa da Rossetti e dellaquale si attendeva il conio; fu dunque una seduta lunga ed intensa,che dovette durare diverse ore.
I discorsi letti in quell'assemblea, per unanime deliberazione deisoci, furono quindi raccolti e ricopiati su di un quaderno con l'inten-zione di darli alle stampe a perpetuo ricordo della cerimonia.
Il manoscritto contenente gli studi venne prontamente inviato al-l'I.R. Ufficio di Revisione dei libri e stampe per le Province Venete diVenezia, per ottenere la necessaria approvazione della censura primadi dare alle stampe l'opuscolo. Gli scritti, oltre che essere di carattere
324
30 ADTs, Giornale del tempo, ms., segn. 1/2 B 30, carte non numerate.
storico, avevano anche un certo carattere politico e quindi gli autorigiaÁ si aspettavano che essi sarebbero stati esaminati attentamente;non avevano peroÁ ragione di preoccuparsene, anche perche quellaseguita era allora la procedura in uso e ben conosciuta da Rossettistesso.
A Venezia il manoscritto venne letto ed esaminato attentamentedal canonico Pianton, regio censore, che ricevuto il fascicolo il 29 di-cembre 1828 formuloÁ il proprio giudizio il 22 gennaio successivo.« Trovai alcuni tratti meritevoli di castigazione » ± egli scrisse ±« sia perche troppo arditi in riguardo all'avvenire, sia perche troppovivi in riguardo aÁ Veneziani ». Ciononostante egli diede l'admittiturad imprimendum, a condizione, peroÁ , che fossero apportate le corre-zioni richieste e che anche il Governo di Trieste accordasse il placet.
In fondo al manoscritto Pianton scrisse solo che il permesso dellacensura era accordato alle giaÁ citate condizioni, senza tuttavia indica-re le motivazioni riportate 31. Il parere del censore veneto venne con-validato da Francesco Brambilla, allora Direttore dell'Ufficio di Re-visione dei libri di Venezia, che scrisse « Previo il placet Gubernialesuaccennato, e con l'obbligo della consegna della prima prova distampa in luogo del suddetto esemplare innanzi alla pubblicazione.Imprimatur ».
Quando il manoscritto venne restituito a Rossetti, con le note deicensori veneti, probabilmente ci si sentõÁ rassicurati dal parere sostan-zialmente favorevole del Pianton. Ora restava da inviare il manoscrit-to all'Imperiale Governo di Trieste e, ottenuto il placet, di consegna-re gli scritti al tipografo Marenigh che si era impegnato a stamparli 32.
325
31 ASVe, Censura, busta 88 (1828), carte non numerate. Cfr. in appendice a questovolume, p.
32 Giovanni Marenigh, noto tipografo nella Trieste della prima metaÁ dell'Ottocen-to, apprese a Lubiana l'arte di legatore di libri. Ebbe una tipografia a Livorno, dovepubblicoÁ i tre volumi di A. DA MORRONA, Pisa illustrata nelle arti del disegno (1812) ea Firenze, dove pubblicoÁ la monumentale edizione in folio della Gerusalemme liberata(1820). RientroÁ a Trieste nel novembre 1824 e un mese dopo aprõÁ una tipografia. Stam-poÁ tra l'altro i primi quattro volumi dell'« Archeografo Triestino » e morõÁ nel 1842 (cfr.PAGNINI, I giornali di Trieste, cit., pp. 55-56). L'altro importante librario della cittaÁ , Gei-stinger, fu il fornitore ufficiale delle gazzette nei primi anni di attivitaÁ del Gabinetto diMinerva (cfr. CMSA, Archivio della SocietaÁ di Minerva, fasc. 1810, carte non numerate).
Rossetti apportoÁ al manoscritto tutte le correzioni necessarie e loconsegnoÁ a Marenigh, affinche lo recapitasse egli stesso alle autoritaÁpreposte, cosa che avvenne senza incidenti. Qualche tempo dopo pe-roÁ il Governo di Trieste restituõÁ il manoscritto con vocale divieto dipubblicarlo ed il direttore censore trovoÁ alcuni segni a margine dellasua introduzione; apportate nuove correzioni egli fece nuovamentepervenire gli scritti al Governo di Trieste, senza peroÁ ottenere il pla-cet richiesto.
Il 24 febbraio 1829, infine, Rossetti indirizzoÁ al Governo unachiara lettera, esponendo le proprie ragioni e mettendo praticamentele autoritaÁ con le spalle al muro, « devotamente supplicando di vole-re: 1.o apporre a manoscritto [...] il suo Vidit et placet per l'effettodell'autorizzazione definitiva della stampa; ovvero: 2.o apporvi l'e-spresso suo divieto, giacche altamente 3.zo saraÁ da ritenersi che, stan-te l'admittitur dell'I.R. Censore di Venezia, la stampa di quello inten-dasi tacitamente autorizzata da parte di quest'Eccelso Governo me-desimo ».
Le autoritaÁ furono cosõÁ costrette a dichiarare per iscritto esplici-tamente che non veniva permessa la pubblicazione del manoscritto.Il 7 marzo il consigliere di Governo Raunicher, il censore governati-vo che aveva esaminato gli scritti, aggiunse una postilla a seguito del-le dichiarazioni di Pianton e del Brambilla. « In seguito alla conclu-sione governiale 7 marzo corrente, Numero 4045 non si impartisce alpresente manoscritto il placet governiale ».
326
Nel 1810 procuroÁ gli abbonamenti alla «Allgemeine Litteratur Zeitung » (Lipsia), alleriviste «Annalen der Litteratur und Kunst » (Vienna), « Annali di scienze e lettere » (Mi-lano), «Archiv fuÈ r Geographie », «Historie », « Staats- und Kriegskunst », « Effemeridimedico-chimiche », « Esprit des journaux » (Bruxelles), « FraÈnkische Korrespondent »,«Giornale bibliografico universale » (Milano), «Giornale della SocietaÁ letteraria di Mi-lano », «Giornale italiano », «Heidelbergsche JahrbuÈ cher », « Journal de l'Empire » (Pa-ris), « Journal de physique, d'histoire naturelle » (Paris), «Magazin encyclopeÂdique »,«Medicinisch chirurgiche Zeitung » (Salzburg), «Minerva di Arschenholz » (Amburgo),«Neue oberdeutsche allgemeine Litteratur Zeitung » (Monaco), «Neuvied Reich derTodten », «Der Sammler » (Vienna), «Wiener Zeitung ». Cfr. la nota autografa di Ros-setti in CMSA, Archivio della SocietaÁdi Minerva, fasc. 1810, carte non numerate. L'elen-co eÁ di grande interesse per lo studio della cultura triestina del primo Ottocento e si notila netta prevalenza delle riviste di lingua tedesca.
Domenico Rossetti ottenne finalmente la restituzione del mano-scritto non appena invioÁ all'« Eccelso Governo », il 13 marzo, la ri-chiesta di « spedirmelo colla maggiore sollecitudine possibile » 33.
Quando infine il manoscritto venne restituito con il rifiuto delplacet, accusarono un duro colpo i soci del Gabinetto di Minerva.Rossetti, amareggiato, scrisse ad Antonio Nobile: « il nostro opuscolodel primo giubileo soffrõÁ delle castrazioni presso la censura di Vene-zia, la quale ordinoÁ per sovrappiuÁ di procurarsi l'approvazione daquesto Governo il quale, siccome tosto previdi, negoÁ assolutamentel'imprimatur. Vedete a qual segno arriva l'animositaÁ di costoro. Il li-bretto dunque non si stampa piuÁ ; ma io ne faroÁ tal uso che talunodesidereraÁ di non avermelo vietato » 34.
Il 5 aprile 1829, in una lettera Andrea Mustoxidi, parlando del-l'« Archeografo Triestino », che avrebbe presto inviato alla Censuradi Venezia, lo stesso Rossetti aggiungeva « e piaccia a Dio che pressoil Sig. Cav. Pianton faccia migliore fortuna di quello del mio PrimoGiubileo » 35.
In effetti Rossetti, non conoscendo le motivazioni del Governo diTrieste che avevano causato il rifiuto del placet, ma solo quelle del cen-sore veneto, imputoÁ tutta la colpa a Pianton, il quale avrebbe vistotroppi ed inesistenti indizi di irriverenza nei confronti dei veneziani edel porto franco che di lõÁ a poco sarebbe stato concesso a Venezia.L'attribuzione di ogni responsabilitaÁ al censore veneto sarebbe stata ri-petuta da tutti gli storici triestini fino ai giorni nostri. Rossetti, alluden-do a Pianton, dichiaroÁ esplicitamente che « quel censore vedeva un po'troppo al di laÁ di quello che sta scritto e fu pensato dagli autori » 36.
Come accennato, Rossetti peroÁ non conosceva ne avrebbe potu-to conoscere i motivi che avevano indotto il governo di Trieste, e
327
33 ASTs, Imperial Regio Governo del Litorale, Atti generali, busta 493, prot. n. 3/6-1.34 TANZI (a cura di), Alcune lettere, cit., p. 162, lettera del 29 aprile 1829.35 ROSSETTI, Epistolario, in ID., Scritti inediti, II, cit., p. 287.36 Dalla Annotazione preliminare in apertura del manoscritto. Rimasto inedito, l'in-
tero opuscolo eÁ stato pubblicato, con annotazione critica, in A. TRAMPUS, Il futuro diTrieste e il primo giubileo del portofranco in un opuscolo proibito dalla censura (1828),«Quaderni Giuliani di Storia », VIII, 1 (1986), pp. 7-82; a quella sede si rinvia per laconsultazione del testo ottocentesco.
Raunicher per esso, a negare l'agognato placet. Il ritrovamento, oraavvenuto, della minuta governativa con il parere di Raunicher ci per-mette di chiarire, dopo un secolo e mezzo, le vicende e ci rivela in-quietanti particolari.
GiaÁ il 28 febbraio 1829 il consigliere di Governo Raunicher ave-va preso in esame il manoscritto per formulare, dopo qualche tempo,le seguenti conclusioni: preso atto del parere della censura di Vene-zia, dichiarava che la tendenza dell'opera era fondamentalmente po-litica e che in essa, ora piuÁ velatamente, ora piuÁ apertamente, si pre-tendeva di fornire dei precetti all'amministrazione statale, criticandola linea politica seguita nell'amministrazione del territorio, del porto,dell'istruzione, ecc.
Raunicher aggiungeva anche che era intollerabile che uno scialboistituto di lettura, quale il Gabinetto di Minerva, si dedicasse a di-scussioni di carattere politico. Una secca nota chiudeva la relazione:Rathschluss. Das Placet wird versagt (= il placet viene negato) 37.
EÁ evidente quindi che i motivi per cui era stata negata la pubbli-cazione del manoscritto erano assai piuÁ gravi di quanto Rossetti ed imembri della «Minerva » avessero potuto immaginare. La colpa, omeglio la responsabilitaÁ del negato placet, non andava interamenteascritta al censore veneto, il cui parere fu relativamente di poco pesonella decisione del governo di Trieste, quanto piuttosto alla severitaÁ ,forse eccessiva, del censore governativo; ma i minervali di allora nonconobbero mai questa notizia 38.
Ritornato in possesso del manoscritto, Rossetti vi aggiungeva l'i-stanza, con la quale nel febbraio precedente aveva sollecitato un pa-rere scritto del Governo, assieme ad una « annotazione preliminare »
328
37 Il documento, in lingua tedesca, si trova in ASTs, Imperial Regio Governo delLitorale, Atti generali, busta 493, carte non numerate.
38 Matteo Raunicher nacque a Vazhe presso Lubiana il 20 settembre 1776. Ordina-to sacerdote nel 1802 resse la cattedra di dommatica nel seminario di Lubiana, del qualeera stato allievo, fino al 1827. Fu anche direttore di quel seminario e professore di reli-gione. Nel 1827 l'imperatore Francesco I lo nominoÁ consigliere effettivo di Governo,« referente ecclesiastico e degli studi nel governo del Litorale in Trieste », incarico chemantenne fino al 1830 quando, essendo deceduto il vescovo Leonardis, venne nominatovescovo delle diocesi unite di Trieste e Capodistria. Fu il primo vescovo sloveno nel Li-torale e morõÁ il 20 novembre 1845. Su di lui cfr. « L'Istria », II, 12-13 (1847).
in cui spiegava i motivi, a lui noti, della mancata pubblicazione e rie-pilogava brevemente le vicende del manoscritto. Scriveva egli di averinviato una bella copia degli scritti a persona « per ogni titolo supe-riore ai censori dello scritto » (l'imperatore Francesco I), invocandola veritaÁ storica « la quale a dispetto di tutti i censori parleraÁ sempre esaraÁ sempre veritaÁ ».
Gli scritti del giubileo del porto franco, assieme ai documenti ag-giunti, vennero fatti rilegare da Rossetti in un quaderno, ora conser-vato presso l'Archivio Diplomatico di Trieste 39. EÁ costituito da 56carte scritte da un copista, sono autografe del Rossetti la Annotazionepreliminare, i titoli dei lavori e alcune pagine della descrizione dellamedaglia. La legatura eÁ in tutta tela e reca a fronte una etichetta dicarta. All'interno, la prima pagina funge da frontespizio e reca il ti-tolo Primo Giubileo / del Porto-franco di Trieste / celebrato / Nel10 Settembre del 1828 / dalla Triestina SocietaÁ del Gabinetto di Mi-nerva; in basso eÁ un'incisione del recto e del verso della medagliacommemorativa.
Il quaderno (mm. 308 x 213) venne depositato nell'Archivio del-la SocietaÁ di Minerva, dove rimase per oltre un secolo. Lo esaminoÁnel 1910 Attilio Gentile per la compilazione del suo lavoro sulla So-cietaÁ e scrisse in una nota che « i manoscritti del giubileo si conser-vano nell'archivio » 40. Nel 1916, assieme a tutto il patrimonio socia-le, a causa dello scioglimento della «Minerva » decretato dal governoaustriaco, passoÁ all'Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica 41.Dopo il 1918, con la ricostruzione del sodalizio, l'archivio della «Mi-nerva » venne riunito per andare nuovamente disperso dopo il 1936,anno in cui la societaÁ venne assorbita dal Dopolavoro commercianti, eil manoscritto del giubileo ritornoÁ all'Archivio Diplomatico.
Gran parte dell'archivio sociale, assieme ad altri documenti ri-guardanti il centenario del porto franco, fu trasmessa ai Civici Musei
329
39 ADTs, segn. 1/2 D 12.40 GENTILE, Il primo secolo, cit., p. 176.41 G. SECOLI, Il terzo cinquantennio della «Minerva », Del Bianco, Udine 1965, p.
35.
di Storia ed Arte, che la conserva presso il Civico Museo di StoriaPatria fin dal 26 febbraio 1938 42.
Il 19 giugno 1829 il direttore Rossetti, nel congresso generale deisoci del Gabinetto di Minerva, assumeva l'ingrato compito di darerelazione sullo svolgimento delle celebrazioni del giubileo: « A me in-combe frattanto darvi brevemente conto di quello per cui appuntoquest'anno scadente va segnalato, e merita rammemorarsi negli anna-li della modesta e povera nostra societaÁ . [...] Era mia intenzione dipubblicare colle stampe i diversi articoli letti nel mentovato congres-so del 10 settembre. Ma, oltre che alcuni passi di quelli furono disap-provati dall'I.R. Ufficio di Censura di Venezia, al tutto fu poi negatol'imprimatur da quest'Eccelso Governo per quelle sicuramente saggevedute, che a noi non lice d'indagare » 43. Ancora l'11 maggio, in unalettera a Nobile, lo stesso Rossetti era giunto a parlare « dell'odiatogiubileo » 44.
I «minervali » incassarono allora il colpo e, sull'esempio del fon-datore che non si era lasciato andare a pubbliche lamentele, apparen-temente dimenticarono l'incidente; ma cosõÁ non fu e giaÁ nel 1842, do-po appena tredici anni, Giuseppe de Lugnani pubblicava una suaconferenza del 7 maggio 1841, Ragguaglio storico del Gabinetto diMinerva, ricordando le celebrazioni del giubileo: «Ora a restaurarela rimembranza di tale avvenimento, e la gratitudine renduta ormaitanto piuÁ solenne e importante dalla successiva protezione dei Re-
330
42 Nell'archivio della SocietaÁ di Minerva vi sono due fascicoli contenenti documentiriguardanti il giubileo del porto franco che ho potuto esaminare vent'anni fa grazie alcortese interessamento della compianta dott.ssa Gabriella Coen Foschiatti. Nel fascicolodell'anno 1828 c'eÁ un gruppo di carte legate da una fascetta recante le parole, autografedi Rossetti, «N.B. Sono le minute originali delle copie legate nel libro. Le mie potrannocassarsi affatto. Le altrui si restituiranno agli autori ». Detto gruppo di carte comprende:la minuta della Annotazione preliminare e copia autografa della lettera al governo del 24febbraio 1829; un fascicoletto (cc. 48) contenente i manoscritti autografi dei vari autorisul giubileo; la minuta (cc. 6) della Descrizione ed illustrazione del medaglione ecc. auto-grafa di Rossetti e la minuta (cc. 2) della sola descrizione della medaglia di cui parleremopiuÁ avanti; inoltre un esemplare del duerno illustrativo della medaglia stampato da Ma-renigh. Nel fascicolo dell'anno 1829 c'eÁ un gruppo di documenti (cc. 7) contenente leminute delle lettere di presentazione della medaglia alle autoritaÁ .
43 ROSSETTI, Allocuzioni, cit., pp. 428-429.44 TANZI (a cura di), Alcune lettere, cit., p. 168.
gnanti austriaci lorenesi, e dalla splenditaÁ , cui, in grazia di tanto so-vrano patrocinio, Trieste pervenne, la nostra Minerva solennizzoÁquella festa secolare. ConsisteÁ la celebrazione in una serie di analoghecomposizioni storiche e votive qui recitate fra numerosa adunanza,con tutto lo slancio della patria riconoscenza da varj socj, ed accoltefra i piuÁ unanimi applausi. Di piuÁ ; quantunque tali letture non vedes-sero la luce della stampa per circostanze straniere alla volontaÁ delGabinetto, si perpetuoÁ dalla Minerva stessa il sovvenire di tale cen-tenario periodo col far coniare [...] un allusivo medaglione » 45.
Kandler nel 1864, in Emporio e Portofranco sarebbe stato ancorapiuÁ esplicito: « Le Orazioni recitate eransi raccolte a libro, e destinatealla stampa. La Censura lo vietoÁ , pel motivo che la vicina Veneziaavrebbe potuto adontarsi delle allegrezze triestine; il quale riguardoera invero delicatissimo, ma non crediamo che vi sia soggetta la Sto-ria » 46.
Ancora nel 1892 Attilio Hortis ricordava le vicissitudini di Ros-setti: « Il libro che aveva composto insieme con altri per celebrare ilcentenario del porto franco fu ammesso alla censura di Venezia, do-po cassati i fatti storici che spiacevano a' Veneziani, e con riserva cheil governo di Trieste desse il placet non dato » 47.
Il quaderno si apre con una presentazione dei tre direttori delsodalizio, un Avvertimento che indica al lettore le origini e le finalitaÁdel Gabinetto di Minerva e che ricorda l'impegno dei membri diquesta societaÁ nel celebrare degnamente l'importante ricorrenza.
Come accennato, in quel tempo i tre direttori erano Rossetti, di-rettore censore, Kohen, direttore archivista e Giuseppe Michele Hof-fer, direttore economo; quest'ultimo ricopriva la carica dal 1821, es-sendo succeduto a Giovanni Lodovico Weber. Negoziante, Giusep-pe Michele Hoffer, benche non avesse mai tenuto alcuna conferenzae mai avesse pubblicato qualcosa, fu sempre uomo di grande stima econsiderazione per i membri del sodalizio. Negli oltre venti anni in
331
45 G. DE LUGNANI, Serate di Minerva, Weis, Trieste 1842, pp. 35-37.46 KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 270.47 A. HORTIS, Commemorazione di Domenico Rossetti letta nella SocietaÁ di Minerva,
Caprin, Trieste 1892, p. 13.
cui occupoÁ la carica di direttore economo, dal 1821 al 1844, egli siprodigoÁ curando il bilancio della SocietaÁ sempre scarso ed incerto 48.
Apre la serie degli scritti l'Introduzione di Domenico Rossetti.Nato nel 1774 e morto nel 1842, all'epoca del giubileo aveva cinquan-tatre anni e aveva giaÁ pubblicato i suoi lavori piuÁ importanti, tra cui laMeditazione storico-analitica delle franchigie del portofranco di Trieste(Picotti, Venezia 1814) e Petrarca,Giulio Celso e Boccaccio (Marenigh,Trieste 1828) solo per citare alcuni fra i piuÁ noti. Avvocato, patriziotriestino, procuratore civico e giaÁ arcade, aveva fondato nel 1810 lastessa «Minerva » divenendone direttore censore fino alla morte, enel 1815 il « Casino Vecchio » di cui era divenuto presidente.
L'introduzione, il cui inizio si fa notare per lo stile un po' aulico esolenne, propone un anomalo ed interessante raffronto storico tra al-cuni importanti avvenimenti della storia della cittaÁ , tutti svoltisi, persingolare coincidenza, nel mese di settembre: tralasciando quelli risa-lenti a epoche piuÁ antiche « che saranno avvenuti ma che per troppadistanza di tempo o per tenuitaÁ di conseguenze meno risplendonone' nostri fasti », l'autore ricordava la dedizione di Trieste al ducad'Austria del 1382, la visita di Leopoldo I del 1660, la visita di CarloVI del 1728 e la cacciata dei francesi da Trieste del 1813.
Nel suo scritto Rossetti non mancava di fare riferimento alle tra-dizioni storiche e al fondamento dell'antica municipalitaÁ triestina, perla validitaÁ e per il ripristino della quale avrebbe condotto una intensaquanto poco fruttuosa battaglia fino alla morte. E proprio a sostegnodelle antiche tradizioni cittadine egli ricordava le visite alla cittaÁ diTraiano, di Costantino, di Carlo Magno, di Federico III e cosõÁ via,senza preoccuparsi eccessivamente di accertare scientificamente lareale consistenza dei fatti storici menzionati.
Con chiarezza il direttore della «Minerva » passava quindi ad il-lustrare le grandi opere edilizie che nel 1828 stavano per essere con-dotte a termine o lo sarebbero state in breve tempo: la chiesa di San-t'Antonio Taumaturgo, la strada nuova per Opicina, l'ospedale, il ri-pristino dell'acquedotto romano, la progettata sede del nuovomunicipio; tutti monumenti, questi, che avrebbero costituito vanto
332
48 GENTILE, Il primo secolo, cit., p. 40.
per la cittaÁ e avrebbero destato ammirazione in quanti l'avrebberovisitata.
Se a cento anni dalla visita di Carlo VI tale e tanto grande appa-riva lo sviluppo della cittaÁ e del commercio ± rifletteva Rossetti ±quale sarebbe stato l'aspetto di Trieste allo scadere del secondo cen-tenario? « Estesa su tutto il piano e sulle pendici delle vicine collineaccoglieraÁ una popolazione forse quadrupla della presente » ± scrive-va ± « quella baja, che appellasi valle di Muggia, un secondo ampio esicuro porto offriraÁ a gran numero di navigli. I monti che ora ci fannoarida e nuda corona, di ridente verdura rivestiti ci appariranno [...];le arti finalmente e le scienze vi terranno sede »; e, se si guarda aglianni Trenta del nostro secolo, le previsioni e gli auspici del patriziotriestino si avverarono realmente, anche se da allora incomincioÁ lalenta decadenza della cittaÁ .
A ragione Rossetti dichiarava: « questa, che taluno sorridendo di-raÁ mia visione, non eÁ che un quadro prospettico di quegli effetti iquali [...] debbono secondo l'ordine naturale delle cose generarsidalla causa e dai fatti innegabilmente esistenti ».
Sono queste, come quelle che seguono, considerazioni che por-tano a ricordare i princõÁpi illuministi enunciati da un altro patriziotriestino: l'economista Antonio de Giuliani che giaÁ nel 1785 nelle Ri-flessioni politiche sopra il prospetto attuale della cittaÁ di Trieste scrive-va: « per ora non sono assegnabili confini all'ingrandimento della Cit-taÁ di Trieste, e della sua popolazione. SalõÁre, e discendere fu sempredestino delle Nazioni » 49.
La stessa preoccupazione, lo stesso interrogativo che si ponevaRossetti, riecheggia nelle parole di de Giuliani, che tra il 1803 ed il1805, nel Panorama politico della cittaÁ di Trieste si era domandato:« se dunque in sõÁ breve spazio di tempo Trieste acquistoÁ un aspettosõÁ imponente, chi fisseraÁ il termine de' suoi progressi? » 50.
Ancora Rossetti dimostrava le sue doti di preveggente, che poinon erano altro che una acuta analisi delle varie situazioni storiche,quando affermava che la natura delle cose dapprima porta « all'apice
333
49 DE GIULIANI, Riflessioni sul porto di Trieste, cit., pp. 48-49.50 DE GIULIANI, Scritti inediti, cit., p. 210.
delle sue possibilitaÁ [...] poi si deprava e retrocede. [...] CosõÁ fu, ecosõÁ saraÁ d'ogni cittaÁ , d'ogni regno, d'ogni nazione. Chi vorraÁ cheTrieste sola ne sia eccettuata? O non saÁ egli forse che questa Triesteappunto non surse giaÁ adesso per la prima volta dal suo nulla? ».
La discussione rossettiana sull'avvenire del porto franco erastrettamente legata, inoltre, al suo concetto di « commercio artificia-le », che giaÁ aveva suscitato l'interesse e la critica di Baraux. GiaÁ inapertura della settima e ultima « lettera municipale » (1819) il patri-zio triestino aveva precisato meglio il concetto, sostenendo che ilcommercio dell'emporio doveva essere ritenuto « artificiale » percheÂnel suo sviluppo storico erano mancati i primordiali caratteri « natu-rali » che ne avrebbero garantito autonoma sussistenza anche di fron-te alle esigenze di un vasto retroterra. Sostanzialmente, Rossetti met-teva a fuoco una concezione propria della storiografia moderna del-l'emporio, quella cioeÁ di Trieste quale « cittaÁ di fondazione », in cui ildecollo urbanistico ed economico era avvenuto per impulso esterno,di natura governativa 51.
Tale considerazione costituiva la premessa del successivo ragiona-mento; il porto franco nella sua costante evoluzione veniva perdendola naturale e storica condizione di piccolo centro di modesto interessee di limitate potenzialitaÁ per assumere l'« artificiale » ruolo di centronevralgico di un articolato sistema economico-politico. CosõÁ precisa-va: « Togliete ai popoli transalpini ed agli oltremarini il reciproco bi-sogno dei prodotti delle loro terre e delle naturali industrie loro; o da-te loro un altro centro di contatto e di comunicazione; o fate che i pri-mi soli, o i soli secondi per qualche tempo cessino di concorrervi:eccovi Trieste oziosa, depauperata, spopolata, priva per cosõÁ dire divitalitaÁ , e costretta di retrocedere alla primitiva sua naturale condizio-ne. La quale retrocessione avrebbe per giunta la sventura di dovereriuscire tanto piuÁ lenta e penosa, da che la nuova esistenza artificialespense in gran parte perfino gli elementi della naturale » 52.
Un commercio « artificiale » considerato quindi non semplice-mente nella sua connotazione negativa ma articolato con le conside-
334
51 D. ROSSETTI, Sette lettere di argomento municipale, Stefani, Trieste 19442, pp. 73-92.52 ROSSETTI, Sette lettere, cit., pp. 74-76.
razioni ± nell'opuscolo sul giubileo del porto franco ± sulla necessitaÁdi garantirne solide basi e di assicurare i mezzi della sua prosperitaÁper l'avvenire e per i destini dell'emporio. CosõÁ la « commemorazionedelle passate cose » non poteva « stare disgiunta dall'aspetto di quel-l'avvenire che da queste ci viene annunziato, e guarentito quasi dallostato delle presenti » 53.
Giambattista Kohen, autore dei Cenni sulla prosperitaÁ e sulle spe-ranze di Trieste era nato nel 1785 e vi morõÁ, dopo essere passato alcattolicesimo, nel 1845.
Si laureoÁ a ventidue anni e, dopo aver vissuto a Venezia ed in To-scana, si sposoÁ trasferendosi nel Litorale Austriaco. « Era un uomodotato di memoria straordinaria, se non d'ingegno potente » ± scriveGiuseppe Caprin ± « i suoi giudizi esatti pronti, sicuri; di una mode-stia rara a trovarsi nelle persone che possiedono vasta erudizione eche hanno la parola feconda » 54.
Divenuto noto nel mondo culturale con la traduzione di Polibio,edita da Sonzogno e Molina, Kohen pubblicoÁ alcuni studi filosoficiSulle sette della Grecia, Ricerche sull'origine del sapere umano e unamonografia Sulla origine di Trieste. Medico valente, poliglotta, epigra-fista, fu amico di Rossetti e direttore archivista della «Minerva » dal1815 al 1829 per la quale tenne numerose conferenze; la sua biografiavenne inserita nella Biografia degli italiani illustri di Giulio Cesare Po-lari e fu sempre uno dei principali fautori e promotori del sodalizio 55.
335
53 Si veda il testo dell'opuscolo in TRAMPUS, Il futuro di Trieste, cit., p. 52. Nuoveosservazioni su Rossetti pedagogista si possono trovare in BERTI, La censura, cit., p. 487,a proposito dell'opera Dello scibile e del suo insegnamento, giudicata « l'esempio, forse ilpiuÁ clamoroso, di una teorizzazione pedagogica in perfetta sintonia con il paternalismoilluminato austriaco ». Si pone quindi la necessitaÁ di verificare quindi con piuÁ precisionel'asserita modernitaÁ del pensiero di Rossetti e il suo rapporto con la cultura austriaca, ingenere trascurato. Limitato all'attivitaÁ letteraria eÁ il volume di F. COSSUTTA, Ideologia escelte culturali di Domenico Rossetti. Il suo petrarchismo, Del Bianco, Udine 1989, cheenfatizza ± seguendo una lunga tradizione triestina ± la funzione del suo « petrarchi-smo » come chiave di lettura del suo impegno civile. Una diversa e piuÁ convincente chia-ve di lettura si ricava da M.R. DI SIMONE, Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoliXVII-XX), GiuffreÁ , Milano 2006, in particolare pp. 108-110 e 185-220.
54 CAPRIN, I nostri nonni, cit., pp. 190-192.55 CAPRIN, I nostri nonni, cit., p. 191; STANCOVICH, Notizie degli istriani, cit., pp. 33-
35; E. GUAGNINI, Il classicismo di Giambattista (Joel) Kohen tra formazione scientifica e
Lo studio di Kohen, per la veritaÁ assai breve in confronto agli al-tri (conta appena quattro pagine e mezza manoscritte), ha il caratteredi un saggio storico sulle vicissitudini della cittaÁ dall'epoca romanaalla nascita del porto franco, con particolare riferimento alle lotte so-stenute dai triestini per affermare la propria indipendenza politica ecommerciale nei confronti delle popolazioni barbariche prima, e deiveneziani dopo.
Kohen ricordava il vantaggio avuto dall'economia e dal commer-cio con la caduta della secolare Repubblica di Venezia per cui l'« ab-bassamento di questa illustre cittaÁ non potea non ridondar in aumen-to della prosperitaÁ di Trieste ». Dichiarava che qualora Trieste fosseirrimediabilmente decaduta da regina dell'Adriatico non si sarebbeesaurita per contro la sua funzione storica e indicava alle future ge-nerazioni di cittadini la via da percorrere per risvegliare Trieste dalsuo torpore: la cittaÁ sarebbe sopravvissuta a se grazie ai suoi « grandimonumenti, figli e testimoni della sua opulenza » ma giammai sareb-be divenuta una « sciagurata Siracusa o Corinto donde trasferivansi aRoma quadri, statue e preziose suppellettili »; Trieste anzi avrebbeassunto il ruolo di una « novella Atene, maestra di civiltaÁ e di lettere »dove tutti avrebbero fatto a gara per mandare i figli a studiare.
Il lungo Carme secolare di Giuseppe de Lugnani, ridondante edampolloso, ad un primo esame potrebbe sembrare poco interessantema cosõÁ non eÁ .
De Lugnani era nato a Capodistria nel 1793 e morõÁ nel 1857; giaÁnel 1810, a diciassette anni, otteneva un temporaneo incarico di inse-gnamento di matematica applicata presso l'UniversitaÁ di Padova. Lasua passione era peroÁ la poesia e nel corso della sua vita scrisse unainnumerevole quantitaÁ di poemi, di odi, di epigrammi e carmi anchese da ultimo cadde « nel piuÁ vuoto manierismo aulico di versi d'oc-casione » 56.
336
interessi filologico-eruditi, in CAPUTO (a cura di), Neoclassico, cit., pp. 300-302. Osserva-zioni interessanti sul retaggio baconiano nelle Ricerche sull'origine del sapere umano esulla base sperimentale nel Prospetto di una scienza logica (1833) di Kohen si trovanoin BERTI, Censura, cit., p. 429.
56 A. GENTILE, Vita triestina nell'Ottocento, « Archeografo Triestino », s. IV, X-XI(1946), p. 6.
Entrato nella «Minerva » nel 1812 come socio « officiato », diven-ne nel 1815 Civico Bibliotecario, fu per molti anni redattore di «L'Os-servatore Triestino » e nel 1817 divenne professore di storia, geografiae scienza del commercio all'Accademia « reale e di nautica » 57.
De Lugnani possedeva una notevole abilitaÁ tecnica del verso che,unita all'abbondanza degli spunti tratti dalla sua piuÁ che vasta cultu-ra, gli consentiva di dedicarsi alla sua grande passione. Il componi-mento poetico per il giubileo del porto franco, nonostante la pesan-tezza dei versi, non manca di alcuni passi che assai efficacemente ren-dono il concetto che vi si vuole esprimere. Ovunque traspare l'amoree l'attaccamento nei confronti della propria cittaÁ di adozione, la fie-rezza e l'orgoglio per le opere compiute onde aumentarne il prestigioe maggiormente decorarla. CosõÁ, quando de Lugnani accennava agliinizi della cittaÁ moderna dopo la creazione del porto franco, sembra-va essere riuscito a trasferire in versi questi sentimenti: « Sotto la roc-ca il picciolo / stuol delle stirpi fide / al pian la cittaÁ florida / videallargarsi; e vide / le vie di genti folte / da tutte parti accolte / all'om-bra inclita vivere / di saldo trono, e d'ara / ove da legge immobile /l'egualitaÁ s'impara / e da paterno impero / la libertaÁ del vero ».
Di un certo interesse sono anche i versi in cui de Lugnani descri-veva i numerosi, ricchi ed inconsueti prodotti che continuamentegiungevano nel porto triestino dai vari continenti, « il pallido semed'arabo arbusto », « l'egizie biade » che forniscono una visione d'in-sieme della operositaÁ del porto nella prima metaÁ del secolo scorso.
Ben diverso e di piuÁ ampio respiro si rivela lo studio di PietroKandler, Saggio sulla storia del commercio di Trieste, condotto su basiscientifiche, con metodo critico e con luciditaÁ di esposizione; esau-rienti note documentano le asserzioni dell'autore e forniscono mag-giori particolari su fatti ed avvenimenti giaÁ ricordati nel testo.
Il giovane Kandler, allora praticante nello studio di Rossetti, ave-va nel 1828 ventiquattro anni ma giaÁ aveva dato prova di notevoleserietaÁ d'intenti e di grandi capacitaÁ . Era il piuÁ giovane socio del Ga-binetto di Minerva e quella del 10 settembre 1828 era la sua primaconferenza.
337
57 GENTILE, Vita triestina, cit., pp. 6-10.
Due anni prima, quando era ancora studente, aveva rintracciatoe pubblicato a Pavia il poema latino di Andrea Rapicio, L'Istria, chegli era valso i primi riconoscimenti. L'intervento di Kandler, perquanto riguardava il testo suo proprio, si era limitato peroÁ a due solepagine di introduzione a firma de « l'editore a chi legge » 58.
EÁ facile quindi comprendere l'aspettativa del giovane che vedevadi imminente pubblicazione il discorso sul porto franco letto davantiall'erudito pubblico della «Minerva »; ed altrettanto facile da imma-ginare eÁ la delusione nell'apprendere che il suo lavoro non sarebbemai stato pubblicato.
Conscio dei propri limiti e rispettoso nei confronti dei suoi maestri,scriveva all'inizio del suo lavoro: «Limitato il giovanile mio ingegno,ignote a me le arti del bel dire, della vostra mansuetudine ho bisognoonde non vacillar nell'impresa: peroÁ pregovi di benigno ascolto ».
Ancora nel 1864, in Emporio e Portofranco, quando ormai avevaraggiunto la notorietaÁ e la massima esperienza ed era divenuto, a ses-sant'anni, una delle colonne portanti della storiografia triestina, sisentiva in dovere di scrivere: « l'autore delle presenti memorie, mo-vendo l'incerto piede giovanile poggiato a quelli illustri, vi recitavale gesta di Imperatore Carlo VI e ne tesseva l'elogio, come allor po-tea; e di questa vanitaÁ chiede venia » 59.
Non che, divenuto piuÁ maturo, avesse sconfessato il suo lavorogiovanile. Nell'Archivio diplomatico di Trieste eÁ stato rinvenuto il di-scorso autografo dello storico triestino, letto in quella sera del1828 60. Molti anni piuÁ tardi egli aveva messo un titolo, sul frontespi-zio, sbagliando per disattenzione la data: Discorso in onore di Imp.Carlo VI recitato dal Dr. Kandler nella festa secolare del Portofrancodel 30 Sett. 1829; Lavoro Puerile; Kandler, dove « puerile » suonavaper « giovanile » non « infantile »; anche se all'interno aggiunse anco-ra: «misere cose ».
Il saggio di Kandler si distingue per la chiarezza della prosa, no-nostante incertezze e incongruenze linguistiche tipiche dell'epoca, e
338
58 P. KANDLER, « L'Istria », poema latino di Andrea Rapicio, Bizzoni, Pavia 1826.59 KANDLER, Emporio e portofranco, cit., p. 270.60 ADTs, segn. 12 D 5/2.
per l'efficacia delle asserzioni. Tanto efficaci che Rossetti stesso, dabuon maestro, vi apportoÁ qualche correzione per attenuare la peren-torietaÁ di talune affermazioni, mentre tanto il censore veneto quantotriestino vi lasciarono vistosi segni, cancellature e correzioni.
In diciassette pagine, con padronanza di metodo e attenzione cri-tica, Kandler tratteggioÁ un esauriente panorama storico-politico edeconomico della cittaÁ adriatica dall'epoca romana all'istituzione delporto franco. L'autore, del resto, aveva avuto la possibilitaÁ di matu-rare la propria formazione culturale e giuridica in ambienti stimolanticome le universitaÁ di Vienna e di Pavia e giaÁ andava sviluppando l'in-teresse per la storia medioevale e moderna nel reperimento dei ma-teriali per l'opera piuÁ importante della maturitaÁ , il Codice diplomaticoistriano 61. Abbandonata infatti la FacoltaÁ di Filosofia dell'UniversitaÁdi Padova, presso la quale era stato iscritto per appena un anno, Kan-dler ottenne nel novembre 1822 l'immatricolazione alla FacoltaÁ diGiurisprudenza dell'UniversitaÁ di Vienna 62; lõÁ rimase iscritto per ol-tre tre anni, fino al 1826. Trasferitosi infine all'UniversitaÁ di Pavia, silaureoÁ in giurisprudenza nel 1827 63.
A Vienna, presso la Hofbibliothek, egli profuse impegno decisi-vo nella ricerca di materiale documentario concernente in particolareil basso Medioevo e riguardante Trieste e l'Istria; risultato di quellericerche fu inoltre la pubblicazione giaÁ ricordata de L'Istria, poemalatino di Andrea Rapicio. Le trascrizioni di documenti destinati acomporre la raccolta preparatoria del Codice diplomatico istriano edelle quali eÁ nota la data di copiatura risalgono nel tempo almenoal marzo 1826 64, quindi ad un momento immediatamente posterioreall'immatricolazione presso l'UniversitaÁ di Pavia, e giaÁ presentano la
339
61 A. TRAMPUS, Alle origini del Codice diplomatico istriano. Kandler e l'insegnamentostorico giuridico a Vienna, «Quaderni Giuliani di Storia », XI, 1-2 (1990), pp. 79-86.
62 ADTs, segn. 12 D 6, cc. 10r.-11r.; cfr. anche S. PESANTE, Inventario dei mano-scritti di Pietro Kandler conservati nella Biblioteca civica di Trieste, in F. CROSARA (acura di), Studi kandleriani, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, Trieste1975, pp. 289-290.
63 F. CROSARA, L'importanza di Pietro Kandler, in ID. (a cura di), Studi kandleriani,cit., p. 49 e i documenti citati, in ADTs, segn. 12 D 6.
64 ADTs, segn. 7 G 13; cfr. per esempio il documento datato anno 1030, 7 agosto,con la data Pavia, 16 marzo 1826.
struttura formale degli elementi poi destinati al Codice. Nel luglio1828, infine, dopo il rientro a Trieste in una lettera a Rossetti Kan-dler giaÁ avvertiva la scarsitaÁ di fonti documentarie sul Medioevo trie-stino e istriano, auspicando la formazione di un «Codice Diplomati-co completo » 65.
La sensibilitaÁ storica dimostrata dal giovane Kandler in quelleoccasioni era stata influenzata in misura non trascurabile dagli studia Vienna; lõÁ aveva avuto come docente di diritto privato romano e didiritto canonico il giurista e storico Thomas Dolliner (1760-1839) 66,noto per gli interessi storico-medioevali e per alcune opere tra cuiErklaÈrung des allgemeinen deutschen Lehenrechtes nach BoÈhmers« Principia iuris feudalis » (Wien 1793), EraÈuterung der deutschenReichsgeschichte nach des geheimen Justizraths PuÈtter (Wien 1794-1802). Soprattutto fu curatore (Wien 1803) del Codex epistolaris Pri-mislai Ottonari II. Bohemiae regis, complectens semicenturiam litera-rum ab Henrico de Isernia, ejus notario contenente l'edizione criticadelle epistolae duecentesche emanate o ricevute dal re di Boemia,con la quale il Codice kandleriano presenta spiccate analogie.
EÁ significativo che in chiusura del Codex epistolaris Dollineresponesse alcuni SaÈtze aus allen Thellen der Rechts-und politischenWissenschaften, tra cui i SaÈtze aus dem natuÈrlichen Privat-Rechte.PrincõÁpi, insomma, che si riferivano direttamente all'indirizzo preva-lente dell'insegnamento giuridico nelle universitaÁ austriache, impron-tato sulla valorizzazione del giusnaturalismo e di taluni aspetti del di-ritto pubblico in funzione di una ormai consolidata Staatswissen-schaft. Inoltre Kandler aveva avuto come docente di diritto natu-rale Franz von Egger 67, giaÁ allievo a Vienna del trentino C.A. de
340
65 Kandler a Rossetti, Trieste 17 luglio 1828 (la risposta di Rossetti, non rintraccia-ta, portava la data Valdagno, 23 luglio 1828), in ADTs, segn. 21 D 5/2.
66 ADTs, segn. 12 D 6; su Dolliner cfr. VON WURZBACH, Biographisches Lexikon, cit.,3 (1858), pp. 350-353; Allgemeine Deutsche Biographie, 5, Duncker und Humblot, Leip-zig 1877, pp. 314-325;OÈsterreichisches Biographisches Lexikon, I, OÈ sterreichische Akade-mie der Wissenschaften, Graz-KoÈ ln 1957, p. 193. Cfr. anche KINK,Geschichte der kaiser-lichen UniversitaÈt zu Wien, I, cit., p. 469 e passim; H. MAIER, Die aÈltere Staats-und Ver-waltungslehre, Deutsche Taschenbuch Verlag, MuÈnchen 19862, pp. 181-190.
67 ADTs, segn. 12 D 6, c. 12r.; su von Egger cfr. OÈsterreichisches BiographischesLexicon, I, cit., p. 222.
Martini, del quale aveva fatto propri i migliori insegnamenti, e chepiuÁ tardi avrebbe pubblicato l'opera Die natuÈrliche Recht nach denLehrsaÈtzen des seligen Freiherrn C. A. von Martini. LõÁ si riproponeva-no talune idee sulla validitaÁ del diritto romano in quanto conformealla legge naturale, e sulla necessitaÁ della storia quale scienza sussidia-ria negli studi giuridici. Va rammentato infine che Dolliner collaboroÁalla rivista di Savigny, Eichhorn e GoÈ schen Zeitschrift fuÈr geschichtli-che Rechtwissenschaft 68, dimostrandosi vicino alle teorizzazioni dellascuola di Savigny sulla continuitaÁ storica del diritto romano. Apparequindi particolarmente interessante l'analoga posizione di Kandler 69
e il fatto che egli nel campo giuridico si ritenesse un esperto di dirittoromano, avendo riservato proprio a se l'insegnamento di quella ma-teria in una progettata facoltaÁ universitaria di giurisprudenza 70.
Approfondita e di ampio respiro giaÁ si rivelava quindi la prepa-razione del giovane autore del Saggio per l'opuscolo celebrativo delgiubileo del porto franco, che in chiusura del suo scritto esaltava l'o-pera riformatrice di Carlo VI il quale ± aggiungeva in un inciso cas-sato dal censore veneto ± « con alti sensi rintuzzava le venete pretesesu di un mare, che tentavan mantenere in irragionevole dominio » 71.
L'autore del Discorso circa il modo di consolidare e perpetuare laprosperitaÁ di Trieste era Antonio Nobile. Fratello di Pietro, famosoingegnere ed architetto, Carl'Antonio nacque a Campestro (CantonTicino) nel 1793 e frequentoÁ le scuole triestine dove compõÁ gli studielementari e liceali. LavoroÁ al Ministero della Guerra a Milano(1813), fu impiegato alla imperial regia Direzione delle fortificazionidella Lombardia (1815), successivamente venne nominato Commis-sario di guerra del Governo del Canton Ticino.
341
68 VON WURZBACH, Biographisches Lexikon, 3, cit., p. 351.69 G. CERVANI, Appunti sul periodo della Restaurazione a Trieste. La relazione di Pie-
tro Kandler al governatore conte Francesco Stadion, in CROSARA (a cura di), Studi kandle-riani, cit., p. 163, nonche P. KANDLER, Del gius di stato e del pubblico. Loro giurispruden-za, in G. CERVANI, NazionalitaÁ e stato di diritto per Trieste nel pensiero di Pietro Kandler.Gli inediti del procuratore civico, Del Bianco, Udine 1975, pp. 108-126.
70 A. HORTIS, Pietro Kandler e la FacoltaÁ italiana di Giurisprudenza a Trieste, « IlPiccolo », 2 giugno 1912, p. 1; CROSARA, L'importanza di Pietro Kandler, cit., p. 41.
71 TRAMPUS, Il futuro di Trieste, cit., p. 68.
PiuÁ tardi, nel 1831, sarebbe divenuto vice-attuario della Deputa-zione di Borsa di Trieste. Tenne numerose conferenze alla «Miner-va » tra il 1828 ed il 1831, assieme a de Lugnani fu redattore di« L'Osservatore Triestino » e morõÁ nel 1860 72.
Assieme allo scritto di Rossetti, il « discorso » di Nobile fu quelloche piuÁ degli altri subõÁ i pesanti interventi della censura ed eÁ proba-bile che Raunicher, quando inveiva contro i « precetti » che la «Mi-nerva » avrebbe voluto fornire al governo, si riferisse proprio a que-sto studio; frasi intere ed addirittura intere facciate vennero sfigurateda vistosi segni di cancellatura, soprattutto nei passi allusivi ai contra-sti commerciali con la vicina Venezia.
Il discorso di Nobile, improntato a sincero realismo, non rifuggi-va da una certa severitaÁ nei confronti della politica commerciale svol-ta dalla Repubblica di Venezia nei secoli precedenti ed il passo cheaccenna alla « gelosa regina del mare a fianco » risulta cancellato, sot-tolineato, fiancheggiato da asterischi.
Come Rossetti, anche Nobile si soffermava ad esaminare le causeche portarono Trieste all'apice della prosperitaÁ ma, a differenza delpatrizio triestino, egli poneva l'accento sulla qualitaÁ della sicurezzache puoÁ offrire una economia fondata esclusivamente sul commerciomarittimo.
EÁ innegabile, egli affermava, che « lo splendore puramente com-merciale dei popoli e delle cittaÁ non solo non poteÁ mai perpetuarsiappo loro, ma neppure fu mai di lunga durata ». La futura prosperitaÁdi Trieste sarebbe stata garantita dagli organi governativi che « altronon possono ne debbono, che dare gli impulsi ai movimenti necessarialla vita dei corpi sociali » cui necessariamente andava aggiunto l'im-pegno del singolo individuo « avvisandone per iscopo il benessere ge-nerale, dal quale il singolo eÁ inseparabile ».
Quanto ad attivitaÁ economiche alternative al commercio maritti-mo, Nobile sollecitava la formazione « d'un patrimonio agricolo », lacoltivazione piuÁ intensa dei terreni giaÁ produttivi, il dissodamento diquelli incolti, lo stabilimento di nuove industrie e di nuove fabbriche,« germe di vita nelle popolazioni ». Quanto piuÁ la produzione delle
342
72 ROSSETTI, Epistolario, cit., p. 199.
industrie avrebbe interessato generi di prima necessitaÁ , tanto piuÁ si-cura sarebbe stata la prosperitaÁ del porto franco. « EÁ ben vero » ± af-fermava ± « che, nel senso suo ovvio, il commercio congiunge indivi-dui, societaÁ e mondi, facendo sparire le frapposte distanze, e ch'eglisoddisfa ai reciproci bisogni; ma non eÁ meno vero che l'alimento suoprimo eÁ il bisogno, e che gli immediati suoi frutti sono sempre deinuovi bisogni » 73.
Complessivamente, Nobile dava maggiore attenzione ai problemilegati allo sviluppo dell'agricoltura piuttosto che a quelli connessi alcommercio di esportazione e al commercio al dettaglio; in cioÁ l'auto-re potrebbe apparire ancora legato ad alcune dottrine fisiocratichesettecentesche che nella sua epoca giaÁ erano state oggetto di ampiariconsiderazione. Nonostante cioÁ il suo Saggio fu tra gli scritti chepiuÁ soffrirono l'intervento della censura, specialmente nei passi incui, con vigore, esortava la monarchia austriaca a provvedere perl'avvenire dell'emporio approntando i rimedi ad una eventuale edimprovvisa cessazione delle attivitaÁ portuali.
Ultimo contributo eÁ l'Epigrafe storico-onoraria pel primo giubileodel porto-franco di Trieste di Lorenzo Rondolini. Nato a Trieste nel1752, studioÁ al collegio gesuitico della cittaÁ natale, si laureoÁ a Viennain medicina e veterinaria. Autore di saggi di argomento medico, tra-duttore dal tedesco e dal latino, fu anche censore governativo duran-te l'occupazione francese del 1809-1813. Fino a tarda etaÁ fu capo-medico al Lazzaretto Nuovo e morõÁ nel 1844. «Misantropo, bronto-lone e burbero benefico, si trascinoÁ alla `̀ Minerva'', quasi novanten-ne, a fare il panegirico delle donne illustri: ± Signori, esclamava, an-cora un istante; e teneva un'altra oretta il pubblico ad ascoltare i suoiepigrammi latini » 74. L'Epigrafe di Rondolini, scritta in lingua latinacon traduzione italiana, non presenta tuttavia elementi di particolareinteresse, a parte il richiamo alla civiltaÁ classica tipico in simili occa-sioni solenni, essendo limitata alla semplice esaltazione dei sovraniasburgici e del ruolo di Trieste nel commercio marittimo.
343
73 TRAMPUS, Il futuro di Trieste, cit., pp. 70-71.74 CAPRIN, I nostri nonni, cit., p. 218; GENTILE, Il primo secolo, cit., p. 174; S. FOR-
MIGGINI, Della vita e delle opere del dottore Lorenzo Rondolini, Weis, Trieste 1844.
Rimasto inedito il manoscritto sul giubileo del porto franco, la me-moria di quella celebrazione promossa dal Gabinetto di Minerva rima-se affidata a una medaglia commemorativa, in oro, argento e rame, cheRossetti fece disegnare dal veronese Francesco Putinati e che fu poipresentata alle massime autoritaÁ politiche del Litorale e dell'Impero 75.
Un caso istriano di « incontro » con la censura veneta, del tuttoindolore soprattutto per la natura storico-erudita dell'opera, eÁ invecequello della Biografia degli uomini distinti dell'Istria (1829), di PietroStancovich 76, primo dizionario biografico relativo al Litorale Au-striaco e all'Istria.
In un'epoca ancora avara di recensioni critiche e di pubblici giu-dizi sugli autori in generale e sulle loro opere, quando rari commentidi carattere confidenziale erano dovuti all'aguzza penna di qualche« collega » letterato 77, l'opera maggiore dello Stancovich, la Biografiadegli uomini distinti dell'Istria, venne accolta tra il generale favore del-l'ambiente culturale istriano, tanto che, ricorda Cernecca 78, l'autorevenne eletto a Plutarco istriano e figlio benemerito della sua patria.
344
75 Le vicende dell'ideazione e del conio della medaglia sono descritte in TRAMPUS, Ilfuturo, cit., pp. 22-26; la medaglia eÁ catalogata in A. CIANA, Primo tentativo di un cata-logo generale cronologico delle medaglie triestine coniate, « Archeografo Triestino », s. IV,XXVII-XXVIII (1965-1966), pp. 395-398.
76 Sulla sua figura vedi L. BARSAN, Di Pietro Stancovich, « L'Istria », VII, 39 (1852), p.181; P. TOMASIN, Il canonico Pietro Stancovich, «Archeografo Triestino », s. II, IV (1876),pp. 134-160; D. CERNECCA, Pietro Stancovich, «Atti del Centro di ricerche storiche di Ro-vigno », I (1970), pp. 163-174 e ID., Pietro Stancovich-vita e opere, « Jadranski zbornikIV», Fiume-Pola 1960, pp. 5-50; M. BERTOSÏA, Frammento di una autotestimonianza (Pie-tro Stancovich nel 1850-par lui meÃme), «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno »,XIV (1983-1984), pp. 245-250; A. TRAMPUS, Alcuni documenti su Pietro Stancovich, «Attidel Centro di ricerche storiche di Rovigno », XVIII (1987-1988), pp. 121-129.
77 Mi riferisco a quanto scrisse Domenico Rossetti in una lettera del 25 febbraio1826 all'amico Pietro Nobile; Rossetti aveva da poco letto lo studio di Stancovich sul-l'anfiteatro di Pola (Venezia, 1822) che «mosse qua e laÁ anche a me la bile ». Nell'estatedel 1825 inoltre «me l'avea mossa l'autore medesimo che, presentatomi da Lugnani nelmio giardino, mi tenne a bada quasi due ore parlando sempre di se e delle sue archeo-logiche scoperte » (cfr. TANZI, Alcune lettere, cit., p. 75). Stranamente questi brani ven-nero ignorati da G. VIDOSSICH, Quattro lettere inedite di Domenico Rossetti, « Archeo-grafo Triestino », s. III, VII (1913), pp. 163-184 che, pubblicando le missive di Rossettia Stancovich, accennoÁ soltanto al fatto che la relazione fra i due « pare piuttosto di let-tere che d'affetto amicale » (p. 174).
78 CERNECCA, Pietro Stancovich, cit., p. 171.
A Trieste la pubblicazione dei tre volumi venne accompagnatada una lunga recensione su « L'Osservatore Triestino » del 14 luglio1829 79. Il brano, apparso nella rubrica VarietaÁ ispirata dal mottoUtile Dulci, uscõÁ anonimo ma non eÁ difficile identificarne l'autorenel capodistriano Giuseppe de Lugnani, compilatore del giornaletriestino e buon amico dello stesso Stancovich 80. Proprio a de Lu-gnani l'autore della Biografia degli uomini distinti dell'Istria aveva de-dicato la propria opera con una lettera assai lusinghiera premessa alprimo volume e datata Barbana 28 novembre 1828 81; e quindi deLugnani, amico carissimo, figlio illustre di Capodistria e stimato trie-stino d'elezione (tanti erano i titoli conferitigli) recensiva il lavoro sulfoglio triestino con benevola considerazione.
Tale recensione affianca e segue in ordine cronologico due docu-menti rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Venezia. Si tratta dei pa-reri della Censura veneta sul manoscritto della Biografia che PietroStancovich presentoÁ per la pubblicazione. All'opera dell'istriano fusufficiente, come si rileva dalla lettura dei documenti, l'admittiturad imprimendum del censore veneto Luigi Montan, giaccheÁ lo scrittonon presentava, almeno esteriormente, passi occorrenti di revisio-ne 82. Del resto i due pareri elogiavano l'opera, che fu approvata sen-za riserve apprezzabili.
345
79 Annunzi tipografici-Biografia degli uomini distinti dell'Istria del canonico PietroStancovich, « L'Osservatore Triestino », n. 330, 14 luglio 1829.
80 Su de Lugnani oltre a GENTILE, Vita triestina, cit., pp. 3-70, si veda anche R.DOLLOT, Un precurseur de l'Unite italienne, l'aõÈeul de Paul ValeÂry: Giulio Grassi(1793-1874), « E tudes Italiennes », n.s., II, 1 (1932), pp. 17-18.
81 STANCOVICH, Biografia, cit., I, pp. 4-7 (riprodotta anche in GENTILE, Vita triesti-na, cit., pp. 21-22). Non figura nella seconda edizione del 1888.
82 Esistono solo i pareri, che pubblichiamo in appendice, relativi ai primi due tomidella Biografia; infatti il terzo nacque dalla divisione del secondo in due parti distintedata la quantitaÁ di materiale raccolto da Stancovich. Di cioÁ avvertiva egli stesso nella pre-fazione al terzo tomo.
XII. - CZOERNIG, LE RIFORME E LA STORIA DELL'AM-MINISTRAZIONE FISCALE A TRIESTE
Non molti anni or sono, in un'ampia panoramica sull'immaginedell'Italia nella cultura tedesca tra Settecento e Ottocento, WolfgangAltgeld ricordava un fenomeno che fa capire in che misura la com-prensione dell'Ottocento passi anche attraverso una piuÁ attenta co-noscenza del secolo precedente: l'immagine della penisola rimanevalegata ampiamente ad uno stereotipo settecentesco, frutto anche del-la letteratura del Grand Tour, che riconosceva vivacitaÁ degli abitanti ericchezze artistiche e naturali, ma vedeva l'Italia come esempio di de-cadenza politica e morale, di scarsa solidarietaÁ collettiva, di inesisten-te identitaÁ nazionale 1. Si tratta opinioni ricorrenti, anche nella cultu-ra austriaca, che rappresentano peroÁ anche lo specchio di un altroatteggiamento tipico dell'epoca, che eÁ quello della costante curiositaÁe attenzione per la situazione italiana, diffusa non soltanto a livelloletterario, ma anche politico, economico e sociale.
Un esempio di come quest'interesse per l'Italia venisse evolven-dosi, e di come Trieste con la sua regione diventasse uno degli osser-
346
1 W. ALTGELD, Das politiche Italienbild der Deutschen zwischen AufklaÈrung und eu-ropaÈischer Revolution von 1848, Niemeyer, TuÈbingen 1984, pp. 21-22; altri riferimenti inI. M. BATTAFARANO (a cura di), Deutsche AufklaÈrung und Italien, Lang, Bern-Frankfurt a.M. 1992; per l'Austria J. BERGHOLD, Das OÈsterreichbild in Italien und das Italienbild inOÈsterreich, in MAZOHL-WALLNIG, MERIGGI (a cura di), OÈsterreichisches Italien, cit., pp.29-55.
vatori privilegiati per accedere a questo mondo, si ha nell'opera diCarl von Czoernig (1804-1889), funzionario boemo formatosi traVienna e Trieste, vissuto lungamente a Milano e considerato il fon-datore della scienza statistica austriaca 2.
Quasi in apertura della propria autobiografia, intitolata Biogra-phische Notizen, Czoernig, ricordando sommariamente l'inizio dellapropria carriera in seno all'amministrazione dello Stato, si soffermavasul suo primo soggiorno triestino, indicandolo come fondamentaleper la propria maturazione scientifica 3. A Trieste, tra il 1828 ed il1831, aveva visto con soddisfazione i primi positivi apprezzamentisulle proprie ricerche storiche 4, lõÁ aveva cominciato a stringere ami-cizie utili e durature, lõÁ pure aveva conosciuto i caratteri e i problemidi un grande emporio; ancora lõÁ, per sua stessa ammissione 5, avevaincominciato a dedicarsi piuÁ intensamente agli studi di statisticache tanto proficuamente avrebbe sviluppato negli anni successivi.
Nonostante in vecchiaia avrebbe riconosciuto che proprio nellacittaÁ adriatica aveva ricevuto nuovo impulso la sua attivitaÁ di storico± con uno studio (perduto) sul movimento statistico e demograficodella popolazione di Trieste intorno al XVI secolo 6 ± Czoernig tace-
347
2 Per la biografia cfr. M. TONETTI, Carl Czoernig: la vita e le opere e U. CORSINI,Czoernig e il Risorgimento italiano, entrambi in Karl Czoernig fra Italia e Austria, Istitutodi Storia sociale e religiosa, Gorizia 1992, rispettivamente alle pp. 1-16 e 17-40.
3 C. VON CZOERNIG, Biographische Notizen, Der Verfasser, Wien 1879 con l'appen-dice di ID., Anhang zu den biographischen Notizen, fuÈr den Zeitraum von 1880-1887, DerHerausgeber, Wien 1888.
4 Aveva giaÁ pubblicato nel 1827 un lavoro su Reichenberg, poi ampliato ed editocome monografia: Topographisch-historisch-statistische Beschreibung von Reichenberg,Gerold, Wien 1829. Una lunga recensione di questo volume, anonima, apparve in piuÁpuntate su « L'Osservatore Triestino » con il titolo Statistica nei numeri 383 del 14 no-vembre 1829 (p. 1552), 389 del 28 novembre (p. 1556), 393 del 10 dicembre (p. 1572),394 del 12 dicembre. L'autore della recensione puoÁ essere identificato forse in Giuseppede Lugnani, collaboratore del giornale per gli argomenti culturali.
5 CZOERNIG, Biographische Notizen, cit., p. 6: « trat ich im Jahre 1828 in der Staat-sdienst, in welchem ich bald die Bestimmung nach Triest erhielt. Den zweijaÈhrugen Au-fenthalt daselbst benuÈ tzte ich zu statistischen Studien ».
6 CZOERNIG, Biographische Notizen, cit., p. 6: «Die damals besonders in AufbluÈ henstehende Populations-Statistik suchte ich durch eine bis in's 16. Jahrhundert hinauf rei-cende Darstellung der BevoÈ lkerungs-VerhaÈ ltnisse von Triest zu foÈ rdern (Das Manu-script dieser bereits sehr vorgeruÈ ckten Arbeit ging leider verloren) ». Da notare che
va un fatto che certamente giaÁ allora era destinato a lasciare un segnonella sua personalitaÁ culturale: il primo incontro, cioeÁ , con una cul-tura e con una lingua diverse da quelle d'origine, il contatto con lasocietaÁ italiana, i cui caratteri di lõÁ a qualche anno avrebbe descrittoaccuratamente in Italienische Skizzen.
EÁ comprensibile che all'epoca un funzionario come Czoernig,dalla solida preparazione culturale e con una certa sensibilitaÁ perl'ambiente nel quale si trovava, giovane e pronto a cogliere nuove sol-lecitazioni culturali, non fosse destinato a rimanere del tutto isolatoin un ambiente vivace come la Trieste del tempo 7. Fin dagli annidel suo soggiorno triestino, infatti, egli prese a frequentare l'unico so-dalizio culturale nel quale poteva discutere le ricerche storiche cheandava compiendo, cioeÁ la SocietaÁ di Minerva, decisamente legalita-ria sul piano politico ma altrettanto chiaramente orientata verso lacultura italiana 8. In quella sede Czoernig si presentoÁ sin dal 13 gen-naio 1830 con una conferenza su Albrechts von Wallenstein Versucheeiner ihm ergebenen staÈndischen Verfassung 9, su un tema che, inqualche modo, preludeva agli interessi maturati piuÁ tardi con gli stu-di sulla costituzione comunale lombarda 10. Sempre alla SocietaÁ di
348
con questo lavoro Czoernig avrebbe anticipato di quasi ottant'anni lo studio analogo diP. MONTANELLI, Il movimento storico della popolazione di Trieste, con 4 diagrammi, 2 ta-belle statistiche e 13 documenti inediti, Balestra, Trieste 1913. Su questi temi cfr. ora an-che A. VASCOTTO, La popolazione di Trieste nel censimento del 1765 e A. SPONZA, La po-polazione di Trieste nel censimento del 1775, entrambi in ANDREOZZI, C. GATTI (a curadi), Trieste e l'Adriatico, in particolare pp. 48-65 e 75-84.
7 Per un inquadramento dell'ambiente culturale e sociale della Trieste prequaran-tottesca cfr. APIH, La societaÁ triestina tra il 1815 ed il 1848, cit., pp. 25-38; CERVANI, Laborghesia triestina, cit., soprattutto la parte prima; NEGRELLI (a cura di), La Favilla, cit.
8 GENTILE, Il primo secolo, cit., pp. 122-123, dove sono ricordate le conferenze diCzoernig.
9 Si veda anche il ms. autografo D. ROSSETTI, Minerva, Conversazioni accademiche1812-1842, in ADTs, segn. 1/2 C 29, sub 13 gennaio 1830.
10 C. VON CZOERNIG, Die lombardische Gemeinde-Verfassung nach ihrer Entstehungund Ausbildung, ihrem Verfallen und ihrer Wiederherstellung, Heidelberg 1843, utilizza-ta da M. MERIGGI, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848), ilMulino, Bologna 1983, pp. 175-177 e ID., Czoernig liberale nostalgico. Gli scritti italiani,« Il Risorgimento », XLIII, 1 (1991), pp. 101-113 (anche in Karl von Czoernig, cit., pp.49-52). Uno studio accurato dell'opera di Czoernig si deve anche a M. TONETTI, Die ita-lienische Provinzen unter oÈsterreichischer Verwaltung in den Schriften von Carl Frh. von
Minerva il giovane boemo tornoÁ il 30 marzo dello stesso anno perintrattenere il pubblico su Ausflug von Triest nach Udine 11; un argo-mento che, nonostante il titolo apparentemente assai limitativo, rive-lava un acuto osservatore e penetrante studioso dei modi e dei carat-teri delle popolazioni italiane. Tra le due conferenze, invece, interve-niva il 10 febbraio un altro giovane, il triestino Pietro Kandler,analizzando il quesito A quale provincia appartiene Trieste, ed a qualeregione l'Istria 12.
Nella primavera del 1831 Czoernig giaÁ si era trasferito a Milano,ma nei due anni di permanenza a Trieste, oltre ad ottenere soddisfazio-ni in campo professionale 13, aveva potuto continuare gli studi storici,pubblicando i testi delle conferenze tenute presso la SocietaÁ di Miner-va 14 e preparando uno studio puntuale sui porti franchi di Venezia edi Trieste e sull'importanza per la monarchia delle linee commercialicon l'Oriente: il volumetto dal titolo UÈber den Freyhafen von Venedig,mit RuÈcksicht auf den oÈsterreichischen Seehandel im Allgemeinen 15.
A Milano, dove operava, Czoernig avrebbe pubblicato inveceItalienische Skizzen, nel cui primo volume due capitoli richiamavano
349
Czoernig, tesi di laurea, relatore Umberto Corsini, UniversitaÁ Ca' Foscari di Venezia, Fa-coltaÁ di Lingue e letterature straniere, a.a. 1986-1987, che edita alle pp. 99-230 il mano-scritto Ursachen der Revolution in Italien.
11 ADTs, segn. 1/2 C 29, sub 10 marzo 1830, corretta da Rossetti nel 30 marzo.12 ADTs, segn. 1/2 C 29, sub 10 febbraio 1830.13 A Trieste fu alunno di concetto presso la direzione di polizia, poi venne promos-
so sottocommissario di polizia a Milano. Cfr. anche L. FACCINI, La scienza del governo el'indagine storica. Un funzionario austriaco dalla Boemia alla Contea di Gorizia, « StudiGoriziani », 69 (1989), p. 8.
14 Come informa lo stesso Czoernig nelle Biographische Notizen (cit., p. 88), lo stu-dio fu pubblicato nel vol. I (1830) dell'Hormayr's Taschenbuch fuÈr vaterlaÈndische Ge-schichte con il titolo Versuche Albrecht's von Waldstein, eine staÈndische Verfassung in sei-nem Herzogthum einzufuÈhren e, riveduto, lo stesso anno nel «Monatsschrift des boÈhmi-schen Museums » con il titolo Albrecht's von Waldstein urkundlich erwiesener Versuch,sein Herzogthum Friedland als ein selbstaÈndiges Gebiet zu organisieren.
15 C. VON CZOERNIG, UÈber den Freyhafen von Venedig, mit RuÈcksicht auf den oÈster-reichischen Seehandler im Allgemeinen. Nebst einer vergleichenden UÈbersicht der Indu-strieverhaÈltnisse Grossbritannien's, Frankreich's und OÈsterreich's, Gerold, Wien 1831.Si trattava della sua seconda monografia, dopo quella su Reichenberg (ampliamento asua volta dello studio BeitraÈge zur Landeskunde BoÈhmens: Reichenberg, «Hormay's Ar-chiv », 1827).
ancora l'esperienza triestina: il primo, Der Corso zu Triest 16, ripren-deva un testo analogo giaÁ edito nel 1830 17; l'altro, Ausflug von Triestnach Udine, sviluppava la conferenza tenuta alla SocietaÁ di Minerva.
Il titolo stesso, Italienische Skizzen, avverte sull'eterogeneitaÁ delcontenuto poiche , infatti, ogni capitolo risulta essere la riedizione ol'ampliamento di altrettanti scritti pubblicati da Czoernig tra il1828 e il 1838. Non si tratta di un diario di viaggio o di una raccoltaorganica di impressioni su particolari aspetti o problemi della vitapolitica ed economica; piuttosto si offre al lettore una serie di bozzet-ti che concorrono a fornire un quadro variegato e vivace della societaÁitaliana del tempo, vista criticamente da un brillante funzionario au-striaco della prima metaÁ del secolo. CosõÁ, infatti, nel primo volumet-to, accanto ai capitoli su Trieste e sul viaggio a Udine, si leggono bra-ni sull'apertura del porto franco di Venezia e sulle relative ripercus-sioni politiche ed economiche 18, sul camposanto di Bologna 19, suMontevecchia nella Brianza 20, ed alcune notizie statistiche riguar-danti la Brianza 21. Parallelamente, nel secondo si indulge a note cri-tiche sul teatro italiano dell'Ottocento, sugli impresari e sui librettid'opera, sulle caratteristiche del pubblico e cosõÁ via. Si tratta, anchein questo caso, della rielaborazione di articoli giaÁ pubblicati nei gior-nali milanesi.
Nella descrizione del Corso di Trieste, in particolare, Czoernig sirivela attento e critico osservatore di una societaÁ diversa da quellad'origine, della quale sono colti l'attivismo e lo spirito fantasiosoma non privo di qualche difetto, il carattere cosmopolita, la tolleran-za dei culti e la varia provenienza etnica. Vi eÁ un'attenta descrizionedella tipologia e della distribuzione delle professioni, con un interesse
350
16 C. VON CZOERNIG, Italienische Skizzen, Pitotta, Mailand, 1838, pp. 1-16.17 C. VON CZOERNIG, Der Corso zu Triest, « JahrbuÈ cher des BoÈhmischen Mu-
seums », 1830 (cfr. ID., Biographische Notizen, cit., pp. 88)18 CZOERNIG, Italienische Skizzen, I, cit., pp. 73-100 (Die EroÈffnung des Freyhafens
von Venedig).19 CZOERNIG, Italienische Skizzen, I, cit., pp. 177-204 (Der Friedhof von Bologna).20 CZOERNIG, Italienische Skizzen, I, cit., pp. 205-244 (Montevecchia, eine Fernsicht
in der Brianza).21 CZOERNIG, Italienische Skizzen, I, cit., pp. 245-258 (Statistiche Notiz uÈber die
Brianza).
specifico per quelle minori del facchino e del ciabattino, delle qualiperoÁ si riconosce l'importanza in un sistema economico complesso diun emporio non animato esclusivamente da uomini d'affari. Czoernigsi rivela quindi soprattutto un cronista di alta cultura e ci restituisceun reportage di grande accuratezza. Il Corso di Trieste per lui eÁ lametafora dell'incontro fra civiltaÁ , professioni e anime diverse, quasila rappresentazione vivente di forze che interagiscono tra di loro.Non meno precisa eÁ la descrizione della gita da Trieste a Udine, incui all'ampia descrizione di elementi naturali e del paesaggio si ac-compagnano rilievi di carattere storico-architettonico e notazioni at-tente sulla popolazione contadina e sulla sua attivitaÁ economica, non-che sul carattere plurilingue degli abitanti 22.
Se eÁ ben vero che, almeno per quanto riguarda i riferimenti di-retti alle regioni orientali d'Italia, l'interesse di Czoernig fu soprattut-to di carattere statistico-economico e non storico, eÁ anche vero chemolte delle sue successive considerazioni e conclusioni in tema dieconomia e di libero scambio, di sviluppo commerciale e di ammini-strazione fiscale, trassero origine proprio dall'esperienza triestina.CosõÁ nel lavoro sui porti-franchi di Venezia e di Trieste sono conte-nuti in nuce molti degli argomenti che avrebbe poi sviluppato nonsoltanto in articoli di giornale e in vari periodici, ma pure nelle mo-nografie sulla statistica dell'Impero e sull'amministrazione fiscale del-lo Stato. La consapevolezza, maturata e sempre piuÁ resa evidente neisuoi scritti, dell'importanza fondamentale per la monarchia e per lasua economia del Lloyd Austriaco derivoÁ essenzialmente dalle osser-vazioni triestine e avrebbe trovato poi rafforzamento nella comunan-za di interessi con il ministro von Bruck 23, personaggio che assieme a
351
22 CZOERNIG, Italienische Skizzen, II, cit., pp. 17-72 (Ausflug von Triest nach Udine).23 Sui rapporti fra Czoernig e von Bruck si veda CZOERNIG, Biographische Notizen,
cit., pp. 14-15. Per la figura di von Bruck, artefice delle fortune del Lloyd Austriaco epoi ministro per il commercio cfr. R. CHARMATZ, Minister Freiherr von Bruck: der Vor-kaÈmpfer Mitteleueropas, Duncker, Leipzig 1916; G. STEFANI, B. ASTORI, Il Lloyd Triesti-no. Contributo alla storia italiana della navigazione marittima, Mondadori, Milano 1938,pp. 1-156; R. E. COONS, I primi anni del Lloyd Austriaco. Politica di governo a Vienna ediniziative imprenditoriali a Trieste (1836-1848), tr. it., Del Bianco, Udine 1982.
Hartig 24 avrebbe rappresentato uno dei riferimenti piuÁ importantinella sua carriera.
Del resto va osservato che proprio gli anni del suo soggiorno trie-stino videro lo sviluppo decisivo della Confederazione germanica e ilmaturarsi del Deutscher Zollverein, elementi che tanto spazio avreb-bero trovato nella sua concezione dinamica dello Stato e dell'econo-mia europea 25.
In questa prospettiva assume grande significato e valore quasiemblematico il successivo soggiorno triestino di Czoernig negli anni1850-1852 che vide, per effetto del proficuo incontro con von Bruck,la trasposizione nella realtaÁ di quanto aveva teorizzato negli anni pre-cedenti. Czoernig venne chiamato da von Bruck, con il quale era sta-to deputato alla Dieta di Francoforte, per l'organizzazione del Go-verno centrale marittimo di Trieste, opera di spicco nel piano delleriforme attuate nel decennio successivo alle vicende quarantottesche.Il programma politico di Czoernig in quegli anni fu tutto teso all'at-tuazione del vasto progetto di riforme e di riorganizzazione dellestrutture dello Stato che, per il Litorale, realizzavano l'obiettivo delcontrollo dell'amministrazione periferica mediante la riforma degliuffici in senso centralizzato. L'istituzione del Governo marittimo aTrieste corrispondeva quindi ad un'esigenza di razionalizzazione eregolamentazione della vita economica, coerente con la necessitaÁ dimodernizzare la monarchia e di preservare i princõÁpi del libero scam-bio. All'interno di questo quadro erano previste nuove forme di in-tervento diretto dello Stato con spirito cautamente progressista (fal-lite le quali si sarebbe dato vita alla Duplice monarchia); quello stessotipo di intervento diretto che Czoernig aveva giaÁ teorizzato in qual-che modo negli anni precedenti in UÈber die Ursachen der Revolutionin Italien 26. EÁ ben comprensibile allora il favore dimostrato daCzoernig per l'iniziativa, confermato anni dopo quando avrebbe ri-cordato l'assunzione di quell'incarico: « Ich unterzog mich dieser
352
24 Sui rapporti tra Czoernig e Franz Hartig cfr., oltre a CZOERNIG, BiographischeNotizen, cit., anche MERIGGI, Amministrazione, cit., pp. 153-157 e passim.
25 Cfr. anche FACCINI, La scienza del governo, cit., pp. 11-12.26 CosõÁ MERIGGI, Amministrazione, cit., p. 156.
Auftrage mit freudiger Energie, da er mich der FoÈ rderung einer mei-ner Lebensaufgaben [...] naÈher brachte » 27. L'impegno profuso eÁ te-stimoniato da non pochi documenti autografi conservati nei fondi ar-chivistici del Governo marittimo, dalle relazioni dettagliate a vonBruck, dai testi che predisposte per la Dienst-Instruction pubblicatanello stesso 1850 in traduzione italiana con il titolo Istruzione di ser-vizio del Governo centrale marittimo 28.
Czoernig, assunta cosõÁ nell'ottobre 1850 « la gerenza direttiva de-gli affari di questo governo centrale » 29, fu uno dei principali arteficidella creazione di una nuova autoritaÁ amministrativa e finanziaria, ilGoverno centrale marittimo con sede a Trieste, dipendente diretta-mente dal Ministero del commercio, con competenza territorialesul Veneto, sul Litorale, sulle coste ungaro-croate e dalmate e concompiti specifici nei settori della direzione e vigilanza del servizioportuale e della regolamentazione e sorveglianza del servizio di sanitaÁmarittima 30. In piuÁ , e cioÁ pare indizio alquanto significativo dellospirito dell'intero lavoro, l'opera avrebbe dovuto trovare coronamen-to e disciplina in un nuovo codice di diritto marittimo 31.
Istituito con sovrana Risoluzione del 30 gennaio 1850 e discipli-nato da un'ordinanza del 26 aprile del Ministero del commercio,pubblicata nel « Bollettino delle leggi dell'Impero » 32, il Governocentrale marittimo inizioÁ l'attivitaÁ il 1ë maggio, assumendo il caratteredi ufficio centrale preposto all'amministrazione, nell'ambito territo-riale di competenza, degli uffici di porto e di sanitaÁ marittima, delle
353
27 CZOERNIG, Biographische Notizen, cit., p. 15.28 Istruzione di servizio del Governo Centrale Marittimo, Tipografia del Governo,
Trieste 1850. I documenti che comprovano l'impegno di Czoernig si trovano in ASTs,Governo Centrale Marittimo (SeebehoÈrde) in Trieste (1850-1923), busta I, fasc. 1/1 ±1850, carte non numerate, dove eÁ conservata pure copia dell'Istruzione di servizio citata(prot. n. 1232) con l'originale manoscritto in lingua tedesca (Dienst-Instruction, di 9 cc.non numerate) annotato da Czoernig (prot. n. 1084). Di Czoernig si conserva, tra l'altro,pure una lunga relazione autografa a von Bruck datata Trieste, 4 luglio 1850 (cc. 4, prot.n. 2003).
29 ASTs, Governo Centrale Marittimo, busta I, prot. n. 1757.30 Sul Governo Centrale Marittimo e sulle sue funzioni cfr. in sintesi COVA, Nota
per una storia, cit., e ZÏ ONTAR (a cura di), HandbuÈcher, cit., p. 145.31 CZOERNIG, Biographische Notizen, cit., p. 15.32 « Bollettino delle leggi dell'Impero », 178 (1850), pp. 838-840.
deputazioni di porto e di sanitaÁ marittima, delle agenzie e delle espo-siture di porto, dei lazzaretti marittimi. Vennero istituiti degli ufficicentrali di porto quali organi amministrativi intermedi fra il governomarittimo e gli uffici di porto e di sanitaÁ marittima, per un migliora-mento dell'attivitaÁ in senso centralizzato, gerarchico e opportuna-mente controllato 33.
Gli operatori portuali e particolarmente i piloti di porto furonoriuniti in corporazioni, o meglio corpi, in modo tale da provvederead una migliore organizzazione del lavoro e delle opere assistenziali 34.
Quest'attenzione per gli organi sociali intermedi, organizzati incorpi o corporazioni, segno evidente di una preoccupazione chenon era soltanto quella di provvedere alla loro regolamentazione, eÁrivelatrice della concezione politica di Czoernig e della sua opinionecirca la funzione e il ruolo degli ordini sociali. Fin dall'epoca del suomemoriale sulle cause delle rivoluzioni in Italia, infatti, Czoernig ave-va analizzato i caratteri della societaÁ lombarda ponendoli a confrontocon quelli della societaÁ austriaca e boema esprimendosi a favore diuna concezione organica della societaÁ italiana, che invece consideravafino a quel momento « inorganica » o «materialista ». Il mantenimen-to degli ordini sociali secondo il modello asburgico, quindi coerente-mente con l'assetto della Restaurazione, avrebbe garantito secondolui una migliore governabilitaÁ e un migliore controllo da parte del-l'autoritaÁ 35. Come opportunamente ha segnalato Meriggi 36, si trattadi opinioni che, mutuate dalla cultura politica metternichiana, tradi-vano la sua formazione intellettuale giuseppina e ben possono essereaccostate ad analoghe idee propugnate da Sonnenfels nel penultimodecennio del Settecento 37. Questo suggerimento trova senz'altroconferma ove si tenga conto che gli scritti di Sonnenfels ancora nel
354
33 Il dettaglio in F. BABUDIERI, I porti di Trieste e della regione Giulia dal 1815 al1918, « Archivio economico dell'unificazione italiana », s. I, XIV/1 (1965), pp. 15-16.
34 Kundmachung des k.k. Guberniums in oÈsterreichisch-ilirischen KuÈstenlandes, nr.4610/1512 del 17 marzo 1850, di cui esiste copia presso l'Archivio storico della Cameradi Commercio di Trieste, riprodotta in BABUDIERI, I porti, cit., p. 16, tavola fuori testo.
35 M. MERIGGI, Il regno lombardo-veneto, UTET, Torino 1987, pp. 108-109.36 MERIGGI, Il regno, cit., p. 144.37 Sul punto anche cfr. DI SIMONE, Aspetti, cit., pp. 141-142.
secondo e terzo decennio dell'Ottocento, cioeÁ proprio nell'epoca incui Czoernig studiava all'universitaÁ , erano considerati fondamentali eformativi 38.
EÁ naturale che dalla nuova esperienza triestina giungessero aCzoernig altre occasioni per studi e riflessioni sull'economia austria-ca, sullo sviluppo dello Zollverein e sul ruolo dei porti adriatici diTrieste e di Venezia. Tra gli interventi di quel periodo merita quindiparticolare attenzione il saggio edito nel 1851 nelle «Mittheilungenaus dem Gebiete der Statistik » 39, integralmente ripubblicato poisulla « Triester Zeitung » dello stesso anno 40, sviluppo di un articologiaÁ apparso nel 1836 41.
Riprendendo il filo delle riflessioni degli anni precedenti e matu-ratosi ormai negli studi economici con l'esperienza lombarda 42,
355
38 KINK, Geschichte, I, cit., p. 469 e passim. Sugli studi compiuti da Czoernig cfr. lascheda biografica in VON WURZBACH, Biographisches Lexikon, III, cit., pp. 117-120 (labiografia si ferma al 1857), nonche FACCINI, La scienza, cit., p. 7 e TONETTI, Carl Czoer-nig, cit., pp. 1-2. PuoÁ essere interessante ricordare, per un eventuale confronto sul me-todo e sulla possibile analogia di contenuti, che proprio Sonnenfels aveva pubblicatouno scritto UÈber die Ursachen der franzoÈsischen Revolution, «Der neue Teutscher Mer-kur », III, 7 (1797).
39 C. VON CZOERNIG, Bericht uÈber die Schiffarts- und HandelsverhaÈltnisse Venedigs,verglichen mit jenen von Triest, «Mitthelungen aus dem Gebiete der Statistik », 9(1851).
40 Con il titolo Dr. Czoernig's Bericht uÈber die Handels- und SchiffahrtsverhaÈltnisseTriests und Venedigs, « Triester Zeitung », I, 180, 29 ottobre 1851 e I, 181, 30 ottobre1851. L'articolo fu annunciato sulla « Triester Zeitung » del 25 ottobre (I, 177) con lanotazione: «Diese Schrift ist viel zu wichtig, im nicht eines Weiteren besprochen zu wer-den, und wir behalten uns vor, in unserem naÈchsten Blatte auf dieselbe ausfuÈ hrlich zu-ruÈ ckzukommen ». Da segnalare ancora alcuni interventi di Czoernig in quegli anni ri-guardanti Trieste: lo scritto UÈber die GruÈndung eines Statuts und einer UnterstuÈt-zungs-Casse in Triest (« Triester Zeitung », 1852) e il precedente articolo Richtung derStaatseisenbahn von Laibach nach Triest («Austria », 166, 1848).
41 Aumento del commercio di Trieste 1816-1836, «Gazzetta di Milano », 1836, tra-duzione dell'articolo Zunahme des Handels von Triest apparso quello stesso anno in«Echo. MailaÈnder Zeitschrift ».
42 Sull'esperienza lombarda di Czoernig si veda, oltre ai precedenti saggi di Merig-gi, anche ID., Czoernig, Mittermeier e la societaÁ lombarda, « Storia in Lombardia », VII, 3(1988), pp. 57-73; L. FACCINI, Karl Czoernig e la statistica agraria in Lombardia, « SocietaÁe storia », 10 (1980), pp. 931-950; ID., D. PORCEDDA (a cura di), Agricoltura e condizionidi vita dei lavoratori agricoli lombardi 1835-1839. Inchiesta di Karl Czoernig, Bibliogra-fica, Milano 1986.
Czoernig si soffermava specificamente sui rapporti commerciali emarittimi fra Trieste e Venezia, analizzando le funzioni dei due portie il carattere potenzialmente concorrenziale delle rispettive operazio-ni commerciali e rivelandosi cosõÁ ancora una volta osservatore precisodi fenomeni che negli anni successivi si sarebbero imposti all'atten-zione degli operatori con maggiore evidenza 43. Constatata la situa-zione di degrado del commercio veneto rispetto a quello del Litorale,nonostante l'istituzione del porto franco e l'esistenza di un vasto re-troterra, intendeva individuare la funzione specifica dei due porti al-l'interno della Confederazione germanica, indicando i modi per svi-lupparne la produttivitaÁ e per consentire la completa attuazione del-l'unione doganale. Tutto cioÁ doveva avvenire in armonia con iprivilegi del porto franco giaÁ esistenti, sui quali esprimeva tuttaviaqualche riserva, ritenendoli opportuni ma meglio distribuibili me-diante un'attenta revisione dell'amministrazione fiscale e un riequili-brio dell'economia statale. Riaffermava la funzione vitale del porto diTrieste per l'economia austriaca 44, suggerendo tuttavia che alcunecompetenze specifiche e alcune linee commerciali (con le isole bri-tanniche e con l'America) fossero destinate a Venezia, anziche a Trie-ste, in modo da ossigenare l'economia della cittaÁ lagunare e allegge-rire il carico di Trieste, dove si sarebbe dovuto creare nuovo spazioper lo sviluppo delle linee con l'Oriente. Oltre a cioÁ , mediante un'at-tenta revisione della fiscalitaÁ e con un'accorta ridistribuzione dei pri-vilegi nonche con la razionalizzazione delle imposte doganali, si sa-rebbe potuto raggiungere quel livellamento necessario per porreTrieste in posizione ancor piuÁ concorrenziale rispetto ai porti di Am-burgo e di Rotterdam. Trieste, lo scalo marittimo piuÁ interno delcontinente europeo, non aveva ancora raggiunto ± a suo parere 45
356
43 Si vedano i termini del problema posti da SALIMBENI, Trieste tra Venezia e Vien-na, cit., pp. 47-52.
44 CZOERNIG, Bericht, cit., parte prima (I, 180, 29 ottobre 1851).45 «Hiermit hat sich Triest seinen Platz unter den wichtigsten HandelsplaÈtzen des
Continentes erworben, und die rasche Zunahme seines Handels in den letzten Jahrenzeigt, daû es noch nicht auf dem HoÈhenpuncte seiner Entwickelung ist. Triest ist deram tiessten in das Herz des Continentes eindingende Punct, bis wohin das Meer reicht;dies erleichtert wesentlich die Einfuhr der uÈberseeischen Producte. Die Grundlage sei-
± l'apice dello sviluppo e soltanto una piuÁ organica attuazione deiprincõÁpi enunciati avrebbe potuto garantire la completa realizzazionedella visione europea, e non semplicemente pangermanica di Czoer-nig; una visione che arditamente, ma non a torto, si eÁ voluta avvici-nare all'idea di Mercato Comune Europeo 46.
Acquista pertanto particolare rilievo il contenuto del volumeOÈsterreich's Neugestaltung edito nel 1858 47, opera di carattere nonsemplicemente tecnico-finanziario ma di notevole significato politicoe sintesi di un'intera stagione di riforme amministrative e finanziarie,attuate nell'Impero tra il 1848 e il 1858 nei piuÁ diversi settori dellavita pubblica ed economica: quasi un rapporto semiufficiale sulla« rifondazione » della monarchia, a dimostrazione delle capacitaÁ dirinnovamento e di superamento delle difficoltaÁ interne seguite al'48. In particolare, vi si concedeva ampio risalto all'istituzione delGoverno centrale marittimo e alle sue funzioni 48, al ruolo del portofranco di Trieste e alle riforme in esso attuate nel 1853 49, al poten-ziamento delle comunicazioni ferroviarie tra i porti dell'Adriatico e ilcuore dell'impero e alla revisione e razionalizzazione dell'amministra-zione fiscale e doganale. Per Trieste, ancora, veniva ricordata l'operapositiva del ministro von Bruck, del quale si sottolineavano le capa-citaÁ professionali, l'esperienza triestina al Lloyd Austriaco e l'operariformatrice e illuminata 50.
357
nes Bestandes und seines AufbluÈ hens muû Triest darin finden, daû es der wichtigsteund nebst Venedig fast einzige bedeutende Hafen eines groûen volkreichen Staatesist » (CZOERNIG, Bericht, cit., ibidem).
46 CosõÁ FACCINI, La scienza, cit., p. 12.47 C. VON CZOERNIG, Oesterreich's Neugestaltung 1848-1858, Cotta, Stuttgart und
Augsburg 1858.48 CZOERNIG, Oesterreich's Neugestaltung, cit., pp. 52-55.49 CZOERNIG, Oesterreich's Neugestaltung, cit., p. 157.50 CZOERNIG, Oesterreich's Neugestaltung, cit., pp. 181-182: « Ein Mann, welcher in
dem grossartigen GeschaÈftsbetriebe des Welthandels-Platzes Triest seinen Blick ge-schaÈrft, seine Erfahrung gereift und von seiner energischen ThaÈtigkeit durch den vonihm ausgegangenen Aufschwung des oÈ sterreichischen Lloyd vollgiltiges Zeugniss abge-legt hatte. Die umfassenden und zahlreichen Reformen, welche er waÈhrend der verglei-chungsweise kurzen Zeit, als er dieses Ministerium leitete, theils durchfuÈ hrte theils an-bahnte, lassen am klarsten erkennen, dass er der hohen ihm gestellten Aufgabe gewach-sen war ».
EÁ interessante rilevare in queste pagine il riferimento diretto adun parallelismo tra l'epoca di Czoernig e quella delle riforme teresia-ne nel porto-franco 51. Raramente nelle precedenti opere di carattereeconomico-statistico egli aveva fatto riferimenti storici cosõÁ evidentied espliciti, preferendo dedicare all'interesse storico e storiograficouno spazio autonomo. Viceversa in quest'opera lo studioso boemointroduceva un richiamo diretto alle riforme teresiane, quasi a volersuggerire nel lettore che le nuove iniziative potevano essere compreseprima di tutto nel senso della continuitaÁ storica.
Fin dagli anni del soggiorno milanese, e in particolare nell'operasulla costituzione comunale lombarda, Czoernig aveva chiarito lapropria interpretazione della stagione delle riforme settecentesche,riconoscendone l'efficacia e individuandone anche alcuni limiti, spe-cialmente nel modo in cui era stata attuata la Riforma del governo edamministrazione delle ComunitaÁ dello Stato di Milano nel 1755 52.Per capire peroÁ come intendesse quest'ereditaÁ , alla luce della sua for-mazione metternichiana, e soprattutto come ritenesse collegati i mo-menti storici del riformismo teresiano, della politica giuseppina e delliberalismo postquarantottesco, occorre andare a vedere alcuni passidella sua storia di Gorizia e di Gradisca. PiuÁ precisamente, apparerivelatore il punto in cui, trattando dell'amministrazione fiscale e del-le riforme economiche, osservava: « I primi sintomi di una piuÁ illumi-nata economia comparvero sotto il governo di Maria Teresa, il cuisenso di giustizia aspirava a tassare in misura uguale tutti i suoi sud-diti. Il completo trionfo di questo principio ed il miglioramento dellasorte degli agricoltori erano previsti dalle riforme dell'imperatoreGiuseppe II le quali, se si fossero completamente attuate, avrebberoraggiunto questa meÁta molto piuÁ rapidamente di quanto non avvennenella vicenda degli avvenimenti successivi » 53.
358
51 CZOERNIG, Oesterreich's Neugestaltung, cit., p. 188 e passim. Si veda inoltre ID.,Das oÈsterreichische Budget fuÈr 1862, in Vergleichung mit jenen der vorzuÈglicheren andereieuropaÈischen Staaten, 4, k.k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1862, pp. 1-2.
52 CZOERNIG, Biographische Notizen, cit., pp. 34-35.53 C. VON CZOERNIG, Das Land GoÈrz und Gradisca, BraumuÈ ller, Wien 1873. La ci-
tazione eÁ dalla traduzione di Ervino Pocar pubblicata con il titolo Gorizia, « la Nizza au-striaca ». Il territorio di Gorizia e Gradisca, Cassa di Risparmio di Gorizia, Gorizia 1987.
Parallelamente a queste riflessioni, nel volume dedicato a DasoÈsterreichische Budget fuÈr 1862, in Vergleichung mit jenen der vorzuÈ-glicheren anderen europaÈischen Staaten, Czoernig affrontoÁ nuovamen-te questi problemi con lo stesso spirito, ma in funzione di proposteoperative alla luce del programma economico dello Stato per il 1862.
Dall'esame della produzione scientifica di Czoernig nel trenten-nio successivo al primo soggiorno triestino, e precedente il pensiona-mento, sembra emergere con sempre maggiore evidenza la matura-zione dello studioso e dello storico impegnato, consapevolmente av-vertito, cioeÁ , della possibilitaÁ di ricorrere ai frutti della ricerca storicaper trovare conferme di iniziative politiche ed economiche giaÁ in cor-so o per promuoverne di nuove. Czoernig concepiva quindi un usomilitante della storia e veniva allontanandosi da quella prospettivasemplicemente erudita che aveva fatto propria negli anni giovanili.In questo modo anticipava, in un certo senso, il futuro politico della« nazione » tedesca del Litorale 54 e si orientava verso quelle posizioniche avrebbero contribuito ad assegnargli una precisa, e in realtaÁ mar-ginale, collocazione nella storiografia sul Litorale.
Dopo il pensionamento e il trasferimento a Gorizia, Czoernig eb-be infatti rapporti saltuari, se non proprio occasionali, con gli am-bienti culturali della regione che ormai andavano riposizionandosisu atteggiamenti decisamente patriottici e filoitaliani 55. Lo studiosoboemo ± che forse proprio per questo scelse la piuÁ austriaca Goriziacome residenza ± non partecipoÁ ad alcuna attivitaÁ culturale triestina enon ristabilõÁ i contatti con la SocietaÁ di Minerva. Non tenne confe-renze, non pubblicoÁ saggi in riviste storiche e mantenne soltanto rap-porti con il giornale di lingua tedesca « Triester Zeitung », per il qua-le scrisse tra l'altro un lungo articolo sul Medioevo triestino 56.
359
54 Cfr. le esaurienti indicazioni di F. SALIMBENI, Carl von Czoernig storico della con-tea di Gorizia e Gradisca, « Studi Goriziani », 69 (1989), pp. 17-32.
55 Sul tema si veda soprattutto G. CERVANI, Il sentimento politico-nazionale e gli stu-di a Trieste nell'epoca dell'irredentismo. L'«Archeografo Triestino », « Rassegna Storicadel Risorgimento », XXXVIII, 3-4 (1951), pp. 317-331.
56 C. VON CZOERNIG, Ein Triester Staatsmann aus der Epoche Kaiser Karl's des Gro-ûen, « Triester Zeitung », nn. 87 e 88, 17 e 18 aprile 1873. Si tratta della rielaborazionedi alcuni brani della storia di Gorizia e Gradisca relativi a Fortunato di Aquileia.
L'unico con il quale continuoÁ a mantenere contatti fu PietroKandler, che aveva conosciuto negli anni giovanili e con il quale sonodocumentati rapporti anche per gli anni Cinquanta 57. Non meravi-glia che, tra quanti si interessavano di storia patria fra Trieste e l'I-stria, fosse proprio Kandler l'interlocutore del boemo; li univano in-teressi comuni non soltanto in campo storico, ma pure sul piano giu-ridico e politico 58, soprattutto nel momento in cui anche il triestinoveniva a trovarsi sempre piuÁ isolato su posizioni legittimiste e legali-tarie nella difesa dei diritti storici degli Asburgo 59.
Anche dopo il pensionamento di Czoernig i due continuarono amantenere notevoli rapporti epistolari come dimostra l'unica e ampialettera superstite di Czoernig, del 17 aprile 1868, che lascia intenderel'esistenza di un carteggio piuÁ ampio. Essa contiene notizie di argo-mento geologico e geomorfico 60 che sono da ricondurre probabil-mente alle ricerche i cui risultati vennero pubblicati nel 1869 conil titolo Die Terrassenbildung des GoÈrzer Landes 61. Risulta inoltreche Czoernig avrebbe dovuto essere anche il destinatario di una delleLettere del conservatore che Kandler, in qualitaÁ di conservatore per imonumenti del Litorale, era solito pubblicare adottando la forma
360
57 Cfr. W. FRODL, Idee und Verwiklichung. Das Werden der staatlichen Denkmalp-flege in OÈsterreich, BoÈhlau, Wien 1988, p. 139, che cita alcune lettere di Kandler aCzoernig del 1853 conservate presso lo Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna (Zl.113/1853).
58 AffinitaÁ di interessi storiografici e ideologici sono richiamate da SALIMBENI, Carlvon Czoernig, cit., pp. 24, 28; per le interessanti considerazioni di Kandler sul concetto,anche storico, di Verfassung cfr. G. NEGRELLI, Alla ricognizione della legalitaÁ, in CROSARA
(a cura di), Studi kandleriani, cit., pp. 191-219; CERVANI, Il Litorale Austriaco, cit., pp.74-77. Per un inquadramento dell'opera di Czoernig e di Kandler per la conservazionedei monumenti del Litorale si veda S. TAVANO, I monumenti fra Aquileia e Gorizia 1856-1918. La cura, gli studi e la fototeca del Seminario teologico centrale, Istituto Pio Paschini- Istituto di storia sociale e religiosa, Udine-Gorizia 1988, pp. 13-40.
59 Per l'evoluzione dell'ideologia politica di Kandler cfr. CERVANI, NazionalitaÁ e sta-to di diritto, cit.
60 La lettera, datata Ischl 17 aprile 1868, venne inserita da Kandler nel proprio ma-noscritto La Giulia (ADTs, segn. 1/2 C 8). Consta di quattro facciate autografe in linguatedesca. Fu imprecisamente schedata con il nome di Carl von Goering da PESANTE, In-ventario dei manoscritti, cit., p. 271.
61 C. VON CZOERNIG, Die Terrassenbildung des GoÈrzer Landes, «Mittheilungen derk.k. geographischen Gesellschaft in Wien », 1869, pp. 31-48.
epistolare per diffondere notizie di carattere archeologico 62. Kan-dler, peraltro, morõÁ nel 1872 e dopo questa data venne a mancarea Czoernig ogni interlocutore triestino.
Da quella stessa epoca, che coincise anche con la pubblicazionedelle opere sul territorio di Gorizia e di Gradisca 63, tutta l'attivitaÁ sto-riografica di Czoernig venne diradandosi e non vi furono piuÁ molteoccasioni per dedicarsi specificamente a temi giuliani; la morte gli im-pedõÁ di veder realizzata la collaborazione all'opera Die oÈsterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, cui fu chiamato nel 1888 64.
Risale tuttavia al periodo dell'amicizia con Kandler e della prepa-razione dei saggi su Gorizia e Gradisca un volumetto pubblicato nel1872 a Trieste dalla tipografia del Lloyd Austriaco intitolato Ge-schichte der Triester- Staats- Kirchen- und Gemeinde Steuern 65, unastoria della fiscalitaÁ triestina attraverso le imposte statali, ecclesiasti-che e comunali. L'operetta venne distribuita alle librerie a partire dalmese di aprile (la prefazione reca la data del mese di marzo) ma nonvenne seguita da alcuna recensione o segnalazione, a parte un annun-cio nella « Triester Zeitung ». Si tratta dell'unico saggio per lungotempo esistente su quell'argomento specifico, la cui importanza eÁ sta-ta riconosciuta ancora in tempi recenti 66.
La particolaritaÁ del volumetto, oltre che nel contenuto, consistenel fatto che eÁ stato ritenuto costantemente opera di Carl von Czoer-nig e come tale incluso nel catalogo delle sue opere, nei repertori bi-bliografici italiani ed esteri. Tuttavia esso reca in frontespizio la firma
361
62 P. KANDLER, Epistolario del Conservatore, ms. in ADTs, segn. 1/2 E 8 (anno1871). In realtaÁ lo scritto, causa la sopravvenuta morte di Kandler, nemmeno venne ab-bozzato.
63 L'eco della pubblicazione eÁ percepibile attraverso le recensioni riprodotte inCZOERNIG, Biographische Notizen, cit.
64 CZOERNIG, Anhang, cit., p. 6.65 C. VON CZOERNIG, Geschichte der Triester Staats-, Kirchen und Gemeinde-
Steuern. Eine Darstellung des Ursprunges und der Entwicklung aller in dieser Stadt seitden aÈltesten Zeiten nachweisbaren und der bis unsere Tage erhobenen Abgaben, Buch-druckerei des Oesterreichischen Lloyd, Triest 1872.
66 PAVANELLO, L'amministrazione giudiziaria, cit., p. 22: « il vecchio lavoro di C. v.Czoernig [...] rimane tuttora il solo che abbia trattato in maniera organica, anche se suc-cinta, la storia fiscale della cittaÁ ».
del figlio omonimo, resa evidente dalla qualifica di « k. k. Finanz-CommissaÈr », cioeÁ commissario di finanza 67. L'omonimia con il pa-dre non ha contribuito certo a risolvere la lunga incertezza nell'attri-buzione; percioÁ una breve analisi dello scritto puoÁ essere interessanteper capire quanta parte puoÁ essere derivata dalle ricerche e dagli in-teressi del padre 68.
L'attenzione di Carl von Czoernig padre per la dimensione sto-rica della fiscalitaÁ , del commercio e dell'economia, anche con riferi-mento specifico a Trieste, eÁ emersa giaÁ dalle riflessioni sin qui propo-ste. Se andiamo a scorrere la biografia del figlio, notiamo invece chegli fu sostanzialmente estranea. Nato a Milano nel 1839 e morto aInnsbruck nel 1893 69, si dedicoÁ soprattutto al problema della tassa-zione dei cambi e firmoÁ pure un lavoro sull'etnografia del LitoraleAustriaco edito nel 1885 e chiaramente influenzato dagli scritti delpadre 70. Fu lui a stendere le voci su Gorizia e Gradisca per l'operaDie oÈsterreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, portandoa termine l'incarico che, come accennato, era stato affidato al padrepoco prima della morte 71. Appare comunque evidente che si tratta
362
67 CosõÁ sul frontespizio dell'operetta. Si veda anche l'Almanacco e guida scematica diTrieste per l'anno 1871, Dase, Trieste s.d., p. 48.
68 Giustamente SALIMBENI, Carl von Czoernig, cit., p. 29, avverte che lo studio « perquanto d'argomento assai circoscritto e specifico », rivela un interesse « tutt'altro chesemplicemente erudito per questa delicata area di confine e per quello che ne era il pol-mone economico e finanziario primario ».
69 Un cenno biografico su C. von Czoernig jr. eÁ contenuto in appendice alla schedabiografica dedicata al padre nel Meyers-Konversations-Lexikon, IV, BibliographischesInstitut, Leipzig-Wien 1897, p. 461. Viceversa manca qualsiasi riferimento nel piuÁ recen-te Oesterreichisches Biographisches Lexicon.
70 C. VON CZOERNIG JR., Die Abgaben von den Ubertragungen unbeweglichen Eigen-thums. Ein Beitrag zur vergleichenden Finanzgesetzkunde, Schimpff, Triest 1869; ID., DieBesteuerung der Wechsel und anderer dem kaufmaÈnnischen Verkehre dienenden Privatur-kunden, Schimpff, Triest 1870; ID., Die ethnologischen VerhaÈltnisse des oesterreichischenKuÈstenlandes nach dem richtiggestellten Ergebnisse der VolkszaÈhlungen vom 31. Dezem-ber 1880, Schimpff, Triest 1885. Sul contesto politico in cui andavano maturando questistudi cfr. A. GOTTSMANN, La paritaÁ linguistica nell'amministrazione del Litorale Austriaco(1848-1918), in A. TRAMPUS, U. KINDL (a cura di), I linguaggi e la storia, il Mulino, Bo-logna 2003, pp. 243-272.
71 C. VON CZOERNIG JR., Fortwirtschaft, Jagd, Industrie, Handel, Gewerbe und Ver-kehr in GoÈrz und Gradiska (pp. 295-302) e Industrie, Handel, Gewerbe, Hausindustrie,
di voci ricavate dall'ampia opera pubblicata dal genitore, ragione percui il lavoro non dovette essere certamente di grande impegno.
Nel contesto della produzione di Czoernig jr. la Geschichte sfug-ge quindi a qualsiasi collocazione, dimostrandosi sostanzialmenteestranea ai temi da lui solitamente frequentati. L'altro dato curiosoeÁ che dopo la pubblicazione della Geschichte, che valse a Czoernigjr. un avanzamento di carriera 72, per almeno un quindicennio l'auto-re non pubblicoÁ altro.
PiuÁ in particolare, il contenuto dell'opera ± il cui nucleo centraleriguarda la storia fiscale del XV e XVI secolo e ricorda molto da vi-cino gli interessi giovanili del padre 73 ± tradisce un rapporto intellet-tuale fra l'autore e Pietro Kandler alquanto approfondito, che non silimita semplicemente ad un'ottima conoscenza della produzione sto-riografica del triestino. Vi si nota un utilizzo delle fonti edite ed ine-dite certamente maturo, proprio cioeÁ di uno studioso dotato giaÁ diuna notevole esperienza nel campo della ricerca storica 74. Vi eÁ dimo-strata la conoscenza approfondita di alcune fonti edite, di circolazio-ne peroÁ non eccessivamente ampia, come l'edizione kandleriana deglistatuti comunali trecenteschi e il Codice diplomatico istriano. Di que-sto, poi, vengono illustrate le vicissitudini editoriali, nonche la consi-stenza del materiale edito e di quello ancora da pubblicare ma prontoper la stampa 75. L'autore della Geschichte rivela un utilizzo non di-spersivo di fonti archivistiche all'epoca difficilmente accessibili, comead esempio dei documenti cancellereschi medioevali la cui letturanon era certo agevole per chi non avesse compiuto studi paleografici.Si tratta, nel complesso, di una serie di cognizioni che non pare fos-sero in possesso di Czoernig jr.
363
Salinen und Bergwesen in Istrien (pp. 348-354), in Die oÈsterreichische-ungarische Monar-chie in Wort und Bild (Das KuÈstenland), K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1891. Danotare che Czoernig padre aveva pubblicato giaÁ nel 1848 sul periodico «Austria » (n.37) l'articolo Die Sardellen und Mehrenlefang in Dalmatien und Istrien.
72 Cfr. Almanacco e guida scematica di Trieste per l'anno 1873, Dase, Trieste s.d., p.43.
73 Si ricordi lo studio perduto sul Medioevo austriaco ricordato all'inizio del capi-tolo.
74 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 3-6 (Quellen der gegenwaÈrtigen Arbeit).75 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., p. 5.
D'altra parte, vi eÁ una notevole analogia tra la struttura e il con-tenuto della Geschichte con quelli di ampi capitoli dedicati da Czoer-nig sr. ad analoghe problematiche nella storia della contea di Goriziae Gradisca. In particolare i riferimenti sono evidenti per quanto ri-guarda il paragrafo 49 della parte prima, Finanzen (MuÈnzverhaÈltnis-se, EinkuÈnfte, u.s.w.) e il paragrafo 9 della seconda parte (Finanzver-waltung, Belehnungen) 76.
Pure dal punto di vista strutturale l'articolazione del testo dimo-stra una conoscenza approfondita dell'argomento e delle vicende sto-riche del Litorale. Al primo capitolo che riguarda le fonti, con cenniessenziali sulla storia di Trieste e della sua monetazione antica 77, se-gue il secondo piuÁ breve dedicato specificamente alle imposizioni fi-scali stabilite dalla Chiesa e dai vescovi 78, che rivela una precisa co-noscenza dell'avvicendarsi a Trieste, dopo il XIII secolo, dell'autono-mia comunale al governo vescovile. Nell'ampio capitolo terzo,centrale rispetto all'economia del volume 79, eÁ data attenzione premi-nente all'amministrazione fiscale del Comune medioevale, di cui siesamina l'organizzazione ± in rapporto alle attivitaÁ produttive del ter-ritorio ± sulla base delle disposizioni statutarie e delle fonti d'archivio.
Il quarto capitolo, dedicato all'amministrazione fiscale dello Sta-to e alla sua incidenza nella cittaÁ adriatica 80, muove cronologicamen-te dalla fine del XVIII secolo, quindi dall'esaurirsi del particolarismomunicipale e dalla stagione delle riforme, concedendo grande rilievoalla politica teresiana e giuseppina, allo sviluppo del sistema tavolarenonche al riordino delle imposizioni fiscali attraverso il censimentodegli immobili 81. L'ultimo capitoletto, infine, condensa in poche pa-gine e in alcuni prospetti numerosi dati riassuntivi e statistici, propo-nendo confronti tra le situazioni economiche e sociali delle diverseepoche trattate 82.
364
76 CZOERNIG, Das Land GoÈrz und Gradisca, cit., pp. 421-434 e 845-874.77 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 7-21.78 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 23-27.79 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 29-70.80 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 71-97.81 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 71-74.82 CZOERNIG JR., Geschichte, cit., pp. 99-105.
L'autore in chiusura dell'operetta non proponeva delle conclu-sioni esplicite; piuttosto, attraverso l'articolazione della ricerca, l'am-piezza del dettaglio a proposito del periodo comunale e la chiarezza ela linearitaÁ del capitolo sulle riforme statali nella seconda metaÁ delXVIII secolo, sembra voler condurre il lettore ad una sola ed auto-noma considerazione. Emerge cioeÁ la sensazione netta dell'inadegua-tezza del tramontato particolarismo di etaÁ comunale, della bontaÁ edell'efficacia delle riforme amministrative e fiscali promosse da MariaTeresa e da Giuseppe II, della necessitaÁ di procedere sulla strada del-la razionalizzazione e dell'accentramento statale.
Con le pagine dei due Czoernig, padre e figlio, che nella secondametaÁ dell'Ottocento evocavano la stagione delle riforme teresiane edella crescita dell'emporio triestino, si compiva idealmente un ciclo.Si avvicinava lentamente la crisi del porto franco, che vent'anni piuÁtardi sarebbe stato abolito. L'esperienza e l'ereditaÁ del Settecentosi trasfiguravano nel mito della cittaÁ di fondazione, cosmopolita eplurietnica, destinato ad accompagnare l'etaÁ contemporanea.
365
APPENDICE
I. - Lettere di Sigismondo Zois
A GIACOMO CASANOVA1
Monsieur
Je suis fort sensibile aÁ l'honneur, que vous me faites, en me reÂgallant de
vos Odes 2; je sens toutte leurs beaute , et je les admire: mais comme je ne
suis pas asseÂs habile pour en faire les eloges, qu'elles meÂritent, d'autant plus
serai-je toujours empresse de vous teÂmoigner l'obligation, que je vous dois
pour un preÂsent si precieux ± ansique pour les expressions flatteuses, dont
vous avez bien vouluà l'accompagner, les quelles m'ont fait rougir parcequ-
'elles sourpassent le grand train tout ce que vous pouviez dire par politesse
aÁ celui, qui lit vos ouvrages avec beaucoup d'agreÂments, mais sans eÂtre con-
naisseur.
Je suis avec la plus vraie consideration
Monsieur
S[on] Ex[cellence] le B[aro]n de Brigido 3 vous fait mille compliments:
il a luà vos vers ± il ne cesse d'admirer vos talents. Je m'acquiterai en quel-
366
1 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr U. 13/e/06. Nella trascrizione sono state ri-spettate le regole di edizione dei documenti casanoviani, di tipo strettamente conserva-tivo, pubblicate in quarta di copertina della rivista « L'IntermeÂdiaire des Casanovistes »,GeneÁve.
2 EÁ possibile che si trattasse di G. CASANOVA, Applausi poetici, dovuti dalla felice, edinclita ed ossequiosa cittaÁ di Trieste al merito sovragrande dell'illustrissimo ed eccellentis-simo signore il signor conte Adolfo di Wagensperg, s.t., Trieste 1773. Su questo librettocfr. CHILDS, Casanoviana, cit., pp. 25-26.
3 Pompeo Brigido de Bresowitz (1729-1881), all'epoca capitano circolare della Car-niola inferiore, poi governatore di Leopoli (1778) e di Trieste (1782).
ques jours de la parole, que je vous ai donneÂ, de vous envojer une copie des
Octaves de Businello 4.
Laubach ce 6. Fev[rier] 1773
Votre treÁs humble et obe isant
Serviteur Sig[mun]d Zois
[busta:]
A Monsieur
Monsieur Casanova de SainGall
a' Triest
A GIACOMO CASANOVA5
Monsieur
Laubach ce 27 Juillet 1773
Le Memoire 6 que vous m'avez fait l'honneur de me reÂmettre, ne pou-
voit pas eÂtre presente jusqu'aÁ preÂsent, parceque Le PreÂsident 7 eÂtoit aÁ la
Campagne, et qu'il n'y a point euà de Conseil pendant son absence.
On vient deme dire, dans l'instant, que Son Excellence est arriveÂe: je feÂrai
don en sorte, que deÂmain mon avocat le presentera. VoilaÁ ce que, je vous en
puis dire avant le deÂpart des lettres d'ahjourd'hui: je vous donnerai compt
exactement de l'issuà e de cette affaire et s'il y aura quelque petite deÂpense,
je vous la marquerai dans le meÁme tems. E tant toujours charme de pouvoir
vous donner des marques de l'estime, et de la consideÂration, que je vous prof-
fesse, vous m'obligerez infiniment toutes les fois, que vous voudrez bien
m'employer en quelque chose, qui puisse vous eÂtre util, et agreÂable.
367
4 Probabilmente Zois faceva riferimento alle composizioni di Giovanni FrancescoBusenello (1598-1659), noto per la sua adesione al petrarchismo e come autore di libret-ti, tra cui l'Incoronazione di Poppea musicato da Monteversi.
5 Praha, StOA, Marr U. 13/e/07.6 Con tutta probabilitaÁ Zois si riferiva al memoriale di Casanova per la soluzione
della controversia circa le stazioni di posta tra Venezia e Trieste, fra le quali si volevacomprendere anche Udine nonostante l'opposizione del Consiglio aulico di commercio;cfr. CASANOVA, Storia della mia vita, III, cit., pp. 972-974.
7 Adolfo di Wagensperg, barone di Sauegg e Rabestein (1724-1773), gran marescial-lo del ducato di Carinzia, capitano civile e militare di Gorizia e Gradisca e presidente del-l'Intendenza Commerciale di Trieste dal 24 aprile 1773, per pochi mesi, fino alla morte.
Mon treÁs amable Cousin 8 ne m'a point envoje les deux Tomes de
Meu[rsiu]s 9, que vous avez eu la bonte de me faire venir: Je lui dois en meÁ-
me tems une reÂponse deÂpuis deux SeÂmaines, aÁ une Lettre, ou il avoit insereÂ
un Serment par eÂcrit de notre Ami Treviso 10. Je vous prie treÁs humblement
de Leurs dire que j'attens la garniture des boucles, dont il s'agit, et qui vaÃt
arriver avec la premieÁre Diligence de' Vienne, et que cependant je n'ose reÂ-
pondre, sans pouvoir joindre le Dedomagement, qu'ils ont gracieusement
impose au Vicarie GeneÂral de l'Eglise Carniole.
Je suis treÁs Curieux de voire la Chanson faite contre M[onsieu]r de
Meaupeou 11, que Mon Cousin m'a promis, ainsi que de Lire Meursius: a
que je vous prie de vouloir bien le lui dire aÁ son reÂtour de GoÈ rtz. D'ailleurs
Nous vegeÃtons treÁs regulieÁrement, et apreÁs tout ce qu'y contribuà e, la Saison
est fort comode: voilaÁ touttes nos nouvelles.
J'ai l'honneur d'eÂtre avec parfaite veneration
Monsieur
Votre treÁs humble treÁs ObeÂissant S[erviteu]r
Sig[mun]d Zois
[busta:] 12
De' Laubach
A Monsieur
Monsieur Casanova de Seingalt
a' Triest
368
8 Giuseppe Sigismondo Kappus de Pichelstein (nato a Lubiana nel 1737 circa), se-gretario presso la Cesarea Regia Intendenza Commerciale dal 1767, morto dopo il 1803.
9 Si tratta dell'opera di Nicolas Chorier (Joannes Meursius), Elegantiae latini sermo-nis Aloisiae Sigaeae Toltane Stira sotadica de arcanis Amore et Veneris, edita per la primavolta a Grenoble nel 1659 circa.
10 Vincenzo Treviso, amico del barone Pittoni e poi del conte Zinzendorf, che spes-so lo nomina nel diario.
11 Nicolas Augustin de Maupeou (1714-1792), cancelliere di Francia sotto LuigiXV, celebre per aver combattuto l'opposizione parlamentare sopprimendo il Parlamen-to di Parigi. Caduto in disgrazia con l'avvento al trono di Luigi XVI, si ritiroÁ a vita pri-vata.
12 Sulla busta sono riportati, autografi di Casanova, i seguenti versi: «Ma vieni aletto, poiche in quanto al core / Maggior per te non ha provato ardore / Ma vieni prestoa letto poiche il core / Non m'avea mai foco d'amor maggiore / ».
A GIACOMO CASANOVA13
Monsieur
J'ai donne une Lettre pour mon Cousin aÁ M[onsieu]r le Chev[alier]
Sorgo de Raguse 14, le priant de lui vouloir faire faire votre connaissance,
dont il est treÁs empresse suà r la reÂputation, qu'il a concËuà e de vous, Monsieur,
sur les eloges, que je viens de lui faire de vos talents, et de vos eÂruditions.
Mais ayant entenduà par le Rev[eren]d P[eÁr]e Costanzo 15, que le sudit ne se
trouve pas aÁ Triest, je me prens la liberte de vous preÂsenter mon ami directement.
Je vous prie treÁs humblement de l'introduire dans la bone societe de
Triest, dont vous formez le gouà t, et de lui accorder votre amitie .
Je vous en serez infiniment oblige , et je suis treÁs aÁ la hate, avec le re-
specte le plus vrai
Monsieur
Votre treÁs humble
TreÁs ObeÂissant S[erviteu]r
Laubach ce 10 Aouà t 73
Sig[mun]d Zois
[busta:]
A Monsieur
Monsieur Casanova de'
Saintgall
a' Triest
4. A GIACOMO CASANOVA16
Monsieur,
En reÂpondant aÁ votre Lettre duà 10 duà Courrant, je vous fais de reÂmer-
369
13 Praha, StOA, Fondo Casanova, U. Marr 13/e/06.14 Il raguseo Michele Antonio conte Sorgo (1739-1796). StudioÁ a Bologna e fu mem-
bro dell'Arcadia romana. FondoÁ a Ragusa (oggi Dubrovnik in Croazia) un'importante ac-cademia letteraria e si dedicoÁ allo studio e alla traduzione dei classici latini e greci.
15 Nota Zinzendorf nel suo diario in data 15 giugno 1776: « Le P. Costanzo, ex je -suite, grand ami du comte Rosenberg » (PAGNINI, Il periodo triestino, cit.).
16 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr U. 13/e/01
cimens pour les pieÁces, que vous ConsignaÃtes a' ma Maison de' Triest avant
votre deÂpart pour Gorice, et dont j'ai trouve belles la plus part, il y a long-
tems; je vous en dois neanmoins autant de recconnaissance, que pour les
Anecdotes Satiriques de la Cour de France 17, qui y eÂtoient jointes, et
qui, nous etant tout aÁ fait nouvelles, nous ont fort amuseÂs.
Le Ch[evalier] Sorgo ne me doit, que le facher d'avoir joui de quelques
instants, qui lui ont eà te d'autant plus sensibles, que l'acueil gracieux, dont
vous l'avez honnore , et la prevention, qu'il tenoit de vos talents, Lui avoit
inspire tout le deÂsir possibile d'en profiter longtems.
Mon avocat a' fini, il y a quelques SeÂmaines, l'afaire que vous m'aviez
reccomandeÂe, mais malheureusement: j'en suis fache , mais je ne m'en eÂton-
ne pas, car apreÁs le deÂpart du Comte Henri d'Auersperg 18, et du B[aro]n
de Brigido, et du Conseiler Janneshitz 19, qui s'est retire suà r ses terres, je
n'ose compter suà r personne dans notre MinisteÁre provincËal, car je suis
de la faction Anti-MinisteÂriale, et par consequence mes reccomandations
sont fort mal recËuà s.
Nos Cavaliers et nos Dames vont jouer, pour la premieÁre fois, une co-
medie allemande: il n'y a que la Comtesse Wurmbrand 20, soeur de la Com-
tesse Rosenberg, qui se tire d'affaires, et Mons[ieu]r Wiser Inspecteur du
TheÂatre 21, qu'on a eÂte oblige de recevoir dans la Compagnie, parcequ'il
n'y avoit personne parmi les Cavaliers, qu'il s'euà t fie de soutenir la farce.
370
17 Si tratta di una serie di fogli periodici manoscritti diffusi in tutta l'Europa. Nelfondo Casanova dell'archivio di Praga (Marr, 15) si trova una serie del « Bulletin de Ver-sailles » che Casanova dovette ricevere a Trieste. L'abbonamento era alquanto costoso epare di capire che Casanova ne condividesse la lettura con Zois.
18 Il conte Heinrich von Auersperg (1721-1793), dal 1742 consigliere del tribunaleprovinciale della Stiria, dal 1753 presidente del consiglio di commercio per la Carniola,dal 1760 al 1760 presidente della RepraÈsentation und Kammer della Carniola, dal 1765capitano provinciale della Carniola, presidente dell'Intendenza Commerciale di Trieste ecaputano provinciale di Gorizia e Gradisca, dal 1773 successore di Ludwig von Zinzen-dorf come presidente della Camera aulica di Conti a Vienna. Fu piuÁ tardi (1774-1780)governatore di Galizia e Lodomiria, e dal 1780 secondo cancelliere per la Boemia. SposoÁJosepha, nata contessa Rottal (1736-1808).
19 Joseph barone von Janoschitz o JaneschuÈ tz (1723-1780), dal 1765 circa consiglie-re provinciale della Canriola.
20 Maria Antonia contessa Auersperg, nata nel 1739, moglie di Gundakar Thomasconte Wurmbrand-Stuppach (1735-1791).
21 Joseph Leopold Wieser von Berg, ispettore del teatro di Lubiana dal 1766. Zoisallude evidentemente a rappresentazioni domestiche, per le quali era richiesta la presen-
Nos femmes sont touttes trop peÂsantes pour le theÂatre, et ce qui est pi-
re encore, personne ne sait prononcer la langue, dans la quelle ils deÂcla-
ment, moins que meÂdiocrement aÁ mon avis.
Je viens de faire une tour aÁ mes forges de fer, ce' qui m'a empeche de
vous reÂpondre pluà stoà t: je part de rechef mecredi prochain, et je m'en vais en
Stirie aÁ vendre une forge de fer preÁs de Cilli 22, puis je ferai une visite au
B[aro]n de Brigido aÁ Gratz, et apreÁs mon reÂtour de laÁ , j'irai sur mes terres
aÁ faire quelques parties de chasse avec mes amis, et vers la fin d'octobre je
ferai une visite aÁ l'eÂpouse de mon freÁre aÁ Agram en Croatie 23.
ApreÁs la moitie de novembre je ferai une petite tour aÁ Triest 24. C'est laÁ
ou j'espeÁre de vous reÂvoire, et de vous assuà rer, que je vous estime avec tous
les sentimens possibles de la consideÂration la plus parfaite
Monsieur
Laubach ce 25 de Sept[em]bre 773
Votre treÁs humble
et treÁs ObeÁisant Serviteur
Sig[ismun]d Zois
A GIACOMO CASANOVA25
Monsieur
Je suis bien charmeÂ, que je n'ose eÂtre redeÂvable duà plaisir de vous voir
cheÁs nous, et de pouvoir vous eÂtre util, aÁ ce qu'il y a de plus affreux au mon-
de. Cependant, comme vous venez d'apprendre, que les eaux de M[e]s-
s[ieu]rs Pollini 26, et Paglierucci 27 ne son pas voiturables, ainsi souvenes
371
za di Wieser. EÁ possibile che tali rappresentazioni fossero organizzate in casa di Vincen-zo Orsini-Rosenberg.
22 Cilli, odierna Celje in Slovenia, localitaÁ a nord-est di Lubiana.23 Agram eÁ il nome tedesco della cittaÁ di Zagabria.24 Non eÁ noto se Casanova e Zois si incontrarono a Trieste, certo eÁ che Casanova
lascioÁ Gorizia (dove si era trasferito alla fine dell'agosto 1773) alla metaÁ di ottobre perfare ritorno a Trieste.
25 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr U. 13/e/02.26 Giuseppe Antonio Felice barone Pollini, dal 1773 a capo della cassa camerale a Trie-
ste, dal 1777 supervisore dell'ufficio dei sali, sposato a Luigia, nata de Jurco (ca. 1744-1798).27 Forse allude ad acque minerali.
vous toujours, que s'il vous arrivaÃt le malheur d'en devoir user, ce sera moi,
qui se prendra tout le soin de votre guerison.
Si vous voudrez m'envojer quelques fois la suite de la correspondance
de votre ami de Versailles, vous m'obligerez infinement.
Ma belle soeur 28 est en cause, que j'ai duà me priver du plaisir de reÂvoir
mes amis le Carneval passe ± je m'eÂtois engage de la promeÃner avec deux
dames de ses amis, et quelques maris, et galants de leur suite ± mais au jour
fixe pour le deÂpart le mauvais tems nous commencËa aÁ diffeÂrer, aÁ la fin les
femmes se detourneÁrent de la partie par la crainte des mauvais chemins,
et le Carnaval se passa. Pour aÁ present, nous voilaÁ disposeÂs d'aller voir le
Bucintoro 29 ± mais je n'en crois rien ancore ± ce qu'il y a de certain, c'est
que je suis avec la plus parfaite estime.
Monsieur
Laubach ce 1:er de Mars 1774
Votre treÁs obe isant S[erviteu]r
Sigismond Zois
A GIACOMO CASANOVA30
MonsieurVoilaÁ vos Bulletins de Versailles ± je les lis avec plaisir, et je vous suis
bien oblige de la bonte , que vous voulez avoir de m'en faire part.
Le Chanoine Torres 31 vous fait des compliments ± il m'a assure , qu'il
ne demandera pas d'eÃtre fait DoõÃen aÁ Gorice.
La Mingelli 32 est donc fort aÁ feliciter, parceque les nippes, q'on lui a
donneÂes valent certainement le ch-p- 33 qu'on en a eues.
372
28 Allude forse alla moglie del fratello Carlo (1756-1800).29 L'antica nave del doge di Venezia, celebre per le sue decorazioni, realizzata tra il
1722 e il 1728, trasformata dopo il 1797 in cannoniera e in nave prigione. Rimase in ac-qua fino al 1824.
30 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr 13/e/04.31 Il canonico Giovanni Torres, del collegio metropolitano di Lubiana, nato nel
1744. Sua sorella, la contessa Maria Giosefa Torres, fu in corrispondenza con Casanova.32 Elisabetta Minghelli, cantante, fu a Trieste per la stagione di carnevale del 1774.33 Parola lasciata volutamente in sospeso.
Le jeune prince Serignano Capitain dans le Regiment de Puebla 34, fort
aimable garcËon, s'est noye dans un eÂtang pres de Clagenfurth, il y a quel-
ques jours ± il e toit aÁ la chasse des canards sauvages avec deux autres offi-
ciers, qui se sont sauveÂs ± on ne me marque pas de quelle facËon cela soit
arrive preciseÂment ± ce qu'on m'eÂcrit, c'est, que le cannot fut renverse , et
que tous les trois officiers tombeÁrent dans l'eau. Je vous prie de faire part
de ceci aÁ mon Cousin, qui connaissoit Serignano, et aÁ nostre ami Costanzo,
qui le doit connaitre aussi.
En vaudra aÁ Son a me un couple de De profundis aÁ faire depeupler le
purgatoire.
Je suis avec la plus parfaite estime
Monsieur
Votre treÁs obe isant S[ervito]re
B[aro]n Sig[mun]d Zois
Ce 29 Mars 1774
A GIACOMO CASANOVA35
Monsieur!
J'envisage aÁ mon reÂtour, avant tout les obligations, que je vous dois pour
les politesses, dont vous m'avez comble cheÁs vous: j'ai prie , en partant de VeÂ-
nise, Mons[ieu]r le Comte d'Attems 36, pour qu'il euà t la bonte de vous porter
mes complimens de conged, que je n'ai pas puà avoir la satisfaction de vous
faire en personne, n'ayant pas euà le sort de vous rencontrer nõÁ cheÁs vous, nõÁ
au teÂatre, nõÁ au casino de S[on] E[xcellence] le Chev[alier] de Zaguri 37.
373
34 Il reggimento di Puebla era l'imperiale reggimento di fanteria n. 26, creato nel1717 e affidato nel 1751 al portoghese conte Antonio Puebla. Dal 1763 la sede dellaguarnigione fu Gorizia, poi venne trasferita a Klagenfurt.
35 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr 13/e/03.36 Forse Ludovico (Vico) Attems (1727-post 1790), dal 1765 consigliere aulico, che
curoÁ tra il 1761 al 1767 la riforma degli Stati provinciali di Gorizia, sposato dal 1765 conAloisia, nata contessa Strassoldo (1745-1783).
37 Pietro I Antonio Zaguri (1733-1806), patrizio veneziano e senatore, Avogadordel Comun nel 1772, protettore di Lorenzo Da Ponte, Fu a lungo in corrispondenzacon Casanova.
C'est pour la meÁme cause, que je suis parti sans avoir puà faire mes re-
merciments au Chev[alier] sudit: je vous suplie donc de l'assurer des senti-
mens les plus profonds d'estime, et d'admiration, qu'il m'a inspireÂs, ainsi
que de la plus parfaite gratitude, que je lui dois pour des politesses, que l'on
ne sauroit s'attendre que d'un homme illustre, et inimitable, comme lui.
Si Son Ecc[ellence]e fait le tour de Udine, de Gorice, et celui de Lau-
bach, je seÂrai l'homme le plus heureux de monde, si les offres que je lui fais
de ma maison de Laubach, ainsi que celle de Triest 38, seÂront agreÂes.
M[onsieur] Bonetti aÁ reÂcuà les eaux de Cilley: je souhaite qu'il le trouve
aÁ son gre .
J'ai l'honneur d'e tre avec la consideration la plus distingueÂ
Monsieur
Laubach ce 6 de Juin 1775
Votre treÁs humble
TreÁs obe issant Servit[eu]r
Sig[ismun]d Zois
A KARL VON ZINZENDORF39
Excellence,
C'est un honneur, et une grace de la plus grande importance pour moi,
que la disposition, que votre Excellence se daigne faire de ma maison, pour
y loger Leurs Altesses Imperiales, Monsieur le Comte, et Madame la Com-
tesse du Nord 40.
Les deux eÂtages, qui sont vuids, vont eÂtre appreÃteÂs sur le champ, et le
comptoir sera eÂvacue le plus toà t possible.
Mes commis Jenner 41 et Jagher deÂpendront des ordres que votre Ex-
cellence voudra bien leur faire donner. Je suis infiniment afflige , de ce que
374
38 A Trieste Zois possedeva la casa n. tav. 170 di piazza Pozzo del Mare, poi demo-lita e prospiciente l'attuale via della Procurerai.
39 Wien, HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf, Nr. 8, Noten und Briefenan K. Maria Theresia und K. Josef II. Sonstige Korrespondenz.
40 Pseudonimo del granduca Paolo Petrovich di Russia e di sua moglie.41 Joachim Jenner von Seebegg und BaÈrburg, amministratore della ditta Zois per il
Litorale, morto nel 1800.
ma mauvaise sante ne me permet pas de venir satisfaire en personne aux
devoirs attacheÂs aÁ la grace, dont votre Excellence me daigne, et dont je suis
d'ailleurs penetre au de laÁ de toutte expression possible 42.
J'aurais l'honneur de reÂmettre aÁ votre Excellence le 2:d tome de l'Oryc-
tographia Carniolica 43 avec la diligence prochaine 44, mais je suis fache de
ne pouvoir pas en dire autant de la continuation des Oeuvres de Bonnet 45;
suivant les dernieÁres nouvelles de mon libraire cette edition a eÂte suspen-
duà e, sans qu'on nous en ait confie le motif.
Je suis avec le plus respecteux deÂvoueÂment
De Votre Excellence
treÁs humble
treÁs obeisant Serviteur
Sig[mun]d Zois
Laubach ce 25 Xbre 1781
II. - Lettera di Giuseppe Barzellini
A GIACOMO CASANOVA46
Ill[ustrissi]mo Sig[no]r P[ad]rone Col[endissi]mo!
MercoledõÁ ultimamente scorso ho ricevuto dal Sig[no]r Prividali 47 la
pregiata di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma 3. andante. Dell'opera di
Lei oggi ho corretto il 15ë foglio. Il Sig[no]r Valerio 48 sono dieci o dodici
giorni, che eÁ a Cividale. La sua famiglia eÁ senza cassa; da cioÁ veda come deb-
bono progredire le faccende sue domestiche.
375
42 Zois soffriva di gotta.43 Si tratta dell'opera di B. HACQUET, Oryctographia carniolica, oder physikalische
Erdbeschreibung des Herzoghtums Krain, Istrien, und zum Theil der benachbarten LaÈnderdi Balthasar Hacquet, Breitkopf, Leipzig 1781.
44 Cfr. il diario di Zinzendorf alla data del 6 febbraio 1782: « Sigismond Zoys m'en-voye le secon volume de l'Oryctographia carniolica » (Bd. 27, c. 26r.).
45 Charles Bonnet, filosofo e naturalista (1720-1793). Si tratta dell'edizione delleOeuvres pubblicata a Neuchatel da dall'editore Fauche nel 1781.
46 Praha, StOA, Fondo Casanova, Marr U. 12/27.47 L'avvocato Antonio Prividali fu in corrispondenza con Casanova fino al 1775.48 Il tipografo Valerio de' Valerj.
I gran divertimenti che qui s'hanno nel corrente tempo sono i balli; ed
io vi sono stato una sola volta. Le mie ore libere anziche a [sõÁ] insul[sa] ri-
creazione, amo passarle al fuoco colla pipa, e con un libro d'analisi.
Ho sommo piacere che V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma stia bene di
salute. Io son parimente sano. Mille rendimenti di grazie per le benigne esi-
bizioni, che non merito.
Ho l'onore di professarmi con ogni ossequio, e venerazione
Di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma
Gorizia
13. di Febb[rai]o 1774
Umilissimo Servo
Barzellini
III. - Lettere di Andrea Giuseppe de Bonomo
A GIANRINALDO CARLI49
Trieste, 3 ottobre 1787
Ho ricevuto ieri il pregiatissimo foglio di Vostra Eccellenza delli 26 del
prossimo passato mese, e mi compiaccio moltissimo che siasi determinato a
riguardare la villa di Trek nel Vipaco 50 per l'antica Tergeste di Strabone,
poiche oltre l'avere qualche similitudine col nome di Trek con cui i cragno-
lini chiamano Trieste ancor oggidõÁ, ha anche le particolaritaÁ di essere sul
passaggio per andare a Cirenidz; e che fatta appena mezza posta in laÁ , si
deve prendere a San Vito rinforzo di cavalli o di bovi per passare la monta-
gna, che si chiama Rebernizza, per arrivare alla posta di Prewald, o sia Re-
sderta posta sotto l'altissimo monte detto Nanos d'onde poi si proseguisce
ad Adelsperg, o sia Postonia e di qui a Cirenitz.
La consaputa macchina antica l'avevo presa per un ara sembrandomi
ch'abbia qualcosa del lavoro che si vede nella medaglia di Tiberio ROM.-
ST.A/ posta nel I tomo del Vaillant 51 in fronte alle medaglie di bronzo di
376
49 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 72r.50 L'argomento eÁ trattato da CARLI, Delle antichitaÁ italiche, I, cit., p. 167.51 Jean Foi Vaillant (1652-1706), medico e numismatico francese, autore di Numi-
questo imperatore. La misura eÁ di due piedi di Vienna nel disegno, divisa per
metaÁ , e del primo piede diviso pure per metaÁ , la cui prima parte dimostra le
sei oncie del primo mezzo piede. Non potrei per altro assicurare Vostra Ec-
cellenza che tale macchina fosse veramente stata quadrata, poiche consisten-
te in frantumi, senza sapersi se ve ne manchino e che con difficoltaÁ si eÁ unita
per copiare. Abbiamo pioggie dirotte, e tosto che faraÁ un poco di buon tem-
po per poter strascinarmi colle mie cattive gambe a Sant Giusto, anderoÁ ad
osservare l'accennatomi cornicione e le scriveroÁ cioÁ che avroÁ osservato.
Rendo a Vostra Eccellenza i piuÁ distinti ossequiosi ringraziamenti per
l'onore che mi vuol fare di nominarmi nella sua opera, che io non merito.
FaroÁ io pure il mio dovere in una mia Dissertazione sopra le monete de' ve-
scovi di Trieste, che pubblicaroÁ nel prossimo anno, e nella quale ci troveraÁ
de' documenti che forse gli potranno servire per le cose del medio evo del-
l'Istria. Sono a' pregiatissimi suoi comandi, e con invariabile sommo rispet-
to e venerazione.
P.S. Credo piuÁ probabile che la machina non sia stata veduta. Che pos-
sa essere stata distrutta all'inizio del Cristianesimo?
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI52
Trieste 10 ottobre 1787
Sono andato a Sant Giusto a vedere il cornicione del campanile, che ha
sofferto le ingiurie del tempo. In quella congerie d'armi non ho potuto ra-
visare fra li molti scudi, che vi sono, alcuno che fosse esagono. Ho bensõÁ
osservato un trofeo, sotto il quale mi parve esservi due figurine, di cui
non ho potuto vedere l'attitudine per esser troppo alto e la mia vista breve.
Merita d'esser copiato, poiche quella del P. Ireneo eÁ un scaraboc-
chio 53. ProcureroÁ di trovare un disegnatore, il migliore che mi saraÁ possi-
bile nella scarsezza in cui son qui in tal'arte.
377
smata aerea imperatorum, augustarum et caesarum, in coloniis, municipiis et urbibus jurelatio donatis, ex omni modulo percossa, Apud T. Moette, Parisiis, 1688, 2 volumi.
52 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 73r.53 Il disegno eÁ pubblicato in DELLA CROCE, Historia antica, e moderna, cit., p. 268.
Informandomi sempre meglio della villa di Trek nel Vipacco, vengo di
rilevare che veramente tal nome gli venghi dato dai villani, ma che nelli re-
gistri si scriva Terleck.
Mi spiacerebbe, se Vostra Eccellenza per far presto ommettesse nella
sua opera qualche buon pezzo. Sono con invariabile rispetto e venerazione
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI54
Trieste 21 novembre 1787
Ho ricevuto due pregiatissimi fogli di Vostra Eccellenza, uno delli 7 e
l'altro delli 14 corrente, e mi sono compiaciuto ch'abbia gradito tanto il do-
cumento dell'articolo della Pace di Torino del 1382, quanto li disegni spe-
ditigli de' pezzi di freggio esistente sul campanile di questa cattedrale.
Negl'Annali d'Ungheria del P. Pray 55 vi eÁ un altro documento di quel-
la pace, che riguarda le condizioni stabilite col ReÁ Lodovico d'Ongaria. Mi
piace il pensiero di servirsi d'uno di quei pezzi d'antichitaÁ per frontespizio
della sua opera e tanto piuÁ che rapportandolo nell'opera stessa nulla ci ve-
do, che possa scriversi per illustrarlo 56. Per la veritaÁ non le posso dare al-
cun conto per li detti dissegni, poiche nulla mi costano. Il disegnatore mi ha
fatto dell'altre e piuÁ importanti fatture senza voler pagamento, avendogli
dato un poco di quella bevanda che chiamiamo giunta, ed essi erano un so-
pra piuÁ senza pagamento 57.
Il barone Pittoni 58 mi promette sempre il disegno della testa d'Adria-
no ma non gli credo, se non lo vedo. Avrei molto piacere d'ottenerlo, e che
fosse pubblicato. Spero che in gennaro possa stampare la mia Dissertazione
378
54 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 74v.55 G. PRAY, Annales veteres Hunnorum Avarum et Hungarorum ab anno Christi 997
ad annum 1597 deducti, Schulzius, Vindobonae 1763-1770, voll. 5.56 Venne poi effettivamente riprodotto in frontespizio del primo volume delle Anti-
chitaÁ italiche.57 Si trattava, forse, dello stesso disegnatore al quale si devono il ritratto di Bonomo
e i disegni inseriti nel saggio sulle monete dei vescovi di Trieste e cioeÁ Ignazio de Colom-bis.
58 Pietro Antonio Pittoni, il direttore di polizia.
sopra le monete de' vescovi di Trieste, e saroÁ sollecito a rimettergliene tosto
un esemplare. Spero che ci troveraÁ qualcosa di nuovo, e di cui prima non
aveva notizia.
Venendomi altro per le mani, sia d'antichitaÁ romane o sia di documenti
del mezzo tempo, si assicuri Vostra Eccellenza che saroÁ sollecito a servirla,
ed intanto col piuÁ distinto rispetto e venerazione ho l'onore di raffermarmi.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI59
Trieste 23 gennaio 1788
Mi lusingavo che in questo mese di gennaio fosse stampata la mia Dis-
sertazione sopra le monete de' vescovi di Trieste; come giaÁ ebbi l'onore di
scrivere a Vostra Eccellenza; ma per impedimenti sopravenuti non ho po-
tuto sortir l'intento. Spero peroÁ che lo saraÁ in questa Quaresima. Ho dato
al signor Marchese Girolamo Gravisi un'Instromento di dissegnazione de'
confini dell'Istria del 1325 fatto traÁ il conte Alberto di Gorizia e li suoi vi-
cini, in cui eÁ nominato il marchese Patriarcale Wilhelmo di Pietrapelosa e
Pietro e Bartolomeo di Pietrapelosa, e l'ho pregato di comunicarlo se non
in copia perche eÁ longo, almeno in estratto a Vostra Eccellenza, come spero
che lo faraÁ , se non l'abbia giaÁ fatto.
Sono con invariabile verace rispetto, e perfettissima stima.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI60
Trieste 13 febbraio 1788
Ho ricevuto il pregiatissimo foglio di Vostra Eccellenza delli 29 prossi-
mo scorso gennaro, e spiacemi che Ella sia in una troppo grande aspettativa
della mia Dissertazione, poiche poi ricevendola si troveraÁ delusa non ravvi-
sando nella medesima quel merito che s'era immaginato.
379
59 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 75r.60 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 75v.
Quello che mi consola, si eÁ ch'Ella eÁ buon conoscitore e che sa compa-
tire le ricerche letterarie in un argomento astruso, e versante sopra tempi
tenebrosi de' quali sono scarse le memorie.
Ho ricevuto l'imprimatur da questo Governo, e l'ho data allo stampa-
tore. Per accelerare il ricevimento, gliela spediroÁ a pezzi di tratto in tratto
secondo l'arrivo dalla stamperia, e spero di poterle spedire il primo capitolo
colla prossima posta di mercoledõÁ venturo, che saraÁ li 20 corrente. Termina-
ta poi l'opera, gliene avanzeroÁ un esemplare integrale per mezzo di qualche
mercante, e probabilmente del signor Filippo Perensteiner spedizioniere
della Dita Mambrini.
EÁ vero che il documento de' confini dell'Istria ha degli anacronismi, e
che invece del Patriarca Pagano vi si legga Rajmondo. SaraÁ probabilmente
un fallo del copista che il P avraÁ preso per R.
Le anticipo i miei umilissimi ringraziamenti per il tomo dell'AntichitaÁ
Italiche che mi favorisce, che mi saraÁ gratissimo, e col solito invariabile ri-
spetto, e perfettissima stima, ho l'onore di raffermarmi.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI61
Trieste 16 giugno 1788
Dal Signor Marchese Gravisi ho ricevuto il primo tomo delle sue Anti-
chitaÁ Italiche, che trovai piene di molta erudizione e mi sono oltremodo gra-
tissime, perche mi servono di grande istruzione delle cose antiche di questa
nostra commune Provincia. Ne rendo percioÁ all'Eccellenza Vostra i piuÁ sin-
ceri ossequiosissimi ringraziamenti, e vorrei di buon animo contribuire a
fornirle qualche monumento che li servisse per li tomi successivi.
Mi eÁ molto spiaciuto poi di non aver l'onore di qui personalmente in-
chinarla, come mi lusingavo, e che questo contento mi venghi differito al-
l'anno prossimo venturo, come rilievo dal suo pregiatissimo foglio delli 7
corrente.
L'avrei persuasa, in passando, d'andar a vedere in Aquileja, dove da al-
cune settimane si sono scoperte molte lapidi ed iscrizione antiche nel tempo
380
61 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 76r.
che fa lavorare il signor conte Cazis compratore de' beni che colaÁ erano del-
le monache soppresse 62.
Se potesse mandarmi qualche intelligente che sapesse anche disse-
gnare per averne delle fedeli copie, mi pare che questa sarebbe ottima
cosa; bisognerebbe mandarlo da Venezia, o da Padova, a scanso di lun-
go viaggio.
Le unisco qui appresso gl'ulteriori fogli stampati sin'ora della mia Dis-
sertazione, e terminata che saraÁ l'Appendice de' documenti gl'invieroÁ anche
questa con un esemplare compito.
Ho l'onore di raffermarmi con invariabile rispetto, e venerazione.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI63
Trieste 6 agosto 1788
Ho ricevuto il pregiatissimo foglio di Vostra Eccellenza delli 30 del
prossimo scorso luglio, ed ho tosto scritto a Monsignor Girolamo de Rinal-
dis canonico della chiesa metropolitana d'Udine accioÁ mi volesse favorire
d'interporsi presso Padre Cortenovis barnabita per ottenere copia della di
lui raccolta dell'inscrizioni inedite scoperte in Aquileja 64.
Ho anche scritto al medico d'Aquileja, accioÁ mi volesse far avere una
tal copia. Se otterroÁ qualcosa da una, o dall'altra parte, saroÁ sollecito senz'al-
tro a fargliene comunicazione.
Il signor Marchese Girolamo Gravisi mi ha favorito la copia d'una bella
inscrizione scoperta in Aquileja tra le rovine di quel monastero. Non dubito
che gliel'averaÁ comunicata ma se mai avesse tardato, avroÁ il piacere d'essere
il primo a partecipargliela, ed eÁ questa: [...] 65. Egli la vede del quarto seco-
lo, perche Costantino ha prescritto che le tre prime arti nominate nell'inscri-
381
62 Si riferisce al conte Antonio Cassis Pharaon, giaÁ appaltatore delle dogane d'Egit-to, rifugiato a Trieste. AcquistoÁ vasti possedimenti nella zona di Aquileia, a Precenicco,dove avvioÁ scavi archeologici.
63 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 77r.64 Girolamo de Rinaldis e Angelo Cortenovis, eruditi ed antiquari udinesi.65 Omettiamo la trascrizione della lunga epigrafe (17 righe) integralmente riportata
da CARLI, Delle antichitaÁ italiche, III, cit., p. 41 e ripetuta ibidem, p. 243.
zione fossero in un corpo solo comprese. Sarebbe rarissima, poiche Tiberio
ha trasferito dal popolo in Senato i comizij e le tribuÁ si trovano notate in
alcune lapidi sino sotto Settimio Severo. Il stampatore mi fa delirare, non
terminando di stampare la mia Dissertazione, mancandogli due soli fogli
dell'Appendice. Tosto che saraÁ finita questa benedetta stampa, non lascieroÁ
di servire Vostra Eccellenza nel modo aditatomi, ed intanto ringraziandola
infinitamente per la buona opinione che ha della mia opera, con sommo ri-
spetto e venerazione ho l'onore di raffermarmi.
P.S. Certamente l'inscrizione di C. MINICIO eÁ mal rilevata, e quando non
si possa averne una piuÁ corretta, converrebbe supplire al difetto alla meglio
possibile.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI66
Trieste 6 settembre 1788
Finalmente questo stampatore mi ha dato i fogli dell'Appendice della
mia Dissertazione, che qui uniti rimetto a Vostra Eccellenza col mezzo
suggeritomi dal signor Marchese Gravisi. Non ho altro ottenuto da esso
stampatore, dicendomi che gli manca d'imprimere i rami e di cucire gl'e-
semplari. Quando averoÁ questi ottenuti, non lascieroÁ di spedirle un'esem-
plare
intiero.
Ho una cosa in testa, ed eÁ che credo la mia famiglia da Capodistria, e
da questa cittaÁ in Trieste trapiantata. La genealogia tessuta da P. Ireneo
della Croce eÁ una fandonia. Monsignor Rapicio ne' suoi manoscritti ha
toccato l'origine: « per hec tempora (1296) familia Bonoma originem tra-
xit; primus enim qui in urbem venit fuit Nicolaus Bertaldus de Crescentio,
cuius filius Bonomus Nicolaus, Oldericum et Guagliorum suscepit, qui
quod Bonomo patre nati essent, Bertaldi cognomine antiquato Bonomi
appellationem retinuerunt ». Egli peroÁ prende sbaglio nel credere che il
detto NicoloÁ avesse avuto il cognome di Bertaldo, quando questo era il
nome del padre e il de Crescentio era il cognome. Sbaglia ancora nel tem-
382
66 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 78r.
po della di lui venuta ad abitare in Trieste, assegnandovi l'anno 1296
quando in carta del Vescovo Arlongo del 1278 fondazionale di questo mo-
nastero di monache si trova fra' testimonj nominato «Nicolao qd. Bertaldi
de Crescentio », stampata dal signor Conte Coronini ne' suoi Miscellanei
pag. 138-139 67. E in altra carta del 1294 ivi al foglio 184 si trova nomi-
nato il di lui figliolo «Odoricus de Bonomo, Guagliorum qm. D.ni Bono-
mi », e «Nicolaus qm. D.ni Bonomi » dal che si vede bene, che lasciato il
cognome de Crescentio abbiano preso quello di Bonomo che proseguõÁ ne'
loro discendenti.
Avendo trovato in carta di Vostra Eccellenza del 1216 della Disserta-
zione terza del medio evo al foglio 109 nominato «Veltramo de Crescen-
tio », ho sospettato che la mia famiglia possa esser derivata da Capodistria,
tanto piuÁ che trovai nelle rilevande del seguente secolo XIV di Corvo Bo-
nomo ammogliato « in Frixam, filiam Ser Ingalperij de Vida Iustinopolita-
ni », ed Ispera figlia del medesimo Corvo Bonomo moglie « eximij doctoris
in decret. Santi de Pelegrinis Iustinopolitani ». Domando perdono a Vostra
Eccellenza di questa mia digressione, e la supplico se mai per casualitaÁ gli
pervenisse nelle mani qualche carta di tal uno della famiglia de Crescentio,
che far potesse al mio proposito, e singolarmente se nominato vi fosse il
Bertaldo de Crescentio, di volermi graziare di partecipazione e con sommo
invariabile rispetto, e venerazione ho l'onore di raffermarmi.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI68
Trieste 5 novembre 1788
Ho ricevuto il pregiatissimo foglio di Vostra Eccellenza delli 28 prossi-
mo scorso ottobre, ed ho letto il contenuto, che finalmente il Signor Stefano
Conti le abbia reso la mia Dissertazione della quale riceveraÁ per mezzo del
Signor Marchese Girolamo Gravisi due altri esemplari in segno della pre-
mura, che ho di servirla; cosõÁ potessi fare colle misure richiestemi della con-
saputa antichitaÁ che non mi eÁ possibile di servirla. BensõÁ se in altro mi trova
383
67 CORONINI, Operum miscellaneorum, cit., pp. 138-139.68 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 78v.
atto ad obbedirla, mi saranno sempre grati i suoi pregiatissimi comandi, on-
de poterle dare sempre maggior prova del mio invariabile vero rispetto, e
distintissima estimazione.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI69
Trieste 8 aprile 1789
Dal Signor Marchese Girolamo Gravisi fui in questi giorni favorito del-
la seconda parte delle AntichitaÁ Italiche che Vostra Eccellenza ebbe la bon-
taÁ di spedirmi in dono. Io le rinovo i miei ossequiosissimi ringraziamenti per
questa tanto pregevole opera, che contiene tanti belli monumenti della no-
stra Provincia e che sono con tanta erudizione e dottrina illustrati, come per
l'onore impartitomi colle replicate menzioni di cui ha voluto contro i miei
meriti favorire. Sarebbero desiderabili de' documenti intorno al cristianesi-
mo della nostra Provincia, e intorno allo stabilimento delle Cattedre, e de'
Vescovi; ma la gran lontananza de' tempi fa che poco, o nulla si possa scri-
vere sopra tale argomento per mancanza di lumi.
Sono sempre a' comandi di Vostra Eccellenza, e con invariabile vero
rispetto e venerazione ho l'onore di raffermarmi.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
A GIANRINALDO CARLI70
Trieste 3 settembre 1789
Ho ricevuto il pregiatissimo foglio di Vostra Eccellenza delli 26 del pros-
simo passato agosto, ed ho dato corso immediatamente col traghetto all'inclu-
sami per il signorMarcheseGravisi. Le inscrizioni d'Aquileja sono state negate
dal possessore signor Canonico de Rinaldis e desidero che il signor Marchese
Gravisi abbia miglior sorte d'acquistarle per mezzo del conte Asquini 71.
384
69 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 79v.70 AmC, fondo Carli, fasc. 1471, c. 80r.71 L'udinese Basilio Asquini, barnabita, autore del volumetto Cent'ottanta, e piuÁ uo-
Ho veduto le due inscrizioni di Licinio Diocleziano dedicate a Gallieno
e Salonina, perche al primo convengono li tre titoli di Magno, invitto e Ger-
manico, ed alla seconda peculiare quello di Santissima. Caracalla ha egli pu-
re il titolo di Magno, ma mi pare conferitogli dopo la morte da Macrino nel-
la consacrazione, come spiega il Vaillant nella medaglia DIVO.ANTONINO.MA-
GNO; e la lapide eÁ d'un imperatore vivo. Si trova peroÁ in medaglia il titolo di
« Patricius Maximus » dato a Caracalla.
Il titolo d'« Invitto » non trovo datogli nelle medaglie del Mezzobar-
ba 72, bensõÁ a suo padre Severo = INVICTO.IMP.TROPHAEUM = quello di Ger-
manico sõÁ.
A Giulia Domna si trovano dati i titoli di «Mater augg. », «Mater
castr. », «Mater senatus » e «Mater patriz. » che non si trovano dati a Sa-
ponina.
Di questo bensõÁ secondo il Liguoro 73 sono dell'inscrizioni col titolo di
« Sanctissima », che non si trova attribuito a Giulia Domna. Veramente ne
ho trovate due con tale titolo: una rapportata dal signor Serviez nelle vite
delle imperatrici romane: CORNELIAE.SALONINAE / SANCTISSIMAE.AUG. / CO-
NIUGI.GALLIENI. / IUNIORIS.AUG.ORDO. / GEMENEL.CURANTE. / AURELIO.IANUA-
RIO. / V.F.
Altra edita dal Patino in Numism. ex aere medio etc. 74: GALLIENO.CLE-
MENTISSIMO.PRINCIPI. / CUIUS.INVICTA.VIRTUS.SOLA.PIETATE. / SUPERATA. / ET.-
SALONINAE.SANCTISSIMAE.AUG. / M.AURELIUS.VICTOR. DEDICATISSUMUS. / NUMI-
NI.MAIESTATIQUE.EOROUM.
Galleino si trova nelle medaglie col titolo di «Germanicus Maximus »,
e con quello di « Invictus ». E queste sono le ragioni che mi hanno indotto a
credere l'esser dedicato ad esso, e alla sua moglie le dette iscrizioni, alla qua-
385
mini illustri del Friuli quali fioriscono, o anno fiorito in questa etaÁ, Pasinello, Venezia1735.
72 F. MEZZABARBA BIRAGO, Imperatorum Romanorum numismata a Pompeio magnoad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta, Ex aedibus societatis Palatinae, Mediolani1730.
73 O. LIGUORO, Ristretto storico sopra l'origine degli abitanti della campagna di Ro-ma, e successivamente de' re, consoli, dittatori..., Casamara, Genova 1717.
74 C. PATIN, Imperatorum Romanorum numismata ex aere mediae et minimae for-mae: descripta et narrata, apud Georgium Gallet, Amstelodami 1696.
le possa aver profuso il Licinio Diocleziano i titoli di «mater castrorum, se-
natus et Patriae », che forse non gli aspettavano.
Compatisca Vostra Eccellenza questa mia filastrocca, e con sommo in-
variabile rispetto, e venerazione ho l'onore di raffermarmi.
[Andrea Giuseppe de Bonomo]
IV. - Fogli di censura
CENSURA DI LUIGI MONTAN (1827) 75
IMPERIALE REGIO UFFICIO DI REVISIONE DEI LIBRI E STAMPE
PER LE PROVINCIE VENETE
Foglio di Censura presentato li 18 dicembre 1827.
TITOLO DELL'OPERA
Biografia degli uomini distinti dell'Istria
del Canonico Pietro Stancovich
Tomo I per la stampa
Esibente: l'Autore.
Decisione: Noto l'Autore per altre sue letterarie produzioni, compari-
sce al presente con un nuovo lavoro, che lo qualifica vero amante del sape-
re, e della sua patria compilando una Biografia degli uomini distinti dell'I-
stria. La molteplice erudizione, che vi eÁ sparsa accompagnata dalla critica
piuÁ giudiziosa rendono questa opera degna della pubblica luce, e meritevole
di tutta lode l'autore, il quale certamente avraÁ dovuto assai travagliare per
raccogliere i documenti piuÁ irrefragabili, onde non cadere in abbaglio. Con
tutta compiacenza percioÁ se ne accorda la stampa, non essendovi giaÁ ogget-
to alcuno politico, per cui sia necessario invocare la governativa licenza.
Venezia 18 dicembre 1827
Admittitur ad inprimendum
L. Montan Regio censore 76
386
75 ASVe, Censura, busta 88 (1827), fasc. 26, rubr. III, prot. n. 3289.76 Luigi Montan, giaÁ priore di San Cristoforo e canonico di San Marco, era stato
lettore nell'Istituto agostiniano della congregazione di monte Ottone. Dopo il trasferi-mento a Venezia fu a lungo insegnante di diritto canonico e storia ecclesiastica al semi-nario della cittaÁ lagunare.
CENSURA DI LUIGI MONTAN (1829) 77
IMPERIALE REGIO UFFICIO DI REVISIONE DEI LIBRI E STAMPE
PER LE PROVINCIE VENETE
Foglio di Censura presentato li 20 gennaro 1829.
TITOLO DELL'OPERA
Biografia degli uomini distinti dell'Istria
del Canonico Pietro Stancovich
Tomo secondo, per la stampa
Esibente: l'Autore.
Decisione: Quanto interessante eÁ il primo volume di questa Biografia,
lo eÁ questo altrettanto per la qualitaÁ ed eccellenza de' soggetti illustrati, e
veramente classici in ogni genere di letteratura, di scienze, ed arti. Nulla
di essenziale si eÁ ritrovato, che si opponga ai veglianti regolamenti, e solo
alcune picciole inesattezze, che si sono o cancellate, o rettificate. Tutto il re-
sto eÁ immune da ogni censura.
Venezia 21 Gennaro 1829.
Admittitur ad imprimendum, omissis delendis,
et correctis corrigendis
L. Montan Regio Censore
CENSURA DI PIETRO PIANTON (1829) 78
IMPERIALE REGIO UFFICIO DI REVISIONE DEI LIBRI E STAMPE
PER LE PROVINCIE VENETE
Foglio di Censura presentato li 29 Dicembre 1828.
TITOLO DELL'OPERA
Primo Giubileo del Porto Franco di Trieste
celebrato nel dõÁ 10 di settembre dell'anno 1828
dalla Triestina SocietaÁ del Gabinetto di Minerva
387
77 ASVe, Censura, busta 88 (1829), fasc. 26, rubr. III, prot. 178/1829.78 ASVe, Censura, busta 88, a. 1828, prot. V-1/165, n. 3366 PG/O, Opere.
Esibenti: Li Direttori del Gabinetto di Minerva in Trieste.
Decisione: Nel giorno 10 settembre 1828 si eÁ compiuto il primo secolo
da che Carlo VI eresse in Trieste il Porto Franco. Questo avventuroso av-
venimento scosse la SocietaÁ del Gabinetto di Minerva a celebrare in prosa
ed in versi il giorno, in cui si eÁ maturato il primo secolo: e sotto il titolo di
Primo Giubileo voglionsi pubblicare le lette cose in quella radunanza. Con-
sistono queste in una introduzione dell'avvocato de Rossetti, in un ragiona-
mento del dr. Joel Kohen, in un carme del prof.e Lugnani, in un discorso
del sr. Kandler, in una memoria del sr. Nobile, in una epigrafe del sr. Ron-
dolini, al che tiene dietro la descrizione ed illustrazione di un medaglione
coniato per tale ricordanza. Trovai alcuni tratti meritevoli di castigazione,
sia perche troppo arditi in riguardo all'avvenire, sia perche troppo arditi
in riguardo a' Veneziani. Ritenute le correzioni, ed ottenuto che abbiano
gli editori il Placet del Governo di Trieste non posso non accordare agli
stessi il permesso di mandar ai torchi tal manoscritto.
Omissis delendis correctis corrigendis
admittitur ad imprimendum
Venezia, 22 gennaio 1829
P.A. Canonico Pianton Regio Censore 79
V. - Lettere riguardanti il giubileo del porto franco
A KLEMENS LOTHAR PRINCIPE DI METTERNICH80
Altezza Principe di Metternich.
Abbiamo l'onore di presentare all'Altezza Vostra un medaglione di ar-
gento e altro di rame, che la SocietaÁ del Gabinetto di Minerva fece coniare
per la celebrazione del primo giubileo del porto-franco di Trieste, avvenuta
nel dõÁ 10 Settembre del prossimo passato anno 1828.
388
79 Pietro Pianton, al secolo Angelo Pasquale, nato a Vicenza nel 1775. Entrato gio-vanissimo nell'ordine dei Carmelitani scalzi prese il nome di Pietro. Laureatosi in dirittocanonico, insegnoÁ filosofia morale e sacra scrittura e successivamente, come prete seco-lare, continuoÁ ad insegnare privatamente diritto civile e canonico. Dal 1815 fu censore ecompare negli elenchi dei confidenti della polizia austriaca.
80 CMSA, Archivio della SocietaÁ di Minerva, fasc. 1829, carte non numerate.
Voglia l'A. V. riconoscervi un tenue segno di suddito amore e ricono-
scimento verso il benefico nostro Monarca e l'Augusta sua Casa; ed aggra-
dirli ad un tempo quale tributo di quella particolare devozione ed ossequio
che a nome della nostra societaÁ , e per noi medesimi godiamo poterLe ras-
segnare, mentre rispettosamente ci segnamo
Di Vostra Altezza umilissimi, obbedientissimi servitori
Direttori del Gabinetto di Minerva
Trieste, 25 Maggio 1829
A CARLO CHOTEK CONTE DI CHOTKOWA E WOGNIN81
Eccellenza Chotek 82.
Se avessi osato seguire l'impulso di un frequente mio desiderio, V. E.
avrebbe giaÁ altre volte avuto a tollerare l'incomodo di qualche mia lettera.
Questa volta peroÁ quello vinse ogni mia tema e dubitazione tra perche op-
portuna me ne venne l'occasione, e perche questa varraÁ alla stessa a meri-
tarmi compatimento.
Il rispettoso foglio qui annesso della SocietaÁ del Gabinetto di Minerva,
faraÁ conoscere all'E.V. tanto l'oggetto di quella occasione quanto gl'ingenui
sentimenti di questa societaÁ , la quale puoÁ essere a certo modo la rappresen-
tante di quelli dei riconoscenti triestini.
A questi sentimenti, pertanto, qui aggiungo anche i miei propri concen-
trandoli in una sola espressione, perciocche lo svilupparli potrebbe offende-
re la modestia di V. E.; io diroÁ solamente che, se la sovrana volontaÁ non
avesse chiamato l'E.V. a maggiori destini, la mia Trieste non starebbe come
sta purtroppo ancora ondeggiante fra il sempre crescente timore di rovinose
innovazioni, e le decrescenti speranze di ripristinazione dell'antico esser
suo. Io tutto potroÁ dimenticare, ma non mai quello che l'E. V. scriveva
per Trieste nel mese di luglio del 1816. Ne d'altro prego l'E. V. che il per-
389
81 CMSA, Archivio della SocietaÁ di Minerva, fasc. 1829, carte non numerate.82 Carlo Chotek di Chotkowa e Wognin (1782-1868), fu nominato nel 1815 gover-
natore generale del regno di Napoli e passo ben presto all'incarico di governatore diTrieste con la morte del barone Bernardo de Rossetti. Successivamente fu governatoredel Tirolo e del Vorarlberg e dal 1826, del regno di Boemia.
mettermi d'esserne memore finche io viva qualunque sia poi per essere la
futura sorte della mia patria.
Sperava potere presentare i medaglioni accompagnati da un libretto
contenente le prose e i versi letti nell'adunanza del 10 settembre passato;
ma avendomene questo governo vietato la stampa, non posso qui rassegnar-
le che la descrizione illustrativa del medaglione medesimo. Come peroÁ nel I
volume che ora stassi stampando di una mia Raccolta di opuscoli e notizie
per Trieste e per l'Istria, non incontroÁ quella sciagura; cosõÁ mi permetteraÁ
l'E. V. che Le faccia a suo tempo (nel venturo Agosto) pervenire una co-
pia 83.
Aggradisca dunque la conferma di quei sentimenti d'indelebile ricono-
scenza a' quali mi glorio potere accompagnare le mie proteste di rispettosa
servituÁ e d'ingenua devozione, mentre ho l'onore di segnarmi
Dell'Eccellenza Vostra umilissimo obbedientissimo servitore
Domenico Rossetti
Trieste, 28 Maggio 1829
DI FRANZ JOSEPH CONTE SAURAU 84
Pregiatissimi Signori!
Ottima idea fu quella di cotesta SocietaÁ del Gabinetto di Minerva, di
celebrare con apposito medaglione il primo giubileo del porto-franco di
Trieste, ed io ammirai la felice esecuzione di questa bella prova di patrio
amore. Nel rendere i dovuti ringraziamenti pel gentil dono, che la SocietaÁ
me ne fece, non posso che formare i piuÁ sinceri voti per la floridezza di co-
testa cittaÁ , e del suo esteso commercio. Aggradiscano pregiatissimi Signori,
la stima con cui mi pregio di dirmi
Il di lei ossequiosissimo servo
Saurau 85
Vienna 29 Giugno 1829
390
83 L'intero paragrafo compreso fra <> venne omesso da Rossetti nella versione de-finitiva della lettera.
84 ARS, II, fasc. V, carte non numerate.85 Franz Joseph Saurau (1760-1832) venne nominato nel 1784 consigliere di Stato a
Praga e nel 1801 ambasciatore in Russia. Dal 1805 fu governatore della Stiria e dal 1813
All'illustrissimo Signore
Il Signor Dr. Domenico Rossetti
Direttore del Gabinetto di Minerva - Trieste
MEMORIA DI DOMENICO ROSSETTI86
Allorche al presente manoscritto fu meravigliosamente vietata la stam-
pa, ne feci eseguire a penna una nitida copia, e la rassegnai a personaggio
per ogni titolo superiore ai censori dello scritto, acciocche conosca se in
questo trovisi cosa ragionevolmente censurabile.
L'Ufficio di Censura di Venezia s'immaginoÁ che il Giubileo triestino
alludesse, invidiasse od attentasse alle liete aspettative, in cui quella cittaÁ sta-
vasi per lo conseguimento di quel porto-franco che le fu conceduto da S. M.
l'Imperatore con suo autografo dei 20 del passato Febbraio 87. Ma quel cen-
sore vedeva un po' troppo al di laÁ di quello che sta scritto e fu pensato dagli
autori, i quali tutti non altamente nominarono Venezia o ad essa allusero,
che relativamente al tempo passato, sulla fede della storica veritaÁ la quale
a dispetto di tutti i censori parleraÁ sempre, e saraÁ sempre veritaÁ .
Il censore veneto, dopo aver corretto e cassato alcuni passi, permetteva
la stampa a condizione che v'intervenisse il Vidit ed il Placet del Governo di
Trieste. Ma questo Governo, allorche il tipografo Marenig glielo presentoÁ
per la conclusiva approvazione, dopo breve indugio resituõÁ il manoscritto
con vocale divieto di eseguirla; ond'io l'obbligai di ripresentarlo per conse-
guire o l'approvazione o il non admittitur per iscritto.
Ma com'egli n'ebbe nuovamente e sempre localmente la negativa; fui io
costretto di chiedere ai 24 del passato Febbraio coll'istanza N. 4045 una de-
liberazione scritta, e l'ottenni con decreto dei 7 Marzo attergandovi. Onde
nulla manchi alla storia di questo manoscritto, l'istanza e il decreto qui ac-
391
ebbe l'incarico di sovrintendere all'organizzazione politica delle Province Illiriche, cheabbandonoÁ nel 1815 quando divenne governatore della Lombardia.
86 ADTs, segn. 1/2 D 12, cc. 5r-6v.87 Con autografo del 20 febbraio 1829 l'imperatore Francesco I concesse l'estensio-
ne del porto franco, sino ad allora limitato alla sola isola di San Giorgio maggiore, a tuttala cittaÁ di Venezia. Il 22 dicembre vennero stabiliti i limiti del porto franco che venneaperto il 1 febbraio 1830.
cennati sono con esso, e tutti in originale, insieme raccolti nel presente vo-
lumetto.
Allorche il Marenig mi riportoÁ il manoscritto col vocale divieto, lo esa-
minai attentamente per ravvisare quali passi osservi stati segnati dal censore
di questo Governo. Ve ne trovai alcuni pochi; ma tutti, per singolare com-
binazione, nella sola mia introduzione. E questi sono quelli che qui veggonsi
sublineati o marginalmente segnati in maniere diverse.
Restituitomisi il manoscritto collo scritto divieto, vi ho fatto nuova rivi-
sta, e vi trovai, sõÁ nel mio che in alcuni altri articoli, parecchi segni nuovi et
una postilla a matita nera.
Sarebbe facilissima cosa il fare degli utili commenti a tutti questi indizi
di disapprovazione; ma io riverentemente me ne astengo. DiroÁ solamente
che se il lodare le istituzioni sovrane, se lo spiegarne riconoscenza, se l'ec-
citare la presente e la futura generazione a rendersi sempre piuÁ utile allo
Stato ed alla sua cittaÁ natale, meritoÁ la superiore disapprovazione; dovraÁ ne-
cessariamente conchiudersi che degni di biasimo siano o quei sentimenti, o
queste disapprovazioni. E com'io non posso crederlo dei primi senza tradire
l'intelletto e la buona coscienza, ne delle seconde senza peccare d'irriveren-
za verso le superiori autoritaÁ , che hanno un tal quale diritto di presumersi
infallibili: finiroÁ coll'attribuire il tutto alla fortuita combinazione di antipa-
tiche circostanze di tempi, di luoghi, di persone, e perfino di atmosferica
temperatura; e me ne conforteroÁ pensando che tutto segue per lo meglio.
Dr. D. de Rossetti
14 Maggio 1829
392
INDICE DEI DOCUMENTI
E DELLE FONTI D'ARCHIVIO
ANTWERPEN, StadsarchivParochial-Register, Sint Jacob n. 59
Parochial-Register, Sint Jacob n. 300Schepen-Register 1264Schepen-Register 1271Schepen-Register 1276
Schepen-Register 1288Schepen-Register 1290
CAPODISTRIA, Archivio antico municipale (microfilm presso l'Archivio di Statodi Trieste), fondo CarliReg. 1486 Relazione di me Tomaso Tarsia cavaliere Dragomanno grandedella Serenissima Repubblica di Venezia alla Porta Ottomana con la descrit-
tione del Compendio delli successi piuÁ essenziali accaduti nella guerra intra-presa da' Turchi contro l'Ungheria - Manoscritti e lettere varie di Gianrinal-do CarliReg. 1500-1502 Corrispondenza scientifico-letteraria di Gianrinaldo Carli
DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek133 G 13/1-6 J. Meerman, Reisjournal door England, Frankrijk, Zwitser-
land, ItalieÈ, Oostenrijk en Zuid-Duitschland, 6 voll.
DEN HAAG, Nationaal ArchivEerste Afdeling, Legatie Smina, inv. nr. ij.
Staten-Generaal, 4.12.1780, c. 8rv2de Afdeling, Legatie-archieven, inv. n.2262de Afdeling, Legatie-archieven, inv. n. 2502de Afdeling, Legatie-archieven, inv. n. 251
PRAHA, StaÂtnõÂ OblastnõÂ Archiv
393
Fondo Casanova, Marr 13/e/05, 13/e/07, 13/e/01, 13/e/02, 13/e/04, 13/
e/03Fondo Casanova, Marr 15Fondo Casanova, Marr U/12/27
ROVIGO, Accademia dei Concordi
Silv. 96-7-5 /fasc. 2), Le smanie della gratitudine angustiata dalla necessitaÁdel parlare e del tacere. Accademia per la partenza dell'Ill.mo et Ecc.mo Si-gnore il Signor Marco Michiel Salomone dal suo acclamatissimo reggimentodi Capodistria, recitata alla di lui presenza da i Signori Accademici Divertiti
sotto la direzione del P. Gio. Maria Foresti C. R. S. l'anno 1698 nel mese disettembre
TRIESTE, Archivio dei conti Rossetti de ScannerBusta II, fasc. V
TRIESTE, Archivio diplomatico
a B 3 A. G. de Bonomo, Codice diplomatico 911-1453a B 4 Privilegj, consegli, istrumenti, lettere, informazioni, agiustamenti etc.(Codice Piccardi)û A 2 Liber aureus Civitatis Tergesti ab anno 1582
û CC 12 Genealogia della nobilissima prosapia de' Bonomo della cittaÁ diTriesteû E 8 Inventario delle scritture esistenti nelle Segrete dell'Archivio Pub.o1/1 B 2 L. de Jenner, Genealogie delle XIII Casade, 2 voll.
1/1 B 3 L. de Jenner, Genealogie triestine, 2 voll.1/1 B 4 L. de Jenner, Biografie triestine, 2 voll.1/1 C 6 P. Tomasin, Codice epigrafico di Trieste e dell'Istria, 2 voll.
1/1 F 9, Incarichi speciali al barone Antonio Marenzi1/1 F 16 Copialettere della Minerva1/2 A 1 Circolari delli Stabilimenti mercantili formalmente insinuati1/2 A 4 SocietaÁ del Casino Vecchio
1/2 B 30 Giornale del tempo1/2 C 8 P. Kandler, La Giulia1/2 C 29 Minerva - Conversazioni accademiche 1812-18421/2 D 12 Primo Giubileo del Porto franco di Trieste celebrato nel dõÁ10 di
settembre dell'anno 1828 dalla Triestina SocietaÁ del Gabinetto di Minerva1/2 E 8 Epistolario del Conservatore2 A 20 A. Alisi, Materiali per le genealogie capodistriane, 2 voll.
2 D 17 Annuae Collegij Tergestini 1722-17722 D 18, Catalogus studiosorum Collegii Tergestini Societatis Iesu 1619-1809
394
2 D 31 Per li Reverendi Padri delle Scuole Pie Direttori del Seminario di
Capodistria 1675-17527 G 11/5 borse di studio7 G 11/12 G. de Periboni, Giornale della venuta dei francesi (1797)7 G 13 Codice diplomatico istriano
7 G 14/2 Magistrato civico9 G 4/7 L. de Jenner, Famiglia Marenzi9 G 6/3 A. G. de Bonomo, Sopra le monete de' vescovi di Trieste12 B 4/1 A. G. de Bonomo, Della giustizia dei diritti austriaci sopra l'Istria
12 B 4/16 Lettera critica sopra un chirografo intitolato: «Memorie dell'an-tica Emonia da altri Antichi chiamata Eraclia, da altri Novizio e finalmenteora Cittanova, raccolte da me Bartolamio Rigo » del Conte Stefano Carli al
Signor Martolomeo Rigo12 D 5/2 Discorso in onore di imp. Carlo VI recitato dal Dr. Kandler nellafesta secolare del Portofranco del 30 Sett. 182912 D 6 Carte Kandler
14 E 2 Documenti su Antonio Marenzi17 G 1 Commissione ratatrice18 F 6 Protocollo dell'Inclita Cesare Regia Economica Comissione 177121 D 3/7 Fondo Incontrera
21 D 3/12 Fondo Incontrera21 D 3/88 Fondo Incontrera21 D 5/2 Carteggio Kandler-Rossetti22 C 1 L. de Jenner, Famiglia Bonomo
142 C Carte Tamaro142 E Carte Tamaro
TRIESTE, Archivio di StatoArchivio Notarile (1680-1923)
busta 179 Testamenti nr. 573, Atti di Valentino Mazzorana notaio inTrieste
I.R. Accademia di Commercio e nautica (1816-1823)busta 3 Atti generalibusta 5 Atti generali
Cesarea Regia Suprema Intendenza Commerciale (1748-1776)
busta 66 Personale dell'Intendenza Commercialebusta 67 Personale dell'Intendenza Commercialebusta 80 Personale dell'Intendenza Commerciale
busta 125 Risolutioni (Resolutiones)busta 177 Impieghi, pensioni, sussidi (Standes, Erhebungen u.Pensions-Gesuchen)
395
busta 311 Commercio del ferro da Carinzia, Svezia e Moscovita
(Eisen-Handel)busta 436 Studio di Nautica (Nauticum Studium)busta 610 Personale dell'Intendenza e altri ufficibusta 698 Personale di uffici pubblici di Trieste
Cesareo Regio Governo del Litorale (1776-1809)busta 44 Cassa cameralebusta 126 Scuole tedesche (Schulwesen)busta 131 SanitaÁ e lazzaretti (SanitaÈtsachen und Lazarethe)
busta 168 Affari commerciali (Commerciale)busta 318 Affari di sanitaÁ (SanitaÈts-Sachen)busta 437 Consoli ed agenti esteri (Fremde hier residirenden Consuln)
busta 561 SanitaÁ, pesca nel lazzaretto, epidemie, fabbrica di tela davele (SanitaÈtsachen)busta 1121 Atti presidialibusta 1164 Consolato olandese
Deputazione di Borsa (1755-1921)Protocollo delle radunanze n. 8 - 1797Protocollo delle radunanze n. 19 - 1808Protocollo delle radunanze n. 21 - 1810-1811
Protocollo delle radunanze n. 22 - 1812Protocollo delle radunanze n. 23 - 1813
I.R. Governo Marittimo (SeebehoÈrde) 1850-1923busta I Atti presidiali
I.R. Governo del Litorale (1814-1850) - Atti generalibusta 493 Censura
I.R. Intendenza dell'Istria (1813-1814)
busta 32 Censura, tipografie, giornaliI.R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918)
± Atti generalibusta 419 Affari di tolleranza
± Atti presidialibusta 64 Pubblico politico
I.R. Tribunale Commerciale e Marittimo (1781-1923)busta 127 Masse concorsuali
busta 137 Ventilazioni ereditariebusta 138 Ventilazioni ereditariebusta 139 Ventilazioni ereditarie
busta 353 Approvazione di ditte mercantili
TRIESTE, Archivio storico del Comune
396
Atti di fondazione n. 21 - Fondazione Zinzendorf
Trieste, Biblioteca Civica «Attilio Hortis »MS MISC. 50 Dissertazione sullo stato naturale dell'Uomo, del Senatore
Domenico Alberto Azuni Patrizio Sassarese e Pisano, Socio di varie Accade-mieR.P. MS 1-2 Il conte di Soisson. Storia galante tradotta dal francese da
A.B.D.S.R.P. MS 3-26/1-10 Carte dell'Accademia arcadicaR.P. MS MISC. 2-43, Passatempi di MinervaR.P. MS MISC. 87/XVII, Carte de Lugnani
R.P. MS MISC. 142 E Memoria della deputazione di BorsaCarte sparse sec. XVIII / Contribuzioni bellicheCarte sparse sec. XIX
TRIESTE, Civici Musei di Storia ed ArteArchivio storico della societaÁ di MinervaFasc. 1810
Fasc. 1812Fasc. 1828Fasc. 1829
TRIESTE, Fondazione Giovanni ScaramangaÁ di AltomonteG 49b, Lorenzo Miniussi, Trieste letterata
VENEZIA, Archivio di Stato
Censura, busta 88, anno 1827-1829
WIEN, Haus-, Hof- und StaatsarchivFamilienarchiv
SammelbaÈnde 15-16.Kabinettskanzlei, Nachlaû Zinzendorf
N. 8, Noten und Briefen an K. Maria Theresia und K. Josepf II. Son-
stige KorrespondenzN. 21 Sonstige KorrepondenzTagebuch Bd. 7, 1762.TagebuÈ cher Bd. 21-27, 1776-1782
ZADAR, Historijski archivMs. 89 Indice dei libri proibiti dal 1814 al 1820
397
INDICE DEI NOMI
399
Adelung, J. C.,Ademollo, A.F.,
Agostini, F.,Agostini, M. T. d',Ahumada Silva, I.,Alatri, P.,
Albertone, M.,Albonico, A.,Alembert, Jean-Baptiste d',
Algarotti, Francesco,Alisi, A.,Almerigotti, Francesco,Altgeld, W.,
Alverdes, P.,Ambrosoli, M.,Amidei, Cosimo,Andreozzi, D.,
Andries, L.,Andrulachi, Michele,Angelici, Antonio,Antonini, Giovanni,
Apih, E.,Apollonio Rodio,Ara, A.,
Arbo, A.,Archibugi, D.,Arcon, R.,Argento, Antonio dell',
Argento, Ferdinando dell',Ariosto, Ludovico,
Arnaldi, G.,Arnaud
Arnault, Emil Lucine,Arteaga, Stefano,Asquini, Basilio,Assezat, J.,
Astori, B.,Attems, Antonio Leopoldo d',Attems, Carlo Michele,
Attems, Ludovico (Vico),Attems, Sigismondo d',Auersperg, Heinrich von,Auersperg, Maria Antonia,
Azuni, Domenico Alberto,
Babudieri, F.,Bachiocco, Pietro,Baczko, B.,
Baecque, A. de,Baggiani, D.,Baiardi, Antonio de,Baiardi, Giovanni Giacomo de,
Baiardi, Giovanni Paolo de,Bailly, Charles,Ba lasz, E.,Baraux Francesco Emanuele Giu-
seppe,Baraux, Louis,Baraux, Michele Giuseppe,
Baraux, Pietro Francesco,
400
Barbabianca, Anteo,
Barbabianca, Giannandrea,Barbarisi, G.,Barbeyrac, Jean,Barcia F.,
Barsan, L.,Barucci, P.,Barzellini, Giuseppe,Basso, A.,
Battafarano, I. M.,Battisti, G.,Bauer, R.,
Bayle, Pierre,Beales, D.,Beaurepaire P.-Y.,Becagli, V.,
Beccaria, Cesare,Becher, Johann Joachim,Beer, A.,Beethoven, Ludwig van,
Begusch, H.,Beidtel, I.,Belli, Aurelio de,Belli, Giacomo de,
Bellusco, Giuseppe,Benco, S.,Bentham, Jeremy,
Benussi, B.,Benzoni, G.,BeÂranger, J.,Berengo, M.,
Berghold, J.,Berlinguer, L.,Bernardini, P.,Berti, G.,
Bertinotti, Teresa,Bertoldo di Aquileia,Bertoli, Gian Domenico,
Bertolino, A.,BertosÏa, M.,Beyreuther, E.,
Biagi, M. G.,
Bianco, C.,Billanovich, M. P.,Bin, A.,Bini Giuseppe,
Bitsch, G.,Bizzocchi, R.,Blaauboer, M.,Blanchenay, Jean,
Blanco, L.,Blumauer, Aloys,Blume, F.,
Blumegen, Cajetan vonBobbio, N.,BoÈdeker, H. E.,Boehm, L.,
BoÈhm, C.,Bolts, William,Bombi, A.,Bomnet, Charles,
Bonaparte Napoleone,Bonazza, S.,Bonicelli, NiccoloÁ ,Bonifacio, Baldassarre,
Bonnet, Charles,Bonomo, Andrea Giuseppe deBonomo, Corvo,
Bonomo, Giuseppe Maria de,Bonomo, Ignazio Andrea de,Bonomo, P.Bonzio, Giuseppe
Borghero, C.,Born, Ignaz von,Borri, G.,Borselli, Andrea de,
Bossi, L.,Bottarelli, G.,Bottura, Pietro,
Bozzi, D.,Bozzolato, G.,Bracewell, C. W.,
401
Branca, V.,
Brati Giovan Battista,Braun, G.,Bravar M.G.,Brecht, M.,
Bremer, T.,Breschi, M.,Breunlich, M.,Brigido, Michele L. de,
Brigido, Pompeo de,Brizzi, G. P.,Broadwood, John,
Bruck, Karl Ludwig von,BruckmuÈ ller, E.,BruÈ ckner, J.,Brunacci, Giovanni,
Brunelli, V.,Brunetti, F.,BuÈ helin Johann,Buquoi, Johann von,
Burlo, Pietro de,Busenello, Giovanni Francesco,Bussolin, G.,Buzzone, G. L.,
Cabanes, P.,Caldana, Marco Petronio,Caldana, Petronio,Callois, R.,
CalogeraÁ , Angelo,Calzabigi, Ranieri de',Cameron, R.,
Cammarata, A. E.,Camnich, Andrea de,Campagna, GiuseppeCantimori, D.,
CantuÁ , C.,Capra, C.,Caprin, G.,Capuano, Ignazio de,
Capuano, Luigi de,
Caputo, F.,
Carboni Tonini, N.,Carciotti, Demetrio,Carli, Gerolamo,Carli, Gian Girolamo,
Carli, Gianrinaldo,Carli, Stefano,Carlo Emanuele III di Savoia,Carlo VI d'Asburgo,
Carpanetto, D.,Carpani, Giuseppe,Cary, John,
Casa, G.,Casanova, Giacomo,Casati, E.,Casini, P.,
Cassese, M.,Cassis Faraone, Antonio,Castiglione, D.,Catalan, T.,
Caterina II di Russia,Catraro, Ciriaco,Cattanei, Carlo,Cattaruzza, M.,
Cavallini, I.,Cavanna, A.,Cavazza, S.,
Cazzaniga, G. M.,Cecovini, M.,Cella, S.,Cernecca, D.,
Cervani, G.,Cesarani, D.,Cesarotti, Melchiorre,ChaÁ , L. della,
Chabod, F.,Charmatz, R.,Chartier, R.,
CheÂrel, A.,Cherini, A.,Cherubini, Luigi,
402
Chevalier, J.-J.,
Chiara, P.,Chiaudano, M.,Childs, J. R.,Chittolini, G.,
Chorier, Nicolas,Chotek, Carlo de,Ciampi, Sebastiano,Ciampini, R.,
Ciancio, L.,Cimarosa, Domenico,Civrani, Leopoldo,
Clary, Antonia de,Clauzel, D.,Clementi, Muzio,Cluver, Philippe,
Cobenzl, Guidobaldo,Cocco Solinas, S.,Codelli, Pietro Antonio de,Coen Foschiatti, G.,
Colbert, Jean-Baptiste,Colesanti, M.,Coletti, Giuseppe de,Colleoni, A.,
Colombis, Ignazio de,Combelle, Pietro,Combi, C.,
Condillac, Etienne Bonnot de,Condorcet, Marie-Jean Antoine-Ni-
colas,Condulmer, Paolo,
Condutsch, Giovanni Ignazio,Contarini, Giovanni Maria,Conti, Stefano,Contini, A.,
Coons, R. E.,Corneille, Thomas,Coronini, Rodolfo,
Corradini, Giovanni,Corsini, U.,Cortenovis, Angelo,
Cosi, L.,
Cossar, G.,Cossar; R. M.,Cossutta, F.,Costa, A.,
Costantini, M.,Costanzo, Mattia,Courten, de (tenente),Cova, U..
Covre, P.,Coyer, Gabriel-FrancËois,Cozzi, G.,
Craigher, Jakob Nicolaus,Cras, H. C.,Cratey, Antonio,Cratey, Franz Karl,
Creglianovich Albioni, Giovanni,Crisci, A.,Croce, B.,Croce, Ireneo della,
Crosara, F.,Csaky, M.,Cunja Rossi, V.,Curcio, C.,
Curiel, C. L.,Curveiller, S.,Cusin, F.,
Czoernig, Carl von jr.,Czoernig, Carl von sr.,
D'Andrea, Francesco,Da Col, P.,
Da Lio, L.,Da Ponte, Bonifacio,Da Ponte, Lorenzo,Darjes, Joachim Georg,
Dassovich, M.,David, Cecilia,Davis, J. H.,De Antonio, C.,
De Canziani JaksÏic, T.,
403
De Franceschi, C.,
De Franceschi, E.,De Grassi, M.,De Maddalena, A.,De Nora, T.,
De Rosa, D.,De Rosa, L.,De Rubeis, Bernardo Maria,De Stefano, F.,
De Werth, (canonico),Dedeyan, C.,Degli Alberti, G.,
Degrada, F.,Del Bianco Cotrozzi, M.,Del Vecchio, G.,Delbello, P.,
Dell'Oro, Maria,Delogu, A.,Deschmann, S.,Deutsch, O. E.,
Deyon, P.,Di Brazzano, S.,Di Giusto, E.,Di Simone, M. R.,
Diaz, F.,Dickson, P. G. M.,Diderot, Denis,
Dietrichstein-Proskau, Johann Karl,Dionisotti, C.,Dittrich, E.,Dolinar, F. M.,
Dolliner, Thomas,Dollot, R.,DonaÁ, F.,Donati, C.,
Donzelli, D.,Dooley, B.,Doria, M.,
Dorsi, P.,Dubin, L. C.,Duchkowitsch, W.,
Duda Marinelli, G.,
Dugulin A.,Dupront, A.,
Ebner, H.,Egger, Franz von,Eichhorn, Johann Albrecht Frie-
drich,Eigeldinger, F. S.,Enrico, V.,
Erb, Johann Ludwig,EszterhaÂzy, Anton von,Evans, R. J. W.,
Fabbri, P.,
Faber, E.,Fabianich, Donato,Faccini, L.,Fasano Guarini, E.,
Fedalto, G.,Fehrenbach, E.,Fekete, Johann von,Fels, Sebastian,
FeÂnelon, FrancËois de,Ferdinando IV di Borbone,Ferrari-Baroni, E.,Ferrone, V.,
Fichte, Johann Gottlieb,Filangieri, Gaetano,Fin, Alessandro de,
Fin, Andrea de,Fin, Francesco de,Fini, Orazio,Fink, G.L.,
Finzi, R.,Flachenfeld, Cristoforo Lorenzo de,Florian, L.,Florio, Francesco,
Forbonnais, FrancËois Veron de,Foresti, Giovanni Maria,Forges Davanzati, G.,
404
Formaggini, S.,
Fortis Alberto,Foscolo, Ugo,Fougeret de Montbron, Louis-
Charles,
Francesco II d'Asburgo,Francol, Daniele de,Francol, Domenico,Francolsperg, Antonello Felice de,
Francolsperg, Antonio Felice de,Franusic, B.,Fries, Johann von,
Frigo, D.,Frijhoff, W.,Frizzi, Benedetto,Frodl, W.,
Frohn Johann Heinrich,Frossard, Ignaz Franz,Fubini, E.,Fubini, M.,
Gabbiati, Giacomo de,Gadolla, Ignazio,Galiani, Celestino,Gallarotti, A.,
Gallo, F.,Gamba, Bartolomeo,Garbarino, P.,Gardina, E.,
Garms-Cornides, E.,Gasser, P.,Gatti, C.,
Gavardo, Alessandro de,Gavardo, Gavardo de,Gavardo, Pietro de,Gavardo, Rinaldo de,
Gay, P.,Gazzaniga, Giuseppe,Genovesi, Antonio,Gentile, A.,
Geoffrin, Marie-TheÂreÁse,
Gerolini, Andrea,
Getto, G.,Ghepardi, R.,Ghisalberi, C.,Giarrizzo, G.,
Giaxich, NicoloÁ ,Gierl, M.,Giese, U.,Gilibert, G.,
Giorgini Bartolomeo,Gioseffi, G.,Girardi, M.,
Girgenti, A.,Giuliani, Antonio de,Giuseppe II d'Asburgo,Glezer, F.,
Gluck, Christoph Willibald,Gobbi, Andrea,Gobbi, Pietro,Goldoni, Carlo,
GoÈ schen,Gottardi, M.,Goubert, P.,Gozzi, Gaspare,
Graciotti, S.,Granzer, E.,Grassi, Giulio,
Gratton, G.,Gravina, Gianvincenzo,Gravisi, Girolamo,Gravisi, Giulio,
Gravisi, Giuseppe,Greci, R.,Green, Nathaniel,Gregis, Filippo,
Grenek,Grimani Marc'Antonio,Griot, Andrea
Grossi, A.,Grozio, Ugo,GruÈ nfeld, Johann Nepomuk,
405
Grusovin, M.,
Gspan, A.,Guadagnini, Francesco Antonio,Guagnini, E.,Guerci, L.,
GuÈ rtler, G. O.,Gutkas, K.,
Habermas, J.,Hacquet, Balthasar,
Haeften, de,Hagenauer, Ignaz,Haitsma Mulier, E. O. G.,Haller, Albrecht,
Hamilton, Niclas,HaÈrtel, R.,Hartig, Franz von,Hassinger, H.,
Haydn, Joseph,Hazard, P.,Heel, J. van,
Heindl, W.,Helbling, H.,Herbecke, U.,Herberstein, Johann Siegfried,
Herder, Johann Gottfried,Hillenaar, H.,Hochepied, Daniele Giovanni de,Hochkofler, Martino,
Hofer, G.,Hoffer, Giuseppe Michele,Hohenwart, Sigmund von,
Holbach, Paul-Henri d',HoÈ rnigk, Philipp Wilhelm von,Hortis, A.,Houtman-De Smedt, H.,
Hutin, S.,
Iacchia, I.,Iancis, P.,Iffland, August,
Incontrera, O. de,
Iona, M. L.,Ivanissevich, S. degli,Ivetic, E.,
Jacob, M. C.,Janoschitz, Joseph von,
Jenner, Joachim,Jenner, L. de,Julia, D.,
Jurco, Luigia de,
Kacin, M.,Kaltenstadler, W.,Kammerhofer, L.,
Kandler, Pietro,Kant, Immanuel,Kappus von Pichelstein, Joseph Si-
gismund,
Karlc, A.,Katsiardi-Hering, O.,Katz, J.,Kaunitz, Wenzel Anton,
Kernkamp, J. H.,Kick, Jakob,Kidric, F.,Kink, R.,
Kitnzler, C.,Klingenstein, G.,Klivisier, Augustin,
Klopstock, Friedrich Gottlieb,Klueting, H.,Knapton, M.,Knigge, Adolph von,
Knoppe- Gouron, F.,Kobler, G.,Kohen, Giambattista,Koller, Franz Xaver,
KoÈnigsberg, Dominik,Kotzebue, August von,Krekic, A.,
406
Kreutzer, Rodolphe,
La Harpe, Jean-FrancËois de,
Lanzer, A.,Lattermann, Cristoforo de,Laval, A.,Lebeau, C.,
Leduc, C.,Leeuw, R. de,Leibniz, Gottfried Wilhelm,
Lellis, Carlo Alessandro de,Leopardi, A.,Leopoldo I d'Asburgo,Lessing, Gotthold Ephraim,
Levi, Masino,Levi, MoiseÁ ,Lichstock de Lichtenein, Margheri-
ta,
Liebel-Weckowickz, H. P.,Liguoro, O.,Lilti, A.,
Livet, G.,Lobkowitz, Franz Joseph Maximi-
lian,Lobreich, K. H.,
Locke, John,Lomonaco, F.,Lorentz, Christiana,Lothieri, Francesco Antonio de,
Lothieri, Terenzia de,Lotta, F.,LoÈwenthal, J.,
Lubomirski, famiglia,Lucchese, Giuseppe,Luccichenti, F.,Lugnani, Giuseppe de,
Lugnani, S. de,Luigi XIV di Borbone,Luzzatto Voghera, G.,Luzzatto, G.,
Macartney, C. A.,
Macchia, G.,Macerati, E.,Machiavelli, NiccoloÁ ,Mader, M.,
Maffei, Andriana,Maffei, Carlo de,Maffei, Scipione,Magris, C.,
Maier, B.,Maier, H.,Majer,
Malesherbes, ChreÂtien-Guillaume,MalusaÁ , M.,Maly, M.,Mandelli, F.,
Manno, G.,Manzioli, Domenico,Manzioli, NicoloÁ ,Marangoni, M.,
Marcelli, U.,Marchesi, Luigi,Marchesini, Marcello,Marenigh, Giovanni,
Marenzi, Antonio,Marenzi, Francesco Antonio,Marenzi, Giuseppe,
Marenzi,.Gabriele,Mari, M.,Maria Carolina d'Asburgo,Maria Teresa d'Asburgo,
Marinelli, S.,Marini, R.,Markov, W.,Marmontel, Jean-FrancËois,
Marri, F.,Marson, G.,Martin, J. J.,
Martina, A.,Martini, Carlo Antonio de,Martini, Giovanni Battista,
407
Martino, G. de,
Martonyi, E.,Marusic, B.,Marussi, G.,Marx, J.,
Marzari, M.,Masiero, R.,Mattei, Marco,Matteucci, N.,
Maupeou, Nicolas Augustin de,Mayr, Giovanni Simone,Mazohl-Wallnig, B.,
Mazzariol, G.,Mazzini, Giuseppe,Mazzocca, F.,Meerman, Gerard,
Meerman, Johan,Meinecke, F.,Mendelssohn, Moses,Meriggi, M.,
MerkuÁ , P.,Messina, M.,Metastasio, Pietro,MetraÁ , Andrea,
Metternich, Klemens Lothar,Meursius, Johannes,Meyer, D.,
Meyer, M.,Mezzabarba Birago F.,Miccoli, G.,Micelli, F.,
Michaud, C.,Michtner, O.,Miculian, A.,Millo, A.,
Minerbi Belgrado, A.,Minghelli, Elisabetta,Miniussi, Lorenzo,
Mirabeau, Victor de,Mizzon, G.,Modesti, Pietro de,
Modesti, Valentino de,
Mohr, R.,Moioli, A.,Molho, A.,MolieÁre, Jean-Baptiste Poquelin,
Moll Christian Hieronimus,Mollerus, A. C.,Molmenti, P.,Monadi, Antonio de,
Montaigne, Michel de,Montan, Luigi,Montanelli, P.,
Monteleone, G.,Montesquieu, Charles-Louis de Se-
condat,More de Pontgibaud, madame,
Moreau, Victor,Morelli, Carlo,Morgan, C.,Mori, M.,
Morpurgo, Giuseppe Lazzaro,Morpurgo, M.,Morreale, M. T.,Morrona, A. da,
Mozart Wolfgang Amadeus,Mozzarelli, C.,MuÈ ller, W.,
Murato, M. T.,Muratori, Ludovico Antonio,Mustoxidi, Andrea,
Naldini, Paolo,
Navarra, E.,Naves, R.,Neal, L.,Necker, Jacques,
Negrelli, G.,Negri Gaspare,Netto, G.,Nevilla Massaro, M.,
Nichetti Spanio, M. L.,
408
Nicolantini, Agostino,
Nicoletti, Francesco,Nicolini, F.,Niederkorn, J. P.,Nissim, D.,
Nobile, Antonio,Nobile, Pietro,Nord, conti del,Nuovo, A.,
Oberdorfer, A.,Olivieri, A.,Olleson, D. E.,Omero,
Orlando, Francesco Saverio,Orsini-Rosenberg, Vincenzo,Osterloh, K. H.,Ottone di Merania,
Oudheusden, M. van,Ovidio,
Pacorig, M.,Padoan, G.,
Pagnini, C.,Pagnini, M. P.,Paladini, F. M.,Paladino, G.,
Paleocapa, Matteo,Panariti, L.,Pancera, Domenico,
Panizzoli, A.,Panjek, A.,Panjek, G.,Paolo Petrovich di Russia,
Papaleca, Anastasio,Parente Salomone,Parentin, L.,Parmegiani, S.,
Paschka, Joseph Anton,Pasquino, G.,Pastore Stocchi, M.,
Pastore, A.,
Patault, A.-M.,Patin, C.,Pauletich, A.,Pavanello, R.,
Pavani, E.,Pedemonti, Paolo,Pederin, I.,Pellegrini, Antonio,
Pellegrini, Cesare,Pellegrini, R.,Pene Vidari, G. S.,
Perensteiner, Filippo,Pergen, Johann Anton,Pergolesi, Giovanni Battista,Perigoni, Giuseppe de,
Perinello, Alvise,Perinello, Antonio,Perrotta, C.,Pesante, S.,
Petau, Denis,Petronio, M.,Petronio, Prospero,Pettenegg, E. G. von,
Peucker, M.,Pianton, Pietro,Piccardi Al drago de,
Piccardi, Francesco de,Pietrapelosa, Bartolomeo di,Pietrapelosa, Pietro di,Pietrapelosa, Wilhelmo di,
Pietro Leopoldo d'Asburgo,Pincus, S.,Pioli Caselli, F.,Piperno, F.,
Pisani, Omobon,Pittoni, Pietro Antonio,Pivec-Stele , M.,
Pizzamiglio, G.,Plaschka, R.,Plattner, Giorgio,
409
Plenario, Domenico,
Pocar, E.,Pogliacco, M.,Polari, Giulio Cesare,Polibio,
Pollini, Giuseppe Antonio,Polsini, Gian Paolo,Pomeau, R.,Ponziani, L.,
Pope, Alexander,Porcedda, D.,Porcia, Alfonso Antonio,
Poschl, Joseph,Postel Guillaume,Postigliola, A.,Pray, Giovanni,
Prims, Fl.,Priuli, Michiel,Prividali, Antonio,Proli, Charles,
Puebla, Antonio,Pufendorf, Samuel,Puliti, Gabriello,Puppo, M.,
Quarantotti, G.,Quarantotto, G.,Quesney, FrancËois,Quondam, A.,
Radole, G.,Radossi, G.,Raigersfeld, Johann Lukas von,Raimondi, E.,
Rainer, J.,Raines, D.,Rapicio, Andrea,Rapozzi, C.,
Raunicher, Matteo,RavaÁ , A.,Razumovsky, Andrea,
RegonoÁ Giuseppe,
Rescigno, E.,Resciniti, L.,Revoltella, Pasquale,Reyer, Francesco Taddeo,
Reyss, Giacomo,Ricci, Giovan Pietro,Ricci, Giovanni Antonio,Ricci, Lorenzo,
Ricci, Pasquale de,Ricci, Pietro,Rice, J. A.,
Richards, A.,Richards, Louis-Antoine-Robert
des,Richter, F. X.,
Ricuperati, G.,Rigo, Bartolomeo,Rigo, Domenico,Rigo, Giampietro,
Rigo, Giandomenico,Rigo, Maria Giovanna,Rinaldis, Giacomo de,Riondato, E.,
Rioux, J. P.,Risnich Stefano,Roche, D.,
Rocker,Romagnoli, A.,Romani, G.,Romano, R.,
Roncoroni, F.,Rondolini, Lorenzo,Rosenberg, Franz Xaver,Rosenkreutzer, Christian,
Rossetti de Scander, Antonio,Rossetti de Scander, P.Rossetti, Domenico,
Rossetti, Gioseffa,Rossetti, Giuseppe,Rossi Sabatini, G.,
410
Rota Ghibaudi, S. ,
Rota, Giacomo,Rotelli, E.,Roth, P. W.,RotondoÁ , A.,
Rottal, Josepha,Rousseau, Jean-Jacques,Rozzo, U.,Rugliano, A. R.,
Rumpler, H.,Rurale, F.,Russo, F.,
Sabini, Antonio,
Sablich, B.,Sagredo, NicoloÁ ,Saint-Pierre, Bernardin de,Saitta, A.,
Salieri, Antonio,Salimbeni, F.,Salimberti, S.,
San Martino, Giovanni Battista,Santonini, Francesco Antonio,Santorio, Santorio,Sarti, S.,
Sartorio, Giovanni Guglielmo,Sartorio, Pietro,Sarzana, P.,Saurau, Franz Joseph,
Savigny, Friedrich von,Scarabello, G.,Scati, Pier Francesco,
Schell, Karl Alexander von,Scherer, J.,Schiavuzzi, Giuseppe Maria,Schiera, P.,
Schiller, Friedrich,Schilling, H.,Schimmelpfenning, Carl Joseph,Schneiders, W.,
SchoÈnleben, Ludwig,
SchroÈder, Wilhelm von,
Schutte, A. J.,Schwarzenberg, Johann Nepomuk,Scio, Wenzel von,Scorfani, Saverio,
Scussa, Antonio,Scussa, Vincenzo,Secoli, G.,Sedlnitzky, Joseph,
Semi, F.,Sestan, E.,Seume, Johann Gottlieb,
Sgard, J.,Sharpe, L.,Sibille, Jean Baptiste,Silvestri O.,
Singeling, C.,Sirinelli, J. F.,Sirugo, A.,SÏkerlj, S.,
Slataper, Scipio,Smith, Adam,Sonnenfels, Joseph von,Sorgo, Michele di,
Sozzi, L.,Spadaio, S.,Spagnoletti, G.,
Spallanzani, Lazzaro,Spanu, G.,Spontini, Gasparo,Sponza, A.,
Srbik, H. von,Stadler Andrea,Stancovich, Pietro,Stanisci, M.,
Stavan, H. A.,Steeb, C.,Stefani, G.,
Steffaneo, Francesco Maria de,Steffani, Giuseppe Maria de,Stella, A.,
411
Stener, F.,
Stettner, Maria de,Sticotti, Giuseppe,Stipcevic, A.,Stoll, H. A.,
Stolleis, M.,Stourtzh, G.,StraboneStrassoldo, Aloisia,
Strassoldo, Marzio,Stratico, Giandomenico,Strimitzer, B.,
Stuparich, G.,Suard, Jean-Baptiste-Antoine,Suratteau, J.-R.,Surdich, F.,
Swedenborg, Emanuel,Swieten, Gerhard van,Swieten, Gottfried van,Szabo, F. A. J.,
Tabacco, G.,Tabisco Giovanni,Tamaro, A.,Tandura, A.,
Tanzi, A.,Tarsia, Andrea,Tarsia, Antonio,Tarsia, Cristoforo,
Tarsia, Damiano,Tarsia, Giacomo,Tarsia, Giovanni,
Tarsia, Tommaso,Tassin, F.,Tassinari, F.,Tassini, L.,
Tasso, Torquato,TatoÁ , G.,Tavano, L.,Tavano, S.,
Tenenti, A.,
Thayer, A. W.,
Tiraboschi, Girolamo,Tognana de Tonnefeld, Giannanto-
nio,Tomasich, Francesco,
Tommaseo, N.,Tommasini, Giacomo Filippo,Tommasini, Giacomo,Tommasini, Giuseppe,
Tonetti, M.,Torbianelli Moscarda, D.,Torre e Valsassina, Teresa della,
Torre, Raimondo della,Torres, Giovanni,Torres, Maria Giosefa,Tortarolo, E.,
Tourney, N.,Trapp, Enrico,Trattner, Johann Thomas von,Trebbi, G. F.,
Tremoli, P.,Treviso, Vincenzo,Triadan, M.C.,Tribe, K.,
Tucci, U.,Tuksar, S.,Turgot, Anne-Jacques-Robert,
Turrini, Antonio,
Ubaldini, T.,Ughelli, Ferdinando,Ugolini Bernasconi, P.,
Urbani, Ch.,Ustia, Tommaso,
Vaillant, Jean Foi,Valentinelli, G.,Valerj, Valerio de,
Valvasor, Johann Weichard,Van Cauwenberh, G.,Vascotto, A.,
412
Vecchi, A.,
Vedaldi Iasbez, V.,Venino,Venturi, F.,Venturini, D.,
Verger, J.,Vergerio, Girolamo,Vergerio, Pierpaolo jr,Vergottin, Bartolomeo,
Vergottini, G. de,Verpoorten, Ignazio,Verri, Pietro,
Viaggiano, A.,Viani, E.,Vicco, Antonio,Vico, Giambattista,
Vidon, A.,Vidulli Torlo, M.,Virgilio,Visintini, C.,
Vital, Samuele,Vivanti, C.,Voinovich, Demetrio,Volpato, S.,
Voltaggio, F.,Voltaire, FrancËois-Marie Arouet,Voltiggi, Giuseppe,
Vordoni, Leonardo,Vovelle, M.,Voxilla de WuÈ stenau, Franz Xaver,
Wagensperg, Adolfo di,
Wagner, H.,Wagner, J.,Wagner, Lorenzo Giuseppe,Wakounig, G.,
Wandruszka, A.,Wassermann, Antonio de,Watzlawick, H.,Weber, Giovanni Lodovico,
Weber, Johann von,
Weber, Konstanze,
Wehler, H. U.,Welz, Thomas von,Wernigg, F.,Whaley, J.,
Widmann, Meinrad,Wiedemann, C.,Wieland, Christoph Martin,WiesenhuÈ tten, Franz von,
Wieser, Joseph Leopold,Wiesflecker-Friedhuber, I.,Winckelmann, Johann Joachim,
Winckowitz Franz,Wit, C. H. de,Witzenetz, J.,Wolff, Christian,
Wolff, L.,WuÈ rtemberg, Sophia Dorothea
von,Wurzbach, C. von,
Zagonel, G.,Zaguri, Pietro,Zalin, G.,Zanchi, Francesco de,
Zanchi, Francesco Vito de,Zarotti, Cesare,Zavoreo, Francesco,Zeno, Apostolo,
Ziliotto, B.,Zingarelli, I.,Zinzendorf, Karl von,
Zinzendorf, Nikolaus von,itko, S.,Zocconi, C.,Zois, Carlo,
Zois, Michele Angelo,Zois, Sigmund,ontar J.,Zoppelli, L.,
Zoric, M.,
INDICE GENERALE
Premessa 5
Premessa alla prima edizione 8
Nota alla nuova edizione 12
Abbreviazioni 15
I. I lumi in Arcadia. Per una storia della cultura nel Litorale enell'Istria tra Seicento e Settecento 17
II. I privilegi antichi e le libertaÁ moderne. La cultura triestinatra Settecento e Ottocento 55
III. La preparazione della «Hauptresolution »: mercantilismo ecameratismo in un memoriale sul porto franco 89
IV. La formazione del funzionario in etaÁ teresiana 112
V. Karl von Zinzendorf tra Maria Teresa e Giuseppe II 135
VI. Le suggestioni naturalistiche in Stefano Carli e il dibattitosulle origini di Cittanova d'Istria 166
VII. Gianrinaldo Carli contro Lodovico Antonio Muratori: ilMedioevo goriziano, triestino e istriano nell'opera di An-drea Giuseppe de Bonomo 186
VIII. Minerva e Mercurio nel tempio di Cibele: accademie e gaz-zette, intellettuali ed eruditi tra le sponde dell'Adriatico 206
415
IX. La pace universale come stato della natura. Domenico A.Azuni e Trieste 253
X. L'ereditaÁ del Settecento nella borghesia cosmopolita: F. E.J. Baraux, il commercio e la massoneria 273
XI. Censura e politica dopo la Restaurazione 314
XII. Czoernig, le riforme e la storia dell'amministrazione fiscalea Trieste 346
Appendice 366
Indice delle fonti e dei documenti d'archivio 393
Indice dei nomi 399
416
CIVILTAÁ DEL RISORGIMENTO
collana di saggi, testi e studi a curadi Giulio Cervani e di Fulvio Salimbeni
1) G. Stefani - Il problema dell'Adriatico nelle guerre del Risorgimento.(ESAURITO)
2) C. Schiffrer - La Venezia Giulia nell'etaÁ del Risorgimento - Momenti eproblemi. (ESAURITO)
3) Autori Vari (a cura di G. Cervani) - Il movimento nazionale a Trieste nellaprima guerra mondiale.
4) G. Cervani - La borghesia triestina nell'etaÁ del Risorgimento - Figure e pro-blemi.
5) G. Cervani, L. Buda - La comunitaÁ israelitica di Trieste nel sec. XVIII.6) R. Monteleone - La politica dei fuorusciti irredenti nella Guerra Mondia-
le.7) G. Cervani - NazionalitaÁ e stato di diritto per Trieste nel pensiero di Pietro
Kandler. Gli inediti del procuratore civico.8) L. Milazzi - Politica scolastica ed irredentismo. I ricreatori comunali a Trie-
ste.9) C. Schiffrer - Le origini dell'Irredentismo triestino, 2ã edizione con prefazio-
ne di Elio Apih.10) S.F. Romano - La monarchia degli Absburgo d'Austria dalla riforma prote-
stante all'austromarxismo.11) L. Tosi - La propaganda italiana all'estero nella prima guerra mondiale. Ri-
vendicazioni territoriali e politica delle nazionalitaÁ.12) U. Del Bianco - Il Lloyd Austriaco e la marina postale dell'Austria e dell'Un-
gheria. Le linee dell'Adriatico.13) U. Del Bianco - Il Lloyd Austriaco e la marina postale dell'Austria e dell'Un-
gheria - La rete austriaca nel Levante ed il ruolo della societaÁ triestina.14) G. Tabacco - Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia.15) R.E. Coons - I primi anni del Lloyd Austriaco - Politica di governo a Vienna
ed iniziative imprenditoriali a Trieste (1836-1848).16) G. Negrelli - Al di qua del mito. Diritto storico e difesa nazionale nell'auto-
nomismo della Trieste asburgica.17) R. Pupo - La rifondazione della politica estera italiana: la questione giuliana
(1944-46). Linee interpretative.18) F. Cusin - Appunti alla storia di Trieste, 2ã edizione, con saggio introduttivo
di Giulio Cervani.19) E. Maserati - Momenti della questione adriatica (1896-1914) - Albania e
Montenegro fra Austria ed Italia.
417
20) M. Dogo - La dinamite e la mezzaluna. La questione macedone nella pub-blicistica italiana 1903-1908.
21) U. Del Bianco - Il Lloyd Austriaco e la marina postale dell'Austria e dell'Un-gheria. I traffici lloydiani nei porti adriatici non austriaci.
22) La Favilla 1836-1846 - Pagine scelte tratte dalla rivista, a cura di GiorgioNegrelli.
23) A. Ara - Fra Austria e Italia - Dalle Cinque Giornate alla questione alto-atesina. (ESAURITO)
24) A. Filipuzzi - Trieste e gli Asburgo - Meditazioni fuori tempo di un mitteleu-ropeo italiano. (ESAURITO)
25) F. Cossutta - Ideologia e scelte culturali di Domenico Rossetti - Il suo petrar-chismo
26) O. Altieri - La comunitaÁebraica di Gorizia: caratteristiche demografiche, eco-nomiche, e sociali (1778-1900).
27) M. Dassovich - La diaspora fiumana nella testimonianza di Enrico Burich.28) M. Morpurgo - F. Salimbeni - La comunitaÁ ebraica di Gorizia. Vicende e
memorie. (ESAURITO)29) P. Santarcangeli - In cattivitaÁ babilonese - Avventure e disavventure in tem-
po di guerra di un giovane giuliano ebreo e fiumano per giunta, con una pre-fazione di Leo Valiani.
30) P. Santarcangeli - Il porto dell'aquila decapitata, 2ã edizione.31) M. Dassovich - I molti problemi dell'Italia al confine orientale. Vol. I: Dal-
l'armistizio di Cormons alla decadenza del patto Mussolini-PasÏic (1866-1929). 2ã Edizione.
32) R. Pupo - Tra Italia e Iugoslavia. Saggi sulla questione di Trieste (1945-1954), con prefazione di Diego de Castro.
33) S. Cella - La liberazione negata - L'azione del Comitato di liberazione nazio-nale dell'Istria.
34) E. Apih - Il socialismo italiano in Austria (1888-1918) - Saggi.35) M. Dassovich - I molti problemi dell'Italia al confine orientale. Vol. II: Dal
mancato rinnovo del patto Mussolini-PasÏic alla ratifica degli accordi di Osi-mo (1929-1977).
36) V. Frosini - La famiglia Stuparich - Saggi critici. (ESAURITO)37) S.M. Katunarich - Frammenti di un vita fiumana.38) M. Cattaruzza - Trieste nell'Ottocento - Le trasformazioni di una societaÁbor-
ghese.39) C. Schiffrer - Antifascista a Trieste. Scritti editi ed inediti (1944-1955), a cu-
ra di Elio Apih.40) S.A. Tokarev - Trieste 1946-1947 nel diario di un componente sovietico del-
la commissione per i confini italo-jugoslavi, a cura di Giulio Cervani e DianaDe Rosa.
41) AA.VV. - Dal Litorale Austriaco alla Venezia Giulia - Miscellanea di studi giu-liani.
418
42) M. Cecovini - Dare e Avere per Trieste - Scritti e discorsi politici (1946-1979), con saggio introduttivo di Diego de Castro.
43) D. De Rosa - Libro di scorno, Libro d'onore - La scuola elementare triesti-na durante l'amministrazione austriaca (1761-1918), con una premessa diLuigi Milazzi.
44) G. Cervani - Gli scritti politici di Fabio Cusin, nel « Corriere di Trieste ». Glianni della polemica dura (1946-1948).
45) U. Cova - Commercio e navigazione a Trieste e nella monarchia asburgica daMaria Teresa al 1915.
46) M. Cecovini - Dare e Avere per Trieste - Scritti e discorsi politici (1980-1983), con prefazione di Diego de Castro.
47) C. Schiffrer - Dopo il ritorno dell'Italia. Trieste 1954-1969 - Scritti ed inter-venti polemici presentati da Giorgio Negrelli.
48) G. Cervani - Momenti di storia e problemi di storiografia giuliana.49) P. Dorsi - Il Litorale nel processo di modernizzazione della monarchia au-
striaca. Istituzioni e archivi, con prefazione di Giulio Cervani.50) G. Cervani - Gli scritti politici di Fabio Cusin, nel « Corriere di Trieste ». Gli
anni della larvata opposizione (1949-1951) integrati con la ristampa de « Laliberazione di Trieste » dello stesso Autore.
51) M. Cecovini - Dare e Avere per Trieste. Scritti e discorsi politici (1984-1994),con prefazione di Diego de Castro.
52) AA.VV. - Trieste, Austria, Italia tra Settecento e Novecento - Studi in onoredi Elio Apih, a cura di Marina Cattaruzza. (ESAURITO)
53) P. Ziller - Adriatici e Trentini dall'Impero Asburgico al regno d'Italia - So-cietaÁ, istituzioni e rapporti etnici.
54) M. Dassovich - Dopoguerra a Trieste - L'esperienza e la testimonianza di un« optante » fiumano (1949-1996).
55) E. Sestan - Venezia Giulia - Lineamenti di una storia etnica e culturale e ilcontesto storico-politico in cui si colloca l'opera, a cura e postfazione di Giu-lio Cervani.
56) M. Dassovich - La Fiumara e le sue due sponde - Aspetti della questioneadriatica: la pubblicazione a Roma della rivista « Fiume » negli anni 1952/1976.
57) D. De Rosa - Maestri, scolari e bandiere - La scuola elementare in Istria dal1814 al 1918.
58) M. Rossi - Irredenti giuliani al fronte russo - Storie di ordinaria diserzione, dilunghe prigionie e di sospirati rimpianti (1914/1920).
59) Maestri di storiografia a Trieste. Nino Valeri - Pagine recuperate, a cura econ un saggio di Giulio Cervani.
60) M. Dassovich - Fronte jugoslavo 1941-'42 - Aspetti e momenti della presen-za militare italiana sull'opposta sponda adriatica durante la seconda guerramondiale.
61) R. Pupo - Guerra e dopoguerra al confine orientale d'Italia (1938-1956).
419
62) D. De Rosa - Gocce di inchiostro - Gli asili, scuole, ricreatori, doposcuoladella Lega Nazionale. Sezione adriatica.
63) M. Dassovich - Fronte jugoslavo 1943 - La fase finale delle operazioni del-l'esercito italiano sull'opposta sponda adriatica durante la seconda guerramondiale.
64) L. Riccardi, Francesco Salata tra storia, politica e diplomazia.65) M. Dassovich, Guerriglia e guerra sui due versanti del Nevoso (1943-1945) -
Aspetti storico-politici nella contrapposizione delle molte forze in campo (acura di).
66) P. Marz, Le milizie del Comune di Trieste dal 1300 al 1550.67) M. Dassovich, L'Impero e il Golfo - I territori degli Asburgo sull'Adriatico
negli anni 1717-1814.68) F. Todero, Le metamorfosi della memoria - La Grande Guerra tra modernitaÁ
e tradizione.69) A. Brambilla, Parole come bandiere - Prime ricerche sulla letteratura e Irre-
dentismo.70) M. Dassovich, L'Impero e il Golfo - Una ricerca bibliografica sulla politica
degli Asburgo verso le province meridionali dell'impero negli anni 1815-1866.
71) D. De Rosa - Spose, madri e maestre. Il liceo femminile e l'Istituto magistraleG. Carducci di Trieste 1872-1954.
72) G. Paladin - La lotta clandestina di Trieste nelle drammatiche vicende delC.L.N. della Venezia Giulia.
73) M. Dassovich - 1945-1947. Anni difficili e spesso drammatici per la defini-zione di un nuovo confine orientale italiano. Il procedimento giudiziario im-propriamente noto come il processo delle foibe-PisÏkulicÂ.
74) I. Fried. - Fiume, cittaÁ della memoria.75) U. Cova - Trieste e il suo provinciale in epoca austriaca. Rapporti economico-
istituzionali con Carinzia, Stiria, Carniola, Gorizia, Istria e Veneto.76) A. Fonda Savio - La Resistenza italiana a Trieste e nella Venezia Giulia.77) M. Dassovich - L'Impero e il Golfo. Da Lissa a Sarajevo. (1867-1914) Una
ricerca bibliografica sulla politica degli Asburgo nelle province meridionalidell'impero.
78) T. Pizzetti, Cinquecento anni di storia di una antica famiglia lussignana.79) M. Benardelli - La questione di Trieste. Storia di un conflitto diplomatico
(1945-1975).80) Trieste 1945-1954 - Moti giovanili per Trieste italiana all'epoca del G.M.A.
a cura di G. Tombesi.81) E. Maserati - La Venezia Giulia nell'etaÁ contemporanea. Uomini e fatti.82) M. Dassovich - 1947-1954 - Verso un confine orientale italiano.83) B. Gatta - Italia irredenta.84) D. De Rosa - Piazza Lipsia n. 1025 - Gli studi nautici nell'Accademia reale e
di nautica.
420
85) A. Trampus - Tradizione storica e rinnovamento politico. La cultura nel Li-torale Austriaco e nell'Istria tra Settecento e Ottocento.
86) R. Spazzali - Volontari della libertaÁ - Dalla resistenza politica all'insurrezionearmata. Documenti e testimonianze.
IN PREPARAZIONE
G. Cervani - Gli scritti politici di Fabio Cusin nel « Corriere di Trieste » - 3. Glianni del ritorno dell'Italia (1952-1956).
D. Redivo - Scritti di carattere risorgimentale irredentistico.
421
Finito di stamparenel mese di maggio 2008
nella Tipolitografia « La grafica »Vago di Lavagno (Verona)