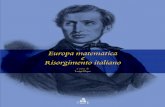Tradizione e rinnovamento nella didattica giuridica: prime riflessioni per un’indagine...
-
Upload
unibocconi -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Tradizione e rinnovamento nella didattica giuridica: prime riflessioni per un’indagine...
RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
2014ANNO LXXXVII VOL. LXXXVII
AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO
FONDAZIONE
SERGIO
MOCHI ONORY
PER LA STORIA
DEL DIRITTO
ITALIANO - ROMA
ANNAMARIA MONTI
TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA: PRIME RIFLESSIONI
PER UN’INDAGINE SULL’ITALIA LIBERALE
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dimensione europea. – 3. Prime evidenze di rinnovamento nelle facoltà italiane: i corsi ‘liberi’. – 4. Conclusioni.
1. Premessa
Il dibattito sull’insegnamento del diritto è di persistente attualità, in
molti paesi. In Italia, in una più generale situazione di trasformazione
dell’istituzione universitaria, da vario tempo ci s’interroga sulle possibili
riforme1; in Francia si sperimentano vie nuove, peraltro già vivacemente
discusse2. Nel mondo anglo sassone, Oltremanica e soprattutto Oltre-
oceano, il confronto da decenni si sviluppa attraverso pubblicazioni
periodiche e coinvolge giuristi pratici e teorici3.
Il tema della didattica giuridica e, prima ancora, quello degli scopi
che la formazione giuridica si pone – quale tipo di giurista s’intenda
1 A. PADOA SCHIOPPA, Ri-formare il giurista. Un percorso incompiuto, Torino 2014, in part. cfr. l’Introduzione, Un percorso incompiuto, pp. 1-27. Quanto agli studi di Orlando Roselli, in parte confluiti in O. ROSELLI, Scritti per una scienza della formazione giuridica, Napoli 2012 e sui volumi pubblicati nella «Collana per l’Osservatorio sulla formazione giuridica», diretta dallo stesso Roselli e da Vincenzo Cerulli Irelli per i tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane, P. COSTA, La formazione del giurista: a proposito di una recente collana di studi, in «Sociologia del diritto», 2013/1, pp. 215-222. V. inoltre già L’educazione giuridica, 1, Modelli di Università e progetti di riforma, Perugia 1975, II ed. a cura di N. PICARDI e R. MARTINO, Bari 2008, nonché F. TREGGIARI, L’educazione al diritto, in Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, a cura di F. CERRONE e G. REPETTO, Milano 2012, pp. 827 ss.
2 Rinvio al recente C. JAMIN, M. XIFARAS, De la vocation des facultés de droit (françaises) de notre temps pour la science et l’enseignement, in «Revue interdisciplinaire d’études juridiques», 2014/72, pp. 107-140, per una sintesi del dibattito suscitato dalla pubblicazione di C. JAMIN, La cuisine du droit. L’Ecole de Droit de Sciences Po: une expérimentation française, Paris 2012.
3 A titolo meramente esemplificativo di una lunga tradizione di studi in questo senso, v. la rivista elettronica «Innovation in Legal Education eJournal», distribuita nell’ambito della rete SSRN, Social Science Research Network.
288 ANNAMARIA MONTI
4 O. ROSELLI, Formation, culture juridique, rôle du juriste et des opérateurs du droit à l’époque contemporaine de transition, in «Revue interdisciplinaire d’études juridiques», 2014/72, pp. 82-98; v. anche Per una riflessione sulla didattica del diritto, a cura di V. Cerulli Irelli e O. Roselli, Milano 2000.
5 Rinvio a M.G. DI RENZO VILLATA, La formazione del giurista in Italia e l’influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia, in Formare il giurista. Esperienze nell’a-rea lombarda tra Sette e Ottocento, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano 2004, pp. 1 ss.
6 Per una sintesi dello status quo, M.R. DI SIMONE, I curricula giuridici prima di Napoleone, in Le università napoleoniche. Uno spartiacque nella storia italiana ed europea dell’istruzione superiore, Atti del Convegno internazionale di studi Padova – Bologna, 13-15 settembre 2006, a cura di P. DEL NEGRO, L. PEPE, Bologna 2008, pp. 145-167.
7 R. FERRANTE, Fare lezione secondo l’ordine del codice: scienza, didattica ed editoria nelle facoltà giuridiche napoleoniche dopo la legge del 22 ventoso XII (1804), in Dalla pecia all’e-book. Libri per l’Università: stampa, editoria, circolazione e lettura, a cura di G.P. BRIZZI, M.G. TAVONI, Bologna 2009, pp. 369-375, nonché già ID., Ambrogio Laberio (1743-1812) e i suoi Razionali sopra il Codice Napoleone (1808), in Giuristi Liguri dell’Ottocento, Genova 2001, pp. 161-186; ID., Dans l’ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’illuminismo giuridico, Milano 2002 e soprattutto ID., Università e cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero, Genova 2002; P. ALVAZZI DEL FRATE, Tra diritto comune e codice: la facoltà di giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico, in «Annali di Storia delle Università italiane», 2000/4, pp. 63-76. Cfr. inoltre DI RENZO VILLATA, La formazione del giurista in Italia cit., pp. 65 ss. Più in generale, A. FERRARESI, Le università dall’età francese all’Unità, in Storia delle Università in Italia, a cura di G.P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO, Messina 2007, vol. I, pp. 193-253.
8 A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocen-to, in Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, a cura di A. MAZZACANE, C. VANO, Napoli 1994, in part. pp. 89-90.
9 Sul metodo delle esercitazioni pratiche, introdotto da Jhering alla metà del secolo, M. CAPPELLETTI, Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania. La crisi delle professioni giudiziarie in Italia. Problemi e rimedi, Milano 1957, pp. 110-111; G. DE NOVA, Appunti sul metodo casistico nell’insegnamento del diritto privato, in «Rivista trimestrale di
preparare, in primis nelle Università, e per quale ruolo4 – è ben pre-sente nella storia dell’Europa da secoli5. In particolare, per ciò che qui specificamente interessa, nel corso dell’Otto e del Novecento si è acuito a più riprese.
La questione, è noto, si affacciò al tramonto dell’ancien régime e nei primissimi anni del secolo XIX6, per l’avvento della codificazione nei paesi che l’adottarono, per cui si impose un rimodellamento della didattica (in Francia sorgono le Ecoles de Droit di Napoleone, ‘importate’ poi in Italia7). Nello stesso periodo, una discussione è aperta anche in Prussia e negli altri paesi tedeschi che rifiutarono i codici, per l’affer-marsi di una salda dottrina giuridica di matrice universitaria: nelle aule d’insegnamento si perfezionarono tecniche per uno studio ‘scientifico’ del diritto8 e le si accompagnarono, poi, con esercitazioni su casi pratici9.
289TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
diritto e procedura civile», 1978/32, in part. pp. 379-381; diffusamente, F. TREGGIARI, Itinerari della casistica. La crestomazia di Emanuele Gianturco fra modelli illustri e nuove istanze, in E. GIANTURCO, Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, rist. an. dell’ed. Napoli 1884, Bologna 1989, pp. XI ss.
10 Cfr. M. GHIRON, Studi sull’ordinamento della facoltà giuridica, Roma 1913.11 P. COSTA, La formazione del giurista cit., pp. 218-219. V. comunque già gli interventi
di V. SCIALOJA, Sugli studi giuridici e sulla preparazione alle professioni giudiziarie [1913] e Ordinamento degli studi di giurisprudenza in relazione alle professioni [1914], ora in ID., Studi giuridici, 7, Scritti e discorsi politici, 2, Padova 1936; al tempo della riforma Gentile, P. CALAMANDREI, L’università di domani [1923], ora in P. CALAMANDREI, Opere giuridiche, a cura di M. CAPPELLETTI, vol. II, Napoli 1966, pp. 222-285; per il secondo dopoguerra e gli anni ’50, M. CAPPELLETTI, Studio del diritto e tirocinio professionale cit., pp. 79 ss.
12 F. AUDREN, Les professeurs de droit, la République et le nouvel esprit juridique. Introduc-tion, in La Belle Epoque des juristes. Enseigner le droit dans la République, «Mil neuf cent», 2011/29, pp. 7-33; F. AUDREN, J.-L. HALPÉRIN, La culture juridique française. Entre mythes et réalités, Paris 2013. V. inoltre Paris, capitale juridique (1804-1950). Etude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, sous la direction de J.-L. HALPÉRIN, Paris 2011, nonché i volumi della serie Les facultés de droit de province au XIXe et XXe siècles, pubblicati dal Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques: Les facultés de droit de province au XIXe
Allo scadere del secolo ‘lungo’ e nel primo decennio del Novecento, il dibattito sulla didattica del diritto riprese vigore e visse momenti di particolare intensità proprio quando la scienza giuridica europea entrò in una fase di rinnovamento del metodo e di sperimentazione di nuo-ve vie d’interpretazione, stimolata dall’emergere delle scienze sociali, sospinta dalle pressanti sollecitazioni di un’economia e di una società in rapida trasformazione10.
Ed è proprio in quel torno d’anni – aperti al cosmopolitismo e segnati però anche dai nazionalismi, destinati a sfociare nella Grande Guerra – che si sollevarono confronti e si prospettarono riforme da un lato capaci di influenzare ancora a lungo le scelte successive; dall’altro, foriere di sviluppi che tuttora attendono un compimento. Come a dire che quei decenni tra gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento e il 1914 paiono rappresentare un periodo specialmente dinamico quanto a stru-menti didattici e nuove materie d’insegnamento e, dunque, sembrano meritevoli di attenzione, soprattutto in tempi odierni di ‘crisi’ della didattica giuridica cosiddetta ‘tradizionale’, che si vorrebbe superare11.
Tuttavia, se a livello europeo sono state avviate e, in alcuni casi, compiute ricerche di ampio respiro dedicate al tema dell’insegnamento del diritto ‘in evoluzione’ al principio del secolo XX – la più recente storiografia francese offre ormai un quadro convincente delle facoltà giuridiche e dei docenti della Terza Repubblica12 – per l’Italia liberale
290 ANNAMARIA MONTI
siècle: bilan et perspectives de la recherche, sous la direction de PH. NÉLIDOFF, tome I, Toulouse 2009 e tome II, Toulouse 2011; Les conquêtes universitaires, sous la direction de J.-C. GAVEN et F. AUDREN, Toulouse 2012. Ancora, si segnala il database dei professori di diritto francesi (1804-1950), curato da C. FILLON http://siprojuris.symogih.org/ (ultimo accesso, marzo 2015).
13 Spunti per una più vasta ricerca si leggono, invero, nelle interessanti pagine di F. TREGGIARI, Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l’opera e la fortuna di Emanuele Gianturco, in L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco, a cura di A. MAZZACANE, Napoli 1987, pp. 80 ss. e soprattutto pp. 98 ss. Non mancano, inoltre, studi singoli rivolti a specifiche esperienze didattiche, che inducono a riflettere sulla complessità del quadro generale: tra essi, V. PIERGIOVANNI, Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di Diritto Costituzionale, in Giuristi Liguri cit., pp. 125-140.
14 Per altri momenti del Novecento indagini su ampia scala paiono già avviate. Sull’epoca fascista, v. ora i contributi riuniti in Giuristi al bivio. Le facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana. Istituzioni, docenti, didattica (1940-1950), Atti del convegno di Bologna 19-20 settembre 2013, a cura di M. CAVINA, in corso di stampa. Per le vicende del diritto amministrativo e costituzionale, v. il numero monografico Il diritto pubblico nella seconda metà del secolo XX della «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2001/4, in part. il saggio di M. D’ALBERTI, Gli studi di diritto amministrativo: continuità e cesure fra primo e secondo Novecento, pp. 1293 ss.; A. SANDULLI, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano 2009.
15 A. MAZZACANE, Secolo delle università – secolo delle professioni: le ragioni di un incon-tro, in Università e professioni giuridiche in Europa cit., in part. pp. 5-9. Nello stesso volume collettaneo v. i contributi di F.A. GENOVESE, La riforma delle facoltà di giurisprudenza e l’introduzione dell’Ordinamento giudiziario nelle università italiane (1859-1865), pp. 117-149; S. TORRE, L’«introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche»: parabola di un insegnamento, pp. 153-192. Cfr. inoltre i saggi confluiti in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, a cura di A. MAZZACANE, Napoli 1986 e spec. A. Mazzacane, Introduzione, pp. 15-23; I. PORCIANI, Attilio Brunialti e la «Biblioteca di Scienze Politiche». Per una ricerca su intellettuali e Stato dal trasformismo all’età giolittiana, ivi, pp. 191-229. V. poi soprattutto L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco cit., con i saggi di TREGGIARI, Scienza e insegna-mento del diritto, cit., pp. 45 ss.; G. CIANFEROTTI, Emanuele Gianturco giurista pratico, pp. 153 ss. e P. BENEDUCE, Il “giusto” metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della “scienza italiana”, pp. 365 ss.
16 P. GROSSI, «La scienza del diritto privato». Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo. 1893-1896, Milano 1988; ID., Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, Milano 2002,
manca ancora una larga ricognizione dello stato della didattica giuridica impartita nelle Facoltà del Regno13, che possa anche meglio far luce sugli orientamenti ‘scientifici’ e sul clima ‘culturale’ dell’epoca14.
In realtà, in alcune opere collettive di taglio innovativo sull’università, la scienza giuridica e le professioni, già da qualche decennio si è riservata un’attenzione specifica proprio all’insegnamento del diritto15: questi con-tributi rappresentano senza dubbio un imprescindibile punto di partenza.
Inoltre, da tempo si è autorevolmente posta in rilievo l’importanza delle prolusioni accademiche quali occasioni per discutere questioni di metodo e nuovi campi d’indagine16: così, l’attenzione degli studiosi
291TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
passim, nonché ora ID., Le ‘prolusioni’dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana, vol. I, Napoli 2012, pp. XVII-XLI. V. anche G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i nuovi giuristi universitari e lo Stato liberale, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1989/4, pp. 995-1023.
17 Cfr. la raccolta in tre tomi a cura di A. CIATTI, Le prolusioni dei civilisti, I-III, Napoli, 2012.18 G. CAZZETTA, Prolusioni, prelazioni, discorsi. L’identità nazionale nella retorica dei
giuristi, in Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, a cura di G. CAZZETTA, Bologna 2013, pp. 11-29; M. CARAVALE, Introduzione, in La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali, a cura di M. CARAVALE e F.L. SIGISMONDI, Napoli, 2014, in part. p. XV. Di recente, v. anche F. MERCOGLIANO, Italia «legibus fundata». Rileg-gendo la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed equità, in «Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino», 2012/1, pp. 171-178.
19 V. comunque M. CARAVALE, «Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzionale» I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l’Unità, in Retoriche dei giuristi cit., pp. 203-230; G. FERRI, Studi di diritto processuale civile nella Facoltà giuridica romana tra Ottocento e Novecento, in «Historia et ius», www.historiaetius.eu, 2013/4, paper 9.
20 Di recente, I. PORCIANI, M. MORETTI, La creazione del sistema universitario nella nuova Italia, in Storia delle Università in Italia cit., vol. I, pp. 323-379; M. MORETTI, I. PORCIANI, Da un frammento a un testo. Estate 1859, la discussione preparatoria della legge Casati, in Le Università e l’Unità d’Italia (1848-1870), a cura di A. FERRARESI, E. SIGNORI, Bologna 2012, pp. 15-34. V. anche I. PORCIANI, M. MORETTI, Il sistema universitario tra nazione e città: un campo di tensione, in Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di M. MERIGGI e P. SCHIERA, Bologna 1993, pp. 289-306.
21 F. COLAO, La libertà di insegnamento e l’autonomia nell’Università liberale. Norme e progetti per l’istruzione superiore in Italia, Milano 1995; EAD., Tra accentramento e autonomia: l’ammini-strazione universitaria dall’Unità a oggi, in Storia delle Università in Italia cit., vol. I, pp. 287-321.
22 La Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università degli Studi di Messina (1908-1946), a cura di G. PACE GRAVINA, Messina 2009; A. MATTONE, Gli studi giuridici e l’insegnamento del diritto (XVII-XX secolo), in Storia dell’Università di Sassari, a cura di A. MATTONE, Nuoro
continua con profitto ad appuntarsi su queste lezioni inaugurali, ora riproposte anche in fruibili collezioni17, commentate e inserite nel più vasto dibattito del tempo cui si riferiscono, per una migliore compren-sione degli sviluppi del pensiero giuridico18. Tuttavia, il profilo della loro valenza circa l’attività di docenza quotidiana resta da approfondire19.
Fioriscono, inoltre, gli studi sull’università, sulla sua organizzazio-ne, struttura e finalità nel periodo successivo all’Unità, così come sulle facoltà e gli ordinamenti didattici: le ricerche di Ilaria Porciani e Mauro Moretti in questo senso20, insieme alle indagini condotte da Floriana Colao sul dibattito intorno all’autonomia delle università nell’età libera-le21, rappresentano una base fondamentale per un discorso che affronti la questione dell’insegnamento del diritto.
Preziosi strumenti di riferimento risultano, al contempo, gli studi dedicati alla storia delle facoltà giuridiche nel secondo Ottocento e nel primo Novecento: si tratta di iniziative editoriali singole22, oppure con-
292 ANNAMARIA MONTI
2010, vol. I, in part. pp. 209 ss.23 Oltre ai contributi che saranno citati in seguito, v. comunque L. MUSSELLI, La Facoltà
di Giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell’Italia unita (1860-1960), in «Annali di Storia delle Università italiane», 2003/7; E. SPAGNESI, L’insegnamento del diritto ‘al modo pisano’ (1861-1945), in «Annali di Storia delle Università italiane», 2010/14.
24 Cfr. G. CIANFEROTTI, Germanesimo e università in Italia alla fine dell’800. Il caso di Camerino, in «Studi senesi», 1988, pp. 327-347.
25 Per il ruolo delle esercitazioni pratiche, DE NOVA, Appunti sul metodo casistico cit., pp. 378-379, nonché ampiamente F.TREGGIARI, Scienza e insegnamento del diritto cit., pp. 88 ss.; ID., Itinerari della casistica cit., pp. VI ss., XVI ss., XXV-XXIX.
26 Un tentativo in questa direzione: M. NARDOZZA, Manualistica e cultura del codice civile in Italia tra Otto e Novecento, Roma 2012. V. comunque già BENEDUCE, Il “giusto” metodo di Emanuele Gianturco cit., pp. 304 ss.; F. TREGGIARI, Scienza e insegnamento del diritto cit., pp. 84 ss.; ID., Itinerari della casistica cit., pp. XX-XXIV. Più in generale, sul tema della manualistica giuridica otto e novecentesca, con specifico riferimento all’esperienza francese, Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, sous la direction de A.-S. CHAMBOST, Paris 2014: in part. cf. F. AUDREN, Con-clusion. Les juristes en travailleurs manuels, ibidem, pp. 337-345; per l’Italia, v. il contributo di F. AIMERITO, Procédure civile et manuels dans le Royaume Piémont-Sardaigne (XVIIIe siècle-1845), ibidem, pp. 287-299.
27 G. CIANFEROTTI, L’università di Siena e la ‘vertenza Scialoja’. Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell’Ottocento, in «Studi Senesi», Supplemento alla centesima annata, vol. II, 1988, pp. 725-750: con il suo insegna-mento, contestato dagli studenti perché troppo impegnativo, Scialoja intendeva mettere in atto un preciso progetto didattico, la formazione di un giurista dotto che fornisse alla
dotte per impulso del Centro interuniversitario di studi sulle università italiane di Bologna, che, oltre alla serie degli Annali, promuove molte ricerche ‘a tema’ sulla realtà universitaria in prospettiva storica. Alcuni di questi lavori si sono focalizzati sul periodo a cavaliere tra XIX e XX secolo, che qui specialmente interessa, ma il profilo della didattica – e nello specifico di quella giuridica – per quell’epoca è spesso rimasto in ombra23.
In sintesi, tra Otto e Novecento in Italia, come altrove in Europa, si ridiscute il metodo di studio del diritto e suggestioni diverse inducono i giuristi a sperimentare e esplorare nuovi (o rinnovati) settori del diritto: ciò si riflette nei corsi e nelle lezioni universitarie24, nei metodi e nei materiali didattici25, nei manuali26 ed è emerso, per esempio, in relazione alla vicenda – non felice, in realtà – di Vittorio Scialoja all’Università di Siena27. Tuttavia, molti sono ancora gli elementi che paiono meritare un approfondimento e tante le esperienze di insegnamento ancora da indagare.
Dalle ricerche che ho finora condotto su alcuni autori del periodo, ho potuto apprezzare proprio i profili di novità della loro attività didattica, sovente occasione di riflessioni originali e perciò vorrei qui proporre
293TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
giurisprudenza gli schemi interpretativi del diritto codificato.28 Cfr. P. SCHIERA, Modelli di università nell’Ottocento europeo: problemi di scienza e di
potere, in L’università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano, a cura di I. PORCIANI, Napoli 1994, pp. 5-34; P. SCHIERA, Università e società come nodo strutturale della storia moderna, in Università e professioni giuridiche in Europa cit., pp. 40 ss.
29 P. SCHIERA, Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell’Ottocento, Bologna 1987, passim. V. anche A. MISSIROLI, Università, società e Stato. L’origine delle «social sciences», in Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di G. CORNI e P. SCHIERA, Bologna 1986, spec. pp. 41 ss.
30 P. GROSSI, «La scienza del diritto privato» cit., passim; G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando cit., in part. pp. 1004 ss.
alcune prime osservazioni in argomento, contestualizzate in prospettiva europea (continentale), da intendersi quale primo passo di uno studio più vasto ancora da compiersi.
2. La dimensione europea
L’influenza del pensiero tedesco, sia sul mondo francese, dopo Sedan, sia sulla dottrina giuridica italiana dagli anni Ottanta del secolo XIX, è assodata ed ebbe una ricaduta anche sulla didattica universitaria28.
Tuttavia, proprio riguardo all’insegnamento del diritto, tra Otto e Novecento si assiste a un ripensamento dei metodi didattici e delle materie studiate, suscitato, nella stessa Germania, anche da altri fattori, in parte già richiamati, quali lo sviluppo economico legato all’avvento della seconda rivoluzione industriale; il diffondersi delle nuove scienze – la sociologia, l’etnografia, l’antropologia –; l’emergere di ambiti di studio inediti per i giuristi, in particolare la statistica. Si aggiunse, poi, l’entrata in vigore di una nuova codificazione civile, il BGB29.
Invero, il diffondersi dei canoni ermeneutici della scienza giuridica tedesca non significò una completa ‘monopolizzazione’ del metodo d’inter-pretazione del diritto, poiché le connessioni e le relazioni tra i giuristi europei del tempo facilitavano gli scambi culturali: le ‘contaminazioni’ reciproche, soprattutto sul terreno delle scienze sociali e dell’insegnamento del diritto, sono spesso all’origine di nuovi insegnamenti introdotti nei piani di studio.
Ciò emerge, in particolare, con riferimento all’Italia: la rivoluzio-ne metodologica, attuata sulla scia della scuola germanica30, porta a considerare gli studi di diritto romano alla stregua di una formazione imprescindibile per il giurista impegnato a costruire il ‘sistema giuridi-co nazionale’31. Nonostante l’impostazione tedesca, gli autori francesi
294 ANNAMARIA MONTI
31 C. SALVI, La giusprivatistica tra codice e scienza, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari 1990, pp. 233 ss., nonché A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia, ibidem, pp. 278 ss. Di recente, v. la sintesi di G. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne, Torino 2012.
32 Per tutti, P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l’itinerario scientifico di Raymond Saleilles, ora in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Milano, 2008, pp. 269-337; M. SABBIONETI, Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912), Milano 2010.
33 P. GROSSI, Ripensare Gény, ora anche in ID. Nobiltà del diritto cit., pp. 217-267; P. COSTA, L’interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, in François Gény e la scienza giuridica del Novecento, «Quaderni fiorentini», 1991/20, pp. 367 ss.
34 Lo scambio non pare a senso unico, cioè dalla Francia verso l’Italia, bensì circolare: sulle pagine delle Annales de droit commercial, Saleilles recensisce uno scritto di Angelo Sraffa (R. SALEILLES, Contribution à l’étude des méthodes juridiques. A propos d’un Livre de M. A. Sraffa. (La Liquidazione delle società commerciali), in «Annales de droit commercial français, étranger et international», 1891, pp. 217 ss. su cui v. A. MONTI, Angelo Sraffa. Un ‘antiteorico’ del diritto, Milano 2011, pp. 88 ss.) e sono discusse le idee di Cesare Vivante, che sarà poi anche tradotto in francese: F. GARNIER, De la coutume et des usages dans la doctrine commerciale française à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, in «Quaderni fiorentini», 2012/41, pp. 309 ss. Sul pensiero del maestro veneziano, di recente A. SCIUMÈ, Cesare Vivante, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, Ottava appendice, a cura di P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI, Roma 2012, pp. 446 ss.
continuano a incontrare consensi, soprattutto quando, anch’essi, sono impegnati a rinnovare il loro metodo.
Ben nota è, del resto, l’attenzione riservata in Italia all’opera di Saleil-les32 e la fortuna di Gény33. Ancora da indagare a fondo sono invece le relazioni culturali tra giuristi francesi e italiani nei settori, per esempio, del diritto commerciale, industriale e del lavoro34. Con riferimento al tema della didattica del diritto, queste ‘circolazioni culturali’ assumono particolare rilevanza, come si metterà in luce nelle prossime pagine.
Innanzitutto, però, in tale ottica, pare opportuna una breve digressione sull’evoluzione della didattica giuridica a livello universitario allo scade-re del secolo XIX proprio in Germania e in Francia, poiché il sistema prussiano-tedesco e il francese in qualche misura si influenzarono reci-procamente e, soprattutto, entrambi ebbero un impatto non indifferente sull’organizzazione delle facoltà giuridiche italiane nell’età liberale.
Dunque, lungo l’Ottocento, nell’area tedesca era prevalsa l’impostazione d’inizio secolo di Wilhem von Humboldt, per cui le università erano rette dallo Stato e in ognuna si insegnava il complesso delle discipline scienti-fiche e umanistiche. Un momento cruciale dello sviluppo della Deutsche
295TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
35 R. VOM BRUCH, Il modello tedesco: università e Bildungsbürgertum, in L’università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano cit., pp. 37-59; F. TESSITORE, L’università di Humboldt e l’unità del sapere, in Università e professioni giuridiche in Europa cit., pp. 15-29, nonché SCHIERA, Università e società come nodo strutturale della storia moderna cit., pp. 33 ss.
36 F.C. VON SAVIGNY, Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842, Herausge-geben und eingeleitet von A. MAZZACANE, Neue, erweiterte Ausgabe, Frankfurt am Main 2004, in part. pp. 91 ss.
37 Cfr. CAPPELLETTI, Studio del diritto e tirocinio professionale cit., pp. 100 ss.38 M. WEBER, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäi-
schen Quellen, 1889, in M. WEBER, Gesamtausgabe, 1, Schriften und Reden, Band 1, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter, Schriften 1889-1894, hrg. von G. DILCHER und S. LEPSIUS, Tübingen 2008, pp. 109 ss. V. anche G. DILCHER, Dalla Storia del diritto alla Sociologia. Il confronto di Max Weber con la Scuola storica del diritto, in «Scienza e Politica», 2007/37, pp. 95-115.
Wissenschaft era stato, nel 1810, la fondazione dell’Università di Berlino, dove ben presto, per ciò che riguarda l’insegnamento giuridico, Savigny fu chiamato alla cattedra di diritto romano, che tenne fino al 184235.
Tra le caratteristiche dell’università ‘tedesca’, si annovera la presenza dei Privatdozenten che, attraverso un procedimento di Habilitation erano designati ‘docenti privati’, appunto, ‘abilitati’ ad insegnare nell’Università che aveva concesso loro la qualifica. Come noto, i Privatdozenten non erano titolari di cattedra: spesso più giovani dei professori ‘ordinari’, con i loro insegnamenti contribuivano ad arricchire il piano di studi delle facoltà. Un esempio tipico è ancora quello di Savigny, che a ventitre anni, nell’anno accademico 1802-1803, da Privatdozent, all’Università di Marburg iniziò il suo fondamentale corso sul metodo giuridico36.
Inoltre, nel sistema educativo tedesco un ruolo strategico era riser-vato ai seminari, organizzati in aggiunta alle lezioni frontali tradizionali e destinati a piccoli gruppi di studenti. Lo scopo dei seminari era sti-molare il coinvolgimento personale dei discenti e suscitare discussioni interattive con i professori37.
Valga anche in questo caso un solo esempio, anch’esso celebre, sui frutti che queste attività ‘collaterali’ seppero produrre: tra i frequentanti il seminario sulla storia del diritto commerciale tenuto all’Università di Berlino da Levin Goldschmidt – titolare della nuova cattedra di diritto commerciale, creata apposta per lui nel 1875 –, spiccava Max Weber. Weber stesso, tempo dopo, conseguiva l’abilitazione quale Privatdo-zent rielaborando proprio il lavoro svolto al seminario di Goldschmidt, discutendo una tesi sulla storia delle società commerciali nel medioevo, condotta su fonti dell’Europa meridionale38.
296 ANNAMARIA MONTI
39 SCHIERA, Il laboratorio borghese cit., in part. pp. 23 ss., 77 ss. e 117 ss.40 Ibidem, pp. 253 ss. e 335 ss.41 Cfr. ora l’edizione italiana M. STOLLEIS, Dottrina del diritto pubblico e scienza dell’am-
ministrazione: 1800-1914, Milano 2014, nonché la recente sintesi ID., Öffentliches Recht in Deutschland: eine Einführung in seine Geschichte (XVI-XXI Jahrhundert), München 2014.
42 P. SCHIERA, Il laboratorio borghese cit., pp. 140 ss., 159-205. V. anche K. LUIG, Il diritto privato germanico e gli studi universitari nella Germania del secondo Ottocento, in Università e professioni giuridiche in Europa cit., pp. 195 ss.
43 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Dalla storia di Roma alle origini della società civile, Bologna 2008, pp. 233 ss.
In sintesi, le Università tedesche dell’Ottocento erano luoghi dedicati alla ricerca, alla formazione alla ricerca e all’incentivazione della conoscen-za nel senso più ampio. Dagli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento e fino alla Prima Guerra, però, si assiste a un incremento della specializzazione, incentivata dalle richieste provenienti dalla società e dall’economia39.
In particolare, fu l’industrializzazione a provocare un aumento, a livello universitario, degli studi e degli insegnamenti specialistici. Inol-tre, sempre più importante divenne il finanziamento privato nell’alta formazione e nella ricerca: il mondo industriale iniziò a sponsorizzare fondazioni, istituti, scuole, cosicché le università tedesche intrapresero la via della trasformazione in grandi ‘aziende’ in cui la specializzazione delle scienze e dei ricercatori ormai prendeva il sopravvento sulla pre-cedente idea di ‘unità’ della conoscenza40.
Tale processo di ‘specializzazione’ investe anche il campo degli studi giuridici e alcuni rilevanti cambiamenti sono discussi e introdotti nel cur-riculum studiorum: per la formazione dei funzionari destinati all’alta buro-crazia imperiale, una maggiore attenzione è riservata a materie di studio quali le scienze sociali, l’economia politica, la statistica e, specificamente, il diritto pubblico41; inoltre, sia per ragioni economiche, sia per motivi politici, il diritto commerciale e il diritto amministrativo acquisirono lo status di discipline autonome, mentre il diritto del lavoro, il diritto d’autore e della proprietà industriale si coltivarono sempre più. Quanto al diritto privato, esso continuò a rappresentare l’asse portante della formazione giuridica e, contemporaneamente, ampliò i suoi spazi ‘interni’42.
Passando ora in breve al caso francese, occorre premettere che all’in-staurarsi della Terza Repubblica, l’idea e la struttura dell’università tedesca affascinarono la Francia. Così, nel 1879, Fustel de Coulanges, lo storico dell’Ecole normale autore della Cité antique43, pubblicava un
297TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
44 Tra gli abbonati – e lettori assidui – della Revue des deux mondes si può ricordare Angelo Sraffa (MONTI, Angelo Sraffa cit., passim).
45 N.D. FUSTEL DE COULANGES, De l’enseignement supérieur en Allemagne d’après des rapports récens, in «Revue des Deux Mondes», 1879/34. Cfr. P. SCHIERA, Modelli di università nell’Ottocento europeo cit., pp. 15-17.
46 La recentissima esperienza dell’Ecole de Droit de Sciences Po, che in una Grande École offre una preparazione giuridica concorrente a quella delle Faculté de Droit, rappresenta un’assoluta novità: JAMIN, La cuisine du droit cit., pp. 171 ss.
47 Ouverture, in Paris, capitale juridique (1804-1950) cit., spec. pp. 35 ss.
saggio sulla celebre Revue des deux mondes – periodico seguito con atten-zione, da un pubblico colto, anche in Italia44 – dedicato all’insegnamento superiore in Germania. Si trattava, in realtà, della recensione di uno studio in argomento pubblicato dalla Société pour l’étude des questions d’enseignement supérieur (fondata a Parigi da Emile Boutmy) ed era l’occasione per l’autore di tratteggiare il sistema universitario tedesco, evidenziandone i punti di forza e comparandolo con quello francese45.
La Francia, invero, sin dalla fine del Settecento, aveva adottato il proprio ‘modello’ di educazione superiore, diviso in due rami, le univer-sità e le Grandes Ecoles: le prime dispensatrici di un’educazione di tipo professionale, chiamate a formare dei liberi professionisti; le seconde, votate alla preparazione delle élites di pubblici funzionari. Quanto alla formazione dei giuristi, essa era riservata alle università, che attraevano studenti delle classi agiate in cerca di un’educazione professionale di alto livello46.
Agli inizi del XIX secolo, quando le università dell’area tedesca avevano adottato il sistema humboldtiano, Napoleone, come già accen-nato, aveva riformato le Ecoles de droit, finalizzate alla formazione di buoni giudici e avvocati, ponendo al centro l’insegnamento del codice civile – in particolare nei primi tre anni di corso (licence) –, retroceden-do l’insegnamento del diritto romano al ruolo di materia secondaria e sopprimendo il diritto canonico. Durante la Restaurazione, poi, si erano discussi dei progetti di riforma (nel 1819-1822 e ancora nel 1838), tut-tavia, sino all’avvento della Troisième République, l’educazione giuridica in Francia non cambiò realmente47.
Fu dagli anni Ottanta, invece, che si avviò un serio movimento rifor-mista, cui parteciparono sia i professori, sia i pratici: l’intero percorso educativo fu messo in discussione e, come accennato sopra, si guardò all’esperienza tedesca. Il dibattito si raccolse sulle pagine della Revue
298 ANNAMARIA MONTI
48 F. AUDREN, J.L. HALPÉRIN, La culture juridique française cit., pp. 111 ss.49 Rinvio ai saggi confluiti nei volumi collettanei Le renouvellement des sciences sociales
et juridiques sous la IIIème République. La faculté de Droit de Lyon, sous la direction de D. DEROUSSIN, Paris 2007; Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle, Etudes réunies par N. HAKIM et F. MELLERAY, Paris 2009; La République et son droit (1870-1930), sous la direction de A. STORA-LAMARRE, J.-L. HALPÉRIN, F. AUDREN, Besançon 2011, nonché ai contributi citati sopra.
50 F. AUDREN, Les professeurs de droit cit., pp. 13 ss.51 C. JAMIN, La cuisine du droit cit., pp. 52 ss.
internationale de l’enseignement, che pubblicò anche una serie di studi comparativi sulla Germania e il suo concetto ‘scientifico’ di sistema giuridico48.
Per sintetizzare, si immaginò un’educazione giuridica di più ampio respiro, volta all’apprendimento non solo del contenuto dei codici vigen-ti, ma anche del ragionamento giuridico, avvalendosi di nuovi strumenti didattici. Si trasferiva, infatti, nelle aule universitarie, la più generale insoddisfazione per i metodi esegetici tradizionali e la ricerca di ‘nuove vie’ d’interpretazione del diritto.
Come accadeva nella Germania dell’Impero guglielmino in conso-lidazione, anche in una Francia impegnata nella costruzione del suo regime repubblicano assunsero sempre maggior peso gli insegnamenti di diritto costituzionale e pubblico e di economia politica. Inoltre, si intro-dussero nuovi corsi di diritto internazionale e di diritto internazionale privato; di diritto tributario; di legislazione industriale e, in particolare, di diritto comparato49.
Anche le cosiddette ‘scienze sociali’, e specificamente la sociologia, nei suoi differenti approcci, ricevettero grande attenzione da parte di numerosi professori di diritto in cerca di metodi innovativi e soluzioni adeguate ai problemi del presente: fu un’epoca decisamente vivace e ricca di discussioni in materia50.
In conclusione – sempre senza alcuna pretesa di completezza, ma solo al fine di meglio chiarire ciò che accadde nell’Italia unificata – secondo letture recenti di quelle vicende, i cambiamenti introdotti nelle facoltà giuridiche francesi agli inizi del Novecento furono determinanti per il futuro dell’educazione giuridica universitaria transalpina, nel senso che le università optarono, alla fine, per un insegnamento più dottrinale e di alto profilo tecnico, lasciando da parte una formazione strettamente professionalizzante51.
299TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
52 P. JESTAZ, C. JAMIN, La doctrine, Paris 2004, pp. 139 ss.; F. AUDREN, Les professeurs de droit cit., pp. 29-33.
53 Così il discorso del Presidente per l’apertura del Congresso dell’Associazione univer-sitaria, 11-13 aprile 1912, P. BONFANTE, La riforma universitaria, ora in ID., Scritti giuridici vari, IV, Studi generali, Roma 1925, pp. 295-304. In merito, F. COLAO, La libertà di insegna-mento cit., pp. 392 ss.; M. LUCCHESI, Un grande laboratorio per la scienza o una scuola per la professione? L’Università italiana nel tempo presente di Pietro Vaccari (1927), in «Historia et ius», www.historiaetius.eu, 2013/5, paper 9, in part. pp. 28 ss.
54 P. BONFANTE, La riforma universitaria cit., p. 295.
Nondimeno, la didattica giuridica mantenne in Francia stretti lega-mi con la pratica del diritto: l’idea che prevalse fu quella di dotare gli studenti di una visione sintetica e metodica dell’insieme del diritto e delle discipline giuridiche, per trasmettere loro i principi generali indi-spensabili per affrontare poi le questioni pratiche. In tale prospettiva, le scienze sociali furono alla fine marginalizzate52.
Nell’Italia liberale queste esperienze – tedesche e francesi – ebbero un’eco e, per certi versi, furono oggetto di una rielaborazione originale, nella tensione verso l’adeguamento della didattica giuridica alle esigenze di una società in mutamento, come ora si vedrà.
3. Prime evidenze di rinnovamento nelle facoltà italiane: i corsi ‘liberi’
«Critico è il momento che attraversano gli studi superiori nel nostro paese. Per vari sintomi è prevedibile che tra non molti anni noi giunge-remo a una fase acuta»: così Pietro Bonfante nel 1912, all’apertura del Congresso dell’Associazione universitaria53.
Tra le criticità, il romanista individua l’impossibilità di ampliare oltremisura il quadro degli insegnamenti, mentre, d’altro canto, la scienza ‘si muove’ e dunque «non tutte le nuove discipline sorgenti potranno adeguarsi in quella categoria così comoda burocraticamente, così infelice scientificamente, delle materie complementari»54.
Per le ‘novità’, non accolte nei corsi ufficiali, si poteva ricorrere, infatti (forse ora, come allora) a una sorta di valvola di sfogo, cioè ai corsi complementari e, pare di poter aggiungere, ai corsi liberi che, come meglio si dirà nel prosieguo, spesso furono l’occasione per ‘sperimentare’ una didattica innovativa, aggiornata alle più recenti dottrine straniere in vari settori, dal diritto comparato all’industriale.
Ciò che si reclamava, nel discorso di Bonfante, era, in effetti, una riforma organica, che consentisse alle materie nuove di integrarsi, senza
300 ANNAMARIA MONTI
55 G. RICUPERATI, Per una storia dell’università italiana da Gentile a Bottai: appunti e discussioni, in L’università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano cit., in part. pp. 319 ss. Cfr. anche G. TURI, Giovanni Gentile: una biografia, Torino 2006, pp. 336 ss., in part. pp. 347 ss.
56 V. l’efficace sintesi di A. SANDULLI, Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi, in Storia delle Università in Italia cit., vol. II, pp. 263-301.
57 Oltre agli studi di Ilaria Porciani e Mauro Moretti già citati, v. ancora I. PORCIANI, L’università dell’Italia unita, in Università e professioni giuridiche in Europa cit., pp. 53-75, EAD., Lo Stato unitario di fronte alla questione dell’università, in L’università tra Otto e Nove-cento: i modelli europei e il caso italiano cit., pp. 135-184. Cfr. inoltre F. COLAO, La libertà di insegnamento cit., pp. 150 ss.
58 G. DI RENZO VILLATA, La formazione del giurista in Italia cit., pp. 77-83.
appesantire il corso degli studi in modo eccessivo E la riforma, attesa e discussa attraverso progetti successivi lungo l’età liberale, sarebbe arrivata, ma dopo la Guerra, con il ministro Gentile, nel 1923, in un clima politico e sociale mutato e recando l’impronta forte del pensiero del suo ispiratore55.
Tornando, però, all’insegnamento del diritto impartito in Italia a livello universitario tra Otto e Novecento, prima di rivolgere l’attenzione ai corsi ‘liberi’, cui si è fatto cenno, si può ricordare che il quadro di riferimento era ancora quello della legge Casati. Estesa dagli Stati sardi e dalla Lombardia all’intero paese, la normativa del 1859 aveva mirato alla ‘standardizzazione’ delle università del Regno, nel segno di una duplice finalità: la preparazione degli studenti alle carriere pubbliche e private (alta amministrazione e libere professioni); la promozione della ricerca56.
Più in generale, infatti, negli anni successivi all’Unificazione si era guardato alle università, insieme alla burocrazia e all’esercito, come a istituzioni fondamentali per costruire il nuovo Stato e la sua classe dirigente: perciò esse furono oggetto di attenzione da parte del governo e non fu loro estraneo un ruolo politico57.
La situazione, per così dire, ‘di partenza’ del nuovo Stato unitario, per ciò che riguarda il sistema universitario e, nello specifico, l’insegna-mento del diritto era, in effetti, di estrema frammentazione e risentiva, in alcuni casi, della tradizione sei e settecentesca, comune anche ad altre realtà europee, per cui la formazione del giurista si svolgeva principal-mente in seno ai collegi professionali58.
L’educazione giuridica nei diversi Stati italiani preunitari, infatti, si era sviluppata secondo modalità differenti, spesso originali: nel Regno di Napoli, per esempio, alla ‘presunta’ decadenza dell’università durante la
301TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
59 V. le considerazioni in merito di A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant’anni, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 1911/9, I, pp. 285 ss.
60 A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Otto-cento cit., pp. 79 ss.
61 F. TREGGIARI, Scienza e insegnamento del diritto cit., pp. 70 ss. e in part. 118 ss., per il suo disegno di legge di riforma universitaria del 1897.
62 A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Otto-cento cit., pp. 108 ss. Per una bibliografia aggiornata su Mancini rinvio a G.S. PENE VIDARI, La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (Torino 1851), in Retoriche dei giuristi cit., pp. 117 ss.
63 La letteratura in argomento è vasta, il richiamo si limita qui a L. MOSCATI, Insegna-mento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, pp. 277-321 e al volume collettaneo Le Università e l’Unità d’Italia (1848-1870) cit., in part. M.R. DI SIMONE, Gli studi giuridici all’Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e regno d’Italia, pp. 189-204. V. inoltre C. VALSECCHI, Ortodossia religiosa e fedeltà allo Stato nell’insegnamento di Giovanni Battista Pertile: il diritto matrimoniale, in Formare il giurista cit., pp. 403 ss., in part. p. 410; C. STORTI STORCHI, Ludovico Casanova (1799-1853) e le sue lezioni di diritto internazionale, in Giuristi Liguri cit., pp. 53-94; A. FIORI, Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana, in Retoriche dei giuristi cit., pp. 135-162.
64 Per un’efficace sintesi, M. MORETTI, Scuola, scienza, università, in Scienza e cultura dell’Italia unita, a cura di F. CASSATA e C. POGLIANO, Storia d’Italia, Annali, 26, Torino 2011, pp. 975-1010.
Restaurazione, denunciata da Savigny nel corso del suo viaggio in Italia del 1826-2759, si contrapponeva una vivacissima realtà di insegnamento privato, che doveva perdurare sino oltre la metà del secolo60.
Si pensi, sempre a mero titolo esemplificativo, a Emanuele Gianturco, a giudizio (anche politico) del quale il fulcro dell’educazione giuridica nazionale si identificava proprio in quell’approccio pratico al diritto, insegnato privatamente da singoli docenti nelle scuole napoletane61. Oppure, ancora, a Pasquale Stanislao Mancini, che studia diritto in privato e prima ancora di ottenere il diploma dall’università inizia a esercitare l’avvocatura, finché nel 1842, con alcuni colleghi, non apre la sua scuola privata per preparare futuri avvocati e giudici62.
Ovviamente, il caso napoletano è solo uno degli esempi possibili, nel variegato panorama dell’Italia preunitaria al momento dell’Unificazione nazionale63, quando la riforma universitaria divenne una priorità della nuova élite di governo ormai italiana e la scelta di fondo – ispirata più dal sistema napoleonico, che non da quello tedesco, pur fortemente ammirato – fu di centralizzare64.
Si accentrò, quindi, il reclutamento dei docenti attraverso un mec-canismo di concorsi nazionali e si riservò al ministero dell’educazione
302 ANNAMARIA MONTI
65 T. TOMASI, L. BELLATALLA, L’Università italiana nell’Italia liberale (1861-1923), Napoli 1988, pp. 144 ss. Sulla valorizzazione della libera docenza da parte del ministro Bonghi nel 1875, F. COLAO, La libertà di insegnamento cit., pp. 186 ss.
66 F. COLAO, La libertà di insegnamento cit., pp. 382-388 e passim.67 Ibidem, pp. 274 ss.68 Ibidem, pp. 334 ss. 69 Il rinvio è alla prolusione romana del 25 novembre 1871 di F. SERAFINI, Del metodo
degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare, ora in La facoltà giuridica
l’approvazione dei programmi e dei piani di studio delle varie facoltà. Le scuole private di diritto gradualmente scomparvero, cosicché l’educazione giuridica al più alto livello si poteva conseguire solo nell’università, dove, proprio attraverso la duplice finalità voluta dalla legge Casati – prepa-razione professionale e ricerca – si tentò di raccordare scienza e pratica.
In questo contesto politico e organizzativo si inserisce la figura del libero docente, versione italiana del Privatdozent germanico, «un elemento di contorno di un sistema gerarchico strutturato»65: i liberi docenti, di solito giovani all’inizio del percorso accademico, oppure più esperti ‘cultori della materia’ non ingaggiati nella carriera universitaria vera e propria – verso i quali, in realtà, non mancarono le polemiche66
–, impartivano, nella facoltà che li aveva abilitati, i corsi cui si è fatto cenno, detti appunto ‘liberi’.
A far tempo dagli anni Ottanta dell’Ottocento, poi, come si è visto accadere anche in Germania e in Francia, la questione dell’insegnamento universitario tornò alla ribalta. Con l’accelerazione degli investimenti nel settore industriale e le profonde trasformazioni economiche e sociali con-seguenti, l’insoddisfazione già a più riprese manifestata per il sistema della legge del ‘59 scatenò un acceso dibattito che si focalizzò, si è accennato, sul tema dell’autonomia degli atenei dallo Stato, a livello organizzativo e finanziario, e fu l’occasione per studiare i sistemi universitari stranieri67.
A livello didattico, comunque, nonostante i limiti della riforma Casati e dei vari decreti successivi che spesso ne avevano stravolto lo spirito, anche a giudizio degli stessi contemporanei, a fine secolo in molte uni-versità italiane si registrava un miglioramento in termini di qualità68.
In particolare, con riferimento all’insegnamento del diritto, si consi-derò strategico per il progresso ‘qualitativo’ il rinnovamento metodolo-gico di marca tedesca che aveva investito la dottrina giuridica italiana: la ‘rivoluzione del metodo’ apparve compiersi proprio attraverso gli studi di diritto romano condotti nelle università69, dove erano riprese
303TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
romana in età liberale cit., pp. 471 ss. (v. A. FIORI, Le prolusioni storico-giuridiche e roma-nistiche della facoltà di giurisprudenza, ibidem, pp. 452-454). Sui seminari storico giuridici guidati da Filippo Serafini alla Sapienza pisana, L. PASSERO, La Facoltà giuridica pisana negli anni Ottanta dell’Ottocento, in «Studi Senesi», 2007, pp. 322-359; EAD., Dionisio Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento, Milano 2010, spec. pp. 45 ss.
70 Tra l’altro, P. NARDI, Lodovico Zdekauer a Macerata tra archivi e insegnamento univer-sitario, in «Annali di Storia delle Università italiane», 2010/14; M.G. DI RENZO VILLATA, per una storia del diritto (italiano). Antonio Pertile e la prima cattedra della materia, in «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 2012/45, pp.63-103; A. FIORI, Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo, in «Historia et ius», www.historiaetius.eu, 2013/4, paper 10.
71 ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia cit., pp. 287 ss.72 Così A. MAZZACANE, Introduzione, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale cit., in
part, pp. 17-19.73 Rinvio alle pagine di G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando cit., pp. 998 ss. 74 Ibidem, pp. 1014 ss.75 Cfr. R. ORESTANO, Sulla didattica giuridica in Italia tra XIX e XX secolo, in L’educazione
giuridica, I [1975] cit., pp. 135-146.
anche le ricerche sulle fonti e le indagini di carattere storico, sempre sull’esempio germanico70.
Una simile lettura dell’andamento della scienza giuridica italiana lungo l’Ottocento – proposta, tra i primi, da Alfredo Rocco71 – avvallava, invero, l’idea di una rinascita degli studi giuridici che transitava pressoché soltanto dalle aule universitarie, per l’imporsi di metodologie interpreta-tive sistematiche e dogmatiche d’ispirazione tedesca, mentre tralasciava di considerare ciò che accadeva in ambienti extra scolastici. Quella di Rocco è stata giudicata, dunque, una ricostruzione storica quantomeno ‘parziale’, funzionale semmai alle esigenze dell’epoca immediatamente successiva, gli anni Venti e Trenta del XX secolo72.
In realtà, neppure nelle università italiane la via del rinnovamento, percorsa tra Otto e Novecento tramite un’internazionalizzazione del pensiero e della didattica, sembrava rivolgersi in un’unica direzione. Benché prevalenti, a livello di formazione scientifica, anzi, espressa-mente prescelti per fondare una dottrina universitaria destinata al «predominio …tra le fonti del diritto»73, i canoni del pensiero di Savi-gny e della pandettistica non erano i soli a contribuire a una stagione felice della scienza giuridica ‘nazionale’. Senza dubbio essi fornirono «lo statuto scientifico del moderno specialismo in tutte le discipline giuridiche»74, tuttavia, in alcuni settori, si osserva una permeabilità a suggestioni straniere diverse 75.
304 ANNAMARIA MONTI
76 Sulle ‘famigerate’ dispense e le litografie universitarie, v. il discorso pronunciato da W. BIGIAVI, in Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione, vol. I, Padova 1953, pp. V ss., nonché G. CHIOSSO, Stampatori ed editori per l’Università e la scuola tra Otto e primo Novecento, in Dalla pecia all’e-book cit., in part. pp. 648 ss.; F. TARGHETTA, Un secolo a servizio dell’Università: la casa editrice Cedam, ibidem, pp. 655 ss. Per l’uso delle dispense dei corsi universitari in Francia, G. RICHARD, La Faculté de Paris et l’aide aux étudiants sous la Troisième République, in Paris, capitale juridique (1804-1950) cit., pp. 211-214.
77 La Biblioteca Bocconi conserva un consistente numero di dispense dei corsi impar-titi dalla fondazione alla metà del Novecento e ne ha curato un catalogo: Lezioni tenute all’Università Bocconi a.a. 1902/1903-1944/1945, novembre 1999. V. anche M. CAVAZZA ROSSI, La cultura economica milanese e l’insegnamento universitario: le dispense di economia dell’Università Bocconi, in Milano e la cultura economica nel XX secolo, I, Gli anni 1890-1920, a cura di P.L. PORTA, Milano [1998], pp. 239 ss.
78 Tra le dispense dei corsi bocconiani di Sraffa, conservate per gli anni 1903-1910 e 1912-1916, v. Università Commerciale «Luigi Bocconi», Corso di Diritto Commerciale del prof. Angelo Sraffa, Appunti raccolti dallo studente A. Rossi, Anno Accademico 1903-904; Università Commerciale «Luigi Bocconi», Diritto commerciale e industriale: anno accademico 1904-1905. Appunti raccolti sulle lezioni del prof. Angelo Sraffa, [a cura di Antonio Boni], Milano, [1905]. Per i corsi torinesi del docente pisano, R. Università di Torino, prof. A. SRAFFA, Corso di diritto commerciale, a cura degli studenti Francesco Mario Margara e Luigi Pirajno, Anno Accademico 1915-16, Torino, 1916. Mi permetto di rinviare a Monti, Angelo Sraffa cit., pp. 190 ss.
79 Oltre a A.-J. ARNAUD, Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, Paris 1975, pp. 106-108 e a J. HILAIRE, Le comparatisme en matière commerciale au XIXème siècle, in «Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique», 1991/12, pp. 141-142, v. J.-L. HALPÉRIN, Thaller Edmond-Eugène, in Dictionnaire historique des juristes français XIIe-
Nel campo del diritto commerciale, per esempio, proprio nelle dispense delle lezioni76 di Angelo Sraffa impartite tra il 1903 e il 1915 in Bocconi77, si apprezza la familiarità del giurista toscano con il pen-siero del francese Edmond Thaller, ampiamente utilizzato per finalità didattiche78.
Formatosi a Strasburgo alla scuola di Aubry e Rau, fondatore e direttore delle Annales de droit commercial, Thaller, certo, fu a sua volta influenzato dalla dottrina tedesca. E si potrebbe forse supporre che proprio sul terreno della metodologia scientifica tedesca i giuristi italiani s’incontrarono con il collega francese. Tuttavia, Thaller manifestò uno speciale interesse per la sociologia, non fu estraneo all’ambiente di Le Play, fu precursore di metodi comparativi – tutti temi cari alla più ‘moderna’ scienza commercialistica italiana di fine Ottocento, cui Sraffa apparteneva – e, senza dubbio, Thaller si annovera tra i protagonisti di una nuova dottrina giuridica francese79. Si può quindi ipotizzare che anche altri fossero i terreni d’incontro.
305TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
XXe siècle, sous la direction de P. ARABEYRE, J.-L. HALPÉRIN, J. KRYNEN, nouvelle édition, Paris 2015, p. 960; F. GARNIER, Edmond-Eugène Thaller (1851-1918) et les annales de droit commercial, in Le renouveau de la doctrine française cit., pp. 159-196; GARNIER, De la coutume et des usages dans la doctrine commerciale française cit., in part. pp. 313 ss.
80 E. THALLER, Traité élémentaire de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, Paris 1898. Sui caratteri di quest’opera, P. JESTAZ, C. JAMIN, La doctrine cit., p. 151; GARNIER, Edmond-Eugène Thaller cit., spec. p. 162, nonché A. MAGES, Le manuel de droit commercial: vecteur d’autonomie (XIXe – milieu du XXe siècle), in Histoire des manuels de droit cit., in part. pp. 160-164.
81 E. THALLER, Trattato elementare di diritto commerciale, Milano 1923.82 A. SRAFFA, Libri e riviste, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni», 1923/21, I, p. 192. 83 A. ROCCO, Principii di diritto commerciale, Torino 1928, p. 111.84 T. BAGIOTTI, Storia della Università Bocconi 1902-1952, Milano 1952; M. CATTINI,
E. DECLEVA, A. DE MADDALENA, M.A. ROMANI, Storia di una libera università, I, L’Univer-sità Commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914, Milano 1992. Cfr. inoltre P.L. PORTA, Istituzioni e centri di elaborazione della cultura economica, in Milano e la cultura economica cit., pp. 172-175.
85 F. ASTONE, Pacchioni, Giovanni, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, vol. II, pp. 1475-1476. V. inoltre M.G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, La ‘seconda’ Facoltà giuridica lombarda. Dall’avvio agli anni Settanta del Novecento, in «Annali di storia delle università italiane», 2007/11, pp. 65 ss.
86 Corso speciale di legislazione comparata. Anno accademico 1906-1907, appunti delle lezioni del chiarissimo prof. Giovanni Pacchioni, Milano 1907; Legislazione comparata. Anno accademico 1907-1908, lezioni del chiarissimo prof. Giovanni Pacchioni, Pavia, Premiato stabilimento tipo-litografico succ. Bruni, [1908].
In particolare, il professore transalpino fu autore, tra l’altro, di un ‘trattato elementare’ ad uso didattico – presto divenuto un «classique à l’Ecole et au Palais»80 – che Sraffa stesso, anni dopo, avrebbe fatto tradurre81, accompagnandone l’uscita sul mercato italiano con un’entusia-stica recensione sulla Rivista di diritto commerciale: l’opera portava nelle scuole «una fresca corrente di pensiero fecondo», compendiando la «bella tradizione francese della limpidità» con gli esiti della più moderna com-mercialistica, tratti «specie dalla dottrina germanica»82. Proprio Alfredo Rocco, del resto, l’avrebbe giudicato un eccellente manuale scolastico83.
E sempre Thaller, con un diverso suo contributo, avrebbe fornito a un altro collega italiano idee e materiali per un insegnamento inno-vativo, impartito nell’università Bocconi di Milano, al tempo di recente fondazione84: Giovanni Pacchioni, infatti, all’epoca professore di diritto romano e di diritto civile a Torino85, nel suo corso di legislazione com-parata degli anni 1906-1908, di cui si conservano le dispense86, dedi-
306 ANNAMARIA MONTI
87 E. THALLER, Des faillites en droit comparé, avec une étude sur le règlement des faillites en droit international, Tomes I-II, Paris 1887. In merito, mi permetto di rinviare a A. MONTI, Enseigner le droit en Italie au début du XXème siècle: les cours de législation comparée de Giovanni Pacchioni (1867-1946), in corso di stampa nei Mélanges en l’honneur du Professeur Xavier Martin, presso Les éditions universitaires juridiques Poitiers/LGDJ.
88 Sulla scia di Raymond Saleilles e Edouard Lambert: M. SABBIONETI, Democrazia sociale e diritto privato cit., pp. 227 ss.
89 Cfr. J. HILAIRE, Le comparatisme en matière commerciale au XIXème siècle, in «Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique», 1991/12, pp. 127-142. Di recente, C. CIANCIO, Les congrès internationaux de droit commercial: un réseau de commercialistes européens à la recherche d’un droit uniforme, in L’idée de fonds juridique commun dans l’Europe du XIXe siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux, sous la direction de T. LE YONCOURT, A. MERGEY et S. SOLEIL, Rennes 2014, pp. 253-275.
90 Sull’apertura alla comparazione e al diritto anglosassone di Pacchioni, R. SACCO, Intervista a Rodolfo Sacco, a cura di G. AJANI e M. GRAZIADEI, in «Annuario di diritto com-parato», 2010, p. 32.
91 Tra i saggi dedicati agli insegnamenti giuridici dell’università di Torino tra Otto e Nove-cento, G.S. PENE VIDARI, Nota sull’inizio dell’insegnamento del diritto commerciale all’Università di Torino, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 1997/95, pp. 511-531; ID., Cultura giuridica, in Torino città viva. Da capitale a metropoli. 1880-1980, Torino 1980, II, pp. 839-855; ID., I professori di diritto, in L’Università di Torino. Profilo storico e istituzionale, a cura di F. TRANIELLO, Torino 1993, pp. 82-91. Più in generale, A. D’ORSI, Allievi e maestri: l’Università di Torino nell’Otto-Novecento, Torino 2002, nonché Maestri dell’Ateneo torinese dal Settecento al Novecento, a cura di R. ALLIO, Torino 2004. Sull’ambiente dei professori e degli studenti, A.C. JEMOLO, Anni di prova, Prefazione di F. MARGIOTTA BROGLIO, Firenze 1991, pp. 98-100.
cava alcune lezioni allo studio del fallimento in prospettiva comparata, richiamandosi direttamente al Des faillites en droit comparé di Thaller, pubblicato nel 1887, quale frutto, a sua volta, di un’esperienza didattica alla facoltà giuridica di Lione87.
Con quell’insegnamento – che in parte Pacchioni replicava anche nell’ateneo subalpino come corso libero – il romanista e civilista inten-deva fornire agli studenti l’occasione di confrontarsi con le scelte dei paesi più moderni e industrializzati e, pur riservando un’attenzione speciale alla storia88, coglieva l’occasione per dirigere la curiosità dei suoi studenti verso il mondo anglosassone, oltre che ai paesi europei continentali e alle colonie, in particolare l’India britannica, illustrando la rimarcabile tendenza all’uniformità che si registrava soprattutto nel settore del diritto commerciale89.
Senza soffermarsi sulla concezione che della comparazione aveva Pacchioni – decisamente pragmatica, invero 90 – interessa qui soprattutto sottolineare come, proprio all’università di Torino, esempio di università di prim’ordine91, i corsi di diritto comparato fossero presenti in gran
307TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
92 A titolo esemplificativo, nel 1906-1907 Emilio Brusa proseguiva il suo consolidato insegnamento di ‘legislazione comparata’ e tra i corsi ‘liberi’ si contavano quello di ‘legisla-zione e giurisprudenza civile e comparata’ di Gian Pietro Chironi, di ‘diritto romano civile comparato’ di Giovanni Pacchioni; di ‘diritto civile comparato’ di Ricca Barberis e il corso di ‘diritto civile comparato’ di Mario Sarfatti: Archivio storico dell’Università di Torino, Verbali della Facoltà di giurisprudenza dal 27 ottobre 1902 al 30 marzo 1909, Adunanza del 19 marzo 1906 e Adunanza del 24 marzo 1906.
93 C. JAMIN, Le vieux rêve de Saleilles et Lambert revisité. A propos du centenaire du congrès international de droit comparé de Paris, in «Revue internationale de droit comparé», 2000/52, pp. 733-751; C. PETIT, Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la Belle Epoque, in La comparazione giuridica tra Otto e Novecento, Milano 2001, pp. 53-98.
94 M. SARFATTI, Sull’utilità dello studio del diritto privato inglese in Italia. Prolusione al corso libero di diritto civile comparato, R. Università di Torino 15 dicembre 1906, in «Il Filangieri», 1907, pp. 1 ss.
95 Ciò accadde a più riprese: nel 1911, per l’abolizione ministeriale di diversi corsi complementari, tra cui quello di legislazione comparata, che si era deciso di affidare a Sar-fatti (dopo la morte di Brusa) e successivamente, nel primo dopoguerra, quando il corso di Sarfatti continuò a essere considerato un punto di forza e, dunque, irrinunciabile: v. i verbali delle sedute in Archivio storico dell’Università di Torino, Processi verbali della Facoltà di Giurisprudenza dal 17 aprile 1909, Adunanza del 1 maggio 1911; Registro verbali delle sedute del consiglio di facoltà dal 24 gennaio 1917 al 23 dicembre 1927, Adunanza 27 maggio 1919 e Adunanza 3 maggio 1920.
96 In questo senso la Prefazione di G.P. CHIRONI a M. SARFATTI, La nozione del torto nella dottrina e nella giurisprudenza inglese (appunti), Milano 1903, in part. pp. VII-IX.
97 Rinvio a A. MONTI, Alla scoperta del diritto anglo sassone: il contributo di Mario Sarfatti (1876-1962) alla comparazione giuridica, in Lavorando al cantiere del “Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)”, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano 2013, pp. 589-623.
numero nell’offerta formativa92. Quegli insegnamenti, per la maggior parte ‘liberi’ e affidati sia a professori ordinari, sia a liberi docenti, senz’altro recuperavano una tradizione antica di studi comparativi, tutta-via proiettavano anche la didattica in un contesto di più ampio dibattito internazionale. La ‘moderna’ comparazione, del resto, solo pochi anni prima, nel 1900, a Parigi, aveva celebrato il suo primo congresso93.
E Pacchioni, d’altronde, a Torino, insieme a Chironi, aveva sostenuto da subito gli studi eterodossi di Mario Sarfatti sul diritto anglo sassone e aveva altresì promosso i suoi corsi liberi e complementari di diritto pri-vato comparato inglese e italiano94, difendendoli all’occorrenza, quando li si voleva abolire95: simili lezioni, infatti, consentivano di perseguire strade alternative nella ricerca di un rinnovato metodo di interpreta-zione e studio del diritto96. Inoltre, permettevano ai giuristi italiani di mantenersi in contatto diretto con la più aggiornata scienza giuridica europea, dai ‘comparatisti’ inglesi all’influente Kohler e al vivacissimo circuito lionese, in particolare a Edouard Lambert97.
308 ANNAMARIA MONTI
98 Archivio Storico dell’Università di Torino, Registro verbali delle sedute del consiglio di facoltà dal 24 gennaio 1917 al 23 dicembre 1927, Adunanza 3 maggio 1920. In generale, sulla crisi ‘antipositivista’ che attraversa la scienza giuridica italiana del primo dopoguerra, A. SCIUMÉ, Le oscillazioni del gusto giuridico: la certezza del diritto fra principia e regulae in Italia nella prima metà del Novecento, in «Roma e America. Diritto romano comune», 2013/34, pp. 93 ss.
99 Cfr. M. AMAR, Manuale della proprietà industriale, Milano 1900. In merito, E. FUSAR POLI, Centro dinamico di forze. I giuristi e l’innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia, Milano 2012, pp. 90-91.
Da preside, in una seduta del consiglio di facoltà del 1920, Pacchioni avrebbe anche fatto verbalizzare un’affermazione forse non del tutto comprensibile, se non si prestasse attenzione alla sua ricca e pluridiscipli-nare esperienza didattica: «…lo studio del diritto inglese può costituire valido rimedio contro l’idolatria per i metodi e modelli tedeschi, dei quali nessuno contesta l’alto valore, ma tutti oramai rilevano le esagerazioni sistematiche e l’esclusivismo ingiustificato»98.
L’insegnamento del diritto comparato, dunque, a titolo di materia complementare o di corso libero, era senza dubbio una ‘spia’ della circolazione culturale ampia e diversificata che caratterizzava alcuni atenei italiani fino alla prima guerra mondiale, al di là delle costrizioni dei piani di studio e della prevalenza dei metodi pandettisti.
A dimostrazione di un clima vivace di studi suscitati da impellenti esigenze pratiche, si può portare l’esempio anche di un altro insegna-mento, davvero nuovo, che induceva i docenti italiani a confrontarsi con la dottrina giuridica europea, non necessariamente pandettista: si tratta del corso di diritto industriale.
Agli inizi del Novecento, la materia detta ‘diritto industriale’ e non meglio definita altrimenti si insegnava solamente alla facoltà giuridica di Torino, dove Amar teneva un corso libero: i suoi argomenti di lezione erano la concorrenza sleale e l’antitrust (si occupava di consorzi e sin-dacati industriali, come forme di concorrenza esercitate individualmente o collettivamente, a danno di altri)99.
Come ben si comprende, l’università Bocconi, destinata a formare i futuri industriali, decise di istituire subito un corso con quell’intito-lazione: si trattava, però, qui, di un corso ufficiale, affidato dal 1904 al 1907 a Angelo Sraffa, prima sotto la dicitura ‘diritto commerciale e industriale’ e successivamente solo ‘diritto industriale’. Immaginato per coloro che un giorno sarebbero diventati imprenditori, l’insegnamento
309TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
100 Si conservano le dispense raccolte dagli studenti per l’a.a. 1906-1907: Diritto indu-striale: Università commerciale L. Bocconi, anno accademico 1906-1907, Appunti dalle lezioni del prof. Angelo Sraffa, Milano [1907].
101 In particolare, F. CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro, I, Roma 1913; ID., Studi di diritto industriale, Roma 1916. In merito, oltre a GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., pp. 125-128, v. G. CAZZETTA, Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro, in ID., Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra otto e novecento, Milano 2007, pp. 155 ss.; P. PASSANITI, Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920), Milano 2006, pp. 480 ss.
102 Corso speciale di legislazione del lavoro: anno accademico 1908-1909. Appunti raccolti alle lezioni del prof. Francesco Carnelutti dallo studente Attilio Scalabrini, Pavia [1909]; Diritto industriale: anno accademico 1909-1910. Lezioni del chiarissimo prof. avv. Francesco Carnelutti, [1910]; Diritto industriale pt. 2, legislazione del lavoro, anno accademico 1910-1911, lezioni del chiarissimo prof. avv. Francesco Carnelutti, Pavia 1911; Diritto industriale: 1911-1912, del chiarissimo prof. Francesco Carnelutti, Pavia, [1912]. In merito, rinvio a A. MONTI, La concorrenza sleale e gli esordi del diritto industriale nell’Italia liberale: verso una teoria generale della concorrenza?, in «Afferrare …l’inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento, a cura di A. SCIUMÈ, E. FUSAR POLI, Milano, 2013, pp. 130 ss.
103 Quando poi, nel 1915-1916, l’insegnamento bocconiano passa a Alfredo Rocco, i connotati del diritto industriale vengono parzialmente ridefiniti, secondo la sensibilità del nuovo docente che, pur apprezzando la sistematica «molto elegante» di Carnelutti, la ritenne artificiosa: Lezioni di diritto industriale, tenute dal chiarissimo prof. Alfredo Rocco al III e IV corso, Milano [1916].
del giurista toscano era incentrato sui temi dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dei brevetti di invenzione100.
Il medesimo corso, biennale, sarebbe in seguito passato a Francesco Carnelutti, che lo tenne dal 1908 al 1912 e, a sua volta, gli avrebbe conferito una fisionomia conforme ai suoi interessi di studio101, sud-dividendo la materia in due macro-settori: il lavoro ‘collaborativo’ e il lavoro ‘competitivo’. Le sue lezioni, perciò, si focalizzavano, in un primo tempo, sulla «legislazione del lavoro o legislazione operaia», conside-rata, appunto, una parte del diritto industriale, inteso quale complesso di norme che regolano i rapporti giuridici sorgenti dal lavoro, quindi sul diritto industriale vero e proprio, cioè della concorrenza, che com-prendeva la tutela delle opere dell’ingegno e dei beni ‘immateriali’102.
Lo sforzo del professore fu, evidentemente, nel senso di offrire agli studenti una sistemazione ‘scientifica’ agli argomenti esposti, dunque, benché si trattasse di materia i cui riferimenti culturali non erano nella pandettistica, fu comunque la tendenza al sistema a prevalere nell’orga-nizzazione formale del corso103. Ciononostante, nel merito, Carnelutti guardava a autori diversi, attenti alla prassi: al tedesco Kohler, agli avvocati
310 ANNAMARIA MONTI
104 P. PIC, Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières, IVème éd., Paris, 1912. Cfr. N. HAKIM, La science de la question sociale de Paul Pic ou les malheurs de l’hétérodoxie dans les Facultés de droit, in Le renouveau de la doctrine française cit., pp. 123-158.
105 Sui ‘rami’ del diritto, le ‘discipline’ e le ‘scienze’giuridiche, M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo [1940], in «Quaderni fiorentini», 1973/2, in part. pp. 182-183. Per il recentissimo dibattito sul tema, v. gli atti del convegno Qu’est-ce qu’une discipline juridique? Fondation et recomposition des disciplines dans les facultés de droit, Paris 28 et 29 janvier 2015, in corso di pubblicazione a cura di F. AUDREN e S. BARBOU DES PLACES per i tipi di Lextenso Editions, LGDJ.
106 T. TOMASI,L. BELLATALLA, L’Università italiana cit., pp. 129 ss. 107 Sulla disciplina dei concorsi universitari secondo la legge Casati e successivi rego-
lamenti e modificazioni: M. MORETTI, I. PORCIANI, Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo, in Annali di storia delle università italiane, 1997/1, pp. 11-39; G. FOIS, Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali dal 1860 ad oggi, in Storia delle Università in Italia cit., vol. I, pp. 461 ss.
francesi Pouillet e Allart, in tema di marchi, brevetti e concorrenza sleale; a un altro lionese, Paul Pic, per la legislazione industriale e del lavoro104.
I due esempi brevemente illustrati del diritto comparato e del diritto industriale paiono molto interessanti perché, se da un lato entrambe le materie sono considerate ‘nuove’ e dunque insegnate in corsi liberi e complementari, dall’altro, proprio attraverso l’attività didattica, le due discipline ‘sperimentano’ i loro confini, alla ricerca di uno statuto scientifico autonomo105.
E qui la storia dell’insegnamento del diritto si intreccia di nuovo con quella del pensiero giuridico, ma in una prospettiva in parte inedita, che consente di apprezzare l’ampiezza degli interessi culturali e scientifici dei giuristi italiani tra Otto e Novecento.
4. Conclusioni
All’oggettivo miglioramento della qualità dell’insegnamento giuridico registrato in Italia verso la fine del secolo XIX, oltre al rinnovamento metodologico operatosi nelle aule universitarie, contribuì la selezione per concorso nazionale dei professori, la valutazione fondata sulla pro-duzione scientifica e il numero chiuso degli ordinari 106.
Fu l’insieme di questi elementi a consentire un ‘ricambio’ nel corpo docente delle facoltà del Regno, rispetto ai decenni precedenti, favoren-do senza dubbio l’inserimento di forze nuove107. Ancora sopravviveva, però, al sorgere del XX secolo, la tendenza a ricoprire incarichi d’in-segnamenti diversi: si trattava di un uso risalente all’epoca in cui, nelle
311TRADIZIONE E RINNOVAMENTO NELLA DIDATTICA GIURIDICA
108 M.G. DI RENZO VILLATA, Angelo Sraffa a Giurisprudenza: tra Parma, Torino e Milano, in Angelo Sraffa, a cura di P. MARCHETTI, M.A. ROMANI, Milano 2009, pp. 21-23.
109 MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento cit., p. 9; ID., La cultura degli avvocati in Italia nell’età liberale, in Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura, a cura di G. ALPA e R. DANOVI, Bologna 2003, p. 88. Cfr. inoltre L. MUSELLA, Amici, parenti e clienti. I professionisti nelle reti della politica, in Storia d’Italia, Annali, 10, I professionisti, a cura di M. MALATESTA, Torino 1996, pp. 593 ss.; M. MALATESTA, I professionisti, in Le élites dell’Italia unita, a cura di G. MELIS, Napoli 2003, spec. pp. 31 ss.
110 Sul punto, con preziose indicazioni su circoli giuridici, seminari e vari organismi didattici sorti presso molte università italiane a fine Ottocento, F. TREGGIARI, Scienza e insegnamento del diritto cit., pp. 122 ss.
singole università, la didattica si reggeva su pochi professori generalisti, pronti a impartire diversi corsi e a insegnare materie differenti.
In proposito, si è potuta già osservare una certa frequenza nei pas-saggi tra gli insegnamenti di diritto commerciale e di procedura civile: Alfredo Rocco e Angelo Sraffa ne sono due esempi all’Università di Parma a fine Ottocento108. Ben comprensibile è, poi, la contiguità e l’in-terscambiabilità tra gli insegnamenti di diritto privato e romano, i corsi fondamentali, impartiti seguendo le dottrine tedesche: qui si trattava, infatti, di una precisa scelta d’indirizzo scientifico.
Con il progressivo miglioramento della preparazione specialistica dei docenti, dunque, la prassi per cui i professori si trasferivano con agilità da un insegnamento all’altro si mantiene: forse un retaggio del passato, forse una necessità imposta dal numero chiuso del ruolo accademico, oppure il segno, ora, di giuristi con una visione ampia della loro ‘scienza’ e dei suoi metodi, pronti a cimentarsi in svariati settori.
Soprattutto, i professori ordinari e straordinari titolari di cattedra, che spesso coniugavano l’attività di docenza con l’esercizio dell’avvo-catura e l’impegno politico, secondo una particolarità tutta italiana109, potevano sempre chiedere che fosse loro assegnato un corso libero – da aggiungere a quelli impartiti dai liberi docenti – se desideravano cimen-tarsi con una materia diversa dalla curriculare, di loro stretta pertinenza.
Ciò, come visto, arricchiva l’offerta formativa dei piani di studio e tem-perava in qualche misura la ‘rigidità’ dei curricula, via via delineati dai diversi regolamenti ministeriali110. Inoltre, la didattica italiana si allineava così a quella europea continentale più «moderna», procedendo spesso per sperimenta-zioni e attingendo a mezzi diversi, senza disdegnare un certo sincretismo.
La dottrina giuridica di quell’epoca che si sarebbe tristemente chiusa con la guerra europea, in effetti, sembrava particolarmente propensa a
312 ANNAMARIA MONTI
* Il presente contributo sviluppa i contenuti della relazione dal titolo «‘Tradition’ and ‘changes’ in the teaching of law in Europe: the turn of the 20th century», discussa a Macerata l’8 luglio 2014, in occasione della terza conferenza internazionale della European Society for Comparative Legal History.
recepire le novità proprio nell’insegnamento e attraverso l’insegnamento: solo un’indagine su vasta scala, che prenda in considerazione i corsi attivati nelle varie facoltà giuridiche del Regno, le materie libere, le eventuali dispense litografate o a stampa, i manuali adottati, le attività didattiche complementari dei seminari e dei circoli, insomma, tutto ciò che concerneva l’attività dei docenti e degli studenti, potrà però suffragare queste prime riflessioni.

































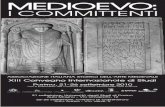


![Due periodici per un nuovo sindacalismo: “Il Rinnovamento” e “L’Italia nostra” fra classe e nazione [2003]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319157dbc8291e22e0ef019/due-periodici-per-un-nuovo-sindacalismo-il-rinnovamento-e-litalia-nostra.jpg)