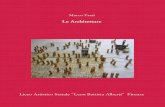“L’artista reagisce in modo artistico. Questa è la sua arma”. Riflessioni di valore...
Transcript of “L’artista reagisce in modo artistico. Questa è la sua arma”. Riflessioni di valore...
1
“L’artista reagisce in modo artistico. Questa è la sua arma”. Riflessioni di valore
introduttivosulrapportoarte‐Shoah,daAlexanderBogeneNathanRapoportaRichard
Serra
Appendice documentaria: Paolo Coen, Intervista ad Angelika Schallenberg sulla
SinagogadiStommeln
PaoloCoen
AdEdith,mioamoredisempre
IllibroraccoglieisaggidedicatialrapportofralaShoahconl’arteedilMuseonell’arco
di tre anni, in occasione di altrettanti incontri che si sono svolti all’Università della
CalabrianelleGiornatedellaMemoriadel2008,del2009edel2010.Fraquestisaggiè
possibile cogliere quattro temi portanti. Il primo tema s’incentra sullo studio della
tradizione figurativa di matrice razzista e ancor più antisemita in età storica. Vi
appartengonoabuontitoloisaggidiAnnaSereniediCarloStefanoSalerno.LaSereni‐
espertadiantichitàpaleocristianeealtomedievali‐mettepreliminarmenteinevidenza
alcuneparticolarifigurazionidellaculturaoccidentaleche,pertinentiaunarcoditempo
che va dal primo fino al diciannovesimo secolo, si contraddistinguono appunto per la
valenza razzista e antisemita. L’autrice da un lato impiega questo portfolio a fini
didattici,ovviamenterovesciandoneilsegno,dall’altrostabilisceunintreccioconalcune
vicendepersonali,moltedellequalisiriannodanoallavitaeall’attivitàdisuopadre,lo
studiosoeduomopoliticoEmilioSereni.CarloStefanoSalernomettea fuoco i legami
esistenti fra la tradizione figurativa antisemita, in particolare l’iconografia del ‘perfido
Ebreo’,eilmondodellafisiognomica,unadisciplinafioritainItalia‐enonsolo‐specie
nel sedicesimo secolo, anche grazie ai contributi di Leonardo da Vinci, Pomponio
Gaurico,GirolamoCardanoeGiovanBattistaDellaPorta.
IsaggidiPaoloCarafaediRitaBorionirientranoinunasecondalinea,intesaad
analizzarel’incidenzadellecampagnerazzisteantisemitenell’arteonellaculturanelsuo
complesso.Ilprimostudioso,tornandoarifletteresualcunicontributiprecedenti,quali
adesempioisaggidelfranceseAlainSchnapp,stilaunbilanciodell’incidenzadelleteorie
razzistenel campodell’archeologiaeuropea tra la finedell’Ottocentoe laprimametà
2
delNovecento,conparticolareriguardonaturalmenteperilmondogermanico.Ilcampo
d’azione di Rita Borioni è l’industria culturale italiana tra gli anni Venti e i primi anni
Quarantadel ventesimosecolo: la suaprincipaleattenzione sono imondidel cinema,
dell’editoria e appunto dell’arte figurativa, dei quali sono posti in evidenza i
collegamenti, i momenti di continuità ma anche alcune situazioni per certi versi
addiritturadesuete,comeperesempioilcontegnodiFilippoTommasoMarinetti.
Un terzo filone di studi è rappresentato da saggi volti ad approfondire le
discriminazionisubitedaalcunespecifichepersonalitàdelcosiddettosistemadell’artea
ridosso delle Leggi Razziali del 1938 ed ancor più nel corso della Seconda Guerra
Mondiale.Duecontributi affrontano il casodiAntoniettaRafael, la scultricediorigine
lituana prima compagna e poi moglie del pittore Mario Mafai. Benché abbiano in
comune il tema, i due scritti partono in realtà da punti di osservazioni diversi e si
prestano volentieri ad una lettura ‘allo specchio’. Giulia‐Giuditta Mafai testimonia
l’impattodevastantedellecampagneantisemitesuun’interafamigliadiartisti.Almeno
nellorocasolaviadiscampo‐nonsolointerminifisici,maancorpiùpsicologici‐risiede
nella cultura e nell’ironia: quanto simili difese alla lunga possano rivelare buchi e
conseguenti rattoppi è dimostrato poi dalle ansie diGiulia nei confronti del nipotino.
Isabella Calidonna offre un saggio di taglio critico. Partendo da quanto già scritto in
passato ‐ per esempio da Fabrizio D’Amico, Maurizio Fagiolo ed Enrico Crispolti ‐ la
giovanestudiosacalabreseripercorreiltragittodellaRafaelallalucedelleesperienzedi
discriminazione vissute fin dagli anni della Lituania. Teresa Cicciarella si occupa di
CorradoCagli:ellarendecontoinparticolaredelclimadicrescenteostilitàincontratoda
CaglinelloscorreredeglianniTrentafinoal1940,annoincuièsostanzialmenteforzato
a trasferirsi in Francia. Con Laura Iamurri il lettore incontra Claude Cahun e dunque
lascia l’Italia per entrare in un più ampio contesto europeo. Il saggio ricostruisce
l’universodiCahune insiemequellodiSuzanneMalherbe‐suacompagnadiarteedi
vita ‐ negli anni successivi al 1939, allorché nella remota isola di Jersey, fra la Gran
Bretagna e la Francia, le due diedero vita a strenui e per certi versi curiosimetodi di
resistenza all’occupazione nazista. Due saggi, l’uno a nome di Paola Nicita, l’altro di
MariaMignini,pongonoinevidenzainonmenogravieffettidellemisureantisemitesul
pianodellastoriaedellacriticad’arte.QuellodiPaolaNicitaeleggeprotagonistaGiorgio
Castelfranco: Direttore della Galleria d’Arte moderna di Palazzo Pitti e come tale
3
licenziato in tronco perché ebreo nel 1938, anno della visita a Firenze di AdolfHitler,
Castelfranco durante e dopo la Liberazione dell’Italia da parte delle truppe alleate
partecipaconRodolfoSivieroaunaseriediepisodiditutelapercertiversieccezionali.Il
contributodiMariaMigniniricostruiscelevicendediduestudiosedirango,Paoladella
Pergola e Fernanda Wittgens, nel 1938 a loro volta costrette in quanto ebree ad
abbandonareilororispettiviruoliall’internodell’AmministrazionedelleBelleArti.
Ilquartoedultimosegmentodelvolumesimisuracongliannisuccessivial1945,
finoal contemporaneo.BeatriceCirulli sulla sciadiuna seriedinovitàdocumentarie‐
riportate nella relativa appendice ‐ riannoda la complessa trama storica relativa alle
commissioniartisticheper ilmemorialedelleFosseArdeatine,aRoma.SiaAlessandra
BertolèVialecheCristianaCoscarellavertonosultemadelMuseo.Lastudiosamilanese
affondailbisturiinuncasoestremamentedibattuto,ilMemorialedegliEbreiassassinati
di Berlino, fornendo a chi legge il filo conduttore delle molte polemiche dietro alla
realizzazionedelprogettodiPeterEisenman.CristianaCoscarellaintreccia l’attualitàdi
Auschwitz con alcuni fra i piùmodernimusei della Shoah, i due a Berlino, lo United
States Holocaust Memorial and Museum di Washington e infine Yad Vashem a
Gerusalemme.
Ricordo la notte di fine novembre in cui la radio
annunciò che le Nazioni Unite in America, in un
posto chiamato Lake Success, avevano deciso di
lasciarci fondare uno stato ebraico, piccolissimo in
effetti e composto di tre pezzi separati. All’una di
nottepapàtornòdacasadeldottorBuster,dovesi
eranoriunitituttipersentirechecosaavrebbedetto
la radio dei risultati del voto per la mozione
dell’ONU,sichinò,miaccarezzòconlamanocaldail
visoedisse:
“Sveglia.Sveglia.Nondormire”1.
1 Il branodiAmosOz,al paridei prossimiquattro che intervallano il saggio, sono trattidaUna
panteraincantina,Feltrinelli,Milano2010,pp.144‐145.
4
18dicembre1940:FranciszecTargoszfailsuoingressonelcampodiconcentramentodi
Auschwitz2. Da allora semplicemente chiamato “prigioniero 7626”, come indica il
tatuaggio bluastro sull’avambraccio, nel giro di poche settimane l’artista polacco non
tardaamettersiinmostraperunaseriediepisodimoltoparticolari.Inqualitàdipittore
professionista Targosz sa disegnare ed anche molto bene, specie quando si tratta di
cavalli,comedimostrafral’altrounsuoschizzoogginelMuseoNazionalediAuschwitz3.
Così,nonostante l’eserciziodel disegnoodiqualunquealtra formadiattivitàartistica
sianoproibiti,ilsuotalentoglipermettediaversalvalavitaediesserenotopersinoal
comandantedelcampo,RufolphHöss.
Ancorpiùparticolare, inognimodo,è il temadellaconversazionechesisvolge
fra Targosz e Höss nei primi mesi del 1941, adibire una delle baracche del campo a
museo d’arte4. In teoria, tutto sembra giocare contro il progetto. Basti solo riflettere
sulla scarsezza delle baracche disponibili, per via del sovraffolamento dei prigionieri.
Nonacaso,giustopersmaltiregliinternatiineccessodilìaqualchesettimana,ilprimo
marzodel1941,HeinrichHimmlerinpersonastabiliràlarealizzazioneapochichilometri
daAuschwitzdiunsecondo,ancorpiùestesodistaccamento,AuschwitzII‐Birkenau,che,
organizzatosempredaHöss,entrerà in funzionenell’ottobredel1941.Ciònonostante,
Höss approva subito l’idea, segnando la nascita del Museo d’arte di Auschwitz, con
responsabileappuntoTargosz.Nellesettimanesuccessivel’artistasimetteallavoro.Da
un lato allestisce la baracca ‐ ossia il contenitore ‐ che viene sgombrata daimobili e
ripulita.Dall’altrosidàdafareperprodurreleoperedestinateadornarnel’interno:per
2SuTargoszcfr. J. Javorska,Niewszystekumre, Ksiaka iWiedza,Warsawa,1975,ad indicem;S.
Milton,FranciszekTargosz,inJ.Blatter‐S.Milton,ArtoftheHolocaust,Rutledge,London1981,p.
266.3J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,pp.207,266,fig.311.4 J.Blatter,Art fromthewhirlwind, in J.Blatter‐ S.Milton,op.cit.,p.20;KunstzumÜberleben:
Gezeichnet in Auschwitz, catalogo della mostra (Oswiecim, 1989), a cura di S. Goldmann ‐ M.
AdamsRösing,SuddeutscheVerlagsgesellschaft,Ulm1989,passim.
5
fareprima,egliottiene l’autorizzazionedi chiamareaccantoa séacuni colleghi, come
peresempioloscultoreXaveryDunikowski,unadelleglorieartistichedellaPolonia.
Inizialmente il Museo di Auschwitz si limita a contenere pezzi d’arte
contemporanea, realizzati come si è detto vuoi da Targosz, vuoi da suoi amici. Nella
maggior parte dei casi le iconografie riconducono alla cosiddetta ‘arte di comando’.
Oltreaicavallieccodunqueritrattidegliufficialitedeschi,paesaggieinfineillustrazioni
dellevirtùdelVolkodeimitiprimordialigermanici.Iltuttoricalcailbennotostilefrail
realisticoedilsentimentalepredilettodaHitlerfindaglianniTrentaesuccessivamente
divenutotipicodell’interoregimenazista.Inunsecondomomentosuquestonucleose
neinnestaunsecondodinaturaaffattodiversa,costituitodaoggettidiartigianatoodi
folklore sottratti agli internati ebrei, come per esempio monete antiche, libri di
preghiera, scialli e filatteri. La loro presenza obbedisce a motivazioni di ordine
antropologico‐etnografico.Negli occhi dei committenti e del pubblico questa seconda
categoriadioggetti servecioèa documentareunaciviltà cheallora si ritiene invia di
scomparsa. La visita è infatti rigidamente limitata al personale di sorveglianza e agli
ufficialitedeschi,sitrattideiresidentistabiliodeidignitariinvisita.
Rimastooperativofinoal1943,ilMuseoartisticoedetnograficodiAuschwitzsi
configura come un episodio di straordinario significato. In primo luogo, molto
semplicemente, esso concede la possibilità di restare in vita a un discreto numero di
artisti, a cominciare proprio da Targosz. Esso poi attesta la capacità dell’arte di farsi
stradaancheincondizionidisperate:comehachiaritofral’altroPninaRosenberg5,non
ha difatti importanza, sotto questo profilo, che si tratti di ‘arte di comando’, ossia di
lavori ove tutto, dalle iconografie al trattamento pittorico, è volto a compiacere gli
addetti alla sorveglianza, il comandante Höss o i dignitari nazisti in visita, anziché il
‘gusto’ o le inclinazioni dell’artista. Infine e soprattutto, l’episodio è di rimarchevole
valore per il contesto e i modi attraverso cui le opere sono concepite, prodotte e
collezionate. Va qui sottolineato come i quadri e le sculture realizzati da Targosz e
5 Cfr. P. Rosenberg, Art of the Holocaust as spiritual resistance. The Ghetto Fighter’s House
collection, inThe lastexpression:artandAuschwitz,catalogodellamostra(Evenston,Wellesley,
New York, 2002‐2003), a cura di D. Mickenberg, C. Granof, P. Hayes, Northwestern University
Press, Evenston 2003, pp. 88‐93, reperibile anche su
http://lastexpression.northwestern.edu/essays/rosenberg.pdf.
6
compagninonsianodestinatiallafruizionesingola,nétantomenoadabbellire lecase
degliufficiali,rendendolemagarisimiliaquellecheavevanolasciatoinGermania,come
sileggeinuncelebreraccontodiSavyonLiebrecht6.Nienteaffatto.Dallaconversazione
fraHösseTargoszvienefuoriunmuseoveroeproprio,cioèun’istituzionecollegataa
quell’insieme di requisiti, funzioni e valori che dal diciottesimo secolo in poi erano
divenuti parte stabile della tradizione occidentale: a cominciare naturalmente dalla
necessità pubblica di cultura e di bellezza, sia pure in questo caso riconosciuta a una
partemoltoristrettadellacollettività.
Lacosanondeveaffattostupire.Entrambiicapidellaconversazionepossiedono
adeguatistrumenticulturaliedunquesannoperfettamentedicosastianoparlando.Ciò
valeinnanzituttoperTargosz,cheperquantooriginariodiLipnik,unapiccolafrazionedi
Bielsko‐Biala, in seguito aveva avuto l’opportunità di formarsi a Vienna, una città di
straordinario livello artistico e museale. Quasi altrettanto vale per Höss, senza che
questo significhi trasformare un uomodedito fondamentalmente all’azione in un fine
intellettuale:cosìalmenoindicano lesuememorieautobiografiche,che,usciteinItalia
coniltitolodiComandanteadAuschwitz,attestanounapienaecontrollataarticolazione
del pensiero7. Ora, nell’utilizzare in senso proprio la parola e il concetto di Museo,
TargoszedHösschiamanoincausaunamatricecomune,contraddistintadaaddentellati
significanti tanto complessi quanto precisi. Il principale è certamente il concetto di
“memoria”,ched’altrocantoancheinterministoriciedetimologicisilegastrettamente
alla natura di questa istituzione.Nel pieno dello sterminio due entità contrapposte ‐
l’aguzzino e il condannato ‐ si uniscono o almeno trovano un’ideale comune nella
costruzionedellamemoria.PerchéesattamentequestoèperantonomasiailMuseo:la
macchina inventata dall’Uomo occidentale per plasmare, indirizzare la memoria
collettiva.
Prima di proseguire è giusto a questo punto sfatare una lettura abbastanza
comune.Com’ènoto,partedeglistudiosihagiudicato l’episodio inquestionefruttodi
circostanzecasualieallimitebizzarre.Secondoquestalettura,Targosz,sorpresomentre
di nascosto disegna un cavallo, tirerebbe fuori l’idea delmuseo solo per sfuggire alla
punizioneesalvarsilavita,piùomenocomeunconigliouscitodalcappelloacilindrodi
6S.Liebrecht,Meledaldeserto,Edizionie/o,Roma1991.7R.Höss,ComandanteadAuschwitz,Einaudi,Torino1997.
7
un prestigiatore; implicitamente, la stessa lettura ritiene che Rudolph Höss sia allora
vittima di un inganno e dunque lo confina entro i limiti della dabbenaggine8. Com’è
facile vedere, tale visione rientra a pieno titolo in quell’interpretazione della Shoah
secondocuigliEbreinonostantetuttoconservanounapienasuperioritàintellettualesu
Hitlere sugli aguzzininazisti,quasi immancabilmente ridotti amacchiette crudeli:uno
stereotipo che viene diffuso dagli anni Trenta del Novecento attraverso imedia più
disparati,daifumettiaglisceneggiatitelevisive,dalcinemaallaletteraturapopolare.
Nonè certoquesta la sedeperentrare inmeritoaundiscorsocomplessivo su
talefenomeno,asuavoltaperaltrovenatodaunafortecaricarazzista,siapuredisegno
invertito rispettoaquelladellapropagandadel regimediHitler. Edunquea suavolta
pericoloso.Rientrandocosìnell’alveospecificodelsaggio,vasolonotatocomeapplicare
talevisioneequivaleatradirelecircostanzerealieilprofilostoricodeiprotagonisti.Si
guardi inprimo luogoalcomandantediAuschwitz.Hössèquelchesidiceunufficiale
tedesco impeccabile.Pluridecoratosulcampo, findagiovanesieramesso inevidenza
conisuperioriperiltenaceattaccamentoallacausanazista,lecapacitàdiorganizzareil
lavoro e l’eccezionale pragmatismo nel risolvere i problemi di carattere operativo.
ProvenientedaSachsenhausen,eglieragiuntonellaprimaveradel1940adAuschwitz‐
quandosostanzialmenteognicosaeraancoradafare‐edaveva impostofindasubito
una visione strettamente funzionale. Il 14 giugno sulla banchina ferroviaria si era
arrestatoiltrenoconall’internoilprimocarico,settecentoventottodeportati.Nelcorso
dei mesi estivi Höss aveva portato avanti a tappe forzate il progetto esecutivo del
crematorio,entratoeffettivamente in funzionenella secondametàdi settembre.Non
basta. Ancora ad Höss si deve l’impiego dello Zyklon B nelle camere a gas, al fine di
rendere lo sterminio più rapido ed economico, che, inizialmente suggerito dal suo
aiutanteKarlFritzsch,benprestodiventerà laprocedurastandard indiversicampi, fra
cuiMaidanek. InunuomodelgeneredotareAuschwitzdiunMuseod’artesignifica in
primo luogocreare qualcosadi cuipotersi vantare con i superiori, in particolare con i
gerarchi nazisti in visita.Nulla esclude tuttavia l’esistenza di altremotivazioni, di altri
obiettivi.IlsensopiùprofondodelMuseosembrainfatticonsisterenellacostruzionedi
una memoria ‘in negativo’ o, per così dire, di una sorta di ‘contromemoria’. Il
comandante, cioè, non solo devolve a beneficio del regime nazista la nota carica
8J.Blatter,op.cit.,p.20.
8
ideologica delMuseo,madecide di farlomettendo a frutto il talento, le qualità ed il
lavorodelpopoloebraico.Inaltritermini:fasìcheilnemicostessocostruiscalebombe
destinate poi a colpirlo. Ma in fondo il potere dell’arte non risiede appunto nel
trasformare larealtà?Sispostiora losguardoversoTargosz.Asuoperfettoagioconil
meccanismobasedelMuseo,valeadirecon lacostituzionedellamemoria,eglicalibra
ed impiega a suo vantaggio l’intero campo di forze del suo mestiere d’artista,
dimostrandodisaperne intendereallaperfezione ilsensoultimo.Egli capiscecioèche
musealizzare l’orroreattraverso l’arteèun’idea talmentefortedatravalicare lastessa
esistenzafisica,sitrattidellapropriaodiquelladelnemicoHöss.L’orroreriesceinfatti
ancor più dirompente proprio perché all’interno della baracca si cerca di addolcirlo,
glassarlo,reprimerlo.Altrocheescamotage;altrocheuomoinfuga.
Alla stregua di un moderno vaso di Pandora, il Museo di Auschwitz, quando
apertoeinterpretatonelmodocorrettoforniscel’ideadellaquantitàedellacomplessità
degli interrogativi connessi al binomio arte‐Shoah. Rispetto a quanto riscontrabile
altrove,inquestosaggioilbinomioverràconcepitoinmodointenzionalmentelimitato,
osesivuoleaddirittura‘tecnico’.D’orainavantisiporrannocioèsottoquestosegnole
opere che si ispirano, che traggono la loro sostanza da quel preciso episodio storico
dettoormaicomunementeShoah.Daunlatoeccodunqueilavorieseguitidaartistiche
vivonoochevedonopersonalmenteighettiedicampidisterminio:echetalora,come
ilfrancesePierreMania,perfareunsoloesempio,continuanoarealizzareopereatema
ancheamolti annidall’accaduto.Dall’altrovengonoquipresi in considerazioneanche
lavori eseguiti dopo il 1945 come risposta alla Shoah: una risposta che è possibile
riscontrarenelleultimegenerazionidiartisti,ebreiononebrei,attraversovarieforme
diricordoeditrasmissionediconoscenza.
Miraccontòconunavocedatenebracom’eraquandoluie
mammaeranoduebambini vicinidi casa inunacittadina
polacca.Dellamarmagliachelitormentavaincortile,cheli
picchiavabrutalmenteperchégliebrei,dicevano,sonotutti
ricchi,truffatorieaffaristi.Ediquellavoltacheinclasse,al
ginnasio,l’avevanospogliatodiforza,davantialleragazze,
9
c’era anche mamma, per prenderlo in giro perché era
circonciso.
L’arte della Shoah, anche ristretto il campo a pittura, plastica e grafica ‐ e dunque
escludendo con un taglio deliberato la fotografia, il cinema e il documentario, come
purel’architettura‐contasuunnumerodimanufattiestremamentecongruo,stimabile
inalcunedecinediunità.Moltipossonoconsiderarsiunaliberaespressionedell’artista,
vale a dire senza che a monte vi siano una commissione ed anche un pubblico di
riferimento.Questogeneredi lavoriappartieneallasferapiùintimadell’individuo,che
attraverso la professionalità e la gestualità che gli sono proprie oggettiva, comunica,
affermaquantoaccade intornoedentrodi sé. Farearte, in condizioni spesso terribili,
diviene intalmodoun’attività irrinunciabileeassumeunavalenzaesistenziale,perché
significa continuare a sentirsi vivi e parte della specie umana. Su questa base ogni
ostacolo,ognirischiopossonoesseresuperati.AlexanderBogen9,originariodiDorpt,in
Lituania,dal1936sieraspostato inEstoniaperstudiarepitturapresso l’Accademiadi
Vilna.Quinel1940viene imprigionatoerinchiusonelghetto.L’artista,notoper ilsuo
caratterefieroe intraprendente,nelgirodiqualchemeseriescetuttaviaadevaderee
9 Su Bogen, morto nel 2010 in Israele e qui considerato un eroe nazionale, cfr. Kunst und
Widerstand.Malerei,Plastik,Graphik,von1922bis1945,acuradiE.Frommhold,VEBVerlagder
Kunst, Dresden 1968,passim; A. Bogen,Revolt: Hamered, catalogo dellamostra (Beit Lohamei
Hagetaot ‐ Jerusalem, 1974), Yad Vashem, Jerusalem 1974; Spiritual resistance 1940‐1945. Art
fromtheconcentrationcamps,catalogodellamostra(Baltimore,1978),acuradiL.Dawidowicz,
M.Novitch,T.L.Freudenheim,TheBaltimoreMuseumofArt,Baltimore1978;M.Novitch,Spiritual
resistance. Art from the concentration camps 1940‐1945. A selection of drawings and paintings
from the collection of kibbutz Beit Lohamei Hagetaot, Israel, Union of American Hebrew
Congregations,Philadelphia1981,adindicem;M.Costanza,Thelivingwitness:artinconcentration
campsandghettos,FreePress,NewYork1982, inparticolarep.XVIII;A.Bogen,AndIneverput
mypencildown,inWithproudbearing,1939‐1945:ChaptersinthehistoryofJewishfightinginthe
NarochForests,acuradiM.Kalcheim,TheOrganizationofPartisans,UndergroundFightersand
Rebels in Israel, Tel Aviv 1991; S. Heller,Bogen as a shaper of cultural memory, inAlexander
Bogen.DrawingsforpoemsinYiddish,catalogodellamostra(Haifa,2003),acuradiS.Heller,The
HechtMuseum,Haifa,2003;P.Rosenberg,ArtoftheHolocaustasspiritualresistance...,cit.
10
dallo stesso 1940 vive come clandestino emembro della resistenza nelle foreste che
circondanolacittà.Nel1943AlexanderBogendiventacapodiVendetta,oNekama,una
brigataebraicadipartigianiilcuiobiettivoprincipaleconsistenelliberarealtriebreidal
ghetto e, come tale, responsabile di una serie di azioni ad alto rischio contro le forze
naziste. Lungo tutto l’arco della guerra, si trovi in prigionia oppure in clandestinità,
Bogen continua a disegnare senza interruzione. Schizzi come ilBambino del ghettodi
Vilna, firmatoedatato “Bogen [19]43”10 (fig.1), rappresentano labasedel cosiddetto
Diario d’artista, oggi diviso fra Yad Vashem a Gerusalemme e Lohamei Hagetaot, la
GhettoFighter’sHouse,anorddiAkko:
Dapartigiano‐ricorderàBogenaguerrafinita‐mentremirecavoinmissionerealizzavoschizzi
diqualunquecosa,nonimportasefossipiegatosull’armaoppuresdraiatoinattesadicoglierei
nemici in un’imboscata. Disegnavo il bosco, i miei compagni e alle volte persino la battaglia
stessa.Nonvieranoiltavolo,nécarta,nématitecolorate.Avevotrovatodellacartadapacchi;
con alcuni stecchi di legno preparai del carboncino per realizzare degli schizzi. (...) Inoltre
collezionavopezzidicartaperdisegnarvisopra.
(...) Questi disegni rappresentano un grido d’angoscia. Sono fatti in pochi secondi, talora
addiritturamentrestavocamminando.Maperchéunuomo ingravepericolodovrebbecreare
arte?Perun’artista, l’impulsodi creare epiùpotentedell’esistenzastessa.Gli schizzi vennero
dunquefattiattraversoilsubconscio.
(...) Nel chiedermi perché continuavo a disegnare mentre stavo combattendo giorno e notte
[realizzaiauncertopunto]chesitrattavadiqualcosadisimileaunacontinuitàbiologica.Ogni
uomoèinteressatoadarecontinuitàalpropriopopolo,allapropriafamiglia,adareunfuturoai
proprifiglieperciòalasciarequalcosadietrodisé.
(...)Ogniuomoquandositrovafacciaafacciaconunpericolocrudele,conlamorte,reagiscea
suomodo.L’artistareagisceinunmodoartistico.Questaèlasuaarma.Questodimostraanche
cheitedeschinonpotevanodistruggereilsuospirito11.
Inunaletteradel10luglio1944ilgiàmenzionatoDunikowskydichiaraaunamico:“Mi
sentofinalmentemeglio.Per laprimavolta inquattroannimiètornato ildesideriodi
10S.Milton‐J.Blatter,op.cit.,p.127,n.167.11A.Bogen,AndIneverputmypencildown...,cit.,p.35.
11
disegnare(...).Lavitaunavoltaancoraacquistasignificatoescopo”12.Lecoseineffetti
noneranoandatesempreinquestomodo.Natonel1875eunanimementeritenutouno
deipiùimportantiscultoripolacchi,Dunikowskydopol’arrestodapartedellaGestapoe
ilsuccessivotrasferimentoadAuschwitz,avvenuti rispettivamente il 15maggioe il26
giugnodel1940,era infattipiombato inuno statodiprofondaprostrazione.Neppure
l’invito di Targosz a far parte dell’impresa del museo era riuscito a smuoverlo. “Ad
Auschwitzeromortoenonriuscivoacombinarenulla”‐dichiareràpiùtardiloscultore.
Colpito dal tifo e perciò tradotto in infermeria, Dunikowsky dopo una serie di
vicissitudinicheloportanoaunpassodall’esecuzioneauncertopuntoricevel’incarico
direalizzareunmodelloinscalaridottadelcampo13eperquestovienedotatodicarta,
inchiostroecolori.Benprestoeglituttaviainiziaautilizzaredinascostoquestimateriali
peraltriscopi,comeperesempioritrarreicompagniinternati14.Alcunediquesteopere
si conservano all’interno della “Królikarnia” la storica “casa dei conigli” di Varsavia,
divenutanel1965sededelmuseopersonaledell’artista.UnbuonesempioèilRitratto
diinternatodisteso,ungrandefoglioapastellodel1944chenellasuaeccellentequalità
mostra,nellaposainqualchemodorodinianaidebitidell’artistaversounastilizzazione
dimatriceespressionista15.
AltreoperedellaShoahprevedonol’esistenzadiunpubblico,cioèdialmenoun
destinatario che ne apprezzi le qualità estetiche o almeno storico‐documentarie. È
questoperesempioilcasodiFranceAudoul16.NataaMartinonnel1894daunafamiglia
di artisti lionesi, l’Audoul allo scoppio della guerra entra nella resistenza. In quanto
partigiana, nel 1943 viene arrestata dalla Gestapo e tradotta nel campo di
concentamento di Raversbrück. Da allora ella disegna tutto quanto le è possibile
osservare,dasingoli ritrattidi internateascened’insiemerelativamentecomplesse.Il
disegno dal titolo Dépouillées et tondues (fig. 2) ‐ ossia Spogliate e tosate ‐ (Parigi,
Bibliothèque de la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et
12LacitazionesitrovainJ.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.202.13S.Milton,Dunikowsky,Xavery,inJ.Blatter,S.Milton,op.cit.,p.246.14J.Blatter,op.cit.,p.20.15J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.202.16F.Adoul,Ravensbrück:150.000FemmesenEnfer,Paris1968;J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,pp.
240‐241.
12
Patriotes), eseguito ad inchiostro su carta fra il 1944 e il 194517, mette in rilievo la
formazioneclassicistadell’artista,inqualchemisuraaccostabileaquelladiunPuvisde
Chavannes, ma anche la sua capacità di aggiornarsi sulle correnti espressioniste, a
partiredaiFauves.
Vi sono circostanze ove l’esercizio dell’osservare e del documentare assume il
crismadell’ossessione.CosìaccadeperesempioaBorisTaslitzki18,oancoraadAuguste
FaviereaPierreMania,soprattuttoneigiornisuccessiviallaliberazionediBuchenwald.
Daquelmomentoiduesirendonoinfatticontochelaloroesperienzacorreilrischiodi
esseredimenticata,piùomenosecondoleprevisionideinazisti,edunquevannoingiro
ritraendoognicosapossibile.RicordaChristianPineau:
Vidi entrambi, sia Favier cheMania, camminare attraverso il campo conpezzi improvvisati di
cartaematiterabberciateetratteggiareoraunasilhouette,oraunapartedellabaracca,oraun
cadavere.Nonavevanopiù‐nonavevamopiù‐unsensodiorrore,perchécisiabituaatutto,
ancheallamorte.Eranoitestimoni19.
L’istanza documentaria contraddistingue i cosiddetti ‘primi osservatori’, vale a dire in
quegli artisti che fanno parte delle truppe alleate al momento della liberazione dei
campi.Conscidel loromandato,costoroadottanodisolitotecnicheecriteridi ripresa
paragonabili a quelli dei colleghi fotografi e cineoperatori, ovvero riportano ogni
elemento utile a rendere l’informazione veridica e al limite inconfutabile, senza che
questo naturalmente pregiudichi in alcun modo la qualità finale della loro
17J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.162,n.231.18Sull’artista,conparticolareriferimentoalleoperecheritraggonoilcampodiconcentramentodi
Buchenwald, cfr. B. Taslitzky,111 Dessins faits à Buchenwald 1944‐1945, Association Française
Buchenwald‐Dora,Hautefeuille,Paris1978;R.Arnould,L’hommenedoitjamaiss’avouervaincu,in
“LeSerment”,1980,n.132,pp.8‐12;S.Milton,Taslitzky,Boris,inJ.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.
266; Boris Taslitzky. Dessins faits à Buchenwald, Biro, Paris 2009, in particolare il saggio di L.
Richard, Soumission et insoumission au réel, alle pp. 232‐237 e quello di C. Cognet, Les yeux
ouvertssurlarealité,allepp.238‐239.19C.Pineau, Introduction, inA.Favier‐P.Mania,Scènesprissur levifdeshorreursdeshorreurs
Nazies(...),Lyon1946.
13
interpretazione. Sinowi Tolkatschev20, arruolato nell’esercito sovietico, è fra i primi ad
entrareneicampidiMaidanekediAuschwitz,rispettivamentenellugliodel1944enel
gennaiodel1945,dacuitraealtrettanticicligraficiintitolatiappuntoMaidanekeIfiori
diAuschwitz.Unpostod’onoremeritapoiCorradoCagli.Cagli,natonel1910inAncona,
aveva raggiunto il successo nel corso degli anni Venti e Trenta, per esempio con i
mosaici per la fontana di Terni, databili al 1935‐1936.Divenuto bersaglio della critica
militantefascista,all’indomanidelleleggirazzialidel1938eraemigratoaParigiepoinel
1940aNewYork.Quieraentratonell’esercitoamericanoepresopartead importanti
azionimilitari, fra cui lo sbarco in Normandia. Al seguito del generale George Patton
Cagli attende alla liberazione di Buchenwald, dal quale trae una straordinaria serie di
schizzi, realizzata su un blocco da disegno di circa venti centimetri per trenta e poi
passata di proprietà dello storico dell’arte Erhard Frommhold21. Le provemettono in
rilievolamaestriadell’artistanell’utilizzarevarieconcezioniesoprattuttovarietecniche
in base alle circostanze e ai soggetti. InBambino sopravvissuto22 il piccolo internato
costituisce un forte elemento verticale, cui l’artista contrappone uno orizzontale, il
recinto del campo, con l’obiettivo di regolare la profondità e restituire una corretta
scansionedimensionaleallascena.Cagli,aderenteallarealtàfinneldettagliominuto‐si
tratti del copricapo, della gavettametallica o della giubba militare appoggiata da un
soldatopietososulloscheletrovivente‐ impiegaovunqueuntrattovigorosoepersino
concitato,graziealqualerestituisce ilsoggettonellasuaassolutafragilità.Buchenwald
1945, un secondo schizzo dell’album Frommhold23, ritrae due cadaveri distesi uno
accantoall’altro.Lacomposizioneanchestavoltafausodelcontrastofraunelementoin
primopiano, stavolta orizzontale, e una ripida scansione prospettica verso il fondo. A
differenzadiquantoosservatoinprecedenza,Cagliquilasciaemergereunsegnografico
ponderatoecalmo, chesibasasudiungiocoestremamenteprecisodialternanzefra
tratteggi incrociatieparalleli: conognievidenza l’artista realizza il foglio trascorrendo
alcuniminutidinanzi al soggettooaddiritturavi torna sopraconcalma inun secondo
20J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.227,fig.341.21 Cfr.N. Corradini,Cagli, Corrado, inAllgemeines Künstler‐Lexikon, XV, SAUR,München‐Leipzig
1997,pp.505‐506.22J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.228,n.343.23Ivi,p.229,n.344.
14
tempo,magaridopoaverne tracciatounprimo schizzoallabrava. Sia l’unoche l’altro
foglio dimostrano, in ogni modo, il dominio della tradizione italiana di matrice
accademicae,piùingenerale,ilricorsoaunpatrimoniofigurativoriccoesedimentato.
Si spiegano così i riferimenti ad alcuni capisaldi della cultura italiana di età
rinascimentale, dalla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello al Cristo morto di
MantegnaaBrera,comepureallerimeditazionisuglistessimodellicheerastataofferta
dallamigliore pittura risoergimentale, per esempio daGiovanni Fattori. D’altro canto,
Cagli era perfettamente aggiornato sull’una e sulle altre: nel 1936, in occasione della
Triennale di Milano, aveva presentato una monumentale Battaglia di San Martino e
Solferino,oggiagliUffizi.
Uncongruonumero diopere sullaShoahè fruttodi commissioni, iniziando da
quellevolteacommemorareinterminiufficialiedistituzionalilosterminiodegliEbreie
che dunque molto spesso coinvolgono luoghi di particolare significato storico o
simbolico. Nel 1973 lo stesso Cagli viene contattato dal comune di Gottinga per
un’impresa del genere (fig. 3)24. Il progetto aveva preso piede su iniziativadiHannah
Vogt, sindaco della città e al tempo stesso presidente dell’Associazione per la
cooperazione cristiano‐ebraica, laGesellschaft für christlich‐jüdische Zusammenarbeit.
L’ideaèdicostruireunmemorialeesattamentenel luogodoveuntemposi trovava la
sinagoga della città, distrutta nel 1938 durante la Notte dei cristalli. Quasi trent’anni
dividono ormai Cagli dall’album di Buchenwald, che gli era peraltro valso nel 1946 il
prestigioso Guggenheim Prize. Durante quel lungo periodo la sua carriera, il suo
linguaggio si erano molto evoluti, passando attraverso esperienze anche distanti da
quantoalloramessoinatto.Edelrestolestessecircostanzedifferisconototalmentedal
1945:unacosaèinfattidocumentarelarealtà,ossial’orroredelregimenazista,altraè
24 P. Wilhelm, Die jüdische Gemeinde in der Stadt Göttingen von den Anfängen bis zur
Emanzipation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973; H. Bonnhoff, Das Mahnmal für die
zerstörteSynagoge, inGöttingenohneGänseliesel,acuradiK.Duwe,C.Gottschalk,M.Koerner,
Wieden, Göttingen 1988, pp. 244‐246; S. Schurr, Zeugnis der Aufarbeitung? DasMahnmal am
Platz der zerstörten Synagoge, in Verewigt und Vergessen. Kriegerdenkmäler, Mahnmale und
GedenksteineinGöttingen,acuradiC.Gottschalk,SchmerseMedia,Göttingen1992,pp.85‐92;B.
Kratz‐Ritter,DasGöttingerMahnmalamPlatzderSynagoge,GöttingerGesellschaftfürchristlich‐
jüdischeZusammenarbeit,Göttingen2004.
15
commemorarlaabeneficiodeicittadinidellamodernaRepubblicaFederaleTedesca.Nel
progettoperGottingaCagli impiega l’acciaioperdarevitaauna formageometrica‐e
dunque fondamentalmente astratta ‐ che si basa sull’elaborazione dei due triangoli
equilateriallabasedellastelladidiDavid.Solopiùtardi‐valeadirenel1995,quandoil
maestroitalianoeraormaimortodaquasivent’anni‐ilcomuneinterverràsulmemoriale
aggiungendo alcuni dettagli di natura descrittiva, vale a dire le epigrafi in bronzo con
incisiinomieledatedeiduecentottantadueebreidiGottingadeportati.
Specialista riconosciuto nelle imprese di taglio commemorativo è lo scultore
polaccoNathanRapoport.Formatosinell’Accademiad’artediVarsavia,suacittànatale,
Rapoportnel1936grazieaunaborsadistudioavevapotutotrascorrereunperiododi
studio in Italia ed in Francia. Con l’invasione della Polonia l’artista aveva deciso di
spingersiadest,versol’UnioneSovietica,rimanendovifinoalterminedelleostilità.Nel
1946, tornatoa casa,Rapoport immediatamente spingeper realizzareunmonumento
voltoaricordarelacomunitàebraicadiVarsaviaedinparticolarelaRivoltadel19aprile
del 1943, allorquando, com’è del resto noto, duecentoventi ebrei, sotto la guida di
Mordechai Anielewicz e poi diMarek Edelmann, si erano ribellati alle truppe naziste,
tenendole in scacco per circa un mese. Rapoport lavorava sul progetto da diverso
tempo, addrittura fin da quando le prime notizie sulla Rivolta avevano iniziato a
circolare in Unione Sovietica, ed avevava anche presentato una maquette del
monumento al comitato artistico di Stalin, che tuttavia l’aveva ben presto messo da
parte25.AVarsavia,unavoltaottenuto ilpienoappoggiodelComitatoEbraico locale ‐
chedifattodaquelmomentoprendeinmanoleredinidell’impresa‐Rapoporteffettua
unadecisapressionesulgovernocittadino:ilsospiratonullaostagiungenel1947.Ilsito
delmonumento coincide con il fortilizio dell’Organizzazione combattente ebraica ‐ la
25 Z. Sohar, Fighters Memorial. Monuments to the fighters in the Warsaw Ghetto uprising,
Workers'BookGuild,SifriatPoalim1964;R.Yaffe,NathanRapoportsculpturesandmonuments,
Shengold, New York 1980; M. Gilbert, The Holocaust, Random House, New York 1987, in
particolarepp.317‐324;J.E.Young,Thebiographyofamemorialicon:NathanRapoport’sWarsaw
Ghetto Monument, in Memory and counter‐Memory, a cura di R. Starn e N. Zemon Davis,
“Representations”,XXVI,1989,pp.69‐106.Perunadiscussionepiùampiadellesoluzionimessein
atto dallo scultore in rapporto alla Shoah cfr. J.E. Young, The texture of memory. Holocaust
memorialsandmeaning,YaleUniversityPress,NewHaven‐London1983,pp.155‐184.
16
Zydowskaorganizacjabojowa,oZOB ‐cuoredellaresistenzaeteatrodiunadelle fasi
piùcruentedellabattaglia.
Al fine di realizzare la parte scultorea Rapoport trasloca nei mesi seguenti a
Parigi,permotividiordinetecnicomaancheperchéavverteilbisognodiaggiornareil
propriolinguaggio.Semprequiincontrapoialcunicoloniebrei,checonsideradeglieroi
echeperciògliservonodamodelli:asuoavviso,costoroincarnanol’Yishuv,lacomunità
politicaesocialeebraicainPalestinaprimadellafondazioned’Israele.Nelfrattempoun
altro ebreo sopravvissuto ai campi, Leon Marek Suzin, disegna e mette in opera la
struttura architettonica destinata ad accogliere le sculture. Suzin aveva già realizzato
sempre a Varsavia un altromemoriale ebraico, per l’esattezza sul sito corrispondente
all’ingresso del Ghetto, dove la rivolta aveva avuto origine: in questo caso egli aveva
tuttaviaesclusoognicomponenteplastica,riducendo il tuttoaunasortadipiedistallo
circolare recante iscrizioni commemorative in polacco, ebraico e yiddish. Una simile
impostazione non può certo risultare gradita a Rapoport, che in una successiva
dichiarazionericorderà:“Potevoforserealizzareunapietraconunbucoedire‘Voilà!La
grandezzadelpopoloebraico?’.Nodicerto”26.
Suzinanchestavoltaobbediscealcriteriodellamassimasemplicità:perlanuova
opera egli pensa infatti ad una sorta di prospetto trapezoidale, che in qualchemodo
ricordagliarchidi trionfoclassici.Architettoescultoresembrano inveced’accordosul
rivestimento esterno. Secondo quanto può ancor oggi apprezzarsi nella maquette
originaria, rimasta fino al 1987 in mano a Rapoport, esso doveva consistere in una
cortinadiblocchifortementesbalzati,cosìdaricordareilmurodelghettodiVarsaviaed
ancor più chiaramente il Muro del Pianto a Gerusalemme, la memoria ebraica per
antonomasia27. La fase esecutiva trasforma tuttavia i loro piani. Nella ricerca dei
materiali i dueartistioptano infattiperunapartitadiblocchi ingranito liscio svedese
messaloroadisposizionedall’AgenziaEbraicaSvedese,conl’ovviorisultatodivanificare
l’effetto plastico del muro. La critica ha molto insistito sui vantaggi di tale scelta in
terminidieconomiae rapidità.Èprobabile, in ognimodo, cheancorpiùdegli aspetti
pratici abbia contato nei due artisti e nella committenza il desiderio di sovvertire la
26J.E.Young,Thebiography...,p.82.27Peralcuneimmaginidelbozzettooriginaleincreta,conservatonellostudiodiRapoportaNew
Yorkfinoallasuamorte,cfr.ivi,pp.84‐85,figg.4‐6.
17
natura o quantomeno la destinazione delmateriale costitutivo: com’è infatti noto, i
blocchidigranitoliscioall’inizioeranostatipreparatiperrealizzareunmonumentoalla
vittoriadiAdolfHitlercheavrebbedovutosorgereaBerlino,sudisegnodelloscultore
tedescoArnoBrecker.
Concluso nel giro di pochi mesi, il Muro di Rapoport prevede due brani di
scultura, uno sul lato principaleeduno sul secondario, che interpretano due reazioni,
dueatteggiamentidelpopoloebraicodinanziallafurianazista.Sulrectoeccodunquela
dignitàelaresistenza,conMordechaiAnielewiczinprimopianonell’attodilanciareuna
granata;sulverso larassegnazione,con lungafiladiebreiche,sotto lasorveglianzadi
alcunisoldatitedeschi,sidirigeversoicampidiconcentramento.Suquestabaseèfacile
comprendere le nette differenze fra l’uno dall’altro. Nella Rivolta, un altorilievo in
bronzo con figure superiori al naturale, domina un tono eroico, enfatico e persino
leggendario. Come rivela la stessa posa di Anielewicz, la fonte immediata consiste
nell’iconografia socialistaeproletaria,quellabennotadei lavoratori inmarciaverso il
futuro radioso. D’altro canto traspare anche una cultura ben più profonda e
sedimentata,cheattraversoÉmileAntoineBourdelle,AugusteRodin,EugèneDelacroix
e Jacques‐Louis David risale fino aMichelangelo Buonarroti. Lo sguardo “terribile” di
AnielewiczsirichiamaperesempioalMosèperlatombadiGiulioII;quantoinvecealla
posaedalprofilodelgiovaneallasuasinistra,immediatamentesopral’uomobarbuto,
essederivanochiaramentedalBrutoogginelMuseoNazionaledelBargelloaFirenze,
un’operached’altronde findallasuaconcezione,nel1538,eradivenutacelebreper il
suolegamescopertoconl’iconografiadeltirannicidio.Un’ariadiversacontraddistingue
l’operainseritanellafacciataposterioreche,costituitamaterialmentedadiecilastrein
granito connesse fra loro così da formare un fregio a bassorilievo longitudinale, è in
genere chiamata Esilio oMarcia finale. La critica ne ha correttamente individuato la
fonte primaria inGalut, oDiaspora, un quadro realizzato nel 1904 dall’artista ebreo
polaccoSamuelHirszenbergedivenuto finda subitouna sortadimanifestovisivodel
movimentosionista,anchegrazieallasuarapidadiffusioneattraversolalitografia.Galut
costituisce tuttavia un punto intermedio di undebito più ampio e radicato, che dalla
tradizione tecnica dello “stiacciato” donatelliano si spinge fino ai due rilievi collocati
nell’intradossodell’arcodiTitoaRoma.
18
Inaugurato il14apriledel1948,acinqueanniesattidallaRivolta, ilMemoriale
degli eroi del ghetto gode fin dai suoi esordi di una fama bifida. La critica d’arte più
avvertita, infatti, lo relega nella categoria delkitsch o della “spazzatura di regime”, lo
stessodoveperlungotemporimarràconfinatalaproduzioneartisticaufficialedeglistati
socialistidiorbitasovietica28.Solo intempimoltorecentialcunistudiosi, inparticolare
Young, ne hanno azzardato il recupero, peraltro partendo da un approccio e da
strumenticaratteristicidellapsicologiadimassaodellasociologia,anzichédellastoria
dell’arte. Al contrario, un giudizio entusiasta sull’opera è caratteristico dei circuiti
culturaliebraici,chelaeleggonometaimprescindibiledeipellegrinaggidellamemoriain
Polonia. Come tale, il monumento diviene oggetto di visite istituzionali, alle volte di
estremaimportanza.Il14dicembre1970ilcancellieretedescoWillyBrandt,nelrecare
l’omaggiodellaRepubblicaFederalediGermaniainaspettamentesi inginocchiadinanzi
all’immagine di Anielewicz e compagni (fig. 4), suscitandoun’ondata di reazioni: “Der
Spiegel”, uno dei più autorevoli settimanali tedeschi, accompagna per esempio
l’immaginedel cancelliere con il titolo “DürfteBrandtknienen?”‐ “Eranecessario che
Brandts’inginocchiasse?”.
In Israele fin dal 1948 ilMemoriale era divenuto l’icona dell’interpretazione
ufficiale della Shoah. Basta a dimostrarlo la stessa iscrizione dedicatoria ‐ “Al Popolo
Ebraico.Aisuoieroieaisuoimartiri”,che,scolpita intre lingue, lapolacca, l’yiddishe
appuntol’ebraica,risultadeltuttoconformeall’indirizzovuoidiBeitLohameiHagetaot,
vuoidiYadVashem.Datiquestipresupposti,dopolaGuerradeiSeiGiornidel1967eil
conseguente, drastico inasprimento dei rapporti diplomatici con paesi del blocco
sovietico,Polonia inclusa, proprioYadVashemauspica la realizzazionedi unacopiadi
ciascuna delle due sculture. Effettivamente realizzate nel 1975, a spese dell’uomo
d’affari e filantropo statunitense Leon Jolson29, le copie vengono poste in opera ed
inaugurate nel 1976 in una piazza di circa quattromila metri quadri nel complesso
museale di Gerusalemme, da allora appunto intitolata ai combattenti del Ghetto di
Varsavia.
28Ivi,pp.69,83;D.G.Roskies,AgainsttheApocalypse.ResponsestocatastropheinmodernJewish
culture,SyracuseUniversityPress,Syracuse1999,pp.276‐280.29Cfr.J.E.Young,Thebiography...,cit.,p.96.
19
RispettoaglioriginalidiVarsaviamoltecoserisultanoquicambiate.Nonsembra
ilcasodi insisterepiùdeldovutosualcunevarianti iconografiche, in realtàmodestee
comunque dettate da ragioni didecorum: a questo si deve, per esempio, la velatura
nellaRivoltadel nudo femminile a sinistra di Anielewicz. La novità principale consiste
nella concezione del montaggio: a Gerusalemme, infatti, Rivolta ed Esodo appaiono
muratel’unadifiancoall’altraentrounalungacortinadimattonirossi,conilrisutatodi
perdereillorocomplessorapportodireciprocità30.
Nel contesto di Yad Vashem le sculture assumono un ruolo chiave. La piazza
infatti da allora rappresenta il luogo dove ogni anno hanno ufficialmente inizio le
cerimoniedellaGiornatadellaMemoria:ancheperquestolapiazzaverràsottopostanel
2006amassiccilavori,voltiadampliarnelasuperficieeamigliorareilcollegamentocon
altrinodidelcomplesso31.Insiemeedancorpiùdiquesto, leriproduzionidaRapoport
divengonounpuntofermonellaformazioneideologicadelleforzearmateisraelianee,
cometale,oggettodivisitecontinuedapartedeisoldatiedellesoldatessedellastelladi
David.Agliocchideicapimilitari,l’EsodoedancorpiùlaRivoltacostituisconodifattiun
tasselloessenzialenellospiritoguidadellanazione,inquantorammentanoladebolezza
del passato e contemporaneamente la necessità di organizzare la difesa armata. In
un’ottica del genere Anielewicz e compagni diventano i naturali discendenti dei
Maccabei:ilcerchiosichiude32.
Benchécaratterizzatodaunamatrice iconograficae iconologicaestremamente
chiara ‐ come peraltro dimostra anche il gesto del cancelliere Brandt ‐, ilMuro della
rimembranzadiRapoportèspessointepretatoinchiaveanchemoltodiversa.Nelcorso
degli anni esso diviene infatti protagonista di fenomeni di decontestualizzazione
semantica, inclini cioè a considerarlo la materializzazione di significati talora molto
distanti dalla Shoah. Secondoun processo curioso e non privo di una certa ironia, da
30Ivi,pp.97‐98.31WarsawGhetto Square connected to the newMuseum Complex, in “Yad Vashem Jerusalem
Magazine”, 40, 2006, p. 13; cfr. anche
http://www1.yadvashem.org/yv/en/pressroom/magazine/pdf/yv_magazine40.pdf.32 Cfr. anche P. Coen, I musei della Shoah ieri ed oggi, fra identità sottaciute e politiche di
riparazione,inMuseiTorino2011.Dacrisiaopportunità,attidelconvegno(Torino,2011),acura
diE.Gabrielli,LeoS.Olschki,Firenze(incorsodistampa).
20
icona filoebraicae filosionista ilMemorialedi Varsaviaassumepermolti la valenzadi
paradigma figurativo del diritto di ogni minoranza a godere di pari rispetto e di pari
dignità33. Ecco dunque spiegato, per esempio, come mai nel 1989 Lech Walesa e il
sindacatoSolidarnosc decidano di tenere proprio qui, e non altrove, alcune fra le più
accorateeintensedimostrazionicontroilregimecomunistapolacco.
All’inizio degli anni Ottanta Rapoport viene contattato dall’autorità dello stato
americanodelNewJerseyperrealizzareunaltromonumentoallaShoah, intitolatofin
dalprincipioLiberation.Delresto,findal1950loscultorepolaccosieratrasferitoaNew
Yorkeneisuccessivitrent’anniavevacontinuatoalavoraresuopereatema,attraverso
commissioni giunte di volta in volta dal Canada, dagli StatiUniti e da Israele. Al 1971
risale per esempioMegilatHa’esh, oRotolo di fuoco (fig. 30), punto culminante della
cosiddettaForestadeiMartiri,unboscodiseimilionidialberipostounacinquantinadi
chilometri ad ovest di Gerusalemme. La nuova opera ha come destinazione il Liberty
State Park di Jersey City, per la precisione quella spianata del parco pubblico che dà
direttamente sulmare. Liberation, inaugurata solennemente nel 1985, consiste in un
bronzo di grandezza superiore al naturale: essa raffigura un soldato dell’esercito
statunitensementresollevadipesounebreointernatoneicampidisterminioeloporta
insalvo.Rapoportuniscequiduefiloniiconografici inrealtàdiversi,caratteristicol’uno
deimonumenti alla Shoah, l’altro deimemoriali ai soldati americani caduti nel corso
della seconda guerra mondiale. Queste due anime trovano puntale riscontro nei
finanziatori.Icostidirealizzazionesonoinfattisostenutidaduegruppi,l’unoformatoda
organizzazioni di veterani di guerra, l’altro dalla comunità ebraica del New Jersey: il
Liberty Park sorge infatti a pochiminuti da Newark, dove sono fra l’altro ambientati
moltiromanzidiPhilipRothconprotagonistaNathanZuckerman.
Iltitolodell’opera‐che,intesoasottolineareilconcettodilibertà,siaccordaal
parco stesso e alla sua principale arteria, Freedom Avenue ‐ si rivela veramente
strategicoinunazonatradizionalmentenotaperilfenomenodell’immigrazione.L’area
del parco, infatti, era in precedenza occupata dal nodo ferroviario impiegato dal
Governo americano dalla fine del diciannovesimo secolo fino ai primi decenni del
ventesimoper smaltire il flussodieuropeiprovenientida Ellis Island, situatagiustodi
fronte,apochedecinedimetrididistanza.SoloneglianniSettantaleautoritàdelNew
33Cfr.labibliografiacitatadaJ.E.Young,Thebiography...,cit.,p.102,nota2.
21
Jerseyavevanodecisosmantellarelastazionedeitreni,nelfrattempoentrataincrisi,e
diconvertirel’interazonaaverdepubblico.All’epocadiLiberationlamemoriadelluogo
eraancorafresca:l’inaugurazioneufficialedelLibertyPark,ilprincipalepolmoneurbano
delNewJersey,risalivainfattial14giugnodel1976.
Il monumento di Rapoport stabilisce dunque un profondo legame di natura
concettualeedeticaconglialtriluoghicardinedellamemoriaamericanacollocatinella
stessabaiaebenvisibilisiadigiornochedinotte,daEllisIsland,nel1990divenutasede
diunarticolatoepercertiversistraordinariomuseosull’immigrazioneesullediversità
etniche, alla Statua della Libertà. Di lì a poco, nel 1993, il cerchio si chiuderà con la
realizzazione dello Holocaust Museum, ubicato nella punta meridionale dell’isola di
Manhattan34. Liberation, in particolare, rende concreto il nesso fra lo sterminio degli
Ebrei d’Europa ed il popolo americano, che viene inteso come “datore di libertà” o
semplicemente“liberatore”.Unnessotantopiùforteladdove,comesièappenavisto,è
ribaditoincontinuazione,daltitolodell’operafinoalcontestodovesitrova.“Onorarei
militari americani in quanto liberatori di popoli oppressi”: esattamente questo, non
altro,è l’obiettivodelGovernatoredelNewJerseyThomasH.Kean,valeadirechidà
vita al Comitato per ilMonumento a Liberty Park, con l’incarico di raccogliere i fondi
necessari al monumento di Rapoport. Gli stessi contenuti, lo stesso tono, persino le
stesse parole contrassegnano i pieghevoli distribuiti in occasione del Giorno della
MemoriadalloDipartimentodiDifesadegliStatiUniti, loUnitedStatesDepartmentof
Defense,oDOD:
[Rapoport's] artistic goal was to embody in bronze a daring vision: in the faceof sorrowand
tragedies, he asserted that hope can triumph despite atrocity (...). Liberation depicts an
Americansoldiercarryingasurvivoroutofaconcentrationcamp.Thechestsoftherescuerand
rescuedare joined,as if sharingoneheart.Theway that thesurvivor's body is cradled in the
armsofhisliberatorreflectscomfortandtrust.
34Id.,Thetextureofmemory...,cit.,p.321;sulmuseodiNewYorkepiùingeneralesuimuseidella
Shoah cfr. P. Coen,Stiamoo non stiamo camminando sulla nostra ombra? Per unamuseologia
dellaShoah,inLaMemoriaelaStoria.Auschwitz,27gennaio1945:temi,riflessioni,contesti,atti
del convegno (Arcavacata di Rende, 2007), a cura di P. Coen, G. Violini, Rubbettino, Soveria
Mannelli2010,pp.109‐150.
22
Liberation si pone dunque come uno degli emblemi più efficaci di quel processo di
integrazione o, se si desidera, di appropriazione della Shoah entro le istituzioni
statunitensi: iniziato poco dopo il 1979, il fenomeno, anche noto come
“americanizzazione della Shoah” ‐ acquista sempremaggior peso negli anni Novanta,
come dimostrano, oltre al citato Holocaust Museum di New York, lo United States
HolocaustMuseumandMemorialdiWashington.
Quando osservato nel contesto dei primi anni Ottanta del ventesimo secolo
Liberation assume anche un’altra valenza35. In particolare, salta agli occhi come le
autoritàciviliedancorpiùquellemilitarinellecomunicazionivolteaillustrarelospirito
dell’opera ricorrano quasi immancabilmente all’espressione “restituire, restaurare la
libertà”. Parla chiaro in tal senso la risoluzione ufficiale emessa il giorno
dell’inaugurazione,dalloStatodelNewJersey:
I nostri militari combatterono non per conquistare o in quanto aggressori, ma piuttosto per
salvareerestituirelalibertàaquantieranoperseguitatieoppressidallepotenzefasciste.
Bene: esattamente “to restore freedom” è uno dei motti preferiti del partito
conservatorestatunitense,che lorecita ininterrottamentealmenodalla finedeglianni
Sessanta del ventesimo secolo. Lo era inizialmente divenuto in seno alla Young
America’sFoundation,oYAF,creatanel1969nellaprestigiosaVanderbiltUniversityallo
scopo di fronteggiare i moti studenteschi del 1968 e appunto di promuovere il
movimento repubblicano all’interno dei campus. Nel periodo di Liberation la stessa
espressionetornadicontinuoneidiscorsipubblicidiRonaldReagan,prima,durantee
dopo le sue vittoriose campagne per le elezioni a presidente. Ancor oggi esso viene
normalmenteimpiegatonelcorsodeinumerosieventiorganizzatidallaYoungAmerica’s
Foundation, specie quando intende valorizzare l’eredità culturale e politica dell’ex
presidente.
Ancoroggila lineastabilitadaRapoportèfra lepiùbattutedallamodernaarte
dellaShoah,particolarmentequandositrattadicommissionigravatedaunafortecarica
istituzionale. Com’è infatti noto, la storia di questa classe di monumenti è
35P.Coen,ImuseidellaShoahieriedoggi...,cit.
23
contraddistintadallafortunapressochéininterrottadiartistiinclini,piùomenocomeil
polacco,atrattareiltemaattraversoilinguaggimodulatidallatradizionedelrealismoo
dell’espressionismo.
Avevobisognodimostrare l’eroismo ‐ questo il commentodi Rapoport a proposito delMuro
della rimembranza ‐di illustrarlo letteralmenteattraverso figureacuiavrebbero reagito tutti,
nonsoltantogliartisti.Dopotutto,questoavrebbedovutoessereunmonumentopubblico.Eda
cosareagisconogliesseriumani?Avolti,afigure,allaformaumana.Nonvolevorappresentare
laresistenzainastratto:nonfuunarivoltaastratta.Fureale36.
AllametàdeglianniOttantatale impostazionerisultaancoravalidaquandositrattadi
sceglierelesculturedadestinarealmemorialediMiamiBeach,inFlorida,realizzateda
KennethTreister.Laprincipale,Amoreeangoscia,sipresentacomeunamanoinbronzo
protesa verso il cielo fino a un’altezza di tredici metri: dall’avambraccio, recante il
numerodiAuschwitz,sistaccanocircacentotrentafigure,cheesprimononeilineamenti
delvoltolepiùdiverseformediangoscia.
Unagrandesculturaambientale‐eccoilcommentodiTreister‐edunaseriedispaziall’aperto,
nei quali il visitatore è condotto attraverso una processione di esperienze visive, storiche ed
emotive,conlasperanzache latotalitàdellavistapotràesprimere, inqualchemodo, larealtà
dell’Olocausto37.
Specularmente, il medesimo indirizzo attesta, in particolare nelle opinioni legate ai
sopravvissuti alla Shoah, un generale sentimento di sfiducia verso le possibilità dei
linguaggidell’astrazionediincarnare,diesprimereappienoilorosentimenti.Unacoltre
disegretezzaavvolgeneiprimianniNovantalecommissioniindirizzatedairesponsabili
36J.E.Young,Thebiography...,cit.,p.82:“Ineededtoshowtheheroism,toillustrateitliterallyin
figureseveryone,not justartists,wouldrespondto.Thiswastobeapublicmonumentafterall.
And what do human beings respond to? Faces, figures, the human form. I did not want to
representresistanceintheabstract:itwasnotanabstractuprising.Itwasreal”.37K.Treister,AsculptureofLoveandAnguish: theHolocaustMemorialatMiamiBeach,Florida;
cfr.http://rhythmqwest.com/index.php?main_page=product_tvprogram_info&products_id=1211.
24
del museo di Washington ad alcuni fra i più affermati maestri dell’astrattismo
contemporaneo,daRichardSerra,sucuiavremomododiritornare,a JoelShapiro,da
Ellsworth Kelly fino a Sol LeWitt38. D’altro canto, qualcosa di analogo, vale a dire un
sentimento di insoddisfazione e di inadeguatezza verso l’astrattismo, aveva accolto
qualcheannoprimaancheilMomumentoaicadutidelVietnamdiMayaLin:concepito
nel1981,essoerastatobenprestoaffiancatodaiTresoldatidiFrederickHart,stavolta
rigorosamentefigurativo39.
Edisuopapà,cioèilnonno,unodeitantinonnicheun
giornoHitlermiavrebbeucciso,checonlacravattadiseta
elagiaccaeraandatoalamentarsidalpreside,ma
uscendodalsuoufficioquellil’avevanopresoespogliato
ancheluidiforza,inclasse,davantialleragazze.
Esempreconquellavoceditenebra,midissecosì,papà:
“Mad’orainpoiavremounostatoebraico”.
L’arte della Shoah attrae precocemente l’interesse del collezionismoprivato. In alcuni
casieccezionali, comeperesempioquellodiFrantisekStrass, ciò capitaquando i fatti
sono ancora in corso. Oggetto dell’attenzione di Strass è il materiale proveniente da
Theresienstadt, o Terezin, vale a dire da quel particolare ghetto vicino Praga che
notoriamente il regimenazistaalmeno in parte concepiscecomeuna sortadi ‘campo
civetta’40.Suquestabase‐edèanchequestounfattolargamenteconosciuto‐aTerezin
erano stati concentrati parecchi artisti, impiegati fra l’altro nel realizzare disegni di
architetturaedigrafica.Benpresto,però,alcuni‐comeperesempioLeoHaas,Bedrich
38Cfr.P.Coen,Stiamoononstiamocamminando...,cit.39C.L.Griswold,TheVietnamVeteransMemorialandtheWashingtonMall:philosophicalthoughts
onpoliticaliconography,in“Criticalinquiry”,XII,1986,pp.688‐719.40G.Green,ArtistsofTerezin,HawthornBooks,NewYork1969.Per lamusica si vedaancheD.
Oliveri, Hitler regala una città agli ebrei Musica e cultura nel ghetto di Theresienstadt, Epos,
Palermo2008.
25
Fritta, Karel Fleischmann, Otto Ungar e Felix Bloch ‐ utilizzano di nascosto gli stessi
materiali adoperati nell’’arte di regime’ per dal vita a immagini di contenuti e tenore
opposti,ingradocioèdirestituirelecondizionieffettivedelghetto:equandopossibile
riescono a trafugarli fuori dal campo. Strass, guidato certamente da una spinta
testimoniale,ancorpiùcheestetica,èfraiprimiaraccogliereeadivulgareidipintiei
disegni di Terezin. Anche grazie a lui, dunque, si deve l’intervento della Croce Rossa
Internazionaleinfavoredegli internati,chesiconcretizzanelgiugnodel1944.Inrealtà
durante la visita l’ispettore della Croce Rossa si trova dinanzi a un’apparenza
immacolata.Nellesettimaneprecedenti, infatti, i responsabilidelghettoavevanodato
corso a un’operazione di ripulitura, che aveva fra l’altro previsto un massiccio
sfoltimento degli internati in sovrannumero con una serie di convogli diretti ad
Auschwitz.Aquelpuntol’ispettorecommetteunerrore,ossiaestraedallaborsaalcuni
diqueidisegniclandestini‘ditestimonianza’cheglieranogiuntifralemanieliesibiscea
titolodiprova.Secondo ilsuometrodigiudizio, inveritàpiuttostoingenuo,l’evidenza
dovrebbemettereiresponsabilidelcampoconlespallealmuro.Lecosevannotuttavia
inmododeltuttodiverso.AppenauscitodaTerezin,l’esibizionedeidisegniclandestini
dà infatti origine alla cosiddetta ‘Questione degli artisti’, per cui viene scomodato
nientemenocheAdolfEichmann.MoltiartistidiTerezinvengonoallora interrogaticon
l’accusadiaveretraditolafiduciapostainlorodalTerzoReiche,dopoavereconfessato,
tradotti ad Auschwitz, un destino condiviso anche dal proto‐collezionista Frantisek
Strass:fratutti,Haassaràilsoloasalvarsi41.
Fra i collezionisti privati di arte della Shoah rientra poi il critico d’ispirazione
socialista Erhard Frommhold di Dresda, sostenitore della ex Repubblica Democratica
TedescaepiùtardiautoredelcelebrevolumeArtedellaResistenza:dellasuaraccolta
hannofattopartediversipezzidinotevoleinteresse,fracuidisegnidiKrstoHegedusice
la citata serie di Cagli su Buchenwald42. Sempre in Germania, ma stavolta nell’ex
RepubblicaFederale,unapassioneanalogaguidaRichardHiepe,unadellepiù influenti
41 SuStrass cfr. J.Blatter,op. cit.,pp. 20‐21;N.Troller,Theresienstadt:Hitler'sgift to the Jews,
UniversityofNorthCarolinaPress,ChapelHill1991,passim.42J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,pp.196‐197,figg.290‐291.Sulcollezionistaecriticod’artecfr.R.
Beck, Gedenkrede fuer Erhard Frommhold, in “AICA. Internationaler Kunstkritikerverband.
DeutscheSektion”,novembre2007,inhttp://aica.kuk.net/meld/index.php?id=131.
26
personalità del sistema artistico di Monaco: Hiepe, attivo sia come critico d’arte, sia
attraversolasuagallerianellacapitaledellaBaviera,hadirecentelasciatoilsuointero
archivioall’Accademiad’artediBerlino.
In considerazione della sua alta valenza documentaria, etica ed istituzionale,
l’artedellaShoahentrabenprestonelpatrimoniodelMuseo,attraversoesposizionia
carattere permanente o temporaneo. Nel 1995 la mostra Créer pour survivre,
organizzatapressoilMuséedesBeaux‐ArtsdiReimsincollaborazioneconl’Universitàdi
Reimsecon laFederazioneNazionaledeiDeportatiedegli Internati (FNDIRP), include
per esempio alcuni schizzi di France Audoul43. Nel 2002 una seconda esposizione,
svoltasi presso il JewishMuseum of New York, vede come protagonisti tredici lavori
contemporaneiatema, fracui il discussoLegoconcentrationcampdelpolaccoLibera,
sucuisiavràmododitornare44.
Alcuni istituti di taglio più ampio e per così dire ‘generalisti’ formano al loro
interno sezioni specifiche. Questa politica contraddistingue per esempio il Museo
Nazionale di Varsavia, che annovera fra l’altro i disegni dedicati ad Auschwitz del
polacco Stefan Wenger45. Il binomio arte‐Shoah risulta pressoché immancabile nei
museidellaciviltàebraica,iqualid’altrocantoriservanosempreunaspecialeattenzione
agliannipiùoscuridelNovecento.IlMuseoNazionaleEbraicodiPragaconservaalcune
centinaia di schizzi del già menzionato Leo Haas dedicati ad Auschwitz. L’artista era
riuscitoametterliinsalvoprimadivenireinternatoadAuschwitz,murandolinellepareti
dialcuniedificidelghetto.DopolaguerraeglieratornatoaTerezine,ritrovatiifoglial
loroposto,decideappuntodifarnedonoalmuseo46.LadirezionedelJewishMuseumof
New York si è data da fare per acquistare e includere nel percorso di visita il calco
autografodelMemorialerealizzatonel1984daGeorgeSegalperSanFrancisco,unodei
43Inparalleloallamostral’UniversitàdiReimshaancheorganizzatounsimposio;cfr.Créerpour
survivre.Ecrituresetpratiquesartistiquesdanslesprisonsetlescampsdeconcentrationnazis,atti
delconvegno(Reims,1995),Paris,FNDIRP,1996.44MirroringEvil:NaziImagery/Recentart,catalogodellamostra(NewYork,2002),acuradiN.L.
Kleeblatt,TheJewishMuseumofNewYork,NewYork2002.45J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.239,fig.359.46S.Milton,Haas,Leo,inJ.Blatter‐S.Milton,op.cit.,pp.250‐251.
27
più famosi tra imoltidedicati alle vittimedello sterminionazistanegli StatiUniti47. In
Israele, lavoridi alcunedecinedi artisti ebreiuccisinei campidi concentramento‐da
Menashe Seidenbeutel a Henri Epstein, da Rudolf Ernst a Jessurun de Mesquita ‐
costellano Mishkan LeOmanut, letteralmente la ‘Casa d’arte’, disegnata nel 1948 da
Smel Bikeles nel kibbutz Ein Harod, sulla strada verso Nazareth, intorno alminuscolo
studio in legno del pittore ChaimAtar48. L’arte della Shoah viene in talmodo letta in
chiave squisitamente collettivista e sionista: d’altro canto proprio ad EinHarod vive e
lavora Yitzhak Tabenkin, amico di Ben Gurion e padre fondatore dello Israel Labour
Party,delloUnitedKibbutzMovementedelMovementforGreaterIsrael49.Lasezionea
tema è ben riconoscibile nell’attuale percorso di visita, che, grazie alla carica di
ideologia,allaqualitàdelcontenitoreeallaforzadeisuoicircasedicimilamanufatti,ha
trasformatoMishkanLeOmanutda“angolod’arte”abeneficiodeisolikibbutzinimnel
piùimportantepoloartisticonelsettentrioned’Israele.
Operesingoleointereraccolteatemaconnotanoquasituttiimuseifocalizzatiin
viaesclusivasullaShoah,sitrattideicosiddetti‘santuaridellamemoria’,ovverodiquei
musei‐memoriali sorti nei luoghi dello sterminio, oppure di istituzioni che ne sono
invece separate damigliaia di chilometri50. IlMuseoNazionale di Auschwitz annovera
dunquepezzidiPeterEdel,WincentyGawronediMieczyslawKoscielniak: ilcorpusdi
Koscielniak,permoltiaspettistraordinario,includeilDiarioillustratoeunbuonnumero
diritratti,partedeiqualiacaricatura,comeperesempioquellodiTargosz,realizzatonel
194451. L’arte gioca un ruolo fondamentale anche presso lo Itzhak Katzenelson
HolocaustandJewishResistanceHeritageMuseum,piùcomunementeconosciutocome
BeitLohameiHagetaot,oCasadeicombattentidelGhettodiVarsavia,ubicatoqualche
47Senevedal’esaurienteschedainMasterworksoftheJewishMuseum,acuradiM.Berger,The
JewishMuseumofNewYork,NewYork2004,pp.70‐71.48Z.Efron,ChaimAtar,MishkanLeOmanutMuseumofArt,EinHarod1975.49N. Ben‐Yehuda,GorMasadamyth: collectivememory andmythmaking in Israel, University of
Wisconsin Press, Madison 1995, in particolare p. 384 s.; G. Gorenberg,The accidental empire:
Israelandthebirthofthesettlements,1967‐1977,TimesBooks,NewYork2006,p.480.50SuimuseidellaShoahesulla lorodifferente impostazionerispettoai ‘santuaridellamemoria’
cfr.P.Coen,Stiamoononstiamocamminando...,cit.,pp.109‐150.51J.Blatter‐S.Milton,op.cit.,p.206,fig.307‐310.
28
chilometroanorddiAkko,inIsraele52.Fralemolteoperechetestimonianoos’ispirano
allaShoahvalealmenoricordareunsecondonucleograficolegatoaLeoHaasedancor
più lanutritaantologiadellascultricedioriginececoslovaccaElsaPollak,deportatanel
1944adAuschwitzinsiemeall’interafamigliaedal1962residentenellacittàdiHerzliya,
inIsraele.Lacosahaunarimarchevoleimportanza.Alparieforseancormaggiormente
di Mishkan LeOmanut, questo museo gioca infatti un ruolo chiave nella piattaforma
ideologica dello stato ebraico. Fondato all’indomani della proclamazione
dell’indipendenza da un gruppo sopravvissuti ‐ parte dei quali avevanomilitato nella
resistenza nei ghetti della Polonia occupata ‐ Beit Lohamei Haghetaot fin dal 1949 si
proponediunirelatestimonianzadellosterminioall’orgogliodichi,comeperesempioil
citatoAlexander Bogen, aveva cercato con ognimezzo di opporsi all’invasore nazista.
Rendendogloriaegiustiziaachieramortoconlearmiinpugno, lastrutturanegacon
forza la visione di un popolo ebraico passivo ed incapace di organizzare una sia pur
minimaformadiresistenzaallaShoah,neanchesifossetrattatodiungreggecondotto
almacello.AnchesedistantemigliaiadichilometridaVarsavia,questoremotoangolo
dellaGalileadivideperciòlospiritodelMemorialediRapoport.
Date lepremesse ideologichediBeitLohameiHaghetaot,sicapisceabbastanza
beneperché l’artegiochiunruolochiaveaYadVashem,di fatto l’archetipodeimusei
dellaShoah,comesièavutomododiosservarealtrove53. Ineffetti l’attualestruttura,
fondatanel1953suduecollinediGerusalemme,èlasolaaprevedereun’istituzionea
tema,valeadireunveroepropriomuseod’artedellaShoah.Ilsuopatrimoniostorico,
fortedioltrediecimilapezzi, includetestimonianzestraordinarie,comeperesempio il
CampodellamortediAuschwitz‐nell’originalepolaccoObozsmierciOswiecim‐l’album
di diciannove fogli all’acquarello, più il frontespizio, realizzato nel 1945 da Zofia
Rozensztrauch54.LamissioneprincipaledelMuseod’artediYadVashem,inognimodo,
52Cfr. J.Kurths,Shoahgedenken im israelischenAlltag.DerUmgangmitderShoah in Israel seit
1948amBeispielderGedenkstättenBeitLohameiHagetaot,YadVashemundBeitTerezin,Frank&
Timme,Berlin2008.53 Su Yad Vashem si rimanda alla bibliografia riportata in P. Coen, Stiamo o non stiamo
camminando...,cit.,pp.109‐150.54Leimmaginidell’albumsonoriprodottedaL.Evangelisti,AuschwitzeilNewHumanism.IlCanto
diUlissedellevittimedellaferocianazista,Armando,Roma2009,pp.47,208s.
29
risiedenontantonelconservarememoriedelpassato,quantonelprotendersiversole
più moderne tendenze contemporanee. Ecco perché la direzione ha concesso per
esempio un posto d’onore aMordechai Ardon55. Damolti giudicato il più importante
artistaisraeliano,Ardoninrealtàsi limitaadispirarsiallosterminio:allievodiPaulKlee
nellaBauhausdiDessauduranteglianniVenti,eglisieratrasferito inPalestinafindal
1933, subito dopo l’ascesa al potere di Adolf Hitler e la promulgazione delle prime
misureantiebraiche.Nonsolo.Piùvolteegliesprimel’opinionechel’arte,nelsuocaso
lapittura,debbaapprezzarsisolointerminiesteticieformaliechedunquenondebba
nutrire implicazioni di natura sociale e tanto meno politica. Ma è d’altronde facile
ravvisarecomelaShoah,lasuacaricadiorroreediingiustizia,costituiscanoun’urgenza
reale del suo percorso, secondo quanto indicano per esempio gli otto trittici
monumentalirealizzatifrail1955eil1988.AYadVashemilruolospecificodell’arte‐ed
in particolare dell’arte contemporanea ‐ è stato ulteriormente sottolineato con
l’aggiunta di un nuovo padiglione di settecentometri quadri, aperto nelmaggio 2005
con l’esposizione Etched voices, a cura di Yehudit Shendar e Sorin Heller. Questa
sensibilità va perfettamente d’accordo con il significato globale dell’intera istituzione.
Com’è infatti noto, Yad Vashem, sorto intenzionalmente come un museo in perenne
divenire, rivendica il diritto‐dovere delle generazioni più giovani di fornire la propria
interpretazione,lapropriariletturadellaShoah.
Poimialzò lacopertaesidisteseaccantoa
mevestitocom’era(luicheinsistevasempre
chenonbisognavamaiandarealettovestiti
da giorno, per nessuna ragione). Rimase in
silenzio per qualche istante e continuò a
carezzarmi la testa, e io non osavo quasi
respirare.
55MordecaiArdon:Bilderausd. Jahren1953‐1978, catalogo dellamostra (Berlin,1978),Neuen
Berliner Kunstvereins, Berlin 1978; Mordecai Ardon: recent paintings, catalogo della mostra
(London,1987),MarlboroughFineArt,London1987.
30
Ancorprimadel1945laShoahdivieneperciòmotorediunfenomenoartisticodiampio
respiro. Ciononostante, la critica per lungo tempo riserva al fenomeno un’attenzione
scarsaoaddiritturanulla.FinoabuonapartedeglianniSessanta, infatti, lateoria faa
menodiinterrogarsideltemanelsuocomplesso,alpiùfissandol’attenzionesuisingoli
interpreti. Si preferisce insomma dare importanza ai sintagmi, ai lemmi, alle parole
anzichécogliereildiscorsod’insieme.Allabasedelsilenziovisonocertamentecausedi
ordinegenerale.InOccidentehannodicertopesogliequilibrigeopoliticicomplessivi:la
guerra di Corea e l’inizio della Guerra Fredda consigliano infatti di evitare qualsiasi
motivo che possa costituire fonte d’imbarazzo per la Repubblica Federale Tedesca
baluardo strategico della ‘cortina di ferro’. È lo stesso clima, per essere ancora più
limpidi, che obbliga i testimoni a restare muti e che impedisce ‐ o rende comunque
estremamentedifficoltoso‐pubblicareautenticicapolavoricomeNottediElieWieselo
SequestoèunuomodiPrimoLevi.Vannod’altrocantopostiinevidenzaalcunifattoridi
ordine squisitamente estetico. Ridurre al silenzio l’arte della Shoah, fino al punto di
negarla,significainfattiadeguarsiallaposizionediTheodorAdornoo,permegliodire,a
unaparticolareinterpretazionedelsuopensiero,quellachenormalmentesiriallacciaa
una sua celebre frase: “Scrivere una poesia dopo Auschwitz corrisponde a un atto di
barbarie”56. In sé, una posizione del genere mette automaticamente in crisi ogni
proposta artistica in rapporto alla Shoah, addirittura la rende inaccettabile sul piano
morale.Comeinfattiesprimerel’inesprimibile?Sebbenepiùtardiritrattataocomunque
messameglioa fuocodallostessoAdornonella suaDialetticanegativa57,questa linea
criticahagodutodivastocreditofinoatempimoltorecenti.AllafinedeglianniNovanta
seneavverteperesempiol’econelleparoledelcuratoreAmnonBarzelapropositodel
MemorialedegliEbreiassassinatid’EuropadiBerlino,cheallorasitrovaancora infase
diprogetto:
Iononsonocontrochifacciaunosforzoperricordare,mapensochetuttociòchepotetefare
conquest’areasiapiantareunpratoverdeconunapiccolapietranelmezzoconscritto:ricorda
l’Olocausto.Qualsiasialtracosasarebbe“arte”.Ilmemorialperl’Olocaustohamoltopocoache
56Perlacitazione,risalenteal1949,cfr.T.W.Adorno,Prismi,Einaudi1972,p.22.57Id.,Dialetticanegativa,Einaudi,Torino2004,p.326.
31
fareconl’arte58.
Nel febbraio 1998, in rapporto allo stesso Memoriale, un gruppo di diciannove
intellettuali firmauna letteraaperta,argomentandochenessun’opera, tantomenoun
monumento, potrà mai rappresentare pienamente l’orrore dell’Olocausto: essa
“sarebbe un’istallazione astratta di proporzioni oppressivamente giganti (...) senza
essere né un testimone del passato, né un segno per il futuro”59. Ironicamente, tra i
firmataridiquestapetizionesvettaancheilcelebrescrittoreGüntherGrass,ilqualedilì
apocoammetteràpubblicamentediavereasuotempoaderitoalnazismo.
I primi segnali di un risveglio critico risalgono nel decennio successivo al 1968,
annochevedefral’altrol’istituzioneinalcuneuniversitàcalifornianedicorsidistoriae
didattica della Shoah. Fanno capo a questo periodo alcuni lavori tuttoramolto validi,
compresa lamostra Spiritual resistance 1940‐1945, concepita e curata fra gli altri da
studiosedirangocomeLucyDawidowiczeMiriamNovitch60.
Unancorpiùsensibilecambiamentodirottasiregistraall’indomanidel1979ed
èalmenoinpartedaricondursiall’ondaemotivacausatadall’enorme‐epermoltiversi
inaspettato‐successotelevisivonegliStatiUnitidallaserietelevisivaOlocausto:mentre
intuttoilnordAmericasiassisteallamoltiplicazionedei luoghidellamemoriaebraica,
neglianniaseguiresipubblicanodunqueunbuonnumerodicontributi,alcunideiquali
58 Cfr. debbo la citazione al saggio in questo volume di Alessandra Bertolé Viale, cui va il mio
ringraziamento.59 Cfr. M. Nolan, The politics of memory in the Bonn and Berlin republics, in Memory and the
impact of political transformation in public space, a cura di D.J. Walkowitz, L.M. Knauer, in
particolarep.119.60KunstundWiderstand...,cit.;Spiritualresistance1940‐1945...,cit.;M.Novitch,op.cit.;N.Toll,
Withoutsurrender:artoftheHolocaust,RunningPress,Philadelphia1978.
32
ancoroggidirimarchevoleutilità61.RientranellacategoriaArtoftheHolocaust,acuradi
Sybil Milton e Susanne Blatter, che si avvale dell’introduzione storica di Henry
Friedländer62.Illibro,uscitoinprimabattutanel1981,offreunquadropiuttostofedele
dellostatodeglistudi,inclusiperciòancheiritardicriticicuisiaccennavainprecedenza.
Aunacoraggiosaintroduzioneeun’ancorpiùvalidabatteriadiapparatisicontrappone
un’organizzazione dellamateria decisamente frammentaria, frutto di un ordinamento
delleoperesubasegeografica,ovverosecondol’ubicazionedeivaricampidiprigioniae
disterminio.
Gli anni Novanta del secolo scorso coincidono con un’autentica esplosione
critica, con una quantità di repertori e di saggi veramente notevole, tanto più se
paragonato al silenzio caratteristico della generazione precedente. Ancora una volta,
unafortespintaversoilcambiamentoprovienedacauseesternealmondodell’arte.In
particolare,ilmutamentodell’assettogeopoliticoplanetariointornoal1989‐chehala
suaiconanelladistruzionedelMurodiBerlino‐crealecondizioniperlamassificazione
dellaShoah.Daallorailsilenzioèdefinitivamenterotto.Anzi,percertiversièaddirittura
necessariochesirompa,dalmomentochelavocedeitestimoni‐ormaianzianaoflebile
‐servedasigillodigaranziapertransizionipolitichedicapitale importanzanellastoria
dell’Occidente, a cominciare dalla riunificazione delle due Germanie. Come si è
osservatoaltrove,ilfenomenoinvestenumerosicampidellaproduzioneculturale,dalla
cinematografiaallaricercastorica,maviveunsuomomentochiavenelledisciplinedel
Museo:èinfattipropriooraeattraversoquestoprocessocheimuseidellaShoah‐sia
pure con significati profondamente diversi ‐ divengono una costante di molte città
d’Europa e del nord America, anziché patrimonio esclusivo d’Israele63. Altre cause
61D.LeVitté‐Harten,HinweiseaufmöglicheBeziehungenzwischenHolocaustundKunst,in“Kunst
undKirche”,XLVI,1983,pp.208‐221;S.Lewis,Artoutofagony:theHolocaustthemeinliterature,
sculptureandfilm,CBCEnterprises,Toronto1984,tuttora imprescindibile;A.Kampf,TheJewish
experienceintheartofTwentiewthcentury,BerginandGarvey,SouthHadley1984;M.Costanza,
op.cit.
62J.Blatter‐S.Milton,op.cit.63P.Coen,Stiamoonon stiamocamminando..., cit.,pp.109‐150; Id., ImuseidellaShoah ieri e
oggi...,cit.
33
possonoinveceesserericondotteall’internodelsistemaculturale.Importantesembrain
primo luogo il contestuale e prepotente emergere dei cosiddetti ‘studi di genere’, o
genderstudies,che,sull’ondalungadelpensierodiMichelFoucaultediJacquesDerrida,
tendono a canalizzare e ad esaltare alcuni determinati ‘saperi’, a cominciare da quelli
ricollegabili ai fenomeni dell’omosessualità e del femminismo. Negli ultimi vent’anni
tutto questo ha determinato per un verso, un deciso aumento delle conoscenze,
dall’altro lacostituzionediunagrigliacriticadecisamentepiùaggiornata,anchegrazie
all’utilizzo estensivo dell’approcciomultidisciplinare. Fra imolti risultati degni di nota,
vale sottolinearequelliottenutida JamesE.Young, chenei suoinumerosi contributi‐
primofratuttiThetextureofmemory‐hadimostratodisapereincrociareconequilibrio
l’arte con la sociologia e la psicologia della memoria, giungendo così a una nuova
ridefinizionedeimemorialidellaShoah64.
64Reflectionsof theHolocaust inArtandLiterature, a curadiR.L.Braham,ColumbiaUniversity
Press, New York, 1990; Z. Amishai‐Maisels, Depiction and interpretation: the influence of the
Holocaust on the visual arts, Pergamon Press, Oxford et alii 1993; J. Young,Mahnmale des
Holocaust:Motive,RitualeundStättendesGedenkens,catalogodellamostra(Berlin,1994),acura
di J.E. Young, Prestel,München 1994; Burnt Whole: contemporary artists reflecting on the
Holocaust,WashingtonProjectsfortheArts,Washington1994;Z.Amishai‐Maisels,Thecomplexity
of witnessing, in After Auschwitz. Responses to the Holocaust in contemporary art, atti del
convegno(London,1995),acuradiM.Bohm‐Duchen,LundHumphries,London1995,pp.25‐48;
J.E.Young,Memoryandcounter‐memory.TowardsasocialaestheticofHolocaustmemorials, ivi,
pp. 78‐102; E. Collotti, Le rappresentazioni della memoria: mostre e luoghi monumentali, in
Insegnare Auschwitz. Questioni etiche, storiografiche, educative della deportazione e dello
sterminio, a cura di E. Traverso, Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 78‐96; P.E. Van Alphen,
Caughtbyhistory.Holocausteffectsincontemporaryart,literatureandtheory,StanfordUniversity
Press, Stanford 1997; L. Saltzman,AnselmKiefer and art after Auschwitz, CambridgeUniversity
Press, Cambridge 1999; J.E. Young, At memory's edge: after‐images of the Holocaust in
contemporary art and architecture, Yale University Press, New Haven ‐ London 2000;
Rememberingforthefuture,catalogodellamostra(London,2000),acuradiE.Maxwell,R.Halter,
The Royal Institute of British Architects, London 2000; G. Sujo ‐ D. Fraser Jenkins, Legacies of
silence.ThevisualartsandtheHolocaustmemory,PhilipWilson,London2001;S.Hornstein‐F.
Jacobwitz, Image and remembrance. Representation and the Holocaust, 2002; S. Milton ‐ L.
34
Le tendenze attuali sembrano aver superato ogni riserva nei confronti del
rapporto fra arte e Shoah. La critica più avvertita sostiene il suo pieno diritto
all’esistenza ed anche ne sottolinea l’eccezionale valore pedagogico e didattico, in
particolarenellalottaalrazzismo65.Significativo intalsensoèilsalutorivoltonel2000
dal rettore del Centennial College di Scarborough, nello stato dell’Ontario, in Canada,
all’arrivodellabibliotecaedallacollezioned’artedeiconiugiJohneMollyPollock.
I Pollock nutrivano il desiderio di vedere la loro vasta collezione (...) circolare al di fuori dalle
università o dai circuiti ebraici tradizionali e al contrario essere disponibile in un’istituzione al
serviziodiunidentitàstudentescamulticulturale.IlCentennialCollegeèriconosciutocomeuna
delle istituzioni di maggiore diversità culturale in Canada: qui vi sono rappresentati almeno
cento gruppi etno‐culturali e si parlano circa ottanta lingue (...). I Pollock desideravano che la
lorocollezionefossemessaadisposizionediunacomunitàchefossetantodiversificataquantoil
mondoentroilqualetuttinoiviviamo66.
Iamurri,Arte,inDizionariodell’Olocausto,acuradiW.Laqueur,ed.italianaacuradiA.Cavaglion,
Einaudi, Torino 2004, pp. 45‐47;M. Baigell, Jewish art in America: an introduction, Rowman&
Littlefield,2006;S.Feinstein,Dall’ossequioallatrasgressione:l’artedell’Olocausto, inStoriadella
Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, a cura di M.
Cattaruzzaetalii,5voll.,UTET,Torino2005‐2006,IV,2006,pp.186‐237;P.Rosenberg,Artduring
the Holocaust, in Encyclopaedia Judaica, New York,Macmillan 2006, ad vocem;Nachbilder des
Holocaust,acuradiI.Stephan,A.Tacke,Böhlau,Köln2007;senevedaanchel’acutarecensionedi
A. Gaskievicz in “Humanities and social sciences on line”, http://www.h‐
net.org/reviews/showrev.php?id=23722; S. Žižek, “Beschreibung ohne Ort": über den Holocaust
unddieKunst."Descriptionwithoutaplace":onHolocaustandart, inPoliticsofart,acuradiT.
Huber,M.Steinweg,Diaphanes,Zürichetalii2009,pp.141‐161.65SivedaperesempioS.Feinstein,op.cit.66 K. Camenietzki, The John and Molly Pollock Holocaust Collection at Centennial College,
Scarborough,Ontario, in38thAnnual Convention of theAssociation of Jewish Libraries, atti del
convegno (Toronto, 2003), in particolare p. 3; cfr. anche
www.jewishlibraries.org/ajlweb/publications/proceedings/proceedings2003/camenietzki.pdf
35
Gliultimiannihannovisto lamoltiplicazionedi programmiche impiegano l’arte come
strumento essenziale per trasmettere la conoscenza della Shoah a bambini e
adolescenti,disponibilitaloranellelibrerietradizionali,talaltradirettamentesullaretee
a titolo gratuito. Al 2005 risaleThe arts and theHolocaust. Lessons from the past for
citizensoftoday,pubblicatodaKaherineMorleyeTimNunninScozia,perl’esattezzaa
curadalloEastRenfrewshireCouncil,conun’impiegoestensivodelleimmaginidiartisti
legatiallaShoaheun’orizzontecriticomoltobendefinito,sianelleartifigurativechein
quelleperformative67.IntempiancorapiùrecentiBetLohameiHagetaothafattolargo
usodelsuopatrimonioperdarevitaaunprogettosimile,daltitoloLearningaboutthe
Holocaust through art68.Obbedendo alla stessa falsariga, l’arte della Shoah è stata al
centro di seminari di studio all’interno delle università, talvolta con la partecipazione
direttadipittoriodiscultori.Il27gennaio2010SharonPortnoff,docentediletteratura
ebraical’UniversitàdelConnecticut,haperesempioinvitatol’artistaGraceAstrove,per
discutere con gli studenti se e come la rappresentazione può integrarsi con quanto
appreso nei corsi di Storia. Nel medesimo ciclo di seminari ha trovato spazio Robert
Mankoff, un celebre vignettista satirico del “New Yorker”, al fine di verificare i limiti
dellarappresentazioneneicartoon.
Èstatoimportantestudiarecomel’Olocaustoèrappresentatonell’arteepersinonellohumour‐
hadichiaratolaPortnoff‐perfareinmodochelanostramemoriadelfattononcorrailrischiodi
veniresantificata69.
Poid’untrattomiopadrecominciòaparlaredicose
dicuiincasamianessunoavevamaiparlato,perché
era proibito parlarne, cose di cui avevo sempre
67K.Morley ‐ T.Nunn,TheArtsandTheHolocaust. Lessons from thepast for citizensof today,
Reeling & Writhing, Glasgow 2005. La pubblicazione è disponibile anche on line: cfr.
www.reelingwrithing.com.68Cfr.http://art.holocaust‐education.net/69 A. Martin, Exploring the Holocaust through art, in “Current news. Connecticut College”, 27
gennaio2010;inwww.conncoll.edu/news/5949.cfm.
36
saputo che non bisognava fare domande e basta.
Non si domandava né a lui né alla mamma e in
generale, da noi c’eranomolti argomenti dei quali
menosichiedevameglioerapertutti.
Il nuovo rapporto fra arte e Shoah configuratosi dopo il 1989 trova un autorevole
riscontro nell’esperienza di Richard Serra, il quale in tre progetti degli anni Novanta
delinea un campo ancor oggi sostanzialmente valido70. Il primo dei tre si lega
all’intraprendenzadiGerhardDornseifer:assessoreallaculturadelcomunediPulheim,
un sobborgo di Colonia, Dornseifer nei primi mesi del 1991 invita Serra a realizzare
un’operaperunamostranella sinagogadi Stommeln,unacittadinaposta sotto lasua
amministrazione.
Iltagliosingolarmenteoffcelaundisegno inrealtàculturalmenteambizioso.La
sinagogadi Stommeln,benchéartisticamente trascurabile,ha infattiuna rimarchevole
valenza storica. Abbandonata fin dal 1933 sotto la pressione delle prime minacce
antisemite, essa era stata venduta nel 1937 dalla comunità ebraica di Colonia a un
contadino:questi l’avevaadibitaa depositoagricolo,unacircostanzachedi lì apoco,
all’indomani della Kristallnacht del 1938, l’avrebbe salvata dalle squadre d’assalto
naziste.Lasinagogaerainiziataarisorgerenel1979,appuntoconl’acquisizionedaparte
delmunicipiodiPulheim:adistanzadiquattroannisierasvoltalasolennecerimoniadi
riapertura, celebratadaimembri della comunitàebraica diColonia.Dopouna seriedi
tentativiabbastanzainsoddisfacentidirenderel’edificionotoalgrandepubblico, l’idea
difarlodivenireunluogosimbolodellaShoahchiamandoogniannounartistaafornirne
un’interpretazione attraverso un’opera a tema era venuta a Dornseifer durante una
conversazione con un suo amico di Colonia, il pittore ed incisore Wilfried Gies. Con
questo spirito era nata l’anno prima la collaborazione con Jannis Kounellis, che fra il
70 Ove non diversamente indicato, per la vita e l’opera dell’artista si vedano Richard Serra:
Arbeiten66‐77/Works66‐77,catalogodellamostra(Tübingen‐Baden‐Baden,1978),acuradiC.
Weyergraf, Kunsthalle Tübingen, Tübingen 1978; R. Serra ‐ C.Weyergraf Serra, Interviews, Etc.,
1970‐1980, The Hudson RiverMuseum, Yonkers 1980;Richard Serra: Sculpture, catalogo della
mostra (NewYork, 1986), a cura di L. Rosenstock,MuseumofModernArt,NewYork 1986; A.
Pacquement,RichardSerra,CentreGeorgesPompidou,Paris1997.
37
dicembre del 1991 e il gennaio del 1992 aveva installato nel piccolo spazio della
sinagogaunodeisuoiSenzatitolo.
Serra,checonoscevail lavorodiKounellisancorprimadiriceverelachiamatadi
Dornseifer, indirizza a Stommeln un’opera in acciaio forgiato dedicata al romanzo di
Primo Levi, vale a direTheDrowned and theSaved, in italiano I sommersi e i salvati.
Ecconeladescrizioneautografa:
The sculpture consists of two forged right angles. Each angle has a short vertical and long
horizontal leg.Neitherofthetwoangles iscapableofstandinguprightbyitself.Theanglesare
top‐heavyduetothefactthatthehorizontallegislongerthanthevertical.Thetwolonglegsof
theforgedanglesareproppedtogethersothattheymutuallysupportandmirroreachother71.
IsommersieisalvatifornisceunoslanciodecisivoalprogettoartisticodiStommeln.Nei
successivi vent’anni lemostre, curate daDornseifer e dopo la suamorte daAngelika
Schallenberg,coinvolgerannoaltriartistidilivellointernazionale,fracuiGeorgBaselitz,
Mischa Kuball, Eduardo Chillida, Maria Nordman, Carl Andre, Rebecca Horn, Erich
Rausch,MaurizioCattelaneOlafMetzel72.
71Cfr.RichardSerra.TheDrownedandtheSaved,catalogodellamostra(Pulheim,1992),Matthew
MarksGallery,NewYork1992;M.Codognato,Ilpesoeiltempo, inRichardSerra,catalogodella
mostra (Roma, 1999‐2000), a cura di M. Codognato, E. Coen, Westzone, Venezia 1999, in
particolarep.35;RichardSerra. Sculpture1985‐1998,catalogodellamostra (LosAngeles,1998‐
1999), a cura di R. Ferguson, A.McCall, C.Weyergraf Serra,Museumof ContemporaryArt, Los
Angeles1998,p.121,dacuièripresalacitazione;H.Foster,TheUn/makingofsculpture(1998),in
Richard Serra, a cura di H. Foster, G. Hughes, The MIT Press, Cambridge ‐ London 2000, in
particolarepp.189‐190.72 Cfr. Richard Serra, The Drowned and the Saved (Die Untergegangenen und die Geretteten)
1992, a cura di K. Winnekes, Diözesanmuseum Köln, Köln 1997; J. Plotzek, Richard Serra. The
drownedandthesaved,DiözesanmuseumKöln,Köln2007;SynagogueStommeln.Artprojects,a
cura di G. Dornseifer, A. Schallenberg, Hatje Cantz, 2001. L’indirizzo internet www.synagoge‐
stommeln.de/index.php?n1=2&Direction=120 fornisce un elenco completo e aggiornato delle
esibizioni. Del progetto si sono inoltre occupati sia Leonardo Passarelli, sia chi scrive nelle
rispettive relazioni per il convegno organizzato sempre da chi scrive presso l’Università della
38
Sempre all’inizio degli anni Novanta, più o meno in contemporanea alla
telefonatadiGerhardDornseiferdallaGermania,Serraintraprendeilsecondoprogetto
contemadifondolaShoah.Stavoltadall’altrocapodelfilovisonoi responsabilidello
United StatesHolocaustMuseumandMemorial, la strutturamuseale che James Ingo
FreedstaalloracostruendolungoilNationalMalldiWashington73.RispettoaIsommersi
eisalvatilecondizionidipartenzanonpossonoesserepiùdiverse.Anzichéun’anonima
strada di una semisconosciuta cittadina tedesca ecco ora la capitale degli Stati Uniti
d’America,metaogniannodimilionidivisitatori.Anzichélamodestavolumetriatipica
di una sinagoga di campagna ecco ora la sala principale di un edificio a scala quasi
gigantesca.Anzichéun’esposizionetemporanea,eccooraunapermanente.Anzichéun
sito di forte sedimento storico, eccone uno vergine, o comunque orientato in
precedenzasolodafunzionidinaturaamministrativo‐burocratica:nonacaso,durante
lacerimoniaperlaposadellaprimapietra,nel1989,l’areadelnascituromuseoaveva
subito un processo di bonifica e per così dire di ‘santificazione’mescolandovi terreno
presoadAuschwitzeinaltricampidisterminio.
La rispostadi Serraallenuovecondizioni si chiamaGravity (fig.50),una lastra
quadrangolareinacciaio‐anchestavoltaforgiato,nonfuso‐ditrecentosessantaquattro
centimetriperlatoedellospessoreditrenta.Lasuadestinazione,fruttodell’intesatra
l’artista e i responsabili del museo, in questo caso lo stesso Freed, è la Sala della
Testimonianza, il principale spazio d’accoglienza del museo di Washington, una
collocazione.Ubicataalterminediunalungarampadiscalini,Gravitydivienel’autentico
polosignificantedellasala, traendo linfadall’imponentemassadellaparetedi fondoe
dallacitazionedallibrodelprofetaIsaiachevicampeggia:“Youaremywitnesses”,ossia
“Voisieteimieitestimoni”.
Inordertoreconfigurethevolumeoftheshaft‐like,elongatedstairwellleadingfromtheHallof
Witnesses in theHolocaustMuseumtothefloorbelow‐commenta loscultore‐ I impaledthe
landingofthestairswitha12‐footby12‐foot,10‐inchthicksteelslab.Theweightofthetilting
Calabria durante la Giornata della Memoria del 2011, i cui atti sono attualmente in corso di
stampa.73 Per gli aspetti museografici e museologici si rimanda a P. Coen, Stiamo o non stiamo
camminando...,cit.
39
block locatesthestairwellshaft,anchors it,gives itaballast,emphasizing its“bottomness”, its
downward compression. The sculpture responds to the gravity of the place in its downward
thrustandworksagainstitaswell:itsbalanceisperceivedtoshiftasonemovesdownthestairs
andtowardsthework74.
Nel percorso dell’artistaGravity trova un naturale punto di tangenza conWeight and
measureche,espostanel1992allaTateBritaindiLondra,nerappresentailprecedente
diretto.Inquesteedaltreoperedellamaturità laforzae laviolenzaappaionoplacate,
risolte, acquistano misura e tempo attraverso alcune funzioni elementari, come ‘il
portare’, ‘l’appoggiarsi’ ed ‘il pesare’. Nel 1988 Serra in una meditazione dal titolo
Weight afferma che il peso della storia e della memoria possono essere messi a
repentaglio e infine dissolti dai media: per questo motivo egli intende bilanciarli
attraverso“theweightofexperience”75.Laforzadigravitàassumeperciòilsignificatodi
certezza e conoscenza; la suamassa di entità coerente ed accumulo d’identità; il suo
peso,infine,dientitàetica,letteraleetraslatamaanchediresistenzaall’accelerazione
delglobalismo76.
Il terzoedultimo lavoropresoqui in considerazionevedeSerraattivo insieme
all’architettonewyorkesePeterEisenman.Lacoppiasi formanellasecondametàdegli
anniNovanta,allorchépartecipaallagarabanditadal governo tedescoperungrande
memorialesullaShoahdarealizzarsinelpienocentrodiBerlino,apochedecinedimetri
dallaportadiBrandeburgo77.Lasoluzionepresentatadaiduestatunitensi‐ancoroggi
ricostruibile grazie allamaquette originale e a una serie di schizzi custoditi presso il
Senatswervaltung für Bauen undWohnen, sempre a Berlino ‐ reca il titolo diWaving
fieldofpillars:si tratta,peramoredibrevità,diunestesocampodiparallelepipedi in
cementodialtezzavariabile,finoaunmassimodicircaquattrometri,intervallatidaviali
74LacitazionediRichardSerrasitrovainRichardSerra.Sculpture1985‐1998,cit.,p.127.75R.Serra,Writingsinterviews,cit.,p.185;ilpassoèchiamatoincausaanchedaH.Foster,op.cit.,
p.199,nota55.76M.Codognato,op.cit.,p.35.77 Per un’analisi del Memoriale degli Ebrei assassinati d’Europa, corredata da opportuna
bibliografia,sirimandaaP.Coen,Stiamoononstiamocamminando...,cit.;sivedanoancheisaggi
diAlessandraBertoléVialeediCristianaCoscarellapubblicatiall’internodiquestovolume.
40
sconnessie in leggerodeclivio. IlprogettoEisenman‐Serra, giàentrato inuna ristretta
cerchia al principio del 1997, risulta vincitore nella selezione finale dello stesso anno.
L’esitodetermina l’attodinascitadelMemorialedegliEbreiassassinatid’Europa,che‐
come avremomododi vedere più oltre ‐ sia pure attraverso un cammino abbastanza
tortuoso e l’esclusione dello stesso Serra, si pone oggi quale esempio fra i più
rimarchevolidimodernaartedellaShoah.
I tre progetti sulla Shoah sono intesi da Richard Serra in sintonia con il suo
percorsodiuomoediartistaedunquetrovanounvalidoinquadramentocriticoallaluce
delleideeguidachenepresiedonoilcatalogoedilpensiero.Ciòvaleinprimoluogoper
ilfermorifiutodelconcettotradizionaledimonumento.
[I miei lavori] ‐ egli afferma per esempio nel 1980 ‐ non hanno relazioni con la storia dei
monumenti.Essinoncommemoranonulla. Essihannoache farecon la scultura ebasta.Non
hanno alcuna intenzione di essere chiamati monumenti. Una curva d’acciaio non è un
monumento78.
IneffettiletreoperediSerranonsiriferisconodirettamenteallaShoah.Piuttosto,esse
hannol’obiettivodistimolarenelsingolodestinatariounariflessionesultema,traendo
principalmentespuntodaquantoglivienesuggeritodairispettivicontesti.Agiudiziodi
Serra, infatti, la memoria può essere solo evocata in termini spirituali. Immanente
all’operastessa,essatrovaformaconcreta“inmeasureandweightalone”,“inmisurae
inpesosoltanto”79.Inquestomodo,negandocioèognivelleitàdirappresentazioneodi
mera analogia, Serra intende evitare la costituzione di uno status oppressivo, di una
sorta di religione con relativa liturgia80.Questo concetto generale si applica anche a I
sommersiedisalvati:
The scultpure ‐ precisa infatti Serra ‐ is dedicated to Primo Levi who was incarcerated at
Auschwitz. The Drowned and the Saved is one ofmany books in which Levi writes about his
78R. Serra ‐C.Weyergraf Serra,op. cit.,p.178;D.Crimp,RichardSerra’surban sculpture, inR.
Serra,Writinginterviews,cit.,p.135;H.Foster,op.cit.,pp.189‐190.79H.Foster,op.cit.,pp.189‐190.80H.Foster,op.cit.,pp.192,199,note57‐58.
41
imprisonment. The relationship of the sculpture to Primo Levi’swriting donot gobeyond the
dedication.Thesculptureitselfcarriesnospecificmeaningbutactsasacatalystforthought in
itsparticularcontext:thecontentofcontextcontributestoitsexperienceandmeaning81.
Sispiegacosì‐perinciso‐comemaiSerraaccettivolentierichealterminedellamostra
diStommelnl’operaentriperacquistonelleraccoltedell’ArcidiocesidiColoniaevenga
successivamenteinstallataall’internodellerovinedellachiesadiSanktaKolumba:
It so happens that the Synagogue in Stommeln, one of the very few to have survived the
Kristallnacht, and the ruin of the sacristy of Sankt Kolumba, a Catholic church in Cologne
destroyedby a bomb in the SecondWorldWar, implicate the sameperiod in recent German
history82.
Mad’altrondenellasuapersonalevisioneèilconcettostessodimemoriacollettivaad
esseremessoarepentaglio:
IthinkthatmemoryisreallyapersonalperspectiveandIdon’tknowifonecangiveadviceaboutmemory
‐ dichiara in un’intervista televisiva rilasciata il 6 giugno 2007. Memory is probably one of the most
individualvaluesthatwehaveandithascloserelationswithcircumstances,perceptionandfeelings(...).I
thinkthatmemoryisreallyindividualisticandcountsforparticularexpressions.CollectivememoryIhave
aproblemwith83.
A suo giudizio, la memoria collettiva, lungi dall’essere davvero condivisa, è sempre
impostadalvincitore,dalpoteremilitareepoliticodi turno,con il risultatodi tradursi
inevitabilmente in retorica. Questa visione, che percorre la sua intera carriera, viene
espressa con singolare chiarezza all’indomani dell’attentato al World Trade Center
dell’11settembre2001.Com’ènoto,avendoilpropriostudionellazonameridionaledi
Manhattan, a due passi dalla zona poi ribattezzata Ground Zero, Serra ha modo di
assisterepersonalmenteall’attaccoterroristacontro leTorriGemelle.Giustoinqualità
81Cfr.R.SerrainRichardSerra.Sculpture1985‐1998,cit.,p.121.82Ivi.83 Charlie Rose intervista Richard Serra, 6 giugno 2007; cfr.
www.charlierose.com/view/interview/2777.
42
di testimoneoculare dei fatti rilascia nel corso degli anni numerose riflessioni, alcune
dellequaliraccoltedalnotopresentatoretelevisivoDavidRose.Eglirammentafral’altro
“iterribiligemitidellepersonechesilanciavanodaigrattacielinelvuoto,perschiantarsi
al suolo come zucche”84, che per un anno intero avrebbero popolato i suoi incubi
notturni. Tuttavia egli continua a pensare che si tratti di un ricordo personale e
incondivisibile. Le memorie dei singoli testimoni ‐ egli osserva ‐ divergono in modo
incredibile le une dalle altre, in quanto ciascuna è rielaborata di continuo
individualmente. Su questa base egli rifiuta la possibilità che quanto allora accaduto
possa tradursi appunto in memoria collettiva, memoria di una nazione, memoria
dell’umanità.
Una seconda, importante linea guida nell’opera di Serra consiste nel rifiuto di
un’arte‘digenere’,valeadirediun’artecheinqualchemododebbarisultarevincolataa
unaparticolare identità:primafratuttenaturalmentedaquellaebraica.Loscultore in
talmodo legge inmodo estremamente chiaro la situazione venutasi a creare dopo il
crollodelMuro.Finoaquelmomento losterminio,come inpartesièvisto,erastato
affrontato quasi sempre da artisti ebrei, che ne avevano fatto un terreno quasi
esclusivo.Tuttoquestoèdestinatoacambiaredopo il1989,quandopervarimotivi la
Shoahnonsoltantoacquistaunpesocentralenell’artecontemporanea,masoprattutto
divienemateriadipittori, scultoriograficinonebreio checomunquenon si vogliono
riconoscere tali. Ma non basta. Laddove alcuni esponenti della nuova generazione
battonosentieripercorsigiàdurantelaguerra‐dall’esistenzialealtestimoniale‐diversi
altri modulano i linguaggi del concept in sintonia con il punto di vista, le fobie o i
sentimenti del nemico, cioè dei Nazisti. Nel 1996 Zbigniew Libera realizza Lego
ConcentrationCamps85,unsetdimattonciniinplasticaprodottidallanotadittadanese,
a quanto sembra inconsapevolmente: seguendo il libretto d’istruzioni è possibile
costruireuncampodiprigionianazista,reticolati,baraccheeprigionieriinclusi.L’artista
polacco utilizza così la carica semiotica e comunicativa della Lego per evidenziare i
legamiesistenti fra lapedagogia, ilmondodeigiochie lacosiddetta ‘pornografiadella
Shoah’. Al 2001 risale Him di Maurizio Cattelan, una scultura antropomorfa in
84Ivi.85MirroringEvil:NaziImagery/Recentart,catalogodellamostra(NewYork,2002),acuradiN.L.
Kleeblatt,TheJewishMuseum,NewYork2002.
43
vetroresinadipintadigrandezzapocomenodelnaturale,dicuiunaversioneèogginella
raccolta del magnate francese François Pinault. Quando osservata da tergo Him si
presenta come un bambino in ginocchio; il fruitore avvicinandosi e soprattutto
giungendole di fronte si accorge tuttavia che il viso ritrae le fattezzediAdolfHitler. Il
giocoèinrealtàmoltoserio,inlineaconquantoaccadespessoconCattelan.Lachiave
diletturadell’operasembrainfattirisiedereneldisagiochederivadallariflessionesulla
labilitàdiogniconfineetico.Cattelanparteanchequidallinguaggiodeisegni,secondo
cui l’uomo ed ancor più il bambino genuflessi incarnano i concetti di spiritualità o
dell’incapacitàdioffendere.SuquestoceppoegliinnestalaStoria.Unodeisuoimodelli
sono le fotografie di Heinrich Hoffmann, che negli anni Trenta erano state uno dei
motori della propaganda nazista e del culto per il Führer e che appunto per questo
eranodivenuteneldopoguerral’iconadelMale;specieperlaposainginocchio,sembra
poiavererilievolafotografiadiWillyBrandtdinanzialMurodiRapoportaVarsavia,già
citata inprecedenza86.L’esposizionetemporaneaorganizzatanellaprimaveradel2002
nel JewishMuseum of New York, intitolata significativamenteMirroring evil, riunisce
tredici opere di artisti internazionali, inclusa Lego concentration camp di Libera,
accomunati dall’impiego del repertorio di immagini degli anni trenta e quaranta del
Novecento,spessoappuntomanipolatoinchiaveconcept87.
Opere del genere hanno suscitato e suscitano ancor oggi comprensibili
risentimenti,inparticolarenelmondoebraico.“ChipossiedeleimmaginidellaShoah?E
chihaildirittodiporvimano?”,questaperesempiolaformularetoricaimpiegatanella
primavera del 2002 dal periodico americano “The Jewish Post” nel commentare
Mirroringevil88.Traendospuntodapresuppostidiordineeticoalcunistudiosi,comeper
esempio Feinstein89, auspicano che chiunque voglia affrontare il tema della Shoah
debbapossedereun’identitàebraicaoperlomenoavereunatotaledimestichezzacon
la cultura ebraica. Ironicamente, giusto Mirroring evil, un evento al centro delle
86 Cfr. in particolare il saggio di AlkeVierck inNachbilder derHolocaust..., cit.; P. Coen, Imusei
dellaShoahieriedoggi...,cit.87MirroringEvil...,cit.88Cfr.larecensioneallamostrasuhttp://www.jewishpost.com/archives/news/mirroring‐evil‐nazi‐
imagery‐recent‐art.html#top.89S.Feinstein,op.cit.,pp.186‐237
44
polemiche più infuocate, si tiene entro un prestigioso contesto ebraico, il Jewish
Museum of New York; a capo dell’idea vi è inoltre un noto curatore ebreo, Norman
Kleeblatt.
Almeno in linea di principio, la figura di Richard Serra parrebbe al sicuro da
argomentazioni del genere, potendo vantare requisiti identitari impeccabili. L’artista
californianonasce infattidagenitoriebrei,cheavevanotrovatoriparonegliStatiUniti
per sfuggire alla violenza dell’Europa in fiamme, il padre dalla Russia, lamadre dalla
Spagna.Nonsolo.Serrateoricamentehadallasuaancheunrapportodiprimamanocon
Israele:nel1983eglisirecaaGerusalemme,inqualitàdivincitorediunaborsadistudio
pressol’AccademiaBezalel.Spingendoafondol’analisi,similicertezzevengonotuttavia
benprestomesseincrisi.L’interastoriaartisticaebiograficadiSerraprescindeinfattida
riferimenti all’appartenenza ebraica. Inoltre, benché avvezzo a comunicare le proprie
intenzioni poetiche attraverso i media, fin dove possibile egli evita di scrivere o di
parlare della Shoah. Persino il coinvolgimento nelle mostre di Stommeln non
rappresentaunfattoredeterminante.Cometestimoniafral’altroAngelikaSchallenberg,
Serra riceve l’invitoperché ritenutocapacedi fornireunottimo lavoro,dimisurarsi al
meglioconlaStoria:noncertoinquantoebreo.L’annoprecedenteGerhardDornseifer
aveva chiamato un artista greco, Jannis Kounellis; dal 1992 in poi sia Dornseifer che
AngelikaSchallenberginterpellerannodivoltainvoltaartistiebreienonebrei.
Ancoranellastessadirezioneva ilcomportamentocheSerratieneall’indomani
dell’11 settembre 2001 nelle ricordate interviste a David Rose. Per quanto la
conversazione cada più volte sui concetti di ‘memoria’, ‘sacrificio’ e ‘morte, i due si
guardanobenedastabilireunnessoconlaShoah,dove,siapureinformaovviamente
assaidiversa,imedesimiconcettirisultanoaltrettantofondamentali.Anchequandogli
vieneportoildestro,RichardSerraevitadunquedisventolarelabandieraebraicaemen
che mai quella della Shoah. La sua condotta risulta alla fine talmente lontana dai
meccanismi identitarida suscitarepersino il risentimentodella comunità statunitense:
nonsembracasuale,sottoquestoprofilo,chealcuniorganid’informazionedellastessa
comunitàloaccusino“dinoncomportarsiabbastanzadaebreo”.
La terza linea guida alla base degli interventi di Richard Serra ‐ inclusi i tre
progetti sulla Shoah ‐ consiste nella necessità che ogni artista fin dove possibile
sottragga la propria opera ad ogni sorta di manipolazione proveniente dalla società
45
contemporanea.Alcunediquestemanipolazioni sonodiordineeconomico‐finanziario.
Com’è infatti noto, nel 1979 il grande successo televisivo della fiction televisiva
Olocausto, seguito da centoventi milioni di persone, determina uno spettacolare
aumentodeiconsumiculturaliinrelazionealtema,dentroefuoridagliStatiUniti.Con
sensibiletempismogiàalloraunadellepiùeminentiesensibilistudiosedellosterminio,
YaffaEliach,commentaicasticamente:“ThereisnobusinessliketheShoahbusiness”90.
Nel corso degli anni più voci provenienti dalla comunità ebraiche stigmatizzano il
fenomeno.Nell’ultimodecennio,peresempio,ilpremioNobelperlapaceElieWieselha
avutomodo di accusareMirroring evil e altri eventi simili di costituire benzina per la
cosiddetta “Shoah’s industry”, ossia di sfruttare la carica emotiva suscitata dallo
sterminiodegliEbreiafinimeramentecommercialioscandalistici.Comesivede,anche
l’arte figurativa è insomma teatro di casi sotto molti aspetti analoghi a quello,
clamoroso,cheesplodenel2006conl’uscitadeLesBienveillantesdiJonathanLittell.
Serra pare comunque ancor più impegnato sul piano delle manipolazioni di
naturaideologicaepolitica,chedimostradiavvertirecon luciditàdavverosingolare.In
questeoccasioniegli lascianell’armadiogliabitidel ‘barbaro’e indossa in lorovece la
toga dell’accademico: in virtù di un linguaggio perfettamente adeguato agli strumenti
odierni di comunicazione, l’artista svela allora i meccanismi di funzionamento, le
ipocrisieelefalsecertezzedelpotere91.Emblematicointalsensoèquantoaccadeconil
90 La citazione è tratta da E.T. Linenthal, The struggle to create America’s HolocaustMuseum,
UnitedStatesHolocaustandMemorialMuseum,Washington1995,p.13.91Serra,aldi làdialcunemiseenpose,sicontraddistingueper ilragguardevolegrado
culturale,particolarmenteinnell’ambitodellastoriaedellaletteratura.Accostatosialle
materieumanistichefindalliceo,siformainizialmenteall’universitàdiBerkeleyepoiin
quelladiSantaBarbara,doveottienenel1961unBachelorofArtsinletteraturainglese.
Spostatosi nel 1964 sulla costa orientale, in Connecticut, egli continua la propria
educazioneaYale,finoalMasterinFineArts.Eglihaquimododiprendereconfidenza
conunambientemoltostimolante,stabilendocontattifral’altroconfilosofi,letteratie
musicisti del livello di Philip Glass. Sempre qui inoltre approfondisce i legami con le
radicidellaculturaanglosassone.D’altrocanto,alloscaderedeglianniSessantaYaleè
nettamenteindirizzataintalsensograzieaunodeisuoimassimibenefattori,ilmagnate
dell’acciaio Paul Mellon. Mellon fra l’altro finanzia su disegno di Louis Kahn lo Yale
46
citatomemorialediBerlino.Comegiàricordato,nelle fasiselettiveilconcorsobandito
dalla Repubblica Federale Tedesca era equivalso per l’artista californiano a un grande
successoufficiale.Nonappenaspentiiriflettorilasituazioneviraperòimprovvisamente
disegnoedha iniziounaseriedicontrasti,destinatibenprestoadiventare insanabili.
Nel gennaio del 1998 il progettoWaving field of pillars viene soggetto a una serie di
manomissioni al fine di renderlo “accettabile”, molte delle quali suggerite
personalmente dal cancelliere tedesco Helmut Kohl in un colloquio con Serra ed
Eisenman nel gennaio del 199892. Kohl ‐ con il pieno sostegno della commissione
giudicante,dicuifaparteancheilcriticoEdwardI.Young‐insostanzachiedediridurre
il numero dei pilastri da quattromiladuecento a tremila, di trattarli con una vernice
speciale antigraffito, di aumentarne l’altezza minima ‐ per impedire che i visitatori
possanosalirvi inpiediconeccessivafacilità‐e viceversadiabbassarne lamassimaal
fine di scongiurare il senso di claustrofobia e l’effetto ‘labirinto’; di ridurre l’area del
memoriale, così da creare lungo i lati spazi sufficienti al parcheggio dei pulman e allo
CentreforBritishArtche,dotatodiopportunifondiediunarimarchevolecollezionedi
opere d’arte, è ben presto affiancato dalla sua istituzione gemella giusto nel cuore di
Londra,a due passidal BritishMuseum, ThePaulMellonCentre forStudies inBritish
Art.PerilgiovaneSerradivieneaquestopuntonaturalerivolgerelosguardoall’Europa,
raggiuntadopoilmastergrazieadunaborsadistudiofornitaancoraunavoltadaYale.
Visita Londra, spende un anno intero a Parigi, frequentando lo studio di Brancusi,
disegnandovi in continuazione e approfondendo i suoi contatti con la cultura
dell’esistenzialismo, cui egli era del resto famigliare già da tempo, grazie ai suoi studi
letterarisuAlbertCamus.Unaltraborsadistudio,stavoltaFullbright,glipermettepoidi
spendere un altro anno in Europa, stavolta con obiettivi Firenze e Roma. È proprio a
Roma,adesempio,cheegliconosceedapprezzaFrancescoBorromini, inparticolare la
suacapacitàdi trattare le curve.Certo, gli esperimenti successivi al ritornonegli Stati
Uniti dimostrano come l’artista voglia liberarsi di questa formazione accademica. In
sintesi, egli avverte il bisogno di liberarsi da questa zavorra per ricominciare da zero.
Eccolasualinea,dichiaratafral’altroinun’intervistaaCharlieRose:“Ilmioobiettivoera
ridefinire lanaturadellascultura(...).Conoscevobene lastoriadellapittura.Madopo
avervistoVelàzquez,sapevochenonmisareimessoincompetizioneconlui”.92J.E.Young,Atmemory’sedge...,op.cit.,p.208.
47
scaricodeipasseggeri;disegnalarne i limiticon il tessutocittadinopiantandounfilare
alberato; infine, di creare nel sottosuolo un centro di documentazione, in stretta
dipendenzadall’archiviodiYadVashemaGerusalemme.Nelcomplesso,questevarianti
producono l’effetto di conferire all’opera una declinazione per così dire ‘cimiteriale’,
ovvero trasformano i semplicipilastri in lapidi commemorative.Diqui,peresempio, il
nuovo titolo di lavorazione: Field of stelae. Soprattutto, come dimostrato altrove, il
Memorialenellamentedelcancellierecristianodemocraticoassumeilvaloredigaranzia
politicachelanuovaGermaniaunitanonperseguiràpiùdegliidealidiespansione:ecco
perché la sede è letteralmente sorvegliata dall’ambasciata degli Stati Uniti, rifatta
proprioallorasudisegnodiFrankO’Gehry93.
Il3giugnodel1998Serra‐evidentementenonriconoscendosipiùnelprogetto‐
decide di abbandonare il lavoro, che da allora attraverso le modifiche previste sarà
portatoavantidalsoloEisenmanfinoallasuainaugurazione,il10maggio200594.Nonsi
tratta certo di una decisione facile. Fino a quel momento Serra aveva profusomolte
energie nel progetto, fornendoun impulso decisivo alla sua nascita e al suo sviluppo.
Sotto questo profilo basta un semplice confronto fra il materiale consegnato da
EisenmaneSerraalla commissionegiudicatrice e le loro rispettive carriere.Èdi certo
possibile che Eisenman abbia avuto un certo peso specifico, ponendo ad esempio
l’accento sul senso di instabilità. Questo elemento rappresenta una linea guida nel
linguaggio dell’architetto di New York, secondo quanto dimostrano, a puro titolo di
esempio,alcuniprogettiperloAronoffCenterforDesignandArtdiCincinnati, inOhio,
uno dei quali esposto nel 1987 alMART di Rovereto95. Va poi sottolineato come nel
memorialediBerlinol’instabilitàvadaaccentuandosiallorchéEisenmanrimarràdasolo:
inizialmente ravvisabile solo nel percorso di camminamento lungo i viali, più tardi
s’impadroniràanchedeipilastri.IlveroideatoredelmemorialesembratuttaviaRichard
93Cfr.P.Coen,Stiamoononstiamocamminando...,cit.;Id.,ImuseidellaShoahieriedoggi...,cit.94L.Andrews,SerraquitsBerlin'sHolocaustMemorialproject,in“TheNewYorkTimes”,4giugno
1998.95Elevenauthorsinsearchofabuilding:theAronoffCenterforDesignandArtattheUniversityof
Cincinnati,acuradiC.Davidson,MonacelliPress,NewYork1996;R.Rizzi,Misticonulla.L’operadi
Peter Eisenman, Federico Motta, Milano 1996, p. 15, figg. 12 e 13; D. Brogi, Peter Eisenman,
FedericoMotta,Milano2007,pp.50‐53.
48
Serra.Asuavoltaeglivantaperesempiounatotaledimestichezzaconl’instabilità,che
sperimenta a più riprese nei lavori del periodo, per esempio nei cilindriciTwo forged
rounds (for Buster Keaton) in collezione di Robert and JaneMeyerhoff a Phoenix, nel
Maryland96; o nei dodici blocchi posti lungo le colline che formano Snake eyes and
boxcars nella fattoriadiNancyeStephenOliver adAlexander Valley, inCalifornia97. Il
migliorterminediconfrontoconWavingfieldofpillars,tantodapoterloconsiderare il
precedente diretto, è rappresentato da58 x 64 x 70, un’installazione del 1996 per la
GagosianGallery diNewYork, costituita da sei blocchi in acciaio accostati gli uni agli
altri98.Valelapenadiriportareladescrizioneche,offertadallostessoSerra,siaccorda
moltobeneaiprinicipipoeticidelMemorialediBerlino:
Although you know from the title that all six blocks are identical your perception contradicts
your knowledge. Eachblock isperceivedasdifferent according to itsparticular relationshipof
height towidth to lenght.No reading isever thesame. It seems inconceivable that theblocks
weighthesame.Theyappeartotallydifferentaccordingtohowtheyareturned.Youneversee
anentireblock;youseeasurface,asideortwo,atop,acorner,anedge,butneverthewhole99.
Afavoredell’autografiadiSerragiocapoilaradicefortementescultoreadelmemoriale.
Unasequenzadimasseforti,scureetendenzialmenteassimilabiliaunparallelepipedosi
ritrovadicontinuonellesueoperedeglianniOttanta‐Novantadelventesimosecolo.Lo
attestanoleElevationsrealizzateinGermania,rispettivamenteaKrefeldedaLemgo,o
le sei Standing stones in granito dinanzi al DesMoines Art Center di DesMoines, in
Iowa100.DiSerraèanche lavolontàdimetterealprimoposto il fruitore.Lesueopere
intendonoristrutturarneilcampovisivo,lapercezionedell’ambiente,sitrattidinaturao
architettura, creando una tensione dialettica talmente forte da produrre sempre una
riflessionesu‘prima’esul‘dopo’101.
96Ivi,pp.106‐107.97Ivi,pp.134‐137.98Ivi,pp.166‐167.99Ivi,p.167.100Cfr.RichardSerra.Sculpture1985‐1998...,cit.,pp.68‐69,91,184‐185.101M.Codognato,op.cit.,p.31.
49
Lospettatore‐affermaSerra‐diventaconsciodiséstessoedelpropriomovimento(...).Nonappenaegli
simuove, lasculturacambia.Lacontrazioneel’espansionedellasculturadipendonodaimovimentidello
spettatore.Passodopopasso lapercezionenonsoltantodellascultura,madell’interoambientesubisce
uncambiamento.
Già negli anni Ottanta il californiano aveva dichiarato che i suoi lavori avevano
maggiormenteachefarecon“l’anticipazione,lamemoriaeiltempo,eilcamminareeil
guardare, piuttosto che semplicemente l’osservare una scultura come si osserva un
dipinto”102.
Questipezzi,a livellomoltosemplicesonosul camminare esul guardare.E sullo staredentro
uno spazio limitato dove, semmai se ne rivelasse qualche contenuto, devi fare attenzione ad
ogni parte della superficie che ti circonda. Il lavoro, nella sua deformazione, ti chiede di fare
propriocosì.Nonèpossibilenonfarlo.Appenaentridentroquestipezzientri inundialogocon
la loro esistenza fisica. Diventi complice della tua stessa visione, del tuo comportamento,
dovendo cercare di gestire cosa succede. Le informazioni teoriche non ti aiutano quando li
guardi103.
LacoerenzafraletreoperededicatedaRichardSerraallaShoahconilrestodel
la sua produzione si rispecchia nella vicenda di Tilted Arc, che per quanto ormai ben
nota, merita di essere ripercorsa per sommi capi104. Serra, interpellato dalla United
StatesGeneral ServicesAdministrationnell’ambitodelprogrammaArt inArchitecture,
installaTiltedArcnel1981nellaFederalPlazadiNewYork. Ilpuntodiriferimentonel
102 Richard Serra con Midory Nishizawa, Akiri Ikeda Gallery, Nagoya ‐ Tokio, 1986, pp. senza
numerazione.103RichardSerraeDavidSylvester,inRichardSerra,catalogodellamostra,cit.,p.193.104Sull’operaelasuaparticolarevicendaesisteormaiunabibliografiaconsolidata.Inquestasede
si rimandaaPublicart,publiccontroversy.TheTiltedArcontrial,acuradiS. Jordanetalii,ACA
Books, New York 1987; Richard Serra’s Tilted Arc, a cura di C. Weyergraf Serra, M. Buskirk,
StedelijkVanAbbemuseum,Eindhoven1988;ThedestructionofTiltedArc:Documents,acuradiC.
WeyergrafSerra,M.Buskirk,conun’introduzionediR.Serra,TheMITPress,Cambridge‐London
1991;Critical issues inpublicart,acuradiH.F.Senie,S.Webster,Smithsonian InstitutionPress,
Washington,1992;M.Codognato,op.cit.,p.32;A.Zweite,op.cit.,pp.70‐72.
50
suopercorsoècertamenteilSaintJohn’srotaryarc,realizzatosempreaNewYorksolo
pochi mesi prima. Anche per questo tutto lascia pensare che le polemiche suscitate
dall’installazione di Tilted Arc siano destinate pian piano a riassorbirsi. Nel 1985 la
questione torna invece agli onori delle cronache. La stessa United States General
Services Administration, che nel frattempo aveva operato un ricambio dei quadri
dirigenziali, adesso chiede infatti di spostarla in altra sede. Serra, rivendicando che il
pezzo è site specific si oppone con forza. La cosa finisce molto male. Sebbene
un’inchiestapopolarediaragioneall’artista,il15giugnodel1989unacorteformatada
cinquegiudicidecideinfattidismantellareedistruggereTiltedarc,cosaeffettivamente
accadutaentrolostessoanno105.
Lacriticaètornataspessosull’episodio,valutandoinparticolarelerimostranzedi
naturatecnico‐pratica.Ancorpiùsempliceèstatalaletturadell’ostilitàdiSerra:alpari
diquantocapitaconilrestodellesueopere,l’artistaavrebbeconcepitoTiltedArccome
un lavoro rigorosamente site specific,unprincipio su cui non è disposto amediare in
alcunmodo.Nonècertoquestalasedeperentrarenelmeritoesvisceraretuttiiproei
contro.Giovatuttaviaricordarecome ilmantenimentodelsitooriginalerappresenti in
RichardSerraunprincipio,nonundogma:dasolo, l’episodiodeI sommersie isalvati
dimostra come in presenza di condizioni adeguate egli sia anche disposto a cambiare
ideaedamutarlo.
LavicendasispiegaassaimeglioallalucedeiconnotatisocialiepoliticidiTilted
Arc,questi sì legati indissolubilmentealla suacollocazione.Va ricordato in particolare
comel’operavengacostruitadinanzialloJacobK.JavitsFederalOfficeBuilding,dovefra
l’altro ha sede il locale ufficio di immigrazione, lo United States Citizenship and
Immigration Service, o USCIS: ogni giorno la Federal Plaza viene dunque percorsa da
impiegati che si recanoal lavoroe riempitadalle lunghecode formatedacentinaiadi
stranieri inattesadirinnovare ilpermessodisoggiornonegliStatiUniti. Insintesi,per
l’artistailcontestonaturaleedancheilsignificatoultimodiTiltedArc‐secondolalinea
poeticagiàevidenziata‐coincidonoconl’immigrazioneeconimeccanismidicontrollo
impostidalgovernoamericano.
Ora,ifenomenimigratorielepolitichediaccoglienzacostituisconounodeiperni
su cui gira l’Occidente moderno e nel contempo anche uno dei principali indicatori
105M.Codognato,op.cit.,p.32.
51
dell’effettivo grado di democrazia all’interno dei singoli paesi. Questo assunto, ancor
oggivalido,loèancorpiùnellasecondametàdeglianniOttantadelventesimosecoloin
un luogo come New York, per antonomasia il luogo simbolo dell’ospitalità e della
coesistenza fra diverse culture ed etnie.Nulla perciò di strano che altri artisti oltre a
Serra affrontino in quel periodo il tema diTilted Arc. Un primo confronto, pressoché
automatico, può stabilirsi con Liberation, il già citato lavoro di Nathan Rapoport. Per
riassumere quanto già detto, nello stesso 1985, allorché la vertenza controTiltedArc
assume risvolti drammatici, lo scultore polacco forgia la tessera di un mosaico
dall’inequivocabileindirizzopolitico.PartendodallavicinaStatuadellaLibertàetenendo
contodell’imminenteconversionediEllis Island inmuseodell’immigrazione,Rapoport
giustoallafocedelfiumeHudsoncontribuisceinfattiaplasmarel’immaginedegliStati
Uniticometerradelleopportunitàedellelibertàindividualigrazieappuntoallavirtuosa
integrazione delleminoranze storiche, a cominciare appunto dall’ebraica.Un secondo
paragone, per certi versi ancora più calzante, vede al centro un prodotto
cinematografico,ossiaGreencard. Il film, scrittoedirettodall’australianoPeterWeir,
divideinnanzituttoconTiltedArc iltemadifondo:orchestratoneitonidellasofisticata
commediaagrodolce,essopremeilpedaledelsentimentopersottolineareleragionidei
protagonisti e l’attrito con la normativa statunitense inmateria di immigrati. Comune
risultapoibuonapartedelleambientazioni. Le intervistevoltea controllare l’effettivo
valore legaledelmatrimonio fra la cittadina statunitenseBrontëParrishe l’immigrato
clandestinoGeorgeFauresisvolgononell’Agenziad’ImmigrazionenellaFederalPlaza;le
scene finali della loro storia d’amore nella piazza antistante lo Jacob K. Javits Federal
OfficeBuilding.Weirnelcomplessoritienelapresenzadellostranierounfattorepositivo
di cambiamento, in grado cioè di incidere in modo favorevole sull’esistenza di una
cittadina americana forse più sofisticata, ma non di meno chiusa entro una gabbia
ideologica sterile e precostituita. Il film si guarda però bene di andare oltre. Il suo
congegnoprevede lapienacondivisionedella leggeedelpersonale incaricato di farla
rispettare: ne deriva l’inevitabile condanna dei due protagonisti, che in fondo
rimangonovittimediséstessiedellorocomportamentotrasgressivo.Sipuòpensareal
massimoaunaprospettivadiriformaodicompromesso,fautricecioèdiunsistemache
sappiainterfacciarsiinmodopiùsensibileconlesituazionichesipresentanodivoltain
volta.
52
Nell’affrontare il fenomeno delle migrazioni Serra, al di là della sua effettiva
collocazione politica, sembra tuttavia respingere vuoi l’interpretazione in positivo di
Rapoport, vuoi quella blandamente riformista di Weir. Tilted Arc infatti si pone nei
termini di crisi, disturbo, frattura.Quello di Serra è un segno dirompente ed al limite
eversivo:unosfregiodeliberatoalpavimentodellaFederalPlaza, lacuievidentefonte
d’ispirazioneeralastellamichelangiolescadelCampidoglio,aRoma.Serraridicolizzachi
paventa il rischio che Tilted Arc nel giro di poco tempo venga rovinata dai graffiti,
diventandounlaboratoriodeiwritermetropolitani:ilsuoscopoèinfatticheessadiventi
partecipedelpresente.Nullad’altrocantorisultatantolontanodallasuapoeticaquanto
le categorie del ‘bello’ o del ‘gradevole’: “I don't think it is the function of art to be
pleasing”, dichiara onestamente106. Ovunque egli evita di stabilire con il fruitore un
rapportodiempatia, tantomeno lo solleticao lo lusinga.Qui, comedel restoaltrove,
l’obiettivoèrealizzare iconepsicologiche ingradodirichiamare inciascundestinatario
visioni primordiali, o minimali: come appunto ‘lo stare’, ‘il bloccare’, ‘l’esistere’, o il
‘misurare’. Lo scultore californiano insomma dimostra di avere conservato integra
quell’energia che, sia pure sotto formediverse, aveva sperimentato già nella seconda
metàdegli anni SessantanegliSplashpieces, oSplash test, valeadire con il lanciodi
piombo fuso contro i muri o sul pavimento. Al tempo i suoi riferimenti
all’espressionismoastrattoavevanodimostratolavolontàdiconfrontarsiconiconcetti
diforza,dienergiaediviolenza,applicatiallamateriaoaiprocessi107.Findaallora, in
ognimodo, la poetica del ‘gesto’, al tempo comune a un congruo numero di colleghi
appartenenti alle avanguardie, si era tradotta in un processo intensamente creativo e
costruttivo. L’aggressione diretta, fisica e quasi brutale verso lamateria si era perciò
combinataadunacalibratacoscienzadelruolodell’artistanellasocietàcontemporanea
edellospaziodilavoro.TiltedArc,disturbandoilcamminodellepersonecheognigiorno
si recano inquell’ufficio,deviando il loro percorsoabituale, interviene sull’eserciziodi
unpoterediscriminatoriofragliamericanieilrestodelmondo.EccoperchéTiltedArcè
realmente site specific. Ecco perché Serra rifiuta di spostarlo: in questo modo essa
106Sull’atteggiamentoditolleranzadiSerraneiconfrontideigraffitisivedaancheA.Zweite,op.
cit.,p.10.107 L. Blumberg, Introduction / Introduzione, in Richard Serra.Weight and measure drawings,
catalogodellamostra(Roma,1999‐2000),Westzone,Venezia,1999,pp.senzanumerazione.
53
perderebbe davvero il proprio significato, che le viene trasmesso esattamente dal
contesto.Edecco infineperché ladecisionefinaleèdistruggerlo. Ironicamente, l’anno
successivo, il 1990, la giuria degli Academy Awards deciderà di premiare con la
nominationperlamiglioresceneggiaturaoriginaleilsuoequivalenteriformatore,Green
Card:unfilmcheritraelaFederalPlazafinalmentesgombra.
Ed’improvvisomiopadremiabbracciò,non
con tenerezzamaquasi selvaggiamente. E quando
nelbuiolamiamanocapitòsullasuafaccia,invece
degli occhiali trovò delle lacrime. Fu quella l’unica
voltainvitamiaincuividimiopadrechepiangeva.
Inrealtàneanchealloralovidi: lovidelamiamano
sinistra.
54
Appendicedocumentaria.IntervistaadAngelikaSchallenberg,curatricedelprogettoartisticodellaSinagogadiStommelnperlacittàdiPulheim,inGermaniaPaoloCoen‐Dott.ssaSchallenberg,possoconoscereilsuoesattoincariconell’amministrazionecomunalediPulheim,dovesitrovalasinagogadiStommeln?AngelikaSchallenberg‐Dalmomentochenonsiamounmuseononesisteunaposizioneassimilabileaquelladelcuratore.LamiaposizioneufficialeèdiDirettricedellasezioneculturalediPulheim:sonodifattoun’impiegatadelserviziopubbliconelconsigliocomunalediPulheim,conl’incaricodiorganizzareilprogrammaculturale,incluselemostrenellasinagogadiStommeln.PC‐SullabasedellastoriadeltuttoparticolaredellasinagogadiStommeln,potrebbedescrivereilprogettoartisticoinetàcontemporaneanellesuesingolearticolazioni?AS‐Lasinagoga,com’ènoto,nonvennedistruttadurantelacosiddettaNottedeiCristalli[del1938]perchégiàl’annoprima,nel1937,uncontadinoneeragiàentratoinpossessoeriutilizzatacomeunasortadideposito.Nel1979essavenneacquistatadalcomunediPulheim:irestauri,iniziatinel1981,sisonoconclusinel1983,quandolasinagogaèstatariapertaalpubblico.Daalloral’edificioèstatoutilizzatocomesededieventiculturali(emessoadisposizionedellacomunitàebraicadiColonia).
Alungotermine,però,ilprogrammaculturaleiniziale,costituitodaconcertipersolisti,conferenzeemostred’arte(dipintiefotografie)sirivelònonconvincente.Glispettatorieranopochiesempreglistessi,unaventinadiresidentilocaliimpegnatipolticamente.Venneallorapostoilproblemasequestofosseunutilizzoappropriatodiunmonumentoememoriale;comepotesseincrementarelaconsapevolezzadell’edificioedellasuastoria.QuestadiscussioneeragiàincorsoquandoioiniziaialavorareperilcomunediPulheim.LepersonealloracoinvolteeranoilDott.GerhardDornseifer,miodirettosuperioreedilDott.KarlAugustMorisse,alloracapodell’esecutivoepiùtardisindaco.L’idea,semprelastessa,eracheavevamobisognodiorganizzarequalcosadieccezionale,qualcosachepotesseinteressareilgrandepubblicoechepotesseconvogliarepiùpersoneall’anticasinagogadiStommeln.
Nel1990DornseiferfeceritornodaunincontroconWilfriedGies,unsuoamicoartistadiColonia,conl’ideanellasinagogasiteneressero“mostreinusualidigrandiartisticontemporanei”;percitareallaletteralasuaintroduzione“ArtProjects.SynagogeStommeln”(p.20),eglipensavaaduna“seriediinterventiartistici(...)capacidiinteragirestrettamenteconilsito,lasuaarchitettura,lasuastoria”.
L’incontrofraGieseDornseiferelalorodiscussioneful’impetoallabasedelprogetto:amiamemoria,giàallorasifeceroinnomidiKounellisediSerra.Mavieraun’altrapersonaancoranecessariaarealizzarelenostreambizioseidee:alludoquiallaDr.KatharinaWinnekes,cheall’epocastavalavorandoperKunststationSt.PeterechepiùtardiavrebbelavoratoperKolumba,ilmuseod’artedell’ArcidiocesidiColonia.All’epocaellaagìcomeunasortadiadvisor;piùtardifuancheresponsabiledelcontattoconJannisKounellis.PC‐Dott.ssaSchallenberg,leistessahaappenacitatoGerhardDornseifer,ormaidatemposcomparso,comeunadelleanimeprincipalidelprogettoartisticodiStommeln.Puòdirciqualcos’altrosudilui,interminipersonalieprofessionali?AS–Sì,ineffettiGerhardDornseiferèmortonel2001.Lasuaesattaposizionenelconsigliocomunaleeradi"Beigeordneter",checorrispondepiùomenoadassessoreagliaffaripubbliciealtempostessoaiservizisociali,allagioventù,allosporteamoltealtrecoseancora.Dornseifersieralaureatoinleggeederaparticolarmenteinteressatoagliaspettifilosoficideldiritto.Egliera
55
inoltremoltosensibileall’arte.Erainoltreunapersonamoltopersuasiva,completamenteconcentratasuqualunquecosaeglistessefacendo,moltosocievole. PC‐AllamortediDornseifercomeavvenneilpassaggiodiconsegneinsuofavoredapartedelcomunediPulheim? AS‐Inrealtàlecosefuronomoltosemplici.Nel2001l’allorasindaco,ilDr.KarlAugustMorissedecisechedaalloraavreidovutoessereioadoccuparmidelprogettoedellasceltadegliartisti.Daquelmomentoeglistesso,ilsuccessorediDorsneiferFlorianHerpeleilconsigliocomunalediPulheimmihannosupportatoinognimodopossibile. PC‐Soffermiamociancoraunmomentosullaselezionedegliartisti.SonosceltipersemplicementeinbaseallaloropopolaritàoperlalororelazioneconlaShoahedilmondoebraico?AS‐Direinél’una,nél’altracosa.Gliartistieranoesonotuttorasceltiperchéciaspettiamochesianoingradodiaffrontare,diessereall’altezzadellasedeespositiva. PC‐Il“mondoebraico”‐semaiunadefinizionedelgenereèappropriata‐hareagitoinmododiversoalleinterpretazionidellaShoahoffertedagliartisticontemporanei,inparticolaredinanzialladialetticafigurazione/astrazione.QuantohapesatotuttociòsulprogettodiStommeln? AS‐Direipoco,senonaddiritturanulla.Inrealtànoncisiamomaipostidinanzialtemaarterappresentativaoartenonrappresentativa.Credochequestotipodidiscussioneabbiaunrilievoperungenereprecisodimemoriali‐cosachenoinonsiamo.Mad’altrocantoospitareartefigurativainunasinagoganonrisulterebbeincoerenteconalcunisettoridellaculturaebraica? PC‐MainchemodoquestatemageneralesiadattaallavorodiMaurizioCattelanperStommeln? AS‐Anchequi,no,nonèmaistataunacosamoltoimportante.Solo,quellodiCattelanèstatounodeipochissimilavori‐accantoalsuonericordosoltantounaltro‐chehafattoinmodocheunapersonaebreaodioriginiebraichemiabbiamessoapartedidettaglimoltointimidellasuastoriapersonale.L’artefigurativarendepiùfacileallepersoneilmeccanismodiidentificazioneo,cheèlostesso,invitapiùfacilmentelepersoneadidentificarsi.D’altrocantol’altrolavoroingradodiprodurresimilieffettièstatoilmurodiSolLeWitt,unlavorochiaramentenonrappresentativo.PC‐VorreiadessoconcentrarmisuRichardSerra.Vifuunaragioneparticolarepersceglierlocomesecondoartista,dopoKounellis?AS‐Beh,Serraèsemplicementeunodeiprotagonistidellasitespecificity.Quindi... PC‐Mipotrebbedirecom’èiniziatoecom’èandatoavantiilvostrorapporto? AS‐AbbiamoincontratoAlexandervonBerswordt‐WallrabenellasuagalleriaaBochum.ÈstatoluiacomunicareilnostroinvitoaRichardSerra. PC‐Com’èavvenutoilcontattodiSerraconlasinagogadiStommeln?ÈvenutoavisitarlaprimadirealizzareISommersieisalvati? AS‐Primadiaccettareformalmenteilnostroinvitoarealizzareun’operaSerravenneeffettivamenteavederelasinagoga.Inognimodo,egligiàlaconoscevaattraversoalcunefotografie:così,quandoarrivòinvisitaavevagiàun’ideaprecisasucosafare. PC‐Allafinequantevolteèvenuto? AS‐Due.Laprima,comehodetto,pervedereilsitoedecidereseaccettareomenoilnostroinvito.Poièritornatoall’aperturadellamostra.
56
PC‐DurantelasuainteracarrieraSerranonsièmaipresentatocomeun‘artistaebreo’ocomeuninterpretedellamemoriaebraica.D’altrocanto,iltitolostessodell’operaperStommelnsembrapalesareunlegameconquestaidentità.SerranehamaiparlatoduranteilsuosoggiornoaStommelnodurantegliscambifradivoi? AS‐No.Macredocheintalsensoabbiaparticolarepesoquantoeglihascrittosullesueesperienzeinfantilineltestochecihafornitoperpubblicarloall’internodelcatalogo.Credochesiaimportantechelesueparolesianostateusciteperlaprimavoltaproprioinquestaoccasione. PC‐Qual’èstatalareazionedelpubblicodinanziaIsommersieisalvati? AS‐Moltopositiva. PC‐Puòriassumerelevicendesuccessivedell’operadopol’esposizioneaStommeln?Lastorianonèchiara:alcunistudiosiscrivonoancheapropositodiesposizionitemporanee. AS‐Evidentementevièstatounequivoco.Dopolamostral’operavenneacquistatadalMuseoDiocesanodiColoniaecollocatanellerovinedell’anticachiesadiSanktaKolumba.Inoccasionispecialièstatavisibiletemporaneamente,maèsemprerimastaalsuoposto,ancheduranteedopolacostruzionedelnuovoMuseodiPeterZumthor. PC‐Potreiaverequalchedettagliomaggioresull’acquisto? AS‐Guardi,l’operaèstatacomprata.MasevuoleaverequalchemaggioredettagliodeverivolgersialMuseoDiocesanodiKolumba.Nonsonoaffarimiei. PC‐Almenod’inverno,nelpercorsodivisitaattualeilpubblicopuòvederel’operadiSerrasoloattraversoun’inferriata.Noncredechel’attualecollocazioneinqualchemodoescluda,taglifuoril’operadiSerra? AS‐Ladomandachemirivolgefapartedell’equivocodicuiparlavoprima.L’operasitrovaancoraaSanktaKolumbaeamioavvisononèinalcunmodoesclusadalsuopercorso.Delresto,SerranonavrebbemaiconcessoIsommersieisalvatiaunluogooaun’istituzionechenonritenesseappropriati.QuandoilMuseoDiocesano‐piùtardiappuntoilMuseoKolumba‐dimostròilpropriointeresseacomprarel’operaSerraritennecheilsitoeilcontestofosserogiustieaddiritturasovrintesedipersonaall’installazionedeIsommersieisalvati.Bastapoiconsultareilsitowebdelmuseo.Quiilposizionamentodell’operadiSerravieneconsideratocomel’attosimbolico,comesitrattassediunapietradifondazione.
MoltoprobabilmentelaDirezionehachiusol’accessoaIsommersiesalvatiquandoleisièrecatoalmuseo:lacosasideveforsearagionidisicurezza,acausadellagrandequantitàdinevecadutaprimadellasuavisita.Ingenereilsitononèinfattichiusodurantel’inverno:sialerovinechel’operadiSerrasonodinormaaccessibili. PC‐LasciamoadessoSerra.IlprogettodiStommelnhadefinitounnuovostandarddiapproccionelrapportofraarteeShoah.QuantopensacheabbiapesatosuquestoilnuovoscenariopoliticovenutosiacreareinGermaniadopoilcrollodelMuro,nelnovembre1989? AS‐Vuolesaperecosapenso?Noncredochevisiastataalcunainfluenza,almenoaquantonepossasapereio. PC‐ComegiudicailrapportofraarteeShoahnelmondodioggi? AS‐MilasciancoraunavoltacitareGerhardDornseifer.“L’ideadietroalprogettoècontribuireconunatesseraalmosaicochecostituiscel’eticadelricordare.Dobbiamoevitareditrattarelastoriainmodochelenostreattitudinisitrasforminoinunarassegnazioneimmutabile.Accettiamoinvecelasfidadiandareincercaditracce,dicontinuarealeggeresultema,difaredomande.Se
57
facciamoquesto,lememorienonsarannorepresseenonl’obliononsopraggiungerà.Leopered’artepresentatenellasinagogapossonofornireuncontributosignificativonelprocessodiricordareealtempostessorafforzarel’ideacheèimportantecheunamemoriacollettivaevolva.Prendereparteaquestoprocessoèlasfidadell’artecontemporanea”. PC‐Qual’èilfuturodelprogettodiStommeln?Rimarràlostessooppureinqualchemodoprevedecambiamenti? AS‐Nonsonounachiaroveggente.Lecosecambianomentresistannofacendo.