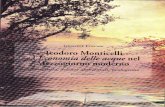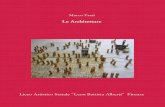Per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l'azione di Andrea Moschetti, in FRANCESCO...
Transcript of Per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l'azione di Andrea Moschetti, in FRANCESCO...
FRANCESCO MALAGUZZI VALERI (1867-1928) tra storiografia artistica, museo e tutela
FR
AN
CES
CO
MA
LA
GU
ZZ
I VA
LER
I (18
67
-19
28
) t
ra s
to
rio
gr
afia a
rt
ist
ica, m
us
eo e t
ut
ela
scalpendi editore
€ 55,00
COPERTINA_MALAGUZZI_GM.indd Tutte le pagine 28/05/14 17:11
CollanaActa studiorum
«Francesco Malaguzzi Valeri (1867-1928).Tra storiografia artistica, museo e tutela»a cura di Alessandro Rovetta, Gianni Carlo Sciolla© 2013, Scalpendi editore, MilanoISBN-13: 9788889546628
Copertina: Leonardo da Vinci, La Belle Ferronniére, Parigi, Louvre
Quarta di copertina: Bottega muranese, Calice detto di Ludovico il Moro, Milano, Castello Sforzesco, Raccolte d’arte applicata
Per i testi© degli autori 2014
Progetto grafico e copertinaFabio Vittucci
Impaginazione e montaggioBarbara Borgonovo
RedazioneSimone Amerigo, Manuela Beretta, Elena Caldara
StampaGrafiche Milani
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.Tutti i diritti riservati. L’editore è a disposizione per eventuali diritti non riconosciuti
Prima edizione: giugno 2014
Scalpendi editore S.r.l.
Sede Legale: piazza Antonio Gramsci 920154 Milano
Sede Operativa: Grafiche Milani S.p.a.via Guglielmo Marconi 17/1920090 Segrate
Direzione Editoriale:via Fontana 1520122 Milano
www.scalpendieditore.eu - [email protected]
Referenze fotografiche
© 2014, Gianpaolo Angelini, Pavia© 2014, Carmelo Bajamonte, Palermo© 2014, CASVA-Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, Civica Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco, Milano. Copyright Comune di Milano-tutti i diritti riservati© 2014, Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (fondo Poppi)© 2014, Comune di Bologna / Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio© 2014, Comune di Bologna / Musei Civici d’Arte Antica / Archivio Malaguzzi Valeri© 2014, Comune di Grosio / Biblioteca Comunale, Archivio Visconti Venosta© 2014, Courtesy of the Cleveland Art Museum© 2014, Courtesy of the National Gallery of Art, Washington© 2014, Luca Carrà, Milano© 2014, Paolo Cova, Bologna© 2014, Ente Raccolta Vinciana, Milano© 2014, Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus, Milano© 2014, Fondazione Cavour, Archivio Visconti Venosta, Santena© 2014, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies / courtesy of the President and Fellows of Harvard College, Biblioteca Berenson© 2014, Museo e Tesoro del Duomo di Monza© 2014, Cristina Principale, Bologna (su concessione degli eredi Malaguzzi Valeri)© 2014, Raccolte d’Arte Applicata, Musei Civici del Castello Sforzesco, Milano. Copyright Comune di Milano-tutti i diritti riservati.© 2014, Andrea Santucci, Bologna© 2014, Tom Sherry, Detroit© 2014, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, Palermo© 2014, Staatlichen Museen zu Berlin© 2014, Stiftsbibliothek, St. Florian© 2014, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Archivio di Stato di Bologna© 2014, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini© 2014, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona© 2014, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese© 2014, Augusto Viggiano, Matera
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributo finanziario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulla base di una valutazione dei risultati della ricerca in essa espressa.
COLOPHON_MALAGUZZI.indd 2 28/05/14 22:15
FRANCESCO MALAGUZZI VALERI (1867-1928)
Tra storiografia artistica, museo e tutela
Atti del Convegno di Studi (Milano, 19 ottobre 2011; Bologna, 20-21 ottobre 2011)
a cura di
Alessandro Rovetta, Gianni Carlo Sciolla
scalpendi editore
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 3 28/05/14 11:17
PresentazioneAlessandro Rovetta, Gianni Carlo Sciolla 6
prima sezione
Gianni Carlo SciollaTra Kunstwissenschaft e Kunstgeschichte als Kulturgeschichte. Francesco Malaguzzi Valeri, le ricerche storico-artistiche e l’impegno per la tutela e la conservazione in italia ed europa tra ottocento e novecento 11
Elena CorradiniFrancesco Malaguzzi Valeri: le ricerche storico-artistiche a Reggio Emilia 25
Lorena CerasiFrancesco Malaguzzi Valeri archivista a Bologna 41
Massimo MedicaFrancesco Malaguzzi Valeri e i primi studi sulla miniatura bolognese (1893-1898) 51
Valeria RubbiIl carteggio tra Francesco Malaguzzi Valeri e Bernard Berenson (1909-1925) 631
Mark Gregory D’ApuzzoFrancesco Malaguzzi Valeri e la scultura del Rinascimento a Bologna: alcune precisazioni e il “caso” della donatelliana Madonna Grassi 73
seconda sezione
Alessandro RovettaFrancesco Malaguzzi Valeri a Milano tra la “Rassegna d’arte” e La corte di Lodovico il Moro 89
Pietro Cesare MaraniMalaguzzi Valeri e Leonardo 107
Marco RossiMalaguzzi Valeri e i pittori del Quattrocento 127
Jessica GrittiL’architettura ne La corte di Lodovico il Moro 135
Paola VenturelliMalaguzzi Valeri e l’oreficeria lombarda: metodi e contenuti a confronto 151
Laura Aldovini«Per ravvivar croci e calici, tabernacoli e paci»: Malaguzzi Valeri e i nielli lombardi al tempo di Ludovico il Moro 163
Sandrina BanderaMalaguzzi Valeri a Brera 173
Francesca TassoMalaguzzi Valeri, le arti industriali e il museo artistico municipale di Milano 177
Simone FerrariMalaguzzi Valeri e l’incisione lombarda del Quattrocento 187
Federico Pecchenini«Quell’argomento interessante ma scabroso». Francesco Malaguzzi Valeri e lo studio dei manufatti tessili nel primo volume de La corte di Lodovico il Moro 195
Cristina GianniniAttilio Steffanoni restauratore e antiquario. Un diario inedito 205
Sandra SicoliL’ispettore Malaguzzi Valeri alla Pinacoteca di Brera: un decennio di attività (1903-1914) 217
Letizia LodiFrancesco Malaguzzi Valeri e Luca Beltrami nella storia della tutela in Lombardia 241
sommario
malaguzzivaleri_sommario 2 29/05/14 00:38
Amalia PaciaMalaguzzi Valeri e alcuni casi di tutela in Lombardia 259
Giampaolo Angelini«Al sicuro dagli indotti e dai mercanti del tempio». Francesco Malaguzzi Valeri in Valtellina e alto Lario, 1904-1906 271
Simonetta CoppaFrancesco Malaguzzi Valeri e la Val d’Intelvi. Trentanove schede di sopralluogo e un articolo sulla “Rassegna d’arte” (1908) 283
terza sezione
Gian Piero CammarotaFrancesco Malaguzzi Valeri direttore e soprintendente 293
Marinella PigozziFrancesco Malaguzzi Valeri e Igino Benvenuto Supino, legami e dissonanze 319
Paolo GiulianiFrancesco Malaguzzi Valeri e la fotografia.Storie e restituzioni, da Brera alla Romagna tra editoria e storiografia 327
Donatella Biagi MainoMalaguzzi Valeri. Le due anime del Settecento e il Congresso mondiale di filosofia a Bologna 347
Silvia BattistiniFrancesco Malaguzzi Valeri e il Museo Davia Bargellini 351
Luca CiancabillaBologna «Mecca degli antiquari». L’affaire Malaguzzi Valeri 361
quarta sezione
Fabrizio FantinoTra erudizione e tutela: gli studi storico-artistici a Torino al tempo di Malaguzzi Valeri 375
Laura GalloEruditi e documentaristi in Piemonte tra fine Ottocento e inizio Novecento 385
Franco BernabeiIntellettuali, eruditi, istituzioni nel Veneto di fine Ottocento 395
Marta NezzoAmbientazione della storia come regia di una memoria identitaria: la Kulturgeschichte di Pompeo Molmenti 403
Giuliana TomasellaPer una nuova fruizione del Patrimonio artistico: l’azione di Andrea Moschetti 413
Cecilia PreteLe Marche ai tempi di Malaguzzi Valeri: da Anselmo Anselmi a Luigi Serra 425
Cristina GalassiUn episodio umbro di Kulturgeschichte: Michele Faloci Pulignani e Le arti e lettere alla corte dei Trinci 433
Nadia BarrellaStoria delle arti, delle industrie, del regno: Benedetto Croce e le proposte di musealizzazione del Palazzo Reale di Napoli nei primi decenni del XX secolo 441
Simonetta La BarberaPercorsi di critica a Palermo dal 1890 al 1920 449
Carmelo BajamonteStoriografia artistica in Sicilia negli anni di Malaguzzi Valeri con aggiunte su Antonino Salinas e il Museo di Palermo 459
Roberta Cinà«Tutto egli raccoglieva e accoglieva nel Museo...». Aspetti dell’attività di Antonino Salinas 469
malaguzzivaleri_sommario 3 29/05/14 00:38
Il convegno di studi Francesco Malaguzzi Valeri (1867-1928) tra storiografia artistica, museo e tutela si è tenuto a Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore e Pinacoteca di Brera) e Bologna (Museo Civico Medioevale, Pinacoteca Nazionale e Museo Civico Davia Bargellini) dal 19 al 21 ottobre 2011. A distanza di poco meno di tre anni escono gli atti che ci auguriamo diano ulteriore respiro al dibattito che in quella occasione si era avviato con notevole vivacità.Dedicare un convegno a Francesco Malaguzzi Valeri ha voluto dire recuperare un protagonista degli sviluppi della Storia dell’arte in Italia complesso e problematico, ma non per questo meno determinante e significativo, al punto che il tentativo di ricomprenderlo si è prontamente spalancato sul più ampio orizzonte nazionale ottenendo uno spaccato suggestivo della persistente influenza della Kulturgeschichte sulla storiografia, sulla tutela e sulla museologia italiana tra Otto e Novecento, ben oltre gli ambiti privilegiati dallo studioso emiliano.Quasi tutte le voci che hanno animato le giornate milanesi e bolognesi sono ora rifluite con ulteriori approfondimenti e argomentazioni in questi atti, che ripercorrono passo dopo passo la carriera di Malaguzzi Valeri cercando di comprendere i diversi contesti di riferimento e i parallelismi, se non le interazioni, con il panorama italiano ed europeo. Solo il poderoso contributo di Richard Schofield, Malaguzzi Valeri e Bramante, prevalentemente volto alla riscoperta di una dimenticata residenza milanese dell’età di Ludovico il Moro, ha trovato spazio sulla rivista “Arte Lombarda” (167, 2013/1, pp. 5-51) con il significativo titolo: Bramante dopo Malaguzzi Valeri.
La sequenza dei contributi qui pubblicati segue da vicino i soggiorni e i trasferimenti di Malaguzzi Valeri. Dalla formazione tra Reggio Emilia e Bologna, che subito identifica e valorizza la sua indole di archivista votato alla ricostruzione storica di opere e monumenti, si giunge al fortunato approdo milanese, che lo vede prima all’Archivio di Stato (1899) e poi alla Pinacoteca di Brera (1903), introdotto e protetto da personalità come Ippolito Malaguzzi Valeri e Corrado Ricci. È soprattutto la sua instancabile attività di ricercatore di documenti a favorirgli la conoscenza dei principali attori della scena milanese – Luca Beltrami, Gustavo Frizzoni, Guido Cagnola, Giovan Battista Vittadini – che presto lo accolgono intercettandone anche la particolare sensibilità editoriale che, oltre a facilitargli la pubblicazione di numerose monografie – Pittori lombardi del Quattrocento (1902), Ricamatori e arazzieri a Milano nel Quattrocento (1903), Gio. Antonio Amadeo (1904) – lo rendono rapidamente protagonista della rivista “Rassegna d’Arte”, organo ufficiale di quel milieu milanese.
Come mostrano diversi saggi di questo volume, il prevalente interesse per la ricostruzione dei nessi tra produzione artistica e assetti culturali e politici, maturato sui fondamenti della Kulturgeschichte europea e vivificato dalle ricognizioni territoriali, rendono gli studi di Malaguzzi una miniera sempre sorprendente di materiali, a dispetto delle polemiche suscitate, molte volte a ragione, dalle sue considerazioni critiche e filologiche.
Al fondo il problema era metodologico, ma venne a scatenarsi nel vivo di un contesto istituzionale e professionale problematico e combattuto, con determinanti accostamenti al mondo del collezionismo e dell’editoria, che alla fine determinò irrigidimenti e contrapposizioni. L’esclusione di Malaguzzi dal concorso alla direzione di Brera, le sue critiche al volume della Storia dell’Arte Italiana di Adolfo Venturi dedicato alla scultura lombarda del Quattrocento, le ripetute stroncature di Roberto Longhi alla Corte di Lodovico il Moro, opera malaguzziana per antonomasia, rappresentano le punte più acute di questo antagonismo.
Vincitori e vinti sono noti, ma obiettivo del convegno non era il risarcimento di Malaguzzi Valeri, quanto piuttosto rilevare e chiarire i fattori messi in campo dalla sua molteplice attività in relazione ai diversi contesti
presentazione
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 6 28/05/14 11:17
da lui intercettati. Accanto alla sensibilità e all’acume spesi nei confronti delle arti applicate, è la conoscenza del patrimonio diffuso sul territorio il lascito più significativo dei suoi studi e della sua attività. Facilitato dalle mansioni di ispettore, prima a Milano e poi a Bologna, e sempre supportato dalle ricerche d’archivio, Malaguzzi ha ampliato in misura straordinaria la conoscenza di monumenti e opere distanti dai grandi centri. È significativo che suo primo collega in questa attività sia stato Pietro Toesca, che seppe riconsegnarci queste acquisizioni con una consapevolezza critica e un fondamento metodologico più rigoroso e moderno.
Mentre a Milano uscivano i primi volumi della Corte, Malaguzzi tornava a Bologna (1914) incaricato di dirigere la Pinacoteca e la Soprintendenza. Qui si chiariscono le sue convinzioni e le sue predilezioni in campo museografico, soprattutto con la creazione del Davia Bargellini, museo di ambientazione prevalentemente destinato alle arti applicate. Non solo, in Pinacoteca Malaguzzi avvia importanti approfondimenti sulla pittura del Seicento e del Settecento bolognese rilanciando la città oltre l’immagine medioevale disegnata da Alfonso Rubbiani. Personalità sempre attiva e propositiva – fondò anche una nuova rivista: “Cronache d’arte” – che verrà piegata dagli scandali suscitati da poco chiari legami col mercato antiquario.
Il convegno e questi atti si chiudono con una felice e articolata risposta all’interrogativo sulla diffusione in Italia di questa lunga coda della Kulturgeschichte: le testimonianze fornite da più parti confermano che Malaguzzi non fu il solo ad avvertire il profondo nesso tra storia della cultura e storia dell’arte, esperito in tempi e modi diversi, lungo tutta la penisola tra Otto e Novecento.
A.R.G.C.S.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 7 28/05/14 11:17
413 per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
L’azione di Andrea Moschetti a tutela e sostegno del patrimonio artistico padovano si protrasse per oltre un quarantennio, dalla fine dell’Ottocento alle soglie della Seconda guerra mondiale, eppure una sorta di damnatio memoriae sembra si sia abbattuta su di lui, forse a causa del fatto che, all’interno dell’università di Padova, dagli anni Venti del Novecento in avanti, si imposero brillanti personalità di storici dell’arte, che ne misero in ombra i meriti e in dubbio il metodo. Giuseppe Fiocco, in particolare, non riconobbe mai a Moschetti un gran rilievo, esagerandone limiti e manchevolezze. I due studiosi, d’altronde, rappresentano molto bene, in modo esemplificativo, due scuole diverse, l’una legata (abbarbicata, da un certo punto in poi) al metodo storico, l’altra fiduciosa innanzitutto nell’occhio, considerato capace di sconfessare perfino il documento.
Moschetti, nato a Venezia nel 1865, apparteneva alla stessa generazione di Malaguzzi Valeri ed era quasi vent’anni più anziano di Fiocco (nato nel 1884). Non deve quindi stupire che faticasse ad adeguarsi ai metodi dei giovani allievi della scuola venturiana; proveniva infatti da una formazione e da interessi assai diversi. A Venezia studiò al Liceo Foscarini ed ebbe come professore di italiano il giovane Pompeo Molmenti, cui restò legato anche in seguito, come testimonia il suo allievo Giulio Lorenzetti1; a Padova si laureò in Lettere nel 1886, discutendo una tesi con il filologo Vincenzo Crescini e fu largamente influenzato dal clima positivistico che all’università si respirava. I suoi maestri e punti di riferimento, Roberto Ardigò, il citato Crescini, Giuseppe De Leva, Andrea Gloria, erano tutti convinti seguaci del metodo storico, accaniti ricercatori di documenti, esperti paleografi.
Subito dopo la laurea, ricoprì incarichi di insegnamento presso vari ginnasi e licei sparsi per l’Italia, da Tortona a Forlì, da Siracusa a Urbino e Lucca. Come ricorda il citato Lorenzetti,
furono questi gli anni in cui fra il giovane docente, dedicatosi ormai con fervore agli studi letterari e il cenacolo di
illustri maestri con a capo Alessandro d’Ancona, a cui più tardi seguirono, in intima unione di intenti e di lavoro,
Vittorio Rossi, Arturo Graf, Emilio Teza, si inizia e si stringe quel legame di fervida operosità nella critica letteraria e
storica che mai verrà meno, anche in avvenire, e di cui, da parte del Moschetti, sono belle prove, oltre alla ininterrotta
Sua collaborazione tra il 1894 e il 1910 nella “Rivista di letteratura italiana”, il gruppo dei suoi primi lavori, in
materia trecentesca e specialmente petrarchesca, frutto di una già solida e meditata preparazione2.
Testimonianza molto significativa, perché consente di collocare Moschetti all’interno della cerchia di alcuni dei più valenti rappresentanti della scuola storica italiana3. Si deve certo anche a tali frequentazioni il suo gusto per l’esplorazione delle biblioteche e degli archivi, alla ricerca di testi inediti e documenti in base ai quali ricostruire biografie, ambienti familiari e sociali, secondo una prassi che in seguito impiegò anche nel campo delle ricerche storico-artistiche. La sua intenzione fu quella di applicare agli oggetti della sua indagine – testi letterari o opere d’arte figurativa – un metodo rigoroso e scientifico, attraverso l’esercizio di una ricerca erudita, l’esame delle fonti, la raccolta di documenti, procedendo con il sostegno di un ricco apparato bibliografico. Cardine del suo metodo, di stampo squisitamente positivistico, fu la centralità accordata al
1 G. Lorenzetti, Commemorazione del membro effettivo Prof. Andrea Moschetti, “Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, CVII, 1948-1949, parte I, pp. 63-77.
2 Ivi, in part. p. 64.3 Sull’argomento rimando a G. Lucchini, Le origini della scuola storica. Storia letteraria e filologia in Italia 1866-1883, Bologna 1990. Per
un approfondimento relativo all’ambito padovano si vedano inoltre C. Dionisotti, Appunti sulla scuola padovana, in Medioevo e Rinascimento veneto con altri studi in onore di Lino Lazzarini, Padova 1979, II, pp. 327-348, e Ugo Angelo Canello e gli inizi della filologia romanza in Italia, a cura di A. Daniele e L. Renzi, Firenze 1987.
per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
Giuliana Tomasella
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 413 28/05/14 11:19
414 giuliana tomasella
contesto storico nell’interpretazione della genesi dell’opera, vista come il prodotto delle influenze incrociate di politica, religione, economia, cultura.
La sua formazione e gli sviluppi della sua carriera sono emblematici del fitto intreccio di competenze, letture, influenze e suggestioni che caratterizzò, fra Otto e Novecento, la nascita della storia dell’arte come disciplina autonoma in Italia. Rispetto alla vocazione di storico di Molmenti, in Moschetti prevalse quella di filologo, come testimonia l’ampia bibliografia giovanile, i cui titoli mostrano un ventaglio piuttosto ampio di interessi, con netta predilezione, tuttavia, per le origini delle letterature neolatine, dalla Chanson de Roland ai codici marciani di Jacopone da Todi, da Dante a Petrarca, in linea con il vivo interesse della scuola storica per questi temi4.
Già nel 1892-1893 lo troviamo incaricato di Storia dell’arte presso l’Accademia di belle arti di Urbino, ma la data davvero cruciale per la sua carriera fu il 1895, quando vinse il concorso per il posto di direttore del Museo Civico di Padova, che allora si trovava nell’area del Santo, nell’edificio progettato da Camillo Boito. Proprio in quel torno di tempo comparvero, nella sua bibliografia, i primi riferimenti all’arte: Penne e pennelli nel secolo XIV (1894), Dell’idea epica nella poesia e nella pittura del ’500 (1896). La prospettiva da cui affrontava questi nuovi temi era quella comparatistica, che gli fu molto cara perché gli consentì di mantenere aperto un canale di comunicazione con i prediletti studi letterari; non c’era ancora, all’interno di queste prime prove, una considerazione specifica nei riguardi delle opere d’arte, per cui gli mancava una strumentazione adeguata. La lenta manovra di avvicinamento all’oggetto passava attraverso i percorsi noti della filologia e della letteratura e quelli degli artisti citati erano poco più che nomi; i caratteri dello stile su cui Moschetti si soffermava rispondevano a una visione sintetica d’insieme, in cui faceva strumentalmente emergere affinità o contrapposizioni con i poeti. Esemplificativo, al riguardo, è Penne e pennelli nel secolo XIV, conferenza tenuta il 6 maggio del 1894 presso l’Istituto di Belle Arti delle Marche, in cui volle mostrare il profondo legame intercorrente fra letteratura e arti figurative, attraverso le analogie rilevate nell’opera di alcune coppie-chiave: Cimabue-Guinizzelli, Dante-Giotto, Petrarca-Jacopo Avanzi, Boccaccio-Beato Angelico. Sia la poesia che la pittura erano viste come il prodotto di una serie di condizionamenti – etici, economici, religiosi, sociali – cui l’individualità degli artisti non poteva mai interamente sottrarsi. Per trovare i primi esempi di un approccio da specialista allo studio delle opere d’arte, bisogna aspettare qualche anno ancora; è ovvio che risulti cruciale, a tale proposito, l’intensa attività di studio e tutela connessa al ruolo di direttore del museo patavino. Spinto a confrontarsi con i vari problemi, documentari, conservativi, attributivi, legati a singole opere presenti nell’istituto da lui diretto, Moschetti via via abbandonò il campo a lui caro della filologia per inoltrarsi, con uguale passione, nei sentieri della nuova disciplina. Si dimostrò talmente sensibile alla necessità di trovare spazi editoriali adeguati all’approfondimento degli studi in questo settore, da fondare, nel 1898, il “Bollettino del Museo Civico di Padova”, cominciando a scrivervi con assiduità5. Del 1899 fu, per esempio, l’intervento sull’Autoritratto del Padovanino, in cui Moschetti procedeva con grande precisione e accuratezza “fotografica” nella descrizione del quadro, mostrando un vivo interesse, oltre che per l’iconografia, anche per la tecnica impiegata dall’artista: «La maniera sua (non so se notata fino ad ora) di filettare e lumeggiare in rosso le carni per dare ad esse le sembianze della vita e mostrarvi quasi la trasparenza del sangue, talvolta lineando di rosso le giunture e le sporgenze o le profonde pieghe della pelle, è qui resa necessaria e portata quasi all’eccesso a causa dei violenti riflessi rossi dello scanno»6. La visione “da lontano”, che aveva caratterizzato i suoi studi precedenti, si rovesciava qui in un esame lenticolare che, perdendosi nel dettaglio, faticava a comporre le singole puntigliose osservazioni in un insieme organico.
Nello stesso 1899, iniziò per Moschetti un’altra esperienza di grande rilievo: l’insegnamento come libero docente (e poi docente incaricato) presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Padova, dove tenne un corso che, pur chiamandosi Letteratura italiana, era in realtà incentrato sui rapporti fra letteratura e arte e prevedeva già
4 Scrive Lucchini in proposito che «il merito precipuo dei seguaci del ‘metodo storico’ fu infatti la riscoperta paziente e minuziosa delle letterature medievali e segnatamente delle origini della letteratura italiana» (Le origini della scuola storica, cit. [vedi nota 3], p. 8). Mi limito, a titolo esemplificativo, a ricordare le seguenti pubblicazioni di Moschetti: I codici marciani contenenti Laudi di Jacopone da Todi descritti ed illustrati, Venezia 1888; Linguaggio figurato. Studio di retorica, Venezia 1890; Il corno di Orlando. Episodio della “Chanson de Roland”. Traduzione in versi italiani, Forlì 1891; Il Gobbo di Rialto e le sue relazioni con Pasquino, Venezia 1893; Noterelle pariniane, “Biblioteca delle scuole italiane”, V, 20, 1893; Chiosa dantesca e Polemica dantesca, “Biblioteca delle scuole classiche italiane”, n.s., VI, 7, 1893; Dell’ispirazione dantesca nelle Rime di Francesco Petrarca, Urbino 1894; Notizia bibliografica petrarchesca, “Rivista delle Biblioteche e degli archivi”, VII, 1, 1896.
5 Sul tema si veda Centenario del Bollettino del Museo Civico di Padova 1898-1998. Arte e cultura nelle riviste specialistiche dei Musei e degli Istituti culturali veneti tra Otto e Novecento, atti della giornata di studi (Padova, 16 novembre 1998), a cura di M. Magliani, M. Varotto e G. Zampieri, Padova 2000.
6 A. Moschetti, L’autoritratto del Padovanino, “Bollettino del Museo Civico di Padova”, II, 1899, in part. p. 52.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 414 28/05/14 11:19
415 per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
la proiezione di immagini. Non appena, nel 1906, la Storia dell’arte venne inserita ufficialmente nei programmi, Moschetti cambiò la titolazione, mantenendo poi il suo insegnamento fino al 1929, quando finalmente fu istituita la cattedra di Storia dell’arte, cui venne chiamato, però, Giuseppe Fiocco7.
Nella direzione del Museo Civico padovano, Moschetti (dopo un intermezzo di Pietro Baita) si trovò a succedere al vecchio Andrea Gloria, al quale naturalmente va ascritto il grande merito di aver creato l’importante istituzione, che accudì amorosamente per lunghi anni, ma che non può certo essere definito uno storico dell’arte, semmai un erudito, oltre che un valente paleografo (per il quale fra l’altro venne creata la cattedra di Paleografia all’università). Il museo e la città divennero per il giovane veneziano un laboratorio, all’interno del quale egli comprese che era necessario mettere a punto strumenti nuovi d’indagine, piegando il metodo storico alle esigenze di una disciplina in fieri. Gli va senz’altro riconosciuta – malgrado la scarsa stima di Fiocco – la capacità di aver operato, da solo, a vari livelli, per promuovere lo studio di un patrimonio artistico di prima grandezza, ma ancora poco noto e poco studiato, a parte alcune emergenze.
Quello che colpisce, considerando la sua attività dagli inizi alla Prima guerra mondiale, è appunto la pluridirezionalità dell’intervento; egli, cioè, si mostrò in grado di diversificare natura e modalità dell’azione, a seconda delle differenti necessità e urgenze. Non si tratta soltanto dell’ovvio mutamento di registro che interviene quando si passi dal livello alto, poniamo, di una rivista specialistica a quello basso di un quotidiano ad ampia diffusione; c’è anche questo, naturalmente, ma non solo. Studiando l’esperienza universitaria di Moschetti è emersa, per esempio, la forte divaricazione esistente fra i temi proposti nei corsi e le coeve pubblicazioni: i primi incentrati sulle grandi personalità della storia dell’arte nazionale, le seconde focalizzate invece sul patrimonio artistico strettamente locale. In particolare, all’interno del “Bollettino del Museo Civico di Padova” venne mantenuto un profilo eminentemente cittadino e non vi si riversò la rete delle relazioni, che egli andava tessendo con illustri studiosi, conservatori e direttori di musei italiani e stranieri. Evidentemente il periodico venne concepito come fulcro della promozione del patrimonio artistico locale, in una prospettiva erudita e documentaria; mentre l’aula universitaria (l’Universitas) era intesa come centro di irradiazione di valori più ampi e condivisi. Non a caso, nel bel saggio del 1903 La funzione odierna dei Musei Civici nella vita municipale italiana8 Moschetti badò a sottolineare bene le differenze di ruolo fra musei civici e gallerie nazionali, mostrando di tenere a un’articolazione precisa del rapporto fra piccola e grande patria. In questo si mostrò anche la distanza da Andrea Gloria, il cui culto della Patavinitas rasentava l’idolatria9. Distinse infatti tra le istituzioni di antica formazione e i recenti musei civici, la cui nascita faceva corpo col sentimento dell’unità e indipendenza nazionali:
Ciascuna città capì che, perdendo la propria individualità politica, non avrebbe tuttavia perduto la propria individualità
storica; – che anzi, quanto le singole individualità storiche fossero apparse maggiori, tanto maggiore sarebbe stata
l’individualità politica collettiva; – che alla costituzione di questo ente complessivo ciascuna doveva recare il proprio
contributo di glorie e di virtù come di sacrificio e di sangue; – che infine l’Italia si sarebbe formata nella fusione delle
memorie dei Vespri colle memorie del Campidoglio e del Peloponneso, nella unione degli splendori artistici di Palermo e
di Monreale e di Agrigento con quelli di Roma, di Firenze, di Milano e di Venezia10.
Di qui la volontà di raccogliere e studiare non solo il patrimonio librario, documentario, artistico municipali, ma ogni traccia lasciata da una storia umana secolare e tutto quanto – dai minerali alla flora, alla fauna – avesse contraddistinto, nei secoli, il territorio. Il nuovo tipo di istituzioni che tale impegno collettivo generò fu caratterizzato dunque, al contrario delle gallerie nazionali, da una connaturata interdisciplinarità:
7 Per un approfondimento in merito, mi permetto di rimandare al mio Le origini dell’insegnamento della storia dell’arte all’Università di Padova. Da Andrea Moschetti a Giuseppe Fiocco, “Quaderni per la Storia dell’Università di Padova”, 35, 2002, pp. 69-96.
8 A. Moschetti, La funzione odierna dei Musei Civici nella vita municipale italiana, Padova 1903. Su nascita, evoluzione e gestione dei musei civici veneti si vedano P. Marini, La formazione dei musei nelle città della Terraferma, in Il Veneto e l’Austria. Vita e cultura artistica nelle città venete 1814-1866, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 30 giugno-29 ottobre 1989), a cura di S. Marinelli, G. Mazzariol e F. Mazzocca, Milano 1989, pp. 300-308; G.M. Varanini, Tra erudizione municipale e metodo storico. Le riviste dei musei civici veneti tra Otto e Novecento, in Centenario del Bollettino, cit. (vedi nota 5), pp. 11-31; G. Zucconi, La nuova figura del funzionario-umanista in un’età di transizione, in Medioevo ideale e Medioevo reale nella cultura urbana. Antonio Avena e la Verona del primo Novecento, atti del convegno (Verona, 28 febbraio-1 marzo 2002), a cura di P. Marini, Verona 2003, pp. 63-75; G.M. Varanini, I musei civici nel primo Novecento e l’identità urbana, in Medioevo ideale, cit. (vedi in questa nota), pp. 83-93; G.M. Varanini, Tra metodo storico e storia delle arti. Percorsi di formazione tra Otto e Novecento in area veneta, in Pietro Toesca all’Università di Torino. A un secolo dall’istituzione della cattedra di Storia dell’arte medievale e moderna 1907-1908/2007-2008, atti della giornata di studio (Torino, 17 ottobre 2008), a cura di F. Crivello, Alessandria 2011, pp. 19-46.
9 Sulla dialettica fra piccola e grande patria in relazione alla tutela dei beni culturali all’indomani dell’unificazione si veda S. Troilo, La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell’Italia unita, Milano 2005.
10 Moschetti, La funzione odierna dei Musei Civici, cit. (vedi nota 8), in part. pp. 4-5.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 415 28/05/14 11:19
416 giuliana tomasella
Da ciò nei municipi, nelle famiglie, negli individui per più di cinquant’anni lo stesso spontaneo, quasi direi incosciente,
desiderio di concorrere con oggetti, con documenti, con ricerche a questo nobile lavoro di ricostruzione del passato. I municipi
rivendicavano a sé il diritto di custodia degli oggetti d’arte tolti dalle chiese e delle carte attestanti la vita dei monasteri e
delle corporazioni allora soppresse, e riordinavano i documenti delle proprie civiche magistrature; i cittadini spogliavano la
casa paterna dei quadri preziosi e toglievano dai forzieri le non meno preziose pergamene dell’antica nobiltà famigliare e ne
facevano omaggio al comune, lieti e fieri di accrescere col proprio lustro il lustro generale. E poi che questi oggetti e questi
libri e questi documenti raccolti dovevano venire conservati e studiati, ne sorsero a poco a poco dei nuovi istituti che per il
carattere loro collezionista si denominarono musei, ma per l’indole loro esclusivamente municipale ebbero l’epiteto di civici. E
furono istituti di un genere del tutto nuovo, poiché non ci fu ramo della vita municipale che non venisse in essi rappresentato.
L’arte v’ebbe il primo posto, non tanto forse per l’eccellenza sua quanto per la sua maggiore appariscenza estetica dilettante
la vista anche del profano; ma accanto all’arte pura trovarono luogo le industrie e del ferro e del legno e delle stoffe e delle
ceramiche, e accanto alle industrie le scienze, i minerali, le roccie [sic], i fossili, la flora e la fauna antiche. Né vi furono limiti di
tempo, come non c’erano stati limiti di materia; dalle rudimentali armi litiche dell’uomo primitivo, dai cocci delle prime terre
cotte si scese giù giù fino alle coccarde tricolori ed ai ricordi dei martiri, il cui cadavere era tiepido ancora. […] Così ciascun
museo fu la personificazione evidente di tutta una storia trenta volte secolare, fu nella grande famiglia italiana, che si stava
costituendo, il rappresentante della genuina nobiltà di ciascun nuovo membro che entrava a farne parte11.
La costruzione dell’identità cittadina – non fondata su leggende suggestive, ma ancorata a una severa indagine scientifica di quanto si era venuto raccogliendo grazie allo sforzo comune – fu sentita come funzionale al rafforzamento del sentimento della nazione e in questa prospettiva venne inteso il ruolo, davvero decisivo, dei nuovi funzionari chiamati a dirigere i musei civici, di cui Moschetti fu ben consapevole, a giudicare dal tono retorico che utilizzò in proposito:
E allora fu necessario in ciascuna città di scegliere uno o più uomini, e si disse loro: Voi siete i depositari di tutte queste
memorie, i custodi, i vindici di questa storia gloriosa; a voi ordinare, illustrare questo enorme materiale tanto eterogeneo
eppure uno solo di origine, a voi rispondere in nome della città a qualunque questione che tocchi l’uno o l’altro dei cento
rami della storia cittadina. E non fu poco!12
In tale azione per la memoria e il patrimonio comune risultò centrale e ineludibile la questione del metodo: esso costituì il collante di una strategia d’intervento diversificata, che si realizzò, come si diceva, a vari livelli.
Questioni di metodo
Proprio nella prelezione al corso libero di Letteratura italiana del 1899, Moschetti fornì un’articolata serie di considerazioni di carattere metodologico; dopo aver enunciato, in apertura, il tema cardine dell’evoluzionismo, «vero e proprio modello analogico della comparatistica»13, propose un approccio interdisciplinare, in cui l’idea di una stretta connessione fra l’arte e l’ambiente che l’aveva generata e fra le diverse branche della cultura, mediata da Molmenti (a sua volta influenzato, fra gli altri, da Taine e Burckhardt), si univa alle suggestioni della linguistica comparata e alla teoria positivistica di una monogenesi delle arti, che Moschetti derivò soprattutto da Roberto Ardigò:
Così, come ben scrisse il filosofo che è vanto insigne di questa università, l’Ardigò, tutti i rami molteplici e diversi
dell’umano sapere si riducono ad un primo unico tronco. Il moltiplicarsi e il diversificarsi di questi rami poi non ne ha
distrutta l’attinenza vitale originaria, e le differenti discipline autonome che ne risultano non cessano del tutto di avere
una correlazione con tutte le altre e una dipendenza da esse14.
11 Ivi, in part. pp. 5-6.12 Ivi, in part. p. 6.13 Lucchini, Le origini della scuola storica, cit. (vedi nota 3), in part. p. 72. Queste le parole di Moschetti: «L’uomo sale, nell’immane
volger dei secoli, l’erta faticosa della civiltà, conquistando mano mano, per gli sforzi collettivi degli individui, delle nazioni, delle razze, i greppi sempre più alti, ed ora sollevando l’occhio verso la meta luminosa che l’attrae, ora soffermandosi un tratto quasi a riprendere lena e volgendosi con amorosa compiacenza a riguardare in giù verso la strada percorsa» (A. Moschetti, Le arti e la letteratura, prelezione a un corso libero di Letteratura italiana nell’università di Padova, 2 dicembre 1899, Padova 1900, in part. pp. 5-6).
14 Moschetti, Le arti e la letteratura, cit. (vedi nota 13), in part. p. 23 (il riferimento è a R. Ardigò, Lo studio della storia della filosofia.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 416 28/05/14 11:19
417 per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
Inoltre, distinse fra metodo storico e critica estetica, utilizzando le formule che erano state tipiche della polemica anti desanctisiana15. Pur non celando i danni che potevano derivare dall’erudizione fine a se stessa, giudicò peggiori i rischi in cui incorreva il metodo opposto:
Né crediate che io, seguace convinto del metodo storico e ad esso guidato fin nei più giovani anni da un mio e vostro
eccellente maestro, valoroso campione di tal metodo, il Crescini (a cui in questo giorno si volge più che mai grato e reverente
l’animo mio) mi nasconda i danni che da esso possono pur derivare o non vegga anche i grandi vantaggi di che è capace il
metodo estetico. Ma, poiché non è qui opportuno divagare dal tema che mi son proposto, dirò soltanto che se il metodo
estetico può talora per la sola felice intuizione di un ingegno svegliato, dare d’un tratto la soluzione dei più ardui quesiti
della storia o letteraria od artistica, lo storico a sua volta può riuscire col più modesto dei documenti, colla più umile delle
indagini a rovesciare pure d’un tratto una intiera teoria dall’estetico sublimemente edificata. E di questi documenti, non
tutti modesti di contenuto, e di queste indagini, non certo umili tutte, ai nostri giorni la critica ha dato innumerevoli alla
luce, demolendo, correggendo, rinnovando grande parte di quello che nella storia veniva da anni o da secoli accettato come
canone indiscusso. […] Oggi non si compendia più, nel nome del Mantegna tutta la scuola padovana del ’400 e in quello
di Tiziano e di pochissimi altri tutta la veneziana del ’500, oggi non s’attribuisce più a Raffaello qualunque Madonna
dalla dolce figura pensosa, né al Veronese qualunque composizione dai colori sgargianti, dai larghi drappi di azzurro e di
porpora; ma dai documenti degli archivi, dai registri dei conventi e delle sacrestie, dalle pergamene delle famiglie escono
nomi nuovi di artisti fino ad ora immeritatamente ignorati, o nomi vecchi tenuti fino ad ora in poco conto acquistano
improvvisamente personalità propria, e si corregge la paternità di cento e cento dipinti, e lo sfondo, in cui campeggiavano
quasi isolate le figure dei più grandi maestri, si anima ora di una vita di cui appena si sospettava l’esistenza16.
Altro scritto importante, sul piano del metodo, fu la risentita risposta di Moschetti all’ingenerosa relazione sul museo padovano stilata da Giorgio Bernardini nel dicembre del 1902 su incarico ministeriale e pubblicata su di un organo autorevole come il “Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica”. In essa trapelava un evidente tono di sufficienza nei confronti delle rivendicazioni localistiche, che portava con sé chiare tracce di quella frizione tra centro e periferia che caratterizzò la fase a cavallo fra i due secoli, in cui venne meno l’iniziale alleanza, alla quale Moschetti mostrava ancora di credere fermamente, che aveva consentito di mettere a punto efficaci strumenti di tutela e valorizzazione all’indomani dell’unità italiana17. Tipico, a questo proposito, risulta l’esordio dell’ampio resoconto, in cui l’autore osservava: «Nelle nostre gallerie comunali accade talora di vedere più e più dipinti attribuiti ai nomi più illustri che vanti l’arte; i quali spesso hanno a fare con gli autori cui vengono ascritti, come il diavolo con la croce; e a questo fenomeno non isfugge interamente nemmeno la collezione che sto esaminando»18. Il che significava, prima ancora di entrare nel merito, lanciare un’accusa preventiva di dilettantismo, che naturalmente (e giustamente) offese moltissimo Moschetti. Utilizzando a sua volta largamente – ma in modo superficiale – criteri morelliani, l’autore
Prelezione, Padova 1881, in part. p. 20).Sull’influsso del positivismo nel campo degli studi storico-artistici italiani si veda G.C. Sciolla, Documento, opera d’arte e analisi dello stile.
L’Archivio Storico dell’Arte e la nuova Kunstwissenschaft, in L’“Archivio Storico dell’Arte” e le origini della Kunstwissenschaft in Italia, a cura di G.C. Sciolla e F. Varallo, Alessandria 1999, pp. 27-71.
15 Lucchini, dopo aver osservato una certa «gracilità» di basi teoriche nei rappresentanti della scuola storica, compreso Pasquale Villari, evidente anche nell’incapacità di mettere a fuoco in modo preciso e rigoroso le caratteristiche del metodo storico in rapporto alla critica desanctisiana, scrive: «La sola monografia di un qualche rilievo sul critico irpino, uscita negli ultimi vent’anni del secolo, Francesco De Sanctis e la critica letteraria (Milano, Hoepli, 1888), di Pio Ferrieri, allievo del D’Ancona, pare, non molto amato, riecheggia il giudizio del Villari, presentando, nel capitolo sulla critica contemporanea del De Sanctis, la nascente scuola storica come il trionfo della concezione ‘scientifica’ della storia letteraria sul dilettantismo ‘geniale’. ‘Quella forma di critica, che sotto la denominazione di storica prevalse di poi, e che altro non è se non un’integrazione del materiale storico, un’indagine e illustrazione di fatti o un giudizio delle opere rigoroso e obbiettivo, prima del ’60 era appena nata. […] De Sanctis, mente filosofica e geniale, non avea né la preparazione di studi necessaria, né la tempra d’ingegno adatta a cogliere allori nel dominio storico e filologico […]. Il suo regno era la critica estetica; […] fuori di essa egli non è che un dilettante. Ma i cultori della critica storica, non lo dissimulino, a lui devono più cose. La fede inconcussa nell’autonomia, nell’evoluzione e nella potenza educativa dell’arte’» (Lucchini, Le origini della scuola storica, cit. [vedi nota 3], in part. pp. 31-32).
16 Moschetti, Le arti e la letteratura, cit. (vedi nota 13), in part. pp. 11-12.17 Osserva Simona Troilo: «L’accusa disinvolta di ‘campanilismo isterico’ esprimeva una frattura grave della relazione locale/nazionale
interna al liberalismo. Era infatti l’idea stessa di patria tramandata dai cultori del sapere locale, ad apparire ormai inadatta a descrivere e a contenere la realtà. Il ‘patto patriottico’ che rendeva possibile l’incontro tra appartenenze, aspettative, ambizioni diverse saltava nel momento in cui la nazione cessava di essere letta attraverso il campanile, ridotto a simbolo di un interesse e di una cultura giudicati ormai estinti» (La patria e la memoria, cit. [vedi nota 9], p. 242). Va tuttavia precisato, data la complessità del quadro di riferimento, che le tensioni fra governo centrale e amministrazioni locali non mancarono fin dalle primissime fasi della tutela, subito dopo l’unificazione, come la stessa autrice ampiamente documenta nel caso dell’area centro italiana.
18 G. Bernardini, La Galleria dei quadri nel museo civico di Padova, “Bollettino ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica”, XXIX, II, 6 dicembre 1902, supplemento al n. 49, in part. p. 2244.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 417 28/05/14 11:19
418 giuliana tomasella
metteva in dubbio numerose attribuzioni, senza peraltro fornire argomenti solidi a sostegno delle proprie tesi e condiva spesso i propri giudizi con notazioni ironiche:
Il nome di Giovanni Bellini lo troviamo sotto tre quadri, nientemeno! Ai numeri 415, 418, 430; ma nessuno di essi può appartenere
al maestro; quello al numero 415 mostra forme tondeggianti e grosse; è piuttosto rozzo, con le pieghe degli abiti un poco gonfie;
porta anche la firma dell’artefice, ma è evidentemente falsa. Il n. 430 ha del pari la firma del pittore, ma in corsivo e si sa che
esso non adoprava che caratteri romani. E qui non posso fare a meno dall’esclamare, che non arrivo a comprendere come si
possano assegnare al patriarca della pittura veneta siffatti prodotti! Sarebbe proprio tempo perso l’insistere ancora a dimostrare
l’esattezza di queste mie osservazioni: l’evidenza è quello che è, non ha bisogno di dimostrazioni, o di argomentazioni19.
Negava le attribuzioni a Giorgione, metteva in dubbio anche la paternità del Polittico De Lazara, ipotizzando la mano di un allievo dello Squarcione, affermava che non c’era traccia di Tiziano nella galleria, nonostante due ritratti (che egli definiva «misere cose») gli fossero riferiti, toglieva un dipinto a Palma il Vecchio e un altro a Veronese e così via, procedendo la sua disamina senza quasi argomentare, come nel caso dei presunti Tiziano: «Ripeto ancora che non faccio discussioni né mi soffermo ad esaminare più particolarmente i segni caratteristici del maestro perché non ne vale la pena: sono cose che saltano agli occhi di primo acchito»20. Proprio su questa arrogante affermazione si imperniò la difesa di Moschetti, che si risolse in un’appassionata perorazione a favore del metodo storico:
Ah, no, signor mio, questa non è libertà, questa è tirannia che ricorda tempi ormai lontani. Da quando il metodo positivo
ha riformato il campo della storia e della critica, i Minosse grandi e piccini, che giudicano e mandano a seconda che giran
la coda, devono essere scomparsi per sempre. Oggi tra gli elementi di giudizio di un quadro l’impressionismo è relegato
all’ultimo posto. Prima han da essere documenti scritti, e, se questi non vi sono, deve sostituirli l’esame minuto, paziente,
intelligente dell’opera e il suo confronto colle opere sicure del maestro. Linea, colore, impasto, ombreggiature, velature,
i particolari del naso, degli occhi, delle ciglia, delle unghie, tutto ha da essere discusso serenamente, seriamente, senza
preconcetti, come in una perizia giudiziaria. E dalla discussione soltanto uscirà fuori la verità, alla quale tutti, anche gli
erranti, si inchinano senza arrossire. Questi fondamenti ha posto al metodo colui che fu maestro della critica italiana, il
Morelli, e su questi fondamenti noi, quanti nel campo degli studi storici positivi militiamo, sogliamo costruire l’edificio
di ogni nostra ricerca. – Ma che ne sa il sig. Bernardini di metodo storico? Egli sembra affettare anzi il più olimpico
disprezzo per ogni testimonianza di documenti. Non solo non li cerca, ma, cacciatigli sotto il naso, non li cura o ne mette
in dubbio, senza dire perché, l’importanza21.
E ancora, alla leggerezza con cui il Bernardini aveva tolto un quadro a Paris Bordon Moschetti contrappose la propria prudenza, la volontà di esprimere giudizi attentamente ponderati:
Con quali cautele io proceda, quali confronti minutissimi io soglia istituire prima di dichiararmi intorno alla paternità di
un dipinto, ho già ormai in più occasioni fatto modestamente conoscere. Sarà deficienza e imperizia la mia, sarà mancanza
di quel colpo d’occhio fatale, che possiede il sig. Bernardini, che possedevano con lui tutti i critici della vecchia scuola, e
che è bastante a giudicare di un dipinto in un mezzo minuto di tempo e a cinque metri di distanza; ma ciascuno fa quel
che può. Così a dimostrare la autenticità di un nostro quadro attribuito a Paris Bordone, io ho impiegato quasi sedici
lunghe colonne di minutissima stampa; il Bernardini, che quelle colonne non può creder certamente degne di lettura,
se la cava con queste quattro parole: È di forme grosse, di brutto aspetto, ma ci apparisce assai rovinato, cosicché non
è impossibile che possa esser uscito dalle mani del maestro. Quel cosicché è di una logicità addirittura stupefacente!22.
19 Ivi, in part. p. 2249.20 Ivi, in part. p. 2253.21 A. Moschetti, Per una «Relazione sulla Galleria dei quadri nel museo civico di Padova». Nota polemica, “Bollettino del Museo Civico
di Padova”, V, 1902, in part. pp. 137-138. Divertente è, in chiusura del saggio (p. 149), quanto Moschetti osserva a proposito del fatto che Bernardini, pur dicendo di essersi soffermato sui dipinti più importanti del museo, non abbia fatto cenno alle tavole del Guariento: «Il Bernardini […] non vide certamente i 29 Guariento che dalla fine dell’aprile scorso occupano un’intiera saletta del museo (una saletta di inevitabile passaggio, si noti bene) e che, tranne per tre o quattro giorni del giugno necessarii alla coloritura delle pareti, non furono mai tolti alla vista del pubblico. Che le varie visite del Bernardini fatte alla nostra Galleria siano avvenute tutte in questi tre giorni? Dimmi la verità, lettore, te ne meraviglieresti dunque? Nota però che quei quadri non avevano sino a pochi giorni fa il cartellino col nome del Guariento, per il motivo che l’operaio, occupato in altri lavori, non aveva ancora avuto tempo di eseguirlo. Che sì, che sì che questa è la ragione dell’inavvertenza del Bernardini? Ecco allora provato che i 29 Guariento non sono autentici, per Bacco!».
22 Ivi, in part. p. 146.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 418 28/05/14 11:19
419 per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
Il dato interessante è che Moschetti qui accusava l’antagonista di appartenere alla «vecchia scuola»; anziché riconoscere nel suo metodo – al di là della superficiale baldanza – il segno di una messa in crisi dell’impostazione di matrice positivistica, preferiva vederne le parentele con una fase anteriore, al di qua della fondazione su basi scientifiche della disciplina; atteggiamento sintomatico, che caratterizzò anche le polemiche contro Fiocco di molti anni dopo e che dimostra, una volta di più, come la già ricordata fragilità di basi teoriche della scuola storica abbia determinato la sostanziale incomprensione da parte dei suoi rappresentanti di quanto di nuovo e vitale – dall’elaborazione dell’estetica crociana alla fondazione di una nuova scuola storico-artistica da parte di Adolfo Venturi, all’influenza del formalismo – stava avvenendo nella cultura italiana.
Un altro esempio – anche se di ben diverso livello ed esaminato senza alcuna acredine – delle derive cui poteva condurre l’assenza di rigore scientifico veniva individuato nella critica «filosofica» di John Ruskin, ai cui Mornings in Florence, nella traduzione francese, Moschetti dedicò una recensione esemplificativa dei limiti di un metodo non rigoroso, in cui denunciò le cantonate che Ruskin aveva preso sia dal punto di vista delle attribuzioni sia da quello dell’interpretazione iconografica:
Al Ruskin, del resto, non sempre faceva difetto soltanto il materiale di erudizione e di comparazione, che fu scoperta e
vanto degli anni più tardi, ma talvolta, appunto per il poco valore che egli mostra di attribuire all’analisi pedantesca o
archeologica del dipinto (come egli soleva chiamarla) e per la tendenza sua a interpretare invece ogni cosa filosoficamente,
l’osservazione e l’interpretazione esegetica stessa riuscivano difettose. Potrei citare, volendo, molti esempi. Nell’affresco
giottesco di S. Croce: Davanti al sultano, il gesto, con cui il santo si tocca la fronte, non vuol dire affatto: «La mia vita
o la mia testa sulla verità di ciò che dico», ma è semplicemente il principio del segno della croce, che il santo si fa prima
di entrare nel fuoco. Nel cappellone degli Spagnuoli l’uomo che porta sulle spalle una falce e una vanga, nel medaglione
al di sopra dell’Astronomia, non indica affatto la brevità della vita umana figurata dal corso degli astri, ma soltanto
l’agricoltura, la quale tanto si giovò dello studio degli astri da potersi considerare la madre di questo studio. Piccole
cose, se vuolsi, ma che bastano talora a fuorviare del tutto l’interprete del dipinto, e che ad ogni modo son indizio della
leggerezza con cui l’interpretazione stessa è condotta23.
Il rigore metodologico che Moschetti rivendicava alla storia dell’arte poteva invece essere attinto dalla grande lezione tedesca, che gli fu molto presente, a giudicare dalla trama delle citazioni che segnano i suoi scritti. Al di là dei richiami ai grandi maestri, da Winckelmann a Lessing, a Burckhardt, i suoi studi appaiono aggiornati sulla bibliografia internazionale recente, in cui gli studiosi di area germanica rivestono un ruolo cospicuo, da Kraus, a Springer, da Zimmermann a Ruhmor, da Dobbert a Thode. Un posto di particolare rilievo occupano, nella sua galassia di riferimento, Cavalcaselle e Crowe, continuamente citati, e Giovanni Morelli, i cui criteri attributivi gli fornivano sufficienti garanzie di scientificità e da cui venne influenzato anche a livello lessicale. Emblematica risulta, a tale proposito, la sua familiarità con il linguaggio settoriale di ambito medico, con aperture anche sul versante della criminologia lombrosiana. Mi limito, a titolo esemplificativo, a un passo relativo agli Scrovegni:
Un tipo tuttavia Giotto ha creato, di maniera sì, ma affatto diverso da tutti gli altri, tipo di meravigliosa intuizione, che
sembra suggerito dalla esperienza scientifica della moderna criminologia: Giuda Iscariote. Già per i pittori precedenti
Giuda rappresentava, diremo così, l’ideale della bruttezza, ma essi non pensavano la bruttezza esteriore se non come
specchio materiale della bruttezza dell’anima; Giotto invece dà a questa bruttezza i veri caratteri anatomici e fisiologici
del delinquente per eccellenza. Nel quadro dove Giuda riceve il prezzo del tradimento e in quello della Cattura troviamo
ripetuto questo medesimo tipo: fronte bassa e sfuggente, cervice manchevole, occhi piccoli e incavati, naso fortemente
23 A. Moschetti, Osservazioni a proposito dei “Mornings” di J. Ruskin, “La cultura”, 26, 1907, in part. p. 248. Va tuttavia precisato che il giudizio di Moschetti su Ruskin non è in complesso negativo; gli riconosce, pur nei limiti appena ricordati, un’indubbia grandezza, anche se ne considera il metodo di indagine irrevocabilmente superato dall’impostazione scientifica dei nuovi studi: «Ora, dopo tutto questo, non si creda che io biasimi la traduzione o la ristampa, alla distanza di circa trent’anni, dei Mornings del Ruskin, o che la lettura io ne creda oggi inutile. Sarebbe press’a poco (fatte le debite proporzioni) come se taluno, incontrando nelle opere di Galileo errori di fatto e di metodo, in gran parte non a lui ma al suo tempo imputabili, ma tali che oggi ne modificano sostanzialmente le teorie, le ritenesse indegne di studio profondo. Anche in mezzo alle imperfezioni dovute a difetti dell’uomo, anche dopo le modificazioni che i nuovi studi e le nuove scoperte hanno portato alle sue teorie, l’opera del Ruskin giganteggia per forza e per novità di concepimento. Ma, poiché sarebbe stato ridevole il dar conto qui del contenuto di quest’opera, ormai divenuta classica e da più decenni universalmente nota e celebrata, ho voluto soltanto metter sull’avviso il comune lettore del modo discreto con cui si deve procedere nel rileggerla. Tenendo conto di tali avvertimenti, l’intima grandezza della estetica ruskiniana si manifesta più pura, poiché per poterla veramente ammirare bisogna pensar bene a ciò che erano al suo tempo la critica e la filosofia dell’arte. E le sue teorie e i suoi postulati, in quanto siano desunti non da fatti erronei, ma da principii genericamente veri ed indiscussi, rimangono e segnano una vera conquista dello spirito sulla verità della storia» (pp. 248-249).
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 419 28/05/14 11:19
420 giuliana tomasella
pronunciato e grifagno, labbro superiore grosso, mento acuminato e sporgente, orecchio basso, angolo facciale ottuso,
barba rada e stentata, l’opposto veramente del tipo, che vedemmo formare per Giotto l’ideale della bellezza umana e che
egli rappresenta nel volto di Cristo. L’accostamento dei due profili nella scena della Cattura non è certamente senza una
deliberata intenzione di antitesi24.
A tale proposito vanno ricordate la frequentazione di scritti quali Il delitto nell’arte, del giurista Bernardino Alimena, e la conoscenza degli studi di Enrico Ferri, allievo di Roberto Ardigò e fondatore della sociologia criminale, che configurano un orizzonte di riferimenti coerente – ancora una volta – con le matrici culturali della scuola storica, che ambiva, sia pur velleitariamente e senza una solida base teorica, a un dialogo con la filosofia positivistica e, in generale, a una sintesi fra scienze della natura e scienze storiche25.
Ciò che trattenne Moschetti al di qua della linea di demarcazione segnata dagli scritti di Adolfo Venturi di quel torno di tempo fu da un lato la fedeltà a una prospettiva comparatistica che appariva di per sé nemica del richiamo venturiano alla specificità (che è anche separatezza) della disciplina e, dall’altro, l’invincibile diffidenza nei confronti delle virtù dell’occhio a indagare la forma e della parola a fornirne una mimesi. Negli scritti di Venturi il termine «comparativismo» ricorre in accezione ben diversa, piegato alle esigenze della nuova storia dell’arte, all’interno della quale è riassorbito, venendo a designare semplicemente il confronto stilistico fra le opere d’arte. Come si sa, è proprio il «vedere e rivedere» che costituisce il fondamento del mestiere di storici dell’arte, assai più dello studio del documento e della fonte, come viene chiaramente espresso: «Vi sono anche ricercatori locali e archivisti, i quali apportano di frequente elementi preziosi, talvolta rivelatori alla scienza, e ritengono che di quegli elementi sia costituita la storia dell’arte confondendo essi la determinazione di una data con l’interpretazione d’una forma»26.
Appunto l’interpretazione della forma nel suo complesso occupa, negli scritti di Moschetti, un ruolo marginale, soffocata com’è dal documento, dall’iconografia e tutt’al più da considerazioni di matrice morelliana che, per loro stessa natura, inclinano a un’analisi parcellizzata dell’opera. È il medesimo limite che è stato individuato negli studi letterari della scuola storica, che pure ebbe eminenti rappresentanti, e che si può senz’altro estendere anche a Moschetti:
La netta separazione e rigida contrapposizione fra concetti e fatti importava un duplice tentativo insuperabile, tra
l’autore (o il testo) e la società, tra la critica “storica” (accertamento e ricostruzione dei fatti) e la cosiddetta “critica
estetica”, affidata al critico di gusto capace di “penetrare” l’arte. I rappresentanti del metodo storico […] si fermarono,
almeno nelle intenzioni, alle soglie dell’interpretazione soggettiva del testo, anche se più volte varcarono tale limite con
intrusioni tra il biografico e lo psicologico27.
Non che manchino considerazioni di carattere formale, ma esse tendono a rimanere allo stato di osservazioni slegate, senza comporsi in una considerazione globale inerente allo stile. Circa i limiti di quell’impostazione, si pensi a quanto lucidamente aveva osservato Adolfo Venturi, in un passo che si connette molto bene anche a ciò che si diceva sopra a proposito del comparativismo:
Volle fortuna che il Cavalcaselle, il patriotta soldato della libertà a Venezia, difensore della repubblica romana, ardente
mazziniano, pensasse, nell’esilio di Londra, a tessere una corona all’Italia, e, primo, applicasse l’analisi comparativa alle
opere d’arte. Non dettò leggi, ma vide molto e profondo, e nella memoria ferrea associò segni, caratteri e tipi. Con la
scorta di quel maestro, la comparazione, aiutata ora dalla facilità de’ viaggi e dalle riproduzioni dirette delle opere d’arte,
ha messo in nuova luce i documenti storici, i documenti più genuini quali sono, per chi sa interpretarli, le opere stesse.
A chiarirli, si provò Giovanni Morelli, indicando alcuni caratteri speciali di questo e quell’artista, alcuni segni della sua
24 A. Moschetti, La Cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto in essa dipinti, Firenze 1904, in part. pp. 94-95.25 In merito a questo tema mi fa piacere citare S. Fantuz, Andrea Moschetti. Ritratto biobibliografico dagli inizi al 1914, tesi di laurea
magistrale in Storia dell’arte, relatrice G. Tomasella, Università di Padova, A.A. 2010-2011; la studiosa ha giustamente messo in evidenza le strette connessioni esistenti fra quanto scrisse Moschetti e I delinquenti nell’arte, di E. Ferri, Genova 1896. In particolare, ha osservato (p. 115) che «non lascia dubbi la concordanza quasi assoluta tra il tipo di Giuda descritto da Moschetti […] e il ritratto del tipo criminale, fornito dall’antropologo Lefort e riportato da Ferri, con ‘testa grossolana e ottusa – volto asimmetrico – occhi piccoli e grifagni – mascelle enormi e quadrate – fronte bassa e sfuggente – arcate sopracciliari e zigomi sporgenti – orecchie ad ansa o puntute […] capelli abbondanti e duri, barba scarsa o mancante’».
26 A. Venturi, Della posizione ufficiale della storia dell’arte rispetto alle altre discipline storiche, relazione ufficiale dei lavori del congresso di Storia dell’arte (Norimberga, 25-27 settembre 1893), ora in Vedere e rivedere. Pagine sulla storia dell’arte 1892-1927, a cura di G.C. Sciolla e M. Frascione, Torino 1990, in part. p. 81.
27 Lucchini, Le origini della scuola storica, cit. (vedi nota 3), in part. pp. 92-93.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 420 28/05/14 11:19
421 per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
fisonomia, la sua firma in quei segni. Il tentativo non riuscì, e può dirsi che furono dal Morelli stesso intravvedute le leggi
delle abitudini artistiche più che determinate, e ch’egli vide meglio che non spiegasse, anzi che, nello spiegare, segnalò
questo o quell’indizio del carattere proprio d’un artista, non il fascio degli indizi necessari per designarne la personalità28.
Il museo e la città
Il metodo che Moschetti via via mise a punto aveva naturalmente un risvolto operativo e prevedeva precise strategie d’intervento. Molteplici furono le prospettive su cui aprì, approfondendole mano a mano che la sua esperienza di conservatore evolveva. Valutò attentamente le tecniche di esecuzione del manufatto e formulò pareri competenti circa le modalità di eventuali restauri; procedette a una sistematica catalogazione del patrimonio museale, che comprendeva tre sezioni: biblioteca, archivio e raccolte artistiche (con pezzi che andavano dall’antichità all’Ottocento), ciascuna delle quali richiedeva competenze peculiari; si occupò dell’allestimento delle collezioni, che, in linea con il gusto del tempo, fu di ambientazione. Va sottolineato, a tale riguardo, come il rigore del metodo adottato lo abbia guidato anche in quest’ambito. La sua proposta era infatti improntata alla misura e sobrietà, poco incline alle intemperanze, che furono tipiche, per esempio, del neo-medievalismo di Antonio Avena a Castelvecchio; in particolare, rifuggì dall’uso e abuso del falso in stile, utilizzando, per l’arredo delle sale, esclusivamente pezzi originali.
Nel 1898, tre anni dopo l’arrivo al museo, fondò – come già si è accennato – il “Bollettino del Museo Civico di Padova”, una delle prime pubblicazioni del genere in Italia, in cui si dava conto dei progressi fatti nella ricognizione relativa alle opere del museo e della città e si lasciava spazio alle dettagliate relazioni del direttore circa nuove acquisizioni, inventariazioni, catalogazioni, restauri, statistiche relative all’afflusso di lettori e visitatori.
Nel 1903 vide la luce il ponderoso catalogo, che venne presentato – non senza una certa fierezza – al Congresso storico internazionale di Roma di quell’anno. Lungi dal configurarsi come dotta pubblicazione specialistica, il catalogo si proponeva quale moderno strumento di descrizione e di divulgazione, arricchito di fotografie e di preziose tavole29. Alle ingenti spese per la sua realizzazione avevano contribuito i notabili cittadini, non solo gli appartenenti alle antiche famiglie nobiliari, ma anche i rappresentanti della nuova borghesia dell’industria e della politica, i cui nomi campeggiano nelle pagine introduttive: forze e tradizioni culturali diverse si erano dunque unite per erigere una sorta di monumento alla città, che voleva allo stesso tempo essere un tributo alla patria.
Moschetti vi affermava la necessità non solo di un incremento delle raccolte, ma anche di una loro catalogazione e riorganizzazione scientifica, già iniziata da Gloria e da lui continuata indefessamente fin dai primi mesi del suo insediamento. Snocciolava con soddisfazione i numeri relativi alla gran mole di lavoro svolto e si soffermava sull’aumento dei visitatori, che attribuiva al nuovo ordinamento delle collezioni e alla ampliata catalogazione di libri e documenti; quanto al nuovo “Bollettino”, precisava che «unico esempio di tal genere in Italia, creato quattro anni fa sul tipo degli Jahrbuch dei musei tedeschi, assurse da modestissimi inizi a forma e ad importanza di rivista storica ed è ricercato con desiderio da studiosi e da istituti e richiesto o accettato in cambio da molti importanti periodici»30. Passava quindi a illustrare i principali nuclei del museo, distinti nelle tre «anime» di archivio, biblioteca, raccolte artistiche. A proposito della pinacoteca, informava che dei 1914 dipinti posseduti, solo 677 erano degni di venire esposti, ma chiariva che «tutti o quasi tutti gli altri, che prima giacevano accumulati nei magazzini, occupano ora le pareti di molte stanze, dove, essendo anch’essi numerati e catalogati, possono formare oggetto di ricerche e di studi per il critico e per lo storico dell’arte»31. Spiegava che per l’esposizione (da cui risultavano ancora esclusi disegni e stampe) si poteva disporre di sole tre sale, il che imponeva severità nella scelta: «Di queste una fu riservata, per obbligo di disposizione testamentaria al legato Emo-Capodilista; delle altre la minore fu data ai quadri di minori dimensioni e l’ultima ai quadri maggiori. Nell’ordinamento di ciascuna delle tre sezioni si seguì il criterio cronologico e storico aggruppando assieme o vicini i quadri del medesimo autore e della medesima scuola o del medesimo tempo»32. Ciò che si evince, anche se Moschetti per motivi “propagandistici” tace su questo, è la situazione di carenza di spazio in
28 A. Venturi, La Storia dell’arte italiana. Discorso letto per la solenne inaugurazione dell’anno scolastico 1904-1905 nella R. Università di Roma, Roma 1904, ora in Vedere e rivedere, cit. (vedi nota 26), in part. p. 74.
29 A. Moschetti, Il Museo Civico di Padova, Padova 1903.30 Ivi, in part. p. 19.31 Ivi, in part. p. 93.32 Ivi, in part. p. 95.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 421 28/05/14 11:19
422 giuliana tomasella
cui egli si trovò a operare, a solo un ventennio dall’edificazione del nuovo Museo Civico, sorto, come si ricordava, all’indomani dell’unificazione su progetto di Boito. Dopo l’attenta presentazione di legati e raccolte, seguiva una stringata analisi delle opere giudicate più rappresentative, in cui finalmente Moschetti faceva qualche concessione alle esigenze di descrizione e di valutazione stilistica. Si concentrava solo sui pezzi più rilevanti della raccolta, documentati fotograficamente in catalogo: dalle tavole ascritte a Giorgione alla Madonna con san Pietro e san Liberale di Marco Basaiti, dal Ritratto d’uomo attribuito ad Alvise Vivarini (ma che egli mantenne dubitativamente ad Antonello da Messina) alla Pala di santa Giustina, dall’Ammiraglio di Alessandro Longhi al San Pietro che guarisce un ossesso di Tiepolo. Invano cercheremmo in queste pagine affondi originali e interpretazioni innovative: qui, come altrove, Moschetti resta al livello, piuttosto superficiale, di una gradevole esposizione, dando conto dei principali aspetti iconografici e compositivi e aprendosi a prudenti valutazioni stilistiche, diluite all’interno di una narrazione molto piana e comprensibile, pensata, evidentemente, per un pubblico di non specialisti. Si pensi alla convenzionale descrizione del dipinto più importante del museo, la pala del Romanino, il cui fine era essenzialmente quello di indurre nello spettatore una stupefatta ammirazione:
Né le nostre parole né la pur nitida riproduzione che qui presentiamo possono rendere un’idea della insuperabile bellezza
di questo dipinto, nel quale la venustà delle forme, la dignità e la ricchezza della composizione, l’effetto smagliante
e pure squisitamente armonico delle tinte s’accordano a formare un insieme di tal perfezione che solo i più grandi
maestri dell’arte italiana, Tiziano e Raffaello, raggiunsero ma forse non superarono. Specialmente le figure del primo
piano, e fra esse in grado supremo la testa di S. Giustina dal volto virgineo acceso di una fiamma d’amore, dagli occhi
come annebbiati dall’estasi, destano l’entusiasmo dell’ammiratore, mentre la bellissima grandiosa cornice originale a
rilievi dorati su fondo azzurrastro, nella quale sono incastonati alcuni tondi col Cristo e con teste di santi, completa la
splendida visione33.
Qui come altrove, l’esigenza della divulgazione fu vivamente sentita da Moschetti, che lavorò assiduamente al rafforzamento del ruolo della piccola patria, attraverso la costruzione di un solido sistema di acquisizioni inerente alle sue opere d’arte; come si diceva, egli era fermamente persuaso di quanto fosse importante la conoscenza dell’eredità cittadina, non solo come collante di un’identità locale, ma come fondamento di una matura coscienza nazionale del patrimonio artistico. Tuttavia, anche in questo caso, la sua posizione appare moderata, lontana da eccessi democratici di matrice ruskiniana e attenta, semmai, alle esigenze di una comunità di “amatori” che avrebbe voluto più ampia possibile, ma di cui, realisticamente, conosceva i limiti34. Così, in un articolo giornalistico del 1903, affidato alle pagine de “Il Veneto”, si dichiarò scettico circa l’apertura domenicale gratuita del museo, preoccupato delle ricadute sul piano della conservazione delle poco rispettose passeggiate all’interno delle sale, fatte da operai e sartine all’uscita dalla messa; lamentò infatti che puntualmente, di lunedì,
o è un quadro che ha ricevuto un’ammaccatura irreparabile, o è una statua su cui hanno inciso il nome, o è una poltrona
antica foderata di stoffa dal colore delicato su cui si son divertiti a fregare un fiammifero con evidente pericolo di
incendio, o è un gruppo di metallo a cui hanno fatto saltar via un pezzo con uno sforzo non lieve, o è un mobiletto a cui
fu strappata vandalicamente una decorazione35.
Il suo impegno per la promozione del patrimonio artistico cittadino appare cospicuo anche al di fuori delle due sedi principali in cui svolgeva il suo lavoro, il museo e l’università. Lo testimoniano sia gli articoli che con una certa continuità andò pubblicando sui quotidiani (come il citato “Il Veneto”), sia due progetti editoriali di diversa caratura e destinazione: il libro del 1904 dedicato alla Cappella degli Scrovegni e la guida di Padova, edita nel 1912 dall’Istituto Italiano d’Arti Grafiche, nella famosa collana dell’«Italia artistica», cui avevano partecipato, fra gli altri, Molmenti con la guida di Venezia e Malaguzzi Valeri con i due volumetti su Milano36.
33 Ivi, in part. pp. 100-101.34 Si pensi, per esempio, alla posizione espressa in più occasioni da Angelo Conti, il quale era convinto della necessità di aumentare le visite
gratuite e serali dei musei, per favorire l’educazione artistica delle classi lavoratrici: cfr. la raccolta di scritti di A. Conti, Dopo il canto delle Sirene, Napoli 1911; si veda, sull’argomento, C. Bertoni, Croce e il ruskinismo italiano: i rapporti con Conti e “Il Marzocco”, in L’eredità di John Ruskin nella cultura italiana del Novecento, a cura di D. Lamberini, Firenze 2006, pp. 31-64, in part. pp. 51-54.
35 A. Moschetti, L’accesso gratuito festivo nelle gallerie e nei musei, “Il Veneto”, XV, 27 agosto 1902.36 Sull’impresa editoriale di Corrado Ricci cfr. M. Domenicali, Corrado Ricci, l’Italia artistica e l’immagine del paesaggio italiano, in A
difesa di un patrimonio nazionale. L’Italia di Corrado Ricci nella tutela dell’arte e della natura, a cura di A. Varni, Ravenna 2002, pp. 53-85, e
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 422 28/05/14 11:19
423 per una nuova fruizione del patrimonio artistico: l’azione di andrea moschetti
Queste imprese editoriali danno eloquentemente conto della capacità di Moschetti di soddisfare – parlando in sostanza degli stessi argomenti – esigenze diversificate, passando dal registro specialistico-erudito a quello di una divulgazione piana ed elementare. Il libro sugli Scrovegni, corredato dalle foto Alinari, gli consentì di affacciarsi alla ribalta internazionale (ricordiamo che venne pubblicato prima in francese, poi in italiano e inglese) e in esso scelse di far convergere i diversi assi della sua ricerca: storico, documentario, iconografico, comparatistico, attribuzionistico, tecnico. Propose un’analisi stratificata e complessa, che scaturiva dall’incrocio di competenze differenti e dal ragionato confronto con gli studi del passato. Vi si coglie molto bene la sua concezione della storia dell’arte come punto d’intersezione di traiettorie distinte, precipitato di esperienze e pratiche diversificate. Il valore del monumento prescelto lo sottraeva a un’angolazione meramente municipale, e l’occasione editoriale venne sfruttata da Moschetti nel senso di un rilancio della piccola patria in prospettiva sovranazionale. Si tratta di una delle opere più impegnative di Moschetti, nella cui produzione tendono a prevalere contributi mirati di natura specialistica, piuttosto che saggi di ampio respiro. Anche in questo caso, tuttavia – e il dato è esemplificativo del metodo – la divisione in capitoli nettamente distinti l’uno dall’altro tende a restituire un insieme sconnesso, in cui ricostruzione storica e dato documentario, valutazioni attribuzionistiche ed ekfrasis si giustappongono anziché armonizzarsi. Le descrizioni delle opere sono copiose e accurate, ma raramente si spingono oltre la considerazione del soggetto e degli stati d’animo dei personaggi, verso i quali Moschetti sembra nutrire una viva e particolare attenzione37, fondendovi reminiscenze albertiane e suggestioni lombrosiane, come si è visto a proposito della descrizione di Giuda; la valutazione relativa allo stile giottesco non è esente da pregiudizi di matrice classicistica, improntata com’è a un’interpretazione di tipo evoluzionistico, che non risparmia rilievi relativi all’imperizia disegnativa di certi particolari o sfondi. Ampio spazio, a ricordo della giovanile passione letteraria, vi ha il parallelo Dante-Giotto ed evidente è la tendenza alla ricerca delle formule sintetiche, capaci di compendiare efficacemente le caratteristiche comuni dell’arte trecentesca:
L’arte trecentista, l’arte che siamo abituati a chiamare dantesca, per antonomasia, solo perché Dante ne fu il più eccelso
campione, nel rendere quelle astrazioni o teologiche, o filosofiche, o morali, che formavano la sua intima essenza, soleva
riunire insieme due pregi che a noi sembrano quasi inconciliabili fra di loro: la plastica materialità dell’espressione
con l’alta e sottile intellettualità dell’idea. […] Giotto dunque non sarebbe stato il sommo artista del trecento se tale
rispondenza non avesse saputo raggiungere al massimo grado38.
Vivissimo appare l’interesse per le questioni iconografiche, dalle fonti letterarie – cui Moschetti riservò notevole spazio – all’identificazione dei personaggi rappresentati, in particolare, all’interno del Giudizio universale; spicca, infine, la notevole considerazione nei confronti dei problemi tecnici e conservativi, che fu il portato della sua concreta esperienza sul campo, a stretto contatto con i restauratori:
Non c’è nessuna prova sicura che le pitture siano state ritoccate a secco, giacché anche fortemente soffregate in vari luoghi col
polpastrello delle dita o con una pezzuola bagnata non lasciarono la minima traccia di colore. E non è neppur vero che il colore
sovrapposto sia caduto o per salsedine o per altro motivo; tutti i colori formano una cosa sola con l’intonaco. Tutti, salvo uno,
ed è ciò appunto che ha tratto in errore il Selvatico. L’ultramarino, appena leggermente tocco colla punta del dito anche asciutta,
si sfarina e scompare totalmente, ed in larghissimi tratti è caduto da per sé o per azione dell’umidità, così che molte vestimenta,
che in origine erano azzurre, ora sono di un colore affatto diverso. Ma ciò prova una cosa sola: che Giotto diede a secco il solo
ultramarino, sciogliendolo probabilmente nell’acqua semplice o con pochissima colla. Difatti l’ultramarino era colore prezioso
e delicatissimo, che facilmente doveva decomporsi o alterarsi, perdendo della sua vivacità e della sua lucentezza; dal che la
necessità di non usarlo a fresco e di non incorporarlo coll’albume d’uovo e con altri eccipienti39.
Zucconi, La nuova figura del funzionario-umanista, cit. (vedi nota 8). 37 Si pensi alla seguente descrizione del Compianto di Cristo, in cui si mette in rilievo la capacità di Giotto di rendere diverse espressioni di
dolore: «Dall’accoramento muto di quell’apostolo, che dall’angolo del quadro guarda la scena straziante, alle lacrime, tanto più dolorose sul volto di un vecchio, del suo compagno, alla disperazione e alle grida di Giovanni, allo spasimo che torce la bocca di Maddalena e che sembra uscire in un rantolo, all’accasciamento che incurva le spalle ed il capo di quelle donne, di cui non vediamo la faccia, l’armonia eterna del dolore umano risuona in tutti i toni. Ma su tante lagrime o mute o gementi od urlanti, sulla desolazione stessa con cui dall’alto rispondono pur in mille guise i celesti o squarciandosi i panni, o strappandosi i capelli, o coprendosi gli occhi, o torcendo la persona, su tante espressioni diverse di dolore che non ha lacrime, che non ha grida, che non ha contorsioni, che non ha moto quasi di muscoli, il dolore di quella madre che ha tolto sulle ginocchia il capo esanime del figlio e accostando volto a volto, quasi labbro a labbro, sembra voler cogliere ancora un soffio da quella bocca, un raggio di luce da quegli occhi, sembra voler trasfondere tutta la propria vita in quel corpo privo di vita» (Moschetti, La Cappella degli Scrovegni, cit. [vedi nota 24], p. 88).
38 Ivi, in part. pp. 112-113.39 Ivi, in part. p. 121.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 423 28/05/14 11:19
424 giuliana tomasella
Al contrario, con la guida di Padova del 1912, egli si dimostrò capace di una sintesi limpidissima, facendo della storia cittadina il collante di una narrazione che si svolgeva anche, parallelamente, attraverso le numerose e belle immagini. Il pubblico a cui si rivolse era non solo quello nazionale dei viaggiatori, ma anche quello locale dei distratti cittadini, poco avvezzi a guardare e a scoprire le bellezze della propria città e a cui era affidato il compito di tramandarne intatto ai posteri il «patrimonio di gloria». La chiusa retorica, in cui fece riferimento all’ignoranza o incuranza con cui i turisti trascorrevano davanti alle mura ferrigne di Padova, senza sospettarne o curarne le «fulgenti bellezze», ben si lega al suo importante contributo al convegno che si svolse a Verona l’anno seguente, nel maggio del 1913, intitolato Utilità e modi di una mutua azione fra le città del Veneto per diffondere la conoscenza delle loro bellezze artistiche e naturali. In esso, Moschetti affrontava il problema (per dir così) costituito dalla prepotente centralità di Venezia, che finiva per assorbire tutto il flusso turistico, marginalizzando le altre, pur importanti, città del Veneto. E indicava alcune possibili soluzioni, molto pratiche e moderne, incentrate, in sostanza, su di una tattica pubblicitaria comune, che trovava il proprio punto di forza nell’uso delle immagini, attraverso il duplice canale delle fotografie stampate su opuscoli che dovevano essere distribuiti, per esempio, negli alberghi, e delle proiezioni luminose che, «piacevole passatempo a vedersi – scrisse – lasciano spesso un’impressione visiva più durevole e più vera»40.
A ulteriore e, direi, estrema dimostrazione di quella pluridirezionalità di intervento che ne caratterizzò l’azione a sostegno del patrimonio artistico, il cultore della paleografia e del documento lasciava qui il posto all’efficiente funzionario, in grado di elaborare moderne strategie comunicative: «Il forestiere è necessario attirarlo di lontano, suggerirgli, presentargli, imporgli quasi, senza che egli se ne avvegga, il desiderio di visitare parte a parte tutta la regione»41.
40 A. Moschetti, Utilità e modi di una mutua azione fra le città del Veneto per diffondere la conoscenza delle loro bellezze artistiche e naturali, Verona 1913, p. 5. Sul superamento della prospettiva cittadina, a vantaggio di quella regionale, si veda ancora Troilo, La patria e la memoria, cit. (vedi nota 9), in part. pp. 239-256.
41 Moschetti, Utilità e modi di una mutua azione, cit. (vedi nota 40), in part. p. 4.
ATTI_MALAGUZZI_VALERI_GM.indd 424 28/05/14 11:19