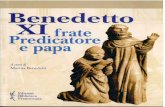A. De Rosa (2014). Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e...
Transcript of A. De Rosa (2014). Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e...
LA GEOMETRIA DESCRITTIVA DALLA TRADIZIONE ALLA INNOVAZIONE
a cura diCesare Cundari e Riccardo Migliari
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
A cura di Cesare Cundari, Riccardo Migliari
Presentazione diCesare Cundari
Contributi diMaria Teresa Bartoli, Vito Cardone, Laura De Carlo, Agostino De Rosa, Mario Docci,
Fabrizio Gay, José Maria Gentil Baldrich, Andrea Giordano, Barbara Messina, Riccardo Migliari, Alessandra Pagliano, Anna Sgrosso, Camillo Trevisan,
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Dottorato in Scienze della Rappresentazione e del Rilievo
Scuola Nazionale di Dottorato in Scienze della Rappresentazione e del Rilievo
Strumenti del Dottorato di Ricerca in Scienze della Rappresentazione e del Rilievo
Nuova serie
diretta da Cesare Cundari
volume n. 2
Comitato scientifico
Albisinni PieroBianchini CarloCarnevali LauraCarpiceci MarcoChiavoni EmanuelaCundari CesareDe Carlo LauraIppoliti ElenaMigliari Riccardi
NB. Il presente volume è corredato da un CD con i testi integrali delle relazioni svolte al Seminario.
Impaginazione
Salvatore De Stefano
Copyright © MMXIV
ARACNE editrice int.le S.r.l.
www.aracneeditrice.it
via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN 978-88-548-7532-6
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore
I edizione: settembre 2014
Indice
Presentazione 9Cesare Cundari
INTRODUZIONE 13La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione 15Riccardo Migliari
LA GEOMETRIA NELL'ANTICHITA' 27Sulla rappresentazione nell'antichità: la visione della circonferenza e della sfera. 29José Maria Gentil Baldrich
La misura nella geometria che descrive l’architettura 53Maria Teresa Bartoli
I SECOLI DELL’OBLIO O, MEGLIO, DELLA CONSERVAZIONEDEL SAPERE 71I secoli dell'oblio o, meglio, della conservazione del sapere: dall'astrazione bizantina ai valori ottici della forma di Giotto, Mantegna e Donatello 73 Andrea Giordano
Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica 95Agostino De Rosa
La stereotomia - Concezione e verifica del progetto e della struttura 121Camillo Trevisan
Monge e la scuola politecnica 139Vito Cardone
PONCELET E LA GEOMETRIA PROIETTIVA 161Genesi proiettiva delle coniche. Le quadriche 163Anna Sgrosso, Alessandra Pagliano
FARISH, SHLÖMILCH, POHLKE, E LA CODIFICA DELL’ASSONOMETRIA 183Un efficace modello per l'assonometria isometrica, che consente anche una semplice formulazione della condizione di perpendicolarità 185Vito Cardone, Barbara Messina
Spunti e riflessioni per una storia della prospettiva parallela 203Laura De Carlo
IL RITORNO DELL'OGGETTO CORPOREO NELL'EPOCA INFORMATICA DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA 229L'Apollo di Felix Klein: categorie geometriche e adeguazione descrittiva 231Fabrizio Gay
Il Ruolo della Geometria nella formazionedell’architetto nel XXI secolo 247Mario Docci
CONCLUSIONI 251Considerazioni conclusive 253Vito Cardone, Riccardo Migliari
Gli autori 255
95
Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica esperimentazione artistica Agostino De RosaIUAV - Venezia
L’intervento affronta l’opera prospettica ed artistica del Padre minimo Jean François Niceron (1613-1646), lacui vita si espresse in un arco temporale assai breve – solo 33 anni –, ma denso di eventi politici e culturali, ri-flessi in opere che si offrono oggi agli occhi dell’osservatore contemporaneo come straordinarie sciarade, inbilico tra rigore matematico e gusto per il meraviglioso e lo stupefacente. Autore di due trattati (il secondo deiquali edito postumo) che sono divenuti pietre miliari negli studi sulla prospettiva seicentesca – La perspective curieuse (Parigi 1638) e il Thaumaturgus opticus (Parigi 1646) –, Niceron fu affascinato pertutta la sua esistenza dall’idea che nella natura si nascondesse un codice segreto divino di cui la matematica, ein primis l’ottica, potevano farsi interpreti, elaborando un lessico espressivo che attraverso la magia artificialene riproducesse la segreta natura configurativa, le leggi formanti del suo farsi e del suo divenire.
The essay is devoted to the artistic and perspectival work by Minim Father Jean François Niceron (1613-1646),whose life was expressed in a very short period of time - just 33 years - but full of political and cultural events,reflected in the works that at the eyes of a contemporary beholder appear as extraordinary charades, in thebalance between mathematical strictness and taste for the beauty and the fantastic. Author of two treaties (the second of which, published posthumously) that have become milestones in studiesof seventeenth-century perspective - the Perspective curieuse (Paris 1638) and the Thaumaturgus opticus (Parsi1646) - Niceron was fascinated throughout its existence from the idea that in nature is hidden a divine secretcode where the mathematics, and in primis the optics could be major interpreters, making an expressive voca-bulary that through the artificial magic could reproduce its hidden configurative nature, the laws of the makingand forming of its becoming.
Il ritratto (fig. 1) mostra un giovane frate dal visoemaciato, delineato da una barba appena accennata,che indossa la tunica con cappuccio tipica dell’Ordinereligioso dei Minimi,1 mentre sorregge con la manola planche di uno dei suoi trattati, quello più prossimoalla data della sua morte, il 22 settembre 1646. L’incisione eseguita da Michel Lasne2 appare comeun paradosso spazio-temporale, soprattutto dal mo-mento che il soggetto del ritratto non avrà il tempomateriale di vedere pubblicata la sua ultima opera,che pure stringe tra le sue mani nell’immagine, e chedunque verrà edita postuma. Se il corpo è rivolto al testo, il viso e soprattutto ilsuo sguardo sono rivolti altrove, oltre i limiti della pa-gina illustrata, verso la sorgente di luce che si riflettenelle sue terse pupille, orientati al di fuori dei cenacolireligiosi e scientifici –romani e parigini– in cui il gio-vane frate minimo visse per gran parte della sua breveesistenza. Jean-François Niceron muore infatti adAix-en-Provence all’età cristologica di 33 anni,
avendo speso la sua giovinezza tra l’esercizio dellefede, la ricerca scientifica e le sperimentazioni appli-cative di una bizzarra, ma affascinante teoria dellamagia artificiale al mondo delle immagini e della per-cezione. Le tracce di questa esistenza sono rarefatte,come sentieri dispersi in una radura improvvisamenteavvolta dalla nebbia, e difficile risulta per lo studiosoavvicinarsi a lui con così pochi punti di riferimento. Scarsi i documenti diretti, molti invece i riferimentiindiretti alla sua vita; stima incontrastata dalle mentipiù notevoli dell’Europa della prima metà del ‘600, epoi il corpus della sua opera scientifica e artistica,spesso negletta e trascurata: queste le coordinate chesi offrono a chi affronti la descrizione del ‘continenteNiceron’, riecheggiate nei versi celebrativi che ac-compagnano il suo ritratto:
“R. P. Joannes FranciscusNiceron ex Ordine Muni-
morum, egregiis animidotibus et singulari mathe-
96
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
seos peritia celebris, obiitAquis Sextiis 22 septem-
bris an. Dni 1646, Æat 33.Ære micat mentis visignea, vultibus ore:
Ars tibi, quid fingis? SuæNiceronis erat.”
Già l’esame della sua unica effige ufficiale, come sidiceva, solleva alcune osservazioni che in qualchemodo ricapitolano il tracciato carsico e obliquo dellabreve vita di padre Niceron. Pur rientrando nel trend stilistico dei ritratti di studiositipici della prima metà del XVII sec.3, che anticipano
la memorializzazione iconografica del soggetto primadella sua morte, l’immagine delineata dal Lasne, nelsuo apparentemente asciutto e ascetico approccio fi-siognomico, offre alcune incongruenze di natura ot-tico-prospettica, il campo di studi di cui proprioNiceron fu campione. Il drappo alle spalle del padre minimo è sollevato, alfine di lasciarci intravedere, da un vano-finestra, ilpaesaggio romano del Pincio e, soprattutto, il con-vento della SS. Trinità dei Monti –dove Niceron sog-giornò–, orientato accidentalmente rispetto al pianodell’immagine: ne scorgiamo appena l’attacco alsuolo, in parte vediamo la doppia rampa che consentel’accesso alla chiesa conventuale che si staglia in tuttala sua elegante simmetricità, con in evidenza le duetorri campanarie di gusto francese. Sulla plache che Niceron sorregge in posizione ver-ticale leggiamo, in calce:
“F. Iaon Franciscus Nice-ron
Delinea Romæ ano Sal.1642
Ætatis Suæ 29”Se ne deduce che essa fu redatta durante il secondosoggiorno romano di Niceron (post gennaio 1641-aprile 1642) e che, in quel lasso di tempo, l’autorestesse elaborando l’edizione latina e le relative tavoledel suo La Perspective Curieuse (1638), un’opera de-dicata a svelare i segreti delle prospettive aberratenote come anamorfosi, e che l’uso del francese avevasottratto ad una più ampia diffusione tra gli studiosidi tutta Europa. La tavola selezionata da Niceron(fig. 2) è la n°13 raffigurante la Propositio Trigesima(30) (fig. 3) dedicata alla rappresentazione prospet-tica di un “un solido stellato sfericamente con pira-midi a basi quadrate”4. La scelta di questo soggetto fu probabilmente legataalla novità tematica che esso simboleggiava, sugge-rendo così, per via grafica, l’ampliamento dell’edi-zione latina rispetto a quella francese. Ritornando all’immagine del cenobio romano raffi-gurato dal Lasne, l’immagine della chiesa appare
1/M. Lasne, R. P. Joannes Franciscus Niceron ex Ordine Muni-morum, egregiis animi dotibus et singulari matheseos peritiacelebris, obiit Aquis Sextiis 22 septembris an. Dni 1646, Aetat33. Incisione. Parigi prima metà del XVII sec.
97
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
leggermente compressa in altezza rispetto alle vedutestereotipate cui l’incisore dovette probabilmente ispi-rarsi: forse la Vue de Rome (1632; National Gallery,Londra) (fig. 4) di Claude ‘Lorrain’ Gellée(1600–1682) che accostava ad una parte ‘archeolo-gica’ di totale invenzione, posta sulla destra del qua-dro, uno scorcio di Trinità dei Monti probabilmenteripreso dal terrazzo superiore della casa dell’artista,all’epoca in via Margutta5. L’immagine del Lorrain, pur mostrando il medesimofianco dell’edifico, non è sovrapponibile a quella diLasne che appare eseguita da una posizione più pros-sima al monumento.
A quest’ultima sono invece decisamente avvicinabilialcune vedute del complesso conventuale di incisorianonimi, risalenti alla prima metà del XVII sec., incui il punto di vista appare più compatibile con quellodi Lasne e che probabilmente ispirarono a loro voltala celebre acquaforte della Chiesa della SS. Trinitàde’ Monti6 (1669) di Giovanni Battista Falda(1643–1678) (fig. 5). Al fine di comprendere la strategia esecutiva del ri-tratto, si è proceduto ad una calibrazione, in ambitodi fotomodellazione, tra le immagini fotografiche at-tuali del complesso e la sua restituzione fornitane dalLasne (figg. 6a, b): il risultato di questo processo di
2/M. Lasne, R. P. Joannes Franciscus Niceron ex Ordine Muni-morum. Dettaglio.
3/J.F. Nicéron, Ioannis Francisci Niceronis... Thaumaturgusopticus, Francisci Langlois, Parigi 1646. Tav. 13.
98
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
accoppiamento delle coordinate spaziali del monu-mento agli omologhi punti rappresentati nelle imma-gini –grafiche e fotografiche–, indica che il punto divista assunto dal ritrattista sarebbe stato collocato acirca -16.00 ml dal sagrato della chiesa, dunque allaquota dell’attuale piazza di Spagna, e in prossimitàdell’attuale via di San Sebastianello, al termine dellaquale si inerpica una delle rampe che raggiunge pro-prio il colle Pincio. Questo dato confermerebbe che l’originario incisore,con tutta probabilità, eseguì il ritratto da una posta-zione remota rispetto allo scenario delineato, cioè daParigi dove la prima edizione del Thaumaturgus op-ticus (1646) fu edita, incorporandola nel suo interno.Lasne non poteva conoscere la topografia della scenafondale da porre alle spalle del ritratto, non essendomai stato a Roma, e per eseguirla dovette basarsi suuna incisione o uno schizzo –forse di mano dellostesso frate minimo?– ritraente il Convento romano
dei Minimi, centro devozionale e di ricerca scientificadel XVII secolo, che vide Niceron protagonista, conle sue opere sia teoriche che decorative.Oppure è ipotizzabile che il set scenografico corri-spondesse ad una vera stanza sita probabilmente alpiano terra, in un immobile appartenente all’Ordinedei Minimi, nei pressi della futura Piazza di Spagna.Nel caso prevalesse questa ipotesi o quella del ‘pla-gio’ iconografico, rubricabile come pratica assai co-mune all’epoca, sorprende invece accorgersi che laveduta della Chiesa minimitana è offerta al nostrosguardo in modalità speculare rispetto alla realtà fe-nomenica dei luoghi: così che l’ala del Convento ap-pare a sinistra della chiesa, e l’area, ancora libera,all’epoca, dall’ingombro di fabbricati, taumaturgica-mente migra alla sua destra, mostrando un muro di-ruto (un contrafforte, come nell’incisione di Falda) edella vegetazione selvaggia che ne invade la sommità(figg. 7a, b).
4/C. ‘Lorrain’ Gellée, Veduta di Trinità dei Monti, 1632. Olio su tela. National Gallery, Londra (Inv. 1319).
99
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
Le fronde di un albero, collocato idealmente tra lastanza che avrebbe ospitato Niceron e la collina delPincio, sono disposte ad arte per nascondere alla vistaporzioni urbane dei dintorni che avrebbero lasciatoimmediatamente intuire il trucco ottico ad un osser-vatore più smaliziato. Ma di un gioco illusionistico si trattava? Forse Lasnee Niceron volevano divertirsi con il lettore –coevo efuturo– del Thaumaturgus Opticus sin dal suo incipit,offrendo una sciarada grafica di gusto barocco chemostrava come anche il più austero e quaresimale au-toritratto possa nascondere un segreto –Vexierbild–dal quale lo sguardo del protagonista, diretto altrove,vuole distrarci o al quale, con la sua ostentata disat-tenzione, vuole suggerirci di prestare maggiore atten-zione, poiché la vista, tra i sensi tutti, è il più fallace. Inizia dunque con un piccolo mistero questa storiache ha per protagonista un geniale padre dell’Ordinedei Minimi, vissuto tra Parigi e Roma in anni mira-
bolanti e complessi (la prima metà del XVII secolo),sia dal punto di vista culturale-scientifico che politico,la cui immagine è affidata a quest’unico ritratto, benpresto divenuto un modello per altri ritratti di suoiconfratelli, in primis per quello agiografico del-l’amico e maestro Emanuel Maignan7 (1601–1676)(fig. 8), e che forse descriveva in tralice la difficiledialettica esistenziale di una vita compressa fra le esi-genze di preghiera, morigeratezza e rinuncia, tipichedella regola dell’Ordine cui egli apparteneva, ed in-vece il continuo contatto mondano con il mileiu scien-tifico e patrizio dei più importanti cenacoli culturalidell’Europa. Sono questi i due poli, rappresentati nell’illustrazionerispettivamente dagli strumenti della conoscenzascientifica e prospettica –un compasso, una squadrae un regolo–, e dal simbolo di vita religiosa e peni-tenziale –l’abito sacerdotale–, tra i quali oscillòl’opera di Jean-François Niceron, immaginiamo non
5/G.B. Falda, La SS. Trinità de’ Monti e Villa Medici, 1669. Incisione. Collezione privata.
100
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
6a, 6ba. Calibrazione degli elementi omologhi per la determinazione del punto di vista da cui la facciata della chiesa della SS. Trinità deiMonti è stata rappresentata nell’incisione di M. Lasne. Elaborazioni digitali: C. Boscaro/Imago rerum.b. Il punto di vista riportato nella Nova pianta et alzata della città di Roma (1676) di G. B. Falda, con una vista della nuvola dipunti. Elaborazioni digitali: C. Boscaro/Imago rerum.
101
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
senza difficoltà, squadernando un universo fatto di vi-sioni apocalittiche e meravigliose.Autore, come si diceva dianzi, di due trattati (il se-condo dei quali edito postumo) che sono divenuti pie-tre miliari negli studi sulla prospettiva seicentesca–La perspective curieuse (Parigi 1638) e il Thauma-turgus opticus (Parigi 1646)–, Jean François Niceron8
(1613–1646) sviluppò sin da giovanissimo un suomondo espressivo che si tradusse in opere dai forticonnotati decettivi: anamorfosi catottriche, giochi ri-frattivi e dipinti murari accelerati prospetticamente(l’unica sopravvissuto, ritraente San Giovanni Evan-gelista che scrive l’Apocalisse in Pathmos, è ora vi-
sibile presso il Convento della SS. Trinità dei Monti,Roma), per citarne solo alcune tipologie. La biografia dell’autore delinea una vita, sospesa traFrancia e Italia, impegnata sia nei dibattiti che si svi-lupparono nei più importanti circoli culturali e scien-tifici dei due paesi, che nelle incombenze teologichee religiose previste dal suo Ordine religioso di affe-renza, quello dei Minimi. Niceron fu affascinato per tutta la sua esistenza dal-l’idea che nella natura si nascondesse un codice se-greto divino di cui la matematica, e in primis l’ottica,potevano farsi interpreti, elaborando un lessicoespressivo che attraverso la magia artificiale ne ripro-
7a,7ba.Confronto fra le vedute di Trinità dei Monti fornite da Niceron (retta) e da Falda (elaborazioni digitali: C. Boscaro/Imago rerum)b.Confronto fra le vedute di Trinità dei Monti fornite da Niceron (speculare) e da Falda (elaborazioni digitali: C. Boscaro/Imagorerum).
102
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
ducesse la segreta natura configurativa, le leggi for-manti del suo farsi e del suo divenire. Il suo percorso gnoseologico attraversò i sentieri delpensiero cartesiano e hobbesiano, le sue opere spessodivenendo uno specchio fedele di coeve posizioni fi-losofiche, pur tuttavia conservando una loro autono-mia stilistica, sia nei contenuti che nella forma. I suoi due trattati a stampa costituiscono uno snodoimportante nella storia della cultura prospettica occi-dentale riassumendo, nel loro sviluppo ‘narrativo’,una delle più avanzate riflessioni sulla nozione di rap-presentazione nell’ambito artistico e architettonicocontinentale del XVII secolo. La complessa e articolata rete di relazioni intellettualiche l’autore stabilì nel suo breve arco esistenziale(solo 33 anni) con le menti più brillanti della primametà del Seicento, collocano il suo lavoro scientificosu un piano di totale congruità rispetto alla produzione
trattatistica coeva, ma anche di straniato isolamento acausa della brusca interruzione del suo estro creativo. Qui ci soffermeremo proprio sull’analisi iconograficadei due frontespizi che adornano le sue opere lettera-rie, così simili eppure densi di allusive diversità chesquadernano, all’occhio dell’osservatore attento, unapluralità di piani ‘narrativi’ e simbolici, così come de-cettiva e perturbante è tutta la sua produzione arti-stica, in bilico fra solida strutturazione e desiderio didissolvenza nel vuoto della forma. Apre dunque lo sviluppo dei due testi ‘gemelli’ unfrontespizio illustrato che assume, in ciascuna delleedizioni, un carattere ben definito, sia in relazione aicontenuti del volume che antecede, sia in rapportoallo percorso intellettuale di Niceron al momentodella loro pubblicazione. Il frontespizio de La Perspective curieuse (Parigi1638) (fig. 9), inciso dal francese Pierre Daret de
8/ J. Michael, Ritratto del Padre Emmanuel Maignan, 1669.Incisione. Parigi seconda metà del XVII sec.
9/J. F. Nicéron, La Perspective Curieuse, ou magie artificielledes effets mervellieux…, chez Pierre Billaine, Parigi 1638.Frontespizio inciso.
103
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
Cazeneuve (1604–1678), ci mostra una serie di eroti(privi di ali) intenti a dilettarsi con strumenti scienti-fici e divertimenti ottico-prospettici il cui funziona-mento verrà spiegato dall’autore, con dovizia diparticolari, all’interno del trattato stesso: uno di loropresta attenzione alla ricomposizione catottrica di unritratto anamorfico di Luigi XIII di Francia che si ri-flette su un cilindro metallico (stesso soggetto che ri-troveremo all’interno del trattato, applicato però adun’anamorfosi conica, e non cilindrica9); un altroguarda dal basso un analogo effetto prodursi su uncono riflettente rovescio, la cui base risulta ancorataall’intradosso di un arco di trionfo10 decorato con unritratto deformato, sempre di Luigi XIII; altri due in-fine si dedicano alla miracolosa ricomposizione, ga-rantita da un apposito cannocchiale munito di unalente poliedrica, ancora del ritratto del Re di Francia,i cui lineamenti somatici sono prelevati diottrica-mente da frammenti di busti di Ottomani,11 dipinti sudi un pannello appeso ad un plinto classico. Non riusciamo a capire se possa trattarsi di un cippo,essendo assente qualsiasi iscrizione (eccezion fattaper il laconico “Daret sculpsit” in basso a destra),forse funerario o celebrativo, come potrebbero sug-gerire i due fusti di colonna spezzati che si appog-giano alla sua base superiore. L’ambientazione bucolica è interrotta dalla bruscapresenza dal grande paramento architettonico in cuisi apre l’arco di cui si diceva dianzi: il fronte dell’edi-ficio presenta colonne con capitelli corinzi che sor-reggono la trabeazione oltre la quale si dispongono,in sequenza ritmica, festoni scultorei.Due medaglioni sono collocati ai lati del fornicedell’arco (sulla cui chiave si trova una lapide recanteil titolo dell’opera), ma solo di quello posto a destrasi intravede il soggetto ivi raffigurato in bassorilievo:una donna (forse personificazione dell’Arte?) è ri-tratta nell’atto di posare una corona di alloro sullatesta di un uomo inginocchiato di fronte a lei. Si tratta, con tutta probabilità, della restituzione alle-gorica di un topos iconografico noto come GloriaeCausa, anche se la didascalia che l’accompagna non
contribuisce a svelarne l’identità12 e non sembra es-sere riconducibile ad un ritratto dello stesso Niceronche, per professione di fede, rifuggiva da riconosci-menti pubblici della propria maestria. L’edifico è sicuramente antico, come dimostrano lelesioni che lo segnano brutalmente, ma solido e pos-sente: in esso, almeno nella parte visibile, sulla destra,si apre una nicchia cilindrico-sferica in cui è inseritauna statua femminile non meglio identificata (forseraffigurazione di una virtù, come suggerirebbe l’astache reca nella mano destra e la cornucopia che la so-vrasta). Così come non meglio riconoscibili13 sono le sculturefemminine che decorano il coronamento dell’edificioche si intravede oltre l’arco, e che si sviluppa in formadi emiciclo su due livelli. Lo sfondo campestre mostra una paesaggio selvaggioe rigoglioso su cui vigilano ancora due statue dalleproporzioni gigantesche, una delle quali totalmenteavvolta in un inquietante panneggio, simile ad unsudario. Come osserva F. Vital-Durand,14 il centro della com-posizione è dominato dal vuoto offerto dall’arco ditrionfo, e da un’orizzontalità diffusa, ma soprattuttodal dispiego di una retorica iconografica che da unlato inscena l’esibizione di strumenti scientifici, comein un museo, e dall’altro allude ad uno spazio labora-toriale dove si sottopongono al vaglio dell’esperienzale nozioni teoriche acquisibili dalla lettura del trattato.In tal senso, non sembra casuale la scelta degli putti(nel numero di quattro, come quattro sono i Libri incui si articola il trattato), creature in bilico tra l’umanoe l’angelico, le cui menti sono ancora aperte e plas-mabili, a simboleggiare il carattere paidetico de LaPerspective curieuse: tuttavia essi non sono rappre-sentati all’interno dell’edificio raffigurato, bensì al-l’esterno o, al massimo sulla soglia (sotto l’arco ditrionfo), l’autore suggerendo visivamente (e poianche verbalmente) che l’accesso all’edifico delleconoscenze prospettiche può avvenire anche per i noniniziati, come recita la citazione greca presentenel frontespizio dell’opera («Kai; agewmevtrhro eij-
104
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
sivtw», ovvero «entri pure chi non conosce lageometria»). Si tratta con tutta evidenza di un calco ‘ad inversione’del celebre motto –citato nella glossa di Elias(VI sec. a.C.) sulle categorie aristoteliche– “ajgewmev-trhroı mhdei;ı eijsivtw”, ovvero “non entri nes-suno che non conosca la geometria” che Platone(427 a.C. – 347 a.C.) avrebbe apposto all’ingressodel suo Mouseion15. Niceron insisterà più volte su questo aspetto nella suaPremessa al lettore, specificando come l’apprendi-mento delle delizie della prospettiva curiosa nonimplichi necessariamente conoscenze pregresse inabito geometrico, questo atteggiamento rivolto mag-giormente alla pratica artigianale potendo conviverecon quello più attento a acquisite competenze ottico-proiettive. La dialettica tra spazio artificiale, dominato dall’in-telletto e dal rigore architettonico (l’edificio, imma-ginato come tempio delle Muse) e spazio naturale,caratterizzato da un ambiente incolto e ribelle (il pae-saggio sullo sfondo), si esprime allegoricamente nelfrontespizio inciso da Daret, così come nell’opera involgare di Niceron, sospesa tra rigore geometrico esemplificazioni pratiche ad uso degli artefici anchemeno profondi nella teoria prospettica. L’intera scena è illuminata da una sorgente impropria(il Sole), collocata alle spalle dell’osservatore e postasulla sinistra: lo si intuisce chiaramente dalle pro-fonde ombre proprie e portate che produce, in specialmodo nel caso del basamento che reca su una dellesue facce (proprio quella in ombra) il gioco diottrico.Stilisticamente l’architettura rappresenta da Daret ri-manda allo stesso linguaggio asciutto di quella pre-sente nei dipinti di Nicolas Poussin16 (1594–1665), digusto sicuramente italiano, e comunica un senso dinaturalismo non comune nei frontespizi di altre operescientifiche coeve, così come realistici sono i trattisomatici dei putti, per niente idealizzati. In definitiva, l’immagine parla in un linguaggio co-mune, aperto e amichevole, al lettore che è invitatoad entrare in quell’edifico della conoscenza scienti-
fica di cui l’arco di trionfo costituisce l’ingresso:senza remore, una volta nel cortile interno, circondatodalle Muse disposte tutte intorno a lui, egli avrà ac-cesso al meraviglioso mondo delle prospettive cu-riose e degli artifizi della magia artificiale. Nell’incisione per il frontespizio del Thaumaturgusopticus (Parigi 1646) (fig. 10), eseguita da CharlesAudran (1594–1674) sulla base di un disegno SimonVouët (1590–1649), questa soglia è stata finalmenteattraversata, e ora ci troviamo, insieme ai putti alati(divenuti ben sette!), dentro l’emiciclo solo intravistonell’immagine precedente. Qui domina un maturo gusto barocco per la resa sce-nografica e chiaroscurale delle masse architettoniche
10/J. F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646. Fronte-spizio inciso.
105
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
e umane, inserite in un’ambientazione decisamentepiù teatrale e dichiaratamente allegorica, ma anchecaratterizzata da un senso di vanitas strisciante, dalmomento che il piedistallo visibile sulla sinistraadesso è proprio divenuto un cippo funerario, contanto di iscrizione recante il titolo dell’opera, il nomedell’autore nel frattempo defunto (Niceron muore in-fatti il 22 settembre 1646, prima di vedere edita la suaopera), e quello del dedicatario, il celebre CardinaleGiulio Mazarino (1602-1661). Adorna la sua fascia trabeata, visibile frontalmente,un’iscrizione – “Nec vidisse seme satis est, Iuvat usquetueri”– tratta con la solita libertà niceroniana dal-l’Eneide di Publio Virgilio Marone (70 a.C. – 19 a.C.).
Il passo originale per esteso reciterebbe:«Intorno gli stanno frementi le anime a destra e a si-nistra. / Né basta averlo visto una volta; ma piace loroindugiare a lungo / e muovere insieme i passi e cono-scere i motivi della sua venuta.»17
Il testo si riferisce ad Enea che, arrivato a Cuma,viene accompagnato dalla Sibilla nell'Ade, il cui ac-cesso si credeva fosse nei pressi del lago d'Averno. È lì, nei Campi Elisi, che l’eroe incontra, tra le tanteombre, quella del padre Anchise, che rivela al figlioche è stato scelto dagli dei per fondare l'Impero diRoma. Nella versione di Niceron l’infinito ‘morari’, ‘fer-marsi’, viene sostituito da ‘tueri’, ‘contemplare’, im-primendo una deriva ottica all’originale testovirgiliano: riferendosi alle meraviglie squadernate dalsuo trattato, Niceron così avvertirebbe il lettore, sindall’inizio del trattato, che “non sarà sufficiente ve-derle solo una volta. Ma chiederanno di essere viste nuovamente”, perpoter godere di tutta la loro complessità.18
Sulla base superiore di questa stessa struttura si tro-vano, oltre ad un icosaedro stellato, due eroti che sor-reggono una tavola cui è ancorata una piramideobliqua, a base esagonale, recante frammenti anamor-fici di un ritratto visibile nella sua interezza solo dalputto che, sul piano di campagna, inforca una cannoc-chiale progettato ad hoc. Altre figure sono intente chi a misurare un esacisot-taedro; chi a usare il compasso su una superficie oriz-zontale19 (redigendo un disegno, forse?); chi infine atrasportare a spalla un pesante cannocchiale. In alto, a destra, si libra in volo un angelo (identifica-bile con la Fama, La Renommée, anche se priva dellatromba, suo tipico attributo) le cui mani srotolano unapergamena con il ritratto del famoso dedicatario, i cuilineamenti somatici appaiono fortemente distesi e ri-lassati rispetto ai coevi ritratti più accreditati.20
L’immagine sembra un calco, almeno nella sua partedi coronamento, di un altro celebre ritratto del Cardi-nale Mazarino (fig. 11), eseguito da Sébastien Bour-don, nel 1645, come frontespizio della Bible
11/S. Bourdon, inventore; G. Rousselet, incisore, Le CardinalMazarin, 1645.
106
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
Polyglotte di Guy Michel Le Jay (1588–1674), e incui le qualità di mecenatismo e di difesa della cultura,attribuibili al celebre prelato, sono rese esplicite gra-zie alla presenza di riconoscibili figure allegoriche. Gli strumenti della conoscenza, un tempo esterni alcortile monumentale, ora sono stati ammessi al centrodello spazio absidato, indicando il progresso com-piuto con l’edizione latina, destinata al più ampiopubblico degli specialisti europei, non solo francesi.Inoltre, le occupazioni degli eroti anticipano in formaiconografica le novità contenute nel Thaumaturgusopticus, rispetto all’edizione francese, in particolarealludendo in forma insistita all’ampliamento della se-zione dedicata ai poliedri, che ora comprende anchequelli stellati nelle fogge più bizzarre. La struttura architettonica si articola verticalmente inuna configurazione concava, ed è caratterizzata dal-l’apertura di una serie di fornici a tutto sesto, sotto iquali sono ospitate statue allegoriche, tra cui si rico-nosce almeno la Matematica (con l’inevitabile globoceleste o terrestre), mentre quella recante nella manosollevata un compasso è di più difficile identifica-zione (forse una personificazione della Geometria).Sul coronamento dell’edificio, in classica prosecu-zione delle paraste corinzie, al di sopra della trabea-zione di chiusura, altre statue si stagliano contro uncielo nuvoloso, tra le quali una maschile sostiene unasfera armillare, dunque simboleggiando in modo am-biguo l’Astronomia.21
L’impressione che questa organizzazione spazialesuggerisce a Vital–Durand22 è quella di una verticalitàascensionale, opposta alla profondità orizzontale elar-gita nel frontespizio dell’edizione del 1638, e che puòessere riconducibile senza alcun dubbio all’esteticadi Vouët, se si fa riferimento alla sua opera intitolataLa Présentation de Jésus au Temple (1640–41)(fig. 12), perfettamente simmetrica all’incisione delThaumaturgus opticus: qui tuttavia l’atmosfera è de-cisamente più laica e l’articolazione degli elementiscenici appare meno intima rispetto al dipinto conser-vato al Musée du Louvre di Parigi.«Lo spazio esterno del frontespizio, un anfiteatro,
un’esedra profana, crea una profondità ed una ele-vazione, segni di intesa intellettuale e spirituale, sim-boleggianti Mazarino e Niceron, al servizio del libroe del suo Sapere.»23
Dunque l’emiciclo architettonico, divenuto schermo-palcoscenico su cui proiettare le molteplici articola-zioni della conoscenza scientifica, qui veicola unnuovo modello del sapere che sembra abbandonarel’archetipo del tempio delle Muse, in precedenza al-luso, rimandando invece all’idea di Académie maza-
12/S. Vouët, La Présentation de Jésus au Temple, 1640-41. Oliosu tela. Musée du Louvre, Parigi. Inv. 8492.
107
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
riniana,24 un’istituzione virtuale che l’alto prelato so-stenne grazie al suo mecenatismo illuminato, comegià il suo predecessore Cardinale Richelieu.Le pagine destinate alle dediche (indicate nelle dueedizione con il titolo di Epistre, ‘lettera’), come si di-ceva, presentano una strana simmetria per la nazio-nalità e il destino politico-legatorio dei due riceventi,Monsignor Giorgio Bolognetti, vescovo di AscoliSatriano (fig. 13), e il Cardinale Giulio Mazarino(fig. 14), entrambi italiani e coinvolti nel futuro
politico-religioso della Francia: il primo fu nominatoda Urbano VIII Nunzio Apostolico presso la corte diLuigi XIII (1634–1639); il secondo fu inviato prima(1634) ad Avignone, come Vice-Legato Pontificio,poi divenendo Nunzio Apostolico a Parigi(1634–1636) e, infine, subentrando nella veste diPrimo Ministro (1642) al Cardinale Richelieu, pressola corte di Luigi XIV. Ne La Perspective Curiuese (1638), Monsignor Bo-lognetti è invocato da Niceron come autorità tutelare
13/J. F. Nicéron, La Perspective Curieuse, Parigi 1638. Dedica..
14/J. F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646. Dedica.
108
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
ancor prima del concepimento dell’opera, in grado didifenderla e sostenerne il valore «malgrado gli Zoilo25
e gli Aristarco26, col vostro consenso, & col favoredella vostra protezione»27. L’autore mostra, con il consueto linguaggio mellifluoed esornativo tipico di analoghe sezioni celebrative,di essere ben conosciuto dall’alto prelato e di essereengagè par devoir a offrirgli la lettura della sua operae a chiederne l’approvazione, potendosi sottintendereuno stretto legame con la sua futura partenza per l’Ita-lia28 (dove soggiornerà, una prima volta, a partire dal25 maggio 1639 fino al 28 marzo 1640) presso il Con-vento di Trinità dei Monti, e dunque immaginandoquesta dedica ad un autorevole ‘italiano in Francia’come una richiesta di sostegno per il suo imminentetrasferimento a Roma. La modalità consolatoria attiva nelle amenità fornitedalla lettura della sua opera, in bilico tra rigore scien-tifico e volontà di diffusione popolare, appare in tuttaevidenza nella chiosa all’Epistre, dove si legge:«Ovunque si riconosce la potenza del vostro Genio,& che voi siete nato per qualcosa di grande, poichévoi fate un divertimento di ciò che gli altri conside-rano come le loro più serie occupazioni: In ciò vi pa-ragonerei volentieri a Scipione l’Africano, il quale,secondo l’opinione di Cicerone nel suo Trattato deiDoveri29, dopo aver adempiuto degnamente agli in-carichi, che aveva nell’amministrazione della Repub-blica, trovava riposo & consolazione nello studiodella filosofia: Così, MONSIGNORE; se le occupazioni& la cura della vostra carica vi lasciano qualche oradurante la settimana, voi le consacrate alle Muse; &,come quel grande Condottiero, non siete mai menosolo, di quando siete senza compagnia; né mai menomentalmente inattivo di quando siete libero dagli af-fari; poiché in quel tempo, o conversate con i defunti,mediante la lettura; o con i vivi, nella conversazione,per coltivare continuamente & aumentare sempre lerare30 conoscenze che ella già possiede. È questo che mi ha dato l’ardire di presentarvi questoTrattato sulla PROSPETTIVA CURIOSA, ben sapendo d’altraparte che voi stimate particolarmente questa scienza»31.
Lo stesso schema retorico ed elogiativo si ritrova nel-l’Epistre32 del Thaumaturgus opticus (1646), il cuifocus è, come si ricordava, il celebre e celebrato Car-dinale Mazarino, ammirato da Niceron, sin dal suoprimo soggiorno romano quando ancora non era por-porato,33 bensì porporescente, ma del quale nella cittàeterna già si magnificavano le doti e si preconizzavail futuro successo. Niceron sottolinea il ruolo culturale, piuttosto che po-litico di Mazarino ricordando che già da allora eglimanifestasse«… quel genio che ora dà utile prova di sé nelleumane cose, che prepara alla Francia vittorie e trionfi,che spinge le Lettere e le Arti sulla strada dell'immor-talità. Io, fervido ammiratore del tuo genio in una città stra-niera, accolto in quel portico che tu ornavi con unastraordinaria e amplissima selezione dei libri mi-gliori, fui ispirato non tanto dalla fama del luogo madalla tua straordinaria cultura a introdurre in quel tuoceleberrimo Iseo,34 in quell'arsenale dell'Arte oratoria,il saggio di quest'opera che avevo già pubblicato nellamia lingua madre: non per acquistare a poco prezzoil favore di un ingegno tanto eccelso, ma per offrireun pegno all'animo del Mecenate migliore e più de-siderabile.» Qui Niceron si riferisce all’impareggiabile e fornitis-sima biblioteca del Cardinale, occupante un terzodella sua dimora, «non una semplice collezione dilibri, ma una Città delle Lettere»,35 organizzata emantenuta da quel Gabriel Naudè36 (1600–1653) acui egli stesso si rivolse più volte, anche per via epi-stolare,37 e nella quale trovò accoglienza anche il suotrattato in volgare, come lui stesso annota.La nuova opera in latino lo vede più profondo inquella disciplina –la prospettiva– annoverabile ‘fra leregine delle arti’, come testimonia anche la pericolosacitazione infratestuale di Filone di Alessandria38:«… dunque la vera arte della magia, cioè una scienzaottica che permette di discernere gli effetti della na-tura con rappresentazioni più nette, viene attivamentestudiata non solo dai privati cittadini ma anche dai re,
109
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
e tra i re dai più grandi e soprattutto da quelli dei Per-siani, tanto che essi dicono che presso di loro nessunopuò essere innalzato al trono se non ha frequentato lagrande famiglia dei magi.»39
La funzione paidetica del testo è dunque qui ripresa,ma con un’impennata che ne nobilita la natura, invo-cando che se ne insegnino i precetti anche al giovaneerede del sovrano francese, ‘figlio per battesimo’ e‘alunno per dottrina’ del cardinale Mazarino.40
La sezione che segue, in entrambi i trattati, è una vera
e propria Premessa: ne La Perspective curieuse indi-rizzata genericamente al ‘lettore’ (fig. 15); nel Thau-maturgus opticus allo ‘studioso’ (fig. 16), in questaspecificazione del destinatario riflettendosi la diversacaratura scientifica delle due opere. Dalla lettura de la Preface et advertissementau Lecteur ritroviamo quel carattere di amabilitàdiscorsiva che caratterizza il trattato in francese, in-cline ad assecondare una approccio gnoseologico allaprospettiva che non si imbastisca solo di teoria, ma si
15/J. F. Nicéron, La Perspective Curieuse, Parigi 1638. Prefaceet advertissement au Lecteur.
16/J. F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646. Praefatioad lectorem studiosum..
110
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
inveri soprattutto in applicazioni pratiche e concrete,le uniche a fornire utilità a precetti altrimenti astratti. In questo senso Niceron si sente distante da Platoneil quale«… credeva che questa scienza (la matematica, n.d.t.)avesse cominciato a degenerare dalla sua purezza,quando aveva prodotto all’esterno qualche effettosensibile & materiale dalla verità che essa insegna.»41
Più vicino allo spirito archimedeo, dunque, l’autorerivendica così il ruolo innovatore delle applicazionidella matematica alla meccanica delle macchine (conle sue ricadute utilitaristiche in strumenti di uso co-mune, eppure indispensabili alla vita economicacoeva, come “il Tornio, le Pulegge, le Gru, i Cabe-stani & le altre”42), e dell’idraulica e della pneumaticaalle fontane e alla movimentazione delle acque. Ma cartesianamente è l’ottica la disciplina sovranache è capace di fornire «grandi vantaggi per il progresso delle scienze & laperfezione delle arti; & piacevolissimi divertimentiper la soddisfazione del più nobile dei nostri sensi,che è la vista.»43
Dal suo studio e dall’applicazione delle sue regole, lageometria ha ricavato strumenti utili a stimare le gran-dezze fisiche degli oggetti come “i Quadranti, le Ar-bastilles,44 i Bastoni di Giacobbe”;45 l’astronomia hainvece desunto quelli utili a «ben calcolare l’altezza,la posizione & il movimento dei Pianeti, coi suoiAstrolabi, le pinnule46, & altri strumenti che orientanoil raggio visivo.»47
Ma è all’ambito artistico, segnatamente pittorico, cheNiceron rivendica i maggiori vantaggi dall’applica-zione delle leggi dell’ottica: se alcuni artisti, sia inFrancia –fra questi, non casualmente, l’autore cita isodali Simon Vouët e Laurent de La Hyre(1606–1656)– che nel resto di Europa48 ci appaionograndi è perché essi hanno appreso l’arte della pro-spettiva, che dell’ottica è figlia, insieme alla teoria deicolori, che ne completa coerentemente il corredoespressivo. Il ruolo di eccellenza assunto dalla scienzadell’arte, per Niceron, ha il suo cantore in Juan Bau-tista Villalpando49 (1552–1608): nei suoi Commentari
ad Ezechiele l’autore affermava infatti che la prospet-tiva certamente svetta sulle altre discipline artisticheperché «si occupa degli effetti e della proprietà dellaluce, che è la bellezza di tutte le cose sensibili»,50 masoprattutto perché essa ci insegna a delineare imma-gini che ingannano non solo gli occhi, ma anche «ilgiudizio e la ragione»,51 come rammentano i citatis-simi esempi di Zeusi52 e Parrasio,53 anche qui invocatida Niceron. Lo spettro di Descartes aleggia con tutta evidenza inquesta sezione della premessa, nondimeno vinco-lando solo i presupposti della riflessione critica nice-roniana, ma non le sue applicazioni pratiche per lequali l’autore, a differenza del filosofo francese,prova affetto e con le quali condivide il gusto per unagenuina meraviglia. La diffusione della prospettiva va ascritta alle operedi tanti autori, secondo Niceron, tra le quali egli ri-corda«… quella di Viator54 in Latino & Francese stampataben 26 anni fa: Albrecht Dürer55 ne ha inserito qual-che elemento nella Geometria Pratica; così comeLeon Battista Alberti56 nel suo trattato sulla Pittura:Jean Cousin,57 du Cerceau,58 Salomon de Caus59 &Marolois ne hanno trattato espressamente, & dopoloro essi ancora Monsieur Vaulezard,60 Monsieur He-rigone61 & Monsieur Désargues ,62 che ne ha pubbli-cato un metodo generale & molto rapido, che hainventato, insieme a molti altri interessanti segreti perl’Architettura & la Prospettiva, dei quali renderà par-tecipe il pubblico quando gli piacerà. Gli Italiani & i Tedeschi ne hanno molti altri, comeSebastiano Serlio,63 Sirigatti,64 Vignola65 con I Com-mentari del R.P. Ignazio Danti, Guido Ubaldo[Del Monte],66 Daniele Barbaro,67 Fernando diDiano,68 Lenkerus,69 Iamitserus,70 Fortius,71 chesarebbe lungo ricercare & nominare tutti dettagliata-mente: Forse ciò che stupirà, sarà che dopo un cosìgran numero di Autori, che ne hanno scritto dellaProspettiva, abbia voluto impicciarmene, come secoloro che ne perseguono la conoscenza, nonavessero di che soddisfare pienamente la loro curio-
111
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
sità in queste opere.»72
Questo elenco, nella Praefatio ad lectorem studiosumdel Thaumaturgus opticus (1646) verrà volutamenteomesso, rimandando il lettore a un dettagliato Cata-logus authorum qui ex instituto de perspectiva(fig. 17) posto in chiusura dell’opera. Pur avvertendo l’autorità dei suoi illustri predeces-sori, Niceron offre al giudizio del pubblico e deglispecialisti il suo trattato che si picca di correggere leastruse costruzioni prospettiche proposte in primis daGuidobaldo del Monte73 e da Daniele Barbaro,74 nonlesinando giudizi severi verso altri colleghi dai qualipaiono salvarsi parzialmente solo Jean Cousin e Vi-gnola con la sua ‘seconda regola’ (si noti la citazionebi-partisan di un autore francese e di un italiano): ilPadre minimo vuole dunque proporre le sue versionicritiche dei metodi già in uso, nel tentativo di renderlipiù speditivi, senza rinunciare al rigore matematicoche pur li deve caratterizzare. Egli è giunto a elaborare le sue proposte dopo un’in-tensa attività di studio e di applicazioni grafiche chegli hanno consentito di distrarsi dai suoi studi ben piùseri di teologia: ritorna così un topos retorico, svilup-pato in entrambi in trattati, secondo il quale la pro-spettiva può costituire un nutrimento della mente maanche dello spirito, capace cioè di alleggerire anche ipercorsi gnoseologici più impervi e ottundenti, attra-verso l’ariosità e l’esercizio sull’infinito che essa con-sente. Si tratta di una scienza non priva di spine, ma seguen-dola si potrebbe concordare col precetto ovidiano, se-condo il quale «Omne tulit punctum qui miscuit utiledulci»75.Dunque la semplificazione della forma espositiva,senza rinunciare al rigore dei contenuti, è dichiarata-mente indirizzata a
«… istruire i semplici e fare in modo checiò che scrivo sia compreso da queglistessi che non professano le lettere: tut-tavia sarà per me una soddisfazione inpiù se potessi piacere a coloro che se neoccupano, per i quali vi ho inserito, al-
l’occasione, qualche massima & Teo-rema, che richiedono un maggiore ragio-namento; e citato in qualche punto glienunciati di altri Autori, che servono dafondamento a ciò che tratto.»76
Per quanto attiene al sottotitolo dell’opera in volgare(Magie artificiel[l]e des effets merueilleux de l'opti-que par la vision directe, la catoptrique par la refle-xion des miroirs plats, cylindriques & coniques,la dioptrique par la refraction des crystaux) è proprio
17/J. F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646. Catalo-gus authorum qui ex instituto de perspective.
112
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
nella Premessa che Niceron chiarisce come mai egliabbia deciso di utilizzare una parola così compromet-tente come ‘magia’, che potrebbe risuonare in modosinistro per chi la collegasse esclusivamente a prati-che esoteriche, soprattutto se proferita da un religiosoquale lui è. Come abbiamo già dimostrato altrove,77 l’autore puòvantare un lungo elenco di illustri predecessori–come Pico della Mirandola78 (1463–1494) Benedic-tus Pererius79 (1535–1610), Julius Caesar Bulenge-rus80 (1558–1628), Francisco Torreblanca yVillalpando81 (*–1645) e, ancor prima di loro,Strabone82 (ante 60 a.C.-23 d.C. ca.) e Filone diAlessandria– che ne hanno certificato il mero signi-ficato in ambito scientifico, tradotto in forme plasti-che in una pletora di invenzioni meccaniche, tra lequali Niceron cita:«la Sfera di Posidonio83 che rappresentava i cieli, imovimenti e le fasi dei pianeti: la colomba di legnodi Archita,84 che volava come una colomba naturale;gli specchi di Archimede,85 che bruciavano nel portole navi nemiche; le sue macchine per mezzo dellequali le sollevava come voleva; Gli Automi di De-dalo;86 In poche parole la testa di bronzo fatta da Al-berto Magno,87 che parlava come se fosse stata creatanaturalmente, & le opere straordinarie del dotto Boe-zio,88 che faceva fischiare serpenti di bronzo e cantareuccelli della stessa materia;»89
La raccomandazione che, da un lato, gli esperti pa-zientino nella lettura del trattato se incontrassero partitroppo divulgative, invitandoli a sorvolare su even-tuali errori di stampa; e che, dall’altra, i principiantisi impegnino anche negli esercizi più noiosi, al finedi colmare le proprie lacune, conclude questa sezionede La Perspective curiuese. Del tutto analoga, nei contenuti, a quella dell’edizionefrancese appare la Praefatio ad lectorem studiosum,con pochi elementi distintivi degni di nota. Tra questi qui vorremo segnalare la breve disserta-zione che Niceron offre circa le motivazioni dellascelta del lemma ‘taumaturgo’, e che l’autore ricon-duce –nell’ottica di una “taumato-poetica univer-
sale”– a quelle già addotte per giustificare l’impiegodella parola ‘magia’ nella prima edizione del suo trat-tato in francese. Inoltre, descrivendo la struttura dell’opera, Niceronne esplicita il piano editoriale che prevedeva la ste-sura anche di altri due capitoli che l’autore però nonfece in tempo a completare per il sopraggiungeredella sua morte:«Nel I Libro della II Parte, che sarà il terzo dell'opera,con il favore di Dio e se il tempo e le forze, per la suaimmensa bontà, non mancheranno, si troveranno lemirabili proprietà degli specchi, assai efficaci per de-formare le proiezioni delle immagini negli specchistessi e per ricondurle, da un dato punto d'osserva-zione, alla forma originaria.Infine, nel IV Libro, che è il II della II Parte, sarannosvelati i principi nascosti delle rifrazioni, e sarannoillustrate specifiche procedure e dimostrazioni permostrare immagini di ogni genere attraverso diafanimultiformi.»90
Niceron fornisce una misura temporale dell’impegnoprofuso nella redazione dell’edizione latina –ben seianni dalla pubblicazione del precedente trattato–,confidando al lettore che aveva erroneamente valu-tato che gli sarebbero serviti solo sei mesi per com-pletarla. Ma gli impegni comunitari al seguito diPadre François La Nouë, nella Visitazione generaledi tutte le province della Francia, hanno minato lacontinuità del suo lavoro scientifico, costringendoloa continue interruzioni e a lavorare durante gli spo-stamenti. Per questo Niceron chiede scusa per gli eventuali er-rori ai filomaqei~", informandoli che l’opera gli «èstata, per così dire, strappata dalle mani senza una re-visione», e dunque chiedendo loro, con l’aiuto di Ora-zio, che «si dia venia alle macchie che l’incuriasparse, o a cui la natura umana poco provvide»91. Chiude la sezione l’indicazione del luogo e dell’annodi stesura della premessa all’edizione latina –«a Gre-noble, nell'anno dell'Era cristiana 1646»–, dati chedrammaticamente forniscono le ultime coordinategeografiche di Niceron appena prima di morire, du-
113
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
rante la sua Visite Générale nel Midi-de-France (Pro-venza), dove lo aggredì una febbre maligna che, dap-prima, lo costrinse al ricovero presso il convento deiMinimi di Pourrieres e, poi, lo condusse alla morte il22 settembre 1646, all’età di trentatre anni (e 14 diprofessione sacerdotale), presso il convento di Notre-Dame-de-la-Seds ad Aix-en-Provence, dove fu tra-slato e sepolto. Proprio in relazione a questo tragico evento, il cura-tore dell’edizione postuma (Padre Marin Mersenne)
antepose un circostanziato ed elogiativo Elogium au-toris (fig. 18) alla stessa premessa, presente dunquesolo nell’edizione latina, ricapitolando in esso i puntisalienti di una così brillante, sia pure breve vita, divisafra dedizione monastica e impegno scientifico, nellaconsapevolezza sia del ruolo fondante dello studio deiclassici –come attestano le insistite, erudite citazionidi autori quali Seneca, Gellio, Clemente Alessan-drino, Orazio, Luciano e il platonico Alcinoo–, chedel potere rivelatore dell’ottica e della prospettiva,espressioni supreme della magia artificiale.
1 La tunica con cappuccio indossata da Niceron è la classica pa-zienza, in genere corredata da un cordone in di lana, detto cingolo,portato intorno alla vita. Il numero dei nodi pendenti –qui non vi-sibili– simboleggia i voti presi dal frate. Cfr. Regola di vita deiFrati dell’Ordine dei Minimi Poveri Eremiti di Fra’ Francescodi Paola, Osservanza dei Precetti Divini, Capitolo Terzo; G.Rocca, a cura di La sostanza dell'effimero. Gli abiti degli ordinireligiosi in Occidente, Edizioni Paoline, Roma 2000, p. 442.2 Michel Lasne (Caen, 1595–Parigi, 1667), figlio di un orafo, al-lievo di Paul Rubens e di van Dyck ad Anversa, fu un celebre il-lustratore e collezionista francese, divenendo, nel 1633, incisoreufficiale di Luigi XIII, per la cui famiglia eseguì ben 23 ritratti.Sin dalle sue prime illustrazioni eseguite per la Mythologie(Rouen, 1611) di Jean de Montlyard, il suo stile appare inizial-mente asciutto e meticoloso nella restituzione dei dettagli e delleforme, per divenire più morbido e rotondo sotto l’influenza diPhilip Galle, Hubertus Goltzius e dello stesso Rubens. Cfr. F. De-baisieux, a cura di, Michel Lasne: Caen, vers 1590 - Paris, 1667,illustrateur de son temps, catalogo della mostra, Hôtel d'Esco-ville, Caen 1967; M. Bryan, Dictionary of painters & engravers,vol. II, George Bell and Sons, Londra 1889, p. 22; G. Duplessis,Histoire de la gravure en France, Rapilly, Parigi 1861, p. 1243 Cfr. A. Mayer-Deutsch, ‘Quasi-Optical Palingenesis’. The Cir-culation of Portraits and the Image of Kircher, in “AthanasiusKircher: the last man who knew everything”, a cura di P. Findlen,Routledge, Londra 2004, pp.105-129; P. Kathke, Porträt undAccessoire: Eine Bildnisform im 16. Jahrhundert, Reimer,Berlino 1997.4 J.F. Niceron, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646, Libro I, pp.94-97. La sezione sui solidi stellati non appare ne La Perspectivecuriuese (Parigi 1638). Sulle influenze del trattato di W. Jamnitzer(Norimberga 1568) sul Thaumaturgus Opticus si rimanda a A.Flocon, Jamnitzer: Orfebre del rigor sensible, in W. Jamnitzer,“Perspectiva corporun regolarium”, Siruela, Madrid 2006.5 Cfr. C. De Seta, a cura di, Imago urbis Romae: l'immagine diRoma in età moderna, Electa, Milano 2005, pp.28-29.
18/J. F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646. Elogiumautoris.
114
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
6 Cfr. G.B. Falda, Il Nuovo Teatro delle fabriche, et edificii, inprospettiva di Roma moderna…, 3 Libri, Gio. Iacomo Rossi,Roma 1665-1669; III, 1669, pl. 73. 7 P. Julien ritiene che il ritratto di padre E. Maignan, eseguito daJean Michel, per la fondamentale biografia redatta da P.J. Saguens(De vita, moribus et scriptis R.P. Emanuel Maignan, Tolasatis,Mathematici praestantissimi elogium, Tolosa 1697) sia stato mo-dellato su quello di J.F. Niceron, inciso da Lasne : infatti esistonoprove - ad esempio il paffuto busto scoplito da Marc Arcis e con-servato presso la galleria degli Illustres célébrant les Grands del'histoire de Toulouse–, che la fisionomia di Maignan fosse affattodiversa da quella affidata i posteri dalla ritrattistica ufficiale. Leturbolenti vicissitudini teologiche e private che videro coinvoltopadre Maignan nell’ultima parte della sua vita, suggerirono al Sa-guens di far adottare uno stile rappresentativo più austero e qua-resimale per l’immagine ufficiale di Maignan, trovando proprioin quella di Niceron una fonte di isipirazione più consona alle sueesigenze agiografiche. Cfr. P. Julien, Anamorphoses et visionmiraculeuses du Père Maignan (1602-1676), in “MEFRIM:Mélanges de l'École française de Rome. Italie et mediterranée”,t. 117, 1, École française de Rome, Roma 2005, pp. 64-718 Cfr. A. DE ROSA (a cura di), Jean François Niceron. Prospet-tiva, catottrica & magia artificiale, Aracne, Roma 2013.9 Si deve supporre che qui Niceron abbia voluto omaggiare, informa indiretta e solo grafica, uno dei trattatisti che maggiormentelo hanno influenzato nella stesura de La Perspective curieuse, ov-vero J.-L. Vaulezard che proprio nel frontespizio del suo Perspec-tivae cilindrique et conique ou traite des apparences vues par lemoyen des miroirs… (Parigi 1630) rappresentò lo stesso disposi-tivo catottrico.10 Questo dettaglio dell’immagine potrebbe riferirsi latamente al-l'episodio, ricordato dallo stesso Niceron ne La Perspective cu-rieuse (Libro III, p. 79) relativo allo stendardo anagrammaticocollocato dai cittadini di Bordeaux nel 1615 sotto l’arco di trionfoin occasione della visita del re Luigi XIII, nel quale era possibileleggere: "Lois de Bourbon, bon Bourdelois" – ovvero, “Luigi diBorbone (nome di famiglia del Re), buon cittadino di Bordeaux.”Su questo frontespizio si veda anche K. IBBETT, The Style of theState in French Theater, 1630–1660. Neoclassicism and Govern-ment, Ashgate, Farnham e Burlington 2009, pp. 1-2.11 È lo stesso Niceron a descrivercelo ne La Perspective curieuse(Proposizione V del Libro IV, p. 115), sottolineando che l’imma-gine si basava su una sua precedente opera, conservata presso ilconvento dei Minimi di Place Royale. La descrizione di una si-mile dispositivo diottrico si ritrova anche in C. WOLF, Elementamatheseos universae, Halae Magdeburgicae Renger, Ginevra1732, p. 240 e fig. dioptr.V (fig. 49).12 F. Vital-Durand (in Id., Art et Langage. Les Frontispices Alle-goriques de la Science a l'Age Classique, L'Harmattan, Parigi2011, p. 175) ipotizza che nel medaglione sia invece ritratto un
dignitario che incorona d’alloro un uomo. Secondo la studiosafrancese, si tratterebbe di un omaggio indiretto al dedicatario deLa Perspective curieuse, Monsignor Giorgio Bolognetti , ‘Ve-scovo di Ascoli e Nunzio di Sua Santità in Francia’. 13 Questa tendenza alla semplificazione dei connotati fisiogno-mici e degli attributi identificativi delle figure allegoriche inseritenei frontespizi di trattati appartiene ad un trend stilistico che siriscontra anche in altre opere collegabili a quella di Niceroncome, ad esempio, nella Perspectiva horaria (Roma 1648) diEmmanuel Maignan. Cfr. F. VITAL-DURAND, Art et Langage. LesFrontispices Allegoriques de la Science a l'Age Classique, cit.,pp. 63 sgg.14 Cfr. F. VITAL-DURAND, Art et Langage. Les Frontispices Alle-goriques de la Science a l'Age Classique, cit., pp. 62-66.15 Cfr. Phlp. in de An. cvii 26-7; Olymp., Proll. viii, 39-ix 1. Tut-tavia, non esiste nessuna prova documentale che tale iscrizionecostituisse il viatico all’ingresso nell’Accademia platonica, comeha ampiamente dimostrato H. D. SAFFREY, Ageometretos medeiseisito. Une inscription légendaire, “Revue des Etudes Grecques”,LXXXI (1968), pp. 67-87.16 In merito, si veda O. BÄTSCHMANN, Nicolas Poussin: Dialec-tics Of Painting, Reaktion Books, Londra 1999, pp. 119 sgg.17 La citazione corretta recita: “nec vidisse semel satis est; iuvatusque morari” (Canto VI, v. 487)18 La citazione virgiliana viene riferita al Cardinale Mazarinoda J. Garcia (in Les Representations Gravees Du Cardinal Ma-zarin Au XVIIe Siecle, Klincksieck, Parigi 2000, p. 66).19 Dietro i putti con compasso si scorge il profilo del cilindro ri-flettente che nel frontespizio inciso de La Perspective curieuseera posto in primo piano.20 Cfr. I. CONIHOUT, P. MICHEL, Mazarin. Les lettres et les arts,Éditions Monelle Hayot, Parigi 2006.21 Cfr. C. RIPA, Iconologia, Roma 1593.22 Cfr. F. VITAL-DURAND, Art et Langage. Les Frontispices Alle-goriques de la Science a l'Age Classique, cit., pp. 190 sgg.23 Ivi, p. 192.24 Cfr. M. LAURAIN-PORTEMER, Ètudes mazarines. Une tête à gou-verner quatre empires, vol. 2, Librairie des Arts, Nogent-le-Roi1997.25 Zoilo di Anfípolis, in Macedonia (c. 400 a.C. - 320 a.C.), gram-matico greco, filosofo appartenente alla corrente dei Cinici, è pas-sato alla storia come il più severo critico letterario degli autoridella classicità, quali Platone, Isocrate ma soprattutto Omero, alpunto da meritarsi l’appellativo di Homeromastix, ‘la frusta diOmero’. Morì in un agguato tesogli dai sostenitori del poetaepico. Cfr. M. V. POLLIONE, De Architectura, 25 a.C., Liber VII– 8. Si fa riferimento alla seguente edizione: M. V. POLLIONE, DeArchitectura, in P. GROS (traduzione e commento di A. Corso eE. Romano), Giulio Einaudi editore, Torino 1997, p. 1021.
115
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
26 Aristarco (c. 310 a.C. – c. 230 a.C.) fu un astronomo e mate-matico greco, nato a Samos, Grecia. A lui si deve il primo modelloeliocentrico del Sistema Solare. Cfr. Sir T. HEATH, Aristarchus ofSamos: The Ancient Copernicus, Dover Publications, Mineola1981.27 J. F. NICERON, La perspective curiuese, Parigi 1638, Epistre,s.i.p.28 L’ Epistre riporta in calce la data di stesura: 28 luglio 1638.29 Qui Nicéron si riferisce evidentemente al De officiis ("Sui do-veri"), trattato di etica pratica scritto in poche settimane da MarcoTullio Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.) dopo la morte di Cesare, nel44 a.C. Ultima opera filosofica di Cicerone, dedicata al figlioMarco, il De officis si articola in tre libri dedicati rispettivamentea ciò che è onesto, a ciò che utile, e infine ad un confronto traquesti due poli etico-sociali, che consentono al cittadino romanodi vivere pienamente nella virtus. Il brano cui fa riferimento l’Au-tore è il seguente: “P. Scipionem, Marce fili, eum, qui primusAfricanus appellatus est, dicere solitum scripsit Cato, qui fuit eiusfere aequalis, numquam se minus otiosum esse, quam cum otio-sus, nec minus solum, quam cum solus esset. Magnifica vero voxet magno viro ac sapiente digna; quae declarat illum et in otio denegotiis cogitare et in solitudine secum loqui solitum, ut nequecessaret umquam et interdum conloquio alterius non egeret. Itaduae res, quae languorem adferunt ceteris, illum acuebant, otiumet solitudo. Vellem nobis hoc idem vere dicere liceret, sed siminus imitatione tantam ingenii praestantiam consequi possumus,voluntate certe proxime accedimus.” Cfr. Marco Tullio Cicerone,Dei Doveri, a cura di D. ARFELLI, Mondadori, Milano 1994,p. 141.30 Les rares cognoissances nel testo originale. Qui Nicèron in-tende l’aggettivo rare riferito alle conoscenze del Vescovo, comesinonimo di ‘che pochi possiedono’. 31 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Epsitre, s.i.p.32 L’Espistre del Thaumaturgus opticus fu redatta da Niceron “ilgiorno prima delle Calende di Maggio dell'anno 1646 dell'Era cri-stiana”, ovvero il 30 aprile 1646.33 Mazarino divenne Cardinale nel 1641.34 L’Isaeum cui fa qui riferimento Niceron è il santuario dedi-cato alla divinità greco-romana Iside.35 J. F. NICERON, Thaumaturgus opticus, Parigi 1646, Epsitre,s.i.p.36 Nadaeus per Niceron. G. Naudè, medico di Luigi XIII, già fa-moso come bibliotecario sia del Cardinale Gianfrancesco Guididi Bagno che del Cardinale Francesco Barberini, divenne respo-sabile della biblioteca del cardinal Richelieu, alla sua morte, ac-cettando di diventare bibliotecario del suo successore, il cardinaleGiulio Mazzarino. Per conto di Mazzarino viaggiò per tutta Eu-ropa, raccogliendo oltre 40.000 volumi e così costituendo il fondodi quella che sarebbe passata alla storia come Bibliothèque Ma-
zarine, ancora oggi attiva e ricca di manoscritti e libri rari. GabrielNaudè è noto anche come autore del primo manuale di bibliote-conomia francese, l'Advis pour dresser une bibliothèque (Parigi1627). Cfr. J. V. RICE, Gabriel Naudé, 1600-1653, Johns HopkinsPress, Baltimore 1939; S. L. JACKSON, Gabriel Naude: 'Most Eru-dite and Most Zealous for the Common Good', “Stechert-HafnerBook News”, 1969.37 Cfr. G. LIVA, Terra incognita: carteggi e fonti ciceroniane, inA. DE ROSA (a cura di), Jean François Niceron. Prospettiva, ca-tottrica & magia artificiale, cit.38 Filone di Alessandria, o Filone l'Ebreo (20 a.C. ca. – 50 d.C.ca.), filosofo ellenistico di cultura ebraica, fu l’autore, tra l’altro,del trattato De Specialibus Legibus, in cui ordinava in modo coe-rente le varie leggi della Torah, confrontandole con i 10 Coman-damenti. Cfr. R. RADICE, Platonismo e creazionismo in Filone diAlessandria, introduzione di G. REALE, Vita e Pensiero, Milano1989.39 Nel testo viene citato in Greco, con alcune varianti testuali esenza un esplicito rimando alla fonte, il capitolo 3.100 del De le-gibus specialibus di Filone di Alessandria, che qui riportiamo nel-l'assetto testuale fede degno su cui si basa la traduzione cheabbiamo proposta: “thün meün ou\n ajlhqh~ magikhvn, ojptikhvn ej-pisthvmhn, h/| taü th~" fuvsew" e[rga tranotevrai" fantasivai"aujgavzetai, semnhün kaiü perimavchton dokou~san ei\nai, oujkijdiw~tai movnon ajllaü kaiü basilei~" kaiü basilevwn oiJ mevgistoikaiü mavlista oiJ Persw~n diaponou~sin ou[tw", w{stÊ oujdevnafasiün ejpiü basileivan duvnasqai parapemfqh~nai parÊ aujtoi~",eij mhü provteron tou~ mavgwn gevnou" kekoinwnhkwü" tugcav-noi.” Cfr. Filone di Alessandria, Tutti i trattati del commentarioallegorico alla Bibbia, a cura di R. RADICE, Bompiani, Milano2005. Come vedremo più avanti, Niceron originariamente citavail brano di Filone di Alessandria nella Prefazione de La Perspec-tive curieuse (1638), spostandola in sede dedicatoria, nell’Epistrerivolta al Cardinale Mazarino nel successivo Thaumaturgus op-ticus(1646).40 Nel 1642, quando Richelieu morì, il Cardinale Mazzarino glisubentrò nelle vesti di Primo Ministro. Alla morte di Luigi XIII(1643), a causa della minore età del legittimo erede Luigi XIV,Mazarino assunse in pratica la reggenza della Francia assiemealla Regina madre Anna Maria Maurizia d'Asburgo, meglio notacome Anna d'Austria (1601–1666). Le controversie sulla politicadel Cardinale, a fronte della debolezza della casa reale, condus-sero la Francia a due guerre civili, note come le Fronde, movi-menti di opposizione alla politica del Cardinale, che questi riuscìabilmente a sconfiggere con l'appoggio del giovane Luigi XIV edella reggente Anna d'Austria, rafforzando l'autorità regia. Cfr.M. CAPEFIGUE, Richelieu, Mazarin Et La Fronde, 2 voll., Belin-Leprieur, Parigi 1844.41 Sui rapporti tra Platone e la matematica si rimanda a: D. MAS-SARO, Matematica e Filosofia in Platone, Seminario G.R.I.M.,
116
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
Università di Palermo, 1996 - Quaderni di Ricerca in Didattica,n.7, 1997, pp. 118-135. 42 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Preface et adver-tissement au Lecteur, s.i.p.43 Ibid.44 Cfr. E. POULI, Les instruments astronomiques du Moyen Age,Société internalionale del'Astrolabe, A. Brieux, Parigi 1983.45 Il bastone di Giacobbe è uno strumento, dalla forma approssi-mativa di croce, atto a stimare: in astronomia, valori angolari tracorpi celesti; in nautica, la latitudine di un vascello misurandol’altezza della Stella Polare o del Sole; e nel rilievo architettonicoe topografico, altezze e distanze di edifici o elementi orografici.Fu inventato dall’astronomo francese Jacob ben Makir(1236–1304) nel Medio Evo, ma codificato dallo studioso ebreoLevi ben Gershon (1288–1344), anch’egli nato in Provenza, notoanche col nome latino Gersonides, o con l’acronimo RaLBaG(Rabin Levi ben Gershon). Lo strumento compare per la primavolta nella sua opera, scritta in ebraico, dal titolo MilHamot Ado-nai (Il Libro delle Guerre di Dio, 1317-29). Impiegato da Paolodal Pozzo Toscanelli nel 1433 per misurazioni astronomiche, fusuccessivamente modificato da Pietro Apiano (Introductio geo-graphica, Ingolstadt 1533) e da Rainer Gemma Frisius (De radioastronomico et geometrico, Anversa e Louvain 1545). Si veda inmerito: G. BOFFITO, Gli strumenti della scienza e la scienza deglistrumenti: con l'illustrazione della Tribuna di Galileo, Facsimilidi Primo Benaglia, Libr. internazionale Seeber, Firenze 1929; B.R. GOLDSTEIN, The astronomy of Levi ben Gerson (1288-1344),Springer, New York 1985; F. CAMEROTA (a cura di) Nel segno diMasaccio. L’invenzione della Prospettiva, Giunti, Firenze 2001.46 La pinnula è un mirino, in forma di piccola penna, che si ap-plicava alla fessura di cui erano dotati gli antichi strumenti astro-nomici e geodetici per la collimazione degli astri.47 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Preface et adver-tissement au Lecteur, s.i.p.48 Nel Thaumturgus opticus (1646) Niceron amplia l’elenco degliartisti meritevoli di lode, in quanto profondi conoscitori dell’otticae dunque della prospettiva, inserendovi i nomi di Guido Reni,Pietro da Cortona, Albrecht Dürer, Michelangelo Buonarroti, Da-niele da Volterra, Raffaello da Urbino. Cfr. J. F. NICERON, Thau-maturgus opticus, cit., Praefatio ad lectorem studiosum, s.i.p.49 L’opera a cui si riferisce Nicéron si intitola Ezechielem Expla-nationes et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani Commen-tariis et Imaginibus descriptus (Roma 1596–1604, 3 voll.), in cuil’erudito e prolifico sacerdota gesuita, insieme al suo confratelloJerònimo del Prado, cerca di coniugare l’esegesi della profezia diEzechiele (il più ermetico tra i Profeti) con la restituzione graficadell’imago mitica del Tempio di Salomone, voluto da Dio (benchécostruito dal leggendario architetto Hiram) e in quanto tale arche-tipo dell’Architettura e matrice dei successivi Ordini della clas-sicità, Cfr. A. PEREZ-GOMEZ, Juan Bautista Villalpando’s Divine
Model in Architectural Theory, in CHORA: Intervals in the Phi-losophy of Architecture, Vol. 3, Montreal 1999. Sempre A. Perez-Gomez, in un altro testo, sostiene che “…Villalpando si ponecontro Barbaro e afferma la sua opinione secondo la quale Vitru-vio avesse voluto intendere prospettiva (scenographia) nel suopassaggio sulle idee in Architettura. La prospettiva con questopreciso uso delle linee e delle ombre piuttosto che il colore pit-torico (che Villalpando associa alla skiagraphia) è l’idea guidadell’architettura, che Villalpando correla al potere stesso di Diodi creare pienamente nella mente.” Cfr. A. PEREZ-GOMEZ, L. PEL-LETIER, Architectural Representation and the Perspective Hinge,Mit press, Cambridge 2000, p. 122.50 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Preface et adver-tissement au Lecteur, s.i.p.51 Ivi.52 Zeusi o Zeusippo, fu un pittore greco vissuto nella secondametà del V secolo a.C. Le fonti sono incerte sulla sua nascita: c’èchi lo vuole nato a Eraclea sul Ponto e chi lo indica nativo di He-raclea in Magna Grecia. Operò del resto in molte aree del mondoantico, soffermandosi ad Atene dove divenne noto per avervi svi-luppato la cosiddetta ‘pittura da cavalletto’. Ebbe fama notevole,e fu citato da Platone (nel Protagora), Senofonte, Aristofane ePlinio. Fra le sue opere, celeberrima è la pittura parietale nel pa-lazzo del Re di Macedonia, Archelao. Fu autore del celebre di-pinto ritraente dell’uva in modo così realistico da trarre ininganno i passeri che vi si schiantavano nel tentativo di beccarnegli acini iperrealistici. Cfr. P. MORENO, M.C. POMA, Pittura greca:da Polignoto ad Apelle, Mondadori, Milano 1987. 53 Parrasio di Efeso, pittore greco antico, attivo nel IV secoloa.C. e contemporaneo di Zeusi, Fidia, Apelle e Timate. La vi-cenda alla quale si riferisce Niceron è la famosa disputa sorta traZeusi e Parrasio in cui il primo dipinse alcuni grappoli d’uva edespose il dipinto all’aria aperta. L’immagine dipinta appariva cosìrealistica dal punto di vista ottico che subito arrivarono degli uc-celli per beccare le immagini dei chicchi. Parrasio, in risposta allasfida lanciata da Zeusi, presentò anch’egli la sua tavola in cui eradipinto un panno che sembrava coprire un ritratto. Allora Zeusigli chiese di alzare quella tela per poter ammirare l’opera sotto-stante e portare a conclusione la competizione, ma Parrasio nonsi mosse e Zeusi solo allora capì di essere stato ingannato, di-chiarandosi vinto. 54 Jean Pèlerin, detto Le Viator (1445 ca.–1524 ca.), prelatofranco-fiammingo e segretario di Luigi XI, fu l’autore del celebreDe Artificiali Perspectiva (Tolosa 1505,) prima opera –se siesclude quella manoscritta di Piero della Francesca– dedicataesclusivamente alla prospettiva e che illustrasse, con linguaggiopiano e notevoli semplificazioni grafiche, esempi concreti di pro-spettive architettoniche e ambientali. Il testo suggella in qualchemodo il successo del procedimento grafico come metodo teoricoassoluto, rispetto ai vecchi studi sulla geometria della visione, di
117
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
cui si occupa e che viene anzi esclusa dalla presente nel titolo conl’impiego dell’aggettivo ‘artificiali’. Le regole esposte dal Viatornel suo trattato sono riconducibili sostanzialmente all’impiegodei cosiddetti tiers points, cioè i due punti di distanza collocatisulla linea d’orizzonte (definita ‘piramidale’ dal Viator) a ugualedistanza da quello definito ‘principale’: si tratta, secondo la mo-derna Geometria Descrittiva, rispettivamente dei punti di fugadelle rette orizzontali inclinate a 45° e di quelle ortogonali rispettoal quadro, il cui impiego consente all’autore di realizzare prospet-tive bifocali –o cornute– di oggetti e architetture disposti in po-sizione accidentale rispetto al quadro iconico. La scelta di questometodo è assolutamente anti-albertiana: laddove Alberti imma-gina un osservatore mesotticamente esterno alla superficie pitto-rica, individuando l’immagina come effetto della celebre sezionedella piramide visiva, nel procedimento di Viator l’osservatore èconsustanziale al quadro. Il trattato del Viator fu più volte pla-giato, soprattutto nelle molteplici edizioni della Margarita philo-sophica (prima edizione, Friburgo 1503) di Gregor Reisch(1467–1552). Cfr. L. BRION-GUERRY, Jean Pélerin Viator. Saplace dans l’histoire de la perspective, Les Belles Lettres, Parigi1962; F. GRUBIC, Jean Pèlerin le Viateur, ‘De artificiali Perspec-tiva’. Entstellung und Herkunst seiner Perspektiva, Vienna 1922(tesi non pubblicata). 55 Albert Durer nell’originale francese. Qui Nicéron intende ri-ferirsi evidentemente all’opera di Albrecht Dürer (1471–1528)nota col titolo di Underweysung der Messung, mit dem Zirckelund Richtscheyt in Linien Ebenen und gantzen Corporen [Insti-tutionum Geometricarum …], pubblicata a Norimberga nel 1525,nella quale era contenuta la prima esposizione teorica della pro-spettiva lineare in ambito nord Europeo. 56 Leon Battista Alberti (1404–1472) pubblicò la prima edizionein latino del suo De Pictura nel 1435, seguita, dopo un anno,dall’edizione in volgare con dedica all’amico Filippo Brunelle-schi.57 Jean Cousin il Vecchio (1490-1560) pittore, incisore e scultorefrancese, fu autore di un importante trattato di prospettiva intito-lato Livre de perspective (Parigi 1560).58 Jacques Androuet du Cerceau (1515/1520–1585/86) fu autoredel trattato Leçons de perspective positive (Parigi 1576).59 Salomon de Caus (1576–1626) architetto e ingegnere francese,fu autore de La Perspective avec la raison des ombres et miroirs(Londra 1611). Cfr. L. MORGAN, Nature as model: Salomon deCaus and early seventeenth-century landscape design, Universityof Pennsylvania Press, Philadelphia 2007.60 Jean Louis De Vaulezard, matematico francese, autore del pic-colo libro intitolato Perpective cylindrique et conique…, pubbli-cato a Parigi nel 1630, seguito a distanza di un solo anno da unaltro testo titolato Abregé ou raccouncry de la perpective…,(Parigi 1631). Entrambi i testi nascono come supporto didatticoper i suoi allievi e, in particolare , il primo desta particolare inte-
resse soprattutto per la parte dedicata allo studio delle anamorfosicatottriche, mentre il secondo propone i principi della prospettivain modo rigorosamente matematico, fornendo dapprima una seriedi proposizioni di geometria cui seguono definizioni e leggi sullaprospettiva.61 Pierre Hérigone, latinizzato sotto la forma Petrus Herigonius(1580–Parigi, 1643), è stato un matematico e astronomo francese.Di origine basca, Hérigone insegnò a Parigi quasi tutta la sua vita.È l'autore di un Cursus mathematicus, nova, brevi, et clara me-thodo demonstratus, per notas reales et universales, citra usumcujuscunque idiomatis intellectu faciles (pubblicato a Parigi insei volumi, tra il 1634 e il 1637; seconda edizione 1644), un rias-sunto di matematica e logica elementare redatto in francese e inlatino. Questo libro si proponeva di utilizzare un simbolismo lo-gico particolare per migliorare lo studio della matematica. Unestratto di questo trattato, composto da ventisette pagine, è dedi-cato ai problemi della rappresentazione divisi in tre paragrafi: De-finitiones perspectivae; Axiomata et nonnulla theoremata inGeometria demonstrata; Propositiones perspectiae. Il contributodi Hérigone alla teoria della prospettiva è corredato da semplicie chiare figure, dove l’immagine realistica dell’oggetto è prece-duta dalla relativa costruzione geometrica. 62 Girard Désargues (1591–1661), matematico francese, è consi-derato uno dei fondatori della Geometria proiettiva. Le sue ideerivoluzionare segnarono una svolta decisiva all’interno del pen-siero scientifico del XVII secolo, contribuendo notevolmente allosviluppo della teoria prospettica; e non soltanto nel senso di faci-litarne i processi costruttivi, ma soprattutto di elevare l’intera geo-metria a un livello di perfezione concettuale e metodologica maiprima raggiunto col tentativo, ben riuscito, di svincolare la stessateoria dal fenomeno fisiologico della visione e ampliandolo aiconcetti più astratti e generali della geometria proiettiva. Désar-gues ha lasciato numerosi ma poco estesi scritti sulla prospettiva,sulle sezioni coniche, sulla stereotomia e sulla gnomonica. Ed èproprio attraverso le sue due prime e brevi opere che le sue ideeprofondamente innovative e originali cominciano ad essere co-nosciute e apprezzate dagli studiosi più illuminati. Della primaabbiamo notizia dal privilegio del 1630: si tratta di un piccolotrattato sulla musica, dal titolo De l’art de bien chater che esponeun metodo facile per apprendere l’arte del cantar bene e insegnarea leggere e scrivere la musica, che sarà pubblicato poi nel VI librodel celebre testo di Marin Mersenne, Harmonie universelle (Pa-rigi 1636–37) e la cui attribuzione a Désargues è attestata dallostesso Mersenne che ne esprime vivo compiacimento. La secondaopera, stampata a Parigi nel 1636, recante il titolo Mèthode Uni-verselle de mettre en perspective les données réallament ou endevis…, è espressamente dedicata alla prospettiva e da essa tra-pela tutto l’interesse dell’autore verso questa disciplina che locondusse allo sviluppo della teoria sulle sezioni coniche trasfe-rendo, in virtù della prospettiva, le proprietà polari del cerchio,consapevole che quella teoria conferisse maggiore generalità e
118
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
completezza alla stessa prospettiva. 63 Sebastiano Serlio (1475–1554), autore di uno dei più importantitrattati di architettura, intitolato I sette libri dell’Architettura, checontribuì a diffondere nel XVI secolo il linguaggio classicista ele nuove tendenze manieristiche. I singoli libri che compongonoil trattato furono pubblicati a partire dal 1537, in ordine irregolaretra l’Italia e la Francia. In particolare, il II Libro, al quale Niceronsi riferisce, fu dedicato alla prospettiva e alla scenografia, com-pletato durante il soggiorno a Fontainebleau e pubblicato a Pariginel 1545.64 Lorenzo Sirigatti (?–1596/97), matematico e membro dell’Ac-cademia fiorentina fu autore del trattato La pratica di Prospettiva,(Venezia 1596). Dal momento che nella Perspective curieuse del1638 non è presente in appendice al volume nessuna bibliografia,possiamo supporre che l’edizione di questo trattato consultata daNiceron sia quella del 1625 (pubblicata sempre a Venezia), cosìcome viene riportata dal Padre minimo nei riferimenti bibliogra-fici presenti invece nell’appendice del Thaumaturgus opticus del1646.65 Jacopo Barozzi da Vignola, detto comunemente Il Vignola(1507–1573), architetto e teorico dell'architettura, fu uno degliesponenti più importanti del Manierismo, in un'epoca di impor-tanti cambiamenti di cui fu protagonista. La sua importanza sto-rica è dovuta anche all’opera di trattatista dell'architetturasoprattutto per la teorizzazione degli ordini che rappresentò unmomento importante nella definizione del canone classicista.L’opera alla quale si riferisce Niceron è intitolata Le due regoledella prospettiva pratica di M. Jacomo Barozzi da Vignola. Coni commentari del R.P.M. Egnatio Danti dei Predicatori, Matema-tico dello studio di Bologna, Roma 1583 (prima edizione). L’edi-zione consultata da Niceron, così come riportato nelle notebibliografiche del Thaumaturgus opticus, è quella pubblicata asempre a Roma ma nel 1611. 66 Guidobaldo Del Monte (1545–1607) matematico, filosofo,astronomo e marchese italiano, fu autore di un importante librosulla prospettiva, intitolato Perspectivae Libri VI, pubblicato aPesaro nel 1600.67 Daniele Barbaro, (1514–1570) Cardinale, Patriarca cattolico eumanista italiano, studioso di filosofia, matematica e ottica. Fuautore del libro di prospettiva intitolato La pratica della Prospet-tiva, Venezia 1568.68 Ferdinando di Diano (Polineus Dianes, Diano,*–*), L’occhioerrante dalla ragione emendate, prospettiva, Venezia 1628. Lafigura di questo autore è molto controversa: infatti alcuni lo iden-tificano con Donato Polieno da Siderno, abate Benedettino dellaConfraternita dei Celestini, professore di teologia vissuto tra lafine del XV e il primo decennio del XVI secolo (cfr. G. MELZI,Dizionario di opere anonime e pseudonime etc., Milano 1868, I,p. 293.); altri invece lo identificano come Ligur ex Oppido Diano(cfr. A. OLDINIO, Athaeneum Ligusticum, Seu Syllabus…, Perugia
1680, p. 177.). L’opera citata da Niceron è composta da un Proe-mio e da 45 Manifestazioni nelle quali è discussa l’intera proble-matica della prospettiva, compresi i fondamenti geometricinecessari al suo svolgimento e le applicazioni a casi semplici nelpiano e nello spazio, Cfr. L. VAGNETTI, De Naturali et artificialiPerspectiva, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1979, p 386.Kirsti Andersen descrivere l’opera come inutilmente prolissa enella quale l’autore, pur dedicando alla prospettiva quasi 30 pa-gine, ha fatto poco più che discutere su come un quadrato possaessere rappresentato in prospettiva. Cfr. K. ANDERSEN, The math-ematical treatment of anamorphoses from Piero della Francescato Nicéron, “History of Mathematics: States of the Art”,San Diego 1996, p. 374.69 Qui Niceron si riferisce a Hans Lencker il Vecchio(1523–1585) studioso appartenente ad una famiglia di gioiellieried orefici, autore del testo intitolato Perspectiva literaria. Dasist ein clerliche Fürreyssung, wie man alle Buchstaben ... in diePerspectif ... bringen mag, Norimberga 1567 (ed. anastatica Fran-coforte 1972). In quest’opera l’autore inserisce, senza alcun chia-rimento o dimostrazione, numerose vedute prospettichecorrettamente costruite di lettere dell’alfabeto lapidario romanoe di strani volumi regolari, stelle, croci, anelli intrecciati, incisein modo particolarmente pregevole e raffinato. Non è dunqueun’opera di teoria prospettica, ma quasi un catalogo di virtuosi-smi grafici realizzati per mezzo della prospettiva. Cfr. K. ANDER-SEN, op.cit., in History of Mathematics: States of the Art, SanDiego 1996; F. CAMEROTA (a cura di) Nel segno di Masaccio.L’invenzione della Prospettiva, Firenze 2001, p. 256; M. DALAIEMILIANI, a cura di, La prospettiva rinascimentale: codificazionie trasgressioni, Milano 1980, p. 454-455.70 Qui Nicéron intende riferirsi a Wenzel Jamnitzer (Jamitzer, oWenzel Gemniczer) (1507/1508–1585), arista, incisore e soprat-tutto orafo che lavorò alle dipendenze di molti imperatori tedeschitra i quali Carlo V, Ferdinando I, Massimiliano II e Rodolfo II.Fu autore del Perspectiva corporum regularium. Norimberga1568.71 Joachim Fortius Ringelberg (1499–1556) iniziò la sua carrieracome incisore presso la corte di Massimiliano I, fu professore indiverse università di varie materie umanistiche e scientifiche,dalla matematica al misticismo, così come l'astrologia. Niceronsi riferisce ad uno dei suoi scritti, in particolare a quello intitolatoOptice, in “Opera”, Lione 1531 (ed. anastatica Niewkoop 1967),una sezione dell’intero lavoro in cui l’autore dedica una ventinadi pagine alla prospettiva sotto il titolo di ottica. Cfr. K. ANDER-SEN, The Geometry of an Art: The History of the MathematicalTheory of Perspective from Alberti to Monge, Copenhagen 2007,p. 166 e seg.72 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Preface et adver-tissement au Lecteur, s.i.p.73 Qui Nicéron si riferisce al IV Libro del testo di Guidobaldo Del
119
La geometria descrittiva dalla tradizione alla innovazione
Monte, Perspectivae Libri VI (Pesaro 1600), dove l’autore si oc-cupa dei solidi e dei poliedri, del loro sviluppo nel piano e deiprocedimenti grafici necessari alla loro rappresentazione in pro-spettiva. 74 Qui Nicéron si riferisce al IV Libro della La pratica della Pro-spettiva di Daniele Barbaro (Venezia 1568), dove l’autore affrontala questione della rappresentazione dei poliedri dimostrando diaver studiato attentamente i trattati di Dürer, Pacioli e di Pierodella Francesca. A differenza dei suoi predecessori, ed in parti-colare di Dürer, che si occupano soprattutto dello sviluppo dei so-lidi sul piano, Barbaro affronta anche la questione relativa al lorodisegno in prospettiva con squadra e compasso. Questa esposi-zione dei corpi regolari culmina negli ultimi due capitoli del trat-tato con La Descrizione del torchio, e con La perfettaDescrizione del Mazzocco, ovvero del mazzocchio. Cfr. F. CAME-ROTA (a cura di) Nel segno di Masaccio. L’invenzione della Pro-spettiva, cit, p. 127.75 Si tratta di una massima di Orazio, la cui citazione completarecita: “Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, lectorem de-lectando pariterque monendo”: "Ebbe il voto di tutti (un consensounanime) chi unì l'utile al dilettevole, dilettando e insiemeistruendo il lettore”. Cfr. Orazio, Ars poetica, in Id., “Le opere.Vol. 3: Le Epistole-L'Arte poetica”, a cura di P. Fedeli, IstitutoPoligrafico dello Stato, Roma 1997, verso 343.76 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Preface et adver-tissement au Lecteur, s.i.p. 77 Cfr. A. DE ROSA, L’oblio del visibile, la memoria dell’invisi-bile: Jean François Niceron taumaturgo ottico, in A. DE ROSA(a cura di), Jean François Niceron. Prospettiva, catottrica &magia artificiale, cit. 78 Giovanni Pico dei conti della Mirandola e della Concordia (oPico della Mirandola), umanista e filosofo italiano, celebre perla sua prodigiosa memoria, svolse studi di diritto canonico a Bo-logna, di lettere a Ferrara e di filosofia a Padova. Dal 1485 Picosoggiornò a Parigi dove partecipò alle dispute della Sorbona e ap-profondì le conoscenze teologiche. Tornato in Italia nel 1486, in-tensificò lo studio delle lingue orientali, in particolare l’arabo,l’ebraico e il caldaico, grazie alle quali poté leggere la Qabbalah,gli Oracoli caldaici e il Corano. In questo periodo Pico della Mi-randola formulò un pensiero incline a uno spiccato sincretismo,nella ricerca di una profonda conciliazione fra le religione e filo-sofie. In questa prospettiva bisogna inquadrare il suo tentativo diorganizzare a Roma, nel 1487, un convegno di dotti, chiamati adiscutere di temi cruciali in ambito dottrinale e sapienziale. Tut-tavia, Pico della Mirandola non riuscì mai nel proprio intento,perché le 900 tesi del proprio programma, riunite nelle Conclu-siones philosophicae, cebalisticae et theologicae (1486) in pre-parazione alla disputa, furono condannate come eretiche da unacommissione di teologi e giuristi. Da questa accusa cercò di di-fendersi nell’Apologia, opera del 1487, redatta prima della firma
dell’atto di sottomissione alle autorità ecclesiastiche. Il brano ci-tato da Niceron è tratto proprio da quest’ultimo lavoro (cfr. Apo-ligia, I, Proem. 1, p. 1). e si riferisce ad un passo che risulta uncalco da Diogene Laerzio (III d.C.?) e dalle sue Vite dei filosofi(I 1-3): “Ed infatti Aristotele nel libro Magico e Sozione nel libroventitreesimo della Successione dei filosofi dicono che gli inizia-tori furono i Magi presso i Persiani, i Caldei presso i Babilonesie gli Assiri, e i Gimnosofisti presso gli Indiani, i cosiddetti Druidie Semnotei presso i Celti ed i Galli. E che inoltre nella Fenicianacque Oco, nella Tracia Zamolsi e nella Libia Atlante.” Cfr. E.GARIN, Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrine, Storia eLetteratura, Roma 2011.79 B. Pereius, filoso e teologo spagnolo entrò nella Compagnia diGesù nel 1552 e insegnò successivamente letteratura, filosofia,teologia e Sacra Scritture a Roma. Autore di numerose opere let-terarie tutte incentrate sui temi religiosi e filosofici tra cui quellaprincipale è la De rerum omnium communibus naturalium prin-cipis et affectionibus libri quindicim (Roma 1576). L’opera allaquale fa riferimento Niceron è il trattato pubblicato per la primavolta a Roma nel 1587, intitolato De Magia, de observatione som-niorum e de divinatione astrologica alla fine dei suoi Commentarisu Daniele e ristampato a parte nel 1598 a Colonia. 80 J. C. BULENGERUS, De Pictura, plastice, statuaria libri duo,Ludovici Prost, Lione 1627.81 F. TORREBLANCA, Dæmonologia siue De magia naturali, dæ-moniaca, licita & illicita, deque aperta & occulta, interuentione& inuocatione dæmonis libri quatuor..., impensis Ioh. TheowaldiSchönwetteri, Moguntiae 1623.82 Qui Niceron cita un passo dell’opera Geografia (1.2.15.10) diStrabone in cui si legge: "(definiscono) maghi coloro che spic-cano per una qualche forma di sapienza". 83 La Sfera di Posidonio era un planetario metallico, ideatonell’87 a.C. da Posidonio di Rodi (135 a.C. ca. – 50 a.C.), filosofoe scienziato naturalista, che consentiva la misurazione del motodiurno del Sole, di quello della Luna e dei cinque pianeti all’epocanoti. Il congegno, probabilmente simile alla macchina di Antiky-thera e diffuso in tutta l'area del Mediterraneo, viene descritto daCicerone che lo acquistò dallo stesso scienziato a Rodi. Cfr. Ci-cerone, De Natura Deorum, ii-34, p. 287. 84 Archita (428 a.C. – 347 a.C.), filosofo pitagorico, scienziato euomo politico, viene considerato il fondatore della Meccanica ra-zionale e della Meccanica. Autore di diversi automi, Archita èl’ideatore del meccanismo cui fa cenno Niceron, e che vien de-scritto da Aulo Gellio (lib. X, c. 12),costituito da una colomba dilegno, vuota all’interno, riempita d’aria compressa e fornita d’unavalvola che permetteva apertura e chiusura, regolabile per mezzodi contrappesi. Messa su un albero, la colomba volava di ramo inramo perché, apertasi la valvola, la fuoriuscita dell’aria ne pro-vocava l’ascensione; ma giunta ad un altro ramo, la valvola o sichiudeva da sé, o veniva chiusa da chi faceva agire i contrappesi;
120
Agostino De Rosa, Le prospettive di Jean François Niceron: tra teoria geometrico-matematica e sperimentazione artistica
e così di seguito, sino alla fuoriuscita totale dell’aria compressa.Cfr. A. TAGLIENTE, La colomba di Archita, Scorpione Editrice,Taranto 2011; A. FRAJESE, Attraverso la storia della Matematica,Veschi, Roma 1962.85 Gli specchi ustori usati da Archimede per la difesa di Siracusacontro l’assedio romano durante la seconda guerra punica sonodescritti da Polibio e Tito Livio come una serie di lamelle metal-liche concave che riflettevano la luce solare concentrandola suinemici, incendiandone le imbarcazioni in legno. 86 Dedalo, personaggio della mitologia greca, figlio di Metione eprobabilmente originario di Atene, vissuto nel periodo in cuiEdipo era Re a Tebe e Minosso a Cnosso, noto per essere il co-struttore del famoso labirinto del Minotauro, fu versato tantonell’architettura, che nella scultura, ma celebre anche come in-ventore. Le sue opere sono elencate da Pausania. Apollodoro loricorda come abilissimo maestro d’arte, il più bravo degli archi-tetti e il primo inventore di statue. Le fonti lo presentano comeun personaggio ingegnoso e abile, i cui ‘sapienti pensieri’ lo por-tarono a cimentarsi ora in piccole invenzioni, come particolaristrumenti per il lavoro artigianale, ora in imponenti meraviglie diingegneria e architettura. Ma, come dicevamo, l’abilità artisticapiù tipica di Dedalo, quella in cui egli si distinse al di sopra diogni altro, è la scultura e la sua capacità di creare statue che eranocopie perfette e identiche dei modelli reali, o addirittura idoli mo-bili, in grado di camminare e di guardare, quasi fossero esseri vi-venti. Cfr. M. PUGLIARA, Il Mirabile e l’Artificio: Creatureanimate e semoventi nel mito e nella tecnica degli antichi, L'Ermadi Bretschneider, Roma 2003.87 Alberto Magno di Bollstädt (detto Doctor Universalis, cono-sciuto anche come Alberto il Grande o Alberto di Colonia;1206–1280), fu un religioso domenicano tedesco. Considerato ilpiù grande filosofo e teologo tedesco del medioevo, si occupòanche di scienza sperimentale, nel cui ambito deve essere collo-cata la sua invenzione di un androide, una ‘testa parlante’, cosìefficace che San Tommaso, recatosi da Alberto Magno per ap-prendere i segreti della filosofia, ruppe con un calcio perché loimportunava con il suo chiacchiericcio, impedendogli di concen-trarsi nella lettura. Cfr. J. A. WEISHIEPL, Alberto Magno e lescienze, ESD-Edizioni Studio Domenicano (collana Lumen),Bologna 1993.88 Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (475–525), filosoforomano noto semplicemente come Boezio, con le sue opere in-fluenzò notevolmente la filosofia cristiana del Medioevo, tantoche alcuni lo collocano tra i fondatori della Scolastica. Boeziorealizzò alcuni automi in forma di serpenti bronzei che sibilavano,
come riferisce Cassiodoro (Varium Libri Duodecim, Liber Pri-mus, 537- 540, I, 6, Epistola Quadrigesima Sexta: "quod nobis co-tidianum, illis videatur esse miraculum: metalla mugiunt,Diomedes in aere gravius bucinat, aeneus anguis insibilat, aves si-mulatae fritinniunt, et quae vocem propriam nesciunt habere, dul-cedinem probantur emittere cantilenae"). Se ne trova traccia anchein Agrippa Von Nettesheim, Henricus Cornelius, De incertitudineet vanitate scientiarum declamatio invectiva, ex postrema auctorisrecognitione, Lugduni 1531 (pag. 43). Si veda: P. DALLA VIGNA (acura di) Lo specchio della magia. Trattati magici del XVI secolo,Mimesis edizioni, Milano 1999, p. 42; M. KANG, Sublime Dreamsof Living Machines: The Automaton in the European Imagination,Harvard University Press, Harvard 2011, pp. 88 sgg. 89 J. F. NICERON, La perspective curiuese, cit., Preface et adver-tissement au Lecteur, s.i.p.90 J. F. NICERON, Thaumaturgus opticus, cit., Praefatio ad lec-torem studiosum, s.i.p.91 Nell'esametro citato in corsivo nel testo, Dent veniam maculisquas aut incuria fudit, si riconosce il v. 352 dell'Ars poetica ora-ziana, fatta salva la sostituzione dell'originale offendar con il sin-tagma Dent veniam nell'attacco del verso. Il successivo verso 353(citato fino al quinto piede) appare invece incorporato nel testoin tondo e separato dal precedente, sia graficamente che logica-mente, da un punto fermo impropriamente collocato dopo fudit.Ciò interrompe la sequenza logica e sintattica delle due proposi-zioni coordinate disgiuntive: aut incuria fudit si completa infatticon il successivo aut humana parum cavit natura. Nella traduzione, Ilaria Rizzini ha pertanto deciso di ripristinarela corretta scansione della citazione e di eliminare il punto fermoindebitamente collocato nel distico oraziano. È anche possibile ipotizzare che l'impropria dislocazione deltesto, che inficia la correttezza della citazione, nonché la sostitu-zione dell'attacco originale con un altro, funzionale ovviamenteal tenore della prefazione, si spieghino con la lamentata incuriadei tipografi, presente in chiusura della Premessa, e che nelle in-tenzioni dell'artefice il testo andasse graficamente articolato inquesto modo: “& dent veniam maculis quas aut incuria fudit /Aut humana parum cavit natura”, e non come appare invece neltesto a stampa: “Dent veniam maculis quas aut incuria fudit Authumana parum cavit natura”. Secondo Rizzini, sarebbe pertantocorretto incorporare il sintagma Dent veniam nel testo in tondo,e circoscrivere la citazione alla sola sequenza originale. Cfr. A.DE ROSA, I trattati di Jean François Niceron, in A. DE ROSA(a cura di), Jean François Niceron. Prospettiva, catottrica &magia artificiale, cit.