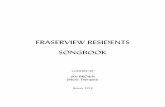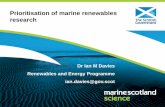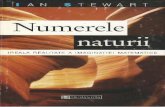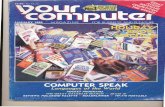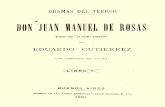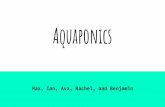Il Riccardo III di Ian McKellen
Transcript of Il Riccardo III di Ian McKellen
1
Pier Giuseppe Monateri
Visiting professor, Sciencespo, Paris.
Univ. Di Torino, Int’l Academy Comparative Law New York, Accademia delle Scienze, Bologna.
Il Riccardo di Ian McKellen.
Oltre lo schema rinascimentale del politico, Belial e il centro del canone.
1. Introduzione: Riccardo III e gli anni ’30
2. Tirannia, Dispotismo e Dittatura, tra Leo Strauss e Carl Schmitt
3. I particolari della versione di McKellen
4. Dittatura, Stato di Eccezione e assassinio politico: dalla tecnica alla estetica del
“colpo di stato”.
5. Conclusioni : La caduta di Gloucester e l’Angelo dell’Anomia.
2
1. Introduzione : Riccardo III e gli anni ‘30
In questo articolo ci occuperemo della trasposizione cinematografica del Riccardo III
pensata da Ian McKellen e operata da Richard Loncraine, nel 1995, con speciale
riferimento al famoso adattamento di Lawrence Olivier del 1955, cioè esattamente di
40 anni prima.
Il nostro punto di vista sarà innanzitutto quello di vedere come la tecnica
cinematografica sia stata utilizzata per enfatizzare un particolare tema di
interpretazione, ovvero per produrre un determinato significato dell’opera, a partire
dall’oggetto proprio del dramma che, presumibilmente, è la tirannia.
Il parallelo tra le due opere non potrebbe, a tutta prima, apparire più contrastante.
Olivier usa una tecnica molto collaudata di “Hard Black and White”, che può essere
colta soprattutto nell’uso drammatico delle ombre e dei contrasti, e che ha ormai
acquisito il sapore del classico, ma che era una tecnica specifica anche del “Cultural
Front” americano, cercando di mostrare soprattutto la complessità della personalità di
Riccardo nel suo abbandonarsi alla propria malizia e al proprio desiderio per la
Corona. In questo modo, nella sua trasposizione, i sentimenti del personaggio
servono a giungere al tema ciclico del passaggio della Corona da un re all’altro, in
una sorta di eterno ritorno dell’uguale politico, che Constance Brown1 ha definito
come il vero “dispositivo centrale di coerenza” del dramma.
Al contrario Loncrain si è affidato ad una trasposizione compiutamente
“ermeneutica”, nel senso in cui questa si oppone alla interpretazione: ovvero nel
senso in cui l’ermeneutica è consapevole della distanza dal testo e non teme, quindi,
di appropriarsene per una attualizzazione conscia dei propri presupposti.
Naturalmente l’effetto più eclatante del film di Loncrain è quello di ridislocare la
vicenda nell’Inghilterra degli anni trenta, con un lento, ma inesorabile passaggio degli
1 Constance Brown, "Olivier's Richard III: A Reevaluation." Focus on Shakespeare Films. Ed. Charles W. Eckert. Englewood Cliffs: Prentice, 1972. 131-45.
3
abiti, delle uniformi e dei costumi, dagli anni ’20, come nella scena iniziale, con
musica da ballo, del celebre discorso sull’ inverno del nostro scontento, che qui
trapassa in monologo di Riccardo di Gloucester sulla propria natura, e sulla propria
ambizione, alla scena finale della battaglia combattuta con uniformi della seconda
guerra mondiale, dove la frase di Riccardo “il mio regno per un cavallo!” viene
pronunciata dando un calcio ad una Jeep militare ingolfata nel fango sotto un
bombardamento aereo.
In questo modo il tema della “tirannia”, e il ciclo del passaggio della Corona, viene
specificato nella direzione storica particolare del nazismo e del colpo di Stato. La
stessa uniforme di Riccardo di Gloucester cambia da quella verde-marrone inglese a
quella bruna delle SA, e infine a quella nera delle SS, i cui uomini finiscono per
circondare e dominare anche il Parlamento di Westminster.
La principale differenza di cui, quindi, ci occuperemo è quella tra la “tirannia”
classica, di cui si fa interprete Olivier, e la “dittatura” che diviene, invece, il tema
dell’opera nelle mani di Loncrain e di McKellen, che è stato, con le sue note, il vero
ispiratore di questa messa in scena . Riccardo di Gloucester non è solo un tiranno che
desidera la Corona, in luogo dei fratelli più legittimi, attraverso il ciclo dell’oggetto
regale che passa di mano in mano, secondo lo schema rinascimentale della sagacia e
della fortuna; egli diviene, piuttosto, l’autore di una rottura specifica
dell’ordinamento, e solo la resistenza armata al suo nuovo ordine riuscirà a re-
instaurare un regno legittimo, ma, si intuisce, diverso dal precedente, attraverso il
referente storico preciso del cambio di dinastia.
Queste osservazioni partiranno nel paragrafo seguente da una analisi dei concetti
politici di tirannia e dittatura, così come sono stati sviluppati soprattutto da Leo
Strauss e Carl Schmitt, proprio negli anni in cui viene trasposta l’azione del dramma.
Nel terzo paragrafo affronteremo le questioni tecniche legate alle realizzazioni
cinematografiche dei due registi considerati. In questo modo nel quarto paragrafo
vedremo come le rappresentazioni estetiche e i concetti politici funzionino come
“due motori in prallelo”, per giungere, infine, nel quinto paragrafo, a tracciare le
4
nostre conclusioni su come l’opera produca il proprio significato attraverso
ragionamenti politici, che invece di essere svolti nei modi del discorso politico, sono
sviluppati nei modi del discorso letterario, ma che conducono ad una conclusione
precisa: ovvero ad una riflessione sul nazismo , a partire dal testo shakespeariano,
come regno esibizionistico della anomia al centro dell’ordinamento; ovvero come
vero e proprio Regno di Belial.
2. Tirannia, Dispotismo e Dittatura, tra Leo Strauss e Carl Schmitt
Il più celebre libro novecentesco sulla “tirannide” rimane quello di Leo Strauss sul
Gerone di Seonofonte2. In questo modo l’opera di Strauss parte dalla distinzione
classica, appunto come avviene in Lawrence Olivier, tra re e tiranno, e la sua teoria è
che questa distinzione è stata superata dall’orizzonte moderno a partire da
Machiavelli, in quanto lettore di Senofonte, e soprattutto della Ciropedia. La
rivoluzione machiavelliana della scienza politica muove dall’abbandono di un
criterio di discriminazione tra bene e male, onde appunto il Gerone, segna il più
stretto punto di contatto tra antico e moderno nella scienza politica.
Una tale tesi sollevò il contrasto quasi immediato di Kojève3 che, partendo da una
reinterpetazione di Seonfonte, si trasformò in un dibattito sulla tirannide, che ha
segnato la classificazione di Strauss, autore di origine ebrea in esilio in America,
come “liberale di destra”, fino al punto di averne fatto il padre nobile di tutti i neo-
conservatori americani. D’altronde la replica di Kojève era ispirata, occasionalmente,
dal tentativo di sottrarre la questione della “dittatura del proletariato” e della
“tirannide” staliniana alla condanna della modernità insita nell’insistenza di Strauss
2 Leo Strauss, On Tyranny: An Interpretation of Xenophon’s “Hero”, The Free Press, Glencoe, 1950. 3 Cfr. A. Kojève, Tyrannie et sagesse, Gallimard, Paris, 1954, ove si trova pubblicata anche la replica di Strauss, De la Tyrannie.
5
sulla necessità di mantenere in qualche modo la distinzione classica tra bene e male
in politica, verso il recupero dell’ideale del governo ottimo, anche quale ideale della
politica comparata e più in generale della filosofia politica.
Al di là delle categorie classiche è, oggi, piuttosto ovvio che la questione della
discriminazione tra bene e male si proponga in termini di legittimità e illegittimità.
Infatti, per tornare alla nostra opera, Gloucester è comunque un re illegittimo, perché,
seppur per nascita discendente, ha provocato, con la sua malizia e il suo desiderio, la
morte di Clarence, e tramite questa quella del fratello maggiore Re di Inghilterra. La
propria consapevolezza di illegittimità, quindi la propria consapevolezza del male,
della propria tirannia, è rafforzata dal matrimonio con una Lancaster, che può quindi
fornirgli una seconda base di legittimazione, e soprattutto dal culmine dei suoi delitti
nell’uccisione spietata degli eredi fanciulli alla Corona. Questa eliminazione è
appunto soprattutto una eliminazione fisica: ciò che ne resta è solo la possibile
discendenza di Gloucester, e, quindi, per quanto lui stesso tiranno, egli è in grado di
pensare di trasmettere un regno legittimo. In ciò risiede parte della sua complessità,
poiché in questo stesso pensiero il tiranno pensa da re. D’altronde Gloucester sarebbe
stato un re legittimo se solo non fosse stato l’artefice della morte dei propri fratelli.
E’ mediante la sua illegalità che egli distrugge la propria legittimità che cerca di
ristabilire, e ciò ne fa un personaggio peculiarmente complesso, sol che si pensi che
egli è, nel testo, uno “specchio” deforme del padre, quando gli altri fratelli ne erano
una vera imago. Nel distruggere le altre immagini sovrane egli, per quanto deforme,
rimane l’unica immagine degli York, in grado di realizzare la pace – matrimonio-
alleanza – con i Lancaster, ciò che gli altri York non volevano, né potevano fare: dal
punto di vista dello Stato il suo è un vero “colpo di stato”, ma nello stesso senso in
cui parliamo di un “colpo di genio” (Coup d’Etat e coup de génie sono molto vicini
nell’estetica della lingua francese).
Tuttavia nel pensiero di Strauss, in quanto cerca di ripercorrere il pensiero greco,
presente ai rinascimentali, la tirannide è essenzialmente un ordine politico corrotto.
6
Riccardo sarebbe quindi un re ma la sua azione inaugurale è una corruzione, operata
da un deforme, da cui segue comunque un ordine corrotto.
Per un attimo dobbiamo ricordare come l’intero discorso politico sulla tirannia si sia
sviluppato in contrapposizione alla monarchia, ma in un senso precisamente anti-
moderno. Ovvero la monarchia sarebbe, qui, una forma di governo in cui l’autorità è
esercitata con il volere dei sudditi, e in conformità alle leggi; la tirannide è invece una
forma di governo in cui l’autorità è esercitata contro il volere dei sudditi, e in
conformità non già al volere delle leggi, ma alla volontà del sovrano4. E’ nel discorso
di Simonide5 che queste categorie “classiche” mostrano la corda: la tirannide può,
infatti, essere un governo su soggetti consenzienti: essi non si difendono da soli
contro gli schiavi e i malviventi come i cittadini di una comunità libera, ma sono
protetti dalle guardie del tiranno; ed in ciò consentono al suo governo. Secondo lo
stesso Rousseau6 è proprio Gerone a confermare la sua tesi per la quale i greci
intesero un tiranno, non come in Aristotele, autore tardo, come un cattivo monarca,
ma come un usurpatore dell’autorità regale, a prescindere dal tipo del suo governo.
Non è difficile, credo, notare quanta parte di Hobbes si alimenti da tali fonti e da
consimili considerazioni.
Il tiranno rimane un despota perché, anche quando governa bene, cioè assicura la
pace e la prosperità del regno, egli stesso agisce al difuori delle leggi, e segue il
proprio arbitrio.
Il goveno dispotico è un governo non limitato dalle leggi7; è un governo puro.
4 Cyropaedia, I 3.18; Aristotele, La politica, 1295a15-18. 5 Cfr. Gerone, 10.4 e 4.3. E’ difficile sottovalutare l’importanza per il politico moderno di questo dialogo di Senofonte sol che si consideri come i consigli di Gerone sulla “buona” tirannia (Gerone 9.1 ss.) siano ripresi compiutamente da Machiavelli, Il principe, XIX e XXI, ed anche da Montesquieu, L’esprit de Lois, XII, 23-24. 6 Cfr. Rousseau, Contrat social, da III 10 alla fine, con riferimento a Gerone 7.2, e cfr. per la trattazione parallela dello stesso problema Montesquieu, L’esprit des Lois, XI 9 e XIV 13. Che il tiranno possa essere giusto, anziché vizioso, è pensiero espresso anche da Plutarco, Memorabilia, II 1.31 - di cui sappiamo il valore di fonte rispetto a Shakespeare - e deriva ovviamente anche da Platone, Phaedrus, 248e3-5. 7 Cyropaedia VIII 1.22; Gerone 9.9-10
7
IL ché non significa che non possa essere un buon governo, o un governo efficace,
significa solo che si situa oltre la soglia della legalità, ovvero fa a meno di essa nel
governare il mondo.
Peraltro si ricordi che per questi greci il governo delle leggi era possibile solo in una
“società conservatrice”, in quanto le leggi sono immutabili, mentre il tiranno muta le
cose, in qualche modo egli è sempre rivoluzionario.
Il Socrate di Senofonte , così diverso da quello di Platone, e sempre ben rintracciato
da Strauss, esprime chiaramente l’idea che esiste un solo titolo di legittimazione per
governare: cioè la conoscenza delle leggi e del bene. Perciò, in questo schema, è la
conoscenza (veritas) e non la forza, l’inganno o l’elezione, o – potremmo aggiungere
anche - l’eredità (auctoritas), a legittimare il governo. Ovvero il Socrate di
Seonofonte rappresenta l’esatta alternativa al pensiero di Hobbes, dove si svilupperà
l’idea opposta che: auctoritas non veritas facit legem. In particolare il potere
derivante dalle elezioni non è sostanzialmente più legittimo del governo tirannico,
entrambi derivando dalla forza (del numero o del singolo) o dall’inganno, perpetrato
nei meandri della corte o dai retori nella pubblica assemblea.
Il discorso su Gloucester, e specialmente il suo doppio parallelo col principe
machiavellico rinascimentale (Olivier), o con il dittatore nazista (Loncrain) mostra
quindi le sottili valenze della nozione politica di tirannide all’interno della tradizione
occidentale, proprio in quanto nozione polemica, specialmente rispetto alla notazione
finale di Strauss, ripresa sempre da Senofonte, secondo cui essere chiamato tiranno e
non re, significa essere stato incapace di trasformare la tirannide in una monarchia,
che è il problema specifico di Riccardo di Gloucester, ovvero di trasformare un titolo
che è generalmente considerato non valido in un titolo che comunemente considerato
valido8, ma ciò significa appunto attrarre la legittimità nell’ambito della decisione.
8 Anabasi III 2.13
8
E’ proprio perciò che tali considerazioni sulla tirannide devono fare i conti con la più
compiuta analisi della dittatura, che è quella operata da Schmitt9. La sua analisi
peculiare deriva dal considerare l’ottica romana, nella misura in cui questa è diversa
da quella greca e conosce istituti non presenti in Grecia. Fra questi spicca appunto la
dittatura in quanto istituto legale e legittimo.
Tutti sappiamo, ed il punto è affrontato da Shakespeare nel Coriolano10, che per la
salvezza della repubblica in situazioni di emergenza era possibile nominare un
dittatore pro tempore con poteri assoluti per risolvere l’emergenza stessa e, quindi,
restaurare l’ordine legale precedente.
Questo tipo di dittatura viene definito da Schmitt come dittatura commissaria. In
pratica lo Stato viene commissariato attraverso la riassunzione da parte di un soggetto
a ciò incaricato dei pieni e assoluti poteri originari, onde la legge, nello stato di
eccezione, può sospendere sé stessa, per ristabilire la legge. Il dibattito greco cambia
qui completamente di coordinate, perché il “vero politico”, come lo definisce Platone
nell’omonimo dialogo, può operare al di fuori delle leggi con il supporto della legge,
ovvero la sua legittimità legale gli permette la propria illegalità di governo puro ed
efficace del mondo. In termini greci egli diverrebbe un tiranno nel momento in cui
(Coriolano) desiderasse mantenere la carica oltre i termini stabiliti, ovvero oltre il
raggiungimento del fine della soluzione dello stato di eccezione, quando la sua
dittatura non avrebbe più ragione sostanziale di essere, ma, insomma, la dittatura è un
istituto giuridico legale che porta dentro la legge lo stato di eccezione come collasso
della legge. Perciò, peraltro, secondo la celebre formula di Schmitt, che risale in
realtà a Bodin, è sovrano chi decide sullo stato di eccezione.
Il punto di svolta individuato da Schmitt, con riferimento all’anno II della
Rivoluzione Francese, e con diretta polemica con la “dittatura del proletariato, quale
9 Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. 1921; tr it. La Dittatura, Laterza, Roma, 1975. 10 Su cui, rispetto al Riccardo III, cfr. la trasposizione cinematografica attualizzante del 2011 di Ralph Fiennes tutta incentrata sullo stato di eccezione, fino a far comparire il senatore Menenio in una breaking news sottotitolata “State of Exception: Rome”.
9
concreta esperienza storica degli anni in cui stava scrivendo, è nell’individuare
un’altra forma possibile di dittatura: la dittatura costituente.
Ovvero la dittatura commissaria come esercizio legale di poteri assoluti volti al fine
della restaurazione, può diventare una dittatura costituente che sfugge alla legalità
precedente per fondare un nuovo ordine di legge. Questa è stata la concreta
esperienza storica dei Comitati di salute pubblica francesi di fronte allo stato di
eccezione reale consistente nell’ Alto Tradimento del re in complotto con le potenze
straniere per una invasione della Francia, e quindi come continuazione della ragione
di Stato, che con buona pace degli italiani non rimonta certo a Botero, dove è
sinonimo praticamente di economia politica, cioè di amministrazione ragionata delle
risorse dello Stato, ma rimonta alla teoria di Naudé e alla pratica di Richelieu11. E’ la
ragione di Stato, la salvezza della Francia, a comportare una dittatura del Club des
Brétons, che da dittatura commissaria si trasforma in dittatura costituente, e cioè
pieno e assoluto governo dell’eccezione permanente, attraverso la trasformazione
della Monarchia in Repubblica e l’instaurazione del Terrore. Questo dispositivo di
governo dell’eccezione sarà costantemente ripetuto in Francia, dal Termidoro, dal
Consolato, dal Primo Impero, dalla parentesi del 1815, dai fatti del 1821, dal 1848,
dall’instaurazione del secondo impero, dai fatti del 1870, dai mutamenti radicali del
Governo Pétain, instaurato legittimamente a Bordeaux e trasformatosi nell’ Etat
Francais di Vichy, dalla presa dell’Hotel Matignon da parte di Chabans del Mas nel
1944, dai fatti di Algeria del 1958. E naturalmente questo dispositivo governamentale
è stato quello della dittatura collettiva del partito dopo il disastro bellico del 1917 in
Russia fino alla sua totale resa incondizionata del 1989.
E’ molto più alla storia di Francia che a Schmitt che noi dobbiamo la teoria della
dittatura costituente e dello stato di eccezione, ed il paradosso per cui la legge si
sospende per riplocamarsi rivoluzionariamente. D’altronde per i francesi il passaggio
dall’ état de siège reale, forze ostili che minacciano la salus rei publicae, all’ état de
11 Cfr. Fabio Martelli, Estetica del colpo di stato. Teologia e politica nella Francia di Richelieu, Milano, Mimesis, 2008.
10
siège fictive , ovvero alla decisione politica della ricorrenza di uno stato di eccezione,
fu assolutamente breve e conseguente12; ed il primo a trarla fu probabilmente, come
aveva intuito Marx, lo stesso Napoleone Bonaparte.
Naturalmente è evidente che la situazione determinatasi in Germania con l’incendio
del Reichstag segua esattamente questi schemi, di origine francese : elezione di un
parlamento con larga maggioranza nazista; conferimento al suo candidato del
mandato di cancelliere, stato di eccezione, decreto di conferimento dei pieni poteri,
dittatura commissaria che si trasforma nella dittatura costituente del III Reich, che
manterrà sempre i caratteri di un governo eccezionale del mondo, oltre lo schema
della legalità, pur all’interno di uno stato di leggi, fino all’utilizzo della legge stessa
per la propria organizzazione rivoluzionaria e omicida : le Leggi di Norimberga.
Come si vede i termini che utilizziamo hanno un’ampia zona di convergenza
semantica, ma rimandano ad esperienze storiche differenti e dischiudono problemi
politici difformi.
In sostanza tiranno è colui che possiede lo Stato senza legittimazione, o con una
legittimazione corrotta. Il tiranno è un falso re, un usurpatore che ha o mantiene una
carica oltre i limiti stabiliti, anche se governa bene, ed anche se rispetta le leggi: il
suo è un peccato originale.
Despota è colui che governa al di fuori del quadro legale, anche se putacaso ha
iniziato il proprio governo in modo legittimo, e che realizza quindi un governo puro
del mondo, cioè un governo che non più, almeno in alcune sue dislocazioni, mediato
dalle forme della legge. La sua è una prestazione politica pura che spiazza la legge.
Il dittatore spezza a sua volta questo circolo di idee classico, perché il dittatore
esercita un potere legale sullo stato di eccezione, sia esso sotto forma commissaria, o
divenga esercizio di potere costituente. Il dittatore non è, quindi, normalmente un
usurpatore, anche se può trasformarsi in un usurpatore, e può o meno, come
quest’ultimo, diventare un despota. 12 F. Martelli, op cit, p. 23
11
L’esempio classico è Robespierre che divenne dittatore e despota, ma fu fermato
prima dell’usurpazione, mentre un ciclo inverso fu seguito da Napoleone che fu
dittatore, divenne usurpatore - e divenne anche re come imperatore legittimato dalla
propria dittatura costituente - ma non divenne mai despota, anzi al contrario
organizzò lo stato moderno di leggi: i codici, i notai e la piramide giudiziaria.
Che cosa fu, allora, Riccardo di Gloucester ?
Ciò che qui ci interessa è vedere come, rispetto alla evidente apertura originaria di
senso rinascimentale dell’opera di Shakespeare, la trasposizione di Olivier rimanga
nell’ambito, per così dire, della riflessione politica classica che si situa alla soglia
della modernità, cioè nell’ambito della tirannide e dell’usurpazione, mentre la
trasposizione di Loncrain, già nel 1995, si trasporti nella dimensione della dittatura in
quanto, in essa, Gloucester cerca non solo una propria legittimazione ma lo
stabilimento di un nuovo regime politico.
3. I particolari della versione di McKellen
Jack Jorgens13 condivide la tesi di Constance Brown secondo cui il tema centrale del
dramma sia il “possesso della Corona”, e i desideri scatenati da questo correlativo
oggettivo. Anzi, potremmo dire che la Corona è, in senso eliotiano, un correlativo
oggettivo per eccellenza: essa infatti è indubbiamente una cosa, e il suo possesso è un
fatto fisico, data la quale, però, sono immediatamente dati ( dislocati ) i sentimenti
dei personaggi che costituiscono il dramma come scontro di azioni.
Jorgens identifica il tema di questo dramma come “the fall and rise of state, and
argues that the fall and rise are represented by the image of the crown”. Ma io non 13 Jack J. Jorgens, Shakespeare on Film. Bloomington: Indiana UP, 1977
12
condivido apertamente questa interpretazione: a sorgere e cadere qui non è lo Stato,
ma il suo possessore, e ciò che rimane incerto è la forma politica di tale possesso,
sospeso, com’è appunto, tra tirannia e dittatura, tra legittimità pubblica e illegalità
centrale.
In modo semplice il dramma inizia con l’udienza concessa da Edoardo IV al fratello
deforme che tanto ha fatto per la sua ascesa al trono, ed è questa udienza stessa che
scatena i sentimenti di Gloucester e la sua malevolenza che culmina nel suo desiderio
di possesso della Corona. Tuttavia il suo “despotismo”, o “tirannide” , o “dittatura”,
provocano una reazione che porterà al trono Richmond, presentato come il legittimo
erede, e fondatore in qualche modo della dinastia dei Tudor, sotto i quali Shakespeare
scriveva.
Quindi un dramma lineare: il fratello deforme vero autore della vittoria degli York si
vendica dell’altezzoso Edoardo che disconosce i suoi meriti, e cerca attraverso
l’assassinio e il matrimonio con Lady Anne di conferire legittimità alla propria
azione, che però non avrà successo (si badi militare) aprendo la via alla vera
legittimità pacificante di Richmond (col tradimento dell’ entourage di Riccardo, che
però è legittimato dal fatto che tradire un usurpatore non è tradire).
La tecnica cinematografica utilizzata da Olivier è, come dicevamo, quella delle
ombre. Quando Riccardo confida il suo piano di uccidere Clarence e sposare Lady
Anne la sua ombra cresce fino a riempire l’intero schermo. Allo stesso modo quando
Clarence racconta il suo terribile incubo la telecamera mostra l’ombra di Riccardo
estendersi sull’entrata della cella. Di nuovo sono le ombre a enfatizzare l’alleanza tra
Riccardo e Buckingham. Naturalmente Olivier, come tutti, non rappresenta il dramma
nella sua interezza , taglia personaggi minori e dialoghi occasionali, e aggiunge anche
una premessa alla prima scena interpolandola dall’ Enrico VI, parte terza, per
introdurre il pubblico ai fatti che avverranno, fino a aggiungere anche una Mistress
Shore, nella scena dell’incoronazione, per mostrare un lato lascivo di Edoardo che
contrasti in modo drammatico con il puro amore per il potere di Riccardo,
rafforzando lo stereotipo freudiano - così caro a Olivier anche nella sua versione
13
dell’Amleto - del Re gobbo e deforme, che non potendo pensare al sesso viene
abbandonato completamente al demone del potere. La sua libido non potendo essere
investita altrimenti si trasforma in un’ossessione patologica per il potere, divenendo
omicida.
Il tema delle ombre, comunque, è di estrema rilevanza, in primo luogo se pensiamo
all’estetica di Welles, propria di quegli anni, ed al suo uso fin eccessivo delle
medesime tanto in Citizen Kane quanto specialmente nel Terzo Uomo, ma anche per
la facilità scenica raggiunta nel coinvolgimento del pubblico: dopo tutto l’ombra di
Riccardo è l’ombra di un gobbo, come tale facilmente identificabile, e lui stesso la
introduce nel suo primo lungo monologo come uno degli elementi della propria
fisicità che gli sono insopportabili, e gli fanno latrare contro i cani per strada.
L’ombra rafforza la bruttezza di Riccardo, e in modo molto greco, se uno è brutto è
anche malvagio. Ma soprattutto, e ovviamente, quest’uso scenico rafforza
costantemente l’idea che quello di Riccardo è un regno dell’Ombra: è il male che
stava per regnare sull’Inghilterra contrariamente all’invocazione del Sole di York.
Anzi, e questo è molto filologico, è proprio il Sole degli York a proiettare
costantemente sulla terra l’ombra di Riccardo e quindi a perdere gli altri York nel
loro destino di morte.
Lontana da questi modelli la trasposizione di Loncrain si basa sul concetto di una
rappresentazione teatrale di Richard Eyre, cui ha contribuito in modo decisivo lo
stesso interprete di Riccardo, ovvero Ian McKellen, che si può dire esserne quasi a
tutti gli effetti il vero autore.
Innanzitutto il concetto di tale versione si basa su un uso non convenzionale di famosi
“luoghi” e spazi londinesi: La stazione di St. Pancras viene utilizzata per
rappresentare Westminster , come sede del governo di Edoardo; Battersea Power
Station è ricollocata sulla costa del Kent e rappresentata come una base aerea
bombardata. Le scene che si riferiscono alla Torre di Londra sono in realtà girate alla
Bankside Power Station, ed il Brighton Pavillon diventa la sede di campagna di
Edoardo e degli York. La “nuova” sede del governo di Riccardo viene dislocata nella
14
Senate House, aggiungendovi scene tratte dalla facciata e dall’interno deco della
Shell Mex House.
Questo apparato di scene urbane dischiude naturalmente un certo sapore
“modernista” dell’opera che sempre più introduce una estetica nazista con particolare
riferimento alle scene del “Trionfo della Volontà” della Riefenstahl. Il risultato finale
è un mix di oggetti e uniformi che distinguono le due parti in causa: uniformi
completamente “alleate” in stile seconda guerra mondiale per gli uni, e uniformi in
completo stile SS per l’entourage di Riccardo.
Ciò diventa ancora più evidente nelle scene di battaglia, dove viene usata una mistura
di carri armati sovietici (T55 e T34) insieme a vecchi veicoli militari americani,
inglesi e tedeschi.
Per sottolineare ulteriormente questa ridislocazione temporale e spaziale della
vicenda Lady Anne , interpretata da Kristin Scott Thomas, è resa il più possibile
simile a Wallis Simpson, e altrettanto “disapprovata” dal resto della Corte.
Come abbiamo già accennato, la più celebre frase del dramma, "A horse! A horse!
My kingdom for a horse!”, viene ricontestualizzata nell’apice della battaglia quando
la Jeep di Riccardo rimane bloccata nel fango, e questa scena dischiude un finale
sorprendente in cui Gloucester rifiuta di farsi catturare, e cerca volontariamente la
morte sul campo - "Let us to't pell-mell; if not to heaven, then hand-in-hand to hell” -
che si realizza con la ripresa di una sua vera e propria “caduta all’inferno”, con un
suo beffardo e trionfante ghigno, accompagnato dalle note di "I'm Sitting On The Top
Of The World” nella classica versione di Al Jolson.
Durante la “caduta” di Riccardo la camera si sposta su un altro sorriso, quello di
Enrico, e, dire, il film volutamente produce entrambi i significati possibili : la
somiglianza tra il ghigno di Gloucester e il sorriso di Enrico, a significare
l’inevitabile parallelo maligno di ogni uomo che diventa re; oppure, al contrario, la
differenza tra l’un sorriso e l’altro a sottolineare un “Happy Ending” - stile seconda
guerra mondiale - reso ironico dalla voce e dalla musica di Al Jolson.
15
Si potrebbero ancora sottolineare altri particolari : il ruolo della Duchessa di York
(Maggie Smith), come quello della Regina Madre emergono notevolmente, se si
pensa che nel 1955 Lawrence Olivier aveva fatto raramente apparire la prima, e
completamente eliminato la seconda.
Per converso i ruoli di Rivers, Grey, Vaughan e Dorset sono riuniti in quello unico di
Rivers.
Le scene di morte sono compiutamente mostrate, invece che semplicemente suggerite
come nel dramma originario e modificate per risultare più attuali : Hastings viene
impiccato piuttosto che decapitato, e Clarence muore con la gola tagliata in una vasca
da bagno, piuttosto che in una botte di vino. Lord Rivers, che normalmente muore
fuori scena, risulta invece accoltellato dal basso di un letto su cui sta amoreggiando
con una Hostess dell’aereo che lo riportava in Inghilterra.
Tutti i monologhi che i personaggi recitano prima di morire vengono soppressi, ad
eccezione, naturalmente, di quello di Clarence e di Buckingham.
Per chi voglia approfondire filologicamente tutte le questioni legate a tali “scelte” Ian
McKellen ha reso disponibili sul web le proprie “note” alla realizzazione di questo
Riccardo III14.
Altre scelte rilevanti, come quelle del casting sono tutte contenute nelle Production
Notes15, dove, ad es., al par. 15 si legge :
“ . . .[Robert] Downey [Jr.] and Annette Bening play Americans. Their casting
grew out of the fact that in the play Queen Elizabeth and her brother, Earl Rivers, are
outsiders. They are not members of the aristocracy and Loncraine and McKellen
wanted to find a twentieth-century equivalent. (Paragraph 15)”
14 http://www.mckellen.com/cinema/richard/screenplay/index.htm 15 "Richard III": Production Notes," Richard III Onstage and Off. 20 Dec. 1995. Richard III Society Home Page. 3 July 1996 <http://www.r3-org/mckellen/film/notes.html>.
16
In questo modo, prima di passare alla nostra discussione, si può notare quanto sia
studiato, e rilevante, ogni particolare di una simile ridislocazione temporale e
spaziale. Cioè come alla rilocazione del dramma in un diverso tempo, corrisponda
una sua parallela ri-localizzazione nello spazio.
Ciò nondimeno occorre notare come spesso i critici si siano dimostrati ostili, per non
dire prevenuti, nei confronti di questa realizzazione.
Come ha scritto Kevin Hagopian, della Penn State University:
“Their adaptation has been, itself, controversial, less for its on-screen violence
than for the violence Loncraine does to Shakespeare’s language. Many of the play’s
scenes are cut or trimmed, and even some of the great speeches have been radically
altered. (The "now is the winter of our discontent" speech, for instance, gets chopped
in half; it is used as a public harangue, and then as a monologue in a men's room.)”16
Non troppo diverso il tono di Mark Lawson sul Guardian: 17
“McKellen insists that the main alterations [in adapting "Richard III" for the
screen] concern concept rather than text. He points out that, having performed the
play 300 times before starting his script, he was perhaps more familiar with the
source material than any previous screenwriter faced with a classic text.”
Questi sono atteggiamenti comuni di fronte ad ogni “adattamento”, che divengono
immediatamente stantii se si cerca di considerarli seriamente come lavoro di critica
letteraria, così come peraltro risulta banale la consueta difesa dell’adattatore di voler
rendere più comprensibile l’opera ad un pubblico contemporaneo, magari dicendo
16 http://www.albany.edu/writers-inst/webpages4/filmnotes/fns04n2.html 17 The Guardian (UK), April 19, 1996.
17
che ‘not wont' potrebbe essere avvertita da un tassista moderno come una doppia
negazione inutilmente fastidiosa e difficile da maneggiare e quindi che il testo deve
essere rivisto. Invero oggi non sarebbe il tassista a non comprendervi, ma anche il
vostro word-processor segnerebbe come errore intollerabile un ‘not wont' e l’intera
sintassi di Shakespeare non passerebbe mai il vaglio di alcun indice di leggibilità.
D’altronde come disse già Eliot, a proposito del teatro di poesia, la grande differenza
tra il pubblico moderno e quello elisabettiano, è che il primo non è più disposto a
tollerare troppa poesia per andare a teatro.
Tutto ciò sarebbe estremamente banale, e proprio per questo è interessante la
notazione fatta da Ian McKellen che le maggiori alterazioni da lui prodotte
riguardano i concetti e non il testo. E sono proprio queste alterazioni che, sulla base
di quanto abbiamo detto nel paragrafo due, cercheremo di sviluppare nel prossimo.
4. Dittatura, Stato di Eccezione e assassinio politico: dalla tecnica alla estetica del
“colpo di stato”.
La riambientazione del dramma di Shakespeare negli anni ’30 costituisce, per noi ,
una sorta di completa rielaborazione dei temi politici del dramma. Infatti, insistere su
una ambientazione fascista dell’opera significa far uscire il dramma dal ristretto
ambito della Corte dove si svolge l’ambientazione politica originaria. Significa
introdurre un elemento di rivolgimento sociale che implica un mutamento d’ordine
rivoluzionario della società stessa nella sua interezza.
Una rivoluzione fascista, o nazista, non meno di una socialista o comunista, non è una
congiura di palazzo e spezza l’anello dell’eterno ritorno delle vicende politiche
sempre uguali a sé stesse che caratterizza lo schema rinascimentale della sagacia e
dell’alterna fortuna.
18
E’ importante, infatti, innanzitutto ricordare queste categorie in quanto esse sono
uscite dal lessico della teoria politica, anche se dominano ancora in parte il
“commento comune” alle vicende politiche.
Nello schema rinascimentale la virtù del politico è propriamente la sagacia, cioè il
sapersi muovere rispetto alle condizioni in costante evoluzione, e sostanzialmente
avverse e pericolose, di una lotta politica il cui unico scopo è il successo nella
conquista del potere. Un tale successo naturalmente non dipende solo dalle capacità
individuali, ma anche dalla fortuna , cioè da quell’insieme di circostanze che il
soggetto non può controllare, e che possono, o meno, offrirgli una occasione di
eccellenza, nel senso semplicemente a-morale della sua riuscita in una lotta che è
sempre sostanzialmente la stessa.
Dico questo dei rinascimentali, ma ciò ovviamente si adatta anche a Tacito o
Plutarco, cioè al modo greco e romano di vedere e percepire le res gestae, che in
fondo costituisce la base di conoscenze e di riflessione degli autori rinascimentali.
Da questo punto di vista l’opera di Machiavelli appare straordinariamente pre-
moderna, e niente affatto come una soglia verso la modernità. La sua opera è
compiutamente rinascimentale rispetto al moderno politico, e costituisce uno
scandalo non perché sia innovativa, ma perché è umanistica: cioè ripropone gli
schemi greci e romani sfrondati della dottrina morale cristiana che piazzava l’arte
politica all’interno della morale pratica.
Il punto è delicato, e spesso non notato, ed ha sicuramente molto a che fare col teatro
“rinascimentale” di Shakespeare in quanto si occupa di politica in questo modo; e,
ovviamente tale considerazione ha strettamente a che fare col modernismo in una sua
riconsiderazione globale delle fonti della tradizione letteraria, esattamente in quanto
si situa tra la fine della prima guerra mondiale e l’inizio della seconda, cioè lo spazio
di tempo in cui McKellen ha deciso di ambientare il suo Riccardo III, spostando di
500 anni in avanti l’azione shakespeariana, pur mantenendola di 65 anni indietro alla
contemporaneità politica della sua realizzazione.
19
Ora questo “schema rinascimentale” di cui parlavo si può cogliere direttamente se si
considera anche solo l’epigrafe, tratta da Dante, di una delle poesie moderniste per
eccellenza: il Prufrock di Eliot18:
“S’io credesse che mia risposta fosse
a persona che mai tornasse al mondo,
questa fiamma starìa senza più scosse”
Ora queste parole sono pronunciate nella Commedia da Guido da Montefeltro, che è
condannato a bruciare nell’al di là insieme a Ulisse in quanto consigliere politico
fraudolento, avendo dato al Papa il consiglio su come entrare di nascosto in Palestina
per occuparla. Ma ciò è appunto un atto che Tacito non avrebbe in alcun modo
considerato come questione “morale”, e che torna a essere a-morale con Machiavelli
il quale non avrebbe potuto che lodare Luca da Montefeltro. E certamente pochi di
noi metterebbero Ulisse a bruciare per l’eternità perché inventò il cavallo di Troia.
Ma la questione è il riapparire in epoca rinascimentale, e quindi anche nel teatro di
Shakespeare, di una categoria politica pura che descrive un mondo di perenni
intrighi, che sicuramente è pagano, tanto che la fortuna torna sulla scena in luogo di
altre divinità, ma altrettanto sicuramente, per me, non è moderno, o almeno non lo è
in modo compiuto. Noi incontriamo la modernità solo con Enrico IV di Francia, con
Naudé e con Richelieu, cioè con l’apparire della Ragion di Stato, quando questo
termine è praticamente sconosciuto a Machiavelli che infatti consiglia il Principe su
come ingrandire e mantenere i propri territori. Il principe, dopo tutto, è qui ancora
una figura privata che può disporre di armati, e non l’astrazione pubblica dello Stato.
Enrico IV può come singolo ragionare in termini puramente privati, ma inaugura
quella stagione per cui, in base alla ragione di Stato, un cardinale cattolico può 18 T.S. Eliot, The Love Song of J.Alfred Prufrock, in Poems, A.A.Knopf, New York, 1920. L’epigrafe (in italiano nel testo) è tratta da Dante, Inferno, XXVI, 61-66.
20
trovare naturale allearsi con i protestanti delle fiandre per battere il Re cattolicissimo
di Spagna, a tutto favore della Francia.
Ora, nei testi di Shakespeare noi abbiamo sempre un Buckingham, o un Essex o un
Gloucester, ma incontriamo una grave difficoltà a definire lo Stato, anche se
possiamo vedere come esso sia in fieri. Basti qui menzionare gli almeno 10 diversi
modi in cui l’idea di Stato, Repubblica, Regno, e così via sono utilizzati in Otello, e
che vengono costantemente appiattiti, o addirittura invertiti senza alcuna apparente
ragione nella traduzione operata da Praz.
In sostanza il dramma politico shakespeariano, e l’intero dramma politico
rinascimentale, rimane un dramma politico “barbarico”19.
In questo senso i personaggi del dramma divengono “interessanti” per i loro risvolti
psicologici che spesso ruotano intorno alle vicende politiche in quanto depilano gli
individui, ma qui ne sono ancora profondamente intrecciate. McBeth sperimenta
l’assuefazione al crimine fino alla follia; Amleto non riesce a credere compiutamente
al fantasma fino a quando non ha la prova offertagli dalla trappola per topi, e quindi
poi agisce come uno spietato rinascimentale. Otello trascura gli affari di stato per la
sua gelosia privata. Giulio Cesare sperimenta la vanità portata all’eccesso dell’ auto-
sicurezza più pericolosa, ed è distrutto dal tradimento “privato” di Bruto. Riccardo di
Gloucester è portato ai propri “crimini” dalla propria figura deforme che lo rende
naturalmente invidioso, e dallo sprezzo con cui Edoardo considera i suoi servigi in
guerra. L’azione politica è, insomma, qui un prolungamento armato dei sentimenti e
delle considerazioni personali. Gli attori del dramma ricoprono cariche e si battono
per esse, ma non sono gli attori politici moderni che sono entità astratte : gli Stati, i
partiti, e così via, che sono, come probabilmente credeva Benjamin, frutto della
successiva capacità dell’allegoria barocca di far vivere delle rappresentazioni astratte,
come base del politico moderno, e come vera e propria esperienza ontologica.
19 Carl Schmitt, Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel. 1956; tr. it. Amleto o Ecuba. L'irrompere del tempo nel gioco del dramma, il Mulino, Bologna 1983.
21
Ciò è particolarmente rilevante oggi in quanto stiamo sperimentando il dissolversi di
tali allegorie del moderno, e riportando lo schema politico a quello del privato che
allarga il proprio potere, o i propri onori, attraverso le cariche e le istituzioni, e
quindi attraverso la sua sagacia e la sua fortuna come categorie politiche dominanti.
In questo senso la trasposizione di McKellen mi appare estremamente importante
proprio dal punto di vista della sua ridislocazione spazio-temporale della vicenda, che
sottopone la vicenda stessa ad una torsione completa di significato, che pure può
esservi racchiuso.
Il portare la vicenda di Gloucester negli anni ’30 non significa solo sovrapporle le
inquietudini di una Inghilterra dominata dagli appeasers,che albergava un Mosley,
sotto il breve, ma significativo dominio di una coppia regale, il Duca di Windsor e
Wallis Simpson, che manifestava una pubblica simpatia per il nazismo, e dove
perfino l’ambasciatore americano a Londra, Joe Kennedy padre, era sostanzialmente
una persona più gradita a Berlino di quanto non lo fosse l’ambasciatore in Germania
Bullit. Inquietudini “fasciste” che, quindi, erano vere, e sono esistite, prima della
svolta decisiva del 1939, e che sono meravigliosamente rappresentate in Quel che
resta del giorno.
Questa trasposizione significa effettivamente traslare il tema politico dell’originale da
quello della tirannide a quello della dittatura, attraverso l’estetica del colpo di stato.
Una tale dimensione estetica è, infatti, come abbiamo visto, quella particolarmente
coltivata da Loncrain e McKellen. Mentre Olivier fa dell’Ombra, e del suo proiettarsi
sulla normalità politica, il tema estetico principale con cui la propria mise en scene
produce un significato del testo, McKellen e Loncrain fanno degli abiti e delle
uniformi le segnature estetiche del colpo di stato rivoluzionario tentato da Riccardo
di Gloucester.
22
Tutto ciò apre la possibilità per la riflessione politica di superare finalmente l’ottica,
che nei miei termini definirei compiutamente rinascimentale, del paradigma imposto
da Curzio Malaparte: ovvero del paradigma del colpo di stato come tecnica20.
Ciò comincia oggi ad avvenire nell’opera di Martelli21, che congiunta con quella di
Agamben, e di Esposito può dirsi far parte di un nuovo paradigma che assume ormai
il nome di “Italian Theory”22.
Innanzitutto voglio essere chiaro su un punto: estetica, rispetto a tecnica, dischiude
qui la possibilità di una considerazione ontologica del colpo di stato, cioè se l’estetica
considera quella soglia in cui qualcosa di invisibile diviene visibile in un certo modo
specifico, la considerazione estetica rimanda ad una determinata ontologia
dell’apparizione, o, in parole povere, ripropone la questione della natura del colpo di
stato.
Ciò è particolarmente presente nell’opera di Loncrain e McKellen in quanto è
attraverso l’estetica degli abiti che si dischiude l’apparizione del nuovo ordine di
Riccardo di Gloucester.
Gli stessi luoghi, come abbiamo notato, cambiano e le istituzioni non si presentano
più con l’aspetto della stazione di St. Pancras, ma con il volto déco dell’orologio e
della facciata della Shell Mex House, segnalando un loro mutamento ontologico: non
sono più le stesse istituzioni, perché diverso ne è l’aspetto, diversa ne è l’apparizione.
Questa notazione è particolarmente interessante se si pensa di quanto Loncrain e
McKellen (1995) hanno antedatato il dibattito intellettuale sullo stato di eccezione,
come se, appunto, il ragionare per immagini arrivasse prima del ragionare per
concetti, e questi effettivamente, come disse qualcuno, prendono il volo sempre
troppo tardi … sul far del tramonto.
20 Curzio Malaparte,Technique du coup d'état, Paris: Bernard Grasset, (1931), 1948; pubblicato dapprima in francese e poi tradotto in italiano come Tecnica del colpo di Stato, Milano: Bompiani, 1948 21 Fabio Martelli, Estetica del colpo di stato. Teologia e politica nella Francia di Richelieu, Mimesis, Milano, 2008. 22 Cfr. Dario Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica. Bologna, il Mulino, 2012.
23
Insomma “Law and Literature” ragiona più profondamente, e più velocemente di
“Law … e nient’altro”, e, sicuramente in modo molto più pregnante di Jurisprudence.
Rispetto ai termini politici, prima delucidati, quello di Gloucester si presenta come un
colpo di stato, perché operano sulla scena pochi armati in segreto per un rivolgimento
completo di potere, che sfocia in una dittatura costituente, operando un salto rispetto
al vecchio schema della tirannide racchiuso nel testo originario.
In ciò il colpo di stato si dimostra effettivamente come il momento di manifestazione
visibile, e come tale anche straordinaria, di ogni pattuizione normativa del potere
nella sua essenza: il colpo di stato come momento in cui tutto l’impianto costruito per
normare il maggior numero possibile di rapporti viene annullato dall’azione eversiva
di un singolo o di un gruppo politico ristretto.
L’azione eversiva di Riccardo si perpetra attraverso l’organizzazione di un suo potere
extra istituzionale che poi riceve l’investitura istituzionale propria della regalità
attraverso l’accordo segreto con Buckingham, e l’offerta della corona, che egli, come
Cesare, ostenta di rifiutare prima di accettarne la pubblicità politica, per operare poi
una trasformazione costituzionale del regno possedendone già la legalità acquisita in
modo illegale.
Ciò che sperimenta Riccardo di Gloucester è però, per così dire, la natura
eccezionale, ed in certa misura anomica del nuovo potere che egli ha raccolto nelle
sue mani, cercando, inutilmente, di ri-collocarla nella cornice delle magistrature
ordinarie. Che questo non sia possibile lo dimostra la necessità, successiva alla presa
del potere, dello sterminio dei giovani York eredi di Edoardo e suoi nipoti. Il loro
“assassinio politico” provoca nel dramma la reazione che trascina Riccardo nella sua
caduta, non solo per ragioni “umanitarie”, ma per le ragioni politico oggettive del
contagio dell’anomia23, dal colpo di stato al sistema dittatoriale costituente del suo
regime in quanto regime nazista.
23 Su cui ovviamente rimandiamo a René Girard, La violence et le sacré, Paris, Gallimard, 1972.
24
In questo senso il nazismo serve alla trasposizione di Loncrain e McKellen più di
quel che possa sembrare. Ovviamente anche Cesare si ritrovò nelle mani un potere
sostanzialmente anomico, e sicuramente Ottaviano fu l’attore in grado di dislocare la
propria anomia essenziale entro il quadro di legalità costituzionale romano attraverso
la distinzione tra auctoritas e potestas24. Una possibilità che si è definitivamente rotta
con Hobbes e la sua contrapposizione tra l’una e l’altra quanto alla possibilità di
ordinamento della società civile. Orbene il nazismo, a differenza di altri regimi, può
essere visto come quella potestà di ordine che non nasconde, ma anzi esibisce la
propria anomia essenziale all’interno del quadro del rechtstaat. Il nazismo, cioè, si
presenta come l’esibizione estetica del regno dell’anomia, all’interno del regno stesso
della legge. Il punto più interessante è ovviamente quello fatto notare da Annah
Arendt : l’anomia del campo preparata dagli atti amministrativi delle gare d’appalto e
dall’organizzazione degli ordini ferroviari entro la cornice delle leggi e dei
regolamenti del Reich. Da questo punto di vista la continua dittatura costituente del
Führer non si presenta altrimenti che come un duraturo stato di eccezione anomico, in
cui, direi quasi come in Amleto, il travestimento serve più ad esibire che a celare,
rendendo, nei termini di Benjamin, l’eccezione uno stato permanente.
Naturalmente, allora, per concludere queste considerazioni, esiste in realtà una
continuità, e non una rottura, di sviluppo di significato tra la rappresentazione del ’55
e quella del ’95: il proiettarsi del regno dell’ombra di Olivier, diventa la compiuta
realizzazione del regno dell’anomia nazista in McKellen e Loncrain.
5. Conclusioni : La caduta di Gloucester e l’Angelo dell’ Anomia.
24 Martelli, op cit, p. 14
25
Il discorso fin qui condotto ci ha portato a considerare il parallelo tra la versione di
Lawrence Olivier e quella di Ian McKellen e Loncrain attraverso il ripensamento
delle categorie politiche della tirannide e della dittatura, per poi approfondire gli
aspetti tecnici della versione nazista del Riccardo del 1995, onde approdare, nel
paragrafo precedente a due conclusioni principali. La prima, di ordine letterario, è che
tra la versione del ’55 di un Riccardo-tiranno come “Re delle Ombre” e quella del ’95
di un Riccardo come dittatore nazista, non esiste in fondo uno iato, ma una continuità
di elaborazione di significato. La seconda, più prettamente politica, è come la
versione del ’95 riesca a far emergere un concetto specifico di nazismo, all’interno
del ventaglio delle forme di dittatura, come esibizionismo dell’anomia al centro stesso
dell’ordinamento. Quindi un concetto politico-estetico che è ben lontano da ogni
estetizzazione della politica e che anzi politicizza la prima: ovvero mostra come i
concetti politici possano venire colti e compresi esteticamente, se solo si rinuncia alla
sua “dipartimentalizzazione”, ovvero se si rinuncia alla ideologia estetica che la
separa dalle altre discipline25.
Naturalmente se l’opera giunge ad un approfondimento del nazismo, non attraverso
una rottura, ma una continuazione di significato con le versioni precedenti, è
legittimo asserire che in Riccardo, come in altre sue opere politiche, a partire forse
proprio da Amleto, Shakespeare sia riuscito a pensare una delle possibili realizzazioni
dell’occidente, cioè l’avvento dell’ anomia come fattore di ordine, e che cosa questo
precisamente significhi. Ovvero come essa risulti non un fatto accidentale e
marginale, ma uno dei veri e propri centri del canone occidentale, di fronte al cui
abisso cerchiamo semplicemente di ritirarci, come chi, avendo costruito la propria
casa….sotto il Vulcano, faccia finta ogni mattina di non vederlo. Questa conclusione
risulterebbe corroborata se fossimo in grado di “spiegare” il sorprendente finale di
McKellen.
25 Dico questo con ovvio riferimento a Paul de Man (Author), Andrzej Warminski (Editor) Aesthetic Ideology (Theory and History of Literature, Vol. 65) University of Minnesota Press, 1996.
26
Naturalmente, infatti, rimane qui ancora da spiegare questo finale: con la caduta
beffarda di Riccardo all’inferno col ghigno del vincitore e non dello sconfitto.
Questo finale sorprendente rimane decisivo per l’interpretazione dell’opera nel senso
banale per cui ogni opera trova la propria soluzione nel finale, il quale rappresenta
quindi il punto d’appoggio necessario per la sua interpretazione26.
Ora, chi se non il Signore delle Ombre è contento di tornare nell’inferno, dopo
l’opera di distruzione compiuta?
Come tutti sappiamo in Shakespeare l’abbondanza dei riferimenti biblici sorpassa
ormai di gran misura la nostra conoscenza attuale di tali testi, ma la richiede. A
questo proposito non può sfuggire, allora, come il ritratto di Riccardo di Gloucester
possa esibire dei paralleli con quello riservato a Manasse, cattivo re, che non adora il
vero Dio, e che condanna Isaia ad essere tagliato a pezzi con una spada di legno. La
malvagità di Manasse si distingue dalle molte e varie iniquità di cui parla la Bibbia,
perché Belial abita nel suo cuore, così come abita nel cuore dei principi di Giuda e di
Beniamino27.
Belial è detto l’ “Angelo dell’Iniquità”, colui che governa questo mondo, ed è
chiamato anche “Matanbuqah”, e fa parte di una teologia dualistica che riaffiora
costantemente nel giudaismo del Secondo Tempio, ed anche negli scritti del canone
cristiano, così che la designazione di Belial come Angelo dell’Iniquità corrisponde
anche alla sua designazione come Angelo delle Tenebre, ed egli è il Signore di questo
mondo, cioè la potenza del politico.
Orbene, questo nome Belial, è tradotto nei Settanta con anomia nella frase nahale
beli’al (2Sam 22, 5 e Is 18,5) e addirittura come “anonéma” in Deutoronomio 15,9 ,
sempre con riferimento al suo epiteto di Aggelos anonimias.
26 Peter Brooks, Trame, Einaudi, Torino, 2004. 27 Su ciò cfr. la fondamentale opera di David Flusser, Il Giudaismo e le origini del Cristianesimo, Marietti, Genova, p. 13
27
Questa visione ricompare esplicitamente due volte nel Nuovo Testamento. La prima
nel passo sull’Anticristo (2 Ts 2, 3-12) in cui è inserito il passo sul katechon che tanta
attenzione ha oggi riattratto28, e dove egli viene descritto come “o Anthorpos tes
anomias", ovvero “o anomos” e come “to musterion tes anomias”.
La seconda volta questo concetto appare, sempre in Paolo, in 2 Cor 6, 14-15 “Non
siate legati al giogo alieno degli infedeli: quale comunanza può esserci tra la giustizia
e l’anomia ? E qual rapporto tra la luce e le tenebre ? e quale intesa tra Cristo e
Belial?”
Il dualismo qui sotteso da Paolo è, ovviamente, straordinario, ma indica proprio il
demonismo implicito, come contro-principio, nel regno del politico di questo mondo.
L’arconte di questo mondo è il Signore della anomia. E’ quel potere anomico che
cessa di nascondersi, ma finisce per esibirsi in quanto tale, cioè in quanto centro
stesso dell’ordine mondano.
Nell’aspetto demonico del re deforme vi è quindi molto di più di quanto si mostri, e
che eccede la sua stessa deformità nella direzione della sua mostruosità politica, onde
la sua caduta sorridente nelle fiamme, diviene un parallelo iconico del ritrarsi, per
tornare, di Belial nel suo regno, come fonte inesauribile del carattere anomico del
politico satanico, ovvero del nazismo.
In questo senso la trasposizione anni ’30 del Riccardo si mostra effettivamente come
un approfondimento di senso, poiché esiste comunque un bello stacco tra la
conoscenza del carattere in ombra del politico, e la visione della anomia come centro
stesso dell’ordinamento.
Il doppio sorriso scambiato tra il Riccardo Belial che cade “…come una folgore”, e
Enrico che ascende come katechon, come forza politica che resiste alle forze del caos
e del male, assume allora una valenza teologico-politica che non può mai staccarsi
28 Si veda, ovviamente a partire da Schmitt, la divulgazione fattane in Massimo Cacciari, Il potere che frena, Adelphi, Mlano, 2013.
28
dalla considerazione dell’ eccezione sovrana che sta al centro della Italian Theory29.
Una teologia-politica che, come ho cercato di porre recentemente, può divenire una
demonologia della genealogia del politico occidentale30.
Quel doppio sorriso di rimando può allora effettivamente essere una condivisione di
natura tra l’angelo dell’anomia e il catechon che si situa però ormai compiutamente al
di fuori del mero schema rinascimentale dell’eterno ritorno dell’uguale politico nella
perenne successione dei possessori della Corona secondo lo schema della sagacia e
della fortuna.
In questo modo la riflessione a partire dal testo di Shakespeare diventa qui una
compiuta ermeneutica politica che pone una questione giuridica essenziale : ovvero il
fatto che al centro della legge non vi sia una Grundnorm, una norma fondamentale,
ma anzi l’assenza fondamentale di ogni norma come eccezione sovrana.
Il film di Loncrain e McKellen va quindi ben al di là dell’analisi delle “inquietudini”
inglesi nei confronti del nazismo, per sfociare in un riflessione sulla esibizione
nazista dell’anomia come centro dell’ordinamento e come regime satanico per
eccellenza, comportando però al tempo stesso una rivelazione della sua apparizione al
centro del canone occidentale, non al suo margine, costituendo, quindi, una
rivelazione del suo eterno e costante pericolo.
29 Per quanto riguarda l’aspetto della teologia politica dualistica non può qui sfuggire il titolo stesso di uno degli ultimi libri di Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Einaudi Torino, 2013. 30 P.G.Monateri, Witches and Kings. James I and His Jurisdiction over Magic at the Root of Modern Demonology of Sovereignty, in Proceedings AIDEL International Conference, Verona, 12-14 nov. 2014, forthcoming.