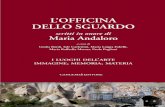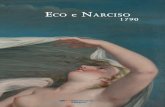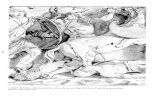La stregoneria tra storia e storiografia: da un consilium di Bartolo(?) (1991)
Gustavo Giovannoni e Corrado Ricci amicissimi. L'epistolario inedito tra Storiografia e Restauro
Transcript of Gustavo Giovannoni e Corrado Ricci amicissimi. L'epistolario inedito tra Storiografia e Restauro
PER UNA STORIA MILITANTEStoria dell’Architettura
tra Scienza e Società
ISBN 978-88-89999-49-3
9 788889 999493 > € 25,00
2009-2010
18-19
P
er u
na s
tori
a m
ilita
nte
di Maria Margherita Bulgarini
BOLL
ETTI
NO
SSF
SO
CIE
TÀ D
I STU
DI F
IOR
ENTI
NI
2009-2010
18-19
BOLL
ETTI
NO
DEL
LA S
OC
IETÀ
DI S
TUD
I FIO
REN
TIN
Ia cura diFerruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
per una storia ‘militante’storia dell’architettura tra scienza e società
a cura di Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
anno 2009-2010 numero 18-19
BollettinoDella soCietÀ Di stuDi Fiorentini
Collana di studi storici
Bollettino della Società di Studi Fiorentini
comitato ScientiFico
Ferruccio Canali, Giorgio Caselli, Giovanna De Lorenzi, Carlo Francini, Virgilio Carmine Galati, Gabriele Morolli, Gastone Petrini, Francesco Quinterio
comitato di lettura e di redazione
Ferruccio Canali, Valerio Cantafio Casamaggi, Giorgio Caselli, Carlo Francini, Virgilio Carmine Galati, Francesco Quinterio, Giuseppe Rizzo
logo: Virgilio Carmine Galati
Soci corriSpondenti
Raffaele Avellino (Umbria), Maria Beatrice Bettazzi (Emilia), Vittoria Capresi (Austria), Tommaso Carrafiello (Campania), Antonella Cesaroni (Marche), Alfredo Cisternino (Liguria), Luigina Galati (Salento), Bombina Anna Godino (Calabria), Motoaki Ishii (Giappone), Enrica Maggiani (Liguria), Olimpia Niglio (Lombardia), Valentina Orioli (Romagna), Andrea Pane (Puglia), Leonardo Scoma (Sicilia), Karin Templin (Inghilterra), Maria Antonietta Uras (Sardegna), Vincenzo Vandelli (Emilia)
Proprietà letteraria e artistica di SSF: divieto di riproduzione e di traduzioni. Gli Organi Direttivi della SSF e la Redazione della rivista non si assumono responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori, né per la corresponsione di eventuali Diritti di Riproduzione gravanti sulle singole immagini. Di norma è la Redazione stessa che si prende cura della correzione delle bozze. L’invio di contributi per la pubblicazione non implica né l’edizione degli stessi (per ogni contributo una “Valutazione di accettazione” verrà espresso dal Comitato Scientifico e/o di Redazione), né una loro edizione immediata (i tempi verranno infatti stabiliti di volta in volta sulla base delle priorità o delle esigenze editoriali indicate dagli Organi Direttivi). I materiali grafici inviati verranno comunque soggetti, sia come dimensione di pubblicazione sia come numero, al progetto editoriale approntato per ogni «Bollettino». Non si restituiscono i dattiloscritti, né le immagini, né i disegni pubblicati o non, né i libri recensiti. Il materiale inviato viaggia a rischio mittente. La pubblicazione di foto, disegni e scritti da parte degli Autori implica la loro totale rinuncia alla corresponsione di ogni compenso di Diritto d’Autore, trattandosi di pubblicazione scientifica e senza fini di lucro da parte della Società di Studi Fiorentini.
PER UNA STORIA MILITANTE«Bollettino SSF», 18-19, 2009-2010a cura di Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
I disegni presenti in questo numero nella serie “L’‘altra’ Firenze” sono di Ferruccio Canali (pp. 8, 10, 140, 231); di Virgilio C. Galati (pp. 178, 210, 231); di Bombina A. Godino (p. 228); di Domenico Leporini (p. 231)Nella serie “Raccomandazioni per le Energie alternative” i disegni sono di Ferruccio Canali (pp. 191, 194, 207); di Virgilio C. Galati (pp. 189, 195, 198, 204). La fotografia di p. 230 è di Virgilio C. Galati.
cura ScientiFica Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galatiprogetto e cura graFica Ferruccio Canali e Virgilio Carmine GalatireviSione editoriale Maria N. Brigliadori, Luigina Galati e Domenico Leporini traduzioni in ingleSe Karin Templincopertina e FaScetta graFica (p.1) Virgilio C. Galati (Clio polemeia)
Il «Bollettino» è stato registrato presso il Tribunale di Firenze al n.4777 del 2 marzo 1998 fino all’anno 2002. Poi è stato trasforma-to in “Collana editoriale” non potendo garantire regolari uscite periodiche. Il «Bollettino» è registrato nel sistema U-GOV (sistema per la governance degli Atenei universitari italiani del “Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica”) con codice: ISSN 1129-2800. Redazione e Amministrazione: via Boccaccio 44/B, 50133 Firenze
finito di stampare nel 2010 daLitografia I.P. - Firenze
Copyright © 2010 by Emmebi Edizioni FirenzeProprietà letteraria riservata
65
1. Biblioteca Classense di Ravenna, «Fondo Ricci», sezione «Corrispondenti» (d’ora in poi: B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.»). Le missive, contenute nei volumi 87, 88 e 221, sono numerate dalla 16582 alla 16584 (vol.88), dalla 16771 alla 16824 (vol.88), e dalla 40827 alla 40846 (vol. 221), per un totale di 75 lettere delle quali molte sono semplici biglietti di ricordo o di invito. Si tratta in genere di missive spedite da Gustavo Giovannoni a Corrado Ricci, che sono state velocemente segnalate in un paragrafo (“3”) secondo l’ordine di numerazione (a suo tempo apposto da Elisa, moglie di Corrado, e da Santi Muratori, Bibliotecario della Classense e grande amico di Ricci stesso), ma senza individuare precisi filoni tematici, da N. LombardiNi, La concezione ricciana del restauro attraverso i carteggi con Gustavo Giovannoni e Giuseppe Gerola. Pretesti per l’individuazione di una chiave di lettura dell’opera di Corrado Ricci ... 3. Corrado Ricci e Gustavo Giovannoni in Corrado Ricci. Nuovi studi e documenti, Atti del Convegno a cura di N. LombardiNi, P. Novara e S.TramoNTi, Ravenna, Società di Studi Ravennati, 1999, pp. 206-211 e in part. “Appendice. Carteggio Ricci-Giovannoni.2. Si veda per un orientamento: m.L.STrocchi, «La compagnia della Ninna». Corrado Ricci e Firenze (1903-1906), Firenze, 2005.3. Il mio F. caNaLi, Ugo Ojetti e Corrado Ricci amicissimi (1890 ca.-1919). Politica culturale, questioni artistiche..., «Ravenna studi e ricerche», IX, 1, 2003, pp. 95-175.4. Il mio F. caNaLi, Gustavo Giovannoni e Ugo Ojetti amicissimi. Questioni di architettura e di tutela nella corrispondenza conservata presso la GNAM di Roma in Ugo Ojetti (1871-1946) critico tra Architettura e Arte, «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», a cura di F. caNaLi, 14, 2005 (ma 2008), pp. 69-91.
aggiornata all’interno dell’Amministrazione, ma anche nella pubblica opinione nazionale1. Non conosciamo l’occasione nella quale Ricci e Giovannoni vennero in contatto (per una delle conferenze tenute dal Ravennate nella Capitale? O in occasione delle manifestazioni per il III° Centenario della nascita di Gian Lorenzo Bernini (1598-1898)? Dovette comunque trattarsi di una conoscenza che, se ci fu, prima del 1904 non dette luogo ad uno scambio epistolare significativo, stando almeno alle missive conservate nel «Fondo Ricci» di Ravenna. E la serie si chiude alle fine del 1932 (nel novembre), un anno e mezzo prima della morte di Ricci (1934). Oltre un trentennio, dunque, di ‘vita italiana’ durante il quale Ricci aveva raggiunto i vertici dell’Amministrazione delle «Antichità e Belle Arti» (ricoprendo anche il ruolo di Soprintendente alle Gallerie di Firenze2, per approdare a Roma alla carica di Direttore della sezione “Antichità e Belle Arti” del Ministero della Pubblica Istruzioni, quindi di Assessore alla Cultura del Comune di Roma e, infine, di Senatore del Regno); mentre Giovannoni, dai primi anni del Novecento, si distingueva nella Capitale e a livello nazionale per le sue riflessioni sul Restauro dei Monumenti e sull’Urbanistica, divenendo uno dei massimi restauratori allora attivi in Italia, prima dalla Facoltà di Ingegneria di Roma, poi, dopo il 1919, dalla neonata Facoltà di Architettura de “La Sapienza”. L’Italia intera era campo di operatività per Giovannoni e Ricci, anche se Firenze, oltre a Roma naturalmente, mantenne comunque una centralità che, grazie alla presenza e alle iniziative fiorentine di Ugo Ojetti (fino al 1919 amico di entrambi3, poi del solo Ingegnere4), costituì una sorta di
Le questioni connesse all’affermazione, in Italia nei primi decenni del Novecento, di una nuova Architettura ‘modernamente antica’, che sapesse compendiare cioè Modernità e Tradizione; e, in parallelo, la nascita di una sensibilità condivisa per la tutela e il restauro dei Monumenti, hanno avuto un loro sviluppo attraverso il confronto scientifico e personale, realizzatosi con alcuni personaggi impegnati nella Cultura nazionale, sia che esplicassero la propria attività nello studio positivistico delle discipline artistiche, architettoniche e ingegneristiche, sia che fossero direttamente coinvolti in nuovi Enti statali adeguatamente predisposti allo scopo (Università, Soprintendenze, Organi ministeriali e così via). Il ravennate Corrado Ricci e l’ingegnere romano Gustavo Giovannoni rappresentarono senza dubbio, all’interno di un tale milieu di intellettuali, due studiosi e operatori in grado di compendiare ai massimi livelli sia l’attività di Ricerca, sia quella di Conoscenza (in chiave di didattica, ma anche di divulgazione colta), sia quella di una stretta operatività professionale, toccando aspetti nodali dell’attività pubblicistica e operativa di Studio, di Tutela e di Restauro. Per questo, la corrispondenza Giovannoni – Ricci depositata presso la Biblioteca Classense di Ravenna, costituita da settantacinque lettere in gran parte inviate dall’Ingegnere al Ravennate in un arco cronologico compreso tra il 1904 e il 1932, restituisce un interessante spaccato di una serie di questioni nodali, aprendo inoltre interessanti squarci sul faticoso affermarsi di una sensibilità conservativa più
GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
Un rapporto di «cortese amicizia e di alta mentalità, infervorata dei nostri ideali» per la formazione dei nuovi architetti, per la Tutela dei Monumenti italiani e per la
costruzione di un’«italiana attività creatrice nel campo dell’architettura»
Ferruccio Canali
abSTracT: Recounts through inedited correspondence the relationship between Gustavo Giovannoni and Corrado Ricci whose joint involvement in the Protection of Italian Monuments Patrimony in the first decades of the 1900s constituted a pivotal moment for the foundation of a diffused conservation discipline.
FERRUCCIO CANALI66
5. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16805, telegramma di Giovannoni a Ricci del 25 settembre 1925, con scuse per un ritardo.6. Giovannoni scrive un telegramma a Ricci, in quel momento a Ravenna, perché non può recarsi in Emilia a causa dell’inizio dei lavori della nuova scuola di Architettura a Roma: «Inizio costruzione Scuola architettura mi impedisce viaggio emiliano» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40828, telegramma di Giovannoni a Ricci del 20 ottobre 1930).7. Nel 1925: «Il male è lieve, ma noioso. La sera stessa in cui venni a trovarla, tornando da Rocca di Papa, caddi nello scendere imprudentemente dal tram in corsa e mi son prodotto una distorsione ad un piede che ha bisogno di cure e di riposo per un periodo non breve. Spero però in settimana di essere di nuovo ‘in gamba’ (ormai quasi non zoppico più) e di poter finalmente venire alla Rocca alla riunione, tante volte differita, del Comitato» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16798, missiva di Giovannoni a Ricci, del 9 agosto 1925). Ancora nel 1929: «Non sono colpevole! ... ma una infezione alla pelle della faccia, si è dovuta combattere energicamente con lo strappamento delizioso dei peli della barba, sicché l’onor del mento è divenuto un vero disonore! Ora sto meglio ... e spero tra qualche giorno di venire, completamente guarito, a farle una visita alla Rocca» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16814, missiva di Giovannoni a Ricci del 31 luglio ottobre 1929).8. Per il rapporto Giovannoni – Ricci al proposito, si veda anche il mio F. caNaLi, Ricci e Giovannoni per i restauri alla Malatestiana di Cesena (1916-1932), «Ravenna studi e ricerche», XIII, 1-2, 2006 (ma 2008), pp.277-302.9. «Gustavo Giovannoni presenta al comm. Corrado Ricci l’egregio dott. Antonio Morassi, studioso di questioni d’Arte, del quale ebbe a parlargli alcun tempo fa» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16817, biglietto di presentazione, s.a.); E «Gustavo Giovannoni presenta al comm. Corrado Ricci padre Michele De Angelis, il quale desidererebbe da lui talune notizie d’Arte » (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16818, biglietto di presentazione, s.a.).10. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.»,vol. 87, n. 16582 (su carta intestata della “Società Filologica Romana”), missiva di Giovannoni a Ricci del 14 gennaio 1904. Il volume su “Viterbo” sarebbe rimasto lettera morta, ma come n. 48 della Collana sarebbe stato edito, di lì ad un lustro: S. bargeLLiNi, Etruria meridionale, Bergamo, 1909. Egidi invece pubblicava, senza Giovannoni: PieTro egidi, Viterbo, Napoli, Perrella, 1912.
banco di prova paradigmatico e di altissima levatura e, soprattutto, di attenzione internazionale. L’«amicizia» tra Ricci e Giovannoni, comunque, non fu mai né troppo stretta, né affettuosa, mantenendosi, piuttosto, nell’alveo della stima professionale, sia a livello degli studi, sia degli interventi restaurativi, come attestano le missive della Classense, dove si alternano questioni di vita ordinaria (come ritardi5, rinunce6 o annunci di visite dopo contrattempi legati alla salute7) a proposte di studio, o di pubblicazione, oltre all’organizzazione di Convegni (paragrafo 1); richieste relative alla vita della romana ”Associazione artistica fra i Cultori di Architettura”, che vedeva Giovannoni sedere negli Organi Dirigenti (o esserne addirittura Presidente) e Ricci tra i collaboratori più influenti, svolgendo un’azione sistematica di promozione degli studi storici e restaurativi (paragrafo 2); per contemplare, quindi, problemi e azioni legati alla formazione, specie in riferimento alla neonata “Regia Scuola di Architettura di Roma”, o alle accademie romane (come l’Accademia di San Luca), ovvero all’Ordine Nazionale degli Architetti, oltre al coordinamento di iniziative connesse alla promozione all’estero dell’architettura italiana (con l’“Istituto Interuniversitario Italiano”) (paragrafo 3); ancora, quelle missive restituiscono problematiche legate alla partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, agli organi di tutela dei Monumenti del Ministero della Pubblica Istruzione presso la sezione “Antichità e Belle Arti” (paragrafo 4); quindi, questioni riferite a specifici casi di restauro8 dai quali scaturivano riflessioni sugli aspetti monumentali (paragrafo 5); infine confronti sulle problematiche della disciplina architettonica con le sue specificità (paragrafo 6).Uno spaccato, così, che fa luce su numerosi casi, ma, soprattutto, mostra l’affermarsi di convinzioni culturali
e professionali ancora oggi ampiamente condivise, ma, in quel momento storico, frutto anche di dura contrattazione.
1. Un’intensissima attività di studio e di promozione: dalle proposte di collaborazione scientifica ed editoriale, all’organizzazione dei primi consessi scientifici per la Storia dell’Architettura
Nel «Fondo Ricci» della Classense, la più precoce attestazione del rapporto tra l’Ingegnere e il Ravennate si apre per noi, nel 1904, con una missiva connessa a questioni di studio e di ricerca, ambiti che poi avrebbero sempre segnato la comune operatività dei due intellettuali. Negli anni successivi, non sarebbero mancate reciproche presentazioni di studiosi o eruditi alla ricerca di informazioni, o entrature di studio9, ma in quel 1904 era lo stesso Giovannoni che scriveva a Ricci - Direttore di quella che stava divedendo una celeberrima collana editoriale, l’”Italia artistica” dell’Istituto Italiano Arti Grafiche di Bergamo (ne erano già usciti sei titoli) - perché
«Insieme col prof. Pietro Egidi, studioso di storia viterbese (come ella potrà rilevare dalle pubblicazioni della “Società Romana di Storia Patria”) ho intenzione di preparare una monografia su “Viterbo” della quale abbiamo da lungo tempo preparato gli elementi, io per la parte artistica e il prof. Egidi per la storica. Le sarei grato se Ella potesse dirmi se tale pubblicazione potrà trovare posto nella serie delle “Città Italiane” da lei così autorevolmente diretta. Il nostro lavoro sarebbe pronto non più tardi del prossimo Aprile. Firmato Gustavo Giovannoni, assistente della cattedra di Architettura nella Scuola di Ingegneria»10.
67GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
11. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16778, missiva di Giovannoni, dai Bagni di Montecatini, a Ricci del 3 agosto 1916.12. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16779, missiva di Giovannoni, da Montecatini, a Ricci del 24 giugno 1917. Prima di ritornare a Roma l’Ingegnere annuncia che passerà da Firenze al GDSU per i disegni del Sangallo. 13. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16782, missiva di Giovannoni a Ricci del 28 settembre 1920.14. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16821 (su carta intestata “Architetura ed Arti Decorative”), missiva di Giovannoni a Ricci, del 26 ottobre s.a. (ma 1920) .15. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16783, missiva di Giovannoni, a Ricci del 4 novembre 1920 .16. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16784, missiva di Giovannoni, a Ricci del 24 novembre 1920.
Si trattava di una delle tante proposte editoriali che giungevano a Ricci con grande frequenza, vista la novità, il prestigio e anche la discreta retribuzione economica, che la partecipazione alla “Collana” garantiva agli Autori; ma anche in questo caso – come in numerosissimi altri – non se ne sarebbe fatto nulla. I rapporti tra Ricci e Giovannoni continuarono comunque negli anni a venire, anzi stringendosi, ma, a livello editoriale, solo nel 1916, veniva a porsi un nuovo momento di interrelazione tra i due, allorché l’Ingegnere, in merito ai preparativi sulla sua monografia dedicata ad Antonio da Sangallo il Giovane, procedeva al riordino dei disegni dell’architetto rinascimentale, conservati presso il fiorentino Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, proponendo una collaborazione al proposito con Giovanni Poggi (della Soprintendenza fiorentina e ‘ricciano doc’):
«nei momenti in cui la cura mantecatinese [cioè alle terme di Montecatini] mi lascia libero, mi vengo occupando attivamente della preparazione del mio lavoro per Antonio da Sangallo, e riordino idee ed appunti e faccio uno schedario accurato di notizie e dati bibliografici. E comincio a sperare di poterne trarre qualcosa di buono ... A questo proposito, mi scrive ora Alfonso Bartoli, a cui prima della partenza mi ero rivolto, dandomi notizia che il Poggi ha preso l’iniziativa d’una proposta affinché a lui, d’accordo con Nerino Ferri, sia affidato il riordinamento dei disegni d’architettura degli Uffizi. Nessuna proposta potrebbe più di questa riuscire opportuna e utile pel mio lavoro, perché quando penso che i disegni del Sangallo e dei suoi accoliti superano di molto il migliaio, mi spaventa l’idea di metterci le mani e sceglierli e studiarli, raggruppandoli, decifrandoli, prima che siano stati ordinati. Io a mia volta – a parte la modestia – potrei riuscire un poco utile al lavoro di ordinamento, quando si svolgesse contemporaneo alle mie ricerche, perché direttamente o incidentalmente potrei aiutarlo con le mie speciali cognizioni. Vedo infatti che fin d’ora ogni mia visita al Gabinetto dei Disegni agli Uffizi porta con sè un bel numero di attribuzioni, rettifiche, di schede nuove. ... Da qui passerò a Quinto al Mare da mio fratello, poi a Roma»11.
La collaborazione al proposito si sarebbe mostrata proficua12, sotto l’égida e lo stimolo di Ricci, il quale, da anni ritenuto anche studioso di prima vaglia di Storia dell’Architettura, veniva di lì a poco chiamato dall’Ingegnere romano per ‘equilibrare’ tematiche di ‘Storia’ e di ‘Progettazione architettonica’ all’interno della neonata rivista «Architettura e Arti Decorative» (co-diretta da Marcello Piacentini e dallo stesso
Giovannoni), con un suo saggio:
«La Rivista d’”Architettura ed Arti Decorative” sta finalmente per vedere la luce: ai primi di gennaio uscirà il primo numero. Ecco perché io mi presento inesorabile a chiederLe l’articolo per il prossimo mese d’ottobre ... sulla “Porta di San Pietro a Perugia” ... Quando ci incontreremo parleremo ... sulla nuova Rivista, sul suo indirizzo, sul suo sviluppo. Lei potrà darmi aiuti e suggerimenti preziosi ... la sua collaborazione fin dall’inizio del nostro periodico è per noi un fatto d’importanza vitale, il quale viene a dare autorità grande all’iniziativa, viene a dare aiuto a questi poveri nostri studi della umile Architettura»13.
Le necessarie questioni tecniche andavano risolte in stretta collaborazione:
«Artioli si è assunto l’incarico di ricercare la pianta della Porta San Pietro di Perugia ... e se la trova di fargliela avere. Se non la troverà, sarà il caso di scrivere al Guidi perché ci mandi un rilievo preciso della pianta e probabilmente anche dell’alzato»14.
Anche se, poi, non mancavano i contrattempi:
«Quanto al Suo studio sulla porta San Pietro di Perugia, non so poi se l’Artioli abbia trovato e le abbia mandato la pianta. Se così non fosse, voglia avvertirmelo perchè la settimana ventura avrò quasi certamente occasione di passare da Perugia e di pregare personalmente il Guidi e il Tarchi di farla eseguire»15.
I ritardi si andavano, però, sommando e Giovannoni non voleva assolutamente rinunciare a quel contributo di ‘apertura’ di Ricci alla sua nuova rivista:
«sarebbe ormai urgentissimo avere il Suo articolo sulla porta San Pietro a Perugia ... Ella mi disse un giorno che Le occorreva un disegnatore per mettere giù la restituzione del prospetto: vuole che l’aiuti a trovarlo?»16.
Il disegnatore individuato dall’Ingegnere era, alla fine, Virgilio Marchi, futurista sui generis molto attento ai problemi della Storia e a quell’Ambientamento tanto caro a Giovannoni e Ricci – come aveva dimostrato nel caso dell’allestimento del Teatro Bragaglia alle Terme Romane:
«Domani spero d’inviarle i bozzettini della porta San Pietro ridisegnati molto bene dal Marchi ... Quanto alle
FERRUCCIO CANALI68
17. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16785, missiva di Giovannoni, a Ricci del 13 gennaio 1921.18. c. ricci, La Porta San Pietro di Perugia, «Architettura e Arti Decorative», I, 1921, 1, pp.17-31.19. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16782, missiva di Giovannoni a Ricci del 28 settembre 1920. Il riferimento era a g. giovaNNoNi, Il restauro architettonico di Palazzo Pitti nei disegni di Pietro da Cortona, «Rassegna d’Arte Antica e Moderna», 20, 1920, pp.290-295.20. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16821 (su carta intestata “Architettura ed Arti Decorative”), missiva di Giovannoni a Ricci, del 26 ottobre s.a. (ma 1920) .21. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16821 (su carta intestata “Architetura ed Arti Decorative”), missiva di Giovannoni a Ricci, del 26 ottobre s.a. (ma 1920) .22. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88 n.16791, missiva di Giovannoni a Ricci del 14 gennaio 1922 .23. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16806, missiva di Giovannoni a Ricci del 15 ottobre 1925 . Il riferimento è a c.ricci,
altre illustrazioni del suo articolo, temo che ad alcune bisognerà rinunziare ... anche perchè il tecnico della Casa Editrice Tuminelli ci ha fatto notare che alcune delle fotografie degli “aborti” sono così gialle e sbiadite da non poterne cavare nulla di presentabile»17.
Gli «aborti» erano certamente le proposte interpretative della facies originaria della Porta secondo i vari progetti che si erano succeduti e dei quali Ricci nel suo articolo avrebbe poi fatto giustizia18.La collaborazione intellettuale e pubblicistica era, però, a doppio binario e, così, il favore fatto da Ricci veniva ricambiato da Giovannoni che, ancora una volta, poneva al centro del proprio interesse questioni storico-artistiche diffuse tra Roma e Firenze:
«Anch’io ho promesso a Lei un articolo per la “Rassegna d’Arte”: un articolo sui disegni di Pietro da Cortona per il restauro di Palazzo Pitti. Orbene il mio articolo è ormai pronto e non vi è che da mettersi d’accordo per qualche riproduzione accessoria, come ad es. per quella dei resti della villa alla Pineta Sacchetti, disegnati nell’opera di Percier e Fontaine»19.
Anche in questo caso le questioni tecniche andavano risolte a stretto giro e in collaborazione:
«Quanto al mio articoletto sui disegni di Pietro da Cortona, attendo che Lei mi telefoni un appuntamento per fare fotografare alla V. Emanuele [la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma] la veduta della villa alla Pineta Sacchetti contenuta nel Percier et Fontaine, ed il disegno di palazzo Pitti contenuto nel Geymueller»20.
Per un albertiano come Ricci (che stava preparando l’edizione del suo “Tempio malatestiano” uscito poi nel 1924 presso l’editore Bestetti e Tuminelli) non potevano poi mancare scambi di notizie e materiali riguardo all’opera di Leon Battista Alberti. E Giovannoni puntualmente rispondeva:
«Eccole una copia del disegno di Antonio Abaco relativo al San Sebastiano di Mantova. Non le pare che sia molto interessante a documentarci la grandiosità costruttiva e la derivazione della pianta dagli schemi classici?»21.
Cosi come non mancavano, addirittura, consulti relativi alle tecniche costruttive rinascimentali – un ambito che vedeva molto attivo l’Ingegnere, ma in relazione
al quale le conoscenze di Ricci non si mostravano evidentemente da meno – tanto che proprio i sistemi costruttivi potevano venir assunti, storiograficamente, come signum autoriale e interpretativo:
«Il quesito che tanto mi interessa è il seguente: se nelle cupole lombarde della fine del XV secolo, che hanno per esempio massimo la cupola racchiusa nel tiburio di Santa Maria delle Grazie [a Milano] e che presentano in Saronno, Crema etc altrettanti interessanti esempi, è mai stato rilevato il tipo di vera struttura doppia. Io ne ho trovato un caso tipico, secondo lo schema qui abbozzato, nella chiesa di Capranica Prenestina dei primi del Cinquecento, certo dovuta a un lombardo bramantesco (ed il quesito mi interessa assai per gli studi relativi alla cupola di San Pietro). Mi è venuto in mente che possa appartenere allo stesso schema costruttivo la cupoletta del tempietto di Bramante a San Pietro in Montorio, poiché la sua sezione è del tipo che qui le disegno [molto rialzata la parte estradossata rispetto all’intradosso] e non saprei immaginarla piena. Sarebbe interessantissimo farne un testo per sincerarsene; ma come si fa ad ottenerlo?»22.
Non erano, però, solo confronti sulle questioni rinascimentali (Antonio da Sangallo, ambiti bramanteschi) o barocche (Pietro da Cortona, un settore cronologico questo, che andava ormai da qualche decennio innovando l’attenzione della Critica, proprio grazie al contributo ricuciano), ma si trattava anche di interessi condivisi in relazione alle architetture romaniche e alla costruzione di esse:
«Ho avuto, nella edizione italiana, il Suo magnifico volume sulla “Architettura romanica in Italia” e La ringrazio vivissimamente. Glielo riporterò per avere la sua firma, a cui molto tengo ed anche, se avrò intanto avuto tempo di studiare il testo, per parlare con Lei delle teorie svolte sulla formazione di quel complesso ed interessantissimo periodo della nostra Arte e della nostra tecnica costruttiva»23.
Un interesse condiviso, che non faceva però dimenticare l’architettura del periodo paleocristiano, vero e proprio ambito specialistico sia di Ricci (‘bizantinista’ ravennate da sempre), sia del romano Giovannoni:
«i Cosmati che hanno lavorato a Civita Castellana sono i seguenti: nel portale si sono firmati Lorenzo col figlio
69GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
Architettura romanica in Italia, Stoccarda, 1925.24. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16808, missiva di Giovannoni a Ricci del 2 ottobre 1926. I riferimenti sono a g. giovaNNoNi, Note sui marmorari romani, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 27, 1904, pp.1-26; idem, Opere dei Vassalotti marmorari romani, «L’Arte», 11, 1908, pp.262-283.25. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16809, missiva di .Giovannoni a Ricci del 24 ottobre 1926.26. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16772 (su carta intestata “Comitato Generale di Organizzazione del IX Congresso Internazionale degli Architetti”) missiva di Giovannoni a Ricci, a Corrado Ricci del 30 settembre s.a. (ma per la pubblicazione: Congresso internazionale degli Architetti. Atti ufficiali del IX Congresso, Roma, 1914. L’attività di Ricci al proposito sarebbe rimasta sempre molto intensa: Si veda: c.ricci, Per l’isolamento e la redenzione dei resti dei Fori Imperiali, «Bollettino d’Arte», 5, 1911, pp.445-455; idem (con disegni di L. PogLiaghi), Per l’isolamento degli avanzi dei Fori Imperiali, Roma, 1913. Quindi: idem, La redenzione degli avanzi del Foro d’Augusto, Roma, 1924. Il progetto complessivo «di liberazione» dei Fori venne approvato il 5 novembre 1924; nel 1930, dopo la prima fase di scavi, lo stesso Ricci, allora «Direttore delle Antichità e Belle Arti» del Governatorato di Roma, fece avviare le demolizioni nei pressi dei Fori di Traiano, di Augusto e di Nerva e alle spalle della Basilica di Costantino (c.ricci, a.J. ruScoNi e g.LugLi, Gloriose imprese archeologiche: il Foro d’Augusto a Roma …, Bergamo, 1927; c.ricci, Il Foro di Augusto e la casa dei Cavalieri di Rodi, Milano, 1930).
Jacopo; in una delle porticelle laterali è la firma del solo Jacopo; di tutto il magnifico portico, che è una vera opera della Rinascenza e che ha la data del 1210, si sono segnati autori Jacopo e il figlio Cosma. Quanto al pluteo che ora trovasi nella sacrestia, è firmato non già “Deod et Lucas”, come quasi tutti gli scrittori hanno riferito, ma “Drud. et Lucas”. Sono cioè uniti i nomi di Luca figlio primogenito di Cosma e di Drudus de Trivio, altro marmorario, forse di diversa famiglia, del quale io ho trovato numerose altre opere, di cui la più importante è il ciborio del duomo di Ferentino. Di tutto questo io ho trattato, ristabilendo la genealogia della famiglia dei Cosmati, nell’articolo “Note sui marmorari romani” nell’”Archivio della Società Romana di Storia Patria” del 1904. Di “Drudus de trivio” ho parlato in un articolo intitolato appunto “Drudus de Trivio marmorario romano” nella “Miscellanea per le nozze Hermanin-Hausmann”. Altre notizie sui marmorari ho raccolto nell’articolo su “Opere dei Vassalletti” nell’”Arte” del 1908. Degli scavi di Monte Cavo detti un brevissimo primo cenno nella “Notizia degli Scavi” del 1912 n.11; ma a fare una relazione ampia ho sempre aspettato la ripresa dello scavo ... che non è mai venuta. Un articolo su Monte Cavo ho pubblicato in quel volume del Club Alpino Italiano sui “Monti del Lazio e dell’Abruzzo” che uscì l’anno scorso. Mi pare d’averglielo mandato; ma se così non fosse, glielo invierò ora e spero che L’interesserà»24.
Non potevano poi mancare le attenzioni imperiali per Roma e i Monumenti della Romanità, argomento di studio sul quale affinare le ricerche e scambiarsi notizie, specie in connessione con l’attività di Ricci per i Fori Imperiali, ma anche visto l’interesse del Regime fascista dopo il 1925:
«ho trovato due fotografie dei “Corridori” e glie Le mando, ma quanto a quella delle sigle della via Trionfale non mi è stato proprio possibile il ripescarla. Penso però che, essendo il cliché del fascicolo “Tra i Monti del Lazio e dell’Abruzzo” molto chiaro, non sarà difficile fare una buona riproduzione da quello. C’è forse di meglio. La Società “Grafia” che ha curato l’edizione (cioè il dott. Luciano Morpurgo) avrà certo ancora i cliché e non sarà difficile farseli prestare. Vuole che io me ne occupi? … [In merito poi] alla posizione degli architetti rispetto agli studi dei Monumenti … Le ricordo la mia proposta, che
mi parrebbe adattissima per l’’Istituto di Archeologia e di Storia dell’Arte’; cioè di promuovere una pubblicazione, per ora descrittiva, poi analitica, sui monumenti dell’Impero Romano sparsi per il mondo. Paribeni ed io ce ne potremmo occupare, e se Paribeni avrà poco tempo disponibile, potrà farsi aiutare, ad esempio, dal Romanelli. Ma la raccolta è ora di una importanza e di un significato grandissimi, tanto che sembra impossibile che nessuno ancora ci abbia pensato»25.
Le comuni riflessioni, relative ai Monumenti dell’Antichità romana, risalivano a oltre un decennio prima e avevano visto Ricci coinvolto da Giovannoni in una conferenza sui «Fori Romani», nel corso del «IX° Congresso Internazionale degli Architetti»:
«Sono venuto più volte al Suo ufficio per mettermi d’accordo per la Sua conferenza sui “Fori Imperiali” al “Congresso Internazionale degli Architetti”. Ed ora l’amico Colasanti mi dice che Ella è a Ravenna! Non ci ha dimenticati, non è vero? ... È così adatta e propizia l’occasione per lanciare agli artisti ed agli studiosi la grande idea, che non potremmo rinunziarvi. ... [potremmo inoltre] facilitarle il lavoro ordinando e disponendo nella sala i meravigliosi disegni»26.
In verità, su quella conferenza di Ricci era nato un disguido, perché il Ravennate alla fine aveva dovuto disdire il suo intervento, ma gli organizzatori, avendolo confuso con Giacomo Boni, avevano mantenuto in calendario il suo intervento:
«L’ing Cannizzaro, a cui io parlai con grande fervore dei disegni e delle fotografie relative ai Fori Imperiali, dei suoi progetti e della sua intenzione di comunicare tutto ciò al Congresso, ha fatto mettere la Sua Conferenza come un numero del programma ... Appena mi giunse la Sua lettera [di rinuncia] fu tolta la Sua conferenza ... e poiché in quei giorni ci fu anche una conferenza del Boni sul “Forum Ulpium”, l’equilibrio tra Modernismo e Archeologia non è rimasto turbato. Chi sa anzi che qualche Congressista non abbia equivocato tra le due Conferenze e i due conferenzieri e non porti nell’animo scolpito il ricordo della barbetta e degli occhi azzurri inspirati del Comm.Ricci!»27.
Per tutti i circa trent’anni della loro conoscenza
FERRUCCIO CANALI70
27. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16774, missiva di Giovannoni, a Ricci dell’11 ottobre 1911.28. Era anche il caso della chiesa della Rosa di Chianciano: «Mille grazie per la notizia segnalante la bella chiesa della Rosa di Chianciano; e arrivederci lunedì 22 per la riunione del Consiglio Superiore. Spero di trovare la signora Elisa completamente ristabilita dopo il ‘restauro’, un po’ forte, di Chianciano» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40831 di Giovannoni a Ricci del 19 luglio 1929).29. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40846, cartolina postale di Giovannoni, illustrante la «nuova sede della R.Scuola di Architettura di Roma a Valle Giulia», a Ricci s.d. (ma dopo il novembre 1932).30. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40832, lettera di Giovannoni a Ricci del 17 luglio s.a. ma 1929-1930 (su carta intestata «R.Scuola di Architettura, Roma». Il riferimento è g.LoreNzeTTi, Onoranze a Jacopo Sansovino …, Milano, 1929.31. Il mio F. caNaLi, Ugo Ojetti e Corrado Ricci amicissimi (1890 ca.-1919) …, cit. E sempre il mio F. caNaLi, Gustavo Giovannoni e Ugo Ojetti amicissimi …, cit.32. «Mi pregio presentare l’egregio architetto Innocenzo Sabbatini, socio dei Cultori d’Architettura, il quale desidererebbe il Suo parere su di un interessante progetto architettonico»: (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16786, missiva di Giovannoni a Ricci, Assessore per le Belle Arti del Comune di Roma, del 1 giugno 1921.33. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.87, n.16583, missiva, firmata da Giovannoni, Presidente dell’“Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura di Roma” a tutti i Soci e, dunque, anche a Corrado Ricci del 1 giugno 1910. Segue una nota personale di Giovannoni a Ricci: «con una speciale vivissima preghiera e coi più distinti saluti». Poi seguiva un biglietto di ringraziamento per il dono che Ricci aveva fatto alla Biblioteca dell’Associazione del suo volume “L’architettura del Rinascimento”: B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.»,
attestataci dalle missive del «Fondo» ravennate, le questioni scientifiche sarebbero, dunque, rimaste nodali, con lo scambio continuo di informazioni e segnalazioni28. A volte con veri e propri ‘giochi di sponda’, come quando era Giovannoni a scrivere una sorta di ‘recensione delle proprie opere’ che poi Ricci pubblicava, con l’aggiunta di ovvie riflessioni personali, ma a nome proprio (una ‘recensione per interposta persona’ ovvero una ‘recensione interposta’):
«Eccole gli appunti riassuntivi sul mio libro; e mi accorgo che sono ancora assai lunghi, cosa inevitabile quando l’Autore parla del suo lavoro, anche se l’autore, come fa il sottoscritto, parla poco. Se ne valga come vuole e poi voglia, a Suo comodo quando crederà, rimandarmeli. La ringrazio fin d’ora per la recensione che, con la Sua cortese amicizia, si è assunto di fare dei miei ultimi lavori»29.
Altre volte, invece, era stato Giovannoni a dover declinare gli inviti scientifici del Ravennate:
«La ringrazio vivissimamente pel cortese invito a preparare per la “Nuova Antologia” un articolo su Jacopo Sansovino; ma purtroppo son ora tante e così intense le mie occupazioni, che non vedo possibile l’accettare l’incarico così bello e lusinghiero. Non sarebbe infatti per me impresa da pigliarsi a gabbo lo scrivere in poche pagine sull’artista grandissimo. Di lui ho avuto occasione di studiare a fondo, e con indagine diretta, un periodo soltanto, cioè quello della produzione architettonica svolta in Roma; periodo relativamente modesto in sé, ma interessante quale preparazione alla magnifica fortuna veneziana. Ma è questo un lato soltanto della grande figura multiforme e lo scolpirla ‘a tutto tondo’ mi richiederebbe un lavoro in gran parte riflesso e certo non lieve … Io mi permetto di suggerirle, in mia vece, alcuno degli studiosi veneziani: o il prof. Bordiga, Direttore dell’Accademia di Venezia che recentemente ha tenuto il discorso commemorativo ufficiale; o l’architetto Luigi Marangoni, il proto di San Marco, o il dott. Lorenzetti che sul Sansovino ha autorevolmente scritto»30.
Anche da quei dinieghi, il rapporto scientifico, ancora una volta, non ne era mai uscito adombrato. Sembrava insomma valere l’adagio: «Meglio una amicizia non molto stretta ma duratura, piuttosto che un rapporto vorticoso destinato a consumarsi più in fretta”. E il caso dell’amicizia Ojetti-Ricci sembrava proprio confermarlo, in questa comune triangolazione culturale31.
2. L’“Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura di Roma”: Ricci e Giovannoni per l’aggiornamento della cultura professionale degli architetti romani
L’ambiente culturale della Capitale era stato vivificato, nel 1890, dalla nascita della ”Associazione artistica fra i Cultori di Architettura di Roma - AACAR”, cenacolo di giovani architetti che negli anni, con studi ed iniziative, contribuivano in maniera decisa all’aggiornamento degli studi e delle aperture storiografiche. Giovannoni era senza dubbio uno dei membri più attivi dell’Associazione (tanto da divenirne anche Presidente nel corso di alcuni mandati) e le sue iniziative, giocate su un ventaglio piuttosto ampio nei decenni, si articolavano secondo un programma che puntava all’affezione dei Soci sia nella promozione di giovani architetti32, sia nell’incremento delle conoscenze anche dal punto di vista della disponibilità bibliografica. Così l’Ingegnere interpellava tutti i membri dell’Associazione e anche Ricci:
«mi permetto di rivolgere un vivo appello al suo costante interessamento a favore della nostra Associazione ... pregandola di un’efficace cooperazione all’incremento della biblioteca sociale ... e tanto più questo contributo può riuscire per l’Associazione nostra prezioso, allorquando si tratti di opere e di studi di cui i soci stessi sono autori»33.
Ma, soprattutto, per fornire lustro alle Conferenze e alle piccole Mostre che quel cenacolo organizzava, Giovannoni non mancava di invitare gli Studiosi allora più influenti e aperti alle novità. E Ricci, ovviamente, sia per la sua notorietà, sia per il suo calibro di studioso (che aveva sistematicamente intrapreso studi di ambito barocco, paleocristiano e bizantino così importanti per
71GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
vol.88, n.16793, missiva di Giovannoni a Ricci, del 12 marzo 1923.34. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16773: convocazione ufficiale per una riunione il 7 ottobre 1911 dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura”, sotto la presidenza di Giovannoni. E ancora un biglietto di invito a partecipare alla riunione dell’Associazione Artistica fra i Cultori d’Architettura (carta intestata Comitato di Organizzazione del “IX Congresso Nazionale degli Architetti”): B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16824, s.d. (ma poco prima del 1914).35. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40827, missiva di Giovannoni a Ricci del 19 marzo 1910.36. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16771, missiva di Giovannoni a Ricci del 4 febbraio 1911. 37. Alfonso Rubbiani. Scritti vari editi ed inediti, a cura di c.ricci, Bologna, 1925. Per il rapporto Ricci – Rubbiani si veda il mio F.caNaLi, Alfonso Rubbiani e Corrado Ricci amicissimi. La questione delle mura di Bologna (1902) dalle teorie dei valori, alle reticenze dell’“Urbanistica artistica”, alle attenzioni di Gustavo Giovannoni per un ‘nuova’ tipologia di Monumenti in I confini perduti. Le cinte murarie cittadine europee tra Storia e Conservazione. Atti del Convegno, a cura di a.varNi, Bologna, Editrice Compositori, 2005, pp. 192-204.38. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16775, missiva di Giovannoni, a Ricci del 3 aprile 1914.39. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n. 16777, missiva di Giovannoni, a Ricci del 30 aprile 1915. Poeta e storico Gnoli (1838 – 1915), studioso dei monumenti di Roma e del Rinascimento, dal 1881 fu Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Roma, anche se lungamente denigrati), non poteva non godere di un posto di privilegio come “socio” (onorario)34, ma pure come conferenziere o organizzatore egli stesso di eventi. Già nel 1910, l’Ingegnere scriveva a Ricci, proprio in riferimento ai problemi dell’Architettura Bizantina di Ravenna, a seguito dei restauri compiuti nel 1897 dallo stesso Ravennate, allora Soprintendente della prima Soprintendenza ‘pilota’ d’Italia:
«Nel preparare il programma del prossimo, breve ciclo di conferenze della nostra Associazione (Artistica tra i Cultori di Architettura) non so resistere alla tentazione di pregarLa di iniziare con una Sua conferenza ... (Potrebbe trattare) sugli ultimi trovamenti e sui restauri recenti a Ravenna. meglio ancora poi se la conferenza potesse giungere a parlarci di tutti i restauri dei monumenti ravennati sotto la Sua guida compiuti»35.
In verità, non si trattava, dunque, di ‘semplici’ conferenze, ma di vere e proprie lezioni che dovevano indirizzare e aggiornare l’operatività dei Soci (architetti e ingegneri) e, soprattutto, diffondere, attraverso il magistero ricciano, una precisa concezione del restauro dei Monumenti. Così, il Programma veniva stilato e si trattava, l’anno seguente, di dare corso a quella conferenza:
«Io mi permetto di ricordarle una promessa che l’anno scorso Ella fece alla nostra Associazione, ed a cui tutti noi teniamo talmente da non potervi rinunciare: quella di tenerci, quando crederà, una conferenza ... e io avevo pensato all’argomento: “Recenti scavi e trovamenti in Ravenna” nel quale avrebbero potuto essere integrate le varie comunicazioni importantissime, da Lei fatte in questi ultimi due anni all’Istituto Archeologico tedesco ... Qualunque altro possa essere l’argomento che Ella ritenga più opportuno sarà sempre per noi ben accetto … sempre lieti e fieri di avere Lei a guida autorevole non solo nelle ferventi battaglie, ma altresì nei sereni trattenimenti nel giardino delle Arti e degli Studi»36.
Sulla stessa linea didattico-operativa si ponevano anche particolari commemorazioni, come quella richiesta, sempre a Ricci, in onore del restauratore bolognese Alfonso Rubbiani, da poco scomparso, per veicolare
una visione dell’Architettura e del Restauro di estremo aggiornamento. E durante l’evento erano state, dunque, parole di stima e affetto per Rubbiani, con il quale aveva avuto uno stretto rapporto personale (tanto da curarne poi una serie di scritti «in memoriam»37). Giovannoni ringraziava, dunque il Ravennate di aver commemorato, nella sede dell’Associazione, «con un discorso così vibrante d’affetto, così mirabile per concetti e per forma», il Bolognese scomparso,
«nobilissima figura ... [Un ringraziamento per quanto] ha voluto dirci dell’opera dello studioso, del restauratore dei monumenti bolognesi, dell’animatore di ogni energia d’arte nella sua città ... La sua commemorazione ... sarà incitamento per noi ad adoperarci pei monumenti e per l’Arte. Il nobile esempio non andrà perduto»38.
L’anno successivo toccava, in una visione coordinata di Storia e Restauro posta alla base di quel «Restauro filologico» condiviso da entrambi, ad un ricordo ‘in memoriam’ dello storico romano Domenico Gnoli, per il quale veniva chiamato in causa sempre Ricci:
«Ha poi pensato alla commemorazione del povero Gnoli all’Associazione dei Cultori? ... [Credo] che niuno possa meglio di Corrado Ricci essere adatto a rendere la “buona e bella immagine paterna” dell’umanista dotto e gentile, e a comprenderne insieme la erudizione e la poesia e la bontà ... E per poesia, intendo non tanto i suoi versi, che forse passeranno presto, quanto quel sentimento di affetto per ogni cosa bella, di amore fervente per Roma, che ha illuminato tutta l’opera dello Gnoli e l’ha mantenuto giovane di animo»39.
La collaborazione culturale tra Giovannoni e Ricci si approfondiva negli anni, tanto che il Romagnolo – allora Direttore della sezione “Antichità e Belle Arti” del Ministero della Pubblica Istruzione – coordinava, insieme all’Ingegnere, l’esposizione, sempre nella sede dell’Associazione, degli studi relativi ai Fori Imperiali; quasi che Conferenze, Mostre e Attività restaurativa (Studio e Attuazione, dunque) costituissero inscindibili aspetti di uno stesso programma culturale e civile:
«Nella sede della Associazione Cultori di Architettura si tiene la mostra delle tavole dei “Fori Imperiali e della
FERRUCCIO CANALI72
oltre che fondatore dell’«Archivio Storico dell’Arte».40. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16776, missiva di Giovannoni a Ricci del 6 aprile 1915.41. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16774, missiva di Giovannoni Corrado Ricci dell’11 ottobre 1911. 42. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16787, missiva di Giovannoni a Ricci, Assessore per le Belle Arti del Comune di Roma, del 12 febbraio 1921.43. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16788, missiva di Giovannoni a Ricci, Assessore per le Belle Arti del Comune di Roma, 22 aprile 1921.44. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 88, n.16823, «F.R.», sez. «Cor.», missiva di Giovannoni a Ricci, s.d., sulle demolizioni e in lavori in Piazza Venezia a Roma (1910 circa). Per l’autore della stampa, Nora LombardiNi (I carteggi..., cit., p.228) legge «Krol»,
Torre delle Milizie”: le tavole dei Fori Imperiali e della torre della Milizie sono ormai, finalmente, incorniciate e pronte per la nostra Mostra ... le rivolgo un quesito relativo all’indicazione di catalogo: dobbiamo segnarle col nome di Corrado Ricci autore, ovvero con quello della Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti? Tra la soluzione di paternità e quella burocratica, decida Lei»40.
E che quegli studi comuni e quelle iniziative intendessero avere una spiccata valenza operativa lo aveva sottolineava lo stesso Giovannoni in occasione di una precedente Conferenza che, proprio riguardo ai Fori, Ricci aveva tenuto nel 1911:
«spero tra poco Lei vorrà trionfalmente varare il magnifico progetto per la risurrezione dei Fori Imperiali con una Conferenza alla nostra Associazione»41. Le Esposizioni e le Conferenze avevano, dunque, un intento programmatico, didattico e scientifico, aprendo dibattiti, ma soprattutto per indirizzare il pubblico degli intendenti verso una precisa linea culturale e operativa. Così
«Abbiano iniziato all’Associazione dei Cultori d’Architettura una serie di piccole esposizioni sociali di varissimo tipo. Ora vorremmo prepararne una di disegni cosmateschi e specialmente di disegni cosmateschi di Andrea Terzi. Ora io ricordo che molti di questi sono di proprietà del Comune ed in particolare quelli relativi alla chiesa dell’Aracoeli; altri invece fanno parte delle Biblioteca della Direzione di Belle Arti – la Sua biblioteca che oggi finalmente risorge – e furono, se ricorda, acquistati da Lei tre o quattro anni fa ... Ed eccoci quindi a domandare i relativi permessi: dei quali il primo dipende certamente da Lei, e forse anche il secondo, se veramente la Biblioteca è passata alla nuova Accademia d’Archeologia e Storia d’Arte»42.
Tra quelle «piccole esposizioni» ed incontri societari, il nucleo forte era ovviamente costituito dalle questioni romane che stavano a cuore sia all’Ingegnere sia a Ricci, divenuto poi negli anni Venti, Senatore del Regno. E si trattava, ovviamente, di incontri sempre estremamente ricchi di implicazioni decisionali.Così, una «comunicazione» veniva avanzata dal Ravennate «sul concorso deliberato dall’Amministrazione Comunale (seguendo la linea già felicemente tracciata dall’Amministrazione precedente) per il Monumento a
Campo Verano»43. Altre due questioni, in particolare, vedevano coinvolti negli anni, i due ‘amicissimi’: e si trattava di aspetti nodali per il restauro urbano a Roma, come nel caso della sistemazione della zona dell’Aracoeli, del Campidoglio e della sottostante piazza Venezia; e per il progetto per l’area del Mausoleo di Augusto.Per l’area di piazza Venezia e le aree limitrofe, la questione si era aperta fin dal 1910, anche se poi si sarebbe protratta per anni. L’attenzione di Giovannoni era sempre vigile e Ricci aveva avanzato proposte precise per l’area compresa tra la piazza Venezia-San Marco (sotto l’Aracoeli), il Monumento alla Vittoria e poi nuovo ingresso dei Fori
«Tutto cammina: il Priori alle 4 aveva già portato avanti la sua prospettiva e gliela porterà domattina presto. In tal occasione prenderà con Lei gli accordi per la seconda fase operativa, per la quale potranno essergli utili le fotografie fatte da Garganelli. ... Mi vengono in mente due altri vantaggi non piccoli del Suo progetto. L’uno è quello di nascondere le casupole che ora danno su piazza San Marco; le quali casupole tra qualche anno saranno sostituite da grandi edifici moderni, peggiori ancora, come effetto d’insieme, delle casupole. Invece la Loggia di San Marco verrebbe a chiudere da quel lato la visuale, a definire il campo, a completare la scena.L’altro vantaggio riguarda il 1911. Sarebbe vano pensare di vedere in meno d’un anno finita la demolizione, ricostruita quasi per intero la torre, ricostruito il nuovo palazzo. Sicché la grande festa commemorativa di cui uno degli elementi sarà l’inaugurazione del Monumento [il Vittoriano] avrebbe per scenario le impalcature e i ruderi! Così invece tutto si risolve e si completa. Venerdì, quando ci troveremo in piazza Venezia, Le porterò le riproduzioni della stampa del Koch raffigurante il Campidoglio – che Lei certo ricorderà – e che nel palazzo centrale ha il motivo della torretta d’angolo laterale al doppio loggiato, che mi ha servito per lo studio della soluzione terminale»44.
La questione rimaneva perà aperta e ancora anni dopo, per il Campidoglio, Giovannoni chiedeva a Ricci del materiale informativo con il quale presentare una Conferenza presso l’Associazione (in modo da sensibilizzare i suoi colleghi nei confronti delle opere che si andavano preparando):
«domani sera avrei intenzione di riferire all’Associazione
73GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
mentre dovrebbe trattarsi di una “Veduta” di Joseph Anton Koch del 1810 ca.45. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16815 , missiva di Giovannoni a Ricci, del 11 s.a.46. Era lo stesso Giovannoni a lamentare con Ugo Ojetti, probabilmente riferendosi proprio a Ricci (se non a Muñoz): «Il Santone sta rimettendo a nuovo e lavorando a polimento i Mercati di Traiano; per attuare la bella idea dell’esedra arborea sta chiudendo tra pilastri e solette di cemento armato le parti dissepolte della basilica Ulpia (e certo sulle solette anche i pini dovranno nascere di cemento armato); ha collaborato con Cesare e con Cicerone nel foro Julio e nel Clivus Argentarius, dove ha collocato il lastrico di pietroni portati da Grottaferrata e il postero ci troverà sotto una conduttura del gas» (Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, «Fondo Ojetti», ad vocem «Giovannoni Gustavo». [D’ora in poi GNAMR, «F.O.», «G.G.»], missiva del 29 novembre 1932 da Giovannoni a Ojetti.) Nel novembre dello stesso 1932 Giovannoni lamentava sempre con Ojetti «per le vicende per l’Aracoeli ... ecco un’altra battaglia per ora perduta, ma che bisognerà riprendere e vincere … non dimentico i tuoi vari articoli e in particolare quelli sulla piazza dell’Aracoeli e sul Campidoglio, che sono stati di una efficacia decisiva» (GNAMR, «F.O.», «G.G.», missiva del 29 novembre 1932 da Giovannoni a Ugo Ojetti). 47. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40839, lettera di Giovannoni a Ricci del 27 maggio 1931.48. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16797, missiva di Giovannoni a Ricci del 4 maggio 1925. 49. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16794, missiva di Giovannoni a Ricci, s.a.. Ma non si dimenticava neppure «il voto sulla zona di rispetto alla basilica di San Paolo. Dopo la protesta di padre Acernese, ho la piena sicurezza che rimarrà dimenticato negli
dei Cultori di Architettura i risultati degli studi della Commissione incaricata di riunire ed integrare le proposte per la sistemazione del Campidoglio e della zona circostante. È un modo questo per richiamare l’attenzione sui problemi interessantissimi che abbiamo trattato e di svegliare un po’ il sonno dei vari Uffici, che dovrebbero occuparsi dell’attuazione. Desidererei illustrare il più ampiamente possibile la mia “Relazione”; e sarei perciò lietissimo se potessi avere i vari disegni prospettici del Pogliaghi, sia quelli relativi al suo progetto per la liberazione dei Fori Imperiali, sia gli altri recentissimi della rupe capitolina isolata. Potrebbe procurarmeli? Potrebbe, insieme ad essi, farmi avere quegli altri elementi che possono essere utili allo scopo ad es. la veduta del Piranesi? Sarei anche lietissimo se Lei intervenisse alla riunione ... Io la inizierò leggendo, ed in parte riassumendo, la nostra “Relazione”; ma certo seguirà una discussione a cui sarebbe utile che Lei portasse l’autorità della sua parola ... Spero d’indurre anche Pogliaghi ad intervenire alla seduta»45.
In merito al progetto di sistemazione dell’Aracoeli e della piazza immediatamente sottostante, a lato di piazza Venezia, si scontravano negli anni proposte diverse e Giovannoni, come faceva sapere all’amico Ugo Ojetti ancora nel 1932, era contrario al progetto di Armando Brasini, oltre a nutrire forti perplessità pure verso l’idea dello stesso Ricci, verso il quale non mancava anche una buona dose di sarcasmo46. La stretta collaborazione con il Ravennate impediva, però, all’Ingegnere di esternare chiaramente il proprio pensiero e dunque, la riflessione non poteva che camminare sul filo del rasoio del ‘detto/non detto’.Del resto, era indubitabile che Ricci avesse svolto per tutta l’area dei Fori un’opera meritoria e che la sua sensibilità restaurativa e conservativa contemplasse, in una visione assai ricca e articolati, aspetti architettonici, valenze urbane e percezioni paesaggistiche. Lo dimostrava nella questione del cosiddetto “Pino dell’Araceli”, dopo la caduta rovinosa dell’albero secolare. che aveva privato il colle di un signum di grande qualità pecettiva. E Giovannoni notava:
«La ringrazio di avermi inviato il Suo articolo sul pino definito d’Aracoeli. Era un vero monumento che completava il quadro del Campidoglio tanto quanto lo
ha invece danneggiato l’attività degli uomini moderni; e, a quel che sembra, alla sua morte non è estranea la colpa degli uomini. Mi dicono che da una quindicina di giorni si segnalava l’aumento della sua inclinazione e nessuno se ne è curato; mentre che una puntellatura e un legamento con tiranti avrebbero potuto arrestarlo ed una gagliarda potatura sarebbe riuscita a diminuire il peso strapiombante, ed un lavoro di rinforzo delle radici avrebbe potuto riuscire stabilmente efficace»47.
Si trattava, nell’ottica giovannoniana, di un caso assimilabile a quello di un consolidamento architettonico, come se la struttura organica del pino fosse stato un Monumento costruito.In riferimento ad un altro problema d’Ambientamento, l’Ingegnere mostrava una posizione culturale complessa anche relativamente alla sistemazione della zona del Mausoleo di Augusto. Un contenzioso anche questo vecchio di anni e per il quale le Commissione di Studio erano ormai innumerevoli. Eppure il Professore scriveva a Ricci
«l’Assemblea sociale dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura portando la sua attenzione agli importantissimi temi di Archeologia, di Edilizia, di Arte che hanno per oggetto il Mausoleo di Augusto a Roma ha deliberato la nomina di una Commissione di studio, che inizi indagini e prepari proposte concrete o di immediata o di remota attuazione, che siano di programma organico ai provvedimenti di vario ordine ... La prima riunione presieduta dal senatore Corrado Ricci ... [vedrà la presenza] di Bartoli, Del Debbio, Giglioli, Giovannoni, Guidi, Limongelli, Piacentini, Pernier, Piccinato, Scifoni, Susini, Venturi»48.
E si trattava, poco dopo, di passare alla fase operativa di studio:
«Suppongo che Lei sia ormai tornato dalla gita a Napoli e Le scrivo sia per accompagnare l’invio del mio ultimo volume ... sia per prendere accordi con Lei per l’inizio di quella Commissione per gli studi tecnico-archeologici-edilizi-pratici sull’Augusteo. Rimanemmo d’intesa di tenere la prima riunione alla sede dell’Associazione per scambiare le idee. Vogliamo fissarla?»49.
3. I problemi della formazione di un nuovo ceto di
FERRUCCIO CANALI74
Uffici in attesa di un altro Ministro».50. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40842, lettera ufficiale di Giovannoni a Ricci del 7 aprile 1932. Il catalogo non veniva pubblicato dopo l’uscita di: Architettura minore in Italia, a cura dell’aSSociazioNe arTiSTica Fra i cuLTori di archiTeTTura, Torino, Società Italiana di Edizioni Artistiche, vol.I 1926 (Roma); vol.II 1927 (Roma). Solo nel 1940 si sarebbe avuto il volume III (Lazio e suburbio di Roma, Premessa di g. giovaNNoNi, Introduzione di M. Zocca).51. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40838 di invito ufficiale del “Pro-Direttore” della «R. Scuola di Architettura di Roma», Giovannoni , a Ricci del 3 novembre 1930.52. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40844, cartolina ufficiale d’invito di Giovannoni, pro-direttore della Regia Scuola di Architettura di Roma, a Ricci del 18 novembre 1932.53. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40845, lettera ufficiale di Giovannoni a Ricci del 3 dicembre 1932.54. «Ho ricercato accuratamente nella mia memoria e negli elenchi dei laureati della Scuola d’Ingegneria e della Scuola d’Architettura di Roma, e vi ho trovato un numero enorme di ingegneri e architetti “Rossi”, ma nessun “Paolo”. Per il che non ho proprio nessun modo di darle l’informazione che Lei mi richiede» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40833, lettera di Giovannoni a Ricci del 12 novembre 1929). Ancora nel 1930: «Le presento l’ing. arch. Marino, mio bravo assistente alla Scuola degli Ingegneri, al quale sarebbero utilissimi dati e consigli ella Sua inesauribile competenza. Egli sta svolgendo, come tema pel conseguimento della Libera Docenza, uno studio abbastanza arduo sui rapporti tra Palladio e il periodo Neoclassico. Ma questo periodo è, specialmente in Italia, così poco noto ed illustrato, che ostacoli gli si presentano ad ogni passo e forse Lei solo può rimuoverglieli» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40834, lettera di Giovannoni a Ricci del 4 agosto 1930). E quindi nel 1931: «Lei mi comunica una domanda per uno studente della Scuola d’Architettura, Arturo Poli. Me ne interesserò volentieri quando, nella prossima settimana, i singoli professori porteranno in Consiglio le note di frequenza, positive o negative, degli studenti» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221,
architetti-intendenti: sistema universitario e Accademie romane
Ancora negli anni Trenta, l’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura di Roma mostrava tutta la propria vitalità propositiva, innervata di nuova linfa vitale giunta dai rapporti sempre più stretti, tramite lo stesso Giovannoni, con la Facoltà di Architettura di Roma e con l’Ordine Nazionale degli Architetti (con la gran parte dei Professori della nuova Facoltà e molti dei Dirigenti dell’Ordine professionale, che erano da sempre parte dell’AACAR):
«Le saremmo gratissimi se vorrà onorare della Sua presenza la inaugurazione della mostra di “Disegni illustranti opere architettoniche minori paesane italiane” indetto dal Circolo di Coltura della R. Scuola di Architettura di Roma e accolta nei locali dell’Associazione Artistica dei Cultori d’Architettura»50.
La formazione, del resto, aveva da sempre costituito un imprescindibile capitolo nel rapporto tra Giovannoni e Ricci, dopo che il Ravennate, fin dalla fine dell’Ottocento, si era attivamente occupato dei problemi delle Scuole Tecniche e Professionali (con particolare riferimento a quelle artistiche), delle Accademie di Belle Arti e del loro ordinamento, oltre che della necessità della creazione di nuove Facoltà di Architettura (con la nascita, nel 1919, dell’esperimento ‘pilota’ romano coordinato, tra gli altri, proprio da Giovannoni). Ricci, quasi si trattasse di un ‘nume tutelare’ (al quale a Firenze faceva da parallelo, per la locale Facoltà, Ugo Ojetti), veniva dunque invitato all’inaugurazione dei vari anni accademici della nuova Scuola per Architetti di Roma:
«Sabato 8, sarà inaugurato l’XI anno accademico … con una esposizione – preceduta dalla relazione direttoriale – di progetti e di lavori eseguiti da laureati e dagli studenti durante il decorso anno»51.
Ma, soprattutto, all’
«inaugurazione del nuovo edificio della R. Scuola di Architettura di Roma … inizio di una nuova vita per la nostra istituzione, finora contratta in locali angusti e inadatti; si fornirà dimostrazione anche dei risultati raggiunti nel primo decennio di vita della Scuola, dal cui inizio data la ripresa dell’insegnamento architettonico in Italia»52.
Ovviamente, non poteva mancare il relativo invio, che già spiegava molte cose, di
«una copia del volume “La R.Scuola di Architettura di Roma” edito in occasione della inaugurazione della nuova sede della Scuola in valle Giuria … L’E.V. che così benevolo interessamento ha voluto rivolgere alla nostra Scuola, vorrà, ne sono sicuro, gradire il deferente omaggio»53.
Sempre dall’ambiente universitario, giungevano poi segnalazioni di allievi o di collaboratori valevoli che i due ‘amicissimi’ si scambiavano54: la promozione di giovani validi era un mezzo per far progredire tutto il sistema nazionale.L’Università, nel campo della ricerca e anche della formazione, non era però l’unico ambito dove gli interessi scientifici e professionali di Ricci e Giovannoni avevano modo di interrelarsi. Anche all’interno dell’’associazionismo’ e delle ‘accademie’ romane di altissima levatura nel campo della ricerca, della promozione culturale e anche della formazione, si strutturava un serrato rapporto di scambio. Come all’Accademia di San Luca, che vedeva sempre Giovannoni ricoprire le cariche più elevate e Ricci interessarsi attivamente delle varie problematiche accademiche:
«Sono lieto di parteciparle che le trattative avute con Governatorato di Roma in merito alla nuova sede accademica sono state condotte a termine con piena nostra soddisfazione … La informo che i relativi lavori verranno iniziati nel prossimo settembre e che per tale motivo l’Accademia si trasferirà dal primo del predetto
75GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
n.40839, lettera di Giovannoni a Ricci del 27 maggio 1931).55. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n. 40840, lettera di Giovannoni , in qualità di «Conte Presidente dell’Accademia di San Luca», a Ricci del 20 agosto 1931.56. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n. 40835, lettera di Giovannoni a Ricci dell’8 agosto 1930. Seguiva la lettera ufficiale, a nome di Giovannoni «Direttore dell’Istituto Interuniversitario Italiano», di accompagnamento per l’inoltro dell’ «opuscolo divulgativo con i programmi di Architettura … e quelli del corso che sarà impartito salla S.V. Ill.ma a pag. 29» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40836, lettera di Giovannoni a Ricci del 16 dicembre 1930).57. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n. 40837, lettera ufficiale di Giovannoni a Ricci del 9 agosto 1930. Il programma dei Corsi, previsto tra il 5 luglio e il 5 settembre 1931 vede per “Corsi di Lezioni”: Paribeni prof Roberto, Topografia e arte romana (lezioni 14); Fasolo prof. Vincenzo, Architettura italiana nel Medio Evo e nel Rinascimento (lezioni 14); Giovannoni, prof. Gustavo, La tecnica delle costruzioni romane (lezioni 6); Giannelli prof. Aristide, La Scienza delle Costruzioni applicata all’edilizia asismica (lezioni 10); Piacentini prof. Marcello, urbanistica italiana antica e moderna (lezioni 14). “Conferenze su argomenti speciali”: Ricci prof Corrado, Scenografia italiana (lezioni 2); D’Achiardi prof. Pietro, Il carattere decorativo dell’Arte Italiana (lezioni 3); De Angelis d’Ossat prof Gioacchino (?), Materiali architettonici italiani (lezioni 2); Giovannoni prof. Gustavo, Bramante, Vignola, Palladio (lezioni 3); Picconato prof. Luigi, Il giardino italiano (lezioni 3); Calza Bini prof. Alberto, Il problema delle case popolari in Italia (lezioni 4). “Esercitazioni”: Tognietti prof. Gustavo, Rilievi di monumenti romani antichi o del Rinascimento; Taccuini di impressioni architettoniche italiane. “Viaggi di istruzione”: Milano, Venezia, Vicenza, Verona, Mantova, Bologna, Ravenna, Firenze, Pisa, Lucca. Sienam Orvieto, Perugia, Assisi, Montecassino, Caserta, Pompei, Pesto (20 giorni); “Escursioni”: Monumenti di Roma, Musei ed
mese nel proprio stabile posto in via Tempio della Pace»55.
Ma non mancavano neppure iniziative singole, specie nel campo formativo, coordinate niente meno che da Giovanni Gentile (Presidente e Giovannoni, direttore) nell’ambito di un programma di internazionalizzazione della cultura architettonica italiana attraverso l’«Istituto Interuniversitario Italiano». Nel 1930, l’Ingegnere anticipava a Ricci che
«Riceverà una mia lettera ufficiale che, anche a nome del senatore Gentile, la prega di voler tenere nell’anno venturo un paio di conferenze (e magari fossero di più) nel “Corso estivo del 1931 per stranieri” … Trattasi di chiamare in Roma i giovani architetti americani a studiare la nostra architettura, togliendoli dall’influenza della Francia e riportandoli alle fonti di una tradizione che, in fondo, essi non hanno mai abbandonato; ed occorre perciò che l’autorità dei nomi e l’importanza dei temi siano tali da attrarli veramente»56.
Il “Programma” era molto serrato, quasi in una sorta di “Prix de Rome” americano:
«L’istituto Interuniversitario Italiano, fra i corsi per stranieri e connazionali che si svolgeranno in Italia nel 1931, istituirà alcuni corsi di “Architettura Italiana per Stranieri”, diretti soprattutto a Nord Americani. Da molti anni, la tradizione nord americana manda i più promettenti e attivi studenti di Architettura in altre nazioni, presso le quali l’Architettura Italiana è conosciuta attraverso immancabili deviazioni e alterazioni volute o involontarie; imbevuti di tali insegnamenti preconcetti, questi giovani tornano in Patria, architetti professionisti di una grande nazione di centoventi milioni di abitanti, in pieno sviluppo etnico, edilizio ed artistico. Così all’Estero e particolarmente negli Stati Uniti, si ignora o si nega ogni nostra attività creatrice nel campo dell’architettura o ci si crede dei mediocri cultori ed imitatori del passato. È invece necessario che, trasmettitori naturali di una viva influenza italiana, siano gli italiani stessi e che un complesso e
organico movimento si inizi e venga perfezionandosi … Appare perciò evidente l’importanza dell’iniziativa dell’I.I.I. che ha recentemente costituito e convocato un apposito Comitato composto dall’on. Giovanni Gentile, Presidente dell’Istituto stesso, da S.E. il prof. Marcello Piacentini, Accademico d’Italia, dall’on. Alberto Calza Bini, Segretario Nazionale del Sindacato Architetti, dal prof. Gustavo Giovannoni, Direttore della Scuola di Architettura di Roma … A Lei è affidato un ciclo di n.2 conferenze di “Scenografia Italiana”»57.
La Storia della Scenografia teatrale era un ambito che aveva visto molto attivo Ricci, considerato internazionalmente una vera Autorità scientifica al proposito.
4. Partecipazione alla vita pubblica: il coinvolgimento negli organi di Tutela dei Monumenti presso la sezione “Antichità e Belle Arti” del Ministero della Pubblica Istruzione
La «partecipazione alla vita pubblica» costituiva, per la vita dei Monumenti, del loro studio, della loro tutela e del loro restauro, un aspetto imprescindibile che accomunava sia l’opera di Ricci sia quella di Giovannoni, usualmente consonanti per le cosiddette ‘questioni di principio’. Il Ravennate, per quanto poteva, non mancava di riconoscere pubblicamente il valore dell’attività di Giovannoni e non mancava, dunque, di fargli conseguire pubbliche onorificenze (come quella dell’Ordine Mauriziano), come sottolineava lo stesso Ingegnere:
«Da casa mi mandano la lettera ministeriale che mi annuncia come i SS. Maurizio e Lazzaro mi abbiano accolto tra le loro larghe braccia ... Non ufficialmente le scrivo per ringraziarla. La gioia per l’onorificenza sarebbe di per sé non grandissima (glielo confesso), se non vedessi nell’iniziativa che l’ha mossa un benevolo riconoscimento della buona volontà e dell’affetto per l’Arte che mi pongo in tutta la mia opera e in particolare per quella che svolgo per l’Amministrazione delle Belle Arti; e questo mi fa vivo piacere e per questo Le sono
FERRUCCIO CANALI76
Edifici moderni; Ostia, Frascati, lago di Nemi, Tivoli e Villa Adriana, Viterbo, Orvieto».58. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16779, missiva di Giovannoni, da Montecatini, a Ricci del 24 giugno 1917 . Ricci era «Cavaliere dell’ordine dei s.s. Maurizio e Lazzaro» dal giugno 1897 e poi «Commendatore dell’Ordine» dal maggio 1911.59. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16819, missiva di Giovannoni a Ricci, s.d., (ma 1925 ca.) sulla tutela dei «paesaggi architettonici» minacciati, come la Villa Aldrobandini a Roma .60. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16779, missiva di Giovannoni, da Montecatini, a Ricci del 24 giugno 1917.
davvero riconoscente»58.
4.1. L’aggiornamento della Legislazione Nazionale (1917): questioni di Restauro ‘estetico’ e di ‘prospettiva’ (a precedere l’ articolo 22 della Legge 1089/1939 e le «visioni» della Legge 1497/1939)
Un caso specifico forniva la misura della inadeguatezza delle legislazione vigente ancora negli anni Venti in relazione alla salvaguardia dei Monumenti, dopo che per la Legge 364 del 1909 erano stati stralciati gli aspetti «paesaggistici». Giovannoni e Ricci contribuivano affinché si corresse ai ripari:
«Dopo vista “la Tribuna” di iersera, ho ripensato a quanto dicemmo ieri a proposito della Villa Aldobrandini. Mi pare opportuno che martedì, nella prossima Assemblea dei Cultori d’Architettura, se ne parli e si emetta il voto che speciali provvedimenti legislativi, se occorono, salvino questo e altri importanti ‘paesaggi architettonici’. Il voto, secondo l’opportunità, potrà rimanere clandestino oppure essere lanciato per la stampa a mostrare che gli artisti appoggiano l’azione della Direzione Generale d’Antichità e Belle Arti e non si disinteressano di una così vitale questione. Non Le pare?»59.
Le occasioni erano però numerose e dopo il 1909, la Legislazione nazionale e l’aggiornamento di essa, diveniva argomento di riflessione e di confronto, in modo da procedere ad un affinamento dell’attività di Tutela:
«L’altro giorno ho spedito al collega Pittarelli quello che potrebbe dirsi il secondo capitolo della Relazione sulla “Prospettiva dei Monumenti”. Come Le accennai infatti la relazione Pittarelli è una bellissima trattazione sulla prospettiva, ma quando giunge alla sua applicazione al celebre art.14 della Legge, casca giù come fa la via dei Serpenti avanti al Colosseo ... Per quanto quindi avessi tutta la buona intenzione di tenermi da parte, ho visto la necessità, per giungere ad un risultato veramente utile ed efficace, di completarla e ristabilire l’equilibrio. Spero di esserci riuscito e spero che tra pochi giorni Le giungerà questo lungamente maturato frutto degli studi dei Cultori d’Architettura»60.
4.2. I Monumenti e l’’esperimento’ ricciano di Roma: la concertazione tra la politica di Tutela nazionale e quella comunale dalla «X Sezione», dalla Podesteria ai poteri del Governatorato
Per Ricci - che aveva avviato fin dal 1897 una riforma
interna del sistema della tutela nazionale fino alla istituzione delle Soprintendenze nel 1909 – Roma costituiva un singolare campo di sperimentazione per sondare le possibilità organizzativo di un sistema di Tutela nazionale e comunale, incentrate sull’interazione tra «Sezioni speciali» e poteri eccezionali.La vita politica attiva vissuta in prima persona, nel caso del Ravennate, aveva dunque una forte influenza sulle dinamiche della riflessione sui Monumenti e così Giovannoni non poteva che congratularsi con Ricci per la sua nomina nella Giunta comunale di Roma come Assessore, dopo la vittoria elettorale:
«Mille congratulazioni per la bella e onorata vittoria: la quale mostra, tra l’altro, nella significativa graduatoria dei voti, quanto il corpo elettorale, il popolo cioè, sia migliore dei piccoli politicanti che vogliono guidarlo e che lo obbligano a votare nella stessa lista i nomi di Ricci, di Caetani, di Gentile, e quelli di noti usurai, di settari di mestiere, di speculatori sui viveri. ... A lei ricorreremo per tutte le questioni che riguardano l’Arte, i monumenti, il carattere di Roma, per tutti gli interessi di un suo sano sviluppo edilizio che l’Amministrazione Comunale deve con tutta energia promuovere. E Lei a sua volta troverà sempre in noi [dell’Associazione dei Cultori] collaboratori ferventi e attivi, liberi da pastoie burocratiche: dei buoni operai dell’edilizia, dell’arte, che lavorano cantando»61.
Ancora qualche anno dopo, quando Ricci era ormai stato nominato Senatore del Regno (dal 1923 al 1934), il problema dell’organizzazione della Podesteria di Roma ritornava con grande evidenza e così, facendo tesoro dell’esperienza acquisita come Assessore, il Ravennate prospettava a Giovannoni le sue intenzioni riguardo alle riforma da apportare all’istituzione podestarile, attraverso il Governatorato:
«Spero col Governatorato di Roma sia giunta un’era benefica per la salvezza artistica di Roma. Durante i quattordici anni nei quali ho tenuta la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti e i tre in cui ho retto l’Assessorato Municipale delle Belle Arti, ho veduto che le incertezze, le contraddizioni, i guai dello sviluppo attorno nei riflessi dell’Arte e dell’Archeologia e dell’edilizia, sono derivati dalla molteplicità degli Uffici che direttamente o indirettamente si debbono occupare di quelle cose. Invece che un ufficio che tutto coordini, se ne hanno quattro o cinque e tutti e quanti lavorano indipendentemente, spesso in contrapposizione e spesso quindi ai danni di Roma, dove i massacri sono stati gravi e forse erano evitabili. La Sovrintendenza ai Monumenti, l’Ufficio del Piano Regolatore, quello d’Edilizia, l’Ufficio Comunale di
77GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
61. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16783, missiva di Giovannoni a Ricci del 4 novembre 1920.
62. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16804, minuta di Ricci per una lettera a Giovannoni.
63. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16806 missiva di Giovannoni a Ricci del 15 ottobre 1925.
64. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16806 missiva di Giovannoni a Ricci del 15 ottobre 1925.
65. «Può convocare Lei quella Commissione ... oltre al Foschini ed a me ci sono Manfredi e il D’Achiardi (nell’assenza di
Belle Arti lavorano senza che l’uno sappia dell’altro, con ideali diversi e con metodi diversi ... Avvengono talora cose gravi e ad un tempo comiche ... Il Municipio indica nel Piano Regolatore come demolenda una casa e la Sovrintendenza la notifica per importante interesse: ossia il primo dice che si deve abbattere, il secondo che non si può toccare. Il proprietario perciò si dispera e dileggia. È indispensabile creare il Governatorato, creare finalmente per Roma (si tratta della città archeologicamente e artisticamente più complessa del mondo) un Ufficio d’Arte unico, che assorba quei quattro o cinque uffici discordanti. Un Direttore di prim’ordine e un Consiglio consultivo elettissimo . E l’assicuro che Roma sarà, per quanto ora è possibile, salva. Verso il 12 settembre io sarò a Roma e, se crederà, io verrò a trovarla a casa»62.
Giovannoni, dal canto suo, poteva avanzare alcune utili puntualizzazioni:
«Combattere bisogna! ... [Volevo sottoporle] la questione che fa capo al nuovo ordinamento del Governatorato di Roma. Sembra che in esso si siano in gran parte attuate le Sue idee della unità nelle funzioni edilizie e di difesa dei monumenti; e sta bene. Ma tanto più diviene essenziale la buona scelta delle persone, quando gli organi di difesa o di iniziativa divengono più agili e semplici; altrimenti potremmo trovarci di fronte a guai irreparabili, che ora talvolta la molteplicità e le lungaggine burocratica allontanano per forza d’inerzia»63.
Giovannoni, da buon romano, mostrava di conoscere bene le pieghe di quella burocrazia, che può scoraggiare, ma anche salvare: decisioni prese da un unico organo funzionano se l’organo è sano, ma se è infetto, non ci sarà altro potere che potrà contrastarne gli effetti perniciosi. Dunque
«Se lei quindi potesse a tal uopo riprendere contatto col ministro Federzoni potrebbe compiere opera provvida di suggerimento. Io vedrei necessaria che nella scelta dei Consultori si desse larga parte ai rappresentanti di enti artistici e culturali (Accademia di San Luca, Cultori d’Architettura, Società degli Ingegneri, Associazione Archeologica, Società Romana di Storia Patria, Sindacato degli Architetti, Associazione Artistica Internazionale, ecc); e vedrei necessario che uno dei Rettori, cioè dei Vice-Governatori, avesse specifico e pieno incarico della Edilizia, dell’Arte, dei Monumenti. Quale persona si potrebbe suggerire? Le dichiaro subito che io sarei inadattissimo, sia pel mio carattere, che mi porterebbe a dare le dimissioni dopo due giorni, sia per la mia apoliticità, e per le mie occupazioni e per la mancanza di appariscenti qualità rappresentative, e per le condizioni di stanchezza e di sconforto che
traverso ... La persona invece che vedrei perfettamente a posto sarebbe l’arch. Alberto Calza Bini, l’attuale Presidente dell’Associazione dei Cultori: uomo di cultura, di rettitudine, di energia, di tatto; fascistissimo, ma non settario, circondato dall’autorità che gli deriva dai grandissimi risultati raggiunti nella Presidenza dell’Istituto per le Case Popolari. Appresso a lui, ma molto dopo, vedrei il nostro dolcissimo Giglioli ... Che l’uno e l’altro siano giovani non è, mi pare, un male. Certo se nella conversazione il ministro Federzoni la interrompesse e le dicesse che l’unico nome possibile è quello del senatore Ricci, non farebbe altro che ritrovare il buon senso che talvolta le vicende del partito gli hanno fatto perdere. Ma non so quanto ne sarebbe contento Lei!»64.
Nodale restava, però, per il rapporto tra tutti gli Enti che si occupavano della Tutela e del Restauro dei Monumenti, il ruolo della Direzione Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione; e, dunque, alla difesa, alla valorizzazione e al potenziamento di essa Ricci e Giovannoni si dedicavano con cura particolare.
4.3. Il rinnovo della “Direzione Antichità e Belle Arti” del Ministero della PubblicaIstruzione: il ‘problema dei problemi’ nella politica italiana della Tutela (1925-1928)
I problemi principali, per una seria azione nazionale di Tutela dei Monumenti, si ponevano soprattutto per la Direzione Generale delle “Antichità e Belle Arti” del Ministero della Pubblica Istruzione, dalla quale Ricci era uscito nel 1918, dimettendosi dal ruolo di Direttore Generale, ma nella quale egli ‘rientrava’ più o meno ufficialmente, tra il 1923 e il 1934, come Senatore del Regno, in qualità di ‘nume tutelare’ delle questioni d’Arte. Giovannoni non poteva non denunciare a Ricci la situazione generale di malessere65:
« Molto grave è … la malattia della Direzione Generale e del ministro Fedele, di cui Lei mi scrive. La malafede del Colasanti e la insipienza del Fedele in fatto di questioni d’Arte fanno un bel paio! Una ventina di giorni fa io parlai al Fedele della necessità di elevare il grado e l’importanza della Commissione Centrale; e poi, a sua richiesta, gli inviai a casa un promemoria delle principali proposte. Come vede, il risultato è stato felicissimo! Subito dopo è venuta la riunione della Commissione ‘Ciarlantina’. E ricordo che alcune sere fa mio nipote, con la cuffia del Radiotelefono in testa, ascoltava il discorso tenuto con roboante eloquenza dal Ministro alla Commissione, e mi domandava “come mai tu stai qui?”. Anch’io ora non so vedere rimedi efficaci a tutelare non tanto noi, quanto gli interessi, la disciplina, il decoro di ciò che riguarda le povere Belle Arti; perché ogni nostra azione finirebbe a sboccare nelle dimissioni,
FERRUCCIO CANALI78
Canonica)?»: B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n. 16809, missiva di Giovannoni a Ricci del 24 ottobre 1926 .66. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16798, missiva di Giovannoni a Ricci, del 9 agosto 1925, L’«amico Colasanti» del 1910 circa (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16772 ) era ora diventato persona «in malafede». E, ancora, anni dopo: «Parleremo di molte faccende che c’interessano, comprese talune malefatte postume colasantiane che mi pare rasentino il Codice Penale» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40833, lettera di Giovannoni a Ricci del 12 novembre 1929).67. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16799, missiva di Giovannoni a Ricci del 20 agosto 1925.
che in questo momento non sarebbero opportune. Forse un suo articolo sulla “Nuova Antologia”, che chiaramente e serenamente riassumesse i problemi artistici attuali e dimostrasse la necessità di creare gli organi adatti, potrebbe intanto essere utile per mettere le cose a posto e fare udire la nostra voce»66.
In verità, si auspicava una riforma radicale, che vedeva in Giovannoni e Ricci tra i massimi promotori, per cercare di riportare le decisioni – e il valore vincolante che esse ponevano – al centro dell’attività della Direzione Generale, nell’ormai ondivaga successione dei momenti di maggiore o di minore efficacia dell’attività di Tutela:
«Io sto per partire per Pescasseroli (L’Aquila) dove mi tratterò 5 o 6 giorni. Mi scusi quindi se rispondo affrettatamente e incompletamente. Non ho potuto vedere il Ministro, che è fuori Roma; ma finalmente alla Direzione Generale ho potuto trovare qualcuno, il Parpagliolo. Gli ho parlato a lungo e senza ambagi, sia delle questioni e delle campagne in corso, sia dell’esautoramento ufficiale che tende a farsi della nostra Commissione Centrale, ed a cui le proteste, indirettamente o direttamente, si riannodano. E gli ho dichiarato che noi non siamo disposti a fare la parte della testa di turco, a disposizione della Direzione Generale per togliersi noie e responsabilità. Mi ha assicurato che per la questione di Venezia avrebbe scritto al Fogolari di dare comunicazione alla stampa e al Comune del nostro voto e della sua portata. Mi ha detto che il Ministro ha espresso il desiderio di tornare al Consiglio Superiore e di aumentargli importanza e prestigio; e che egli verrà presto da Lei per domandarLe parere su questo nuovo Ordinamento e sul Regolamento interno da prepararsi pel Consiglio, poiché ritiene anche lui illogica e illegale la procedura attuale con cui le questioni si presentano. Gli ho esposto anche in questo le mie idee: necessità che il Presidente della Commissione prepari l’ordine del giorno e disponga il modo di svolgimento; e poi riferisca direttamente al Ministro, commentando il lavoro compiuto: necessità dei referendari che preparino regolarmente le pratiche; necessità della inaugurazione ufficiale delle sessioni, della presenza del Direttore Generale, delle Commissione regolari alla stampa, della pubblicazione delle Relazioni sul “Bollettino”; necessità che i principali problemi di direttive artistiche vengano al Consiglio Superiore ... Sono, del resto, le idee che ho già esposto, a voce e per iscritto, al Ministro. Ma ci crede Lei? Io no! Orazi le manderà i voti per Villa Aldobrandini»67.
Una serie di missive si susseguivano al proposito nel giro di neppure un mese, in modo che alla riapertura dell’attività consultiva, nell’ottobre, Giovannoni e Ricci potessero presentarsi al Ministro con proposte ben
strutturate. Lo sottolineava l’Ingegnere:
«Paribeni ed io siamo (è quasi superfluo ripeterlo) pienamente d’accordo con Lei nel ritenere le condizioni attuali in cui si svolge l’opera della Commissione Centrale sgradevoli per tutti noi e tali da ostacolare un vero lavoro proficuo; e lo siamo altresì nel desiderare vivamente di allontanarcene. Ma quanto all’opportunità di dare ora le dimissioni, pur con quella formula giusta e chiara che Lei propone, desideriamo esporle alcune considerazioni. In certe questioni non basta essere d’accordo con la propria coscienza, ma occorre anche rendersi conto delle conseguenze nel pensiero e nell’azione degli altri, e più specialmente nei commenti in mala fede che possono muovere i commenti in buona fede [per Giovannoni era la saggezza del politico navigato: vero o solo detto significano la stessa cosa per molti]. Ora si dirà: “proprio al momento in cui la Commissione Centrale sta per ritornare a maggiore importanza e a funzione più vasta e regolare, questi signori se ne vanno?”. E si dirà anche: “Di che cosa si dolgono? In tutte le manifestazioni ‘ufficiali’ del Ministero negli ultimi tempi, e specialmente negli ultimi attacchi, la solidarietà ed il riguardo verso la Commissione Centrale (apparentemente) non sono mancati”. E si citeranno comunicati ufficiali e lettere e voti. Ma più di tutto si farà dire: “le dimissioni sono conseguenza necessaria degli ultimi errori e delle campagne della stampa. Questi signori hanno finito a comprendere che la loro posizione era insostenibile dopo i reati commessi con l’esodo del Tiziano, la sopraelevazione della casa sulla Riva degli Schiavoni e magari anche il deturpamento delle fonti del Clitumno!”. A noi pare che debba per ora tenersi altro viaggio; cioè quello di prendere noi l’iniziativa delle riforme della Commissione Centrale, come del resto io personalmente ebbi a fare due o tre mesi fa, ad acque chete, con un Memoriale al Ministero. O riusciamo ad ottenere che il Ministro ci convochi per sottoporci lo schema di nuovo Ordinamento e di nuovo Regolamento preparato; oppure ci riuniamo una volta tanto da noi e mandiamo una Relazione al ministro e comunichiamo alla stampa un sunto delle nostre proposte. Io parlai, come Le scrissi, al Parpagliolo nel senso della prima soluzione, quello cioè della discussione da parte nostra della proposta del Ministero. E in questo senso insisteremo vivacemente Paribeni ed io presso il ministro Fedele»68.
Così si procedeva, a stretto giro, alla preparazione di una Relazione di modifica approntata dai membri ‘tecnici’ della Commissione:
«Ho fatto copiare la Relazione; ma ho pensato che sarebbe più opportuno e riguardoso ed efficace, anziché spedirla per la posta, consegnarla personalmente al
79GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
68. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16800, missiva di Giovannoni a Ricci, del 27 agosto 1925.
69. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16801, missiva di Giovannoni a Ricci, s.d. ma di pochi giorni successiva alla precedente n.16800.
70. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», La “Relazione” definitiva (n.16802) è allegata alla missiva di G. Giovannoni a Corrado Ricci, del
Ministro dandogli tutti i chiarimenti che richiederà. Rappresenterebbe questo l’inizio di quei rapporti diretti tra Ministro e Presidente della Commissione che noi desideriamo, non Le pare? Faccia in ogni modo Lei ciò che crede meglio. Voglia dare un’altra occhiata alla copia che ho riveduto sommariamente»69.
E infine:
«eccole finalmente il libro e le proposte pel Consiglio Superiore. Domani sera io parto e starò qualche giorno fuori Roma. Vuol farmi il favore di provvedere Lei ad avvertire Paribeni e gli altri?»70.
Si trattava, insomma, di una sorta di ‘fronda interna’ nei confronti della Politica, ma tutti erano concordi che la Commissione tecnica dovesse ritornare al centro del momento decisionale. La Relazione prevedeva infatti che:
«La Commisisone Centrale per le Antichità e Belle Arti ritiene opportuno trarre dall’esperienza triennale alcune proposte di rinnovamento e di riforma nella sua costituzione nel suo rinnovamento. Essa è convinta che, nel grave momento che l’Arte e il patrimonio artistico ed archeologico italiano traversano, , sia più che mai necessario rendere adeguato allo scopo l’organo primo della competenza tecnica ed artistica nel campo delle Antichità e delle Belle Arti, ed aumentarne il prestigio e l’autorità in modo da attribuirgli nella coscienza del Paese un grado non inferiore a quello degli altri consessi dello Stato e disciplinarne la procedura specialmente nelle sue funzioni giurisdizionali».
Le indicazioni erano dunque molto puntuali:
«Tali proposte che i sottoscritti si pregiano sottoporre all’E.V. sono le seguenti:1. Nei riguardi dell’importanza e della figura stessa della CommissioneRitorno al nome ed alla tradizione del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti. Attribuzione ad esso non solo delle funzioni giurisdizionali assegnategli dalla Legge, ma altresì di quelle riguardanti le principali questioni generali relative all’Arte e al patrimonio archeologico ed artistico (quali ad esempio l’ordinamento degli insegnamenti d’arte, i criteri da seguirsi nei principali restauri di monumenti, negli scavi e nelle raccolte d’Arte, l’esame dei Piani Regolatori delle città, le eventuali nuove disposizioni a riforma della legislazione artistica, ecc.); il parere sugli acquisti, quando questi superino l’importo di 10.000 lire ed, in casi speciali, quello su temi e quesiti singoli, su cui già si siano pronunciate le R.Sovrintendenze e le Commissioni provinciali ed eventualmente abbiano riferito gli Ispettori Onorari locali».
Delicatissimo, poi, il problema dell’individuazione e delle nomine dei componenti:
«2. Nei riguardi della costituzione del rinnovamento dei componentiNumero portato a 11 membri, invece dei 5 attuali, senza divisioni prestabilite in diverse sezioni ma con facoltà di costituire, a volta a volta, alcune sotto-commissioni per lo studio di singoli problemi speciali. La Giunta per le Bellezze Naturali s’identificherebbe col Consiglio stesso, non sembrando una riduzione di numero dei componenti opportuna per l’importanza e lo speciale carattere delle questioni che alla recentissima Legge fanno capo. Facoltà di aggregarsi per speciali questioni, esperti senza diritto di voto, ovvero di avere nei vari centri alcuni corrispondenti. Rinnovamento quinquennale per nomina ministeriale di circa la metà dei componenti del Consiglio, la prima volta di 6 per sorteggio, e quindi degli altri alternativamente per anzianità».
La necessità di un Regolamento univoco veniva fortemente avanzata da Giovannoni:
«3. Nei riguardi del funzionamento e del Regolamento internoIstituzione di due sessioni annuali inaugurate da S.E. il Ministro e ordinariamente presiedute in sua vece dal Vice Presidente, al quale spetta di rappresentare S.E. il Ministro, di convocare le sedute e prepararne gli ordini del giorno, di prendere all’uopo gli accordi con la Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti, di riferire sul lavoro compiuto. Costituzione di un ufficio del Consiglio Superiore con un Segretario e due Ispettori referendari. Regolare istruzione e preparazione delle singole pratiche. Nomina preventiva, da parte del Vice Presidente, d’un relatore per le principali di esse od eventualmente di una sotto Commissione. Presenza alle sedute del Consiglio del Direttore Generale per le Belle Arti. Parere scritto da unirsi in tutti i casi agli atti, dei Regi Sovrintendenti, delle Commissioni provinciali (nei casi in cui il parere ne sia stato richiesto) o del Direttore Generale per le Belle Arti. Riferimento ad una procedura già stabilita per un magistrato amministrativo (quale ad es. il Consiglio di Stato) per l’esame, la trattazione, la discussione, la sentenza nei ricorsi presentati al Consiglio, e per negli accessi eventualmente stabiliti con l’intervento delle parti.Pubblicazione nel “Bollettino d’Arte” del Ministero della P.I. dei deliberati e dei voti del Consiglio (salvo in quei casi speciali in cui questi li ritenesse non ancora definitivi), dei discorsi di S.E. il Ministro nella inaugurazione delle sue sedute, delle principali relazioni dei componenti del Consiglio e degli altri esperti da esso chiamati, eventualmente delle “Istruzioni”, degli studi speciali che il Consiglio, d’accordo con la Direzione Generale, intendesse promuovere»
FERRUCCIO CANALI80
14 settembre 1925, vol.88, n.16803.71. Relazione allegata alla missiva precedente, indirizzata al Ministro P.I., vol.88 n.16802.72. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16806, missiva di Giovannoni a Ricci, del 15 ottobre 1925. Il Comunicato stampa venne diramato fatto poiché è presente nel «Fondo Ricci» come lettera n.16803 bis, anche se fuori posto il sunto della Relazione, che venne consegnato alla stampa e pubblicato come “Cronache per l’Arte Italiana” a firma oltre che di Ricci, Giovannoni e Paribeni, anche di Pietro Canonica e Adolfo De Carolis.73. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40829, missiva di Giovannoni (e gli altri membri del Consiglio Superiore: Roberto Paribeni, Marcello Piacentini e altri) a Ricci, del 4 ottobre 1928.
Un quarto punto faceva riferimento al rapporto tra Enti:
«4. Nei riguardi dei rapporti con altri Enti superioriFacilitazioni, mediante accordi tra i vari Ministeri, alle intese tra il Consiglio Superiore delle Belle Arti ed altri consessi per la trattazione utile di questioni di comune interesse; come ad esempio, col Consiglio Superiore LL.PP. per opere architettoniche e monumentali, per pareri riguardanti piani regolatori edilizi, costruzioni e concessioni che interessino le bellezze naturali ecc, col Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l’insegnamento artistico superiore; col Ministero delle Colonie pei provvedimenti relativi a monumenti, scavi, raccolte fuori d’Italia; col Consiglio di Stato per l’applicazione delle Leggi sul patrimonio artistico e sulle bellezze naturali ecc. Intervento in tali casi ad referendum del relatore per chiarire i criteri e definire i rapporti e coordinare i deliberati. Firmato Corrado Ricci, Gustavo Giovannoni e Roberto Paribeni»71.
In quest’ultimo caso echeggiavano le idee di Ricci sul coordinamento tra Enti e, sostanzialmente, si prefiguravano delle “Conferenze di Servizi” tra i vari rappresentanti per dirimere le questioni più spinose. Il documento finale di proposta, datato 13 settembre 1925 e inviato al Ministro P.I. (lettera n.16802) veniva firmato da Ricci, Giovannoni e Roberto Paribeni. Il ferro andava battuto in breve e, così, qualche tempo dopo l’Ingegnere tornava alla carica con Ricci:
«Combattere bisogna! Eccomi a parlarle di due mosse strategiche che mi sembrano necessarie. La prima si riferisce alle nostre proposte pel rinnovamento del Consiglio Superiore. Si era rimasti d’intesa che subito dopo la comunicazione ufficiale al Ministro se ne sarebbe dato un riassunto a qualche giornale, per prendere posizione e per dimostrare che l’iniziativa è nostra. Non crede ormai opportuno di farlo?»72.
La collaborazione si protraeva negli anni e Ricci – ‘Senatore delle Belle Arti’ - restava una sorta di ‘faro’ per le questioni della Direzione:
«La Giunta del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, riunita per la prima volta dopo le vacanze estive, rivolge un devoto ed affettuoso pensiero al suo Presidente, e confida che non voglia da Lui essere negato l’amichevole aiuto e il consiglio illuminato che essa verrà a chiedergli nei casi più importanti e difficili»73.E Ricci rispondeva prontamente offrendo la propria disponibilità:
«Grazie dal cuore per la gentilissima lettera scrittami. La loro cultura ed esperienza sono ben lontane dall’aver bisogno dei miei aiuti, ma se si crede che in qualche caso particolare io possa giovare in qualche forma con qualche informazione o parere, sarò ben felice di corrispondere ai loro desideri»74.
4.4. Prodromi per la fondazione dell’“Istituto Centrale del Restauro” e per la ‘scientificizzazione’ (archeometrica) della pratica restaurativa (1930)
La necessità di fornire alla disciplina del Restauro un approccio sempre più scientifico, nell’ottica del cosiddetto «Restauro filologico» sia di Giovannoni, sia di Ricci, non passava unicamente attraverso un approccio storico-umanistico che facesse proprie le istanze metodologiche delle cosiddette ‘Scienze esatte applicate’; si trattava anche di strutturare l’indagine e la raccolta delle fonti materiche e materiali attraverso ricerche che applicassero quelle stesse ‘Scienze esatte’ nella fase dell’esegesi dei dati, e non solo dal punto di vista metodologico. Un’ottica scientista e positivistica, che anticipava le sensibilità archeometriche. Così, un Giovannoni trionfante annunciava al Ravennate:
«Apprendo ora, e ne son lieto, che sta per essere attuata la idea, che io da anni sostengo, per lo studio scientifico dei tanti temi della conservazione e del restauro dei monumenti, di dipinti, di oggetti d’arte, mediante una Commissione di esperti; e suppongo che Sua sia stata l’iniziativa, poiché mi par difficile che senza nessuna spinta il nostro buon Paribeni abbia potuto trovare l’energia e il coraggio per nominare una Commissione. Se però il numero ed i nomi dei componenti che mi hanno comunicato sono esatti, parmi che ci sia qualche lacuna che sarà facile colmare ... Il fisico e il chimico, cioè il Cialdea e l’Helbig, si trovano ambedue nelle condizioni di non avere nessun grande laboratorio, nessun istituto a cui far capo nelle loro ricerche. Credo quindi che sarebbe necessario porre loro accanto alcuno della scienza ufficiale che in Italia non è che la universitaria: ad esempio il Parravano per la Chimica, il Bordoni per la Fisica Tecnica. Manca poi chi si occupi della tecnologia costruttiva, cioè un ingegnere o un architetto; ed è mancanza grave perchè toglie il rapporto tra la teoria e la pratica. Bisognerebbe perciò rimediarvi includendo un altro nome. Quale? Forse il Milani, ed il Passarelli od il Giannelli o l’Astorri od il Chierici ... Non certo quello del sottoscritto, se non altro pel fatto di questa segnalazione»75.
81GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
Un battaglia che i due ‘amicissimi’ combattevano da anni dunque, per la ‘scientificizzazione’ del Restauro e che, nel 1930, sembrava essere vinta; ma della quale Ricci, morto nel 1934, non avrebbe visto i frutti, compiutisi solo nel 1939 con l’avvio dell’”Istituto Centrale del Restauro” («Regio Istituto del Restauro») dipendente dalla Direzione Antichità e Belle arti del Ministero della Pubblica Istruzione e fondato da Cesare Brandi e Giulio Carlo Argan76 per incarico del ministro Giuseppe Bottai.
5. Questioni salienti di Tutela e Restauro dei Monumenti alla luce del «Restauro filologico» di Ricci e di Giovannoni
Oltre agli studi e alle questioni generali connesse alla Tutela, c’erano, poi, tutta una serie di casi specifici per i quali, per motivi di partecipazione alla vita pubblica o per incarichi della Direzione delle “Antichità e Belle Arti”, i due amicissimi venivano chiamati a fornire il loro operato scientifico. Del resto, nella visione giovannoniana fin dal 1910 il magistero di Ricci risultava imprescindibile, dopo l’esperienza della ‘Soprintendenza pilota’ di Ravenna del 1897:
«I restauri dei monumenti ravennati sotto la Sua guida compiuti … rappresentano un modello insuperato e d’interesse capitale per gli architetti di ciò che debba essere una restituzione architettonica»77.
E in quella definizione di «restituzione» erano impliciti significati e valori che intendevano distaccarsi dal consueto «ripristino in stile».Per i casi specifici verificatisi nel corso del ventennio successivo a quel 1910, non siamo sempre in grado di riconoscere i singoli interventi, ma ci furono delle situazioni che dovettero, rispetto ad altre, coinvolgere maggiormente il magistero giovannoniano e i consigli di Ricci. Come per la famosa abbazia benedettina di Nonantola78. Si trattava, ad ogni modo, di battaglie lunghe e, soprattutto, il più delle volte senza speranza di vittoria definitiva. Le vibranti proteste e le Reazioni di Giovannoni si susseguivano nelle singole situazioni e a Ricci toccava, spesse volte, moderarne i termini come sottolineava l’Ingegnere stesso:
«Son tornato a Subiaco ed ho visto lo scempio che stanno eseguendo. Al solito, arriviamo tardi, a caso disperato, ma forse mai ho visto una infamia simile. Per questo Le proporrei [nei documenti della Commissione AA.BB.AA:] di ripristinare nell’ordine del giorno almeno alcune delle frasi forti che ci avevo messo. Rinunzio alla “vergogna”, ma mi lasci la “deturpazione”»79.
In altri casi si trattava di organizzare sopralluoghi per poi decidere il da farsi:
«Quanto a Terni, le cose stanno così. L’incarico a Grassi e a me di andarci per vedere i lavori del San Francesco è stato dato non nel gennaio scorso, ma una ventina di giorni fa. Intanto io ho parlato della cosa con Bertini Calosso [il Soprintendente dell’Umbria] ed ho bene identificato il quesito, che è abbastanza interessante. Nell’abside c’è, completa, una finestra bifora a cui è stato, nel chiuderla, sovrapposto all’interno un altare settecentesco, non brutto, di stucco. Prima di decidersi tra bifora e altare, io vorrei provare ad avere l’una e l’altro tagliando e distaccando accuratamente lo stucco e ricomponendolo altrove. Ma per decidere questo non basta una semplice occhiata in una breve visita di due Commissari. Ho detto pertanto al Bertini che porti con sé un bravissimo stuccatore e che gli faccia studiare la cosa e fare un preventivo. Poi, se occorrerà, arriveremo noi»80.
Firenze, oltre che per gli studi, si mostrava imprescindibile dal punto di vista dell’esecuzione di restauri o per problemi di conservazione:
«Non ho mantenuto la promessa di scriverle perchè il telegramma inviatole dal Gamba ha reso inutile la mia lettera. Delle altre faccende fiorentine, il parco di Vincigliata, i bussolotti della Loggia dei Lanzi, parleremo più compiutamente al mio ritorno»81.
Le integrazioni dovevano essere molto ben ponderate:
«Quanto alla chiesa scorata (senza coro) è quella di Osimo. Il Costantini mi ha fatto domandare da suo figlio dove avrebbe potuto trovare un tipo di coro “del tempo”. Io gli ho risposto di non conoscere che
74. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, ln.40830, minuta della lettera di Ricci a Giovannoni, s.d.75. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40835, missiva di Giovannoni a Ricci del 8 agosto 1930. Il riferimento è a Nicola Parravano, professore di «Fisica chimica ed Inorganica» e «Chimica Naturale»; fu anche Preside della Facoltà di “Scienze fisiche, matematiche e naturali” (poi membro dell’Accademia Pontificia, dell’Accademia d’Italia, dell’Accademia dei Lincei). Ugo Bordoni nel 1923 fu chiamato alla cattedra di «Fisica Tecnica» della Facoltà di Ingegneria di Roma dove si dedicò allo studio della Termotecnica, della Termodinamica e dell’Acustica. Il riferimento per le segnalazioni di Ricci era a Umberto Cialdea e a Demetrio Helbig, chimico e generale d’aviazione (figlio del noto archeologo tedesco Wolfgang che con sua moglie, la principessa russa Nadine Schahawskoy, aveva fatto di Villa Lante al Gianicolo, che solo nel 1909 Demetrio comprò, un salotto culturale assai noto a Roma).76. g. baSiLe, L’Istituto centrale del restauro in Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta, a cura di v. cazzaTo, Roma, 2001, vol.II, pp.693-749.77. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40827, telegramma di Giovannoni a Ricci, del 19 marzo 1910.78. «Dal canonico Manzini di Nonantola ricevo la unita lettera sui restauri della chiesa; e gliela invio, perchè io per mio conto non ho nulla di specifico da rispondergli» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16777, missiva di Giovannoni a Ricci del 30 aprile 1915).79. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n. 16810. missiva di Giovannoni a Ricci, del 9 febbraio 1927.80. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n. 16814, missiva di Giovannoni a Ricci del 31 luglio ottobre 1929.
FERRUCCIO CANALI82
81. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16816, missiva di Giovannoni a Ricci del 14 ottobre (s.a.).82. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16816, missiva di Giovannoni a Ricci del 14 ottobre (s.a.).83. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16820, missiva di Giovannoni a Ricci, s.d.84. «Ministro, Sottosegretario, Capi di Gabinetto al Ministero dei LL.PP. stanno tutti fuori Roma. Bisognerà tornarci fra 8 o 10 giorni. Fuori di Roma è anche il Piacentini (del Manfredi non so nulla) e questo giustifica la sua assenza e il suo silenzio. Ma dal figlio ho saputo essere il Piacentini entusiasta della sua idea, che anzi egli avrebbe già avuta da non so quanto tempo e concretata in non so quale disegno. Cominciano le questioni di priorità: buon segno! Il Priori le porterà domattina i bozzetti modificati. L’ho incaricato anche di disegnare una generale piantina schematica della località, piantina che mi sembra sia un’illustrazione indispensabile a definire la soluzione proposta ... e se per la Sua pubblicazione nel “Bollettino” non servisse, potrei benissimo servirmene io per il prossimo “Annuario dell’Associazione” [dei Cultori di Architettura]» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.87 n.16584, missiva di Giovannoni a Ricci del 5 agosto 1910).85. Nel corso del 1920 veniva dunque redatta una «Relazione» del Comitato per la “Sistemazione edilizia del colle Capitolino e delle sue adiacenze”, del quale facevano parte R. Lanciani, (in qualità di Presidente, archeologo), Corrado Ricci (come Vicepresidente), G. Botto, N. Cinelli, F. Galassi (consiglieri comunali),, L. Mariani (del Consiglio Superiore dell’ Educazione Pubblica, sezione “Antichità e Belle Arti”), l’architetto A. Muñoz (Direttore Scavi e Demolizioni), R. Paribeni (della Soprintendenza per i Musei e gli Scavi), gli architetti G.B. Giovenale, M. Manfredi, P. Piacentini, e l’ingegnere A. Pullini, Giovannoni era “Relatore” della Proposta insieme a A. Sprega e A. Susino. In settembre la «Relazione» venne votata dal Consiglio Comunale a modifica del Piano cittadino del 1909 e successive “Varianti” del 1917.86. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16780, missiva di Giovannoni, a Ricci del 18 gennaio 1920. Allegata la lettera di Lanciani a Giovannoni, su carta intesta del Comune di Roma: «col Sindaco malato, con quattro assessori idem ... non mi è stato, né mi è momentaneamente possibile occuparmi della tua bellissima, egregia, brillante Relazione ... Agite senza di me» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16781).
esistano più cori in legno del XII o del XIII secolo; di potergliele solamente indicare i modelli attendibili nelle numerose rappresentazioni di cattedre e scanni contenute nelle pitture, da cui tuttavia non è in pratica cosa facile il trarli fuori. L’ho messo in guardia contro il gotico, difficilmente imitabile e molto più fuori stile di una cosa semplice semplice e di una elegante economia. poi abbiamo parlato e Lei mi ha fatto venire l’idea d’un coro del Rinascimento, bello che fatto»82.
In altre situazioni, il consiglio di Ricci si mostrava fondamentale per Giovannoni, specie per casi specifici nel quale il Restauro risultava imprescindibile dalla Filologia:
«Le bozze che Le unisco sono di una polemica tra me e il Sindaco di Ferrara, originata da una mia nota di ‘Cronaca dei Monumenti’ nella “Rivista d’Architettura”. Desidererei il suo parere sulla mia risposta e, più di tutto, il suo aiuto nei riguardi di un dato di cui il Sindaco parla con grande sicurezza e di cui solo ora mi avvedo. Dice il Sindaco che il disegno della Comunale si riferisce non al palazzo del Comune, ma al palazzo della Ragione. Sono andato a rivedere la riproduzione nel libro dell’Agnelli e ho trovato che veramente egli attribuisce il disegno al palazzo della Ragione; ma mi pare che abbia ... torto. Mi pare cioè che l’esistenza del Volto del cavallo appaia chiara e che la fabbrica d’abitazione che chiude la piazza a destra del quadro stia ad indicare che la veduta è presa dal loggiato del Duomo e si riferisce appunto al palazzo del Comune. Non Le pare?»83.
Non sappiamo l’esito del parere ricciano, ma certo che la sua conoscenza di cose ferraresi dovette risultare imprescindibile.Roma costituiva, comunque, l’ambito operativo fondamentale della riflessione e anche dell’attività di Giovannoni e Ricci, anche se a volte, come nel caso
ferrarese, ci sfuggono le singole problematiche84. Specie dopo la nomina del Ravennate ad Assessore al Governatorato della Capitale presso la «Sezione X - Antichità e Belle Arti» (laddove il nuovo Governatorato sostituiva la Podesteria), iniziava la serie delle richieste e delle proposte anche da parte di Giovannoni. Tra le prime iniziative si distinguevano gli ardui problemi connessi alla sistemazione del Campidoglio, oltre che della piazza dell’Aracoeli sottostante (e, poi, i Fori Imperiali).Ricci era stato nominato Vice-presidente dell’apposita Commissione e Giovannoni cercava di tenere le fila delle varie proposte, informandone l’Assessore85:
«Il Lanciani m’invia la lettera che Le unisco e mi rimanda insieme la Relazione, che da un paio di settimane gli avevo mandato, per la sistemazione del Campidoglio. Mi parrebbe il caso quindi che Lei, vicepresidente, convocasse la riunione finale della Commissione. Io porterò la Relazione e spero anche completi i vari disegni che l’illustrano»86.
I progetti legati alla sistemazione del Campidoglio erano solo una parte dell’attenzione giovannoniana e l’occhio vigile dell’Ingegnere non mancava di segnalare ulteriori pericoli a Ricci, in modo che l’Amministrazione comunale si muovesse per tempo:
«Mi segnalano ora che si vuol fare nel galoppatoio di Villa Borghese un “Luna Parck” con tuboga, montagne russe e simili piacevolezze. Suppongo che Lei già avrà avuto notizia dell’incredibile proposito e già l’avrà sventato. Ma per colmo di prudenza, ho voluto avvertirla»87.
Poi era la volta dell’area comunale presso il convento dei Cappuccini che, dovendo essere alienata all’I.N.A., secondo Giovannoni doveva essere ceduta solo sub conditione che «si tenga un concorso per la veste
83GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
architettonica dell’edificio … Lei che ha già così validamente difeso via Veneto ed i suoi alberi e la sua bellezza»:
«Lei conosce le vicende dell’area comunale ai Cappuccini e io ricordo che Lei stesso mi informò dei pericoli corsi per un balordo progetto milanese, che Lei riuscì a far mettere da parte. Ora il contratto di vendita sta per stringersi ed i pericoli risorgono. Ed ecco che molti Soci, con iniziativa felicissima, hanno pensato che la questioni potrebbe essere risolta ponendo a concorso il tema architettonico, arduo in sè; per dare degna sede ad un pubblico istituto, ma più arduo nei riguardi edilizi, che si riferiscono al rispetto alla chiesa, al caratteristico aspetto vivace e ridente della località, che ora rappresenta l’unico bell’inizio di strada delle nuove vie romane. Non si potrebbe dunque, nel concedere l’area a trattativa privata, stabilire questa condizione, che il progetto di un così importante edificio fosse redatto per un pubblico concorso, indetto insieme al Comune e dall’Istituto delle Assicurazioni? Affido questa idea a Lei che già ha così validamente difeso via Veneto e i suoi alberi e la sua bellezza ... E’ superfluo che Le raccomandi prudenza sull’argomento, perché gli interessati hanno occhi e orecchi in tutti gli uffici del Comune!»88.
Però, dopo mesi e la sequela di iniziative, la delusione di Giovannoni montava anche nei confronti di Ricci:
«Mi rivolgo non già all’assessore, che il gretto ambiente dell’Ufficio X è riuscito a paralizzare e a rendere nostro nemico, ma a Corrado Ricci in persona, a Corrado Ricci autentico e son sicuro di ritrovare la cordiale accoglienza di una cortese amicizia e di un’alta mentalità, infervorata dei nostri ideali. Su tre argomenti vorrei intrattenerle e discutere con Lei il “quid agendum?”:1. Che fare per ridare vita alla Commissione del Campidoglio? Non si potrebbe dividerle in sottocommissioni, lasciando il Lanciani alla parte Archeologica, cioè agli scavi sotto la rupe? Noi intanto potremmo andare avanti con la sua guida per tutto il resto e, liberati dall’inerzia presidenziale, a qualche risultato riusciremmo.2. Che fare per riattivare la biblioteca del nuovo “Istituto di Archeologia e di Storia dell’Arte”? So che il Ministero non vuol dare i fondi ed occorre costringerlo con una ben ordinata campagna di voti di Associazioni, di articoli su giornali e riviste, e proteste di studiosi, ecc. ma bisogna organizzarla. Io potrei cominciare subito con un voto dei Cultori d’Architettura da consegnare al Ministro; ma attendo ancora per non fare un’azione staccata.3. Che fare per la nuova attività nel Monumento a Vittorio Emanuele? Ci si pone il soldato ignoto, ci si costruisce l’edicola (e c’è da scommettere che
87. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16785, missiva di Giovannoni a Ricci del 13 gennaio 1921.88. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16788, missiva di Giovannoni a Ricci, Assessore per le Belle Arti del Comune di Roma, del 22 aprile 1921.89. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16789, missiva di Giovannoni a Ricci, Assessore per le Belle Arti del Comune di Roma, dell’8 ottobre 1921.
sarà quanto di più volgarmente vignolesco possa immaginarsi) e la Commissione reale non sa nulla? Che non la convocassero quando non si faceva niente era giusto, ma ora che si lavora nel punto più importante e più significativo, no!Suppongo che Lei, vicepresidente, qualcosa sappia e qualcosa abbia detto. La mia tendenza sarebbe quella di dare le dimissioni, ma, da soldato disciplinato, attendo»89.
Ricci non poteva rimanere in silenzio di fronte ad una sequela tanto articolata e puntuale di richieste e, dunque, rispondeva a Giovannoni con precisione, anche se non senza venature di risentimento:
«1. Nel Campidoglio si lavora e, spero, si conclude. Gli accordi col Ministero dell’Istruzione per la permuta dei terreni municipali di Valle Giulia con l’area capitolina (che chiamano) “Caffarelli”, si può dire raggiunta. Ora si lavorerà per l’adesione del Ministero delle Finanze (Demanio). 2. Il Senato ha approvato la formazione dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte e la sua biblioteca è già completamente in ordine nei nuovi locali. Ho pochi giorni or sono conferito personalmente col ministro Corbino, che mi ha promesso di far finire l’impianto della luce elettrica e fornire un po’ di mobilia. Appena votata la legge in Parlamento (e quindi fornito di mezzi e di personale) l’Istituto (spero nel prossimo novembre) si aprirà.3. Ciò che sarà fatto per la tomba del soldato ignoto mi è ... ignoto. Quando la Commissione Reale del Monumento si radunò nel maggio scorso, il Presidente disse (Ella certo ricorda) ch’essa sarebbe stata riconvocata nel giugno. Nella settimana scorsa cercai del Fradeletto per parlargli in proposito, ma egli era assente. Ci tornai senza trovarlo. Ora mi si assicura che la Commissione sarà convocata a giorni. Attendo il Del Vecchio per parlargli delle mura di Roma; già si è provveduto a fare un piccolo stanziamento per restauri. ma alla dipendenza dall’Ufficio V, ed è male perché quell’Ufficio dà all’asta lavori che (è ovvio) debbono essere fatti in economia. Circa alla zona di rispetto, converrà che ne parliamo. Io non credo che si possa stabilire una norma. Mi venga a trovare ...»90.
Del resto, Giovannoni non poteva non rimanere perplesso da certe scelte che andavano contro la Relazione tecnica per il Campidoglio e l’area limitrofa da poco stilata e se ne lamentava con Ricci (come non riuscisse a comprendere la scollatura sempre esistente tra Bene ‘tecnico’ e volontà politiche):«da più parti mi segnalano che domani sera il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare una variante di Piano Regolatore che porterebbe la demolizione
FERRUCCIO CANALI84
90. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88 n.16790, minuta della risposta di Ricci a Giovannoni del 12 ottobre 1921. 91. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88. n.16792, missiva di Giovannoni a Ricci, Assessore per le Belle Arti del Comune di Roma, del 15 gennaio 1922.92. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16797, missiva di G.Giovannoni a Corrado Ricci, del 4 maggio 1925 . E poco dopo: «Suppongo che Lei sia ormai tornato dalla gita a Napoli e Le scrivo sia per accompagnare l’invio del mio ultimo volume ... sia per prendere accordi con Lei per l’inizio di quella Commissione per gli studi tecnico-archeologici-edilizi-pratici sull’Augusteo. Rimanemmo d’intesa di tenere la prima riunione alla sede dell’Associazione per scambiare le idee. Vogliamo fissarla .. Occorre che non dimentichiamo il voto sulla zona di rispetto alla basilica di San Paolo. Dopo la protesta di padre Acernese, ho la piena sicurezza che rimarrà dimenticato negli Uffici in attesa di un altro Ministro ...» (B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16794, missiva di Giovannoni, a Ricci, s.a.).93. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16795, missiva di Giovannoni a Ricci, del 2 maggio 1925 . Si tratta della Casa del Burcando, ovvero di Johannes Burckhardt cerimoniere papale di papa Alessandro VI Borgia, raro esempio di abitazione del XV secolo posta tra la chiesa del Santo Sudario dei Piemontesi e quella di San Giuliano dei Belgi, nel quartiere di Torre Argentina (di fronte a palazzo Caffarelli Vidoni).94. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16807, missiva di Giovannoni a Ricci del 5 novembre 1925.
della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami sotto il Campidoglio. Ma come mai? E tutto il nostro progetto edilizio, che quella chiesa rispettava, non conta più niente?»91.
O forse, invece, Giovannoni comprendeva tutto anche troppo bene, ma cercava, in extremis, di non farsi sottrarre il controllo della situazione, appellandosi a Ricci, Ma invano. Come nel caso dell’arduo problema della sistemazione dell’area del Mausoleo di Augusto, con il concorso, in questo caso, degli architetti più influenti dell’”Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura di Roma”:
«portando la sua attenzione agli importantissimi temi di Archeologia, di edilizia, di Arte che hanno per oggetto il Mausoleo di Augusto a Roma, l’Assemblea sociale ha deliberato la nomina di una Commissione di studio che inizi indagini e prepari proposte concrete o di immediata o di remota attuazione, che siano di programma organico ai provvedimenti di vario ordine ... La prima riunione presieduta dal senatore Corrado Ricci ... [vedrà la presenza] di Bartoli, Del Debbio, Giglioli, Giovannoni, Guidi, Limongelli, Piacentini, Pernier, Piccinato, Scifoni, Susini, Venturi)»92.
Certo meno complessa perché non di rilevanza urbana, ma certamente notevole se non altro per la notorietà acquisita, la questione della cosiddetta «casa del Burckhardt»:
« Occorre che ci occupiamo del restauro della casa del Burchardt. Alla Biennale vedo esposto quel disegno di facciata dell’Antonelli, tutto inventato, che prescinde dalle cornici orizzontali autentiche, esistenti e le taglia. Ma non mi meraviglierei che quel cocciutissimo uomo lo volesse attuare a nostro dispetto»93.
Pochi mesi dopo la situazione non era certo migliorata:
«mi giungono bruttissime notizie di alterazioni che si sono commesse nel restauro della casa del Burchardt e di altre, ancora più gravi, che se ne minacciano. Io, in verità, fino dal primo giorno vidi le cose non bene avviate, ché mi sembrò l’Antonelli un artista egregio, ma inadattissimo per carattere e per preparazione all’arduo
tema dei restauri. Ho voluto segnalarle tutto questo perché mi sembra che la Commissione da Lei presieduta debba dire il suo parere ed esigere che sia seguito ovvero debba andarsene. Sono forse 9 o 10 anni che non ci convocano più ed intanto fanno ciò che vogliono. E così noi contestiamo senza volerlo tutti gli arbìtri»94.
Più rilevanti ancora le problematiche riferite ai lavori su Villa Madama
«eccole la copia del voto del Consiglio Superiore su Villa Madama, che finalmente mi è riuscito avere. Nel rovistare la pratica ho trovato anche una risposta del Bergès (il proprietario) in data del novembre scorso, alla nostra relazione. In essa il Bergès, con molto garbo e molta abilità, si rimangia le promesse generiche fatteci di attuare le nostre proposte ... Certo però che anche questa volta c’è da pentirsi di avere usato tante agevolazioni e fatto tanti complimenti esagerati ad uno straniero!»95.
In allegato era la Relazione, del 7 giugno 1918 e firmata da Manfredo Manfredi, da Adolfo Venturi, da Guido Cirilli e, naturalmente, da Giovannoni, sui lavori alla Villa. Una Relazione che, se letta sub specie giovannoniana, mostrava chiaramente come le teorie dell’Ingegnere contemplassero anche una pratica operatività nell’orientamento:
“Relazione sulla Villa Madama”.Nelle visite compiute nei giorni 11 e 10 maggio dai sottoscritti membri del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti alla villa Madama sulla falda orientale di Monte Mario, essi hanno avuto agio, mediante l’esame diretto del monumento e i chiarimenti forniti dal proprietario sign. Bergès che è stato loro guida cortese, di rendersi conto della portata del restauro e delle aggiunte compiute alla mirabile opera architettonica e di avere nozioni precise dei lavori ivi e tuttoggi eseguiti. Questi possono dividersi in tre categorie: 1. di consolidamento costruttivo e di ripresa dei suoi elementi costruttivi;2. di adattamento dell’edificio esistente ad uso di abitazione;3, di ampliamento in nuove costruzioni innestate alle antiche.Niun elogio sarebbe bastevole a commento dei
85GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
provvedimenti della prima categoria suddetta: isolata la fabbrica dal monte attiguo da cui proveniva afflusso di umidità che infradiciava gravemente le murature, rinsaldati gli stucchi meravigliosi che erano giunti ormai ad uno stato di fatiscenza che ne faceva temer prossima la completa ruina, riportata la solidità e il decoro nelle sale e nelle loggie, che un tempo furono sede di un “Vaticano in miniatura” e che servivano di magazzini, di granai, di luride abitazioni, reso nuovamente ridente e vivace l’insieme dei giardini e delle fontane, queste opere associano il giusto senso di religiosa venerazione per l’Arte e per i ricordi del passato a quella della signorile utilizzazione e del nobile godimento del luogo incantevole».
Il fatto che un privato, e per giunta uno straniero, intendesse operare per il restauro della famosa villa, aveva indotto i membri della Commissione a guardare con occhio bonario a quanto si intendeva realizzare, consapevoli che era preferibile l’utilizzo all’abbandono:
«anche analogo criterio di beninteso rispetto [per l’Arte e per i ricordi del passato] ha informato la soluzione del tema, ben più difficile e di ordine più complesso, dell’adattamento della villa alla sua nuova funzione. Limitato il piano di abitazione a quelle che furono le soffitte dell’edificio, adattate signorilmente allo scopo, costruita per accedervi una scala ben ideata come linea e come decorazione che non altera la forma della stanza che occupa, i grandi ambienti del piano terreno sono rimasti immutati ed hanno avuto una destinazione, consona alla primitiva, di sale di ricevimento e di studio, di sede di artistiche raccolte. Quanto ai lavori della terza categoria, l’intendimento che ad essi ha presieduto è certo quello di aggiungervi alcuni ambienti all’edificio, avviandosi al suo completamento in conformità di quei disegni antichi, del Sangallo, di Raffaello e dei loro allievi e seguaci che, conservati nelle varie collezioni, e segnatamente in quella della Galleria degli Uffizi di Firenze, ci attestano, sia pure in modo frammentario e non definitivo, quale fosse nell’intenzione degli architetti di Clemente VII il tipo immaginato per la grande e sontuosa villa romana, di cui la costruzione attuale costituisce un inizio di attuazione. Ma se il proposito può sembrare giusto in massima, non si può tuttavia dirsi che le gravi difficoltà che esso presentava abbiano avuto in realtà soddisfacente soluzione».
Accettazione sì dei generali desiderata del proprietario, ma non certo supina accondiscendenza, per non rinunciare all’assunto scientificamente assai rigido per la teoria del «Restauro filologico» che i completamente potessero avvenire solo in presenza e in conformità di quei disegni antichi … che ci attestano, sia pure in modo frammentario e non definitivo, quale fosse nell’intenzione degli architetti» pur consapevoli delle «gravi difficoltà, che il proposito presentava» e il fatto che non vi fosse stata «in realtà soddisfacente soluzione … causa di un arbitrio stilistico» :«Il primo e forse il maggiore degli inconvenienti si riferisce alla massa della nuova costruzione che altera la euritmia di linee e di proporzioni dell’edificio esistente,
senza che si dimostri in alcun modo parte organica di un più vasto edificio. Esso appare, così come era è, illogica superfetazione, non coordinata con l’esterno della villa e, ancora più, mancante di legame architettonico con l’esedra che ne forma internamente la corte. Il difetto grave suindicato riflettesi dalla massa negli elementi architettonici e decorativi. Il motivo tutto traforato della doppia loggia contrasta con l’aspetto forte e massiccio della costruzione cinquecentesca, e certo la sua rispondenza con un bozzetto sangallesco (per la pianta del solo pianterreno) non lo salva dall’arbitrio stilistico. La forma goffa delle due colonne brecciate, il tipo della mezza colonna enorme che chiude la composizione non rispondono certo a quella bella e fine e eleganza che, pur nelle sue ineguaglianze, pervade tutta la espressione artistica della magnifica villa. Ed anche l’effetto della costruzione rustica con cui è espressa la muratura non risulta armonico, per la non conformità della tecnica seguita, del tipo e del colore del materiale adottato, con quelli della fabbrica primitiva».
Se si poteva tentare un dialogo con l’originaria progettazione sangallesca e raffaellesca sulla base del principio dell’Ambientamento, certo doveva trattarsi di opera elegante (anche se la competizione con gli architetti rinascimentali non era poca cosa)!
«A questi inconvenienti i sottoscritti, dopo maturo studio, opinano che possa in grandissima parte porsi rimedio, attuando le proposte che gli allegati bozzetti prospettici chiaramente dimostrano.Essi consistono, in riassunto, nel diminuire di un piano la maggior parte della costruzione aggiunta; nel sostituire le due colonne del loggiato inferiore con due altre di minori dimensioni, non di marmi ma di costruzione rustica a tufelli e mattoni; nel lasciare al coronamento mosso di tale costruzione nuova, al termine dei suoi pilastri che si elevano alquanto al di sopra della sua linea terminale, nello inizio di un arco da cui dovrebbe partire la copertura del grande vano susseguente, e più nel rivestimento parziale di piante rampicanti, il carattere che può dirsi ‘romantico’ di costruzione non finita, quasi di rudero, da cui può rilevarsi il concetto del più vasto edificio, senza che ne risulti sostanzialmente turbata la massa in cui è risultato armoniosamente composto il palazzo cinquecentesco finora eseguito.Implicitamente, da tale progetto verrebbero risolti altri problemi minori. Il risvolto del motivo dell’esedra potrebbe avvenire regolarmente sul fianco associandosi alla costruzione nuova, bassa e non invadente. Il portichetto, in verità meschino e fuori carattere, aggiunto sul terrazzo superiore quasi a costituire un treillage in pietra, scomparirebbe con l’abbassarsi di un piano del terrazzo stesso».
Restava però aperto, e non era poco, il contenzione legale tra il Ministero e il proprietario: «Nello svolgere queste considerazioni e queste proposte di massima, i sottoscritti si sono preoccupati solo secondariamente delle varie considerazioni legali, a cui di gran lunga sovrastano gli interessi dell’Arte quando trattasi di un cimelio artistico unico nella
FERRUCCIO CANALI86
95. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16822, missiva di Giovannoni a Ricci del 12 marzo s.a. 96. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16822, missiva di Giovannoni a Ricci del 12 marzo s.a. 97. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16795, missiva di Giovannoni a Ricci del 2 maggio 1925 . 98. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16796, missiva di Pietro Sommariva a Corrado Ricci, del 4 maggio 1925.99. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n. 16809, missiva di .Giovannoni a Ricci del 24 ottobre 1926.
Storia del Rinascimento, qual’è Villa Madama. Essi perciò non si fermano a rilevare se nella esecuzione siano state introdotte modifiche più o meno importanti al progetto di restauro, o viceversa se alcuni degli inconvenienti lamentati vadano a riportarsi, appunto, a quel primo progetto, Essi sanno che in tema di tale importanza e di tale complessità, un progetto non può tutto comprendere e non può molto contare se non è accompagnato da un amoroso e assiduo studio che sperimentalmente ne controlli i risultati; essi sono d’altra parte ben convinti che a chi [il proprietario] ha saputo conquistarsi così alte benemerenze per la conservazione di un mirabile monumento ... non sarà discaro l’attuale provvedimento»96.
Emergeva, con chiarezza, specie nelle ultime battute, la necessità operativa del cosiddetto «Progetto aperto giovannoniano» - rimarcando il contributo imprescindibile dell’Ingegnere alla stesura della Relazione – ma, soprattutto, si imponeva l’idea, che nel Restauro di Monumenti pregevoli la conduzione esecutiva delle opere doveva contare (e dunque essere degnamente affidata) tanto quanto previsto in fase progettuale.Il contributo del Restauratore non si esauriva però nelle sole questioni realizzative: com’era nelle competenze delle Soprintendenze ‘ricciane’, anche le questioni relative alla toponomastica stradale finivano per essere argomento di confronto tra i due ‘amicissimi’. Lo segnalava, per gli architetti e per le questioni romane, Giovannoni:
«Lei, che è presidente di tante cose, lo è anche della “Commissione per la nomenclatura strade romane”. Ora, non le pare che in questa siano stati assai dimenticati gli architetti? Si affacciano, appena, i Sangallo, tutti insieme, nel Lungotevere e Bramante in una brutta piazza a San Saba. Vedrei invece la opportunità di dare a nuove e belle strade nomi di architetti, o di romani che abbiano lavorato fuori Roma o di artisti di ogni paese che abbiano lavorato a Roma. Butto là dei nomi alla rifusa: Vitruvio, Apollodoro, Rabirio ... Leon Battista Alberti ... Peruzzi, … Sansovino ... Borromini, Bernini ... Piranesi, Canina ... Poletti .. Avanzini ... Ripensandoci però vedo una obbiezione grave: se questi grandi artisti entro le vie e le piazze volgarmente tracciate tra le brutte case nuove, non ci volessero stare e se ne andassero via?»97.
Era la Storia che assumeva, nella Contemporaneità, valore celebrativo, e dunque la questione non andava trascurata, come faceva notare, dopo le sollecitazioni giovannoniane, Pietro Sommariva, a Ricci:«i nomi sono già stati apposti e quanto prima verranno apposti alle strade … nella scelta dei nomi la Commissione ha dato la preferenza ad architetti che
lasciarono in Roma traccia notevole della loro opera ... Alberti ... Borromini, Stern … Sacconi ... Vespignani ... Ciro da Urbino»98,
laddove non si può non notare l’estremo aggiornamento delle scelte Giovannoni-Ricci, a contemplare anche architetti ottocenteschi e addirittura primo-novecenteschi come Giuseppe Sacconi (e, nella serie, colpisce, parallelamente, «Ciro da Urbino», se si voleva fare davvero riferimento al feltresco Ciro Ciri e Scirro Scirri).
6. Questioni di ‘Architettura del Nuovo’: l’impre-scindibilità del ruolo dell’architetto nella creazione di una Cultura moderna
Senza dubbio Ricci e Giovannoni condividevano la convinzione che gli Architetti dovessero ricoprire un ruolo nodale non solo nella conservazione dei Monumenti (se non altro viste le lotte che il Ravennate aveva compiuto fin dai primi anni del Novecento per l’istituzione di Facoltà di Architettura), ma anche nell’ambito di una professionalità che servisse a ribadire il valore della Tradizione e della Cultura italiane. Giovannoni non mancava occasione per ribadire l’assunto, mettendo in evidenza l’imprescindibilità del ruolo dell’architetto nella creazione della nuova Società italiana:
«Le unisco le bozze d’un mio articolo ora comparso sulla “Rivista d’Architettura” relativo alla posizione degli architetti rispetto agli studi dei Monumenti, e spero che Lei anche in questo sarà vicino al mio pensiero. E a proposito di tale argomento, Le ricordo la mia proposta, che mi parrebbe adattissima per l’’Istituto di Archeologia e di Storia dell’Arte’; cioè di promuovere una pubblicazione, per ora descrittiva, poi analitica, sui monumenti dell’Impero Romano sparsi per il mondo»99.
Non si trattava solo di studio, ma anche di un programma ‘politico’, che andava circostanziandosi in uno stretto rapporto tra Architettura e Società, come si poteva evincere anche nel caso dell’importante concorso per la cattedrale de La Spezia, dove Giovannoni sedeva in Giuria:
«Quanto ai progetti per la Cattedrale di Spezia, non li ho ancora visti perchè la Commissione non è ancora stata convocata. Quando li vedrò guarderò con attenzione il lavoro del Rossi (Paolo), e al mio ritorno, se sarò ancora vivo (pensi che i concorrenti sono circa cento!) Le riferirò la mia impressione»100.
Ma l’intervento ‘politico’ dell’Architetto emergeva soprattutto in relazione ai nuovi monumenti celebrativi («Le unisco una cartolina del piccolo monumento da me
87GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
100. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40833, missiva di Giovannoni a Ricci del 12 novembre 1929.101. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n. 16809, missiva di Giovannoni a Ricci del 24 ottobre 1926. 102. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16811, missiva di Giovannoni a Ricci dell’ 8 giugno 1927. 103. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16812, missiva di Giovannoni a Ricci del 17 novembre 1927. a nome del gruppo «La Burbera». 104. Del 1925 era stata una “Proposta di Variante” al Piano del 1909, poi mai approvata. Nell’occasione Marcello Piacentini aveva avanzato un «Piano della “Grande Roma”», cui era seguito, tra il 1927-1928, un “Piano per l’area dei Fori Imperiali” del gruppo “La Burbera” (Giovannoni con P. Aschieri, G. Boni, E. Del Debbio, V. Fasolo, A. Foschini, F. Giobbe, A. Limongelli, G. Nori e G. Venturi in accordo con la Direzione “Architettura e Fabbriche”, della “V Ripartizione” del Comune Roma). Tra il 1928 e il 1929 lo stesso Gruppo presentava una organica “Proposta di Piano Regolatore”.105. Il Piano Regolatore di Roma venne redatto da una Commissione presieduta dal Governatore F. Boncompagni Ludovisi e composta dagli Accademici d’Italia arch. C. Bazzani, arch. A. Brasini, R. Paribeni, arch. M. Piacentini (Relatore), dai deputati arch. A. Calza Bini e ing. E. del Bufalo, dal prof. G. Giovannoni, dagli ing. P. Salatino e A. Bianchi e dal prof. A. Muñoz del Comune, dai segretari ing. A. Maccari e ing. A. Bianchi. Si veda: Piano Regolatore di Roma, a cura del goverNaToraTo di roma, Roma, Treves - Treccani
disegnato pei caduti di Capranica, che ha il solo merito di non avere pupazzi!»101). Anche la Storia, però, forniva casi esemplari, come nel caso della nascita della tipologia del teatro «moderno»:
«se c’è un argomento che ora sarebbe di interesse vitalissimo per gli architetti e per l’architettura italiana, è quello di cui parlammo pochi giorni fa, della forma dei nostri teatri quale si è determinata nel Seicento e nel Settecento, specialmente per opera dei Bibbiena. Si stanno infatti diffondendo pubblicazioni tedesche sui teatri moderni che tecnicamente hanno notevole importanza, ma artisticamente raccolgono capolavori di goffaggine. ed i giovani le copiano. Contrapponendovi gli esempi di un’arte nostra agile, viva, piena di risorse, dimostrare la priorità italiana in tante disposizioni pratiche in tanti criteri tecnici, collegare la costruzione dei teatri alla scenografia, ecco, se non erro, un magnifico tema e, ciò che più importa, utilissimo. Nessuno certo potrebbe trattarlo adeguatamente se non Corrado Ricci … alla proposta si è associato anche Marcello Piacentini. ... Si tratterebbe di preparare per la rivista “Architettura e Arti Decorative” uno o due articoli brevi con illustrazioni ... E la rivista di “Rivista d’Architettura” [e Arti Decorative] che ebbe da Lei il Battesimo, avrà ora la Cresima»102.
Scopo di Giovannoni era quello di creare un team affiatato di operatori anche perché ormai si andavano profilando sempre più le vicende per la redazione di un nuovo Piano Regolatore per Roma. Così l’Ingegnere chiedeva l’aiuto di Ricci, prospettandogli stagioni di precise prese di posizione e puntuali linee culturali:
«Le dò una notizia che Le farà piacere. Ho messo insieme un gruppetto di architetti romani che ha per programma di affermare (Le trascrivo le prime frasi del manifesto che proponiamo) “con le opere più che con le parole i diritti della nostra grande tradizione architettonica nella graduale formazione di una Architettura che sia diretta espressione delle esigenze, dei mezzi, del sentimento del tempo moderno”; contrapporre cioè vivacemente il nazionalismo architettonico agli aspetti internazionalisti, alle mode che ci vengono con le riviste tedesche, alle tendenze verso un esagerato materialismo arido, così lontano dallo spirito italiano.
Ma ci manca un bel nome di battaglia e io confesso di non esser riuscito a trovarlo; e qui bisogna che Lei ci aiuti. Occorre un titolo che sia un programma, ed un motto non troppo accademico, non troppo pesante, non troppo scherzoso, non troppo simbolico. Avevo pensato per un momento “Collegium Architectorum” e siamo scappati via inorriditi dalla riesumazione archeologica. Il nome semplice di “Gruppo degli Architetti Romani” dice troppo e troppo poco e sembra comprenderli tutti mentre che per ora siamo una dozzina, ed è bene che per non far confusioni non siamo troppi di più. Trilussa ci ha suggerito: “Casa Nostra” e sarebbe bello se non fosse già sfruttato dalle tante Cooperative di costruzione di volgarissimi villini. Altri ha proposto qualche parola artistica o tecnica: l’”Acanto”, il “Marcapiano”, la “Martellina”, ma neanche questi soddisfano. Ci pensi dunque anche Lei e son certo che verrà fuori qualcosa di buono. Faremo il battesimo con un bel fiasco di vino alla Sua salute»103.
Dunque nel novembre del 1927 il nome di «Gruppo “La Burbera”» ancora non era stato scelto104.Un momento nel quale però l’attività di Giovannoni e del suo team poteva assumere una grande rilevanza, addirittura coordinando aspetti salienti dello sviluppo della città, era costituito dal coinvolgimenti nelle vicende dei nuovi Piani Regolatori italiani, tra i quali si stagliava, ovviamente quello di Roma. Una vicenda, quella del Piano per Roma che, dopo la redazione del 1931 (che aveva visto il concorso di molti competitori dello stesso Ingegnere, da Piacentini a Brasini a Bazzani)105, sembrava trovare una propria composizione operativa, nell’ottica giovannoniana, attraverso, l’intervento puntuale e l’accordo con gli uffici gestionali, invece che sperare in un incarico in toto. La consultazione tra Ricci e l’Ingegnere avveniva, dunque, su singole questioni. Com’era avvenuto già negli anni precedenti: «la proposta di legge per la costruzione di una Colonia lavorativa a Porta Furba non mi suona bene, perché evidentemente si tratta di edifici da eseguire presso gli acquedotti; ma d’altra parte non ne so nulla di preciso. Mi pare che i pareri dei Sovrintendenti alle Antichità e alle Belle Arti avrebbero dovuto essere sentiti prima ancora di fissare l’area e di presentare la legge. Ma poiché ora la Legge è presentata, e deve quindi avere
FERRUCCIO CANALI88
- Tuminelli editori, 1931.106. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.88, n.16813, missiva di Giovannoni a Ricci del 25 novembre 1928.107. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40841, missiva di Giovannoni a Ricci del 8 marzo 1932. 108. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40841, missiva di Giovannoni a Ricci del 8 marzo 1932.
il suo corso, non c’è che da insistere nell’avvertire che dai ruderi ci si debba tenere a notevole distanza, che gli edifici debbano essere bassi e radi e non disposti secondo schemi regolari da Genio Civile. Come c’è un’area di rispetto per la Colonia, si potrà anche averne una pei resti antichi! Per ottenere il massimo decentramento si potrà suggerire di estendere eventualmente l’area da espropriare che, del resto, con l’applicazione della Legge di Napoli, si paga pochi soldi, Non le pare?»106
Dopo il 1931, però, le questioni dovevano essere concretamente disciplinate non più in maniera puntuale, ma all’insegna, piuttosto di una visione organica, ed ecco che l’Ingegnere presentava a Ricci, vista la sua influenza e il suo coinvolgimento diretto nelle Commissioni del Governatorato, una serie di ‘punti cardine’:
«Riservandomi di farle avere domani i dati sulla chiesa brasiniana [di Brasini] dei Parioli Le mando intanto gli appunti promessi sugli argomenti del Piano Regolatore di Roma di cui parlammo iersera: 1) Necessita che al Piano Regolatore nello spazio si unisca il Piano Regolatore nel tempo, cioè un programma ed un metodo per graduare i provvedimenti in conformità dello scopo»107.
Entrava in gioco il ‘Giovannoni urbanista, e dunque, la scansione temporale e spaziale del «Piane Regolatore» trovava un proprio primo pilastro nel problema del «Piano d’Ampliamento»:
«2) Necessità di dare, sia nello studio definitivo sia nel programma di attuazione, importanza preponderante al Piano d’Ampliamento che va dal collegamento coi Castelli e col mare alla formazione di nuovi quartieri periferici per oltre 1milioni di abitanti, dalla sistemazione ferroviaria alla creazione di vie di arroccamento e di rifornimento dei centri (mercati e stabilimenti industriale). E questo deve farsi dapprima con uno studio organico, poi col mettere in azione i mezzi delle comunicazioni, della costituzione di un demanio comunale, delle facilitazioni finanziarie, delle convenzioni con Enti e imprese; senza di che lo sviluppo sporadico ed indisciplinato porta ai quartieri pidocchiosi di Porta Furba, o della via Flaminia, o del Pigneto che ostacolano ogni sviluppoSoprattutto occorre per questo abolire o diminuire gli improvvidi sbarramenti (come le vie ristrette fuori porta Maggiore e le mal disposte stazioni della cintura) che formano un rigido involucro edilizio. In questo tema dell’ampliamento finora trascuratissimo, non solo è il grande scopo di formare la città del tempo nostro, ma insieme di aiutare quella dei tempi passati invece di rovinarla sempre più. Il nuovo con cui
l’innesto si compie può infatti o congestionare sempre più il nucleo esistente, od alleviarne le condizioni di traffico col costituire circuiti esteriori e creare nuovi centri sussidiari. E forse allora molti tagli previsti nell’interno pel solo scopo della viabilità non saranno più necessari»108.
La viabilità costituiva un aspetto complesso e, in particolare, andavano risolti alcuni nodi problematici di particolare rilevanza:
«3) nei riguardi di questi tagli, domandare che nell’art.2 del R.Decreto sia soppresso il Comma che parla della comunicazione tra via Arenula ed il Pantheon per via Argentina. È’ l’unica variante introdotta dalla Legge al piano studiato ed è così inorganica ed inopportuna che mette conto di unirla agli altri provvedimenti accennati nello stesso articolo che richieggono ulteriore studio; 4) Insistere sulla opportunità di provvedimenti spiccioli nella vecchia città (allargamento del tratto di via della Scrofa ove è la chiesa protestante, abbattimento di una sporgenza in via del Leone, scantonamento in via Campo Marzio), opere più efficaci sia per il movimento che per la sosta che non le nuove strade troppo larghe;5) Nei riguardi giuridico-economici far notare con ampia lode l’innovazione dell’art.8 che dà diritto ai proprietari delle zone finitime di ricostruire fino al margine e li libera dalla pirateria di società edilizie, e con questo libera la città da tagli richiesti solo da interessi degli speculatori»109.
Di lì a poco sia Ricci che Giovannoni si sarebbero resi conto che tutte le previsioni non risultavano comunque sufficienti e, dunque, non si poteva che procedere con una «Variante», visto che poi la contrattazione reale si apriva su aree ben circoscritte:
«Ho avuto la proposta di variante al Piano Regolatore che finalmente ha maturato e che Lei gentilmente m’invia. Va benissimo. Non c’è che da stare in guardia contro gli interessi privati, ad esse. Contro quello del Principe Massimi, che non si sa come, ha mosso perfino la nostra stagionata e prudente Accademia di San Luca in favore di una variante che salverebbe, è vero, l’insignificante oratorio de’ Falegnami (il quale invece può rimanere sotto la rampa), ma ricoprirebbe nientemeno che i resti del Foro di Cesare alla Marmorella! Spero che domani l’avv. Parpagliola interverrà e riferirà su di una lettera al Comune a proposito della quale mi ha scritto. Il Comune domanda di costruire subito su quell’area tra via Cavour e la Croce Bianca che ora rimarrebbe area fabbricabile. La questione è grave. Legalmente il Comune avrebbe ragione Ma parrebbe quanto mai inopportuno iniziare i lavori della zona proprio del provvedimento più lontano
89GUSTAVO GIOVANNONI E CORRADO RICCI ‘AMICISSIMI’ (1904-1932)
dai nostri scopi. Solo forse ci si potrebbe indurre pei soliti inevitabili criteri di transazione, se il Comune contemporaneamente li compensasse con qualche lavoro utile, ad es. sistemando regolarmente lo sbocco di via Alessandrina. Intanto potremmo mantenere fermo, indipendentemente dal nuovo Piano Regolatore, il vincolo della zona monumentale su tutta la regione e quindi anche sull’area per la quale soltanto il Comune sembra avere interesse ai nostri lavori»110.
Si trattava di contrattazioni continue e per casi specifici, ma tutto ciò non faceva perdere di vista, nei due ‘amicissimi’, il senso della ‘missione’ che essi sentivano di compiere per cercare di migliorare la situazione dell’Architettura italiana. Una posizione di tutto rispetto, condivisibile o non condivisibile che fosse.
109. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol. 221, n.40841, missiva di Giovannoni a Ricci del 8 marzo 1932.110. B.Cl.Ra., «F.R.», sez. «Cor.», vol.221, n.40843, lettera di Giovannoni a Ricci del 17 maggio [dopo il 1932].
Un sentito ringraziamento va espresso a Floriana Amicucci e a
1. Corrado Ricci, Ritratto fotografico, primi anni del XX secolo2. Gustavo Giovannoni, fotografia, primi anni Quaranta del Novecento (da G. De Angelis D’Ossat, Gustavo Giovannoni, Roma, 1949. Ringrazio Andrea Pane per avermi fornito l’immagine e l’indicazione)
1
2