Cassette, pissidi, olifanti. Un taccuino inedito di Ugo Monneret de Villard
Transcript of Cassette, pissidi, olifanti. Un taccuino inedito di Ugo Monneret de Villard
L’OFFICINA DELLO SGUARDO
scritti in onore di Maria Andaloro
a cura di
Giulia Bordi, Iole Carlettini, Maria Luigia Fobelli, Maria Raffaella Menna, Paola Pogliani
I LUOGHI DELL’ARTEIMMAGINE, MEMORIA, MATERIA
©Proprietà letteraria riservata
Gangemi Editore spaPiazza San Pantaleo 4, Romawww.gangemied i tore . i t
Nessuna parte di questapubblicazione può esserememorizzata, fotocopiata ocomunque riprodotta senzale dovute autorizzazioni.
Le nostre edizioni sono disponibiliin Italia e all’estero anche inversione ebook.Our publications, both as booksand ebooks, are available in Italyand abroad.
I volumi sono stati pubblicati grazie ai contributi di
redazione scientificaSimone PiazzaconMichele BenucciChiara BordinoIvana BrunoDaniela Sgherri
Elaborazione delle immaginiDomenico Ventura
TECNO-ART, ASCOLI PICENO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEI BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO
DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. “D’ANNUNZIO” DI CHIETI
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA SICILIA
ISBN 978-88-492-2753-6
In copertina: Pittura, architettura, paesaggio. Contaminazioni, abrasioni, innesti. Immagini, 2014 (particolare).
L’OFFICINA DELLO SGUARDOScritti in onore di Maria Andaloro
a cura diGiulia Bordi, Iole Carlettini, Maria Luigia Fobelli,
Maria Raffaella Menna, Paola Pogliani
Volume 2
IMMAGINE, MEMORIA, MATERIA
Indice
V. L’ESTETICA E LO SGUARDO
L’immagine dell’immagine 13LUCIA PIZZO RUSSO
L’immagine ibrida 21ELIO FRANZINI
Epistemologia dell’ornamento. Un’ipotesi di lavoro 27MASSIMO CARBONI
Icona e immagine 33GIUSEPPE DI GIACOMO
Icone moderne 39VICTOR I. STOICHITA
Il Fayum di Alberto Giacometti 45ELENA TAVANI
L’ultima spiaggia del monumento. Per una tipologia della contro-monumentalitàcontemporanea 55ANDREA PINOTTI
VI. L’OPERA �EL TEMPO
Mostri marini con e senza ali: considerazioni sul ‘grande pesce’ che ingoiò Giona 63FRANCESCA POMARICI
«In forma di teatro». Lo spazio liturgico antelamico in diocesi di Parma: nuove scoperte tra rimozioni e rilavorazioni 69CARLOTTA TADDEI
Paraíso e infierno en Gormaz: una iglesia a los pies de un castillo 75MILAGROS GUARDIA
Sfortuna del San Ludovico di Tolosa di Donatello: lo spazio negato 85LAURA CAVAZZINI
Segnalazioni del ‘Maestro dell’Adorazione di Glasgow’ 91RICCARDO NALDI
Giovanni Bellini introduce l’Anticristo 101ENZO BILARDELLO
Il disegno nascosto di Giovanni Santi 107MARIA ROSARIA VALAZZI
Uno sguardo su Maria. Iconografia mariana nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma 113BARBARA FABJAN
Raffaello, Polidoro e lo Spasimo di Sicilia: un caso di scuola 119ANDREA DE MARCHI
La Pietà di Michelangelo: nuove ricerche su una Madonna coronata in San Pietro 127PIETRO ZANDER
Visione nordica e allegoria italiana nella Battaglia di Mühlberg di Enea Vico 141ENRICO PARLATO
Recomposition: Blade and Glue in Some Drawings by Ludovico Carracci 147GAIL FEIGENBAUM
Un nuovo quadro di Marco Benefial ‘che si direbbe di Carlo Maratta’ 153LILIANA BARROERO
VII. SEG�I E PERCORSI DELLA MEMORIA
Edizioni moderne, problemi antichi: la gloria del μεγαλόψυχος (Isocrate, Evagora 3) 161MADDALENA VALLOZZA
Peristili e cortili porticati nelle domus aristocratiche della Roma tardo-antica: alcuni esempi da ricerche recenti 167CARLO PAVOLINI
Note sulle iscrizioni ‘damasiane’ della basilica di Sant’Ippolito a Porto 173VINCENZO FIOCCHI NICOLAI
Johannes, monaco di San Pietro in Ciel d’Oro, e l’armarium dimenticato di San Savino a Piacenza 181STEFANIA BABBONI
L’immagine di Lemno in Italia tra XV e XVII secolo 185MARINA MICOZZI
Un’impresa per la Virtù. Accademia e parodia nella Roma farnesiana 191PAOLO PROCACCIOLI
I manoscritti di Antonio Bruzio (1614-1692) sulla basilica di San Giovannia Porta Latina 197ALIA ENGLEN
Immagini come documenti. Il caso del Fiume del terrestre Paradiso (1652) di Niccolò Catalano con le incisioni di Francesco Curti 205GIOVANNA SAPORI
Luoghi di memoria e memoria dei luoghi: Costantinopoli e le mura terrestri nei diari del reverendo John Covel (1670-1677) 213ALESSANDRA RICCI
Su alcuni disegni di un frammento della serie dei Rilievi ‘Valle-Medici’ con personificazioni di nationes e civitates 221STEFANO DE ANGELI
Temi di metodo. Mengs, il Barocco e il Naturalismo spagnolo: una riflessione e un interrogativo 227ROSANNA CIOFFI
Survey of Iasos by Royal Navy, 1822 231FEDE BERTI
Le torri di Vlanga Bostani: un tratto perduto delle mura marittime di Costantinopoli nei disegni di Mary Adelaide Walker 237ANDREA PARIBENI
«Ai tempi del potente re Ruggero…». Aubin-Louis Millin a Santa Maria del Patir 245ANNA MARIA D’ACHILLE, ANTONIO IACOBINI
La «stanza di re Ruggero» del Palazzo reale di Palermo dalla destinazione d’uso alla fortuna nell’arte dell’Ottocento 257IVANA BRUNO
Cassette, pissidi, olifanti. Un taccuino inedito di Ugo Monneret de Villard 265SILVIA ARMANDO
Alla ricerca di Cimabue: i disegni di Ingres ad Assisi 271IOLE CARLETTINI
Calamatta: l’ideale d’artista ne Les Maîtres Mosaïstes di George Sand 277ROSALBA DINOIA
Pavel A. Florenskij e il discorso sull’icona 283MARIA LUIGIA FOBELLI
La ‘questione delle origini’: un dibattito nella Viterbo neomedievalista 291MARIA TERESA MARSILIA
Wrap Museum: un progetto di Christo per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma 297STEFANO MARSON
Persistenti memorie. Segmenti identitari dell'arte contemporanea nell'area del Mediterraneo 303PATRIZIA MANIA
VIII. CRITICA, STRUME�TI E METODI DEL RICO�OSCIME�TO
Il riconoscimento come ricostituzione. Per un’edizione commentata della Teoria del restauro di Cesare Brandi 311MARIA IDA CATALANO
Appunti sul ‘restauro preventivo’, oggi 317PIETRO PETRAROIA
L’occhio del fotografo e l’occhio del restauratore 325GIOVANNA MARTELLOTTI
Il restauro scientifico per le opere d’arte decorativa 331MARIA CONCETTA DI NATALE
Fragili oggetti riscoprono antichi contesti 337ROSALIA VAROLI PIAZZA
Percorsi inediti del restauro in Italia negli anni Quaranta del Novecento: Federico Zeri e Mario Modestini 343SILVIA CECCHINI
Politica e accademia: Lionello Venturi, Roberto Longhi e la successione a Pietro Toesca nell’ateneo romano 347VALENTINO PACE
Il dibattito tra arte e architettura in Italia negli anni della ricostruzione (1945-1955) 353ELISABETTA CRISTALLINI
Proposta per una nuova organizzazione museale 359FRANCESCO ANTINUCCI
Niğde Müzezi 365FASLI AÇIKGÖZ
Uso e abuso dei GIS: dal bene immobile alle collezioni museali 367ELENA LATINI
Conservazione preventiva e controllo climatico nei musei: un viaggio fra Viterbo, Teheran e Città del Vaticano 371HAYDÈE PALANCA
La chiesa di Santa Maria Assunta a Monterano: fonti documentarie, stratigrafia, fasi costruttive 375MICHELE BENUCCI, GIUSEPPE ROMAGNOLI
Rilievo morfologico e rappresentazione dell’architettura rupestre 385MARCO CARPICECI
Un futuro per il passato: un tell tra ricerca, conservazione e fruizione 391ISABELLA CANEVA
Dendroprovenienza dei legni dei supporti dipinti (IV-XV secolo) e delle sculture in area mediterranea 397MANUELA ROMAGNOLI
Il contributo delle Scienze della Terra nei beni culturali 403GINO MIROCLE CRISCI, MAURO FRANCESCO LA RUSSA, DOMENICO MIRIELLO
Il MLAC Museo Laboratorio di Arte Contemporanea all’Università degli Studi della Tuscia (1992-1997) 407SIMONETTA LUX
La formazione universitaria nel settore della Conservazione dei beni culturali: qualche riflessione 413GIOVANNI SOLIMINE
L’arte del restauro, eccellenza made in Italy: dalla mente alla mano 421LIDIA RISSOTTO
Al di fuori dei percorsi accademici 427RAFFAELLA PASCUCCI
IX. DAI PO�TEGGI
Lazur de graico colore: sui sentieri del lapislazzulo 431GIOVANNA VALENZANO
I primi due strati dipinti della parete-palinsesto di Santa Maria Antiqua: nuove osservazioni di carattere tecnico-esecutivo 437WERNER MATTHIAS SCHMID
Pittori e mosaicisti nei cantieri di Giovanni VII (705-707) 443PAOLA POGLIANI
L’uso di sagome per dipingere: il ciclo dei Santi Quirico e Giulitta nella cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua al Foro Romano 451VALERIA VALENTINI
Nella basilica di San Pietro a Tuscania, il più antico disegno di cantiere conosciuto del Medioevo italiano? 457RENZO CHIOVELLI
«Prestarsi con tutto amore ed impegno per le cose patrie»: il barone Mandralisca e i restauri ottocenteschi dei mosaici di Cefalù 465VINCENZO ABBATE
Un illustre inedito. L’Istituto Centrale per il Restauro e la prima campagna di restauri dei soffitti della Cappella Palatina di Palermo (1948-1953) 473FRANCESCA ANZELMO
L’esperienza del Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro ‘Michele Cordaro’ nel cantiere di studio del frammento musivo con l’Angelo dalla Navicella di Giotto 479CLAUDIA PELOSI
L’icona musiva di san Sebastiano nella basilica romana di San Pietro in Vincoli. Analisi critica con l’ausilio dell’indagine digitale riflettometrica 487GABRIELE BARTOLOZZI CASTI
Impurezze associate al litargirio in cicli pittorici medievali 495PIETRO MOIOLI, CLAUDIO SECCARONI
Una statua di età giulio-claudia dal Palatino: studio delle tecniche di esecuzione 501SILVIA BORGHINI
The Conservation Work on the Mosaics of the Amazons Villa from Early Byzantine Period, Şanlıurfa-Turkey 507Y. SELÇUK ŞENER
An example of rock-hewn church restoration in Cappadocia: Ürgüp Kayakapı rock church 513BEKIR ESKICI
A propósito de la reciente restauración del claustro de Santa María de Ripoll y del hallazgo de una imagen medieval de estuco 519IMMACULADA LORÉS I OTZET
Restauro di un tratto crollato delle mura medievali di Tarquinia presso la chiesa di Santa Maria in Castello. Metodologia di analisi e di intervento 527MARINA A.L. MENGALI
OMAGGI 533RODOLFO FIORENZA, GAETANO ALFANO, DOMENICO VENTURA
La signora del viaggio 541A Maria Andaloro ΔέσποιναPIETRO LONGO
Corsi tenuti da Maria Andaloro nelle Università di Chieti e Viterbo 545
Maria Andaloro. Bibliografia 1970-2013 547
265
Ugo Monneret de Villard (Milano 1881 –Roma 1954) si laurea in Ingegneria al Politecni-co di Milano nel 1904. Attraverso un percorsosui generis, diventa nei decenni seguenti uno deipiù autorevoli esperti di arte dell’Oriente medie-vale. Un ‘Oriente’ dapprima vagheggiato cometerra delle piramidi e delle principesse sepolte,poi – dagli anni Venti – oggetto di rigorosi studistorici e archeologici. Inizialmente focalizzatosull’architettura e l’arte cristiana medievale, l’o-rizzonte si estende grazie alla scoperta della coe-va produzione islamica: dall’Egitto al Sudan,all’Africa orientale, fino all’Iran. Risalgono al-l’inizio degli anni Trenta anche i primi studi de-dicati all’arte islamica in Italia1. Sebbene questatematica affiori episodicamente dall’immensaproduzione bibliografica di Monneret2, i profon-di e complessi legami tra cultura artistica islami-ca e sviluppo dell’arte nell’Italia meridionalesono oggetto di prolungate riflessioni.
I manufatti eburnei oggi generalmente attri-buiti a quest’area rappresentano il caso più signi-ficativo di un interesse coltivato a lungo dallostudioso, tuttavia mai sfociato in una pubblica-zione specifica.
In ambito europeo l’attenzione per tali ogget-ti si risveglia dalla seconda metà del XIX secolo,in concomitanza col progressivo superamentodell’ideale classico dell’arte che si manifesta nel-la riscoperta di forme artistiche extraeuropee, maanche nel dilagare della passione per le ‘arti de-corative’. Gli olifanti e i pregiati cofanetti in avo-rio, scolpiti o dipinti con repertori ispirati allacultura figurativa islamica e recanti non di radoiscrizioni in arabo, rispondono appieno alleemergenti curiosità di studiosi e collezionisti3.
Le pubblicazioni in cui Monneret affrontala questione, peraltro sotto forma di excursus
all’interno di opere di più ampio respiro,datanoalmeno agli anni Cinquanta4. L’interesse po-trebbe apparire tardivo se paragonato agli studidei colleghi stranieri, ma una serie di materialid’archivio consente di estendere l’arco crono-logico e la portata delle sue indagini ben oltreil limite degli scritti pubblicati.
Il ritrovamento del carteggio con UmbertoZanotti Bianco5, ha rivelato l’esistenza – giàdalla prima metà degli anni Trenta – della vo-lontà di una parte della comunità scientifica eintellettuale di promuovere gli studi di arte isla-mica in Italia: Friedrich Sarre, Paolo Orsi,Giorgio Levi della Vida, Giuseppe Gabrieli enaturalmente Monneret e Zanotti, concordanosulla necessità di promuovere tanto la ricercasul territorio quanto l’istituzione di un insegna-mento universitario dedicato, senza tuttaviatrovare appoggio alcuno tra i rappresentantidella ‘Scienza Ufficiale’, inclini piuttosto a col-tivare il culto della Romanitas. In tale circo-stanza Monneret, rassegnato all’impossibilitàdi istituire nell’immediato una cattedra affidataa seri specialisti, chiede a Zanotti di finanziareun progetto organico di «studio dell’arte mu-sulmana in Italia», come si legge in una letteradel luglio 1934:
«Credo che un procedimento buono sia quellodi cominciare a formare uno schedario di tutto ciòche si sa: spoglio di libri, di riviste, ecc. compilazio-ni quindi di vecchie bibliografie, schede…monu-menti. Insieme reperire tutte le fotocopie [sic] … efar fotografare tutto quanto si può. Cominciare daquanto è più facilmente accessibile: gli oggetti d’artemusulmana d’Italia che si trovano nei musei, poi ri-salire ai monumenti architettonici e se sarà possibileagli scavi»6.
CASSETTE, PISSIDI, OLIFANTI. UN TACCUINO INEDITO DI UGO
MONNERET DE VILLARD
Silvia Armando
La produzione eburnea è il primo nucleoproblematico individuato dallo studioso. Tut-tavia olifanti e cofanetti dipinti sono da studiar-si in connessione con le altre produzionigeneralmente attribuite all’Italia meridionale,come uno degli aspetti di un fenomeno organi-co e ben più articolato:
«Vi sono problemi interessantissimi: cito alcuni:le cassette d’avorio dipinte, gli olifanti, le stoffe. Matutti involvono problemi assai ardui e specialmentequello dell’origine. Sono veramente roba siculo-Ita-lia meridionale? E non piuttosto della Siria Egitto oMesopotamia? Vede che la cosa non è lieve. Bisognaraccoglierli tutti. Studiarli nel loro complesso … Fi-nalità sarebbe di pubblicare tanti fascicoli, ognunodedicato a un gruppo di monumenti: per ritornareagli esempi citati, uno delle cassette dipinte, uno de-gli olifanti ecc.»7.
Soltanto il fascicolo dedicato alla cassetta in-crostata della Cappella Palatina vedrà la luce,nel 19388; il progetto viene poi interrotto, forsea causa delle turbolenze legate allo scoppiodella guerra, probabilmente anche a seguitodelle persecuzioni politiche subite da Zanottiin quanto antifascista9.
La raccolta sistematica di dati e materialirappresenta per Monneret l’imprescindibile
punto di partenza di ogni ricerca e lo studiofondato sull’osservazione di fotografie prose-gue per l’intera carriera: circa seimila immagi-ni sono conservate presso l’Istituto Nazionaledi Storia dell’Arte di Roma e costituiscono unvariegato fondo d’archivio, suddiviso in ordinealfabetico con criterio geografico; sono moltele fotografie di cofanetti eburnei e olifanti di-stribuite nei diversi faldoni (fig. 1)10.
Oltre alle fotografie, anche l’archivio di stu-dio di Monneret è stato donato all’Istituto, ma èdepositato presso la Biblioteca di Archeologia eStoria dell’Arte di Roma11: si compone di tac-cuini, appunti, note bibliografiche, disegni, lacui ricchezza rispecchia la straordinaria varietàdegli interessi coltivati dallo studioso. Vi si trovail già noto catalogo Opere di arte Islamica inItalia: una «raccolta di note», come volle defi-nirla Monneret, di circa quattrocento schede ma-noscritte, corredate di una prefazione e di unaaccurata bibliografia, dedicate a manufatti isla-mici presenti in Italia. Redatto nel 1954, il cata-logo rimase purtroppo inedito in seguito allamorte dello studioso, avvenuta lo stesso anno12.
Lo spoglio sistematico dell’archivio13 hacondotto al recupero di un importante taccuinodi appunti, intitolato AVORI ARABO-SICULI.CASSETTE – E PISSIDI – OLIFANTI14. Esso ècomposto da circa centoventi pagine, ma inclu-
266 SILVIA ARMANDO
FIG. 1 Roma, Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, Fototeca, Fondo Ugo Monneret de Villard, n. inv. 70978, cofanetto di Würzburg(distrutto dai bombardamenti nel 1945)
de anche numerose note sparse (fig. 2). Le primesettanta pagine sono dedicate alle cassette dipin-te, le successive agli olifanti (fig. 3) e ai cofanettiscolpiti. A ciascuna pagina corrispondono uno odue manufatti conservati nel medesimo luogo:sono riportate misure, eventuali numeri di in-ventario, riferimenti bibliografici e fotografici.Spesso queste brevi schede sono accompagnateda disegni o schizzi e dalla trascrizione delleiscrizioni in arabo, qualora presenti15.
I riferimenti bibliografici permettono di ri-salire con una certa precisione agli anni in cuiMonneret redasse il taccuino: gli importanti ca-taloghi dedicati da Perry Blythe Cott e JosèFerrandis agli avori dipinti, pubblicati rispetti-vamente nel 1939 e nel 194016, non sono maimenzionati17; il testo più recente tra quelli citatirisale al 193418, fatta eccezione per rare notesparse che arrivano al 193919. È dunque possi-bile collocare la redazione del taccuino neglistessi anni in cui Monneret de Villard collaboracon Zanotti Bianco, e cioè tra il 1934 e il193820. Si tratta con ogni probabilità di quei da-ti «raccolti intorno agli avori dipinti musulmani
dell’Italia meridionale» ai quali Monneret si ri-ferisce in una lettera inviata a Zanotti nel mar-zo 193521, proseguendo: «Questi sono almenocinquanta, o almeno tanti sono a me fin’ora no-ti: non mi nascondo che attente indagini ne po-tranno aumentare il numero». La lista èdestinata ad arricchirsi negli anni seguenti: nel1937, completato il fascicolo dedicato alla cas-setta incrostata, Monneret annuncia «Ho giàraccolto moltissimo materiale per il II (gli avoridipinti) e per il III (gli avori scolpiti)»22. Il tac-cuino include in effetti riferimenti a circa set-tanta cofanetti con decorazione dipinta, oltreche a più di trenta olifanti e quasi una decinadi cofanetti con decorazione scolpita. Per gliavori scolpiti le note sono tuttavia meno ag-giornate23. Oggetto d’interesse principale sonoi cofanetti, per i quali Monneret prevede la rac-colta sistematica di fotografie:
«parecchi debbono essere fotografati da più lati,quindi occorreranno circa 100 fotografie … Natu-ralmente durante questi viaggi raccoglierei anchetutto il materiale … per le altre opere d’arte musul-
267Cassette, pissidi, olifanti. Un taccuino inedito di Ugo Monneret de Villard
FIG. 2 Roma, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Fondo Monneret, Scatola 7, C15, copertina e f. 12a
268 SILVIA ARMANDO
mana dell’Italia meridionale che si trovano nei mu-sei d’oltr’alpe»24.
Lo studio è configurato come un vero eproprio catalogo e le schede del taccuino pos-sono essere considerate ‘progenitrici’ di quellerelative ai manufatti eburnei incluse nella rac-colta Opere d’arte islamica in Italia, redattanel 1954. È probabile che la pubblicazione delcatalogo di Cott, avvenuta nel 1939, abbia in-dotto Monneret ad abbandonare, almeno tem-poraneamente, il lavoro.
Si è detto che solo negli anni CinquantaMonneret pubblica alcune considerazioni aproposito degli avori dipinti25. Sulla base del-l’osservazione di aspetti stilistico-iconograficiegli ipotizza l’esistenza di due ‘scuole artisti-che’, nettamente distinte e sviluppatesi non pri-ma della seconda metà del XII secolo: l’una daattribuirsi alla Persia occidentale, se non all’a-rea mesopotamica, per la presenza di iconogra-fie cristiane; l’altra, caratterizzata da uno stilepiù raffinato e da dettagli che richiamano la tra-
dizione mongolica, da collocarsi nel cuoredell’area iranica. Monneret riprende in parte leposizioni già espresse da altri26, opponendosifermamente all’ipotesi di una provenienza sici-liana già autorevolmente formulata da Küh-nel27, poi ribadita da Ferrandis e Cott. Inparticolare, taccia d’indolenza quei «molti stu-diosi che preferiscono accettare una attribuzio-ne suffragata dal nome di uno scrittore di valore[Kühnel], piuttosto che sobbarcarsi della faticadi riesaminare a fondo un vasto materiale»28, edetichetta lo studio di Cott come presuntuoso29,non senza tradire una punta di invidia o di irri-tazione quando fa riferimento ai «larghi mezzifinanziari» su cui lo studioso americano ha po-tuto contare30. L’asprezza dei toni è dovuta for-se, almeno in parte, alla delusione per non averpotuto pubblicare per tempo un lavoro che –non più tardi del 1938 – era già a uno stadiosorprendentemente avanzato, come dimostra iltaccuino. Di fatto nei suoi scritti editi Monneretasserisce con convinzione quanto aveva soloipotizzato nelle lettere a Zanotti Bianco, cioè
FIG. 3 Roma, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Fondo Monneret, Scatola 7, C15, ff. 36v-37r
269Cassette, pissidi, olifanti. Un taccuino inedito di Ugo Monneret de Villard
Queste riflessioni intorno al fortunato ritrovamento diun taccuino di appunti di Monneret de Villard dedicatoagli avori ‘arabo-siculi’ sono il mio piccolo omaggio aMaria Andaloro: metaforicamente, il quadernetto racchiudein sé i miei due principali filoni di ricerca, nati e coltivatigrazie al suo prezioso sostegno.
1 Per un profilo biografico-scientifico del personaggio eper ulteriori riferimenti bibliografici: S. ARMANDO,Monneret de Villard, Ugo, in DBI, vol. LXXV, Roma2011, pp. 698-701; EAD., Ugo Monneret de Villard (1881-1954) and the Establishment of Islamic Art Studies inItaly, in «Muqarnas», 30 (2013), pp. 31-71.
2 Ivi, bibliografia integrale di Monneret de Villard in ap-pendice.
3 Per ragioni di spazio non è possibile riportare qui imolti studi. Si veda S. ARMANDO, Avori ‘arabo-siculi’nel Mediterraneo medievale, Tesi di dottorato, Universitàdegli Studi della Tuscia, Viterbo 2012, tutor Maria Andaloro,vol. I, pp. 27-52 e bibl. Numerosi manufatti entraronopresto nei musei d’arte decorativa europei e americani; atitolo di esempio: Victoria and Albert Museum, Londra,nn. inv. 4073-1857 e 603-1902, acquisiti rispettivamentenel 1857 e nel 1902.
4 U. MONNERET DE VILLARD, Le pitture musulmaneal soffitto della Cappella Palatina in Palermo, Roma 1950,pp. 29-30; ID., Arte cristiana e musulmana del Vicino
Oriente, in Le Civiltà dell’Oriente, a cura di G. Tucci, Roma1962, vol. IV, p. 508 (pubblicazione postuma).
5 S. ARMANDO, Ugo Monneret de Villard (1881-1954),cit.
6 Roma, Associazione Nazionale per gli Interessi delMezzogiorno d’Italia (d’ora in poi ANIMI), ArchivioStorico dell’ANIMI (d’ora in poi AS ANIMI), A.III.03.UA29:«Monneret de Villard. Monumenti dell’arte musulmana inItalia». Monneret a Zanotti, 2 luglio 1934.
7 Ibidem.8 U. MONNERET DE VILLARD, Monumenti dell’arte
musulmana in Italia, I. La cassetta incrostata dellaCappella Palatina di Palermo, Roma 1938.
9 Per riferimenti bibliografici aggiornati: S. ZOPPI, Um-berto Zanotti-Bianco. Patriota, educatore, meridionalista,Soveria Mannelli 2009.
10 Roma, Istituto Nazionale di Storia dell’Arte (INASA),Fototeca, Fondo Ugo Monneret de Villard. Tra gli altri, icofanetti di Würzburg (nn. inv. 70977-70980) e Fitero(nn. inv. 67115-67117), e il pettine dipinto di Roda deIsabena (nn. inv. 70070,70071).
11 Roma, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte(d’ora in poi BiASA), Fondo Monneret. F. ZANNONI, Ilcarteggio e l’archivio di studio di Ugo Monneret de Villardnella Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma,in L’eredità di Monneret de Villard a Milano. Atti del con-
l’origine orientale degli avori dipinti. È tantopiù curioso che il quadernetto sia intitolato agliavori ‘arabo-siculi’, e che in tale categoriaMonneret abbia incluso non solo i manufattidipinti, ma anche cofanetti e olifanti con deco-razione scolpita31.
Sempre negli anni Cinquanta Monneretviene incaricato di redigere un testo dedicatoagli avori dipinti per la prestigiosa Encyclopé-die de l’Islam, come testimonia lo scambio epi-stolare relativo alla compilazione della voce’Adj, ‘avorio’, datato al 195232. M.S. Stern di-chiara che i membri del comitato scientifico so-no impazienti di ricevere il testo dedicato agliavori dipinti, poiché Monneret è «the foremostexpert on this subject»33. Egli è pertanto con-siderato a livello internazionale tra i migliorispecialisti; tuttavia la voce viene infine redattada Ralph Pinder-Wilson34.
La documentazione rinvenuta è preziosa te-stimonianza della quantità e varietà di materialiinediti relativi agli studi di Monneret che atten-dono di essere valorizzati e resi più facilmentefruibili. Emergono anche la forza e la moder-nità di un metodo che, con rigore e precisione,
intende ricondurre a sistema anche i manufattitotalmente decontestualizzati. Il taccuino Avoriarabo-siculi rappresenta un tassello mancantetra il progetto concepito da Monneret grazieallo stimolo di Zanotti Bianco e la redazionedi Opere d’arte islamica in Italia, assai più tar-da. Inoltre, le informazioni in esso contenutecostituiscono una fonte significativa per lo stu-dio degli avori dipinti.
Nel complesso, dalle brevi pubblicazioni,dalle note d’archivio e dalla corrispondenzasi evince un’attenzione precoce e persistenteper il tema degli avori, osservati sì come grup-po a sé stante, ma anche come declinazionepeculiare del più ampio e problematico feno-meno artistico della produzione e della diffu-sione di opere d’arte islamica in Italia, cheMonneret voleva approfondire in tutte le sueparti. Sebbene le sue considerazioni sulla pro-duzione eburnea medievale abbiano trovatoscarso consenso negli studi successivi35, il ruo-lo dello studioso merita di essere riconsideratoalla luce dei suoi scritti editi e inediti, ufficialie privati, per entrare a pieno titolo nella storiadegli studi.
vegno, Politecnico di Milano 27-29 novembre 2002, acura di M.G. Sandri, Firenze 2004, pp. 15-21.
12 BIASA, Fondo Monneret, scatole 6 e 9. Per una primadescrizione: M.A. LALA COMNENO, Monneret islamista:il Catalogo Opere di arte islamica in Italia, in L’ereditàdi Monneret de Villard, cit., pp. 63-65. Si veda anche S.ARMANDO, Ugo Monneret de Villard (1881-1954), cit.Del catalogo esiste anche una versione dattiloscritta, curataverosimilmente dallo stesso Monneret. Alcune schede, siamanoscritte che dattiloscritte, sono sparse in faldoni di-versi.
13 Le ricerche sono state effettuate grazie ad una borsadella Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paoloin collaborazione con l’Institut National d’Histoire de l’Artdi Parigi (novembre 2007-ottobre 2008). Di recente si è resadisponibile presso la BiASA la consultazione di un inventariodigitale del fondo con la supervisione di un funzionario.
14 BiASA, Fondo Monneret, Scatola 7, C 15 (d’ora in poiTaccuino avori).
15 Monneret numerò tutte le pagine con un pastello rossomentre in apertura inserì un indice alfabetico (sebbene in-completo) dei luoghi.
16 P.B. COTT, Siculo-Arabic Ivories, Princeton 1939; J.FERRANDIS, Marfiles arabes de Occidente, Madrid 1940,vol. II (il primo volume, dedicato agli avori spagnoli, erauscito nel 1935).
17 Monneret cita invece J. FERRANDIS, Marfiles y aza-baches españoles, Barcellona 1928; assente dai riferimentiP.B. COTT, Siculo-Arabic Ivories in the Museo Cristiano,in «The Art Bulletin», 12 (1930), n. 2, pp. 131-146.
18 A.O. QUINTAVALLE, Avori medievali nelle pubblichecollezioni napoletane, in «Bollettino d’Arte», III serie, 28(1934), pp. 198-214 (Taccuino avori, foglio 27v).
19 Ad es. G.H. DOBLE, The relics of Saint Petroc, in «An-tiquity», 13 (1939), pp. 403-415 (Taccuino avori, foglio34b).
20 In effetti, anche il timbro sulla copertina del quadernoriporta sia il nome di M. che l’indirizzo della sua residenzamilanese, lasciata nel 1937 per trasferirsi a Roma.
21 AS ANIMI, A.III.03.UA29: «Monneret de Villard. Mo-numenti dell’arte musulmana in Italia». Monneret a Zanotti,28 marzo 1935.
22 Ivi, lettera del 20 maggio 1937.23 Mancano indicazioni bibliografiche essenziali quali gli
scritti dedicati da O. Von Falke agli olifanti, si veda«Pantheon», 4 (1929), pp. 511-517 e 5 (1930), pp. 39-44.Poiché le note sugli olifanti si trovano nella seconda metàdel taccuino, non è logico supporre che la loro redazione siaprecedente a quelle relative agli avori dipinti: la mancanzadi aggiornamenti può forse essere attribuita a un interessemeno urgente.
24 AS ANIMI, A.III.03.UA29: «Monneret de Villard. Mo-numenti dell’arte musulmana in Italia». Monneret a Zanotti,28 marzo 1935.
25 V. supra nota 4.26 Monneret citava espressamente gli studi di Ernst Diez e
Philippe Lauer. Si vedano rispettivamente: E. DIEZ, BemalteElfenbeinkästchen und Pyxiden der islamische Kunst, in«Jahrbuch der Königlich preussischen Kunstsammlungen»,31 (1910), pp. 231-244 e 32 (1911), pp. 117-142; P. LAUER,Le trésor du Sancta Sanctorum, Paris 1906. Per un dettagliatoquadro storiografico v. S. ARMANDO, Avori ‘arabo-siculi’nel Mediterraneo, cit., vol. I, pp. 27-52.
27 E. KÜHNEL, Sizilien und die islamische Elfenbein-malerei, in «Zeitschrift für bildende Kunst», 25 (1914),pp. 162-170.
28 U. MONNERET DE VILLARD, Le pitture musulmane,cit., p. 29.
29 ID., Arte cristiana e musulmana, cit., p. 508.30 ID., Le pitture musulmane, cit., p. 29.31 Va anzi specificato che molte delle note dedicate agli
olifanti sono accompagnate da appunti a matita che specificano«siculo», «non siculo», «arabo-siculo».
32 BiASA, Fondo Monneret, MS MONNERET II. Stern aMonneret de Villard, 20 maggio 1952.
33 Ibidem.34 Ibidem. Dalla lettera si evince il disappunto di Monneret,
che avrebbe voluto gli fosse assegnata l’intera voce. Laparte dedicata ai «commercial objects» e agli avori scolpitiera invece stata assegnata a Pinder-Wilson, che più tardiavrebbe pubblicato uno studio sugli avori dipinti ad oggiconsiderato imprescindibile: R. PINDER-WILSON, C.BROOKE, The Reliquary of St. Petroc and the ivories ofNorman Sicily, in «Archaeologia or Miscellaneous tractsrelating to antiquity», 104 (1973), pp. 261-305
35 È la tesi siciliana a prevalere nella storiografia piùrecente, cfr. S. ARMANDO, Avori ‘arabo-siculi’ nel Medi-terraneo, cit., vol. I, pp. 43-57.
270 SILVIA ARMANDO






















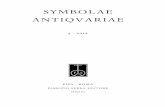




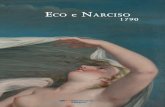





![Ugo ZANETTI, L'Église Copte, dans Seminarium, 38 [= N.S. 27, 3] (1987), p. 352-363.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317feafd93a162f9c0e5f64/ugo-zanetti-leglise-copte-dans-seminarium-38-ns-27-3-1987-p-352-363.jpg)

