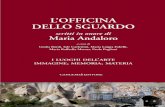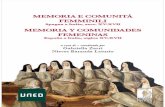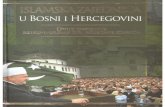Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti
La parole e le cose. La comunità immaginata di Ugo Pellis
-
Upload
independentscholar -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La parole e le cose. La comunità immaginata di Ugo Pellis
15
17
19
INDICE
39
Lorenzo Pelizzo(PRESIDENTE SOCIETA FILOLOGICA FRIULANA)
Presentazione
Silvano Antonini Canterin(PBESIDENTE FONDMIONE CASSA DI BISPARMIO DI UDINE E PORDENONE)
Presentazione
Claudio DominiUgo Pellis fotografo. La lingua della fotografia, la fotografia della lingua
Enrico BiasinLa parole e le cose. La comunità immaginata di Ugo Pellis
Lorenzo Massobrio«Mi sono rampigato fora dai malanni, o squasi».lmpegno e cerlezze di Pellis nel lavorodi preparazione dell'Atlante Linguistico ltaliano.
63
75 Stefano PerulliLa catalogazione del fondo fotografico ugo Pellis: criteri e modalità.
121 SEZIONEFOTOGRAFICA
Indice / I1
Enrico Biasin
La parole e Ie cose.La comunità immaginata di Ugo Pellis
Ballentare la modernità e ricomporre il nazionaleL'ttalia, come nazione, ha costantemente incontrato notevoli difficoltà a farvalere il proprio statuto unificatore. ll nostro Paese, infatti, nonostante i ripetutieaccorati appelli, dopo il 1861, all'unità nazionale, lanciati a viva voce dapersonalità politiche indigene, ha faticato ha trovare per sé un'immagine cul-trale socialmente condivisa e strategicamente efficace. John Dickie ha
sintetizzato tale fondamentale assunzione con queste parole: "La storiad'ltalia, sin dal momento dell'unificazione politico-territoriale, è sempre sta-ta scritta come la storia del continuo fallimento a costruire una nazione e
creare una relazione concreta tra Stato e cittadini"'. D'altra parte, com'èrdo, per Antonio Gramsci la mancanza per l'ltalia di un progetto "nazionalepopolare" ha drammaticamente coinciso con un'altra ragguardevole ina-
dernpienza: il vuoto di egemonia culturale, politica e sociale lasciato dalleftrze socialiste autoctone all'alba del Novecento'z. Una simile assenza dipospettiva si è riverberata sino ai nostri giorni, tanto che ci è consentito dirùouarci in una nazione soltanto quando alcuni epifenomeni indotti dallalcrlt-rra popolare" (si pensi, per esempio, alle occasioni sportive nelle quali
FIG,1RITRATTO DI UOIVO CON BADILE;A TERRA: GERLA CON PELLED'ANIMALE SULLA PABTECHE SI APPOGGIA ALLA SCHIENA,VALFURVA, SONDRIO, 1937.
La parole e Ie cose. La comunità immag:inata di Ugo Pe11is / 39
gioca la Nazionale di calcio) immergono le nostre individualità entro un fluidocoesivo e rassicurante.ll fascismo ha puntato morto sul|identità nazionare e suile sue accessoriepotenzialità strumentali. ln particolare, il regime mussoliniano ha avuto buongioco nell'impadronirsi der mito di rigenerazione nazionare nato in epocarisorgimentare e ro ha utirizzato quare àispositivo ideorogico adatto a creareconsenso3. Questo mito, ha osservato Emirio Gentire, è lervito quare mezzodi riscoperta palingenetica del ruolo affidato alla nostra nazione nella missionetesa al superamento deile awersità che hanno episodicamente accompa_gnato il manifestarsi deila modernità negri svariati campi deila vita sociare,culturale e poritica itariana dart'ottocentò sino armeno agri anni rrentao. si èarticolata per il suo tramite, per adoperare un'espressiorie coniata di recen-te dalla psicoanarista Louise J. Kapran, una «strategia feticista,, ir cuiprincipio si è risolto nel "trasformare qualcosa di stràno e intangibile [lanazionef in..qualcosa di famiriare e tangibire [r'identità nazionarefus. Tareaggregato di valori prodotto in forma discorsiva si è definito come ir mecca_nismo essenziale attraverso cui lo stato fascista ha potuto garantire agriitaliani la possibilità di entrare senza timori nella modernità pur restandolegati al terreno della tradizione, ed in particolar modo a quello della tradi_zione risorgimentare.. scrive a tar proposito Ruth Ben-Ghiai:
Numerosi moderli di modernità si contesero la regittio'azione u_fficialesotto Ia dittatura, ma tutti presentarono iI fascismo come un movimentoche avrebbe arrestato la diffusione det materialismo, della standardizza_zione e dena degenerazione, pur apportando al contempo agri itariani ivantaggi di vivere moderno. Arl'interno di questo schema, gli spazi delamodernità - qua,li il cinema, le coronie, Ie adunate di massa - avrebberoperso ogni legame con l'anarchia e ta decadenza sociate per diventareluoghi di rafforzamento dell,ordine e delLa gerarchiaT.
È proprio all'interno di questo paradigma storico e curturare che va circo_scritta l'analisi dell'operazione compiuta da Ugo pellis e daglispecialisti chelo coadiuvarono neil'impresa in merito aila preparazione e ail,esecuzione derprogetto riguardante rAilante Linguistico ltariano (d,ora in poi, ALI).
lO/Enrico Biasrn
L"importanza scientifica del lavoro, soprattutto se considerata in rapporto ai
mvistudi d'ambito dialettologico allora in stato diaffinamento metodologico,rrm va affatto disconosciutas. Cio che in questa sede si desidera porre inrkvo è bensì l'aspetto ideologico dell'operazione, nella quale hanno giocatoln ruolo non di poco valore le immagini fotografiche scattate da Pellis nel
Gmlo della sua ricerca.H considerare tali fotografie dobbiamo tenere conto anche del quadro isti-
in cui esse sono state inserite, così come dobbiamo farealle diverse produzioni discorsive lasciate in questi stessi anni
mstro raccoglitore-fotografo'g. ln tal senso, Liz Wells ha notato come i
istituzionali nei quali le immagini fotografiche trovano una propriae una propria sisiemazione sono di vitale importanza per la loro
La nozione di "istituzione" è un qualcosa che rimanda, dun-rsr solo agli istituti e organizzazioni che in senso proprio promuovono
in quanto forma culturale (archivi, associazioni di fotografi,d fotografia, riviste di fotografia ecc.), ma altresì alle "istituzioni in
alle quali la fotografia fa la sua comparsa, nelle quali delle conven-hglafiche specifiche sono emerse"'.. Ed è proprio dall'analisi di
- per un verso istituzionali e per l'altro discorsivi- che si pro-di un'opera fotografica.
al nostro specifico caso, i testi fotografici, allo stesso modo diprodotti dal nostro autore, suggeriscono, infatti, due fondamen-
il ffiegia: da un lato, ricondurre la manifestazione di ciò che è
ffiittura marginale entro un orizzonle culturale e ideologico di
; dall'altro, inserire delle operazioni sicuramente innovative
- }a preoccupazione di raccogliere dei dati in modo sistematicoatrmlendosi peraltro del dispositivo fotografico - entro la prassi
Da una parte, quindi, c'è il gesto di ricomporre il "nazionale",Cè llatto di rallentare la modernità. Entrambe le procedure se
- Grrne vedremo fra poco - la volontà di avallare il progetto diipotizzato e praticato dallo Stato fascista in quegli stessi
prE esse rivelano la difficoltà di allargare i contorni linguisticiqindi cercando di farli coincidere con quelli dell'unica forma
quella nazionale.
La parole e 1e cose. La comunità immaginata di Ugo Pe1lis / 41
ll progetto e i! discorso: I'Atlante Linguistico ltalianoL'ALI si presenta agl'occhi dei contemporanei come una collezione ordinatae slsfemafica di carte sulle quali sono state metodicamente riprodotte le tra-duzioni dialettali di un concetto, nozione o frase appartenenti alla viva vocedi parlanti abitanti più di settecento località dell'allora Regno d'ltalia,,. Lacornice istituzionale che fa da guida e supporto alla costituzione di taleatlante linguistico risale agli anni antecedenti alla Grande Guerra, quandoMatteo Giacomo Parodi dell'lstituto di studi superiori di Firenze insieme aMatteo Bartoli dell'Università diTorino cominciarono a studiare il piano di unatlante linguistico italiano, preparandone la bozza12. L'idea, mai abbandonatadeltutto, fu ripresa ad ostilità cessate. Com'è noto, l'intera operazione costòla fatica di quasi due decenni di lavoro, dal 1925 al 1943, e vide all,opera,oltre allo stesso Pellis, anche Matteo Bartoli e Giulio Bertoni, linguistidell'Università di Torino.secondo gliauspici dei suoi promotori, I'ALl avrebbe dovuto servire a cata-logare le parlate "italiane" in tutti i territori entro i quali si distribuiva lanostra nazione, spingendo il proprio raggio d'azione addirittura oltre i mar-gini "naturali" da essa allora raggiunti. ln un articolo pubblicato nel 1g24dalla "Rivista della Società Filologica Friulana", ente patrocinatore dell'in-tero progetto, si può infatti leggere: «Questa ardimentosa opera italianasarà, in primo luogo, il documento indistruttibile del confine linguisticoanche al di là di quello politico; e, allargata alle aree linguistiche italianed'Oltreoceano, attesterà la nostra forza d'espansione,,3. Un simile propositofa il paio con un di poco successivo intervento di Giuseppe Vidossi, il quale,dalle pagine del "Bollettino dell'Atlante Linguistico ltaliano", elenca lesostanziali novità metodologiche che il progetto promosso dalla FilologicaFriulana si preoccuperà di porre in atto rispetto al pur lodevole lavoro intra-preso per la compilazione, ad opera di studiosi svizzeri e di pocoprecedente, dell'Atlante Linguistico ed Etnografico dell'ltalia e dellaSvizzera meridionale'0. L'ALI, secondo Vidossi, avrà il merito di differenziar-si dall'opera consimilare non sels «per l'ampiezza del questionario; per ilnumero dei punti d'assaggio; per i criteri seguiti nella compilazione del que-stionario e nella scelta dei punti d'assaggio,,, ma altresì in ragione di treaspetti fondamentali:
42 I Enrìco Biasin
1. per iI modo come fu concepito da studiosi italiani come opera italiana;2. per I'inclusione di tutti i territori italiani situati fuori dai confini del
Regno;3. per I'inclusione di tutte le'penisole e isole alloglottiche" che si trovano
nei confini del Regno, nonché dei gerghi che vi si parlanols.
ll tentativo di rilanciare, in chiave nazionalista prima ancora che in quellaerninentemente fascista, l'idea di una "forte" e circoscritta identità nazionaleappare, tutto sommato, evidente: in un frangente storico nel quale l'ideaottocentesca di Stato-nazionel. sembra essere posta in discussione in virtùdi una serie di spinte laterali centrifughe (gli idiomi locali)", il proposito prin-cipale è quello di ricondurre ogni particolarità culturale al fulcro diirradiazione nazionale.Sotto questa configurazione istituzionale, locale e globale, periferia e centro,ùovano il modo non solo di convivere ma anche di saldarsi e di trasformarsi avbenda. Più che tenere le distanze dall"'altro" da sé, promuovendo Ia propriaspecificità individuale, cio che dunque si punta ad attuare è una sorta di appro-priazione dei caratteri costitutivi e originali di chi ci si pone dinnanzi e sembrastuggire dalle proprie coordinate di controllo. Si tratta di una pratica di appro-priazione formale che Stuart Hall ha così definito: "è solo attraverso la relazionecon I'Altro, la relazione con ciò che non è, con ciò che precisamente manca,con ciò che è stato chiamato il suo esterno costitutivo, che il significato "posi-tirc' di ogni termine - e quindi Ia sua "identità" - può essere costruito"'u. Lapcta in gioco, sotto questo profilo, è quindi quella di riformulare l'identità ita-kn della lingua e del territorio a partire - e non a prescindere - dalle singoleparlate regionali. lmplicito è in tal senso il convincimento in forza del quale
anche le aree più ristrette serbano al loro interno delle differenze e per conse-g[Enza sono segnate da frontiere: "Sebbene si possa tutti acconsentire -scrive PaulWillemen - che le zone culturali sono lontane dall'essere spazi uni-ficdi, omogenei, ciò non deve indurci a negare o indebitamente a relalivizzarefesistenza dei confini"'n. ln nome dell'affermazione di questo principio, ifauto-;i ddl'All hanno quale obiettivo quello di indagare i margini linguistici nella loroftir:nomia interna, per poi convenientemente adeguarli alla logica nazionale.
La parole e Ìe cose. La comunitàt, tmmaginata di Ugo Pellis / 43
dell'All, è necessario porci degli interrogativisu quelli che sono stati gli ordlnldi discorso che hanno dato corpo, sul piano della pratica della scrittura, aspecifici modi di concepire lo strumento dell'atlante linguistico in rapportoall'esistenza delle parlate dialettali. Per ordine didiscorso s'intende un insiemediscorsivo che, prescindendo dalla propria logica linguistica ed espressiva,dà origine a degli aggregati socio-culturali, capaci di costituire dei carytpiepistemologici tramite i quali osservare e circoscrivere la realtà. Nelle parole diNorman Fairclough,
Un ordine di discorso è una rete di pratiche sociali nel suo aspetto dilinguaggio. t...1 Gli ordini di discorso sono organizzazioni sociali e
di controllo della variazione linguistica, e i loro elementi (discorsi,generi, stili) sono in misura corrispondente non categorie puramenteIinguistiche ma categorie che superano la divisione fra linguaggio e"non-linguaggio", fra il discorsivo e il non-discorsivo20.
lnnanzitutto, è possibile separare le pratiche di discorso individuali,"autoria-li" - quelle che in termini foucaultiani possiamo leggere come pratiche
"fondatrici di discorsività"" e quelle che, per comodità di analisi, indichiamocome più prossime al percorso di scrittura e di riflessione teorica lungo il qualesi muove lo stesso Pellis -, da quelle collettive. Nondimeno, quest'ultime gio-cano un ruolo assai rilevante nel rilanciare assunzioni ideologiche e modi dipensare non necessariamente collegati fra loro, e quindi privi di una certa coe-renza strutturale, ma capaci allo stesso tempo di creare nodi discorsiviindubbiamente rilevanti e di intercettare modelli enunciativi simili a quelli
espressi nella loro forma individuale dal nostro raccogliore-fotografo.ll primo ordine di discorso che prendiamo in considerazione riguarda la ten-denza, riscontrata in alcuni testi interessanti I'ALI, a trovarsi in uno stato digenerale problematicità epistemologica circa lo statuto da attribuire alla nozionedi "regione" in rapporto alla missione autenticamente "nazionale" assegnataall'Atlante. Per esempio, in polemica con il professor Bottiglioni, il già citatoGiuseppe Vidossi boccia ogni concezione regionalistica che dovrebbe guidare,sul piano esecutivo, la stesura dell'Atlante per elogiarne, invece, le qualità di '
metodo esclusivamente d'impronta nazionale. Scrive Vidossi:
44 / Enrico Biasin
I principi di metodo, da cui il prof. Bottiglioni dissente, dell'esploratoreunico e dell'uniformità delle domande, intesa con qualche mitigazione,
. rispondono [...] alla concezione dell'Allt come atlante unitario e totalitario,cmforme alla realtà lingrristica unitaria e totalitaria d'Ita,lia, cioè alla evi-dcnte realtà, nazionale, e non a evanescenti e arbitrarie divisioni regionali.
l---l I,o spezzettaxtento, necessariamente arbitrario, del territorio naziona-
b, consegrrenza della W@iatnzzazione, in sezioni che non potrebbero mai
rinsaldarsi in unità, non può concilarsi con i fini di un aUante unitario".
lq,radro discorsivo si complica ulteriormente quando guardiamo ad alcunirftdi pubblicati all'interno del periodico ufficiale della Società Filologicaftiltra, il mensile "Ce fastu?". ln esso prendono a confluire interventi che,
ad altri ordini di discorso che si perpetuano al di fuori delledella rivista, tendono a riprodurre concetti e forme d'intervento cul-quali quelli riferibili alle nozioni di "strapaese" e "stracittà". ln
in simili ambiti discorsivi si può scorgere nel "regionalismo" il
contrapposto a quello di "urbanesimo", ed un uso del primo alladi referente ideale per trasmettere la tradizione e gli ideali nazionali
rce- A tale riguardo, si puo leggere in un articolo del 1929:
la lotta risorta è tra strapaese e stracittàr, basato iI primo sulla valo-
Lme dei nostri valori nazionali, in massima data dal regionalismo,sul1a diffusione del verbo nuovo nel mondo, verbo italico, otte-
qualsiasi rrlezzo, anche forestiero, pur di raggiungere Io scopo.
[a vittoria resterà certo a strapaese, visto e considerato Io sviluppopreso da poco tempo a questa parte dai vari folklorismi regiona-
:[Etùé a,nche la nostra maggiore poetessa, Ia Deledda, insignita del
[ùùel, è essenzialmente regionale, più che italiana del tutto,23
v'è la sostanziale, netta, contrapposizione fra i valori culturali
italiana, espressi nell'endiadi nazionale-locale, e i valori culturali
che trovano una loro esemplificazione immediata nell'urbane-sapde cosmopolita. Fra i due sistemi valoriali quello che risulta
è I primo, data la facilità con cui è possibile articolare in maniera
La parole e le cose. La comunità immaginata di Ugo Pellis / 45
opportuna la coppia dei suoi elementi costitutivi ("nazionale', e ,,locale,,) albscopo di rilanciare l'identità culturale di un paese. In questo senso va dunqueinteso il contenuto del seguente passaggio, la cui paternità è direttamenteriferibile all'istanza discorsiva che si è vista all'opera entro il testo precedenter
"La corrente letteraria di strapaese sta vincendo: il folklorismo predomina sututta la linea. [...] Sembrami quindi che le tradizioni popolari italiane costitui-scano una ricchezza artistica, e oltreché artistica, anche patriottica, spirituale,atta ad unire, ad allacciare, a permeare della sua sana vitalità tutta l'anima ita-lica"2o. cultura popolare, tradizione nazionale e particolarità locale vengono aquesto punto a coincidere nell'unico progetto plausibile: quello di awallareuna coesa identità italiana.D'altro canto, lo stesso mezzo dell'atlante linguistico serve a formalizzare unaserie di reciproci scambi fra esperienze culturali nazionali e fenomeni circo-scritti a livello locale. ln ciò esso si pone quale uno dei veicoli essenziali perinnestare, entro la comunità di una nazione, forme di modernità. Bartoli, adesempio, guarda a tale dispositivo di raccolta linguistica alla stregua di unmuseo, al cui interno collezionare tanto le testimonianze del presente quantodel passato secondo un'ottica d'avanguardia che mira in paritempo alla assi-milazione e alla suddivisione delle differenze: "LAtlante dev'essere sopra tuttouno strumento di lavoro, e non ha da essere unicamente - come altri vorreb-be - un magazzino d'antiquario. Dev'essere tutto un Museo di arte antica emoderna, popolare e aristocratica, rustica e urbana,2s. Ma c'è chi si spinge piùavanti, avocando proprio all'atlante linguistico il compito di riscoprire, sotto lacoltre del tempo, cio che si presume essere l'autentica anima della nazione: aldi là della prospettiva puramente geneaologica di cerle indagini storiche,occore porre in risalto come le singole parlate di un luogo geografico possanorispecchiare la spiritualità di un popolo e la sua pecuiliare inclinazione mentale.È, questo, il personale punto di vista di lstvan Papp, quando, dalle pagine del
"Bollettino dell'Atlante Linguistico ltaliano", si propone di istituire delle corri-spondenze tra prassi di ricerca storica legata a metodi positivisti, psicologiaancorata a dettami post-lombrosiani e fenomenologia del "nazionale" configu-rata alla maniera di "un sisfema di rappresentazione culturale,ru. presentandole caratteristiche dell'Atlante Linguistico Ungherese, Papp, nella parte conclu-siva del suo articolo, osserva:
46 / Enrico Biasin
lientre gli studi storici, mirando aI problema delle origini, aderivanostrettamente agl'interessi nazionali, Ie ricerche psicologiche, appunto
lmché generali, rimanevano prive di un vincolo più stretto con Ia vitamzionale. Spetterà all'Atlante linguistico ungtrerese di mostrare, frafallro, il valore effettivo della psicologia linguistica per Ia conoscenza
dla vita nazionale e di apprestare i materiali per rifare dalle fonda-mrta la psicologia del popolo ungherese, in quanto si manifesta nelffingfraggio. [...] Con osservazioni di questo genere ci avviamo a valercidLlnterpreta,zione dei fenomeni linguistici di elementi di psicologiatecsiale" o etnica; e si può quindi riconoscere negli atlanti linguistici:i rigliori sussidi per un'interpretazione delle diverse collettività lin-gpirtiche fondata sulla psicologia etnica. LAtlante linguisticonglp-ese potràr, dunque servire a svelare le caratteristiche psicologiche
della lingua e della Nazione ungherese2T.
4li esempi di discorso che sono statiformulati sino a questo punto,discorsiva autografa di Ugo Pellis appare essere investita da
funzione regolativa. I suoi testi, accompagnati dalla sua firma, si
irffiti, *come principio di raggruppamento dei discorsi, come unitàtld loro significati, come fulcro della loro coarar'za»2'. Ciò significa
:rti tuviamo ripetuti, rilanciati e riconfermati alcuni temi e oggetti difr mupano le pratiche discorsive a loro coeve. Ma negli scritti del
rxn soorgiamo soltanto la mera ricomposizione di concetti culturali,ùffii discorsi. Al contrario, nella sua produzione scritta è operantelI sddare insieme due fondamentali prospettive d'interesse. ln pri-
Creila debitrice del pensiero nazionalista e totalitario, in virtù dellai particolarismo culturale, sociale e politico deve abbandonare
@gative di soprawivenza per connettersi al principio ordinatoreùsnato dalla nazione. ln secondo luogo, quella attenta avaloriz-lI rnaginalità e "sottoculture" linguistiche, le quali si delineanocdihnive dello stesso tessuto della nazione e si esprimono nelleffi[ cbi gerghi e delle parlate comunitarie locali. Entrambe le
§ dà il caso che possano intrecciarsi anche all'interno del
reob, così come si qualificano come la prova più certa - che
La parole e le cose. La comunitàt immag"inata di Ugo PeIIis / 47
emerge altresì dall'intero repertorio fotografico - del tentativo compiutoPellis di far convivere due punti di vista - talvolta alterni, talaltra concomiti- sulfa modernità incipiente. ln un saggio del 1g24, pellis denuncia nerobianco la necessità per lo stato italiano di dotarsi di una decisa politica di ctfine. con essa il nostro paese dovrebbe attuare un,*azione di conouirivolta alfindirizzo di quei territori che, secondo un,ottica irredentista, appar_tengono storicamente al Regno d'ltalia. ll testo in questione non dà adito adequivoci di sorta: Pellis mira a denunciare una situazione d,inerzia generaleche riguarda la nazione, la quale avrebbe quale missione inderogabile quelladi colonizzare culturalmente e linguisticamente le zone liminari e adiacenti a[eproprie frontiere. Questo uno dei passaggi chiave dell,articolo:
lirtalia non vuore ra soppressione degli sloveni e degri altri alogtotti. rIoro ringrraggio familiare sarà rispettato; esso corrisponde a un bisognointimo locale, regionare. euesto linguaggio è 1,espressione d,una limitatavita proprio che può svolgersi pacificamente nelre pareti domestiche. Maagli sloveni d'rtalia (e non solo ad essi) sia fatto presente quare minimaparte deì-lo stato essi siano: 1/zoo, una quantità trascurabile che, volendo,si può a breve scadenza scompaginare, disperdere, schiacciare [...]. Inquesto senso va intesa Ia tealtà e dedizione all,Italia2s.
ll medesimo ordine di discorso esplicitato in questo passaggio trova un proprioomologo discorsivo in un altro testo, pubblicato sulle paEne di *ce fastu?,.si tratta della prolusione pronunciata da pellis in òccasione del XIVcongresso della Filologica Friulana celebratosi presso cordenons nel set_tembre del 1933. In tale occasione l,oratore tesse le lodi della politicalinguistica intrapresa dal fascismo, riconoscendo a quest,ultimo il pienomandato di un'azione improntata alla salvaguardia dell,identità nazionaleitaliana. ciò che conta, per pellis, è combattere l,uso dei dialetti da parte deiparlanti locali e promuovere, per iltramite di diverse agenzie educative e cul_turali, un unico idioma valevole per l'intero territorio delta penisola.
rI Governo mussdtniano ha rotto energicamente tutti i compartimentistagni della vita nazionale, e va creando un completo rivorgimento derla
48 / Enrico Biasin
vita, che ha per naturale conseguenza Io smistamento regionale, pro-rnuove in tutti i modi Ia diffusione della cultura livellatrice e
hificatrice, primo maggior firezzo per Ia elevazione del popolo, con isti-hzioni che vanno dall'Università, aI Dopolavoro [...]. I dialetti, che sono
eqrressione di una realtà attuale, saranno ridotti a quell'aspetto che lorodarà la vita awenire della nazione. TUtti si stanno livellando con ritmoimfinita.rnente più accelerato che nei tempi in cui iI centro intellettualeera mtituito dalla farmacia all'ombra del campanile e si faceva testa-rrsrto prima di mettersi in viaggio per due giorni. I dialetti subirannole loro naturale evoluzione. Quello che importa è la diffusione di condi-nirri culturali che diano pieno assoluto valore alla lingrra nazionale. IIDemisrno 1o vuole, e cosi sarà ad onore e gloria d'Italia3o.
;nrò interessante notare come in altri contesti di enunciazione Pellis riveli
ùa sua curiosità di studioso nei confronti di realtà sottoculturali; all'indi-cioe di quei fenomeni marginali che appartengono alla lingua e alla
e che si consumano entro lo spazio di un sistema dominante che ha
Ferogativa peculiare quella di eliminare, estinguere e riassorbire qual-Estimonianza residuale o finanche "resistente". Pellis, sotto questasernbra essere consapevole che «lo stile della sottocultura è allora gra-{I s(lnificazione" e che «le sue trasformazioni vanno "contro natura",
il processo di "normalizzazione",, supposto in atto31. Scrive aSilvio Pellegrini: «A lui non piaceva ricalcare le piazze trite;vocazione che in altro secolo lo avrebbe forse portato ad aprir
ignoti, lo spingeva verso i territori della scienza difficilib zone linguistiche periferiche, dalle condizioni intricate,
flÉriosio@. E ancora, precisa Egrem Qabej: "Una partico-
#e il Pellis per tutte le lingue speciali, per lo zingarescodatigiani e della malavita"3s. Gli appunti e le inchieste
il lrrrco rErcconto dell'incontro avuto con gli zingari e lac[ predicazione antica sottratte alla modernità friula-ddle chiare spie discorsive di come il nostro fosse
ùWarùz,azione sociale in diretta antitesi con le conven-allora egemoniche.
I-r- parole e Ie cose. La comunità immaginata di Ugo PeIIis / 49
Le immagini della nazione"Ricorsi a testi scientifici, a libri scolastici, a cartoline, a cataloghisacrificai mie annate di riviste, feci fotografie, ma senza riuscire a coprirtutto il fabbisogno. Perciò ricorsi all'opera di soci capaci e disinteressati.c-Con queste parole, assai spesso citate in diversi articoli e saggi rivolti alla srafigura, Pellis ci dà conto della necessità di awalersi di immagini per l,esecrrzione del proprio lavoro. Riponendo un'elevata fiducia nel valore testimoniabed evocativo di qualsiasi forma di figurazione, il raccoglitore dell,ALl adoperasvariate tipologie di immagini per documentare i risultati delle proprie ricerche.sotto questa luce, Pellis incarna perfettamente la figura dell'uomo borghesed'inizio Novecento che intende accostarsi alle cose del mondo secondo unapropria aspettativa di condivisione culturale. Lo storico Donald M. Lowe hadescritto questa modalità di percezione tipicamente borghese come essen-zialmente obiettiva, visiva e in grado di articolarsi spazio-temporalmentes;. Lefotografie scattate da Pellis certificano la dimensione percettiva appenadescritta, dato che attestano la volontà di estendere il campo della visioneanche se in forma controllata; interpretano i propri soggetti contando su schemirappresentazionali definiti e ben riconoscibili; catalogano, infine, ambienti,soggetti umani e oggetti secondo il quadro sinottico pensato per l,Ailante equindi necessariamente improntato a logiche di ricerca spazio-temporali.Nelle precedenti pagine si è detto più volte che pellis adotta una prospettivaconoscitiva nei confronti dei propri oggetti d'indagine debitrice di due diversiordini epistemologici: da un lato, si evince la volonta investire nei propri inte-ressi cio che naturalmente si esclude a priori, cio che non entra nel campodi conoscenza dominante; e dall'altro, si nota parimenti l'urgenza di ricon-durre a misura verificabile, appunto "controllata", interi spazi di realtàculturale sconosciuti o renitenti a qualsiasi progetto di livellamento. Lacomunità immaginata da Pellis attraverso il dispositivo ottico-meccanicodella fotografia è quindi un organismo nazionale che reca in sè tracce dimodernità e che nello stesso tempo le sopprime; che si propone come localee che intanto punta divenire rappresentativa dell,intero paese.Nelle immagini scattate da Pellis, il processo di costituzione identitariaappena tracciato ha modo di delinerasi almeno su due livelli di attenzione. llprimo investe l'oggetto della percezione, mentre invece il secondo la retorica
50 / Enrico Bia,sin
della rappresentazione. Roland Barlhes ha scritto che l'immaginenon restituisce mai - in nessun caso - un corpo neutro, anatomico,
sempre conto di una interpretazione, di un atto performafivo: "nonio mi sento guardato dall'obiettivo - scrive Barthes - tutto cambia:
in un atteggiamento di "posa", mi fabbrico istantaneamente un
Gorpo, mi trasformo anticipatamente in immagine"3'. D'altra parte,
Martine Joly, "6611 bisogna dimenticare [...] che se ogni immagine èciò implica che essa ulilizzi necessariamente le regole di
te"o- Corpi pertormati e strategie di rappresentazione: sono questi,
i due assi lungo i quali si formano le fotografie di Pellis.sono i ritratti sia di soggetti maschili che femminili che presentano
dicomplessità iconografica facilmente accessibile. ln questi casi,
fireso a figura intera oppure a mezza figura risulta sempre perfet-isito nel contesto che lo ospita, disponibile allo sguardo e
h grado di performare una propria identità. ll montanaro immor-ffirva da una delle macchine fotografiche portatili di Pellis (fig. 1,
campione esemplificativo di quella commistione di tratti loca-d cui si è più volte discusso; ma parimenti è anche espressioneihalipiù generali e meno ascrivibili ad un'ottica eminentemente
Da un lato, il giovane è a tutti gli effettiparte del com-cfre lo circonda e lo contiene, e la sua specificità indigena è
f;dto che egli, forzatamente, posa con accanto gli utensili di
credere si serva per svolgere la propria attività lavorativa.rhqra figura è semioticamente predisposta per accogliere quei
cfie la cultura dell'epoca attribuiva ai soggetti di genere
hdfuklui dotati di aggressività, tipi eroici, ma esseri in gradopronte e immediate. "L'uomo davvero mascolino
llme, spiegando la nascita dello stereotipo maschile chedurante gli anni Trenta del Novecento - si integrava
È di ogni giorno, smussando i suoi aspetti più spigolosi
Fertare a tutti, o quasi, gli effetti come un buon capofa-in questione convivono più elementi di raffronto
essa sia apre ad una gamma piuttosto ampia di signi-
La parole e le cose. La comunità immaginata di Ugo Pe11is / 51
FIG.2RITRATTO DELTINFORMATORE,
TBAPANI, 1940.
FIG.3RITRATTO DELL'INFORMATORE,
CASTELDELFINO, CUNEO, 1936.
FIG. 4RITRATTO DI RAGAZZE
CHE INDOSSANOIL COSTUME LOCALE,
VALPRATO SOANA, TORINO, 1936,
FIG. 5RITRATTO DELUINFOBMATRICE
CHE INDOSSA UN ABITO A LUTTO,VALPRATO SOANA, TORINO, 1936.
ulteriormente sulle modalità attraverso le quali Pellis raffigura i suoi soggefli fmaschili. A tale proposito, Richard Dyer, riflettendo su alcune immagini fote Igrafiche di corpi maschili destinate alconsumo di un pubblico essenzialmente Ifemminile, enumera una serie di instabilità che permeano le loro raffigurazioni. fUna di esse concerne lo sguardo del soggetto ritratto: la posizione di superie. frità di genere sessuale è comunicata visivamente dal gesto di non posizionare fgli occhi in direzione del destinatario cui l'immagine è diretta. Secondo Dyer; Iin questo caso lo sguardo della persona immortalata dalla fotografia "sugge- Irisce un interesse in qualcosa d'altro che lo spettatore non può vedere - esso fcertamente non indica alcuna attenzione nei confronti dell'osservatore,lo. Ciò Ifa sì che si formalizzi un tentativo di divincolamento compiuto dal corpo Imaschile neiconfronti del dispositivo di ripresa, denunciando fra l'altro la pos- Isibilità che tale specie di peiormance può aver luogo grazie al fatto che Iquesto tipo di raffigurazioni fluttua all'interno di uno spazio sociale e culturale Ilargamente dominato dalla logica patriarcale. L'uomo, seppure trasfigurato Inella superficie riflessa prodotta da un dispositivo ottico-meccanico, non Isfugge per nulla alla sua caratlerizzazione mascolina, rimuovendo il timore di Iessere trasformato in oggetto di speffaco/o e di cadere nella logica della I"feminilizzazione" dei suoi attributi tradizionali ILa coppia di informatori rappresentati nelle loro abitazioni - alla quale si Ipotrebbero aggiungere molti altri esempi - denuncia la sostanziale adesio- |ne a quei valori della cultura patriarcale di cui s'è detto. lnoltre, l'impianto Ialtamente ritualizzalo della rappresentazione e il mantenimento di un ordine Idella stessa entro i canoni di un certo pittoricismo di maniera non fanno che
I
perfezionare il progetto di ricerca di una forma nazionale perseguito dall'au-tore di tali fotografie.Dove, invece, modernità e tradizione si trovano inserite in un processo dinegoziazione formale è nei ritratti femminili. ln alcuni di essi, ad esempio (fig.4 e fig.5), se Pellis, com'è stato fatto notare, ricorre "alla scena di genere, cioèalla ricostruzione, culturalmente controllata, di una situazione"4,, viceversaemergono, da parte dei personaggi considerati dall'obiettivo della macchinafotografica, degli atteggiamenti di "resistenza" alla loro instaurazione all'inter-no di un ordine cosuetudinario. Nelle due immaginini citate, infatti, le ragazze
52 / Enrico Biasin
.
FIG. 6RITRATTO DI DONNE
CHE INDOSSANOIL COSTUME LOCALE,
VILLAGRANDE, NUOBO, 1934.
FIG. 7GEBLA DA FORNAIO E GRUPPO
DI RAGAZZI DEL PAESE,CORDENONS, PORDENONE, 1933-
si mostrano ai nostri occhi, e prima ancora a quelli delfotografo che posadi loro il proprio sguardo, con una cefia compiacenza. Gli abiti che portanosono quelli tradizionali, quelli "essenzialmente folcloristici", anche se Peldiversamente da quanto accade per altri contesti di ripresa (ad esempio, '
6) in cui è evidente quell'oscillazione mortificante "tra l'esecuzione capitalela messinscena, tra la camera della toftura e il salone del trono",, notata atempo da Benjamin nei confronti dei primi ritratti fotografici, non domandaloro, insistentemente, di porsi in posa. Anzi, sono le stesse donne che, avendoelaborato una certa consapevolezza del mezzo fotografico, si dispongonosecondo un assetto più libero e meno strutturato. ll particolare, poi, dellezature indossate connota queste raffigurazioni in senso ancor più marcato:uno stridore abbastanza palese fra gli indumenti semioticamente connessicon la necessità di produrre delle immaginifacilmente assimilabili al clima folclorico regionale voluto e cercato da Pellis e gli accessori tipicamentefemminili e di fattura moderna esibiti dalle protagoniste ivi rappresentate.Nelle fotografie del nostro raccoglitore-fotografo abbiamo dunque a che farecon due atteggiamenti: il primo, quello del soggetto ripreso, è un comportamento oramai quasi smaliziato, in parte cosciente del proprio ruolo"attore" e delle intrinseche potenzialità performative del medium (cfr. fig. 7il secondo, quello del soggetto di ripresa, risponde ad una condotta avolta divisa fra lo sforzo teso a modellare alcune situazioni e il bisogno, quasifisilogico, di documentare gli stili di vita dei personaggi fatti rientrare nel propriocampo di osservazione.
54 / Enrico Bia,sin
Note
10
J. DrcKrE, lmagined ltalies, in ltalian Cultural Studies: An lntroduction, edited by D. Fononcs, R.Luurev, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 19 (traduzione mia).
Secondo l'intellettuale sardo, che scrive nella prima metà degli anni Trenta, nel nostro Paeseesiste ancora il sostanziale problema "della faticosa elaborazione di una nazione italiana ditipo moderno, contrastata da condizioni di equilibrio di forze interne e internazionali". A.GRnrasct, Quaderni del carcere, edizione critica dell'lstituto Gramsci, a cura di V. GeRRnrera,Torino, Einaudi, 1975, p.2107.
Nella realtà del Ventennio, la nazione si configurava come "il frutto della tradizione e dellavolontà presente di integrarsi in un corpo sociale statuale» ed «era eminentemente una affer-mazione spirituale e volontaristica". PG. Zur.r[.ro, tideologia del fascismo. Miti, credenze evalori nella stabilizazione del regime, Bologna, il Mulino, 1985, p. 196.
E. GerurtrE, The Myth of National Regeneration in ltaly,in Fasclst Visions: Ari and ldeotogy inFrance and ltaly, edited by M. ArrnoN, M. ANTLIFF, Princeton, Princeton University Press, 2000,pp. 25-45.
L.J. KnpL-qN, Falsi idoli. Le culture del feticismo, trad. it. Trento, Erickson, 2008 (tit. orig.:Cultures of Fetishism), p.7.
Cfr. S.J. Wooc, Risorgimento e fascismo.' l/ senso della continuità nella storiografia italiana,"Belfagor", XX (1965), 1 , pp. 71 -91 . M. Bnrorur, Fascismo e Risorgimento. lilstituto per la sto-ria del Risorgimento italiano, "Passato e presente», XV (1997), 41 , pp. 45-75.
R. Beru-Gnnr, La cultura fascista, trad. it. Bologna, il Mulino, 2000 (tit. orig.: FascistModernities: ltaly, 1922-45), p. 11.
Cfr. B. TennnclNt, L?tante Linguistico ltaliano nell'opera di Matteo Bartoli e Ugo Pellis,"Bollettino dell'Atlante Linguistico ltaliano", n.s., dispensa n. 1, Torino, .195S, pp. 3-9.
Cfr.. per-l'elenco completo delle pubblicazioni di Pellis, G.B. Concrumr, Bibtiografia di lJgoPellis, "Ce fastu?", XIX 0943), 4-5, pp. 183-186.
L. Werrs, General lntroduction,inThe Photography Reader, edited by L. Wells, London-NewYork, Routledge,2002, p. 5 (traduzione mia). Per una descrizione dettagliata di come nell'am-bito di un archivio fotografico discorso istituzionale e discorso ideologico possano talvoltacoincidere, si veda K. BecrEn, Picturing Our Past: An Archive Constructs a Nationat Culture,"The Journal of American Folklore", vol. 105 (1992), 41S, pp. 3-18.
T. Bnusrr.r, Atlantelinguisticoitaliano, "Cefastu?",XVl (1941), 1,pp.26-28.
56 / Enrico Biasin
11
12 L'AU si pone all'interno del campo di ricerca dell'inchiesta /esslca/e. È it tlpo di tecnica piùantico, dato che I'inchiesta /essrba/e è nata in ambilo dialettologico con i rilievi sistematici ini-ziati verso il 1880 da J.L. Gilliéron. Fu questi a ideare lo strumento del questionario, "una listacI domande concepita in modo da ottenere sistematicamente il lessico che interessa". G.R.Garcore, lntroduzione all'etnolinguistica, Bologna, il Mulino, 1976, p. 245. Da allora, il que-§imario è stato lo strumento più usato per raccogliere in breve tempo una documentazionebssicale omogenea in un determinato punto geografico.
13 I- Cor.rsrer-ro Drnerrrvo, Per l'Atlante linguistico italiano, "Rivista della Società Filologicakiulana", V (1924), p. 99.
l{ Cft. J. Juo, Atlante linguistico ed etnografico dell'ltalia e della Svizera meridionale (AlS),.Sollettino dell'Atlante Linguistico ltaliano", lll (1935), 1, pp. 29-30.
15 G. Vroossr, l:Atlante Linguistico ltaliano. Questioni di metodo e di fini, "Bollettino dell'Atlantel-irguistico ltaliano", I (1933), 1, p. 6.
l§ sl.il concetto di Stato-nazione e sulla sua crisi in epoca novecentesca, si veda D. Beerrnu,TIre Future of the Nation Stafe, in The ldea of the Modern State, edited by G. Mclrruunru, D.th.o, S. Hu, Milton Keynes-Philadelphia, The Open University Press, 1984, pp. 208-222.
fI Secondo Mari D'Agostino, l'awersione nei confronti del dialetto da parte del fascismo non èSah solo contraddittoria, ma anche motivata dal timore che la conservazione delle tradizio-d bcali potesse fomentare spinte autonomistiche. "Va quindi inquadrata - nota D'Agostino -ndla opposizione allo sviluppo di un modello policentrico, diverso da quello centralista tipicodd rcgime fascista, e in una politica linguistica che ha come linee conduttrici [...] l'afferma-zime della lingua nazionale contro i nemici sul piano interno (i dialetti e le lingue di minoran-z4 ed esterno (le llngue straniere)". M. D'AcosrNo, Sociolinguistica dell'ltalia contemporanea,Bologna, il Mulino, 2007, p. 37.
1A S- llALr, lntroduction: Who Needs "ldentity"?, in Quesfions of Cultural ldentity, edited by S.thu.. P ou Gnv, London, Sage, 1996, pp. 4-5.
flg P- WUTMEN , The National, in Flelds of Vision: Essays ln Film Studies, Wsual Anthropology, andPtatognphy, edited by L. DeveRenux, R. Hrlll,tnr, Berkeley-Los Angeles-London, University ofCdifomia Press, 1995, p. 23.
2O H- Ferncroueu, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, London-New York,RorUedge, 2003, pp. 24-25.
2l Cxr- M. FoucAULr, Che cos'è un autore? (1969), in Michel Foucault. Scritti letterari, Feltrinelli,trflano 2004, pp. 1-21.
22 lrbc$, tAtlante Linguistico ltatiano, cit., p. 19.
El Fm., ll Friuli alla testa del Folklorismo italiano?, "Ce fastu?", V (1929), 3, p. 34.
2l E Feean., Folkloismo è ltalia nuova, "Ce fastu?", V (1 929), 5, pp. 77 -78.
25 M- Banror-\ Dal "Piano generale dell'Atlante linguistico italiano", "Ce fastu?", Vll 0931), 8-10,9.7.
gG S- HALr, The Question of Cultural ldentity, in Modernity and lts Future, edited by S. Hnll, D.lE-D, T. McGnew, Cambridge, Polity Press/The Open University Press, 1992, p. 292.
Ztr l- Papp, Piano d'un Atlante linguistico ungherese, "Bollettino dell'Atlante Linguistico ltaliano",ill (1935), .1, p. 7 e p. 8.
La paro\e e le cose. La comunità immaginata di Ugo Pellis / 57
28
29
30
31
32
33
34
M. fouc{uLr, l:ordine del discorso. Meccanismi sociali di controtlo e di esclusione della parola,trad. it., Torino, Einaudi ,1972 (1970), p.22.
U. Perus, Politica di confine, "Rivista della società Filologica Friulana,, v (1924), p. 59.U. Perrrs, Ai margini della friulanità, "Ce fastu?,, lX (1933), 9-10-11_12, p.232.
P:lleeoree, sottocultura, il fascino di uno stite innaturale, trad. it., Genova, costa & Nolan,1983 (tit. orig.: Subculture: The Meaning of Style), p. 1 9.
s. PeuecRrr.rr, Per una raccolta degli scritti di lJgo peltis, *ce fastu?,, xlx (1g43), 4-5,'b. 1gg.E. Qeerr, Ricordo di tJgo Pellis, lvi, pp. 116-177 .
Rispettivamente, u. PELLrs, clpgtlqnla inchieste tinguistiche in sardeqna, *Bollettinodell'Atlante Linguistico ttariano.,.lì (i.934),2,pp.qs-zai.pÉits,ùrzuiei. Apiiìti'iù uomini, iio-_9!ti, cgge., parole, "961;sttino.deil Ailanle Linguistico ttatiano,,, ttt OS3Slii, pÉ.-iZ_ZA. ÉLL.À,con gti zingari, "ce fastu?", xv{1 939), 5-6, pÉ n7-24r. Èei.''s, oìràtrÉ' pìi"Ziònà friutane de'lI'epoca napoteonica, "Ce fastu?", XVi ltg4il, t, pp. OOì9.--U. Perrts. tAtlante Linouistico ltatiano. La prima messe, .Rivista della Società FilologicaFriutana", vil (1926), p. 59.
D.M. LowE, History of Bourgeois perception, chicago, The University of chicago press, 19g2.R. Bnnrnes, La camera chiara. .Nota suttg.tgtogralia, trad. it., Torino, Einaudi, 1gso (tit. orig.: LaChambre claire. Note sur la photographie, pl 12. '
M. Jorv, Introduzione all'analisi dell'immasine. trad. it., licrino, Lindau, 1999 (tit. orig.:lntroduction à I'analyse de I'image), p. 53. -39 G.L. Mosse. L'lmmaoine dell'uomo. Lo stereotipo magglite nell,epoca moderna, trad. it.,Torino, Einaudi, 1997"(tit. o;,tig.tTh;imagiii Uàià1, pp. 1s0-191.
40 R. Dven, Don't Look Now: The lnstabitities of Male pin-up,.Screen,, vol. 23 (19g2), 3_4, p. 3.41 G..Err-eno, ug9 lellis etno.grafo e fgtoglqfg, in G. Er_lrno, M. Mrcnelurn, lJgo pelis fotografodella parola, Udine, Società FilologicaFriulàna, 1994
42 w. Berurer,,ilN, Piccola st?lta qeila.fotografia {1931), in w. Benlnurr.r, topera d'afte nett'epocadellasuaiproducibititàtecnica,trad. lt., Toriho, Einaudi, tSÒì, b. dZl--- - -
35
38
36
37
58 / Enrico Biasin
Eliografia di riferimento
lHgùnariLinguistico ltatiano promosso dal/a Società Filologica Friulana, "Ce fastu?", XV 0939),
p-273-288.
E sltrr, I dialetti dell'ltalia settentrionale, "Ce fastu?", Vl 0 930), 7-8, pp. 1 14-1 16.
Ersrru, Dat "Piano generale dell'Atlante linguistico italiano", "Ce fastu?", Vll (1931), 8-10' pp.
Atlante linguistico italiano, "Ce fastu?", XVI (1941), 1, pp. 26-28.
DrRErrMo, Per l'Atlante linguistico italiano, "Rivista della Società Filologica Friulana",pp. 97-99.
Gomrnu, Bibliografia di tJgo Pellis, "Ce fastu?", XIX (1 943), 4-5, 31 , pp' 183-1 86.
fuvrcn, tl Fiuli atta testa det Fotktoismo italiano?, "Ce fastu?", V (1 929), 3, pp. 39-41 .
Folklorismo è ltalia nuova, "Ce fastu?", V (1 929), 5, pp. 77 -78.
]mr,Atlante Linguistico ltaliano. Attività svolta datl'ottobre 1929 al settembre 1930, "Cerll-, vl 0930), 9-10, pP. .151 -153.
AtWe linguistico ed etnografico dell'ltalia e della Svizzera meridionale (A/S), "BollettinorÈ Unguistico ltaliano", lll (1935) 1 , pp. 29-30.
gm,fup d'un Atlante linguistico ungherese, "Bollettino dell'Atlante Linguistico ;161;266", lllI, pp. 1-16.
Pei una raccolta degli scritti di lJgo Pellis, "Ce fastu?", XIX 0 943), 4-5, pp. 1 82-183.
futitica di confine, "Rivista della Società Filologica Friulana", V (1924), pp. 50-59.
EAdante Linguistico ltaliano. La pima messe, "Rivista della Società Filologica Friulana",pp.97-104.
È.rc, Ferazione preliminare per t'edizione dell'Atlante Linguistico ltaliano, "Ce fastu?", Vllùlll 8.10, pp. 13-46.
Èrts,Ai margini della friulanità, "Ce fastu?", lX (1933), 9-10-1 1-12, pp.229-237.
hts, Cinquanta inchieste linguistiche in Sardegna, "Bollettino dell'Atlante LinguisticonD,,I ttSSal, 2, pp. 49-76.
La parole e Ie cose. La comunità immag:inata di Ugo PeIIis / 59
U. PELLrs, Urzulei. Appunti su uomini, luoghi, cose, parole, "Bollettino dell'AtlanteItaliano", lll (1935), 1, pp. 17-28.
U. PELLrs, Con gli zingari, "Ce fastu?", XV 0939), 5-6, pp. 237-242.
U. PELLrs, Quattro prediche fiulane dell'epoca napoleonica, "Ce fastu?", XVI (1941), 1, pp. 66-69-
B. Tennactrut, fAtbnte Linguistico ltaliano nell'opera di Matteo Bartoli e lJgo Pellis, "Bollettimdell'Atlante Linguistico ltaliano", n.s., dispensa n. 1, Torino, 1955, pp.3-9.
G. Vtoosst, L'Atlante Linguistico ltaliano. Questioni di metodo e di fini, "Bollettino dell'AtlanteLinguistico ltaliano,, I (1933), 1 , pp. 4-27 .
Testi secondari
B. AuoeRsot't, Comunità immaginate. Origini e foftuna dei nazionalismi, trad. it., Roma, manifesto-libri, 1996 (tit. orig.: lmagined Communities: Reflections on the Origins and Spread dNationalism).
G. BnccnRo, Ugo Pellis e Ia fotografia di architettura rurale,Tesi di laurea, lstituto Universitario diArchitettura Venezia, a.a. 1 997-1 998.
D BeErHer,I, The Future of the Nation State, in The ldea of the Modern Sfafe, edited by G-Mc,Lqryrynu, D. Hrro, S. Hnu, Milton Keynes-Philadelphia, TheOpen University press, 1984ipp.208-222.
R. Bnnrues, La camera chiara. Nota sulla fotografia, trad. it., Torino, Einaudi, 1980 (tit. orig.: LaChambre claire. Note sur la photographie).
K. Becrrn, Picturing Our Past: An Archive Constructs a National Culfure, "The Journal of AmericanFolklore", vol. 105 (1992),415, pp.3-18.
R. Beru-Gurnr, La culturafascista, trad. it., Bologna, il Mulino,2000 (tit. orig.: Fascrbf Modemities:Italy, 1922-45).
W. BENJAMTN, Piccola storia della fotografia (1931), in W. BENJAMIN, L'opera d'arte nelt'epoca dettasua riproducibilità tecnica, trad. it., Torino, Einaudi, 1991 , pp. 55-78.
G.R. Cmooun, lntroduzione all'etnolinguistica, Bologna, il Mulino, 1976.
M. D'Aoosrno, Sociolinguistica dell'ltalia contemporanea, Bologna, il Mulino, 2007.
J. Dtc«re,_lma$ned ltalies, in ltalian Cultural Studrès: An lntroduction, edited by D. FoRGAcs, R.Lur,rlrv, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 19-33.
R. DvEn, Don't Look Now: The lnstabilities of Male Pin-up, "gc,1ssn", vol. 23 (1982), 3-4, pp. 61-73.
G. Et-uno,.Ugo Pellt-s elnogrqfo e fotografo, in G. ErEno, M. Mrcxelurn, lJgo Pellis fotografo deltaparola, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1994, pp. 67-71 .
G. Errrno, Le 'bssessioni" di un linguista fotografo, in Voci e immagini. lJgo Pellis tinguista e foto-grafo,a curadi G. ErrrRo, l. Znrururen, Milano, Federico Motta Editore, 1999, pp.9-15.
N. Fruncrouctt, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, London-New York,Routledge, 2003.
60 / Enrico Biasin
Ghe cosè un autore? (1969), in Michel Foucault. Scritti letterari, Milano, Feltrinelli,1-21.
[rn, fordine del discorso. Meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola,lEin, Enaudi, 1972 (1970).
lrry Mylh of National Regeneration in ltaly, in Fascisf Visions: Aft and ldeology infdy, edated by M. Arrnoru, M. Arururr, Princeton, Princeton University Press, 200d, pp.
ù*mi del carcere, edizione critica dell'lstituto Gramsci, a cura di V. GeRnnrnrun,1975,
rCnsfion of Cultural ldentity,inModernityand ltsFuture, edited byS. Hnu, D. Hero,ffiridge, Polity Press/The Open University Press, 1992, pp.273-316.
@mmunity, Nation, "Cultural Studies", vol. 7 (1993), 3, pp. 349-363.
q: Who Needs 'ldentity'?, in Questions of Cultural ldentity, edited by S. Hnrr,Sage, 1996, pp. 1-17.
ta, il fascino di uno stile innaturale, trad. it., Genova, Costa & Nolan, 1983The Meaning of Style).
alfanalisi dell'immagine, trad. it., Torino, Lindau, 1999 (tit. orig.: lntroduction
ihli- Le culture del feticismo, trad. it. Trento, Erickson, 2008 (tit. orig... Cuttures
d fuurgeois Perception, Chicago, The University of Chicago Press, 1982.
&ll'uomo. Lo stereotipo maschile nell'epoca moderna, trad. it., Torino,:Tle lmage of Man).
, The Photography Reader, edited by L. Werrs, London-New York,p-1-9.ìtral, in Fields of Wsion: Essays ln Film Studies, Visual Anthropology, andH by L DEveneaux, R. Hluunru, Berkeley-Los Angeles-London, Univeièity ofr5§p- 21-34.
d fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizzazione del regime,
La parole e Ie cose. La comunità immaginata di Ugo PeIIis / 61